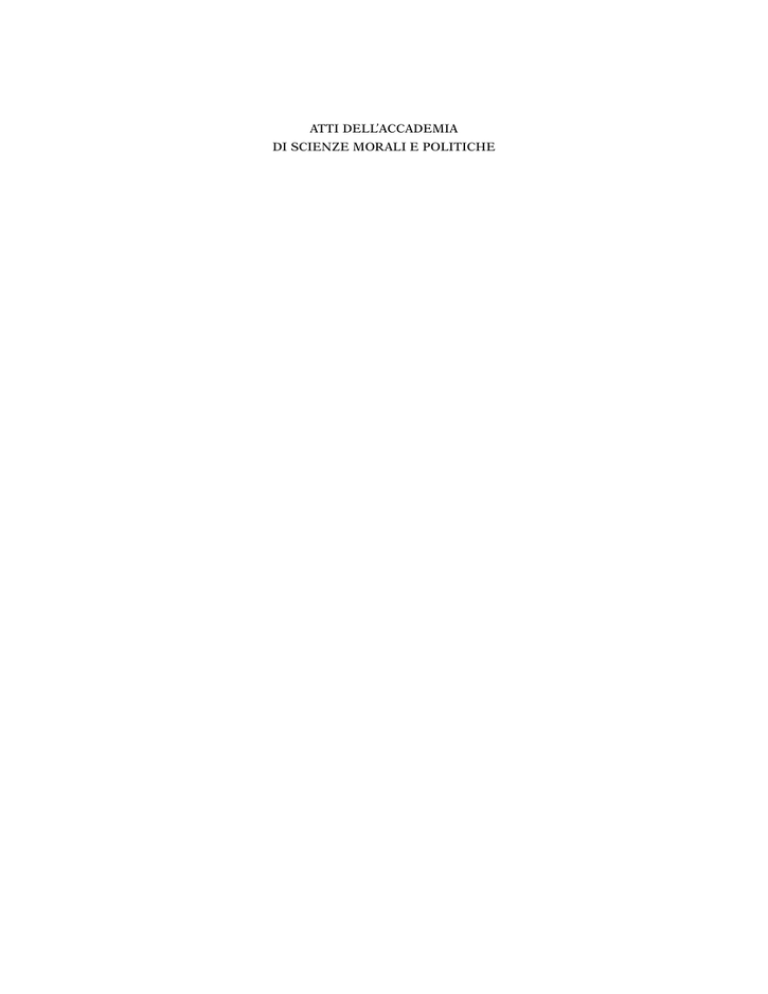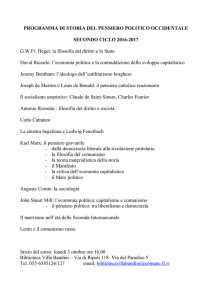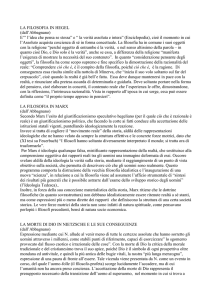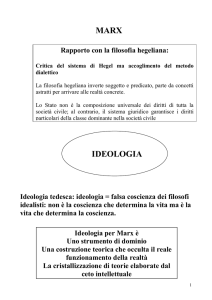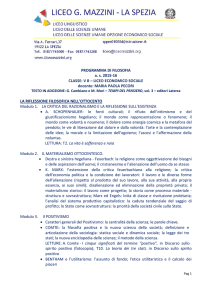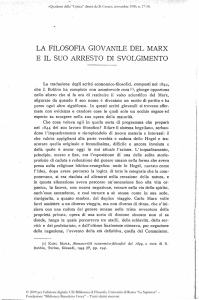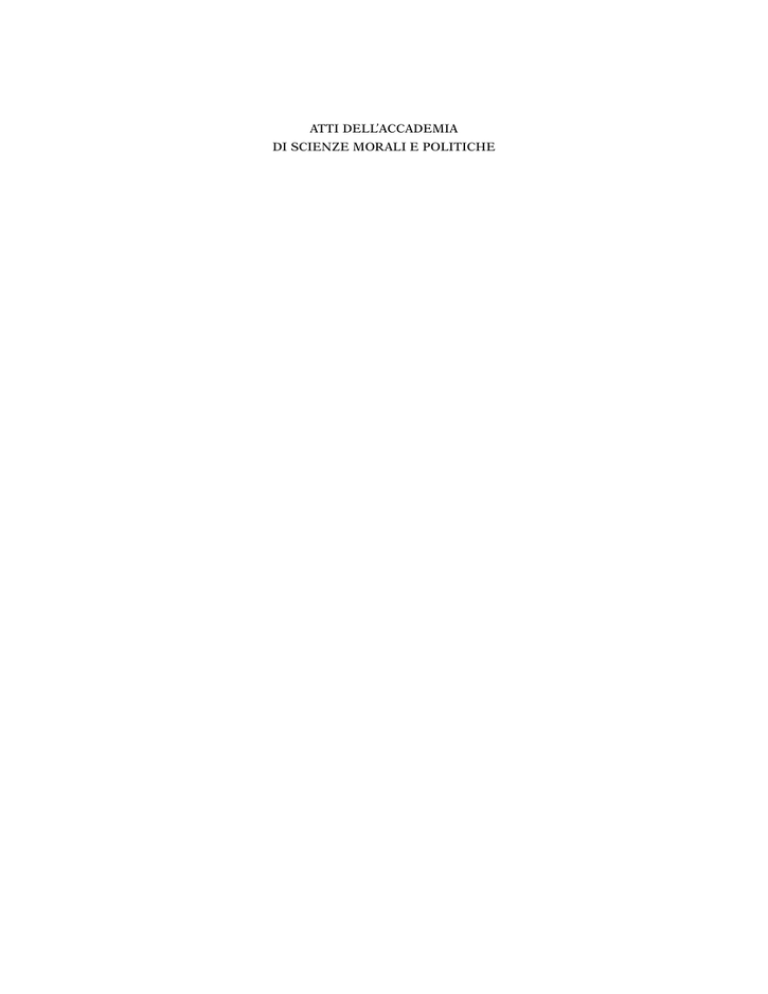
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
Società nazionale di scienze, lettere e arti in napoli
Atti dell’accademia
di scienze morali e politiche
volume CXIX - anno 2009
Giannini editore
napoli 2009
Con il contributo della Regione Campania e del Ministero dei Beni Culturali
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
L’Editorial Board della rivista è composto da tutti i Soci ordinari delle due sezioni
dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
Il Comitato di lettura della rivista è composto da tutti i Soci corrispondenti e da
tutti i Soci stranieri delle due sezioni dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche.
ISSN: 1121-9270
ISBN-13: 978-88-7431-475-1
Le memorie presentate per la pubblicazione sono preventivamente sottoposte
a una procedura di blind peer review.
L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
5
L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli
di Thomas Mann
Memoria di Donatella Nigro
presentata dal socio naz. ord. res. Domenico Conte
(seduta del 30 gennaio 2009)
Abstract. In this article, Thomas Mann’s Joseph und seine Briider is described as the contribution
to the foundation of a new kind of humanism: “nocturnal”, so to say, because able to reconcile
the faith in reason and progress with the attention to the dark sides of human life.
Analysing not only the biblical tetralogy, but also the many essays written about it from the
author himself, it seems to be clear that right through the character and story of Joseph (who
is blessed both from earth and sky, from body and spirit) Thomas Mann meant to represent
a possible solution to the crisis of european culture, setting against the theories of modern
fascism a new notion of myth and primitivity.
Il Giuseppe e i suoi fratelli è comunemente noto quale l’opera mitica di Thomas Mann che, abbandonato il romanzo borghese, si volge alla narrazione di
una delle più antiche leggende mediorientali, immergendosi, per quasi due decenni (tra il 1925 e il 1943, per l’esattezza), nello studio delle civiltà e delle religioni ebraico-egizie.
È l’autore in persona, in una lettera del 1944 indirizzata a Clemence B. Boutelle, ad individuare nei Buddenbrook, nella Montagna incantata e nel Giuseppe le tre
tappe fondamentali della sua poetica: “Il primo era un romanzo tedesco, il secondo
un romanzo europeo, il terzo un canto mitico-umoristico dell’umanità.1”.
D’accordo con Carl Kerényi, Mann ritiene infatti che sia giunta l’ora di “un
vero e proprio rimpatrio2” “dello spirito europeo alle supreme mitiche realtà3”,
di un passaggio dalla moderna dimensione individualistica e borghese alla sfera del mitico e del tipico. E non è dunque un caso - leggiamo nel saggio dedicato
1 F. Cambi, Mito ed epicità, in T. Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, tr. it. di B. Arzeni, a cura e
con un saggio di F. Cambi, Mondadori, Milano, 2006, p. XII.
2 T. Mann - C. Kerényi, Dialogo, introduzione di G. Debenedetti, Il Saggiatore, Milano,
1963, p. 35.
3 Ibidem, p. 23.
6
Donatella Nigro
a Ur e il diluvio universale - che molti dei libri di maggior successo degli ultimi
decenni (“Mondo primigenio, saga e umanità di Dacquè, Lingua del Pentateuco
di Yahuda, La realtà degli ebrei di Goldberg, Totem e tabù di Freud, Posizione
dell’uomo nel cosmo di Max Scheler, gli stimolanti saggi di Gottfried Benn raccolti sotto il titolo Bilancio delle prospettive”) condividano, pur nella straordinaria varietà disciplinare e tematica, proprio il riferimento all’Ur, al problema
dell’origine dell’uomo e dell’originariamente umano.
“La domanda dell’uomo” – aggiunge Mann nel saggio Del libro dei libri e
«Giuseppe» – “donde provenga, dove vada, la domanda su quale sia la sua posizione nell’universo, è diventata per noi tutti in questi decenni sconvolgenti un
pressante interrogativo spirituale e religioso, posto in modo del tutto nuovo, un
problema che può sottrarsi a ogni soluzione e destinato a restare un mistero,
ma a cui il pensatore, l’antropologo, lo studioso dell’antichità, il paleontologo,
il teologo, il filosofo della società, lo scrittore, ognuno alla sua maniera e con i
suoi mezzi si sente spinto a offrire il suo contributo fattivo4”.
Tra gli anni Venti e Trenta, in un’Europa ancora scossa dalla Prima Guerra
Mondiale e prossima alla Seconda, in un’atmosfera spirituale contrassegnata
dal sentimento della fine, dal tramonto dei vecchi valori e della tradizionale
visione del mondo, si impone infatti con forza la necessità di ripensare la cultura occidentale. Non però, come pretende il pensiero irrazionalistico, per affermare il primato dell’anima e della vitalità, bensì per rifondare su nuove basi
i princìpi, ormai ritenuti imprescindibili, di libertà, individualità e ragione. Per
fare ciò - suggerisce Thomas Mann in numerosi scritti di questo periodo, tutti
da leggersi anche nel contesto della tetralogia biblica - occorre rifarsi alla lezione di tre grandi “maestri di morale” come Schopenhauer, Nietzsche e Freud,
che osando oltrepassare le certezze convenzionali, hanno svelato, al fondo della
natura umana, le tenebrose sfere della volontà, del dionisiaco e dell’inconscio,
inaugurando, così, un nuovo tipo di umanesimo, “notturno”, poiché capace di
conciliare la luce del moderno razionalismo con la notte dell’anima e del mito.
Il Giuseppe e i suoi fratelli rappresenta, per non pochi aspetti, il contributo
manniano alla fondazione di un tale umanesimo. E non sorprende, dunque, che
proprio il tema dell’Ur costituisca il Grundakkord della Discesa agli inferi, ovvero del lungo e assai complesso prologo con cui si apre il primo volume della
tetralogia: Le storie di Giacobbe.
4 T. Mann, Del libro dei libri e “Giuseppe”, in Giuseppe e i suoi fratelli, op. cit., pp.758-759.
L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
7
“Profondo è il pozzo del passato. O non dovremmo dirlo imperscrutabile? Imperscrutabile anche, e forse allora più che mai, quando si discute e ci si interroga sul passato dell’uomo, e di lui solo: di questo essere
enigmatico che racchiude in sé la nostra esistenza per natura orientata
al piacere ma oltre natura misera e dolorosa, e il cui mistero, come è
comprensibile, forma l’alfa e l’omega di tutti i nostri discorsi e di tutte le
nostre domande, dà fuoco e tensione a ogni nostra parola, urgenza a ogni
nostro problema. Perché appunto in questo caso avviene che quanto più
si scavi nel sotterraneo mondo del passato, quanto più profondamente si
penetri e cerchi, tanto più i primordi dell’umano, della sua storia, della
sua civiltà si rivelano del tutto insondabili e, pur facendo discendere a
lontananze temporali favolose lo scandaglio, via via e sempre più recedono verso abissi senza fondo5”.
In queste pagine, nel corso di una vera e propria riflessione filosofica sulla
natura del tempo e della storia, Thomas Mann ripercorre il passato della tribù
d’Israele: gli eventi mitico-storici del diluvio universale e della torre di Babele; la
vicenda di Abramo (esule, non a caso, dalla città di Ur in Caldea); l’età di Adamo,
il primo uomo, nel giardino dell’Eden; e infine la creazione stessa del mondo ad
opera di Dio che in principio era il Logos. Ma anche questo, si domanda l’autore, “era poi davvero l’inizio dell’inizio, il vero principio?”. L’origine delle cose si
configura infatti come “l’inesplorabile” che “si diverte a farsi gioco della nostra
passione indagatrice, le offre mete e punti d’arrivo illusori, dietro cui, appena
raggiunti, si aprono nuovi tratti del passato, come succede a chi, camminando
lungo le rive del mare, non trova mai termine al suo procedere, perché dietro
ogni sabbiosa quinta di dune, a cui si prefiggeva di arrivare, altre ampie distese lo attraggono più avanti, verso nuovi promontori”. Ciononostante - continua
Mann - “ci sono inizi particolari e circoscritti che formano, concretamente e
fattualmente, la scaturigine prima della tradizione di una determinata comunità
o raggruppamento etnico e religioso, così che la memoria, pur consapevole di
non poter mai scandagliare l’ultima profondità, può presso questa scaturigine
acquietarsi6”, sottraendosi alla vertigine di una discesa senza fondo.
L’inizio provvisorio da lui prescelto è, per l’appunto, l’epoca del patriarca Giacobbe e dei suoi dodici figli: uno stadio primitivo della storia in cui gli uomini non
hanno ancora chiaro il senso della propria individualità né la distinzione tra pas-
5 6 T. Mann, Le storie di Giacobbe, in Giuseppe e i suoi fratelli, op. cit., p. 5.
Ibidem, pp. 5-6.
8
Donatella Nigro
sato, presente e futuro. Emblematica è, a tal riguardo, la figura di Eliezer, il servo
più vecchio: era infatti tradizione - spiega l’autore - “che un tale tipo di figlio [avuto da un’ancella] fosse un giorno dichiarato libero e si chiamasse Eliezer. […] ce
n’era sempre stato uno nella cerchia dei discendenti spirituali di Abramo, vi aveva
sempre svolto la parte di maggiordomo e di primo servo e, al caso, era stato anche
inviato a chiedere la mano della sposa per il figlio della Giusta, e secondo la regola
il capo della famiglia aveva poi dato moglie anche a lui e da lui erano nati due figli,
Damasek ed Elinos. In breve, egli era un’istituzione7”. E dunque, così come Giacobbe, parlando di lui, soleva riferirsi sia al suo maggiordomo sia a quello di Abramo,
allo stesso modo Giuseppe era “ben lontano dal distinguere con solare esattezza
fra Eliezer, l’antichissimo servo, e il suo vecchio maestro; e aveva del resto tanto
minor motivo di farlo in quanto lo stesso Eliezer non lo faceva, ma, parlando di sè,
intendeva in gran parte Eliezer, il servo di Abramo8”.
“L’io del vecchio - leggiamo infatti nelle Storie di Giacobbe - non sembrava
nettamente circoscritto ma stava, per così dire, come aperto indietro, verso
il passato, traboccava in un tempo anteriore, posto fuori dai limiti della sua
personalità, e così facendo si appropriava di un materiale di fatti e di esperienze che nella forma della rievocazione e del ricordo, secondo la logica e la
grammatica, avrebbe propriamente richiesto la terza, non la prima persona.
Ma che cosa significa «propriamente» nel nostro caso? Forse l’io umano è
solidamente in sé chiuso, ermeticamente isolato nei suoi limiti temporali e
corporei? Molti elementi che lo costituiscono non appartengono al mondo
prima e fuori di lui e l’affermazione che ciascuno è solo se stesso non è forse
un’ipotesi fatta per comodità e per ordine ma deliberatamente ignara di tutti
i punti intermedi che congiungono la coscienza del singolo con la coscienza
universale? Il concetto di individualità rientra infine nella stessa sfera dei
concetti di unità, totalità e generalità. La distinzione tra spirito universale
e spirito individuale non ebbe sempre, nemmeno approssimativamente, la
stessa influenza e lo stesso valore che ha nel nostro tempo, dal quale ci siamo allontanati per raccontare di un altro ormai remoto, il cui linguaggio
ci offre un’immagine fedele della sua profonda vita spirituale, quando per
l’idea di «personalità» e «individualità» lo vediamo usar parole semplici e
sobrie come «religione» e «fede»9”.
T. Mann, Il giovane Giuseppe, in Giuseppe e i suoi fratelli, op. cit., p. 40.
T. Mann, Le storie di Giacobbe, op. cit., p. 116.
9 Ibidem, pp. 116-117.
7 8 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
9
È proprio a Giacobbe e Giuseppe (i prediletti da Dio, i portatori della primogenitura spirituale) che spetta, però, il compito di inaugurare una nuova e più
moderna concezione dell’io che, contrapponendosi sia alla natura che al collettivo, consenta la fondazione di un’autentica eticità oltre che della peculiare
concezione occidentale della storia (intesa non più ciclicamente, quale eterno
ritorno dell’identico, bensì come sviluppo e progresso rettilineo). Ed è proprio
l’antitesi di primitività e modernità a percorrere, come un filo rosso, l’intera tetralogia, definendo la progressiva spiritualizzazione della civiltà ebraica quale
graduale distacco dal tempo delle madri (caratterizzato da promiscuità sessuale, culto della morte e indifferenza al peccato) e accoglimento dell’astratta religione del Padre, con la sua severa e innaturale legge morale.
Esemplare, a tal proposito, è l’episodio del terzo volume, il Giuseppe in Egitto, che vede protagonisti i due augusti genitori di Potifar: Huij e Tuij.
Il padrone di Giuseppe e Flabellifero alla destra del Faraone, Potifar, conduce un’esistenza drammaticamente dimidiata: tanto meravigliosa e ricca di
onori alla luce del giorno, quanto vuota e frustrante nel privato, al calar della
notte. Appena nato, egli è stato infatti evirato, e il suo matrimonio con la bella
aristocratica Mut-em-enet ha dunque solo un valore formale, di prestigio sociale, non potendo essere realmente consumato. Ma perché, si domanda Giuseppe, la sua virilità ha dovuto essere sacrificata?
I due coniugi e fratelli, Huij e Tuij, avevano giocato insieme tutti i giochi della vita, a imitazione degli dèi, che “generano tutti nel proprio sangue e si congiungono in matrimonio con le loro madri e sorelle10”, in un amplesso simile a
“quello in cui la profondità della palude abbraccia se stessa e la materna materia primordiale gorgogliante si autofeconda11”. Ed era stato Huij, il marito, ad
accendere per primo “nella sacra oscurità l’idea del sacrificio propiziatorio12”.
“Noi vivevamo a imitazione degli dèi e dei re - afferma, rivolgendosi alla
moglie - in piena armonia col pio costume, ed eravamo una gioia per gli
uomini. E tuttavia in me, uomo, c’era una spina, una pena, a causa della
vendetta della luce. Poiché magnifica è la luce, cioè di natura maschile, essa
odia il gorgoglio del materno buio primordiale, a cui il nostro modo di generare era ancora vicino, ancora attaccato al suo cordone ombelicale. Vedi,
bisogna recidere il cordone ombelicale, affinché il vitello si stacchi dalla vacca e diventi il toro della luce! Quali dottrine siano ancora valide, se ci sia un
T. Mann, Giuseppe in Egitto, in Giuseppe e i suoi fratelli, op. cit., p. 245.
Ibidem, pp. 244-245.
12 Ibidem, p. 240.
10 11 10
Donatella Nigro
tribunale dopo che avremo emesso l’ultimo respiro, questo non è affatto
importante. Importante è solo la questione dell’eone, e se le idee, in base a
cui viviamo, siano ancora all’ordine del giorno. Solo questo è importante,
dopo la necessità di saziarsi. Ma ora nel mondo è venuto il fatto nuovo che
io presentivo da tempo: il maschile vuole rompere il cordone ombelicale tra
sé e la vacca e porsi sul trono del mondo come signore sopra la materia, il
femminile-materno, per fondare il regno della luce13”.
Con l’evirazione del figlio primogenito, essi avevano dunque inteso propiziarsi il nuovo eone spirituale, destinando Potifar all’avvenire splendido ma
vuoto di camerlengo del sole; e sua moglie, Mut-em-enet, a quello di casta sacerdotessa della luna, costretta a sacrificare la sua natura innata di madre primordiale.
Come non cogliere in questo brano la presenza di motivi e suggestioni provenienti dal pensiero bachofeniano?
Anche il filosofo di Basilea (come è suggerito in diversi studi recenti che
ne analizzano l’influenza sull’opera manniana14) aveva descritto infatti l’evoluzione dell’umanità quale passaggio dal regime matriarcale al predominio del
Padre; come trionfo, cioè, della luce dello spirito sulle oscure forze della vita.
E nel riprendere tale suggestione, Thomas Mann intende contrapporsi ai suoi
seguaci e riscopritori di inizio Novecento (Alfred Baeumler in testa) che, lungi
dal leggere in tale passaggio un progresso e un’evoluzione, indicano proprio
nel riferimento all’anima e agli istinti originari la via d’uscita dalla decadenza
contemporanea.
Già nel Rendiconto parigino del 1925, Mann contesta e smaschera nelle sue profonde implicazioni politiche l’introduzione baeumleriana alla nuova edizione degli
scritti di Bachofen (vero e proprio “libro nel libro” - come la definisce Paolo Chiarini - che “forniva di quegli scritti una interpretazione ambiguamente seducente per
i suoi risvolti anti-classici e insieme post-romantici e post-nietzscheani15”).
“Non si può leggere nulla di più interessante - annota Thomas Mann - è
un lavoro magnifico e profondo, e chi conosce il soggetto ne resta affascinaIbidem, p. 247.
Particolarmente in E. Galvan, Zur Bachofen-Rezeption in Thomas Manns “Joseph-Roman”, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1997. Ma anche nell’opera a cura di M. Baeumler, H. Brunträger e H. Kurzke: Thomas Mann und Alfred Baeumler. Eine Dokumentation,
Königshausen & Neumann, Würzburg, 1989.
15 P. Chiarini, Intersezioni weimariane: Thomas Mann e Johann Jakob Bachofen, in “Cultura
tedesca”, settembre, 1994, p. 62.
13 14 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
11
to. Ma che sia una buona azione, cioè un’azione pedagogica, che giovi alla
vita, empir oggi le orecchie ai tedeschi con tutto questo entusiasmo di tipo
notturno, questo complesso «alla Goerres» di terra, popolo, natura, morte e
passato, questo oscurantismo rivoluzionario così acerbamente caratterizzato, con la muta insinuazione che tutto ciò è di nuovo all’ordine del giorno,
che siamo di nuovo a quel punto, che non si tratta tanto di storia quanto di
vita, di gioventù, di passato - ecco la domanda che rende inquieti16”.
Il Giuseppe e i suoi fratelli - scrive ancora Chiarini - è appunto “la risposta di Mann alla domanda che rende inquieti17”. Iniziato l’anno successivo al
Rendiconto parigino (nel 1926), esso costituisce, secondo Helmut Koopmann,
“un tentativo unico di confutare la dottrina bachofeniana della ginecocrazia18”.
Laddove Bachofen aveva collocato il matriarcato e il culto della madre all’origine della civiltà, nel Giuseppe è il Padre dei padri (Dio in persona) a costituire
il fondamento ultimo della storia, e sono i patriarchi (Abramo, Giacobbe e poi
lo stesso Giuseppe) a determinare, come si è visto, il progresso spirituale della
loro stirpe.
Ciononostante, nel 1927 (quando la tetralogia biblica è solo agli inizi della
sua gestazione), Thomas Mann viene coinvolto da Benedetto Croce nella polemica contro i seguaci novecenteschi del Bachofen, condotta nello scritto intitolato Il Bachofen e la storiografia afilologica
“In Germania - nota il Croce in queste pagine - è venuta, non dirò il tempo,
ma l’ora del Bachofen, morto più di quarant’anni fa, e la cui opera fondamentale, Das Mutterrecht, rimase a lungo (tranne in qualche ristretto circolo) poco
considerata e quasi ignorata19”. Bachofen, che Croce definisce quale “raccomandatore e risvegliatore del senso del remoto e barbarico20”, ha avuto certo
il merito di intendere il diverso che il primitivo rappresenta, seguendo in ciò il
principio di Vico secondo cui “appena intender si può, affatto immaginare non
si può, come pensassero i primi uomini che fondarono l’umanità gentilesca21”.
16 T. Mann, Rendiconto parigino, in Scritti storici e politici, prefazione di A. Andersch, tr.
it. di B. Arzeni, C. Baseggio, M, Battaglia, L. Mazzucchetti, E. Pocar, L. Scalero, Mondadori,
Milano, 1957, p. 200.
17 P. Chiarini, Intersezioni weimariane: Thomas Mann e Johann Jakob Bachofen, op. cit.,
p. 66.
18 H. Koopmann, Der schwierige Deutsche. Studien zum Werk Thomas Manns, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1988.
19 B. Croce, Il Bachofen e la storiografia afilologica, in Varietà di storia letteraria e civile. Serie
I, Bari, 1935, p. 302.
20 B. Croce, La filosofia del Bachofen in Conversazioni critiche. Serie IV, Bari, 1932, p. 66.
21 B. Croce, Il Bachofen e la storiografia afilologica, op. cit., p. 306.
12
Donatella Nigro
Ma si è reso poi colpevole di un ingiustificabile rifiuto della filologia che, sorto
dalla legittima esigenza di opporsi all’eccessivo razionalismo positivistico, lo ha
portato ad accogliere prospettive misticheggianti e del tutto fantasiose: “Certo,
forte è la seduzione, quando si ha la mente tutta presa da un’ipotesi luminosa
e nuova, a saltare il fosso della filologia; ma, fatto una volta quel salto, non si
torna più indietro: il paese, a cui quel salto conduce, non è più storico o critico,
e per ciò stesso è incantato e incantevole22”. Il paese a cui quel salto conduce
è, per l’appunto, la storiografia afilologica o misofilologica, al cui carattere divinatorio, arazionale e religioso sarebbe da imputare, nell’ottica di Croce, la
riscoperta bachofeniana entro le più diverse discipline e branche del sapere.
Non solo il filosofo Klages e il geologo Dacquè, ma anche gli scrittori Hugo von
Hofmannstahl e Thomas Mann (ed è questo che nel presente contesto maggiormente ci interessa) sarebbero stati “colpiti - infatti - dalle grandiose figurazioni
che tralucono nelle sue pagine, dai lampi che sembrano rischiarare bui recessi
dell’umanità23”. “Sembrano”, scrive non a caso il Croce, poiché, come si legge in
alcune celebri pagine della Storia come pensiero e come azione, l’origine ultima
della storia sfugge alla nostra comprensione. “Non essendo nessuna cosa nata
da sé, ma avendo ognuna un padre, essa ci riporta indietro, in un fondo più fondo, nelle profondità primordiali e negli abissi del passato24”. E lo storico è chiamato dunque a scegliere, di volta in volta, un inizio circoscritto, illuminando,
in base all’interesse contemporaneo, una porzione di quell’ “emisperio di tenebre che cinge la nostra luce, la quale non sarebbe luce se non avesse quell’emisperio”. Coloro che pretendono, invece, di ricostruire la totalità estensiva della
storia, retrocedendo dalla rivoluzione francese sino alla cellula e alla nebulosa
originaria, e intuendo, con una sorta di illuminazione mistica, il principio primo della vita, non solo commettono un errore metodologico, ma dimostrano
anche di fraintendere il senso autentico del divenire storico, interpretandolo in
chiave metafisica e irrazionalistica.
È in linea (ma, al contempo, in conflitto) con la riflessione crociana intorno
ai rischi del primitivismo, che si colloca l’intera indagine di Ernesto de Martino,
a partire dal suo primo libro del 1940.
“La nostra civiltà è in crisi”, leggiamo nell’introduzione a Naturalismo e
storicismo nell’etnologia . “Un mondo accenna ad andare in pezzi, un altro si
annunzia”. E lo studio del mondo primitivo si impone con urgenza sempre
maggiore. “Certe forme recentissime di prassi politico-religiosa, certe dispoIbidem, p. 307.
Ibidem, p. 303.
24 B. Croce, La storia come pensiero e come azione, Laterza, Bari, 1978, p. 250.
22 23 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
13
sizioni d’animo strane, certi appelli ad esperienze ineffabili (si pensi al Gemüt
che stringe in unità sentimentale il suolo e la razza, la razza e il sangue) non si
spiegano abbastanza con la storia del secolo XIX, e, in generale, con la storia
della civiltà nostra. Non si spiegano del tutto con tale storia la «bramosia di lontane esperienze ataviche» in un Möser, in un Wagner o in un Bachofen, non si
dichiara completamente, per una mente aperta soltanto a esperienze europee,
la vibrazione d’accento che molti dotti tedeschi conferiscono al prefisso ur”.
Manca infatti un filo per la comprensione dell’ordito della contemporaneità, “e
il filo che manca è per l’appunto quello del cosiddetto mondo primitivo, di quel
mondo che oggi più che mai dà segni di presenza, simile a tradizione quasi inaridita che rinverdisca, simile a linguaggio liturgico quasi obliato che ritorni in
piena evidenza alla memoria25”.
Se da un lato, si richiede dunque una correzione dello storicismo crociano
(che, avendo escluso dai suoi interessi l’indagine della preistoria, si è rivelato
incapace di comprendere la crisi spirituale della contemporaneità), è dall’altro
necessario rifarsi proprio alla lezione del Croce poiché, come leggiamo nell’introduzione al Mondo magico (l’opera Leucesti-miama del 1948), solo un’autentica “pietà storica verso l’arcaico” può costituire una valida “profilassi contro
l’idoleggiamento antistorico degli arcaismi26”.
Thomas Mann, da parte sua, pur se sedotto dalla discesa agli inferi e dalla
ricerca dell’Ur, condivide con Croce e de Martino la ferma opposizione alla “torbida corrente” dei precursori del fascismo, colpevoli di aver abusato delle teorie
bachofeniane (ma anche nietzscheane), piegandole alle esigenze politiche del
momento.
Nel 1934 (due anni prima, Benedetto Croce gli aveva dedicato la sua Storia
d’Europa, scorgendo in lui non più un temibile scrittore della crisi, bensì un
compagno nella difesa della “nobiltà dello spirito”), scrive infatti a Carl Kerényi:
“Non sono amico del movimento (rappresentato in Germania soprattutto da Klages) di ostilità allo spirito e all’intelligenza. Assai per tempo l’ho temuto e combattuto perché ne avevo viste tutte le conseguenze
brutali e antiumane, prima ancora che si manifestassero… Quel “ritorno
dello spirito europeo alle realtà supreme, alle realtà mitiche”, del quale
Lei parla con tanta efficacia è in verità una grande e buona causa nelIbidem, pp. 12-13.
E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Universale Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 5.
25 26 14
Donatella Nigro
la storia dello spirito, e io posso vantarmi di avervi parte, in certo qual
modo, con la mia opera. Ma confido nella Sua comprensione se Le dico
che alla moda «irrazionale» si accompagna spesso la smania di sacrificare, di buttare maliziosamente a mare conquiste e principii che non solo
rendono europeo l’Europeo, ma persino uomo l’uomo27”.
E nello stesso anno, annota nel suo originale diario di viaggio Una traversata
con Don Chisciotte:
“Quale narratore io sono giunto al mito; però, con immenso scandalo
degli pseudo barbari e dei primitivi, ho cercato di umanizzarlo, tentando
una fusione tra mito e umanità che a me pare più feconda per l’avvenire
dell’attuale, fanatica lotta contro lo spirito, in cui si cerca di adulare il
presente calpestando con grande zelo la ragione e la civiltà28”.
Cosa sia il mito fascista e quali siano le sue implicazioni politiche, Thomas
Mann lo chiarirà in alcune celebri pagine del suo ultimo grande romanzo, Il
Doctor Faustus: per l’esattezza, nel capitolo XXXIV, dedicato alla descrizione
del salotto monacense di Sixtus Kridwiss.
Siamo negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale e il sentimento dominante - scrive Mann per bocca di Serenus Zeitblom, l’umanista - è di
trovarsi “al termine di un’epoca la quale non solo comprendeva il secolo decimo nono,
ma risaliva fino allo spirare del medio evo, alla rottura dei legami scolastici, all’emancipazione dell’individuo, alla nascita della libertà, un’epoca che dovevo veramente considerare quella della mia più ampia patria spirituale, l’epoca insomma dell’umanesimo
borghese29”. I valori e gli ideali di questa lunga epoca, considerati un tempo assoluti e
dunque eterni, sono ormai al tramonto, ritenuti sorpassati nel loro facile ottimismo. La
centralità dell’individuo, innanzitutto, messa in discussione a partire dalla prima guerra mondiale (che, in quanto prima esperienza di “mobilitazione totale” - come scrive
Jünger nel suo Operaio - vede imporsi la nuova figura del tipo con la sua visione del
mondo radicalmente antiborghese). In secondo luogo, l’ideale della libertà, criticato
dai convitati del salotto Kridwiss in quanto concetto vuoto e contraddittorio, che per
sussistere ha bisogno di negare se stesso, rendendo gli altri schiavi. E infine la ragione,
T. Mann - C. Kerényi, Dialogo, op. cit., pp. 25-26.
T. Mann, Una traversata con Don Chisciotte, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, a cura di
A. Landolfi, con un saggio di C. Magris, Mondadori, Milano, 1997, pp. 826-827.
29 T. Mann, Doctor Faustus, tr. it. e introduzione di E. Pocar, Mondadori, Milano, 1980,
pp. 414-420.
27 28 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
15
accusata, nietzschenamente, di allontanare l’uomo dalla realtà delle cose, rendendolo
sì eccezionale tra i viventi, ma in quanto animale malato.
Le Réflexions sur la violence di Sorel sono il libro più acclamato entro la
cerchia Kridwiss che riconosce all’autore francese di aver intuito anzitempo
“che nel secolo delle masse la discussione parlamentare doveva risultare assolutamente inadatta a formare una volontà politica e che in avvenire bisognava
sostituirvi un vangelo di finzioni mitiche destinate a scatenare e a mettere in
azione le energie politiche come primitivi gridi di battaglia. La rude ed eccitante profezia del libro era in sostanza: che i miti popolari o, meglio, fabbricati
per le masse, sarebbero diventati il veicolo dei moti politici: fiabe, fantasie e
invenzioni che non occorreva contenessero verità razionali o scientifiche per
fecondare, per determinare la vita e la storia, e dimostrarsi in tal modo realtà
dinamiche30”.
Il Giuseppe e i suoi fratelli si fonda, invece, su una nozione radicalmente opposta di mito, inteso - per dirla con Kerényi - non quale “quid dinamico” che
“ha un potere, afferra la vita e la plasma”, bensì come “un’opera comune dell’uomo e del suo mondo31”, quale facoltà, insomma, autenticamente umana.
Il mezzo prescelto per tale “rifunzionalizzazione” del mito è la psicoanalisi freudiana: “Il mito vissuto è proprio il principio epico del mio romanzo”,
leggiamo nel lungo saggio dedicato a Freud e l’avvenire. “E io vedo bene che
nel momento in cui, da narratore di vicende borghesi e individuali, mi sono
rivolto a ciò che è mitico e tipico, il mio rapporto con la sfera psicoanalitica è
entrato, per così dire, in una fase acuta32”. La ragione di ciò sta nell’intrinseca
connessione di mito e psicologia: quando l’analisi si addentra nelle profondità
della psiche individuale, essa giunge inevitabilmente a quel livello che Jung ha
definito come “inconscio collettivo”, quel fondo di memorie mitiche e archetipiche che accomunano l’intera umanità. E non è dunque un caso che lo stesso
Freud abbia considerato la medicina e la psicoterapia (scienze che si occupano dell’individuo) quali “vie indirette” per indagare anche la storia umana e in
particolare “le origini della religione e della morale33”. Tale avvicinamento tra
analisi del singolo e analisi della civiltà, “trova la sua più grandiosa espressione
nel libro scritto nell’ora più alta della sua vita, Totem e tabù34”. In esso, l’espressione “psicologia del profondo” contiene un doppio significato, psicoanalitico
Ibidem, p. 435.
T. Mann - C. Kerényi, Dialogo, op. cit., p. 121.
32 T. Mann, Freud e l’avvenire, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, op. cit., p. 1394.
33 Ibidem, p. 1394.
34 Ibidem, p. 1394.
30 31 16
Donatella Nigro
e temporale: allude, cioè, sia ai “fondamenti primordiali dell’anima umana”
che all’ “età primordiale, quel pozzo profondo dei tempi in cui il mito è di casa
e costituisce le norme e le forme prime della vita35”. Ed è proprio nel pozzo del
passato, insondabile poiché infinitamente profondo, che Mann ci conduce nel
prologo delle Storie di Giacobbe. Fino a un tempo remoto in cui, pur se tra uomini più simili a noi che ai bestioni dei primordi, si manifesta in tutta la sua
forza il nesso fondamentale di mito e psicologia.
“Mito è fondazione di vita”, leggiamo ancora in Freud e l’avvenire. “E’ lo schema senza tempo, la formula religiosa in cui la vita, dopo aver attinto dall’inconscio i tratti del mito e averli riprodotti, confluisce36”. La vita, per dirla in altri
termini, si limita a ripetere il mito, imitando quello schema senza tempo che
ciascuno possiede entro la sfera dell’inconscio, agendo, per così dire, secondo
un formula “religiosa”. Intesa in tal modo, essa non è mai assoluta novità, bensì
un costante ricalcare orme altrui, recitare una parte, rappresentare un tipo:
“Ciò che con questo modo di vedere si acquista è lo sguardo per la
verità più alta che si mostra nel reale, la sorridente sapienza di ciò che è
eterno, immutabile, sempre valido, dello schema nel quale e secondo il
quale vive anche chi crede di vivere in maniera assolutamente individuale, nell’ingenua convinzione di essere il primo e l’unico, non sospettando
nemmeno come la sua vita sia invece formula e ripetizione, un procedere su orme già mille volte calcate. Il carattere è un ruolo mitico che noi
recitiamo nell’ingenua convinzione della sua unicità e originalità, come
nostra iniziativa e nostra personalissima invenzione. Ma la sicurezza e
la dignità con le quali ogni attore, appena salito alla ribalta, rappresenta
quel ruolo, non gli derivano, come egli crede, dalla sua unicità e originalità, bensì, all’opposto, dalla coscienza più profonda di rappresentare qualcosa di legittimo, conforme a un’antica norma, e di comportarsi
quindi nel suo genere, sia esso buono o cattivo, nobile o ripugnante, in
modo esemplare. Se tutta la sua realtà fosse unicamente in un presente
irripetibile, egli non saprebbe come comportarsi, non avrebbe nulla su
cui poggiare: perplesso, impacciato confuso di fronte a se stesso, non
saprebbe né muoversi né atteggiarsi. Invece la sua dignità e la sicurezza
della sua recitazione si fondano appunto sull’inconscia certezza che con
lui qualcosa di eterno torna alla luce e diventa presente; è una dignità
35 36 Ibidem, p. 1395.
T. Mann, Freud e l’avvenire, op. cit., p. 1395.
L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
17
mitica, retaggio di tutti, anche del carattere più indegno e più misero, ed
è una dignità naturale, perché deriva dall’inconscio37”.
Vivere calcando le orme è un’esperienza che riguarda ciascuno, anche nella
contemporaneità: molti di noi, infatti, “vivono anche oggi un tipo biografico
determinato, il destino di una classe, di un ceto, di una professione; la libertà
dell’uomo di foggiare la propria vita è palesemente limitata e ristretta da quel
rapporto impegnativo che chiamiamo «vita vissuta»38”. Ma la cultura occidentale, dal cristianesimo in poi, si è fondata sul primato del concetto di individuo
e sui valori ad esso connessi di libertà, responsabilità morale, progresso. Una
teoria come quella appena illustrata non considera, invece, l’azione come frutto
di una libera scelta. Ciò che in essa conta sono schemi impersonali e atemporali, a cui l’uomo deve rifarsi fedelmente se vuol esser ritenuto “degno”, indipendentemente dalla natura del ruolo interpretato. E dunque una tale nozione
di mito vissuto e vita come mito si ritroverebbe, in forma autentica, solo nella
cultura pre-cristiana del mondo antico.
Riprendendo Ortega y Gasset, Mann scrive che l’uomo dell’antichità “prima
di fare qualcosa, indietreggiava di un passo, come il torero che prende lo slancio per il colpo mortale. Nel passato egli cercava un esempio in cui calarsi come
un palombaro nel suo scafandro per poi, così deformato e nello stesso tempo
protetto, immergersi nel problema del presente39”. Alessandro, per esempio,
seguì le orme di Milziade, e Cesare a sua volta volle imitare Alessandro. Cleopatra, poi, non solo visse in tutto e per tutto come reincarnazione di “IshtarAstarte, Afrodite in persona, come ben vede Bachofen nel suo studio sul culto
bacchico e la cultura dionisiaca40”. Ma anche la sua morte “rimanda a ciò: si
racconta infatti che si sia uccisa ponendosi un aspide sul petto. Ma il serpente
era l’animale sacro a Ishtar e dunque anche con la morte ella diede prova della
sua autoconsapevolezza mitica. […] Non c’è alcun dubbio che fu una grande
donna, «grande» nel senso antico, una donna che sapeva chi era e su quali orme
incedeva!41”. È la ripetizione mitica, infatti, a conferire grandezza e dignità.
Colui che vive senza calcare orme altrui è sradicato, privo di fondamento e di
legittimità. Il mito, viceversa, “legittima la vita, e solo in lui e attraverso lui la
vita trova la propria giustificazione e consacrazione”. Persino le celebri parole
Ibidem, pp. 1395-1396.
Ibidem, pp. 1393-1394.
39 Ibidem, p. 1397.
40 Ibidem, p. 1396.
41 Ibidem, p. 1397.
37 38 18
Donatella Nigro
pronunciate da Cristo sulla croce non sarebbero state, come nota Max Weber,
uno spontaneo urlo di dolore: “Quel suo «Eli, Eli, lamma sabactani?» non fu assolutamente, come poteva sembrare, un grido di disperazione e delusione, ma
al contrario la testimonianza della più alta consapevolezza messianica. Queste
parole non sono infatti «originali», non sono un grido spontaneo, ma il principio del ventiduesimo salmo, che dall’inizio alla fine è un’annunciazione del
Messia. Gesù citava un passo della Scrittura e con ciò voleva dire: «Sì, io sono
quello!»42”.
Oltre a costituire l’imprescindibile fondamento teorico del Giuseppe e i suoi
fratelli (i cui personaggi - come già accennato - sono uomini ancora incapaci di
distinguere tra io e non-io, presente e passato, azione autentica e ripetizione mitica), la psicoanalisi freudiana ha però un altro e ben più alto merito agli occhi di
Thomas Mann. Essa - leggiamo in Freud e l’avvenire - costituirebbe “quella forma
fenomenica dell’irrazionalismo moderno che si oppone inequivocabilmente a ogni
abuso reazionario43”; vera erede del Romanticismo, si rivela, al contempo, antirazionale e rivoluzionaria: da un lato, infatti, il suo interesse va alle sfere oscure della
psiche, a quell’Es che, pur restando in buona parte inconoscibile, ne costituisce la
porzione più vasta e profonda; dall’altro, invece, essa si pone un fine autenticamente illuministico: definita dallo stesso Freud come “un nuovo tratto di terra strappato dalla scienza alla superstizione e al misticismo44”, l’analisi dei sogni e delle nevrosi mira infatti alla vittoria finale dell’intelletto sull’inconscio e alla costituzione,
dunque, di un nuovo “ordine vitale, assicurato dalla consapevolezza, fondato sulla
libertà e sulla verità”, che non si possa però “tacciare di serena superficialità” poiché “passato attraverso troppe cose45”.
Sigmund Freud, che in questo scritto viene definito come “una delle pietre
angolari di quella nuova antropologia che ora si va in vari modi costruendo, e
quindi uno dei fondamenti dell’avvenire, asilo di una umanità più libera e saggia46”, non è stato però il primo a tentare una conciliazione tra intelletto e istinti: Mann lo reputa infatti “un autentico figlio del secolo degli Schopenhauer
[…] al centro del quale è nato47”. Certo, egli non ha letto nulla del filosofo della
volontà, né tanto meno ne ha conosciuto il più illustre discepolo: Nietzsche.
Ma nel pensiero di entrambi risaltano “a ogni passo lampi precorritori delle
Ibidem, p. 1398.
Ibidem, p. 1368.
44 T. Mann, Freud e l’avvenire, op. cit., p. 1403.
45 T. Mann, La posizione di Freud nella storia dello spirito moderno, in Nobiltà dello spirito
e altri saggi, op. cit., p. 1375.
46 T. Mann, Freud e l’avvenire, op. cit., p. 1402.
47 Ibidem, p. 1384.
42 43 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
19
scoperte freudiane48”, suscitatori di scandali pari a quelli prodotti dalla teoria
dell’inconscio eppure, come questa, mossi non da “antiumana malvagità, che
è il tristo motivo delle moderne teorie nemiche dello spirito, ma […] da quel
severo amore della verità proprio di un secolo che combatteva l’idealismo per
l’idealismo49”. Il contributo originale di Freud consisterebbe dunque nell’aver
accolto le suggestioni presenti nei maggiori spiriti dell’epoca (quelli proiettati
all’avvenire, piuttosto che al passato), conferendo loro, attraverso l’inaugurazione della psicoanalisi, una forma scientifica che le rendesse capaci di influire
concretamente sulla realtà.
“Come psicologo della volontà, Schopenhauer è il padre della moderna psicologia50”, scrive Mann nel contributo dedicato al filosofo della sua gioventù.
“L’oscuro regno della volontà di Schopenhauer si identifica completamente con
ciò che Freud chiama l’«inconscio», l’«Es»; così come, d’altro lato, l’«intelletto»
schopenhaueriano corrisponde perfettamente all’«Io» freudiano, a quella parte
dell’anima rivolta verso il mondo esterno51”. Schopenhauer è stato il primo ad
individuare nella volontà, e non più nella ragione, “la cosa in sè52” dell’essere,
la sorgente di tutti i fenomeni e della vita in genere, di cui l’uomo rappresenta
il gradino più alto. L’intelletto, pur illudendosi di esserne il signore, è stato in
realtà creato per servirla e la sua condizione, come leggiamo a proposito dell’Io
freudiano, “è quasi commovente e davvero inquietante: esso è una piccola parte
che sporge in fuori, vigile e illuminata, dell’Es, pressappoco come l’Europa è
una piccola e vivace provincia della grande Asia53”.
Muovendo da tali premesse, la filosofia di Schopenhauer non può che risultare
estremamente pessimistica: la volontà che dirige e determina ogni nostra azione è
infatti “l’opposto di una condizione di appagamento” poiché, tendendo sempre a
qualcosa, essa “è per sua natura fondamentalmente infelice”, e finanche il conseguimento dell’oggetto ambìto non procura che una gioia momentanea destinata a
convertirsi rapidamente in noia e nuovo desiderio. Un mondo della volontà, dunque (attribuendo valore soggettivo alla preposizione della, poiché è la volontà stessa
a produrre il mondo, rappresentandolo), “non può essere altro che un mondo di
dolore54” e la vita stessa “una specie di assaggio55” dell’inferno. Ciononostante, il
Ibidem, p. 1380.
Ibidem, p. 1384.
50 T. Mann, Schopenhauer, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, op. cit., p. 1289.
51 Ibidem, p. 1290.
52 Ibidem, p. 1245.
53 T. Mann, Freud e l’avvenire, op. cit., p. 1386.
54 T. Mann, Schopenhauer, op. cit., p. 1248.
55 Ibidem, p. 1251.
48 49 20
Donatella Nigro
pessimismo di Schopenhauer non sfocia in quella malignità antiumana che esulta
dicendo “Viene la fine, la fine viene!”; esso è anzi indissolubilmente connesso a un
vero e proprio “culto dell’uomo” che, in quanto “più alta ed evoluta oggettivazione
della volontà” ed “essere conoscitivo per eccellenza56”, è il solo vivente che possa
ambire a emanciparsi dalla volontà stessa, prima con l’arte, poi con l’etica, e infine
con l’ascesi. Gli asceti sono appunto coloro che sollevando l’ingannevole “velo di
Maia”, hanno compreso che “la grande illusione della disparità e ingiustizia delle
sorti, dei caratteri, delle situazioni, dei destini umani si fonda sul principium individuationis57”, vale a dire sul pregiudizio occidentale di una distinzione netta fra
“me” e “te”. “All’io prigioniero del principium individuationis, avvolto nel velo di
Maia, tutti gli altri esseri appaiono come larve e fantasmi […]. Tutto dipende da te,
tutto è in relazione a te. Tu sei l’unico essere che veramente conti ed esista, non è
vero? Tu sei il centro del mondo (e tu lo sei, il centro del tuo mondo!) e tutto è in relazione unicamente al tuo benessere58”. L’etica e l’ascesi consentono però di superare tale prospettiva, che conferma la verità del detto “homo homini lupus”, poiché,
se perseguendo la bontà già si riesce a oltrepassare la distinzione tra i vari “sé” del
mondo, imparando a percepire come proprio il dolore di ogni vivente, l’atarassia
dell’asceta costituisce l’estrema redenzione umana visto che in essa un’individuazione della volontà giunge a rinnegare la sua stessa sostanza.
È chiaro che alla base della proposta schopenhaueriana ci sia il rifiuto del
concetto di individualità su cui da sempre si fonda la civiltà occidentale; eppure
Thomas Mann, che in quanto paladino della “nobiltà dello spirito” non ha mai,
al pari di Croce, strizzato l’occhio all’Oriente, definisce la sua “umanità pessimistica ricca di avvenire59”. Un umanesimo pessimistico rappresenta quasi una
contraddizione in termini, poiché “l’umanesimo, di solito, ha invece una coloritura fondamentalmente ottimistico-retorica”; ma mentre l’ottimismo sarebbe
quanto meno inappropriato nella drammatica età contemporanea, un pensiero
che riconosca il primato dell’uomo proprio in nome della sua capacità di soffrire (“mano a mano che la conoscenza acquista chiarezza e la consapevolezza
aumenta, cresce anche il dolore, che tocca quindi nell’uomo il suo grado più
alto”), è una novità che “ha in sé, per quel che riguarda l’atteggiamento spirituale, molti elementi di futuro60”.
Ibidem, p. 1280.
Ibidem, p. 1259.
58 Ibidem, p. 1261.
59 Ibidem, p. 1291.
60 Ibidem, p. 1281.
56 57 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
21
Nietzsche, a sua volta, “significa un passo avanti nel dolore, nel raffinamento, nella modernità; specie in quel campo che come nessun altro lo rivela allievo
di Schopenhauer, vale a dire la psicologia61”. In lui, “nostro maestro morale62”
(come Mann lo definisce nella prolusione a un concerto in suo onore), la psicologia rappresenta la prima delle passioni, tanto è vero che le sue più grandi
opere, Al di là del bene e del male e La genealogia della morale, si fondano sull’asserto psicologistico di Schopenhauer che “non è l’intelletto a creare la volontà,
ma viceversa”. Ciò che lo ha spinto a capovolgere tutti i valori, dimostrando che
quelli buoni derivano dai cattivi, e che i cattivi sono in realtà “nobili e vitali63”,
è proprio la scoperta che la vita (dominata dalla volontà) è superiore alla verità
(che è di pertinenza dell’intelletto e della morale), per cui compito del filosofo
sarebbe la difesa della vita contro coloro che, sia in nome degli ideali ascetici
promossi dalla religione ebraico-cristiana, sia del primato dell’intelletto sostenuto in Occidente da Socrate in poi, l’hanno indebolita facendo della storia occidentale un processo di graduale declino e degenerazione.
Tale interpretazione si spiega, secondo Thomas Mann, “storicamente, come
il prodotto di una situazione filosofica momentanea, come il correttivo di una
saturazione razionalistica64”. Ma essa contiene due valutazioni errate, da cui
sono dipese conseguenze fatali per la Germania e l’Europa intera. Da un lato,
Nietzsche ha ricondotto ad unità l’ascetismo religioso e il razionalismo moderno, vedendo nel primo la culla del secondo; dall’altro, egli ha frainteso il
“rapporto di forza, regnante sulla terra, fra istinto e intelletto”. A differenza di
Schopenhauer e Freud, che descrivono fedelmente il commovente asservimento della ragione alla forza irresistibile della volontà, egli si presenta quale paladino della vita, dando a intendere che sia “necessario difendere la vita contro lo
spirito! Come se esistesse il minimo pericolo che la vita possa diventare troppo
spirituale!65”. Un pericolo del genere sarebbe in realtà auspicabile nell’epoca
contemporanea, in cui realmente la vita si prende ogni rivincita sulla ragione
e le sue superfetazioni; ma Nietzsche, questo, non ha fatto in tempo a vederlo.
Con il suo disgusto verso la democrazia, gli illuminismi, la morale e la religione
cristiana, egli ha posto involontariamente le basi per il sorgere dei fascismi: le
sue dichiarazioni guerrafondaie (secondo cui “rinunciando alla guerra si riIbidem, pp. 1288-1289.
T. Mann, Prolusione a un concerto in onore di Nietzsche, in Nobiltà dello spirito e altri
saggi, op. cit., p. 1293.
63 T. Mann, La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza, in Nobiltà dello spirito
e altri saggi, op. cit., p. 1315.
64 Ibidem, p. 1320.
65 Ibidem, pp. 1320-1321.
61 62 22
Donatella Nigro
nuncia a vivere con grandezza66”), l’aspirazione alla barbarie (in cui la cultura
ha bisogno talvolta di reimmergersi, per acquistare nuovo vigore), le proposte
di una morale per medici (“che prescrive l’uccisione dei malati e la castrazione
dei minorati67”), le norme di igiene razziale, la necessità della schiavitù… tutto
ciò è stato assunto dalla teoria e dalla prassi fascista che, con il riferimento a
Nietzsche, si è ulteriormente legittimata. “Come ci appare legata al suo tempo, dottrinaria, inesperta, oggi, l’esaltazione romantica che Nietzsche fa del
male!” commenta Thomas Mann in La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza. “L’abbiamo conosciuto in tutta la sua miseria, il male, e non
siamo più abbastanza esteti da temere di professare apertamente la nostra fede
nel bene e da vergognarci di concetti così banali e di guide così comuni come
verità, libertà, giustizia68”. Ciononostante, Nietzsche continua a costituire “una
delle esperienze fondamentali del nostro spirito, un’esperienza infinitamente
determinante e plasmatrice69”. Anche in lui, come in Schopenhauer, è presente
infatti il nesso di pessimismo e umanesimo: “Egli deve rassegnarsi ad essere
chiamato un umanista, così come deve tollerare che la sua critica della morale
venga intesa come un’ultima forma dell’illuminismo. La religiosità al di sopra
delle confessioni di cui egli parla, non so immaginarmela che legata all’idea
dell’uomo, come un nuovo umanesimo con un fondamento e un accento religioso che, dopo molte esperienze, dopo essere passato per molte prove, accolga
in sé, nel suo rispetto per il mistero dell’uomo, ogni conoscenza degli elementi
sotterranei e demoniaci. Religione è rispetto”, scrive Mann in calce al saggio
del’47. “Rispetto, prima di tutto, del mistero che è l’uomo70”.
Ed è proprio l’idea di una nuova religiosità, in cui al culto di Dio subentri
quello dell’uomo, ad occupare l’autore nell’ultimo decennio della sua vita, come
testimonia, tra l’altro, il fitto scambio epistolare intrattenuto con Carl Kerényi.
In una lettera del 1945, Mann riflette sul termine “umanista”: esso indica “il
custode e conservatore, premuto dalla necessità (custode e conservatore pure,
in fondo, malgrè lui) di comuni, tradizionali tesori dell’umanità europea, di un
retaggio che si tratta di salvare e trasportare da un mondo vecchio in uno nuovo71”. In un’epoca di rivolgimenti politici e spirituali, anche l’umanesimo cambia di segno e, da movimento tradizionalmente progressista, si fa conservatoIbidem, p. 1323.
Ibidem, p. 1327.
68 Ibidem, p. 1336.
69 T. Mann, Prolusione a un concerto in onore di Nietzsche, in Nobiltà dello spirito e altri
saggi, op. cit., p. 1293.
70 T. Mann, La filosofia di Nietzsche alla luce della nostra esperienza, op. cit., p. 1337.
71 T. Mann - C. Kerényi, Dialogo, op. cit., pp. 133-134.
66 67 L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi fratelli di Thomas Mann
23
re: la tendenza dominante “a gettare via il bambino insieme all’acqua sporca”,
facendo piazza pulita di tutto quanto la tradizione ha consegnato in nome di
pretestuose esigenze di rinnovamento, impone infatti a “chiunque abbia in sé
un più alto senso della serietà e della libertà, e non sia banderuola al vento, a
riandare ai fondamenti, a riacquistarne consapevolezza e a insistere su di essi,
pur nel dissenso72”.
Alla conservazione occorre però affiancare la rivoluzione: a differenza dei precedenti umanesimi, che hanno considerato unicamente la ragione quale prerogativa dell’uomo, “gli spiriti e i cuori migliori di tutto il mondo”, scrive Mann nel saggio
del ‘44 intitolato Del libro dei libri e Giuseppe, sono adesso “impegnati nel tentativo
di concepire un modello umano che corrisponda di nuovo, anzi in modo miglior
e più completo di qualsiasi altro del passato, a questo concetto di cultura e all’idea
della totalità; credo che stia per nascere un nuovo sentimento di umanità in cui il
demoniaco nella vita dell’uomo, le forze dell’anima che operano da oscure profondità, lungi dall’essere misconosciuti e rinnegati, vengano sempre di più penetrati
e rischiarati dalla ragione e posti al servizio della vita e della cultura. E credo che
il comune rispetto per una simile immagine dell’uomo, una nuova unità simpatetica con la straordinaria, complessa, affascinante posizione dell’uomo fra natura e
spirito, sia il presupposto morale per il compimento delle speranze che muovono
gli uomini nei travagli attuali: la speranza nel raggiungimento di uno stadio più
elevato della loro maturità sociale, la speranza in un mondo migliore e più giusto,
la speranza nella pace.73”
Già nel lungo saggio del ‘25 dedicato a Goethe e Tolstoj, Mann aveva affrontato il cosiddetto “problema aristocratico” che coincide, in realtà, “con quello della dignità umana”. “Che cosa è più nobile e degno dell’uomo? Libertà o
vincolo, volontà o costrizione, moralità o ingenuità?74” si chiedeva, ponendo a
confronto due opposte categorie di genio: da un lato, Goethe e Tolstoj, beniamini della natura; dall’altro, Schiller e Dostoevski, nobili dello spirito. La conclusione cui egli era approdato è che né l’una né l’altra nobiltà possa dirsi superiore: né la salute alla malattia, né la vita alla morte, né i meriti innati alla vita
morale. Il primato spetta invece alla sintesi, a quell’humanitas che rappresenta
il fine più alto dell’umanità, al tendere reciproco “dei figli dello spirito verso la
natura e dei figli della natura verso lo spirito75”. “Farsi spirito! Suona l’imperativo sentimentale dei favoriti della natura. Farsi corpo! Suona invece quello dei
T. Mann, Una traversata con Don Chisciotte, op. cit., p. 824.
T. Mann, Del libro dei libri e “Giuseppe”, op. cit., p. 762.
74 T. Mann, Goethe e Tolstoj, in Nobiltà dello spirito e altri saggi, op. cit., p. 73.
75 Ibidem, p. 154
72 73 24
Donatella Nigro
figli dello spirito. […] L’importante è che nulla sia troppo facile. Dove manchi lo
sforzo, la natura è materialità rozza, lo spirito è inconsistenza e sradicamento.
Dove natura e spirito, l’uno rivolto alla nostalgica ricerca dell’altro, altamente
s’incontrano, là nasce l’uomo76”.
Come già accennato, è proprio col Giuseppe e i suoi fratelli che Thomas Mann
offre il suo contributo alla costituzione dell’umanesimo notturno. Giuseppe, infatti, il doppiamente benedetto, rappresenta la sintesi ideale dei due opposti
principi dell’umano e il modello, quindi, di un’umanità futura che sappia finalmente conciliare spirito e corpo, elevazione e profondità, passato e futuro. “La
tradizione” - leggiamo in uno dei punti cruciali di Giuseppe il nutritore - “viene
dal profondo, dalle regioni sotterranee, ed è l’elemento che ci vincola. Ma l’io
viene da Dio e appartiene allo spirito, che è libero. Si dà vita improntata a civiltà allorquando nell’elemento modellante che ci vincola e viene dal profondo
si trasfonda la libertà divina dell’io e non vi è civiltà umana senza l’una e senza
l’altra77”.
La tetralogia di Giuseppe e la proposta, in essa avanzata, di un umanesimo
notturno, costituiscono, per certi versi, il culmine ideale nonché la conclusione di un complesso itinerario, politico e di pensiero. Un itinerario che, partito
dalle ben diverse posizioni delle Considerazioni di un impolitico, sarebbe poi
sfociato, col Doctor Faustus, in una rinnovata ma anche differente riflessione
sulla primitività e il primitivismo, ormai svuotati delle potenzialità soteriologiche che pur erano state loro attribuite rispetto alla figura di Giuseppe e al suo
mondo, e condannati infine, in anni molto propizi alle tenebre ma del tutto
impropizi per qualsivoglia umanesimo, a ispirare la colpa senza redenzione di
Adrian Leverkühn, della sua musica e del suo ambiente.
76 77 Ibidem, p. 118.
T. Mann, Giuseppe il nutritore, in Giuseppe e i suoi fratelli, op. cit., p.174.
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
25
In margine alla recente pubblicazione degli Scritti
di Benedetto Croce su Francesco De Sanctis*
Memoria di Maria Della Volpe
presentata dal socio naz. ord. res. Domenico Conte
(seduta del 30 gennaio 2009)
Mai si è avuto un popolo senza religione,
senza nozione del male e del bene.
(Dostoevskij)
Abstract. The works of Croce on Francesco De Sanctis, now published by Teodoro Tagliaferri and Fulvio Tessitore, give to the scholars not only the opportunity for a new comparative analysis on the Neapolitan historian and the critic from Irpinia, but also a necessary and,
from many points of view, privileged instrument to better understand Croce. By defming,
explaining and upholding De Sanctis’ theory of history, Croce defines, explains and upholds
his own theory of history which, by 1894, the latter regards, like De Sanctis, as a intimate,
moral and spiritual history. In other words, a history of Mankind, that in the course of time,
loses its eminently human character to get a theophanic condition.
I. A proposito degli scritti di Benedetto Croce su Francesco De Sanctis
Sono stati finalmente raccolti e pubblicati da Teodoro Tagliaferri e Fulvio Tessitore, per la Giannini Editrice di Napoli, col titolo Scritti su Francesco De Sanctis,
tutti o quasi i contributi dedicati da Benedetto Croce a Francesco De Sanctis: saggi,
prefazioni, note, recensioni, postille e ‘varietà’ di argomento desanctisiano redatte
da Croce tra il 1896 e il 1952 e di cui vengono ora riproposte, in un’opera che conta quasi mille fitte pagine, le prime edizioni ripulite da errori tipografici e refusi.
è un’iniziativa, questa, quanto mai opportuna e benemerita, che colma un vuoto
negli studi su due grandi interpreti della cultura italiana ed europea. Essa, infatti,
non solo ha il merito di restituire, in modo compiuto ed ordinato, una delle più
importanti interpretazioni di De Sanctis, quella crociana, ma anche quello di indi* Se queste poche pagine sopportano il peso di una dedica, questa non può se non essere
per Aniello Finizio.
26
Maria Della Volpe
care, attraverso il De Sanctis di Croce, una via indispensabile, e sotto certi riguardi
privilegiata, per comprendere lo stesso Croce.
Nella preziosa e lunga introduzione che si legge nel primo dei due volumi in
cui si articola l’opera, Tessitore, infatti, ricordando la complessità del rapporto
Croce-De Sanctis e precisando che a nessuno dei suoi autori, neanche a Vico
o ad Hegel, Croce dedicò «tante cure» e «tanta costante attenzione», indica,
nonostante i molti contributi che conta la sterminata bibliografia crociana, un
nuovo percorso di ricerca. Che è, come egli scrive, «lo studio del rapporto tra
Croce e De Sanctis nel senso di indicarne l’evolversi, il successivo correggersi e
il non infrequente ritorno delle interpretazioni date da Croce dell’opera di De
Sanctis» (p. XIV). L’analisi ravvicinata e puntuale dei testi del filosofo napoletano, consente allora a Tessitore di mostrare i «motivi originari» del desanctismo
crociano, che egli rintraccia nell’«hegelismo critico» di De Sanctis, che condurrebbe Croce a rifiutare l’idea della storiografia come passaggio da concetto a
concetto e a rivendicare il valore dell’individualità. Dopo un itinerario articolato e complesso, Tessitore conclude la sua analisi rintracciando in De Sanctis il
tramite attraverso cui Croce poté «avvertire la più rigorosa istanza storicistica
consacrata dalla rivoluzione gnoseologica della filosofia contemporanea» intesa come «logica del concreto e del particolare» (p. XXXVII).
Accanto all’introduzione, sulla quale ancora molto ci sarebbe da dire ma di
cui ci sembra d’aver mostrato il nucleo concettuale fondamentale, nel primo
volume trovano posto una utile nota ai testi ed un ricco apparato critico in cui,
con pazienza, precisione e nota esperienza, Teodoro Tagliaferri assolve il non
facile compito di tracciare le coordinate bio-bibliografiche indispensabili per
comprendere i testi crociani ristampati, ordinati e riproposti nel secondo volume dell’opera, e le modifiche, non di rado numerose, apportate da Croce ai testi
nella loro prima riedizione in volume.
In conclusione, dunque, gli Scritti su Francesco De Sanctis, come hanno autorevolmente sostenuto Dante Della Terza e Sergio Zavoli in occasione della
loro presentazione nella Biblioteca del Senato, sono uno strumento indispensabile per indagare i molteplici volti di due classici capaci di vincere il tempo. E
proprio su uno di essi si articolerà l’analisi qui di seguito condotta1.
1 A proposito della genesi del rapporto Croce De Sanctis rimandiamo agli autorevoli studi
di F. Flora, Croce e De Sanctis, in AA.VV., Benedetto Croce, a c. di F. Flora, Milano, Malvasi,
1953, pp. 195-231; G. Contini, Croce e De Sanctis (1953), ora in Altri esercizi (1942-1971), Torino, Einaudi, 1972, pp. 71-75; G. Savarese, Croce e De Sanctis (1967), ora in Primo tempo del De
Sanctis, Bologna, Patron, 1971, pp. 155-190; F. Tessitore, Introduzione a B. Croce, Scritti su
Francesco De Sanctis, a cura di T. Tagliaferri e F. Tessitore, 2 voll., Napoli, Giannini Editore,
2007, pp. XIII-XLV. La maggior parte degli interventi di Tessitore sul critico irpino sono con-
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
27
II. Le due razze della storia dell’umanità
Personalità morale e persona vitale
Sin dai primi anni della giovinezza, come è noto, De Sanctis è per Croce lo
scrittore «prediletto» e «amorosamente interrogato»2, al punto tale che, con insolite parole cariche di attaccamento come quasi mai lascia trasparire nelle sue
pagine, di lui scrive: «Il nome di Francesco de Sanctis, di un uomo dal quale io
ho tanto e tanto imparato, suona sempre per me con così affettuoso grido, che
non potrò mai resistere al suo appello, finché avrò vita»3. De Sanctis è «spirito
fresco e limpido»4, che mai si lasciò sopraffare dal mestiere di professore5. Egli,
nelle pagine crociane, è sì filosofo dell’estetica, espositore dell’opera letteraria,
critico, storico6, ma, sopra ogni cosa, è «maestro di vita morale»7. Che non è
cosa di poco conto se si tiene presente che per Croce la storia è sempre storia
dello scontro tra «uomini spirituali» e «uomini materiali». Ovvero figli di Giove
e figli di Era, eroi e giganti che, come il mitico Anteo8, prendono la loro forza
dalla terra. In una parola: «uomini morali» e «pover[i] uomin[i]». Se è vero,
infatti, che il male è «in noi»9, in ognuno di noi, e che ciascuno porta dentro di
tenuti nel terzo volume dei Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 1997.
2 B. Croce, La critica letteraria. Questioni teoretiche (1919), in Scritti su Francesco De Sanctis,
cit., pp. 5-100, qui p. 58.
3 B. Croce, Prefazione al Saggio sul Petrarca (1907), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit.,
p. 202.
4 B. Croce, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902), a c. di G.
Galasso, Milano, Adelphi, 1990, p. 460. In questo caso rimandiamo all’Estetica e non al volume
degli scritti su Francesco De Sanctis in cui pure queste pagine sono raccolte, perché le parole
qui riproposte non vengono riportate nella prima edizione del 1902 ma vengono aggiunte nelle
edizioni successive a quella del 1908.
5 Cfr. B. Croce, Cultura e vita morale (1926), a c. di M. A. Frangipani, Napoli, Bibliopolis,
1993, p. 265.
6 B. Croce, La critica letteraria, cit., p. 58.
7 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis
(1913), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 252-264, qui p. 254.
8 E, di contro al mitologico gigante, Croce, in risposta al discorso inaugurale del Congresso di filosofia di Oxford, tenuto dal prof. Smith, scrive: «noi prendiamo le nostre forze non dalla terra, ma dal cielo» (B. Croce, Congresso di Filosofia di Oxford. Parole di risposta al discorso
inaugurale del Presidente prof. Smith, in Id., Epistolario I. Scelta di lettere curata dall’autore,
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1967, pp. 162-163, qui p. 162).
9 B. Croce, L’innocenza e la malizia (1917), in B. Croce, Etica e politica (1931) a cura di G.
Galasso, Milano, Adelphi, 1994, pp. 166-171, qui p. 166. Sulla connaturalità del male alla natura umana, Benedetto Croce, all’indomani della seconda guerra mondiale, tornerà a parlare
in uno scritto suggestivo ed inquietante del 1946: l’Anticristo che è in noi (B. Croce, Filosofia e
Storiografia (1949), a cura di S. Maschietti, Napoli, Bibliopolis, 2005, pp. 292-298). Pur tuttavia già nel 1915, in pagine meno drammatiche e più serene di quelle appena ricordate, Croce
scrive: «Quegli individui inferiori sono insieme infelici, condannati alle sofferenze e ai castighi
o almeno alla privazione delle migliori gioie, e non sono essi che si sono fatti così, ma è l’or-
28
Maria Della Volpe
sé un «pover’uomo»10 sicché nessuno può credersi «puro tra gli impuri»11, è pur
vero però, che, come si legge in alcune pagine del 1939, gli uomini si distinguono in «due razze»12, quella degli uomini intenti unicamente al loro particolare,
e quella degli uomini che sottendono la loro vita particolare a quella dell’universale. Al di là della provocatorietà di queste pagine in cui Croce sembra fare
il verso alle teorie razziali fascistiche, il rimando a due diverse stirpi di uomini
trova il suo fondamento nella distinzione dei due eterni momenti della sfera
pratica, l’«utile» e il «morale», che, sebbene presenti in ogni essere umano, tuttavia danno luogo alle diverse formazioni psicologiche che trovano loro compiuta espressione tipica nelle due progenie, il cui ruolo, nella storia, sembra
fisso e immutabile, al punto tale che di loro Croce può scrivere:
«Provatevi a sollevare alcuno dalla prima razza verso l’universale, il
dovere, l’ideale; e voi lo vedrete, nonostante i vostri sforzi, sempre pesantemente ricadere nel suo consueto e come connaturato calcolo delle
utilità. è raro, e quasi miracoloso, che una conversione effettiva abbia
luogo»13.
Un abisso profondo, dunque, separa, inesorabilmente, le due razze che vivono, sotto forme diverse, in ogni tempo. E allora, se vani sono tutti gli sforzi per
risollevare gli «uomini materiali» al rango di quelli «spirituali», non resta che
sperare che da essi nascano «figli di altro cuore»14.
Il tono caustico e il colore livido che assume il discorso crociano nelle pagine sopra richiamate, è acuito senza dubbio, dal luogo e dal momento15. Nondine del mondo che così li ha voluti; e, così essendo, lavorano per noi e conferiscono a far noi
quello che noi siamo nei nostri aspetti e momenti migliori. Perciò del loro male siamo anche
noi in certo senso responsabili, noi che ne profittiamo, noi fatti della loro medesima sostanza
[…]. Perciò ciascuno di noi sta innanzi a essi pavido come innanzi all’infermo della malattia
che può colpire anche noi» (B. Croce, Lo spirito sano e lo spirito malato (1915), in B. Croce,
Etica e Politica, cit., pp. 62-71, qui pp. 70-71). Sull’importanza di questo saggio all’interno della
riflessione crociana cfr. D. Conte, Storia universale e patologia dello Spirito. Saggio su Croce, il
Mulino, Bologna, 2005, pp. 142-150.
10 B. Croce, L’ ombra del mistero (1940), in Il carattere della filosofia moderna (1941), a c. di
M. Mastrogregori, Napoli, Bibliopolis, 1991, pp. 29-40, qui p. 36.
11 B. Croce, Personalità filosofica e personalità morale e identità di questa con l’opera (1947),
in Filosofia e storiografia, cit., p. 293.
12 B. Croce, Le due razze (1936), in Id., Dal libro dei pensieri, a cura di G. Galasso, Milano,
Adelphi, 2002, pp. 94-95, qui p. 94.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Il saggio, si ricorderà, è pubblicato nel 1936, così come il volume de La Poesia e quello
delle Vite di avventura di fede e di passione. Il 1936, come è noto, però, è anche l’anno del patto
tra l’Italia fascista e la Germania hitleriana, preceduto nel 1935 dalle leggi razziali di Norim-
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
29
dimeno la dicotomia tra «uomini materiali» e «uomini spirituali», che in altri
luoghi si presenta in quella tra volgo e élite16, intesa non senza malizia da numerosi studiosi17 e che in questa cornice ci sembra riportata nella sua giusta luce,
attraversa una larga parte della produzione crociana. Sicché è importante insistere su di essa. E a tal riguardo sarà utile prendere in esame uno scritto composto nel 1947 e significativamente intitolato Personalità filosofica e personalità
morale e identità di questa con l’opera. Si tratta di pagine complesse, pubblicate
per la prima volta nel 1948 nei «Quaderni della critica» e poi riproposte nel volume Filosofia e storiografia. In esse Croce parte da una domanda di non poco
conto e di non facile risposta: che cos’è la «personalità»? A dispetto dei cultori e
predicatori della personalità carismatica in grado di pronunciare parole di tuono, e dei teorici della personalità come di una x18 misteriosa al cui cospetto non
resterebbe che rabbrividire19, Croce rivendica la «vera», l’«unica» personalità:
«la personalità morale»20, che, «purgata da tutte le private passioni», esalta sé
stessa nell’universale21.
La personalità cui Croce si richiama, dunque, non ha nulla di quella maberga. Le pagine di cui ci stiamo occupando, dunque, si inscrivono in un momento importante
per la biografia intellettuale di Croce e cruciale per la storia dell’umanità. Esse, potremmo
dire, sono una risposta alla politica italo-tedesca e dunque l’affermazione, di contro ad una
storia fascistizzata e nazistizzata, di una storia che è storia morale.
16 A tal riguardo basterà andare alle pagine che il filosofo napoletano dedica alla storia
etico-politica (B. Croce, Storia economico-politica e storia etico-politica, in «La Critica», 1924,
pp. 334-341. Questo stesso saggio è stato ripubblicato, tra l’altro, nel volume Etica e politica,
cit.; Id., La storia tra le storie: la storia etico-politica (1926), in Teoria e storia della storiografia
(1917), Milano, Adelphi, 2001, p. 91. Del volume del 1917 è inoltre disponibile l’edizione critica
curata per Bibliopolis da Edoardo Massimilla e Teodoro Tagliaferri, pp. 372-373) e a quelle
della tetralogia storica in cui essa – la storia etico-politica – da principio teorico si traduce in
canone di ricerca storica. La storia, infatti, per Croce è aristocrazia. Che non è, dal punto di
vista di Croce, una classe formatasi intorno al sangue o alla razza, ma indica l’esistenza nella
storia di un gruppo di uomini che appartengono alla ‘nobiltà dello spirito’.
17 Scrive ad esempio Eugenio Montale: «Una virtù dei Grandi è di essere sordi / a tutto il
molto o il poco che non li riguardi. / Trascurando i famelici e gli oppressi / alquanto alieni dai
vostri interessi / divideste lo Spirito in quattro spicchi / che altri rimpastò in uno: donde ripicchi, faide / nel gregge degli yesmen professionali. / Vivete in pace nell’eterno: foste giusto senza
saperlo, senza volerlo. / Lo spirito non è nei libri, l’avete saputo, e nemmeno si trova nella vita.
La sua natura resta / in disparte. Conosce il vostro vivere / (lo sente), anzi vorrebbe farne parte /
ma niente gli è possibile per l’ovvia / contraddizione che nol consente» (E. Montale, Un Grande
Filosofo. In devoto ricordo, in E. Montale, Tutte le poesie, Milano, 2006, p. 488).
18 F. Meinecke, Esperienze 1862-1919, Napoli, Guida, 1990, p. 82. Il problema della personalità non può essere qui affrontato, in poche battute, senza incorrere in banalizzazioni o
in ricostruzioni sommarie. Tuttavia ci piace comunque rimandare alle opere di uno dei più
grandi storici tedeschi del XX secolo, F. Meinecke che su questo problema non poco ragionò.
19 O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia mondiale, Parma, Guanda, 1990, p. 669.
20 B. Croce, Personalità filosofica e personalità morale e identità di questa con l’opera, cit.,
p. 237.
21 Ibidem.
30
Maria Della Volpe
schera d’uomo nelle cui mani le masse sono pronte, trepide o fanatiche, a
giurare obbedienza. Ma non solo. Essa non è neanche un’«anima-sostanza» o
una monade. Il ragionamento crociano, allora, pur seguendo problematiche
diverse, è mosso dall’esigenza di combattere da un lato il rischio dell’animalizzazione e dell’annientamento della personalità, dall’altro il pericolo, insito in concezioni sostanzialistiche della personalità, di sfociare in teorie non
solo irrazionalistiche ma anche trascendenti e misticheggianti della realtà.
Tuttavia, va qui detto, anche se solo brevemente, perché su questo torneremo nel prosieguo del nostro discorso, che per il filosofo napoletano, le due
tipologie umane a cui sopra si è fatto riferimento, sono così create da Dio22.
Per ora, però, ci basti dire che per Croce non esistono le personalità, ma o la
vera «personalità morale» o la «persona vitale». Da un lato dunque, «profeti», «santi», «martiri»23, «eroi della morale» che si innalzano «sul piacere e
sul dolore», che rinunciano «all’ubbia della beatitudine personale», che trovano «appagamento nella gioia austera di partecipare, nella propria piccola
o grande parte, alla continua creazione del mondo»24; dall’altro eudemonisti
ed edonisti che servono la «vita organica» o «fisiologica» e il cui ideale è «il
benessere soggettivo»25.
Sotto questo riguardo allora, la storia si trasforma in gigantesco campo di
battaglia in cui «uomini umani» e «fiere» o «pezzi di macchina», «religiosi» e
«irreligiosi», «aristocrazia umana» e «volgo», l’uno di contro all’altro, si fronteggiano senza posa. Alla fine, però, sebbene i secondi siano i più e rappresentino la quantità, mentre i primi sono più rari e rappresentano la qualità, saranno
proprio questi ultimi, avverte Croce, ad avere sempre ragione della quantità e a
piegarla ai propri fini26.
è ormai chiaro allora, il fatto che, quando Croce definisce De Sanctis uno
dei «rari moralisti» che l’Italia possiede27, un «educatore […] morale»28, un «maestro di vita morale»29, così dicendo lo inserisce all’interno dello scontro tra le
B. Croce, Le due razze, cit., p. 95.
Si veda B. Croce, La Storia del Regno di Napoli (1925), a cura di G. Galasso, Milano,
Adelphi, 20052, p. 229; Id., Storia d’Europa nel secolo decimonono (1932), a cura di G. Galasso,
Milano, Adelphi, 1991, p. 186.
24 B. Croce, Le due razze, cit., p. 95.
25 B. Croce, Lo storicismo e l’inconoscibile (1946), in Filosofia e storiografia, cit., p. 134.
26 B. Croce, Le due razze, cit., p. 95.
27 B. Croce, Prefazione al saggio sul Petrarca, cit., p. 201.
28 B. Croce, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti (1898), in Scritti su Francesco De
Sanctis, cit., pp. 139-171, qui p. 164.
29 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis,
cit., p. 254.
22 23 In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
31
due «razze» di uomini, eterno momento della storia. Che è poi sempre storia
dell’umanità.
III. La parola storia
Storia intima e storia esteriore
«Sarei rimasto rattristato se l’Italia avesse allontanato da me il De Sanctis,
col quale tutta la vita sono stato congiunto e nel nome del quale, mio maestro e
compagno di studii, spero di vivere ancora e morire»30. E la morte, da quando
Croce scrive queste parole, nel 1952, non attese molto.
è tutt’altro che fortuito il fatto che, ormai sul limitare della sua non breve
vita, Croce avverta il bisogno di ritornare, con parole niente affatto retoriche, su
Francesco De Sanctis che, molti anni prima, al liceo, aveva conosciuto attraverso un compagno calabrese31; quel De Sanctis che per i più era stato solamente
un «sottile grammatico»32, un «cervello nebuloso»33, e che per lui invece diviene il «maestro» da cui deriva la sua concezione dell’Estetica e della Storia34. è,
infatti, seguendo e svolgendo l’opera del De Sanctis che Croce giunge alle tesi
secondo cui tanto l’arte quanto la storia siano forme di conoscenza dell’individuale. Che è il modo attraverso cui egli, sulla scorta degli insegnamenti desanctisiani, sottrae l’arte al dominio delle volizioni irrazionali e la storia a quello
della scienza. Tuttavia, ricondurre la storia sotto il concetto generale dell’arte non
significa per Croce identificarla con essa, perché la storia è conoscenza dell’individuale reale, mentre l’arte è conoscenza dell’individuale possibile35.
Affermata, dunque, la sua filiazione dal De Sanctis, Croce nei suoi numerosi scritti sul critico irpino insiste sì sul valore estetico e letterario ma anche e
soprattutto, ed è quello che qui maggiormente ci interessa, sull’alto valore storico dell’opera del De Sanctis. Ai fini del nostro discorso allora, sarà necessario
soffermarsi su come il concetto desanctisiano di storia venga inteso, interpretato e svolto da Croce. Negli scritti che in più di un cinquantennio il filosofo
napoletano dedica a De Sanctis, infatti, il lettore può seguire come, attraverso
30 B. Croce, De Sanctis-Gramsci (1952), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 574-575,
qui p. 576.
31 Ivi, p. 575.
32 B. Croce, Estetica, cit., p. 489.
33 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis,
cit., p. 252.
34 B. Croce, Prefazione ai «Primi Saggi» (1919), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp.
441-445, qui p. 442.
35 Ivi, pp. 442-443.
32
Maria Della Volpe
la spiegazione, la difesa e il confronto con la teoria desanctisiana della storia,
Croce, di volta in volta, vada definendo la sua teoria della storia. Ma allora che
cos’ è la storia per De Sanctis?
Il passato per De Sanctis, si legge nelle pagine crociane a lui dedicate, non
è mai quieto ed immobile, la storia non è incrollabile catena di «cause» ed
«effetti»36, ma è divenire, svolgimento, progresso37 in cui il «male» è solo un
simulacro del bene38. Essa, inoltre, non è un Giano bifronte in cui spirito e
natura, come granitiche forme, si voltano le spalle, giacché per il critico irpino, come riporta Croce, «tutto quello che è in natura ha diritto di essere nello
spirito»39. E ancora. La storia, nelle sue pagine, non si confonde né si fonde mai
con la malsicura «storia universale»40, né con l’incerta «filosofia della storia».
De Sanctis, dunque, è per Croce filosofo dell’Estetica, espositore dell’opera
letteraria e critico, ma prima di tutto storico41. Che è quanto Croce, con chiarezza, espone in note pagine del 189442, in cui, confutando l’idea secondo la
quale De Sanctis sia stato un cattivo storico, scrive:
36 B. Croce, recensione a G. A. Cesareo, Storia della letteratura italiana a uso delle scuole
(1909), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 469-475, qui p. 470.
37 Cfr. B. Croce, Scritti varii, inediti o rari di Francesco De Sanctis. Prefazione (1898), in
Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 125-136, qui p. 128.
38 B. Croce, Per la storia del pensiero di Francesco De Sanctis (1912), in Scritti su Francesco
De Sanctis, cit., pp. 207-222, qui p. 208.
39 B. Croce, La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale-scuola democratica. Prefazione (1897), in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 103-122, qui p. 115.
40 Per quanto concerne il complesso problema della storia universale nell’ambito della
riflessione crociana rimandiamo al saggio di F. Tessitore, Croce e la storia universale, in Humanistica. Per Cesare Vasoli, a c. di F. Meroi ed E. Scapparone, Firenze, Olschki, 2003, pp. 369388, e al volume di D. Conte, Storia universale e patologia dello spirito. Saggio su Croce, cit. A
proposito della questione della storia universale si veda inoltre F. Tessitore, Il senso della storia
universale. Dalla filosofia della storia alla storia universale: il problema della storia tra tardo Settecento e primo Novecento, Milano, Garzanti, 1987 e D. Conte, Storicismo e storia universale.
Linee di un’interpretazione, Napoli, Liguori, 2000.
41 è importante qui cercare di comprendere, anche se solo brevemente, il perché della insistenza con cui il filosofo napoletano definisce De Sanctis non solo grande storico della letteratura, ma
anche e primariamente storico. Per Croce, come è noto, la storia non si divide in «circoli», essa è
sì sempre storia «artistica», «politica», «morale» e «filosofica» ma mai «storia generale», tuttavia,
per lui, pensare un aspetto della storia è «pensarne insieme tutti gli altri», perché ciascuna storia
«ha in sé l’unità dello spirito». Che è poi, quanto Croce, in termini più espliciti, scrive nel 1894 nel
quarto capitolo del volume La critica letteraria. Questioni teoretiche, intitolato «Di alcune questioni
particolari concernenti la storia letteraria». Qui, sin da subito, il discorso sulla possibilità o meno
della storia letteraria viene congiunto con quello sulla possibilità o meno di ogni storia, che, scrive
il filosofo napoletano, «non si può negare». Il significato della storia letteraria così, viene intimamente congiunto con quello della storia in generale che, a sua volta, avverte Croce, non va confusa
con le «pure» e «semplici» «fantasticherie» della filosofia della storia. La storia, e dunque con essa
la storia letteraria, infatti, ha in sé stessa «la sua spiegazione e la sua giustificazione». Essa così «si
fa con un sol metodo»: «raccogliendo, vagliando e interpretando i fatti».
42 B. Croce, Di un giudizio intorno all’opera letteraria di Francesco De Sanctis (1894), in
Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 57-69.
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
33
«è stato spesso detto che nelle opere del De Sanctis sia deficiente
la “parte storica”: cosa vera soltanto quando si prende la parola storia
in senso affatto materiale ed esteriore; ossia quando si chiami storia la
copia di fatti minuti, di nomi, di titoli, di date, e si confonde, insomma, la storia col repertorio o dizionario storico. Ma con un concetto più
vero e più elevato della storia, il De Sanctis apparirà, quale fu, storico di
prim’ordine»43.
Egli, infatti, continua Croce, coltivò il «concetto più vero e più elevato della
storia»44, interessandosi «alle parti più notevoli di quella che si chiama materia storica»45. De Sanctis sapeva cioè coglierne i «fatti capitali e dominanti»46, i
«tratti salienti e caratteristici»47. Nella sua Storia della letteratura italiana narrò
così «la storia dei grandi moti ideali e delle grandi personalità»48. Il suo «sguardo d’aquila»49 gli permise dunque di liberarsi «da quei convenzionali legami
cronologici che rendono schiavi i deboli»50. Egli inoltre era mosso dalla consapevolezza che la storia non si fa solamente con i «documenti materiali», ma
anche e «principalmente, coi documenti che noi conserviamo nel nostro spirito
e coi quali i primi vengono interpretati e rischiarati»51.
E sono parole queste di non poco conto per l’interprete interessato a seguire il
percorso che dalla teoria desanctisiana della storia porta a quella crociana. Insieme
con esse, inoltre, vanno lette, perché per certi versi loro ideale completamento, le
pagine di poco successive della Memoria del 1898, intitolata «Francesco De Sanctis
e i suoi critici recenti»52, in cui, ad un anno dalla pubblicazione da parte di Croce
del volume postumo desanctisiano sulla Letteratura italiana nel secolo XIX, il filosofo napoletano prende la parola contro le critiche che da più parti gli si levarono
contro. Al Bertana, al de Lollis e al Carducci che accusavano De Sanctis di essere
uno «scarso espositore di fatti»53, di non avere un «saldo fondamento storico»54, di
aver tentato, «con l’applicare alla letteratura i concetti essenzialmente politici di
Ibidem.
Ibidem.
45 Ivi, p. 63.
46 Ivi, p. 62.
47 Ivi, p. 64.
48 Ivi, p. 62.
49 Ivi, p. 64.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 B. Croce, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti (1898), in Scritti su Francesco De
Sanctis, cit., pp. 139-171, qui p. 139.
53 Ivi, p. 143.
54 Ivi, p. 144.
43 44 34
Maria Della Volpe
libertà e democrazia»55, una sintesi «fondamentalmente sbagliata»56, e, cosa ancor
più grave, di contro al «disconoscimento della personalità morale di Francesco De
Sanctis»57, Croce afferma che quella del critico irpino è una storia dei «fatti generali» o «dominatori»58 e che quella che egli fece è un «capolavoro» al pari della Storia
romana del Mommsen59. De Sanctis, continua Croce, non era un «professore», non
«un retore crudele»60: egli era piuttosto come un pittore che per ritrarre l’aspetto di
un paesaggio, lo contempla dall’alto di un colle61.
La storia, dunque, dalle altezze da cui la guarda De Sanctis non è mai
storia dei «piccoli fatti» o dei «fatti esteriori»62, ma sempre storia «morale e
intellettuale»63, «storia intima»64.
Giunti a questo punto si può comprendere meglio in che senso all’inizio del nostro discorso abbiamo detto che attraverso il De Sanctis di Croce avremmo capito
meglio lo stesso Croce. Le pagine fin qui analizzate, infatti, contengono in nuce
alcuni dei nuclei teorici intorno ai quali Croce organizzerà la sua filosofia dello spirito. è significativo che già negli ultimi anni dell’Ottocento, Croce, sulla scorta degli
insegnamenti desanctisiani, pensi all’unità di spirito e natura, alla storia come ininterrotto progresso i cui documenti sono serbati nel cuore dell’uomo. Esponendo,
chiarendo e difendendo la teoria desanctisiana della storia Croce, allora, espone,
chiarisce e difende la sua teoria della storia, che già nel 1894 egli può definire, desanctisianamente, storia intima, morale, spirituale. Quella storia cioè che di contro
al disumanamento del mondo, egli, con accenti diversi, continuerà a definire, tenacemente, l’unica e vera storia dell’umanità65.
IV. Individui come simboli della storia
«Non intesa», «mal giudicata» ed «affatto screditata», «l’unica» o «quasi sola
opera» che, tra l’ottanta e il novecento, fu esempio di un vero libro di storia è
Ivi, p. 152.
Ibidem.
57 Ivi, p. 163.
58 Ivi, p. 141.
59 Ivi, p. 143.
60 Ivi, p. 164.
61 Ivi, p. 155.
62 Ivi, p. 143.
63 Croce, Di un giudizio intorno all’opera letteraria di Francesco De Sanctis, cit., p. 63.
64 Ivi, p. 62. Cfr. anche B. Croce, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti, cit., p. 142.
65 A proposito del concetto crociano di storia dell’umanità ci sia consentito di rimandare
al nostro saggio intitolato Teofanie e «vera storia dell’umanità» in Benedetto Croce, in «Archivio
di storia della cultura», 2008, pp. 285-339.
55 56 In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
35
«la storia che il De Sanctis aveva data della letteratura italiana»66. Così si legge
nelle primissime pagine del primo paragrafo, intitolato «La storicità di un libro
di storia», della Storia come pensiero e come azione.
è significativo che il libro del 1938, proprio quello dedicato alla storia, il
libro, cioè, in cui Croce chiarisce e, per certi versi, ridefinisce i princìpi della
sua teoria della storia, si apra sotto il segno di De Sanctis, innalzato finanche al
di sopra di Ranke e Burckhardt definiti invece, nel terzo capitolo, storici senza
problema storico67. Qui, come è noto, Croce afferma che un libro di storia non
va giudicato secondo la sua forma letteraria o secondo il numero e l’esattezza
delle notizie che offre, e neanche secondo la sua capacità di scuotere l’immaginazione, di commuovere o di incuriosire68, ma unicamente secondo la sua
«storicità»69. Che è atto di comprensione e di intelligenza e che nasce da un
«bisogno della vita pratica»70. Sicché tutte le storie di tutti i tempi e di tutti i
popoli71 sono nate per gettare luce sulle «nuove oscurità»72 che la vita, di volta
in volta, ha posto.
Un vero libro di storia allora, così come Croce lo intende, riesce ad aprire le
porte della distanza e a tramutare il muto passato in eloquente storia. Definito,
dunque, il criterio a partire dal quale il filosofo napoletano giudica la storicità
di un libro di storia, resta ora da capire perché proprio il libro del De Sanctis
ne assurga a modello.
In più di un cinquantennio, Croce definisce la Storia della letteratura italiana
del De Sanctis come «vera storia intima dell’Italia»73 in cui è narrato «il ‘cammino ideale della storia’»74. De Sanctis, infatti, precisa Croce, non cedendo ad una
«concezione meschina della storia», e non abbandonando «i problemi grandi
ed intimi» in nome dell’«erudizione minuta»75, scrive «la più libera di tutte le
storie», in cui è rappresentato «tutto il dramma della vita italiana»76.
66 B. Croce, La storia come pensiero e come azione (1938), a c. di M. Conforti, con una nota
al testo di G. Sasso, Napoli, Bibliopolis, 2002, p. 9.
67 I capitoli dedicati a Ranke e Burckhardt rientrano nella sezione de La storia come pensiero e come azione intitolata «La storiografia senza problema storico», pp. 59-81.
68 Ivi, p 11.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ivi, p. 12.
72 Ibidem.
73 B. Croce, Di un giudizio intorno all’opera letteraria di Francesco de Sanctis, cit., p. 62.
74 B. Croce, Per la storia del pensiero di Francesco De Sanctis, cit., p. 217.
75 B. Croce, Francesco de Sanctis e i suoi critici recenti, cit., p. 167.
76 B. Croce, Francesco De Sanctis e il pensiero tedesco (1912), in Scritti su Francesco De
Sanctis, cit., pp. 243-248, qui pp. 247-248.
36
Maria Della Volpe
Sebbene in tutti o quasi gli scritti che il filosofo napoletano dedica a De
Sanctis il riferimento alla Storia della letteratura italiana sia sempre esplicito,
a nostro avviso, tra tutti, uno è quello che, meglio degli altri, permette di capire in che senso e perché per Croce l’opera del De Sanctis rappresenti l’esempio di un vero libro di storia: «La letteratura italiana nella seconda metà del
secolo XIX: Francesco De Sanctis». Che è pubblicato per la prima volta nella
«Critica» del 1912 e poi inserito come capitolo nella Letteratura della nuova
Italia. A questo saggio Croce affida un ritratto preciso e amorevole dell’opera
e dell’uomo De Sanctis e delinea il contesto in cui l’opera del critico irpino
si inserisce, spiegandone i motivi di continuità e di novità. Il discorso crociano, in queste pagine, muove dalla consapevolezza che le opere del De Sanctis
comparvero, per certi versi, troppo tardi, per altri troppo presto. Troppo tardi,
spiega Croce, perché era ormai passato il periodo in cui l’Italia si era rivolta
alla «grande filosofia» e al «problema della sua storia passata»77; troppo presto
perché facendola finita con l’astrattismo e l’intellettualismo, si rivolgeva alle
forze spontanee della vita78. Sicché essa non incontrava simpatie né tra gli
«uomini vecchi» né tra gli «uomini nuovi»79, al punto tale da essere trattata
con «compassione» ed «irrisione»80. Tuttavia, l’opera del De Sanctis, ispirata
ai princìpi dell’indipendenza dell’arte e del suo legame con la vita, generò un
vero e proprio rinnovamento che però non può essere compiutamente compreso, come avverte Croce, se non si tiene presente che essa non fu opera di
un filosofo, ma di un maestro di vita morale che, per tutta la vita, cercò di
combattere, in nome della vera coscienza morale, l’infiacchimento volitivo ed
etico del popolo italiano81.
La Storia della letteratura italiana del De Sanctis, dunque, scritta con prosa
non letteraria, oratoria o poetica ma con prosa che asseconda il ritmo della vita82, è vero libro di storia perché nasce dall’esigenza di rispondere ai bisogni del
suo tempo. Essa è «storia intima», «umana», «libera da preconcetti»83. Ovvero è
«un grande esame di coscienza» in cui «tutta la vita italiana, religiosa, politica,
77 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis,
cit., p. 251.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Ivi, p. 255.
82 Ivi, p. 260.
83 Ivi, p. 253.
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
37
morale, vi è rappresentata»84: «una storia morale»85; che trova il suo principio e
il suo oggetto nella vita morale, e i cui protagonisti sono i «sinceri di cuore»86.
Tuttavia se è vero che la storia desanctisiana è «vera storia», «intima», «morale», è pur vero però che ad essa Croce non risparmia dure critiche. La storia
del De Sanctis, intesa e organizzata per «raggruppamenti», per «antitesi», non
tiene conto, per Croce, del fatto che la storia «non si lascia riassumere» e che le
personalità storiche «non sono gli impiegati del destino»87. De Sanctis, infatti,
dimentico che le libere personalità hanno una propria storia, «che è assai più
larga di quella del popolo e dell’età cui il poeta sorge e vive»88, adoperò i «grandi nomi» solo come «simboli» e i «singoli scrittori» solamente come «fasi dello
svolgimento generale»89. La storia, allora, nelle pagine desanctisiane, diventa
essenzialmente scontro tra forze cui gli uomini prestano l’opera loro. Che però,
a ben guardare, è quanto lo stesso Croce fa nelle opere della tetralogia storica.
Anche se questa non è la sede per un’analisi delle Storie crociane, nondimeno
ai fini del nostro discorso va osservato che nella Storia del Regno di Napoli, nella
Storia dell’età barocca, nella Storia d’Italia e nella Storia d’Europa, Croce non
narra, e non vuole narrare, una storia fatta di «guerre», di «paci», dell’«avvicendarsi delle famiglie regnanti» e delle «lotte dei partiti politici»90, ma una storia
che è storia morale, intima, spirituale. Una storia che è vera storia dell’umanità,
una storia cioè che abita nella coscienza, nella mente e nel cuore dell’uomo, una
storia che, come aveva scritto in Teoria e storia della storiografia, è «in noi tutti
e le cui fonti sono nel nostro petto»91. La storia, ovvero la «vera» Storia, trova
allora il suo «principio» e il suo «oggetto» nella vita morale92. I protagonisti
delle Storie crociane così sono i rappresentanti di una «aristocrazia» spirituale
ed intellettuale. Sono «apostoli», «confessori» e «martiri»93che ingaggiano una
lotta fratricida contro il volgo «disarmonico» e «prosaico»: forze dello spirito
contro quelle della vitalità bruta ed infera.
La storia, allora, così come Croce la pensa, non è mai storia eminentemente
Ivi, p. 254.
Ivi, p. 256.
86 B. Croce, La letteratura italiana nel secolo XIX. Scuola liberale-Scuola democratica. Prefazione (1897), in Scritti su Francesco de Sanctis, cit., pp. 104-122, qui p. 108.
87 Ivi, p. 111.
88 B. Croce, Prefazione a una traduzione inglese della storia letteraria del De Sanctis (1931),
in Scritti su Francesco De Sanctis, cit., pp. 421-423, qui p. 422.
89 B. Croce, Storia della letteratura italiana. Nota bibliografica, in Scritti su Francesco De
Sanctis, pp. 225-239, qui p. 233.
90 B. Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 50.
91 B. Croce, Teoria e storia della storiografia cit., p. 91.
92 B. Croce, Storia economico-politica e storia etico-politica, cit., p. 320.
93 B. Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 229.
84 85 38
Maria Della Volpe
umana. Essa è sì storia di ceti e gruppi dirigenti; è sì storia di grandi uomini
(eletti, apostoli, eroi, santi, martiri) ma le loro opere e la loro vita hanno un
valore «sopraindividuale». Genovesi, Galilei, Bismarck, e con loro tanti altri,
incarnano, infatti, tendenze ora sublimi ora infami, ora ideali evangelici ora
barbarici, forze ora di progresso ora di conservazione, di sanità o di patologia.
Essi sono princìpi e mondi spirituali. Sono simboli.
Del limite, dunque, di cui Croce vede affetta l’opera desanctisiana, non è immune neanche la sua stessa opera.
V. Due fedi a confronto
Benedetto Croce e Francesco De Sanctis
Se è vero che la storia, desanctisianamente intesa, sia storia intima, spirituale, morale e che questa sua dimensione sia quella sulla quale Croce pone
l’accento, è pur vero, però, che in essa vi sono rilevanti elementi religiosi, non
trascurati da Croce, che nel 1898 scrive: Francesco De Sanctis «aveva ciò che
manca di solito agli altri: una concezione della vita ed una fede»94.
Per comprendere il senso di queste importanti parole crociane, sulle quali
però il filosofo napoletano non ritiene necessario soffermarsi, converrà affidarsi direttamente alle pagine desanctisiane e, in modo particolare, a quelle ben
note dedicate alla scuola liberale e a quella democratica95. Qui, attraverso un
colpo d’occhio, fuggevole, rapido ma efficace, tipico dell’artista, De Sanctis descrive tutta quanta la storia dell’umanità, dai Greci ai Romani, dal Medioevo
alla Rivoluzione francese, fino ad arrivare al XIX secolo, a quando cioè, a suo
dire, la democrazia si presenta con fattezze nuove: essa ha «faccia apostolica e
profetica», e assume come punto di partenza la ricostruzione del «sentimento
religioso»96. Che, come scrive in altri luoghi, si fonda sul principio secondo cui
«l’uomo non è il tutto della creazione […] ma è una piccola particella di una
infinita catena di esseri, che vanno fino all’ignoto e al misterioso […]. Il sentimento di questo «di là da lui» […] è la famiglia […] è la patria […] è l’umanità
[…] è la libertà […] è la giustizia»97. Sicché, come dice nella prolusione del 16
novembre 1872 in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Uni94 B. Croce, Francesco De Sanctis e i suoi critici recenti, cit., p. 168. Il maiuscoletto è di
Croce.
95 F. De Sanctis, La Scuola Democratica, in Id., La letteratura italiana nel secolo XIX, a cura
di F. Catalano, 2 voll., Bari, Laterza, 1953, pp. 325-336.
96 Ivi, p. 333.
97 F. De Sanctis, Opere, a cura di C. Nuscetta, Toino 1979, vol. XVI, pp. 201-203.
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
39
versità di Napoli: «Noi abbiamo bisogno […], se vogliamo fondare l’Italia, di
uomini che abbiano forti e sicure convinzioni, e questo […] non potete ottenerlo che aprendo ogni libertà alla religione e alla scienza»98.
E proprio la scienza, nel suo intimo nesso con la vita, è il nucleo di un noto
discorso desanctisiano del 1872 poi ripreso e riletto da Croce nel 1924. Crediamo che in queste pagine e nella rilettura che Croce ne offre, all’interprete
apparirà chiara la concezione della vita e della fede di cui Croce parla a proposito del De Sanctis, ma anche la concezione della vita e della fede del filosofo
napoletano. Sicché dalla comparazione di questi due scritti ci sembra di poter
scorgere, meglio che in altri luoghi, il crinale a partire dal quale De Sanctis e
Croce, pur considerando la moralità come fulcro interpretativo della realtà, ne
offrono una visione diversa, perché diversa è la connotazione religiosa con cui
la declinano.
Il discorso desanctisiano, costruito con una prosa possente, fatto di parole
energiche, vigorose che non lasciano spazio a pause o ad incertezze, pronunziato, come l’oratore stesso dice, «nel tempio della scienza»99, ha come prima
ed unica finalità quella di dire la verità. La verità sul conto della scienza. Qual
è questa verità, si chiederà?
Che «la Scienza non è Vita»100. Essa, infatti, non può fare «meraviglie» né
«miracoli»101. Ovvero: non può infondere la vita, non può arrestare la «corruzione», la «dissoluzione»; non può rinnovare il «sangue» né tanto meno rifare la
«tempera»102. La scienza, continua De Sanctis, è il prodotto dell’«età matura», è
«l’ultimo frutto della vita», è l’ultimo «io posso» della vita: essa non può rendere
la gioventù, perché dopo di lei viene solo la vecchiezza e la dissoluzione103. Dunque, «la scienza cresce a spese della vita»104, alla forza della prima corrisponde
la debolezza della seconda. E per dimostrare la sua tesi, De Sanctis allunga il
suo sguardo sul vasto orizzonte della storia dell’umanità: la scienza di Socrate,
che non era la vita, nulla poté contro la vita, così come quella di Platone non
poté ritardare neanche di un solo minuto il corso della storia; similmente al
tempo dell’imperatore Giuliano essa non solo non poté arrestare la dissoluzione
della vita pagana o rallentare la formazione della vita cristiana105, ma non poté
Ivi, vol. XV, pp. 97-98.
F. De Sanctis, La Scienza e la Vita (1872), in Id., Saggi Critici, a cura di L. Russo, 3 voll.,
qui vol. III, Bari, Laterza, 1957, pp. 140-162, qui p. 146.
100 Ivi, p. 145.
101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 Ivi, p. 143.
104 Ibidem.
105 Ivi, p. 143.
98 99 40
Maria Della Volpe
neppure contrastare i barbari106. Se questi, dunque, sono i giudizi desanctisiani
sulle età d’oro della scienza nell’era antica, non diversamente viene valutato il
Rinascimento che, con parole che restano impresse nella mente di chi legge, De
Sanctis definisce «il sonno di Michelangelo e la tristezza di Machiavelli»107. Il
Rinascimento cioè è l’età in cui la natura era «maledetta», «scomunicata», età
dell’ «intelletto adulto» che andava disgiunto dal sentimento e dall’immaginazione. Il discorso desanctisiano però non si arresta qui. Non solo l’età antica e
quella moderna sono attraversate da momenti di crisi, ma anche gli anni in cui
egli stesso si trova a vivere sono uno di quei momenti della storia:
«La nostra vita» – scrive infatti De Sanctis – «è a pezzi, a ritagli, con molto di nuovo nelle parole, con molto di vecchio nei costumi e nelle opere»108.
La vita, dunque, è ormai «guasta». Essa è affetta da «un male incognito»109
i cui sintomi sono l’ «apatia», la «noia», il «vuoto»110. E, come in momenti simili della storia dell’umanità, anche ora la scienza, riconosciuta e incoronata
regina da tutti i popoli,111 non è più al servizio della vita. La decadenza, allora,
sta nell’idiosincrasia tra «pensare» e «fare»112, sicché la sua risoluzione può avvenire solamente attraverso una ricomposizione della loro frattura tramite la
rigenerazione delle «forze morali»113.
Chiarito, sebbene in sintesi, il nucleo argomentativo e concettuale del discorso desanctisiano su «La scienza e la vita», possiamo ora analizzare le pagine del
saggio crociano del 1924, intitolato «Rileggendo il discorso del De Sanctis sulla
Scienza e la Vita». Chi però si aspettasse di trovare il nome del De Sanctis in
queste pagine resterà deluso: non una sola volta, fatto salvo per il titolo, lo si
incontra. Cionondimeno, in esse, il taciuto nome del critico irpino, riecheggia
con fragore, sicché, non si va lontano dal vero se si dice che, il saggio del 1924
più che una rilettura ed una interpretazione del discorso desanctisiano ne è
una risposta polemica. Qui, infatti, Croce ribadisce, virilmente, i capisaldi del
suo sistema: l’inviolabile unità dello Spirito in cui non è ammissibile il primato
di una parte sulle altre.114 Dunque, ed è questo il vero nucleo polemico di non
Ivi, p. 144.
Ibidem.
108 Ivi, p. 159.
109 Ivi, p. 161.
110 Ibidem.
111 Ivi, p. 141.
112 Ivi, p. 158.
113 Ivi, p. 161.
114 B. Croce, Rileggendo il discorso del de Sanctis sulla ‘Scienza e la Vita’ (1924), in Saggi su
106 107 In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
41
poco conto nei confronti del discorso desanctisiano, il pensiero non può essere
disgiunto dalla vita perché lo stesso «sangue circola in tutto l’organismo»115 e
dove c’è pensiero, c’è morale, c’è azione, c’è arte, sana, energica, buona, come
quello stesso pensiero. Precisa, infatti, Croce:
«[…] è comune convincimento che la scienza, come si dice, si scompagni dalla vita o dall’arte; e in questo proposito si arrecano esempi storici di individui e di popoli che, decadendo nella vita morale, tuttavia
chiaramente vedevano e teorizzavano il vero […] o, sterili nel produrre
l’arte, costruivano ottime teorie dell’arte […]. In qual modo bisogna interpretare quei fatti storici, posto che certamente l’interpretazione che se
ne suol dare non regge?»116.
E qui, per quanto omesso, il nome di Francesco De Sanctis è scritto a chiare
lettere. Di contro al critico irpino, infatti, Croce pensa che se la scienza è vera
scienza, se il pensiero non è arido acume né sofisticata chiacchiera, ma vero
pensiero, allora esso non può se non sorgere da un bisogno morale e non può
se non rinvigorire moralmente l’anima in cui sorge. Sicché anche in tempi di
decadenza la scienza è sempre progresso intellettuale e morale. è vero, prosegue Croce, che Machiavelli pur vedendo chiaro non poté rigenerare l’Italia ma
non perché il suo pensiero era guasto, quanto perché non tutti i nostri desideri
possono essere attuati:
«Ai nostri desideri e sogni non soccorre il nostro pensiero con l’azione
che l’accompagna, ma il nostro stesso desiderare e sognare o, se così piace, invocare: invocare con quella intensa fede che, picchiando e picchiando, si vede alfine aperta la porta, o che talvolta è costretta a rassegnarsi,
perché Dio non vuole che quella porta le s’apra almeno per allora. [sovente si fa] Confusione tra la parte che tocca all’uomo e quella che tocca
a Dio, tra quella che è dell’individuo e quella che è del corso delle cose o
della storia, alla quale si collabora ma che non si lascia comandare. […].
Volete una grande Italia. E se la storia la volesse invece piccola? Volete
nuovi poemi pari a quelli di Dante, nuovi drammi pari a quelli dello Shakespeare, nuove pitture pari a quelle di Michelangelo. E se la storia vi
consentisse solo brevi liriche e pagine di prosa e quadretti e miniature?
Francesco De Sanctis, cit., pp. 395-397, qui p. 395.
115 Ibidem.
116 Ivi, p. 396.
42
Maria Della Volpe
Che cosa, o piccoli uomini, con la vostra stessa volontà opporreste a queste disposizioni della Provvidenza? Meglio chinare la fronte alla potenza
che ci guida e ci soverchia»117.
Per Croce, dunque, il nesso tra pensiero e azione è inviolabile poiché, se così
non fosse, non solo andrebbero in frantumi i pilastri della terra, ma l’ordine
stesso del cosmo andrebbe perduto. Scienza e vita allora non sono l’una di contro all’altra, sibbene la forza dell’una è quella dell’altra, la sanità della prima va
di pari passo con quella della seconda. Vi sono sì tempi bui, barbarici, di crisi;
tempi finanche demoniaci in cui le furie si abbattono sulla terra, ma il pensiero,
la morale, l’azione, l’arte, serbate nel petto di chi per lei vita rifiuta, continueranno a vivere e a progredire; tempi in cui l’uomo potrà fare solo come chi sta
dinanzi ad una porta chiusa: invano egli si agiterà se il suo moto non asseconda
quello della superiore forza delle cose.
De Sanctis e Croce allora, avvertono la crisi che, in anni diversi e in diversi modi, corrompe gli animi, guasta i cuori e, tutti e due, ad essa oppongono,
per contrastarla, una rigenerazione delle forze morali e un rinnovamento dello
spirito religioso. Nondimeno essi sono animati da una fede e dunque da una
religione diversa: mazziniana e risorgimentale quella del primo, goethiana118 e
provvidenzialistica, potremmo dire, quella del secondo.
La religione, nella prospettiva crociana, non è infatti risolvibile nella famiglia, nella patria, nell’umanità, nella libertà, nella giustizia, ma è «innalzamento
all’Eterno»119. Essa penetra e compenetra tutta quanta la vita. Senza di lei le
scienze positive languirebbero, inaridirebbero120; le lotte politiche e sociali non
avrebbero impulso né alimento; la «verità», la «bellezza», le opere del «pensiero» e della «fantasia» abbandonerebbero la terra121. Essa, infatti, è poesia,
eroismo, coscienza dell’universale122. è accordo di «mente» e di «animo». è
«sanità» e «vigoria». è «cultura»123. è «aristocrazia»124. La religione, dunque,
Ibidem.
Croce, facendo sue le parole di Goethe, scrive che: «“Il tema proprio, unico e profondo
della storia del mondo e dell’uomo, il tema al quale tutti gli altri sono subordinati, consiste
nel conflitto della fede con la miscredenza”», in B. Croce, Storia economico-politica e storia
etico-politica, cit., p. 328.
119 B. Croce, L’intellettualità (1921), in Etica e politica, cit., pp. 226-229, qui p. 228.
120 Ibidem.
121 Ivi, p. 227.
122 Cfr. B. Croce, Religiosità (1922), in Etica e politica, cit., pp. 243-246, qui p. 246.
123 B. Croce, Storia del Regno di Napoli, cit., p. 210.
124 B. Croce, Religiosità, cit., p. 244.
117 118
In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
43
«antimitologica», libera da ogni residuo «utilitaristico» e «naturalistico»125, non
è, per Croce, la religione delle «genti», delle «tribù», dei «popoli» o dell’«umanità», ma «religione umana»126: «pura fede» che nasce dal pensiero e che diviene
fondamento d’azione, «lume di vita morale»127. Pur tuttavia quella che Croce
definisce «religione umana», non sarà immune dal ricorso a Dio, alla Grazia,
alla Provvidenza.
In note pagine del 1920, che recano il titolo «L’individuo, la Grazia e la
Provvidenza»128, Croce scrive:
«[…] ogni individuo sente che l’opera sua è un’opera a lui commessa,
che la forza sua gli viene prestata; e, nei momenti nei quali par quasi che
la sua vita sia sospesa o inaridita, invoca e aspetta che l’Eterno Padre, il
Tutto, rifluisca in lui, lo rianimi, lo spinga a un segno: e prega, invoca e
aspetta la Grazia»129.
Parrebbe qui, che Benedetto Croce rivolga lo sguardo al Dio Padre che è nei
cieli. Pur tuttavia basta poco per capire che l’atmosfera è di tutt’altro segno.
«Dio», «Grazia», «Provvidenza», scrive Croce, sono solamente metafore che,
solo se non intese rettamente, comportano dualismo e trascendenza130. Non si
tratta, qui, dunque, di forze estranee, ma «dell’eterno respiro»131 di un’unica
forza. Croce non vuole riproporre il vecchio dualismo, ma l’eterna «dialettica
dello spirito nella varietà ed unità delle sue forme»132.
Ma solo di metafore si tratta in realtà? «Dio», «Grazia», «Provvidenza» sono
dunque solo parole, formule, immagini che la filosofia conserva come semplice
«blasone di nobiltà»133? Chi fa la storia? Chi la guida? Chi la orienta?
Alessandro, Cesare, Napoleone furono artefici delle loro imprese? e Platone, Dante, Michelangelo furono autori delle loro opere sublimi? Né gli uni, né
gli altri lo furono, scrive Croce in un saggio del 1925 intitolato «L’individuo e
Ibidem.
Ivi, p. 245.
127 B. Croce, Storia economico-politica e storia etico-politica, cit., p. 330.
128 B. Croce, L’individuo, la Grazia e la Provvidenza, in «La Critica», 1920, pp. 123-127. Per
il prosieguo si citerà da questa edizione. Lo stesso saggio però, è stato riproposto da Croce in
Etica e politica, cit., pp. 132-135.
129 B. Croce, L’individuo, la Grazia e la Provvidenza, cit., p. 124.
130 Ivi, p. 126.
131 Ivi, p. 124.
132 Ivi, p. 126.
133 Ibidem.
125 126 44
Maria Della Volpe
l’opera»134. Le gesta dei «grandi uomini di pratica e di politica», si legge in queste brevi ma dense pagine, non appartengono punto a loro: essi non diressero
gli eventi, ma furono «diretti»135, non «autori», ma «collaboratori», «strumenti di una forza superiore»136. Analogamente si dirà delle opere del pensiero e
dell’arte: esse non appartengono all’individuo di cui portano il nome, bensì «al
corso delle cose, allo spirito universale»137.
Per Croce allora non è l’uomo, e neanche gli uomini o l’umanità, come abbiano detto prima a proposito della tetralogia storica, a fare la storia, a cambiarla, a indirizzarla: siamo sempre irrimediabilmente sopraffatti da una forza
che, però, ha il volto rassicurante della Provvidenza e lo sguardo salvifico di
Dio. Che è sì la storia, ma è anche il senso della storia; è sì il mondo ma anche
le leggi che lo regolano e lo orientano.
La storia così, con il cambiare dei tempi e con gli incalzare degli eventi, diventa sempre più nelle pagine crociane, un «divino mistero»138 cui l’uomo prende parte con la parte a lui commessa. Essa, infatti, è «peccato» e «redenzione»139,
lotta tra «bene e male»140, «Dio» e «Mefistofele»141, «luce e tenebre», «fede e
miscredenza»142. È «teofania»143.
La storia, dunque, la «storia per eccellenza», intima, spirituale, morale ma,
anche e soprattutto, religiosa è, come Croce l’ebbe a definire nel 1924, la «vera
storia dell’umanità». Che poi, come abbiamo cercato di dire, non è mai storia
eminentemente umana.
VI. Conclusioni
Al cospetto della crociana storia dell’umanità allora la storia del De Sanctis diventa, come Croce ebbe a dire, storia nazionale, italiana144, tipica opera
B. Croce, L’individuo e l’opera (1925), in Etica e politica, cit., pp. 140-144.
Ivi, p. 140.
136 Ivi, p. 141.
137 Ivi, p. 142.
138 B. Croce ad E. Marroni, lettera del 17. 11. 1919, in Epistolario I, cit., p. 38.
139 B. Croce, La storia come pensiero e come azione, cit., p. 17.
140 Ivi, p. 42.
141 Ivi, p. 162.
142 B. Croce, Storia economico- politica e storia etico-politica, cit., p. 328.
143 B. Croce, Esperienze storiche attuali (1948), in Filosofia e storiografia, cit., pp. 306-312,
qui p. 309.
144 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis,
cit., p. 253.
134 135 In margine alla recente pubblicazione degli scritti di B. Croce su F. De Sanctis
45
del Risorgimento da cui egli, però, non poco ebbe da imparare145. È proprio
pensando a De Sanctis, infatti, come si è cercato di mostrare sopra attraverso
l’analisi del volume crociano sugli scritti di Francesco De Sanctis, che Croce
definisce la storia come storia morale, intima, spirituale, una storia che, dinanzi alle nuove istanze, ai nuovi bisogni del vivo presente, prende poi il nome di
storia etico-politica. Che è, come Croce scrive in più di un luogo, la vera storia
dell’umanità. Storia morale, questa, ma anche e soprattutto storia religiosa i cui
protagonisti ed eroi non sono quelli delle altre storie. Gesù di Nazareth e Paolo
di Tarso, Lutero e Mazzini in essa risaltano più di un Augusto e di un Tiberio,
di uno Shakespeare e di un Rosmini.
Per quanto, dunque, programmaticamente aliena da qualsivoglia contaminazione con la filosofia della storia e con la storia universale, la crociana storia
dell’umanità – che non è storia particolare, speciale, ma vera storia, storia per
eccellenza - finisce però col fondersi e confondersi con queste. Essa, infatti,
così come Croce la pensa, investe non solo la sfera umana ma il cosmo tutto, al
punto tale che, con l’incalzare degli anni e degli eventi, si configura sempre più
come scontro tra forze cosmiche: bene e male, luce e tenebre. Sicché, rompendo ed erompendo dagli argini delle storie nazionali e da quelli stessi dell’umanità, essa si eleva al rango di storia teofanica.
La storia desanctisiana allora, pur essendo storia morale, intima, appare,
dinanzi alla crociana storia dell’umanità, come una microscopica isola.
Alla fine del nostro discorso, però, non possiamo non rilevare che nonostante le critiche e le prese di distanza, De Sanctis resta per Croce l’amato maestro.
Amato con quell’amore di chi sa che «amare è […] conoscere i limiti della cosa
amata»146.
145 B. Croce, Errori ‘di fatto’ ed erroti ‘di concetto’nella critica desanctisiana (1952), in Scritti
su Francesco De Sanctis, cit., pp. 577-580, qui p. 580.
146 B. Croce, La letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX: Francesco De Sanctis,
cit., p. 258.
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
47
Descartes e la filosofia trascendentale:
a proposito di Lauth lettore di Cartesio
Memoria di Salvatore Principe
presentata dal socio naz. ord. res. Fabrizio Lomonaco
(seduta del 30 gennaio 2009)
Abstract Reinhard Lauth exposes the ideal connection that ties the philosophical approach of
Descartes, Kant and Fichte in different places of his works and in special way in a monograph
devoted to the French philosopher: Descartes. The conception of the system of the philosophy.
In these pages the author develops the thesis of a continuity of the transcendental philosophy
beginning from Descartes up to Fichte, passing for Kant and Reinhold. It underlines as in the
French philosopher there is not only the origins of that that it then will be the transcendental
philosophy, but that, indeed the transcendental turn, necessary to the “Copernican revolution” of
Kant, mature, knowingly or less, really with Descartes. In these pages I intend to verify the legitimacy de iure of a theoretical position that is set de facto to the base of a certain type of historicalconceptual reconstruction of the thought of the French philosopher.
Reinhard Lauth1 espone il nesso ideale che lega l’approccio filosofico di Descartes, Kant e Fichte in diversi luoghi2 delle sue opere e in special modo in una
1 Qualche breve notizia a proposito della figura di R. Lauth, massimo animatore della “Scuola
di Monaco” è sicuramente doverosa nel ricordo, a due anni dalla sua dipartita. R. Lauth nacque
l’11 di agosto del 1919 a Oberhausen, dove realizzò i suoi studi secondari dal 1930 al 1938. Dopo
la seconda guerra mondiale studiò Filosofia, Romanistica e Fisiologia dal 1938 al 1942 simultaneamente agli studi di Medicina. In questa materia si laureò nel 1944 presso l’Università di Kiel. Nel
1948 ottenne la Cattedra di Filosofia a Monaco. Aveva realizzato allora due lavori: La domanda sul
senso dell’esistenza, pubblicato nel 1950 in Monaco, e La Filosofia di Dostoivewski, anch’esso pubblicato a Monaco lo stesso anno. Il suo mentore fu Alois Wenzl. Dall’aprile del 1955 fu professore
universitario di Fondamenti della Filosofia presso l’Università di Monaco, dal 1968 a Tel Aviv ed a
Gerusalemme. Nel 1975-76 ha tenuto corsi all’Università di Parigi, conferenze al Collège di France,
e presso l’Accademia delle Scienze Sociali di Beijing. Da allora ha impartito la sua docenza in molte altre Università. Dal 1961 assunse la direzione dell’edizione critica delle opere di Fichte presso
l’Accademia Bavarese delle Scienze. Ha pubblicato 31 dei volumi di quest’opera storico-critica, ed
è stato il responsabile di importanti incontri scientifici sull’opera di Fichte dal 1977. Nel mondo
filosofico Lauth è universalmente conosciuto come il filosofo trascendentale che assume e svolge
con straordinario rigore gli assunti fondamentali della dottrina di Fichte (quel Fichte del quale è
anche impeccabile editore), e prima ancora di Descartes e di Kant. In tal senso la linea DescartesKant-Fichte offre il retroterra e la concettualità specifica della prospettiva sistematica della filosofia
trascendentale di Lauth.
2 Cfr. R. Lauth, Con Fichte, oltre Fichte, a cura di M. Ivaldo, Trauben, Torino 2004; Id.,
48
Salvatore Principe
monografia dedicata al filosofo francese, Descartes. La concezione del sistema
della filosofia. In queste pagine l’autore svolge la tesi di una continuità della filosofia trascendentale a partire da Descartes fino a Fichte, passando per Kant
e Reinhold. Sottolinea come nel filosofo francese non vi siano solo le origini di
quella che poi sarà la filosofia trascendentale, ma che, effettivamente la svolta trascendentale, necessaria alla “rivoluzione copernicana” di Kant, maturi,
consapevolmente o meno, proprio con Descartes. Perciò già con questi ci troveremmo appieno in una filosofia di tipo trascendentale o, volendo essere più
cauti, in un pensiero che si sviluppa lungo una direzione o prospettiva da Kant
e da Fichte poi identificata come trascendentale. E tuttavia Lauth ritiene che il
nesso di interconnessione di Descartes con gli altri due sia da riscontrarsi nella
concezione che il filosofo francese matura del “sistema della filosofia”, ovvero
della filosofia intesa come l’edificio sistematico delle conoscenze in generale.
A noi pare che questo nesso tra Descartes, Kant, Fichte sia di per sé valido e,
tuttavia, al contempo abbastanza labile se fondato su un principio, quello della
“filosofia come sistema”, che non ci sembra essere caratteristica del solo trio
preso in considerazione, ma anzi capace di richiamare alla mente non solo
Schelling ed Hegel, ma Wolff e Baumgarten prima di Kant. Né ci sembra che
questi condividano con Descartes il proprium di tale nesso richiamato da Lauth
e, cioè, l’atteggiamento trascendentale, nel senso che se un nesso sussiste tra
queste tre figure della filosofia e le loro dottrine, esso è, a nostro avviso, da ricercarsi nell’atteggiamento metodologico con il quale si apprestano a fare filosofia
piuttosto che nell’idea di “sistema” o della filosofia come sistema3.
La posizione di Descartes come filosofo trascendentale non era certo una
novità allorché Lauth si accingeva a scrivere il suo saggio sul filosofo francese.
Non a caso egli espressamente cita gli importanti studi di M. Gueroult4 e di
Descartes- La concezione del sistema della filosofia, a cura di M. Ivaldo, Guerini e Associati, Milano 2000; Id., Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und Dostojewski,
Meiner, Hamburg 1989; Id., Zur Idee der Transzendentalphilosophie, Pustet, München u. Salzburg 1965; Id., Vernünftige Durchdringung der Wirklichkeit. Fichte und sein Umkreis, Ars Una,
München 1994. Circa l’interpretazione cartesiana di Lauth si veda la puntuale esposizione fornitane recentemente in T. Valentini, Sistema di filosofia trascendentale e fondamenti conoscitivi
degli oggetti d’esperienza. Reinhard Lauth interprete di Descartes, in A. Allegra e G. Marchetti (a
cura di), Le forme dell’oggetto. Percorsi della rappresentazione nella filosofia moderna, Morlacchi
Editore, Perugia 2007, pp. 23-61.
3 Si ricorderà in tal proposito la distinzione notevole avanzata da Cassirer tra “Spirito di
sistema” e “Spirito sistematico” (Cfr. E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung). Sia Descartes che Kant ci sembrano orientati verso quest’ultimo, mentre espresso intento di Fichte è
invece quello di costruire un sistema che sia a fondamento della scienza in generale, appunto
la Dottrina della Scienza (Cfr. prima lezione della Dottrina della Scienza seconda esposizione
del 1804).
4 Cfr. M. Gueroult, Descartes selon l’ordre des raisons, 2 voll., Aubier, Paris 1968.
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
49
F. Bader5; quest’ultimo ha certo trattato largamente della posizione di Descartes all’interno dell’ideale processo di sviluppo della filosofia trascendentale. Tra
l’altro l’accostamento di Descartes al termine trascendentale era stato adottato
già da Husserl6 nelle Meditazioni cartesiane. La novità di Lauth sta innanzitutto nella specificazione del termine “trascendentale” che in Husserl appare con
contorni concettuali non meglio determinati che da una suggestione; determinazione concettuale che in Lauth viene attuata mediante l’ipotesi storiografica
di un filo rosso che leghi i portati filosofici di Descartes a quelli di Kant e di
Fichte. Nel suo “Descartes. La concezione del sistema della filosofia” Lauth ha
affermato chiaramente che:
«Descartes non soltanto rientra nella sfera del pensiero originariamente trascendentale, ma si evidenzia come uno dei pensatori maggiori
in questa chiave, che in alcuni dei suoi punti di partenza è proceduto più
innanzi di tutti quelli che sono venuti dopo, come Kant, Maimon, Reinhold, Fichte e Husserl. Non si può riflettere sulla problematica specifica
della comprensione trascendentale della filosofia nella modernità senza
riconoscere a Descartes una posizione decisiva»7
Si tratta, come lo stesso Lauth dice di una interpretazione retrospettiva, ovvero della non troppo storiograficamente ortodossa operazione di lettura, anzi
di rilettura di un filosofo con la coscienza pre-comprensiva del portato filosofico della filosofia successiva, lettura che è suscettibile di giustificazione nell’ottica propria della filosofia trascendentale.
Per fare ciò, scrive il filosofo bavarese, «dobbiamo valutare la ‘filosofia prima’ di Descartes in chiave prospettica, muovendo da quanto hanno fatto i successivi scopritori di un tale sistema. È grazie a questi che concezioni su aspetti
specifici dell’essere spirituale che sono del tutto peculiari di Descartes e che
sono state da lui creativamente scoperte, acquisiscono, mediante la loro funzionalità in quanto momenti generativi del sistema dello spirito, un grande significato, allorché le si riconosce»8. Una lettura della filosofia di Descartes condotta
alla luce degli sviluppi successivi di una filosofia che si vuole mostrare nasca
con lui. Insomma l’esposizione di una tesi di storiografia filosofica che tracci i
5 Cfr. F. Bader, Die Ursprünge der Transzendentalphilosophie bei Descartes, 3 voll., Bouvier,
Bonn, 1979.
6 Cfr. E. Husserl, Meditazioni cartesiane, tr. it. a cura di F. Costa, RCS Libri, 1996.
7 R. Lauth, Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., p. 11.
8 Ivi, p. 189.
50
Salvatore Principe
momenti dello sviluppo aurorale della filosofia trascendentale nell’ottica del legame Descartes, Kant, Fichte e che, al contempo, operi in quanto tale una reinterpretazione complessiva della filosofia cartesiana; una interpretazione che
non si pone semplicemente come tale ma che tende ad una profonda autolegittimazione. E, tuttavia, ciò che mi pare Lauth lasci come assunto in via preliminare senza alcuna legittimazione di diritto di una pretesa che di fatto si trova
sullo sfondo di tutta la sua trattazione (così come vorrebbe l’approccio stesso
della filosofia trascendentale) è il fatto stesso che si possa dire Descartes filosofo
trascendentale, se non altro perchè mai il filosofo francese ha utilizzato questo
termine nei suoi scritti né per descrivere la sua filosofia né tantomeno in riferimento ad altri9. La tesi su menzionata del fondamento del nesso nell’approccio
trascendentale alla filosofia in generale è, infatti, da Lauth lasciata sullo sfondo
ad ogni mentre della sua interpretazione quasi a criterio di intendimento di un
certo modo di concepire la filosofia come sistema. Varrebbe a dire che il nesso
fra i tre sussisterebbe nella loro idea della filosofia quale sistema sviluppantesi
secondo un tipo di approccio alla filosofia che è da definirsi trascendentale. Il
punto è che in tal caso Lauth avrebbe dovuto chiarire adeguatamente la questione dell’approccio o prospettiva trascendentale in Descartes e di riflesso negli
altri due, con la conseguenza che sarebbe risultato superfluo sottolineare il legame fra i tre in base alla loro idea della filosofia come sistema. Questa, invece,
come lo stesso Lauth osserva sul finire del libro, risulta in Descartes solo accennata e non completamente espressa10; affermazione con la quale ad un tempo
sta e cade l’impianto teorico giustificativo che Lauth aveva voluto edificare sin
dall’inizio del libro nella sua ricostruzione della filosofia cartesiana alla luce del
suo presunto legame ideale con “l’idea della filosofia come sistema” in Kant e
Fichte. Ciò che qui è in questione non è la reinterpretazione in un ottica di filosofia trascendentale della filosofia cartesiana quanto la legittimazione di una
tale operazione. Ciò che Lauth attua è la diretta reinterpretazione della filosofia
cartesiana con un significativo risultato di rilevante incremento ermeneutico
che amplia positivamente gli orizzonti concettuali di aspetti fondamentali della
filosofia cartesiana. Il punto è che lo fa senza legittimare preliminarmente questa sua posizione, destinata altrimenti a risultare storiograficamente e interpretativamente poco adeguata e anzi foriera di fraintendimenti; cosa che per altro
l’analisi di Lauth non fa, apportando anzi notevole chiarezza in punti nodali del
9 Ivi, p. 356.
Ivi, pp. 379-381; p. 386.
10 Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
51
pensiero cartesiano come il ruolo del giudizio e dell’immaginazione nella gnoseologia cartesiana11, lo statuto della volontà12, e l’unione di corpo e anima13.
Ciò che intendo fare in queste pagine è, dunque, verificare la legittimità de iure
di una posizione teorica posta de facto al fondamento di un certo tipo di ricostruzione storico-concettuale del pensiero del filosofo francese. Partendo dalle definizioni
che sia Kant che Fichte danno di Trascendentale e di Filosofia trascendentale verificherò la legittimità della posizione di Lauth attraverso una consultazione diretta
dei testi di Descartes e un confronto incrociato con i passi di Kant e Fichte. D’altra
parte è ciò che lo stesso Lauth invitava sempre a fare, considerando la “filosofia
trascendentale” come quel particolare tipo di approccio genetico ai problemi fondamentali che non si limita solo alla posizione di tesi ma alla legittimazione autoevidente delle stesse. Ciò ci permetterà di abilitare il nesso Descartes, Kant, Fichte
e di legittimare una pretesa di interpretazione della filosofia cartesiana in questo
senso non fondando il nesso sull’ “idea del sistema della filosofia” ma sul proprium
della filosofia trascendentale, cosa che ci pare Lauth abbia inteso, ma non espressamente tematizzato, lasciandola come l’implicito della sua esplicita tesi.
Ciò che va osservato in via preliminare, è che quando parliamo di trascendentale o di prospettiva trascendentale più che di un termine sic et simpliciter si
tratta di un approccio, di una forma mentis, un modus philosophandi. Dunque,
posto che riteniamo che il nesso fra questi tre filosofi possa essere giustificato
in base al fatto che tutti e tre assumono nella loro riflessione quella che noi
qui chiamiamo una “prospettiva trascendentale”, è doveroso preliminarmente chiarire che cosa si intenda con questo lemma. Prima di definire Descartes
filosofo “trascendentale” bisognerà dunque stabilire con cura cosa si intende
con questo termine e perciò cosa si intende per filosofia trascendentale. L’accostamento che Lauth fa tra Descartes, Kant e Fichte ci dà l’indicazione di come
delineare questo lemma a partire dal portato kantiano-fichtiano. In un passo
famoso della Critica della ragione pura si legge:
«Chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa, non degli oggetti ma del nostro modo di conoscere gli oggetti, in quanto è possibile
a priori»14. E precisa «Bisogna chiamare trascendentale non ogni conoscenza a priori ma solo quella per cui sappiamo che e come certe rappreIvi, p. 239 e sgg.
Ivi, p. 317 e sgg.
13 Ivi, p. 283 e sgg.
14 I. Kant, Critica della ragione pura, tr. it. a cura di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 48.
11 12 52
Salvatore Principe
sentazioni (intuizioni o concetti) sono applicate o sono possibili esclusivamente a priori. È cioè trascendentale la conoscenza della possibilità
della conoscenza o dell’uso di essa a priori»15
Con ciò il “trascendentale” non si identifica, per Kant, con le condizioni a
priori della conoscenza umana e dei suoi oggetti (che sono i fenomeni); ma è
piuttosto inteso come la conoscenza (o la “scienza” come dirà Fichte) di tali
condizioni a priori. Da questo punto di vista, “trascendentale” non è «ciò che
è al di là di ogni esperienza»16, ma piuttosto «ciò che antecede l’esperienza (a
priori) pur non essendo destinato ad altro che a rendere possibile la semplice
conoscenza empirica»17.
Il termine fu ripreso da Fichte per designare la sua Dottrina della Scienza.
Per Fichte è precisamente il “punto di vista della filosofia trascendentale” che
deve essere sottolineato. A tal proposito nella seconda esposizione della Dottrina della Scienza del 1804 Fichte delinea in questo modo il proprium della filosofia trascendentale:
«Per poco che voglia riflettere, ciascuno può rendersi conto e vedere
che assolutamente ogni essere presuppone un pensiero o una coscienza
dell’essere stesso; che, di conseguenza, il semplice essere è sempre soltanto una metà di cui l’altra metà è il pensiero di esso, quindi è il membro di una disgiunzione originaria e situata più in alto che svanisce soltanto per chi non rifletta o pensi superficialmente. L’unità assoluta può
essere posta altrettanto poco nell’essere quanto nella coscienza che gli si
oppone, altrettanto poco nella cosa quanto nella rappresentazione della
cosa; essa deve essere posta nel principio da noi scoperto dell’assoluta
unità e inseparabilità di entrambi, principio che, come abbiamo visto, è
contemporaneamente il principio della loro disgiunzione; noi vogliamo
dunque chiamarlo sapere puro, sapere in sé, dunque assolutamente non
Ivi, p. 80; cfr. Prolegomeni ad ogni futura metafisica, par. 13, Osservazione III.
A tale riguardo il riferimento kantiano è alla tradizione della scolastica tedesca e più in
generale di un certo tipo di aristotelismo medievale che da essa era stato assunto. Si tratta in
generale dei tre trascendentali “Unum” “Verum” “Bonum”, intesi come attributi trascendenti la materia terrena perchè attribuibili come tali alla sola sostanza divina. Cfr. J. De Vries,
Grundbegriffe der Scholastik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1983, pp. 96-97.
Per una trattazione organica del termine trascendentale in Kant si vedano: N. Knoepffler, Der
Begriff „transzendental“ bei Immanuel Kant, Herbert Utz Verlag, München, 2005 (5. Auflage),
(in particolare, riguardo all’eredità della scolastica tedesca, pp. 13-16); R. Eisler, Kant-Lexikon,
Georg Olms Verlag, Hildesheim- Zurich- New York 1984, alla voce „transzendental“.
17 I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica, Appendice, nota [A204].
15 16 Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
53
sapere di un oggetto, poiché in questo caso non sarebbe un sapere in
sé, ma mancherebbe ancora oggettività al suo essere, a differenza della
coscienza, che sempre pone un essere e che perciò non è che una delle
due metà. Questo lo scoperse Kant, che divenne perciò il fondatore della
filosofia trascendentale. La Dottrina della Scienza è filosofia trascendentale come la filosofia kantiana, del tutto simile ad essa nel porre l’assoluto né nella cosa, come è avvenuto finora, né nel sapere soggettivo, cosa
che propriamente è impossibile – poiché colui che riflettesse sul secondo
termine dovrebbe certamente tenere anche il primo –, ma nell’unità di
entrambi»18.
Dunque se con Kant abbiamo una definizione del lemma “trascendentale”
con Fichte, oltre ad una reiterazione di tale definizione, osserviamo una consapevole fondazione della filosofia trascendentale con una espressa identificazione di essa, le cui origini il filosofo della Dottrina della Scienza rintraccia nella
filosofia critica di Kant che egli qui appunto definisce trascendentale.
«La filosofia trascendentale è dottrina del sapere, soltanto questo. Lo
stesso rapporto con l’oggetto, che è costitutivo del sapere, deve essere
giustificato – nel senso di ricostruito riflessivamente nella sua condizione
di possibilità – dal sapere necessariamente dentro l’orizzonte referenziale e autoreferenziale del sapere stesso»19
A tal proposito, occupandosi di Fichte, Marco Ivaldo non parla tanto di “filosofia trascendentale” quanto di “visione trascendentale”, quello che io penso si
possa esprimere anche con “prospettiva trascendentale” o anche – come ho detto
prima – come “atteggiamento trascendentale”, impegnato a definire un modus
facendi piuttosto che una struttura predeterminata come edificio o sistema.
«Ciò che caratterizza l’approccio trascendentale è che il principio viene ricercato tramite una radicalizzazione dell’autoriflessione (“osserva
te stesso!”) che conduce ad evidenziare la condizione necessaria di pos18 J. G. Fichte, WS. 1804-II, pp. 10-11, tr. it., Dottrina della scienza, seconda esposizione del
1804, a cura di M. V. d’Alfonso, Guerini e Associati, Milano, 2000, pp. 63-64. Per questo specifico passo mi sono avvalso della traduzione, fornitane da M. Ivaldo (cfr. M. Ivaldo, I principi del
sapere. La visione trascendentale di Fichte, Bibliopolis, Napoli, 1987, p. 41-42), che ho ritenuto
in questo caso stilisticamente più corretta e rispondente all’originale tedesco.
19 M. Ivaldo, I principi del sapere. La visione trascendentale di Fichte, Bibliopolis, Napoli,
1987, p. 47.
54
Salvatore Principe
sibilità del sapere. Il principio fondamentale nell’impostazione trascendentale è la non “soggettiva” ma universale e necessaria condizione di
possibilità del sapere, è cioè il principio di un ontologia del sapere, o
meglio – se si prende specificamente in considerazione il contributo di
Fichte – di un’ontologia della coscienza finita»20
Trascendentale, dunque, in sintesi è ciò che rientra nei limiti della conoscenza possibile sintetica a priori, cioè non trascende l’esperienza empirica, ma è
fondamento della sua possibilità. Non è né trascendente né empirico né tanto
meno una banalizzante via di mezzo, ma è il fondamento “formale” di ogni conoscenza in generale. Un sapere che sia trascendentale studia non gli oggetti
della conoscenza, siano essi empirici (il questo o il quello fattuale), oppure metafisici (i concetti di sostanza e di accidente), ma quelle modalità o attuazioni
del pensare che ci permettono la conoscenza degli oggetti, cioè le facoltà della
mens e le investiga nel loro articolarsi all’interno del processo conoscitivo che
è insieme teoretico e pratico. Va da sé che un sapere di tipo trascendentale non
ammette al suo interno separazioni tra gnoseologia e ontologia, oppure tra teoretica, pratica e estetica, considerato che, pur distinguendo in via del tutto
metodico-funzionale tali ambiti (appunto ambiti “disciplinari”), esso studia le
“facoltà” dell’io sempre nel loro articolarsi. Questo rimane lo stesso benché si
atteggi in modi specifici e diversi a seconda che l’oggetto della conoscenza sia
un oggetto empirico in generale oppure un concetto logico astratto o un dilemma morale o un’opera artistica, (laddove questa distinzione è però sempre di
natura alquanto fittizia e, in definitiva, insussistente).
Trascendentale è, insomma, un sapere circa le “facoltà” dell’uomo, i principi
e le modalità di queste “facoltà”. Un sapere trascendentale o filosofia trascendentale è un sapere né solo teoretico, né solo pratico, né solo estetico, ma tutti
questi insieme e riguarda il loro fondamento, il che ci rimanda al concetto su
menzionato di Dottrina della Scienza.
La domanda di partenza di una filosofia trascendentale è: “Come posso sapere ciò che affermo?”. Questa filosofia implica, in maniera concomitante, il rendiconto riflessivo delle operazioni che il filosofo realizza; e ciò in maniera tale
da tendere alla coincidenza del suo dire e del suo fare. Perciò quella trascendentale è una filosofia che deve sempre di nuovo diventare consapevole del punto
di vista da cui vengono avanzate le sue affermazioni. In tal senso non possiamo
avere in filosofia conoscenza ontologica (che affermi cioè qualcosa a proposi20 Ivi, p. 76.
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
55
to di ciò che è) senza concomitante giustificazione epistemologica, senza cioè
che si mostri come tale conoscenza venga in essere in atti dell’essere-cosciente,
visto nella totalità e complessità delle sue prestazioni, anche pre-consapevoli.
Quella che Fichte chiama Dottrina della Scienza è precisamente la ricostruzione
di tali atti costituenti dell’esperienza; così anche per la Critica della ragione pura
di Kant e per i Principi della Filosofia di Descartes. La filosofia trascendentale
non estende materialiter il nostro sapere-di-esperienza quale esso si dà volta a
volta nella vita; piuttosto essa regredisce ai principi dell’avere in generale un
sapere-di-esperienza. In quest’ottica l’atteggiamento o prospettiva trascendentale consente di identificare un certo tipo di approccio al problema della filosofia indipendentemente dal fatto che il filosofo al quale si attribuisce un tale
atteggiamento ne sia consapevole oppure no. Certamente nel caso di Kant e in
quello di Fichte ciò avviene con dichiarata consapevolezza. Non egualmente si
può dire per Descartes, del quale però si può esibire appunto un certo atteggiamento trascendentale che ci pare sia il vero punto di inizio della filosofia trascendentale. È quell’atteggiamento che si trova alla base dello spostamento cartesiano del punto archimedico21 che sarebbe il punto di inizio della “rivoluzione
copernicana” di Kant. Diversi sono i luoghi delle opere del filosofo francese in
cui traspare questo “atteggiamento”, che risulta proprio della sua investigazione filosofica sul cogito e sulle sue facoltà, così come si può vedere sollecitando i
testi cartesiani mediante lo spunto delle riflessioni di Kant e Fichte. Da quanto
fin qui detto, nel tentativo di esplicazione del lemma “filosofia trascendentale”,
si può dedurre che in quanto presa di coscienza delle modalità della propria
conoscenza e propria coscienza, quella filosofia si pone come propedeutica del
sapere in generale, appunto critica della ragione o dottrina della scienza che
investiga i principi del sapere o della filosofia. Come osserva Lauth,
«la filosofia trascendentale è propedeutica nell’esposizione dei passaggi dal non-sapere al sapere e di nuovo dal sapere al non-sapere. Come
tale si propone anzitutto il Discours. Già i titoli delle opere principali che
sono qui in questione esprimono che le esposizioni di Descartes sono “directio ingenii”, “méthode pour bien conduire sa raison et cercher la vérité
dans les sciences”, “recherche de la vérité”. La filosofia, come Descartes la
intende, non può non essere propedeutica, dato che persegue la progressiva ascesa al sapere supremo e la progressiva discesa nel dispiegamento
(résolution) delle forme del sapere in passi deduttivi evidenti, ed essa in21 Cfr. H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2004, p. 211.
56
Salvatore Principe
segna insieme nella sua esposizione a colui che apprende come egli deve
procedere se vuole conoscere e realizzare verità»22
Per essa «i mezzi conoscitivi e le forme possibili del procedimento devono
venire chiarite precedentemente a ogni asserzione relativa a cose e devono venire impiegati in maniera corrispondente. Le Regulae ad directionem ingenii
sono regole del procedimento dell’indagine scientifica e indicazioni a prestare
attenzione a per mezzo di quale facoltà conoscitiva viene eseguito un tale procedimento, fino a che punto può avanzare l’esecuzione, che cosa viene in tal
modo acquisito. Il Discours de la méthode ha per oggetto la sintesi di queste procedure, in vista della realizzazione non soltanto di scienze particolari, ma della
sapienza in quanto tale come sapere del sapere, cioè come filosofia»23.
Non è un caso che in questo senso le parole di Descartes e quelle di Fichte
abbiano lo stesso tono. Quando infatti Fichte, nel corso di lezioni private tenuto
nel 1803 sulla Dottrina della scienza, descrive quale è il modo adeguato di prepararsi a qualsiasi conoscenza ovvero descrive un metodo generale per le scienze
da contrapporre alla disattenzione e all’incoscienza, osserva:
«1) In generale, raddoppiamento dell’attenzione, raddoppiamento in
senso proprio, cioè che si faccia attenzione, e si renda massima ferma e
incrollabile quella di fare attenzione a fare attenzione. […]
2) Bisogna abituarsi a elaborare qualcosa secondo una regola fissa,
stabilita in precedenza e incrollabile (qui questa doppia attenzione si trova già di per sé, verso la regola – e verso l’oggetto da elaborare, e le sue
interne proprietà). Il pensare consueto non è così: oppure anche nel caso
in cui venga presa a pretesto una regola, partizione, e così via, come nelle
prediche, nei libri ecc., ciò è in gran parte solo facciata; i pensieri, prodotti del resto solo per associazione di idee, stanno sotto queste rubriche
solo esteriormente, ma non vengono collegati interiormente dalla regola
in quanto organo del loro collegamento.
3) In proposito, una buona regola: pensare scrivendo: tenere carta e
penna; prima di stendere qualcosa per iscritto, infatti, si pensa se questo
va bene a questo punto, e ci si coglie di sorpresa. Al contrario, nel mero
meditare, senza corrigens esterno, la fantasia non ha nulla da temere, e
prende facilmente il volo.
22 23 R. Lauth, Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., pp. 376-377.
Ivi, p. 356.
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
57
4) Mantenersi ora in modo particolare all’interno di queste vedute
scientifiche; provarle da tutti i lati, ad es. su teoremi matematici. Bisogna
essere e restare al loro interno; finché non ci si sente saldi, sarebbe addirittura opportuno non fare altro»24
Facilmente il lettore attento si accorgerà che il tono di queste riflessioni è
molto simile a quello delle quattro regole del metodo nel Discours. Entrambi
i passi, infatti, con le necessarie distinzioni dovute alle evidenti differenze
linguistiche e stilistiche, hanno analoghi obiettivi e intenti: comunicare quale sia l’atteggiamento e il metodo più giusto per l’autore nell’avvicinarsi allo
studio di qualsiasi tipo di verità, ovvero quale sia l’approccio metodologico
generale più adeguato alle impostazioni fondamentali di qualsiasi sapere.
Ritroviamo confermata in questa similitudine la caratteristica propedeutica
propria della “filosofia trascendentale”. Non solo, ma per di più così come
per Descartes anche per Fichte tali osservazioni non si pongono come indicazioni perentorie di un metodo, ma semplicemente come l’esposizione del
metodo che personalmente l’autore della Dottrina della Scienza così come
quello del Discours hanno adottato. Difatti a proposito di tali consigli metodologici Fichte osserva:
«[...] i miei consigli sono tanto più ininfluenti, e ogni individuo deve
decidere da sé in che misura prestarvi ascolto e come applicarli»25
In apertura della sua II esposizione della Dottrina della Scienza nel 1804,
Fichte scrive:
«La caratteristica della nostra epoca, secondo me, è che in essa la vita
sia diventata solo storica e simbolica, mentre assai raramente si pervenga a una vita reale. Una non insignificante parte costitutiva della vita è il
pensare. Una volta che l’intera vita sia impallidita a storia estranea, anche
al pensiero dovrà accadere proprio lo stesso. Si sarà certo udito e notato
che gli uomini, tra le altre cose, possono anche pensare; e che in effetti ve
ne sono stati parecchi che hanno pensato, che uno ha pensato in un certo
modo, il secondo in un altro, il terzo e il quarto in un altro modo ancora, ciascuno in modo diverso; anche come ciò sia riuscito; – tuttavia alla
24 J. G. Fichte, Privatissimum 1803, Dodici lezioni sulla dottrina della scienza, Edizioni
E.T.S., pp. 83-84.
25 Id., Dottrina della scienza, seconda esposizione del 1804, cit., p. 67.
58
Salvatore Principe
decisione di esercitare una buona volta questo pensare in prima persona
non si giungerà facilmente»26
Analogamente Kant della Critica della ragione pura:
«Ormai, dopo aver inutilmente tentato (se n’è convinti) tutte le vie,
impera sovrano il fastidio ed un totale indifferentismo, padre del caos
e della notte, nelle scienze, ma ad un tempo origine o almeno preludio
di un loro prossimo rinnovamento e rischiaramento, mentre uno zelo
male impiegato le aveva rese oscure, confuse e inservibili. […] Frattanto,
questa indifferenza, che s’incontra proprio in mezzo al fiorire di tutte le
scienze, e che tocca appunto quella, alle cui conoscenze se fosse possibile
averne, meno si vorrebbe rinunziare, è un fenomeno che merita attenzione e riflessione. Non è per certo effetto di leggerezza, ma del giudizio maturo dell’età moderna, che non vuole più oltre farsi tenere a bada da una
parvenza di sapere, ed è un invito alla ragione di assumersi nuovamente
il più grave dei suoi uffici, cioè la conoscenza di sé»27
Queste osservazioni dei due filosofi tedeschi non sono molto dissimili nel
tono e nel contenuto dall’apertura del Discours e dall’articolo 1 dei Principia
Philosophiae. Mantengono intatto il carattere autobiografico della constatazione storica della vertenza culturale che era generalizzata in un relativismo di posizioni e che di fronte all’avanzare univoco delle scienze matematiche e fisiche
non facevano altro che porre in continuo dubbio la verità portata innanzi dalla
filosofia con tutta la serie dei valori morali e teologici che da essa discendono.
Né si dimentichi che tutti e tre i filosofi qui considerati sentono la spinta a porre
le basi certe della propria scienza delle scienze per salvaguardare un patrimonio valoriale da essi ritenuto moralmente rilevante.
E, ancora, se consideriamo il passo seguente tratto anche esso dall’esposizione 1804 della Dottrina della scienza:
«Se tutta la filosofia trascendentale – tale è anche la kantiana, e a tale riguardo la dottrina della scienza non se ne è ancora distinta –, pone l’assoluto
non nell’essere nè nella coscienza, bensì nel loro legame, verità e certezza
in sé e per sé = A (Assoluto), segue allora [...] che per una tale filosofia la
26 27 Ivi, pp. 55-56.
I. Kant, Critica della ragione pura, cit., p. 6.
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
59
differenza tra essere e pensare come in sé valida scompare assolutamente.
Mentre tutto ciò che in essa risiede nello sguardo intuente [Erschauung] che
proprio nelle ultime ore abbiamo prodotto in noi: nella visione che non ci
sia essere senza pensare e viceversa – essere e pensare del tutto simultanei,
senza che possa accadere nulla nell’ambito che dell’essere appare, senza che
parimenti – se solo si è riflettuto correttamente e non quasi sognato – compaia nell’ambito che del pensare appare, e viceversa»28
Qui la mente vola subito alle considerazioni, quasi alle scoperte dirompenti,
della primarietà del cogito e della consustanzialità di essere e pensare che con
esso sono posti alla base di qualsiasi possibile ammissione di realtà e verità.
Essere e pensare sono assolutamente compresenti nel Cogito seppure in modo
puntuale. In ciò il Cogito rappresenta il primo vero per conoscenza, mentre Dio
è il primo vero per essenza. E che Fichte abbia ben considerato il portato cartesiano in proposito risulta da quanto l’autore tedesco osserva a proposito del
cogito cartesiano nel Fondamento dell’intera dottrina della scienza, commentando il principio “cogito, sum” come «principio fondamentale del sapere», «che
non deve essere la minore e la conclusione di un sillogismo, la cui premessa
maggiore suona: quodcumque cogitat, est, ma che egli [Descartes] può assai
bene aver considerato come un fatto immediato della coscienza»29. E tutto ciò
ricordando probabilmente quanto proprio Descartes affermava nella risposta
alle seconde obiezioni30.
Fichte nelle sue Eigne Meditationen scrive:
«L’io che si presenta [l’io che si realizza in un atto, non soltanto l’io
rappresentante] viene intuito intellettualmente, ovvero l’intuito è insieme
l’intuizione. Non c’è alcun patire: viene intuita un’azione. […] In quanto
l’io è attivo nel rappresentare, se esso venisse intuito come tale una tale
intuizione sarebbe intellettuale. Soltanto si chiede: una tale intuizione è
possibile, perviene alla coscienza? Oppure viene semplicemente pensata,
perciò inferita? […] L’io sono – perviene alla coscienza? Sì, ma non alla
coscienza empirica, sebbene alla pura: ed è la coscienza pura»31
J. G. Fichte, Dottrina della scienza, seconda esposizione del 1804, cit., pp. 72-73.
Id., Fondamento dell’intera dottrina della scienza, tr. it. a cura di G. Boffi, Bompiani,
Milano, 2003, p. 157.
30 R. Descartes, Œuvres AT IX-1, p. 110: «Lorsque quelqu’un dit: Je pense, donc je suis, ou
j’existe, il ne conclut pas son existence de sa pensée comme par la force de quelque syllogisme,
mais […] il le voit par une simple inspection de l’esprit»
31 J. G. Fichte, Eigne Meditationen, Fichte Akademie Ausgabe, II, 3, p. 144; cit. in R. Lauth,
28 29 60
Salvatore Principe
Commentando questo passo che egli stesso cita, Lauth commenta, che «ciò
corrisponde precisamente all’idea di Descartes!»32. Così come non si può non
notare una certa analogia tra questo passo cartesiano tratto dalla lettera a Mersenne del luglio 1641:
«È impossibile che potessimo mai pensare a qualcosa senza che contemporaneamente avessimo l’idea della nostra anima, come di qualcosa
capace di pensare a tutto ciò che pensiamo»33
E quello kantiano:
«L’Io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni:
ché altrimenti verrebbe rappresentato in me qualcosa che non potrebbe essere per nulla pensato, il che poi significa appunto che la rappresentazione o sarebbe impossibile, o, almeno per me, non sarebbe. Quella rappresentazione che può esser data prima di ogni pensiero, dicesi
intuizione»34
Affermazione che potrebbe ben essere avvicinata all’osservazione cartesiana
in risposta a un quesito di Burman:
«La coscienza è infatti insieme pensare e riflettere il proprio pensiero.
È falso però dire che ciò non possa avvenire durante il precedente pensiero. Infatti […] l’anima può pensare contemporaneamente molte cose e
[in ciò] perseverare nel suo pensiero, e in quanto le piaccia può riflettere
sul suo pensiero ed esser così consapevole del proprio pensiero»35
Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., p. 271.
32 R. Lauth, Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., p. 271.
33 R. Descartes, Œuvres AT III, p. 394: «Il est impossible que nous puissoins jamais penser à
aucune chose, que nous n’ayons en même temps l’idée de notre Âme, comme d’une chose capable
de penser à tout ce que nous pensons».
34 I. Kant, Critica della ragione pura, cit., p. 110. Va detto tra l’altro che Kant risulta non
aver compreso del tutto chiaramente il portato cartesiano in proposito e in molti punti crede
di correggere Descartes apportando quei chiarimenti al portato del filosofo francese che egli
stesso aveva già fatto: «[…] la mia esistenza non si può considerare come conseguente alla
proposizione: Io penso, come la ritenne Cartesio (perché, se no, dovrebbe precedere la premessa maggiore: tutto ciò che pensa esiste) ma è identica ad essa» (Critica della ragione pura,
cit., p. 274).
35 R. Descartes, Entretien avec Burman, Œuvres AT V, p. 149: «Conscium esse est quidem cogitare et reflectere supra tuam cogitationem; sed quod id non possit fieri manente priori cogitationem,
falsum est, cum […] anima plura simul cogitare et in sua cogitatione perseverare queat, et quotiescumque ipsi libuerit ad cogitationes suas reflectere, et sic suae cogitationis conscius esse».
Descartes e la filosofia trascendentale: a proposito di Lauth lettore di Cartesio
61
Posto dunque il legame dei tre nel generale approccio “trascendentale” alla
filosofia, risulta chiaro che ognuno a suo modo ponendosi all’investigazione dei
principi fondamentali del sapere non possano non richiamarsi vicendevolmente, per cui si intravede un filo rosso tra l’annunciarsi del Cogito, “l’appercezione
trascendentale” e “l’intuizione intellettuale” fichtiana.
Su questa base si possono leggere certo le opere di Descartes come espressioni graduali del darsi aurorale della filosofia trascendentale. In tal senso è
pienamente condivisibile l’osservazione di Lauth che pur ammettendo che in
fondo la filosofia cartesiana non «ha compiuto il sistema del sapere finito»36
guardando la filosofia di Cartesio alla luce di quella prospettiva trascendentale osserva come il Discours sia l’espressione del programma scientifico che
Cartesio ha in animo di compiere; nelle Regulae presenta il metodo di questa
ricerca; nelle Meditationes l’argomento e la prova del che e del come conosciamo davvero l’esistenza; nei Principia la ricapitolazione dell’epistemologia presupposta e la sua applicazione alla fisica; nelle Passioni dell’anima l’analisi del
lato “volontativo”37 della metafisica mediante la fisiologia dell’anima, in stretta
connessione al tema dell’unio di mente e corpo38. Effettivamente, se osserviamo
le opere di Descartes in modo sinottico ci accorgiamo della veridicità dell’analisi di Lauth. In ogni testo di Descartes che sia cronologicamente successivo o
precedente ad un altro viene ripreso e ampliato un punto che nell’altro era stato
accennato o abbozzato, o esplicitamente posto come anticipazione di un lavoro
successivo. Accade così nel Discours per le Meditationes e viceversa, come nei
riferimenti impliciti che nel Discours Descartes fa alle sue Regulae; chiude il
cerchio la lettera a Picot39 nella quale Descartes mostra le sue opere all’interno
del loro nesso sistematico che mostra come egli non si occupi della verità ma
del modo di conoscere e discernere la verità, il che è appunto “filosofia trascendentale”. Descartes vede insomma in nuce il sistema della filosofia trascendentale così come lo auspicheranno Kant e Fichte, non come sistema dei saperi, ma
come architettonica dei saperi e metodologia propedeutica di essi, ancora una
volta filosofia prima o dottrina della scienza.
R. Lauth, Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., p. 384.
Col termine “volontativo” cerco di rimarcare in italiano la differenza tedesca tra Wille e
Willkür, ovvero tra il lato strutturale della volontà intesa come facoltà entro l’articolarsi delle
attività della mens (Wille, lato volontativo), e il lato dell’arbitrato morale (lato volontario, Willkür).
38 Cfr. R. Lauth, Descartes- La concezione del sistema della filosofia, cit., pp. 384-385.
39 Cfr. R. Descartes, I principi della filosofia, in Opere filosofiche I, a cura di E. Garin, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 7-20.
36 37 62
Salvatore Principe
E dunque effettivamente, ora, a partire dal presupposto trascendentale e
dalla sua graduale esplicazione è possibile vedere le opere di Descartes come
punti graduali di uno stesso discorso, di uno stesso sistema del sapere, o sistema della filosofia, in analogia con quanto maturerà nella filosofia critica di Kant
e nella filosofia di Fichte. Ma solo ammesso il presupposto trascendentale si
può discutere legittimamente della filosofia di Descartes in quanto sistema del
sapere in generale; ed è per questo in fondo che le sue opere non sono rubricabili in opere teoretiche o gnoseologiche o pratiche; esse sono opere di filosofia
trascendentale.
Posta una tale base dimostrativa e legittimante che, mi pare, in un’ottica
trascendentale, non si possa lasciare come assunta sottobanco ma vada invece dimostrata legittima nella sua posizione, l’argomentazione di Lauth, allora, risulta valida e maggiormente comprensibile, e tuttavia – come dicevamo
all’inizio – risulta anche come tale limitata in quanto differenza specifica di un
atteggiamento generale che accomuna i tre e che risulta caratterizzare maggiormente le loro filosofie.
Il tema della reine Erfahrung
63
Il tema della reine Erfahrung
nella prima edizione delle Grenzen di Heinrich Rickert
Memoria di Chiara Russo Krauss
presentata dal socio naz. ord. res. Edoardo Massimilla
(seduta del 30 gennaio 2009)
Abstract. The topic of reine Erfahrung in the first edition of Heinrich Rickert’s Die Grenzen.
Proceeding from an analysis of two paragraphs of Die Grenzen, where Rickert deals with the
problem of the objectivity of historical sciences and with the connection between physical
and psychic, this essay aims at clarifying Rickert’s references to Avenarius’ thought, showing
how the influence and the critical dialogue with the founder of empiriocriticism run through
the pages of the book. Even if they disagree about the role – not the meaning – of subject and
object in the gnoseology, according to Rickert, Avenarius’ positions still represent an example
of radical and coherent empiricism, against the natural-scientific worldview.
1. L’oggettività empirica
Se la concezione dell’esperienza rinvenibile all’interno delle Grenzen1 di Heinrich Rickert è in generale influenzata dall’immanentismo di Richard Avenarius2,
un confronto esplicito con la nozione avenariusiana di reine Erfahrung si trova in
particolare nel paragrafo intitolato “Die empirische Objektivität”3 il secondo del
quinto e ultimo capitolo dell’opera. Il paragrafo in questione fa parte di un tritti1 L’opera venne pubblicata in due momenti successivi: i primi tre capitoli nel 1896, il
quarto e quinto nel 1902. La prima edizione cui facciamo riferimento è quella del 1902: H.
Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in
die historischen Wissenschaften, Tübingen-Leipzig, 1902 (d’ora in poi: Grenzen); tr. it. I limiti
dell’elaborazione concettuale scientifico naturale. Un’introduzione logica alle scienze storiche, a
cura di M. Catarzi, Napoli, 2002.
2 Rickert conosceva Avenarius non solo tramite i suoi scritti, ma anche personalmente; i due si
conobbero a Zurigo nel 1885 ed ebbero modo di frequentarsi. Fu così che Rickert potette entrare
in contatto con l’ambiente filosofico che ruotava attorno alla rivista fondata e diretta da Avenarius,
la «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie». A questa stessa rivista avevano tra l’altro già collaborato figure come Friederich Paulsen, di cui Rickert era stato allievo a Berlino, ma
soprattutto Windelband, che – oltre ad essere il maestro di Rickert – era stato anche collega di
Avenarius a Zurigo. Cfr. M. Catarzi, A ridosso dei limiti. Per un profilo filosofico di Heinrich Rickert
lungo l’elaborazione delle Grenzen, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2006, p. 49.
3 Grenzen, pp. 626-642; tr. it. cit., pp. 333-341.
64
Chiara Russo Krauss
co in cui Rickert desidera mostrare che, in qualunque modo si voglia determinare l’oggettività – “empirica”, come nel caso di chi parte dall’esperienza pura, “metafisica” o “critica”, come negli altri casi presentati4 – l’elaborazione concettuale
storica gode sempre di un’oggettività almeno pari a quella della Begriffsbildung
scientifico-naturale. Pertanto le posizioni di Avenarius non vengono evocate per
essere smentite o sostenute da Rickert, quanto piuttosto per mostrare come esse
non possano essere usate per assegnare alle scienze storico-culturali un posto di
minor rilievo rispetto a quello delle scienze della natura.
Rickert comincia la sua difesa dell’oggettività della storia proprio a partire
dal punto di vista della reine Erfahrung, in quanto esso è quello che «suole essere ritenuto come il punto di vista che nella gnoseologia ha meno presupposti»5.
Tale caratterizzazione ha un significato ben preciso derivante da Avenarius stesso, il quale affermava essere compito fondamentale della critica dell’esperienza
pura il «concepire qualsiasi comportamento teoretico in generale – in se stesso
e nel suo rapporto con il comportamento pratico, anche questo considerato in
generale – come conseguenza di un unico semplice presupposto»6. Di questo
presupposto, chiamato da Avenarius «presupposto empiriocritico»7, vengono
date diverse formulazioni all’interno della Kritik der reinen Erfahrung, la prima
delle quali recita così: «Una qualsiasi parte costitutiva del nostro ambiente si
trova con gli individui umani in un rapporto tale che, se quella è posta, questi
asseriscano una esperienza»8; detto altrimenti, un contenuto di coscienza viene
caratterizzato come “esperienza”9 quando, in sua corrispondenza, viene posto
un costituente dell’ambiente. Questo presupposto empiriocritico è «unico» e
«semplice» perché non pretende di determinare ulteriormente cosa siano l’am4 “Die metaphysische Objektivität”, in Grenzen, pp. 642-660; tr. it. cit., pp. 341-358. “Die
kritische Objektivität”, in Grenzen, pp. 674-704; tr. it. cit., pp. 358-374.
5 Grenzen, p. 626. Catarzi rende invece il passo tedesco «weil als der voraussetzungloseste
Standpunkt in der Erkenntnistheorie der Standpunkt der reinen Erfahrung zu gelten pflegt»
con «poiché in gnoseologia il punto di vista con meno presupposti è quello dell’esperienza
pura». Cfr. tr. it. cit., p. 333.
6 R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, Hildesheim-Zürich-New York, 2004, vol. I, p. V;
tr. it. parziale, Critica dell’esperienza pura, a cura di A. Verdino, Bari, 1972, p. 3.
7 Ibid., vol. I, p. 11; tr. it. cit., p. 16.
8 Ibid., vol. I, p. 3; tr. it. cit., p. 7.
9 Bisogna distinguere in Avenarius l’esperienza pura dall’“esperienza” indicata fra virgolette. Mentre la prima è data dal piano immanente sul quale si trova tutta la realtà, e costituisce il «presupposto empiriocritico» da cui si sviluppa tutto il sistema filosofico avenariusiano, l’“esperienza” è invece un determinato contenuto di coscienza, presente all’interno
dell’esperienza pura, che l’individuo caratterizza come dipendente da uno o più costituenti
dell’ambiente. L’esperienza pura, in sé, non conosce alcuna contrapposizione tra contenuti di
coscienza e ambiente, né – a maggior ragione – conosce “esperienze”; pertanto queste ultime
costituiscono solo una determinazione che si sviluppa a partire della rottura dell’unità originaria dell’esperienza pura. Cfr. ibid., vol. II, pp. 363-365; tr. it. cit., pp. 115, 116.
Il tema della reine Erfahrung
65
biente e i suoi costituenti, o la coscienza e i suoi contenuti; specifica infatti
Avenarius che «chi accetta il presupposto empiriocritico non è affatto obbligato
ad assumere, per esempio, anche che col concetto di valori R venga simultaneamente posto, o non posto, un qualsiasi concetto di “materia” o di “oggetto della
conoscenza”, di “cosalità” o addirittura di “sostanzialità”; o che col concetto
di valori E venga simultaneamente posto, o non posto, un qualche concetto di
“anima” o almeno un concetto di “coscienza”»10. Parlando di «ambiente» Avenarius non vuole quindi riferirsi a una qualche realtà fuori dall’esperienza, e da
cui questa derivi o rispetto alla quale si adegui, ma vuole indicare il correlato,
il significato che l’esperienza stessa pone ed esprime; è per questo che essa si
qualifica come esperienza pura, in quanto è «un’asserzione alla quale non è
mescolato nulla che non sia a sua volta esperienza, la quale quindi non è, in se
stessa, altro che esperienza»11.
Pertanto, quando Rickert parla del punto di vista della reine Erfahrung come
di quello dell’oggettività empirica, che riconduce «il valore dei giudizi a verità
puramente fattuali (rein tatsächlichen Wahrheiten)»12, non bisogna intendere
questa fattualità nel senso di una realtà effettiva che trascenda l’esperienza pur
essendo tramite essa conoscibile. Infatti l’oggettività del punto di vista della
reine Erfahrung è empirica non perché l’esperienza sia la forma di conoscenza
più vicina ad una realtà effettiva cui bisognerebbe riportare ogni nostro sapere,
ma perché tutto il reale e tutto il sapere umano si esplicano esclusivamente sul
piano immanente dell’esperienza pura; così che Rickert stesso specifica che ciò
10 Ibid., vol. I, p. 22; tr. it. cit., pp. 27-28. «Valori E» e «valori R» sono i termini con cui Avenarius indica rispettivamente i contenuti dell’“esperienza” e i costituenti dell’ambiente; formule coniate appunto per evitare che nel presupposto empiriocritico venga assunto più di quanto
dovuto, assimilando così l’empiriocriticismo a teorie gnoseologiche o scientifiche determinate.
Il progetto avenariusiano di una sorta di metafilosofia in grado di spiegare tutto il comportamento teoretico umano si regge anche sulla creazione di tale metalinguaggio filosofico, che
ha creato non poche difficoltà alla comprensione e trasmissione del suo pensiero persino a
colui che viene solitamente accostato ad Avenarius, tanto da essere etichettato anch’egli come
empiriocriticista, ovvero Ernst Mach. Ne L’analisi delle sensazioni, parlando del suo rapporto
con Avenarius, Mach non manca di criticarne a più riprese il lessico. Ad esempio: «Avenarius
ci presenta un’esposizione schematica molto esauriente, mantenuta però in termini generali,
la cui comprensione è resa difficile da una terminologia estranea, inconsueta»; oppure: «Nel
primo scritto [la Kritik der reinen Erfahrung] la terminologia un po’ ipertrofica mi impedì di
poter godere la gioia di un’adesione piena. È chiedere troppo a un uomo già avanti negli anni
di imparare, oltre alle molte lingue dei popoli, anche la lingua di un singolo» (E. Mach, L’analisi delle sensazioni e il rapporto tra fisico e psichico, Milano 1975, p. 70 e p. 72).
11 R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. I, p. 5; tr. it. cit., p. 10.
12 Grenzen, p. 626. Dove Rickert usa l’espressione «rein», come nel qui presente «rein
tatsächlichen Wahrheiten» o nel successivo «rein empirische Geltung», ho preferito tradurre
con «puramente», invece che con il «semplicemente» proposto da Catarzi, per rendere più
evidente il riferimento alla reine Erfahrung. Cfr. tr. it. cit., p. 333.
66
Chiara Russo Krauss
che caratterizza questo empirismo è il sostenere che «non solo il materiale, ma
anche i punti di vista che orientano la sua elaborazione possiedono una validità
puramente empirica (rein empirische Geltung)»13, ovvero tutta interna al piano
dell’esperienza pura.
Se nella gnoseologia puramente empiristica il punto di vista che orienta
l’elaborazione concettuale è dato dal confronto diretto tra oggetti che guida le
generalizzazioni, così che – essendo questi oggetti da intendere come aggregati
di componenti dell’esperienza – esso ricade sempre all’interno della reine Erfahrung, parimenti, aggiunge Rickert, ricade nella reine Erfahrung anche la constatazione dell’esistenza dei valori, in quanto essi costituiscono dei dati di fatto
empiricamente riscontrabili quando ci si volga ad osservare il comportamento
umano e sociale. Così il punto di vista dei valori che orienta l’elaborazione concettuale storica risulta conciliabile e giustificabile all’interno di una prospettiva
empiriocriticista; al contrario – aggiunge Rickert – di quello che accade secondo la «concezione scientifico-naturale», per la quale i valori costituiscono la
«pietra dello scandalo»14. Possiamo quindi notare come Rickert contrapponga
il punto di vista della reine Erfahrung a quello di una visione del mondo scientifico-naturale. Ciò che differenzia le due posizioni è il modo di considerare i
rapporti tra esperienza e realtà, nonché tra individuale e generale; contrapposizione che avvicina l’empirismo puro alle opinioni di Rickert, segno dell’influenza che le opere di Avenarius hanno avuto sulla sua formazione filosofica.
Nell’empirismo puro, infatti, i costituenti dell’ambiente espressi dall’esperienza sono assunti dal presupposto empiriocritico «in tutta la loro determinatezza e mutabilità»15, ed è solo tramite l’elaborazione concettuale che vengono
sviluppate – a partire dalle ricorrenze dell’esperienza – quelle che Avenarius
chiama le «costanti perfette del sistema C»16, ovvero i concetti generali che fissano artificialmente una realtà empirica in origine individuale e mutevole. Se
quindi da tale prospettiva, comune a Rickert e all’empirismo puro, la realtà
coincide con l’esperienza ed è come costitutivamente mutevole ed individuale,
dal punto di vista di una visione del mondo scientifico-naturale o razionalistica,
invece, la vera realtà non è quella testimoniata dall’esperienza, bensì una realtà
Grenzen. pp. 626-627; tr. it. cit. 333.
Grenzen. p. 627; tr. it. cit. 333.
15 R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. I, pp.12-13; tr. it. cit., p. 18.
16 Ibid., vol. I, p. 182; tr. it. cit., p. 67. Il «sistema C» in Avenarius è l’insieme di funzioni che
vengono generalmente implementate dal sistema nervoso umano, tuttavia è possibile vedere
anche un gruppo di individui legati dallo svolgimento di funzioni comuni, in particolar modo
quella «di conservazione», come un «sistema C di ordine superiore». Cfr. ibid., vol. I, p. 158;
tr. it. cit., p. 63.
13 14 Il tema della reine Erfahrung
67
generale e immutabile come le leggi che la reggono e gli atomi che la compongono. Pertanto mentre nell’empirismo puro i concetti sono uno strumento con
cui l’uomo elabora l’esperienza e quindi la realtà – posizione anch’essa condivisa da Rickert – secondo la visione del mondo scientifico-naturale essi svelano
invece quella che è la vera realtà al di là dell’apparenza dell’esperienza17.
Da ciò si comprende anche perché l’elaborazione concettuale storica sia inconciliabile con una visione del mondo scientifico-naturale: per un verso infatti
i valori, la cui esistenza è empiricamente constatata, non costituirebbero un
valido principio di elaborazione concettuale, dal momento che l’esperienza da
cui sono tratti non costituisce la vera realtà; per un altro verso la realtà stessa,
essendo essenzialmente generale, non potrebbe né dovrebbe essere conosciuta
tramite una elaborazione concettuale individualizzante come quella della storia, e pertanto i punti di vista costituiti dai valori, che reggono tale elaborazione, sarebbero ad ogni modo inutili. Al contrario, se – come accade per la prospettiva della reine Erfahrung – si ritiene che la realtà coincida con l’esperienza
e sia originariamente individuale, non si può rifiutare il riconoscimento empirico dei valori e l’esigenza di una conoscenza – che di quei valori si serve – volta
a rendere scientificamente conto dell’individualità della realtà.
Rickert prosegue la sua analisi dell’oggettività empirica della storia cercando di affrontare due obiezioni che si frappongono alla sua equiparazione con le
altre scienze, facendo nascere dubbi sulla validità della conoscenza storica rispetto a quella delle scienze naturali. Entrambe queste obiezioni sono legate al
problema di una presunta minore validità delle elaborazioni concettuali storiche rispetto a quella delle elaborazioni concettuali scientifico-naturali: la prima
obiezione pone il problema della porzione di realtà in rapporto alla quale i due
tipi di elaborazione concettuale sono validi; la seconda pone invece il problema
del carattere più o meno condiviso dei principi di selezione che orientano i due
tipi di elaborazione concettuale.
Per quel che riguarda la prima questione, Rickert sottolinea come non sia
possibile, sul piano dell’esperienza pura, sostenere che i risultati delle scienze
naturali e storiche abbiano differenti ambiti di validità a partire dal fatto che i
concetti delle prime – fondati sulla astrazione generalizzante – arriverebbero a
valere per l’intera realtà in qualunque luogo e tempo, mentre i concetti delle seconde – fondati sul riferimento a valori empiricamente riscontrati all’interno di
17 La prospettiva propria di una visione del mondo scientifico-naturale viene poi analizzata da Rickert nel dettaglio all’interno del paragrafo “Die metaphysische Objektivität”, successivo a quello dedicato al punto di vista della reine Erfahrung. Cfr. Grenzen, pp. 642-660; tr. it.
cit., pp. 341-358.
68
Chiara Russo Krauss
una determinata comunità – varrebbero solo all’interno della porzione di realtà
dalla cui esperienza sono stati tratti. Infatti dalla prospettiva di un empirismo
puro coerente i concetti scientifico-naturali possono valere esclusivamente per
quelle esperienze determinate dalla cui osservazione e dai cui confronti sono
stati ricavati, e avere così una validità solo empiricamente generale. L’idea di
una validità assolutamente generale, invece, presuppone che si possano «formulare giudizi su di una molteplicità di cose e di processi immensa, quindi non
direttamente accessibile all’esperienza»18. Pertanto, il punto di vista della reine
Erfahrung non può accettare quest’ultima forma di validità perché l’affermazione secondo cui «ciò che vale per mille casi osservati vale “probabilmente” anche
per il milleunesimo»19, si fonda su un presupposto sovraempirico, su un a priori
che «deve precedere ogni osservazione»20 e che non può essere tratto dal o giustificato sul piano della pura esperienza.
In queste pagine l’obiettivo polemico di Rickert non è certamente Avenarius,
ma tutte le forme non sufficientemente radicali di empirismo in cui si fanno nascostamente valere presupposti propri di una visione del mondo scientifico-naturale e razionalistica. In Avenarius, infatti, le generalizzazioni empiriche con
cui opera l’elaborazione concettuale, per quanto reiterate, non pervengono mai
ad una validità assolutamente generale. All’interno della Kritik l’unico concetto
che gode di una tale validità è proprio quello di esperienza pura, che costituisce
il solo «concetto universale» o «multiponibile dell’ordine più alto pensabile»21.
Ma esso non è il frutto di generalizzazioni bensì, per l’appunto, un presupposto: quell’«unico» e «semplice» «presupposto empiriocritico» su cui si fonda il
sistema filosofico avenariusiano.
Appurato che dal punto di vista della reine Erfahrung bisogna accordare tanto ai
concetti delle scienze naturali quanto a quelli della storia una validità solo empiricamente generale, Rickert affronta il nodo costituito dalla possibilità di un universale riconoscimento dei principi di selezione su cui essi si fondano. Potrebbe sembrare, infatti, che la comparazione empirica attraverso la quale vengono elaborati i concetti della
scienza sia priva di quell’arbitrio che parrebbe invece connaturato al riconoscimento
dei valori, così che la validità dei risultati di un confronto tra degli oggetti debba essere
riconosciuta da tutti, al contrario dei frutti dell’elaborazione concettuale storica operante tramite riferimento a valori. Rickert controbatte rilevando che «proprio sul ter-
Grenzen, p. 628; tr. it. cit., p. 334.
Grenzen, p. 637; tr. it. cit., p. 338.
20 Grenzen, p. 638; tr. it. cit., p. 339.
21 Si veda il capitolo “Die Beziehung der Weltbegriffe zur reinen Erfahrung”, in R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. II, pp. 403-416; tr. it. cit., pp. 140-153.
18 19 Il tema della reine Erfahrung
69
reno dell’esperienza pura questa affermazione risulta inattuabile», in quanto «sia nella
scienza della natura che nella storia, non è la “cosa stessa” che determina il contenuto
dei concetti, ma è il soggetto conoscente che decide che cosa è essenziale e che cosa
non lo è»22. Essendo infatti insita in ogni singola configurazione della realtà un’infinita
molteplicità intensiva, vi sono innumerevoli punti di vista da cui si possono confrontare due oggetti, e pertanto «una comparazione scientifico-naturale puramente empirica
ha comunque bisogno di un punto di vista che la orienti e (…) la scelta di un punto di
vista, per unificare ciò che è comune, rest[a] sempre un atto “arbitrario”»23.
Questo significa che nel momento in cui il punto di vista della reine Erfahrung, al contrario di quello scientifico-naturale, non contempla l’esistenza
di una «cosa stessa», ovvero di una “vera realtà” essenzialmente generale che
fornisca il termine di riferimento e la misura – in senso pieno – oggettiva delle
nostre generalizzazioni, allora deve ammettere che la direzione verso cui noi
sviluppiamo i confronti e le classificazioni dei mutevoli e variegati componenti
dell’esperienza è il risultato di nostre scelte arbitrarie. Da ciò consegue che la
validità che viene riconosciuta ai risultati dell’elaborazione concettuale scientifica, nel puro empirismo, non può derivare dalla loro aderenza alla “vera realtà”
ma deve quindi dipendere da una adesione24 (Zustimmung) altrui ai punti di
vista orientanti la ricerca, adesione che non è incondizionatamente accordata
da tutti in ogni tempo e luogo, ma deve essere guadagnata volta per volta, uomo
per uomo, in un orizzonte spazialmente e temporalmente determinato e quindi
empiricamente limitato. Questo comporta che tanto i valori che guidano l’elaborazione concettuale storica, tanto i punti di vista che orientano quella scientifico-naturale sono validi soltanto a partire dal riconoscimento effettivamente
– e quindi fattualmente – accordatogli da gruppi di individui, e che ai risultati
dell’una e dell’altra bisogna attribuire lo stesso grado di oggettività empirica.
Anche in questo caso il bersaglio delle considerazioni di Rickert sono i cultori
di un empirismo non sufficientemente radicale, e non Avenarius stesso. Quest’ultimo infatti riconosce da un lato che «non si può intraprendere alcun tipo di
analisi senza introdurre un qualsiasi punto di vista da cui la si intraprende»25,
ed è consapevole dall’altro che nell’orizzonte del puro empirismo la validità dei
risultati delle scienze, non potendo dipendere dalla «cosa stessa», da una realtà
esterna che faccia da referente di ogni elaborazione, consiste nell’accordo interpersonale che tali risultati riescono a ottenere. Per Avenarius è il commercio
Grenzen, p. 630; tr. it. cit., p. 335.
Ibid.
24 Grenzen, p. 631; tr. it. cit., p. 335.
25 R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. I, p. 10; tr. it. cit., p. 14.
22 23 70
Chiara Russo Krauss
linguistico a garantire una validità superindividuale alle nostre conoscenze, al
punto che quella che noi chiamiamo la “verità” è definibile come una modificazione, condizionata linguisticamente e quindi socialmente, dei caratteri «fidenziali» – quali “esistente”, “sicuro” o “noto” – la cui peculiarità consiste nella
“concordanza” (Übereinstimmung) dei valori E propri e altrui26. Se fosse solo la
caratterizzazione delle esperienze come “sicure” o “esistenti” a determinare la
validità dei giudizi, Avenarius incorrerebbe nella critica condotta da Rickert a
chi pretende di far passare la «sensazione psicologica di ovvietà» per una «giustificazione logica»27. Ma dal momento che le esperienze, per essere chiamate
“vere”, devono necessariamente ottenere una «epicaratteristica dialettica»28 la
posizione di Avenarius non incorre nell’obiezione di Rickert.
Riassumendo la propria analisi dell’oggettività empirica, Rickert osserva
anche che coloro i quali prendono coerentemente le mosse dalla prospettiva
della reine Erfahrung – per la quale «non solo il materiale, ma anche i punti
di vista che orientano la sua elaborazione possiedono una validità puramente
empirica»29 – non solo non possono negare l’oggettività e la validità dei risultati delle scienze storiche, ma debbono anzi riconoscere che «è la storia la vera
scienza di esperienza»30, sia perché essa mira a conoscere la realtà empirica
nella sua effettiva individualità, sia perché i valori che costituiscono il principio
di selezione della sua elaborazione concettuale godono dal punto di vista empirico di un riconoscimento generale più ampio di molti dei punti di vista che
orientano la comparazione generalizzante delle scienze della natura31.
2. Soggetto e oggetto
Non si può però affrontare il problema della presenza del tema della reine
Erfahrung all’interno delle Grenzen senza toccare una delle sezioni del testo in
26 Cfr. R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. II, p. 140. Per vedere nel dettaglio
come Avenarius analizzi il modo in cui il discorso interindividuale fa sì che le “esperienze”
acquistino i caratteri di “concordanza”, “certezza”, “verità”, etc., si veda il capitolo “Modifikationen im Sinne einer dialektischen Epicharakteristik”), vol. II, pp. 129-151; (Ibid. sintetizzato
dal curatore dell’edizione italiana in R. Avenarius, Critica dell’esperienza pura, cit., pp. 80-81.
27 Grenzen, pp. 630-631; tr. it. cit., p. 335.
28 Cfr. R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, cit., vol. II, p. 140.
29 Grenzen, pp. 626-627; tr. it. cit., p. 333.
30 Grenzen, p. 634; tr. it. cit., p. 337.
31 Sui temi rickertiani fin qui trattati cfr. E. Massimilla, Il saggio di Rickert sul “generale”
e la storia come traccia di un itinerario weberiano nelle Grenzen, in «Archivio di storia della
cultura», XX (2007), pp. 39-110, in part. pp. 74-79.
Il tema della reine Erfahrung
71
cui questo argomento, così come l’influsso di Avenarius, sono più vivi: ovvero il
paragrafo intitolato “Physisch und Psychisch”32 del secondo capitolo. Come abbiamo detto Rickert condivide con il punto di vista della reine Erfahrung l’identificazione della realtà con l’esperienza, il che lo porta a confrontarsi con le
opinioni di Avenarius quando si tratta di chiarire, a partire da questa presa di
posizione, in che rapporti si trovino soggetto ed oggetto, nonché – appunto – fisico e psichico. L’affermazione che tutto l’essere si trova sul piano dell’esperienza, infatti, conduceva quelli che Rickert chiama «presunti positivisti» e «cultori
dell’esperienza pura» ad una «metafisica spiritualistica» che «vorrebbe bollare
tutto l’essere come psichico»33. In una nota della stessa pagina Rickert, dopo
aver citato come rappresentante di queste posizioni M. Verworn – il quale nella
sua Allgemeine Physiologie sosteneva che «esiste solo la psiche»34 – si dichiara
sorpreso che egli, per supportare tali opinioni, «voglia richiamarsi proprio alla
Kritik der reinen Erfahrung di Avenarius, in cui idee del genere sono decisamente avversate»35.
Tanto per Rickert quanto per Avenarius, infatti, identificare la realtà con
l’esperienza non vuol dire ricondurre la sfera del fisico a quella dello psichico, ma porre come primaria un’esperienza che non conosce alcuna differenza
sostanziale e che precede ogni divisione concettuale tra questi due domini. Da
un lato infatti, come sottolinea Rickert, manca ormai una sostanza “anima”
che faccia da oggetto specifico delle ricerche della psicologia; dall’altro, conseguentemente, i termini che solitamente le si attribuivano – come «psychische» o
«seelische» – «non forniscono alcuna indicazione sul contenuto del concetto di
quei processi a cui sono attribuiti»36. In altri termini, in assenza di un referente
sostanziale, i vocaboli della psicologia hanno un significato meramente arbitrario, derivante dal modo in cui si sceglie di sezionare il campo originariamente
unitario dell’esperienza nei due regni del fisico e dello psichico. A conferma di
queste osservazioni Rickert riporta proprio una citazione di Avenarius che recita: «il termine psichico è perciò puramente convenzionale; dopo l’eliminazione
del concetto di anima, è addirittura divenuto privo di senso»37.
Ciò nonostante, pur sostenendo entrambi che l’identificazione della realtà
Grenzen, pp. 151-183; tr. it. cit., pp. 83-100.
Grenzen, p. 178; tr. it. cit., p. 97.
34 M. Verworn, Allgemeine Physiologie, Jena, 1895, p. 38; citato in Grenzen, p. 179 in nota;
tr. it. cit., p. 97 in nota.
35 Grenzen, p. 179 in nota; tr. it. cit., p. 97 in nota.
36 Grenzen, p. 152; tr. it. cit., p. 84.
37 R. Avenarius, Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes der Psychologie I, in «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», XVIII (1894), p. 141; citato in Grenzen, p. 152
in nota; tr. it. cit., p. 84 in nota.
32 33 72
Chiara Russo Krauss
con l’esperienza non può e non deve condurre ad una sua psichicizzazione perché l’esperienza – proprio essendo tutta la realtà – non è considerabile né fisica
né psichica, Rickert e Avenarius fondano questo loro comune convincimento
su basi differenti, che rimandano al modo in cui essi concepiscono il rapporto
tra soggetto e oggetto.
In Avenarius l’esperienza che non conosce alcuna differenza tra fisico e psichico è l’esperienza pura, la quale è presupposto «unico» e «semplice» anche in
quanto è unità originaria che precede tutte le divisioni e specificazioni classiche
della gnoseologia e delle scienze, come quella già citata tra fisico e psichico, o
quella tra soggetto e oggetto. La reine Erfahrung, infatti, si contraddistingue
perché non è l’esperienza che consegue dall’incontro, dalla sintesi, tra un soggetto esperiente ed un oggetto esperito. Essa è “pura” in quanto è esperienza
libera da ogni determinazione e opposizione, ed è tale poiché le precede e le
pone: ogni determinazione e opposizione può infatti essere ricavata solo da
un’analisi dell’esperienza pura stessa, dal taglio che ne facciamo.
In Rickert, invece, l’esperienza che è oltre la differenza tra fisico e psichico non
è l’esperienza pura. Non a caso egli afferma di dissentire da Avenarius riguardo alla
possibilità e alla necessità di fare a meno dell’opposizione tra soggetto e oggetto38, e
si serve proprio di questo binomio per mostrare come l’identificazione della realtà
con l’esperienza non conduca alla sua psichicizzazione e non rischi di tradursi in
una sua concezione tendenzialmente solipsistica; rischio con cui si trova a fare i
conti Avenarius, il quale, dopo aver rigettato soggetto e oggetto fuori dal piano della
reine Erfahrung, è costretto a ricorrere alla sfera linguistico-sociale per superare la
valenza meramente individuale dell’esperienza39.
Dunque, per evitare di essere accostato a concezioni solipsistiche o psichicizzanti della realtà e dell’esperienza, Rickert riprende dalla sua opera precedente – Der Gegenstand der Erkenntnis (1892) – l’analisi di tre coppie di significati dei termini “soggetto” e “oggetto”: «In primo luogo viene chiamato soggetto
il corpo animato in opposizione al mondo esterno che lo circonda nello spazio.
Poi, il termine soggetto può designare l’anima in opposizione al proprio corpo
fisico. Infine, soggetto è chiamata anche la coscienza, in opposizione agli oggetti
privi di coscienza»40.
Cfr. Grenzen, pp. 163-164 in nota; tr. it. cit., p. 89 in nota.
Quando Avenarius parla della «società umana» la definisce appunto come «una maggioranza di individui che vivono in una comunità linguistica, in modo tale che un individuo,
grazie alle denominazioni (Bezeichnungen) comunitarie, può comunicare (mitteilen) ad un
altro uomo un’esperienza (Erlebnis) che questi non condivide (teilen)» (R. Avenarius, Kritik der
reinen Erfahrung, cit., vol. II, p. 84).
40 Grenzen, p. 159; tr. it. cit., p. 87.
38 39 Il tema della reine Erfahrung
73
I termini con cui Rickert designa i tre soggetti sono: «soggetto psicofisico»41,
l’io come insieme di corpo e “anima”, e comprendente quindi i legami tra l’attività degli organi di senso e le sensazioni; «soggetto psicologico»42, i contenuti di
coscienza che costituiscono la vita psichica; e «soggetto gnoseologico»43, la coscienza che – contrapposta a tutti i suoi contenuti – non comprende più niente
di determinato. I loro rispettivi oggetti sono: il mondo spazialmente esteso ed
esterno al mio corpo ed alla mia pelle, la realtà fisica, l’interezza dei contenuti di coscienza. Se però consideriamo che Rickert, come Avenarius, identifica
realtà ed esperienza, vediamo che nella seconda coppia non si contrappongono da un lato l’insieme dei contenuti di coscienza e dall’altro una realtà fisica
trascendente, quanto piuttosto da un lato i contenuti di coscienza che – sulla
base di caratterizzazioni sulle quali Rickert dichiara esplicitamente di non volersi soffermare nelle Grenzen44 – vanno a costituire il regno dello psichico, e
dall’altro lato i contenuti di coscienza che vanno a costituire il mondo fisico. Da
ciò deriva che la caratterizzazione criticamente accorta dell’intera realtà come
l’insieme dei contenuti di coscienza che si danno al soggetto gnoseologico non
comporta alcuna solipsistica psichicizzazione del mondo fisico, poiché il soggetto psicologico non può essere identificato con quello gnoseologico, ma solo
con una parte dell’oggettività che ad esso si contrappone.
Dunque a chi ritiene che identificare la realtà con l’esperienza voglia dire ricondurre l’oggettività del mondo “esterno” e “fisico” alla soggettività di un’esperienza “interna” e “psichica”, Avenarius risponde sostenendo che la reine Erfahrung
– ponendosi al di là di ogni determinazione soggetto/oggetto – non conosce nemmeno alcuna distinzione tra fisico e psichico. Al contrario Rickert credendo che «in
nessuna teoria della conoscenza può essere del tutto assente il principio secondo
cui ogni oggetto immediatamente dato (…) si deve necessariamente pensare in
riferimento ad un soggetto»45 si trova a dover spiegare all’interno di una dialettica
soggetto/oggetto perchè non avvenga una psichicizzazione della realtà. Ovvero se
Avenarius, piuttosto che sciogliere la tradizionale identificazione della sfera della
soggettività con il regno dello psichico, rifiuta entrambe, Rickert invece procede
proprio a slegare – almeno parzialmente – il soggetto gnoseologico dal riferimento
allo psichico, riconducendo poi tanto l’essere fisico quanto lo psichico alla sfera
dell’oggettività, dei contenuti di coscienza, dell’esperienza.
Grenzen, p. 163; tr. it. cit., p. 89.
Ibid.
43 Grenzen, p. 168; tr. it. cit., p. 93.
44 Grenzen, p. 153; tr. it. cit., p. 84.
45 Grenzen, p. 167; tr. it. cit., p. 91.
41 42 74
Chiara Russo Krauss
Come avevamo accennato, l’identificazione della realtà con l’esperienza compiuta da Rickert e Avenarius doveva anche fronteggiare il pericolo di essere tradotta in una concezione solipsistica del mondo. Tale concezione, secondo Rickert,
appartiene necessariamente a coloro che attribuiscono un carattere psichico alla
realtà e all’esperienza, perché ciò significa che queste due sfere vengono riferite
ad un soggetto inteso in senso psicologico, ovvero ad un individuo determinato
che si trova così nella condizione di fare affermazioni «come: “il mondo fisico è
dato solo nella mia coscienza” o “io sono il soggetto cui il mondo fisico deve essere riferito”»46. Il soggetto gnoseologico cui Rickert rapporta tutta la realtà come
contenuto di coscienza, invece, essendo assolutamente indeterminato, non è una
persona, un uomo con una vita psichica, ma solo «il prodotto di una riflessione
gnoseologica»47. L’analisi del rapporto tra soggetto e oggetto permette quindi a Rickert di evitare ogni accusa di solipsismo, dal momento che «l’io individuale è così
poco identico al soggetto gnoseologico e a quella coscienza per la quale il mondo è
dato come suo contenuto, da essere per questo soggetto e per questa coscienza solo
un oggetto tra gli altri. Quindi, è del tutto errato sostenere che il mondo immediatamente dato sia mio contenuto di coscienza»48.
Per quel che riguarda Avenarius, invece, considerando che l’esperienza pura
originariamente non contempla affatto l’opposizione soggetto/oggetto, essa non
dovrebbe essere nemmeno attribuibile a un qualsivoglia soggetto; l’esperienza
pura non sarebbe cioè l’esperienza di qualcuno, né tanto meno potrebbe quindi
essere soggettiva. In realtà il rifiuto della nozione di soggetto dall’orizzonte della reine Erfahrung serve principalmente a negare l’idea di una realtà oltre l’esperienza, ma non consente di dedurre l’impersonalità dell’esperienza pura stessa.
Al contrario l’esperienza pura, pur non essendo di un individuo nel senso di un
soggetto che si ponga in un rapporto di alterità rispetto ad essa, è comunque individuale, nel senso che è il fatto stesso che sia una esperienza a renderla di un
individuo. Detto altrimenti, l’esperienza pura non è personale perché appartiene
ad una persona, ma perchè le appartiene una persona, tanto che ogni individuo
è solo se è la sua esperienza pura. Per questo Avenarius, pur non avendo una
concezione psichica del soggetto, si avvicina a posizioni di tipo solipsistico e ad
una concezione relativistica della realtà, che è costretto a bilanciare assumendo gli altri individui come un’esperienza determinata all’interno dell’esperienza
pura e introducendo il commercio linguistico per estendere il valore dell’esperienza da una sfera meramente individuale ad una inter-individuale.
Ibid.
Grenzen, p. 168; tr. it. cit., p. 92.
48 Grenzen, p. 174; tr. it. cit., p. 95.
46 47 Il tema della reine Erfahrung
75
Dal punto di vista di Rickert proprio la mancanza della separazione tra soggetto e oggetto nella reine Erfahrung condanna la posizione di Avenarius al soggettivismo, perché per liberarsi di esso bisogna trasformare i soggetti psicologici individuali in oggetti tra gli altri, e rendere indeterminato e impersonale il
soggetto, come è il soggetto gnoseologico.
Alla base dell’identificazione di realtà ed esperienza compiuta da Rickert e
Avenarius è dunque riscontrabile una differente caratterizzazione dei rapporti
tra soggetto e oggetto. Ciò nonostante, proprio nell’analisi rickertiana di questi
rapporti è possibile cogliere l’influenza di Avenarius.
Determinare un’intera serie di coppie di soggetto e oggetto è infatti possibile
perchè siamo noi – con la nostra analisi – a tagliare in maniera diversa l’esperienza e a stabilire quale parte di essa considerare oggetto e quale soggetto. Il
fatto che Rickert consideri la differenza tra soggetto gnoseologico e psicologico una «distinzione concettuale»49 indica che questi termini non vengono visti
come elementi originari che precedono l’esperienza, ma come il risultato di una
nostra elaborazione concettuale che va ad operare sull’esperienza scindendola
in due parti. Così soggetto e oggetto non sono qualcosa di rigidamente definito,
ma concetti il cui significato si sposta all’interno di limiti dati: i limiti propri
dell’esperienza da cui vengono tratti. Infatti non sono determinabili solo tre
coppie di significati, ma tutta una serie in cui da un lato aumenta progressivamente la porzione di esperienza e realtà che ricade nel dominio dell’oggetto e si
restringe quella del soggetto, e dall’altro accade il contrario.
Da questo punto di vista la nozione di esperienza di Rickert riprende la reine
Erfahrung avenariusiana in quanto precede e fonda l’opposizione di soggetto e
oggetto invece di seguire ed essere fondata da essa. Rispetto alla prospettiva di
Avenarius, dunque, ciò che cambia è fondamentalmente soltanto la necessità o
meno di operare tale divisione: se per Avenarius il taglio dell’esperienza pura
in soggetto e oggetto – comunque li si voglia ripartire – è solamente una delle
possibili analisi e determinazioni che si possono portare avanti e rappresenta
quindi un percorso gnoseologico specifico, cioè ristretto ed unilaterale rispetto
alla prospettiva metafilosofica costituita dalla critica dell’esperienza pura, per
Rickert, invece, ogni gnoseologia deve necessariamente mettere in conto una
suddivisione e determinazione della coppia soggetto/oggetto, perché non si può
concepire una teoria della conoscenza fuori da una qualsiasi considerazione di
questi due termini e del loro rapporto.
49 Grenzen, p. 173; tr. it. cit., p. 94.
Fenomenologia delle emozioni
77
Fenomenologia delle emozioni
Memoria di Lucia Corrado
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 26 febbraio 2009)
Abstract It is absolute the comparisons with the arcipelaghos of emotions whenever it
wants to touch on Red hot enigmas that the being imposes, to study them within their
phenomenology and in their psycologic and human meaning. Therefore, Sartre blamed
suitable well on the emotions , on the affections, on the non verbal feeling and he disputed the logos’ primate: the rationality can only arise on an emotional base. A thought that
does not develop in dialectics correlation on the emotional background risks continually
to dry up and to deprive it of every human horizon.
The emotional behaviour is described by Sartre as a immanent possibility to our own
abitual relationship with the world because of itself urges her.
Sartre suggested that emotions, far from being blind istintual mechanisms, are fundamental for the interation between the self e the things of the world , as well as the complexity of the events.
Perché conferire una tale importanza al tema delle emozioni, indagabili e
filosoficamente e nell’ambito specificamente clinico della psichiatria?
È imprescindibile il confronto con gli arcipelaghi delle emozioni quando
si vogliano sfiorare gli enigmi roventi che l’esistere impone, per studiarli nella
loro fenomenologia e nella loro significazione psicologica ed umana.
Pertanto la stessa psichiatria ha l’umiltà di riconoscere che un discorso radicale sulle emozioni esige un’alleanza con le scienze umane perché sia delimitabile un soggetto-oggetto così camaleontico e complesso.
Quale risposta di senso dare all’urgenza di significazione che l’emozione impone? (Non dimentichiamo che Sartre, col prezioso supporto della fenomenologia, è riuscito a chiarire il concetto di emozione come fenomeno significante,
e questa assunzione di base va tenuta ben ferma perché il discorso sulle emozioni possa essere ampliato e sviluppato in maniera conseguente).
Cosa propriamente sono le emozioni, questo fenomeno massimamente noto
e minimamente chiaro nelle complesse dinamiche che lo sottendono?
78
Lucia Corrado
Anzitutto va ad esse attribuito un valore conoscitivo ed un forte nesso con il
pensiero, del quale innegabili sono le radici emozionali.
Non a caso Sartre ritenne opportuno soffermarsi sulle emozioni, sugli affetti, sul sentire non verbale – eventi che arricchiscono la filosofia malgrado le
tolgano ogni pretesa di apoditticità.
Sartre, in modo sottile e non sempre esplicito, ha contestato il primato del
logos: la razionalità non può che sorgere su di una base affettiva; è la “coscienza non-tetica” che divora quella tetica, è l’affetto che divora il logos, è il cogito
preriflessivo che divora la riflessione.
Un pensiero che non si svolga in correlazione dialettica con lo sfondo emozionale rischia continuamente di inaridirsi e di svuotarsi di ogni orizzonte umano.
Le emozioni consentono inoltre il realizzarsi di una dimensione intersoggettiva.
Ab origine sta lo sconvolgimento che la realtà fuori di me porta nel mio orizzonte
emotivo, ed è tale sconvolgimento a darmi la certezza che oltre me esiste “altro”.
Subentra poi l’emozione legata al rapporto con l’altro, fortissima e misteriosa (al rapporto io-altri Sartre ha dedicato feconde riflessioni in Essere e nulla).
Le emozioni sono molteplici nelle loro connotazioni tematiche, ma un elemento comune non manca: esse conducono fuori dai confini del proprio io e
mettono in contatto con il mondo delle cose e delle persone in quanto contrassegnate dalla intenzionalità (nel senso husserliano).
Ovviamente la misura della trascendenza (ovvero della intenzionalità), in
questo metterci in relazione continua ed articolata con gli “altri”, cambia in
ogni condizione emozionale.
*******
Sartre definisce testualmente l’atteggiamento emotivo, la relazione con le
cose dominata dall’emozione, una «degradazione spontanea e vissuta della coscienza di fronte al mondo»1.
Nel linguaggio sartriano “coscienza” significa “libertà”, “movimento”, “irriducibile dimensione soggettiva dell’esperienza”.
Ebbene, l’emozione è un depotenziarsi di tutto questo nonché della nostra
capacità di tener ferma quella modalità tipicamente umana di esperienza che è
il nostro essere-nel-mondo come “prospettiva sul mondo”.
1 J-P Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, trad. E. Bonomi, Bompiani, Milano 1962, pag. 54
Fenomenologia delle emozioni
79
L’emozione ci degrada facendo saltare ogni prospettiva abituale sul mondo.
Si tratta di una eventualità compresa nella formulazione che gli esistenzialisti danno della nostra condizione ontologica, ovvero il possibile ridursi della
distanza nel consueto movimento-verso-il-mondo.
Ed è quanto accade nel caso di un’emozione.
L’analisi condotta da Sartre è giusto considerarla classica.
La condotta emotiva si rivolge ad una realtà strutturata (al mondo coordinato degli utensili) come condotta destrutturate.
La realtà che ci circonda viene destrutturata nel senso che saltano i tracciati
abituali ed è trasformata in qualcosa di ottuso e indifferenziato.
Questo modificarsi straordinario dei tracciati abituali, dello spazio e delle
distanze, è messo in atto, precisamente, dalla “degradazione della coscienza”.
La condotta emotiva è da Sartre descritta come una possibilità immanente
al nostro rapporto abituale col mondo in quanto esso stesso la sollecita.
È tuttavia, ad un tempo, un rischio da esorcizzare (soprattutto a causa delle
derive patologiche che in soggetti predisposti può implicare).
Mi viene da pensare a Roquentin che è, fin dall’inizio, uno che parla con le
cose e al quale le cose parlano.
Le cose lo commuovono a tal punto che lo sorprendiamo immerso in un
atteggiamento emotivo.
Va anche detto che le emozioni vissute da questo alter-ego sartriano sono
regolate dalle circostanze che le suscitano per cui non posseggono quella forza
straordinaria che strappa la coscienza dai suoi abituali percorsi.
Resta intatto il dato essenziale: un costante rapporto tra mezzi e fini.
Certo, Roquentin si aggira per il mondo un po’ da stralunato ma non giunge
ad una visione radicalmente diversa del mondo: non è minimamente scalfito
quel principio di realtà che assicura una coerente adesione alla vita.
L’esperienza di Roquentin ricalca senz’altro l’instabile andamento delle emozioni, ma le sue azioni conservano la logica delle esperienze abituali.
Infine, da questa stessa logica Roquentin si separa recidendo ogni legame
tra la propria esperienza emotiva delle cose e l’esperienza abituale di esse.
Accade che le tante emozioni differenziate scompaiono e resta, come unico
oggetto della sua esperienza, l’oggetto ideale dell’emozione pura.
Si tratta, precisamente, dell’oggetto ideale che l’emozione tende a realizzare,
dell’oggetto-limite dell’esperienza emotiva al quale corrisponde il sentimento
peculiare dell’ottuso e indifferenziato.
Ecco l’emozione archetipa che con Sartre chiamiamo Nausea.
80
Lucia Corrado
L’emozione archetipa è svincolata dagli schemi dell’apprensione abituale,
trascende tutte le possibili condotte emotive e ciò che resta è un unico sentimento regolativo, a tratti minaccioso, che sulle cose del mondo getta una luce
opaca che induce infine alla rilettura di un mondo ove ogni ragion d’essere è
andata perduta.
Sarebbe fuorviante definire la coscienza di Roquentin come “reificata”.
Reificata è la coscienza irrigidita nella propria funzione.
Di contro, quello di Roquentin è l’esempio-limite della coscienza “liquefatta”, sottratta alla propria funzione.
Evidente è l’utilità conoscitiva di una siffatta coscienza: è messo in atto quel
tipo di intelligenza che non sbaglieremmo a chiamare “comprensione ontologica” la quale asseconda, sul terreno dell’esperienza, l’esigenza di conoscere per
astrazione, tipica della condizione umana.
Da notare quanto la nausea di Roquentin debba alla riduzione fenomenologica di Husserl, alla indicazione husserliana circa la possibilità di mettere fuori
gioco funzioni semantiche abitualmente in gioco.
Cosa rivela dunque la coscienza liquefatta di Roquentin?
Quella sua coscienza “in sciopero” ci rivela un mondo destrutturato, ridotto
ad un essere senza ragione.
Resta la nausea, l’unica emozione legittimata ad investire il tutto indifferenziato del mondo.
*******
L’emozione che irrompe improvvisa è lì a dimostrare che l’armonia col mondo non è mai così salda e definitiva; l’ordine apparente che imponiamo alla vita
(per meglio gestirla sul piano emotivo) ha durata breve e quest’ordine non ha
ancora definitivamente rotto i legami col caos che lo sottende e lo nutre.
Non si può pretendere di identificare una via che agevola l’ingresso nel mondo con l’assetto del mondo; l’emozione rammenta questa impossibilità e modifica il nostro rapporto con il mondo dal quale siamo sopraffatti.
Fuori da un contesto fenomenologico, fuori da quell’originaria apertura del
corpo al mondo in cui si risolve la nostra quotidiana esistenza, il fenomeno
dell’emozione è incomprensibile (ecco perché Sartre coglie nel segno quando
descrive l’emozione come una certa maniera di apprendere il mondo).
L’emozione non è disordine fisiologico (anche quando siano costeggiati i bordi
pericolosi della follia l’emozione estrema e distruttiva che si prova ha un senso) ma
una condotta organizzata che consente di sfuggire ciò che non si può sostenere.
Fenomenologia delle emozioni
81
Le lacrime e la commozione che invadono chi ricorda una perdita non sono
affatto disordine espressivo, ma una condotta adeguata ad una esistenza che
ancora non vuole ammettere l’irrimediabilità della perdita.
Non potendo sostenere questo vuoto l’esistenza si abbandona ad una condotta compensatoria che riduce la sofferenza di una irrimediabile solitudine.
Nel pianto non c’è calcolo ragionato, ma la soluzione brusca di un conflitto.
L’emozione è un mezzo per eludere una difficoltà che non si è ancora in grado di
reggere ed è dunque un modo per continuare, nonostante tutto, ad essere-nel-mondo.
Il significato dell’emozione non va cercato, come fa la psicanalisi (in questo
concordo con Sartre), nell’inconscio, perché l’emozione non è l’effetto manifesto di una causa latente.
Il rapporto di causalità, infatti, se è idoneo a spiegare le relazioni tra le cose,
non lo è per l’ordine delle intenzioni, dei segni e dei significati.
Sartre presuppone che la coscienza non sia mai pienamente abolita, che le
distanze effettive del mondo non siano mai veramente annullate.
Ma è proprio questo che nell’emozione accade: vi è un’alterazione improvvisa
del mondo e la conseguente improvvisa alterazione del mio modo di abitarlo.
A questa alterazione magica la coscienza ricorre per risolvere a suo modo
(ovviamente si tratterà di una pseudo-soluzione) il conflitto che l’attanaglia.
Questa alterazione magica produce un universo analogo a quello del sogno
in cui gli oggetti non sono più percepiti per quel che sono, ma a partire dallo
sfondo di un mondo catturato dall’atmosfera dell’angoscia.
*******
Sartre lo si può senz’altro dire indagatore sottile delle operazioni dell’anima,
ma è corretto supporre uno “spaesamento” nell’argomentazione che, proprio
per questo, manca di compiutezza.
Ciò non significa misconoscergli il merito di aver sostituito la psicologia
analitica dei suoi maestri con la “comprensione concreta”, sintetica e indivisibile degli individui e dei comportamenti.
La coscienza immaginante e la coscienza commossa sono indagate da Sartre
come significative di un rapporto col mondo e, come tali, negazioni di interiorità.
La coscienza esiste dunque in un perpetuo superamento di se stessa verso
un oggetto del mondo: le cose, le verità, i sentimenti, i significati, l’io.
Vorrei ora soffermarmi sul saggio Idee per una teoria delle emozioni(1939) in
quanto fornisce un ottimo spunto di riflessione sulla natura dell’uomo e sulle
dinamiche della sua psiche.
82
Lucia Corrado
Quello fornitoci da Sartre è solo un abbozzo; le pagine del suo breve saggio sono
costellate di rare ma preziose intuizioni che, completandosi alla luce delle odierne
acquisizioni, consentono una più accurata e completa indagine sull’uomo.
La necessità di uno studio veramente positivo sull’uomo commosso è giustificata da Sartre con l’esigenza posta da Husserl, e da Heidegger, di far luce sulle
nozioni di uomo, di mondo, di essere-nel-mondo, di situazione.
In un sì ampio approccio all’uomo è impossibile non tener conto dell’emozione, fenomeno trascendentale, forma organizzata dell’esistenza umana che
significa il tutto della coscienza o, ancor meglio, la «stessa realtà umana realizzantesi nella forma ‘emozione’»2.
Sartre si pone in queste pagine lo stesso problema che qualche secolo prima
si era posto Kant: se e come le ricerche psicologiche del suo tempo rispondevano alla domanda che cos’è l’uomo.
Ebbene, il procedimento fenomenologico, diversamente dagli approcci
“classici” della ricerca psicologica, mira all’emozione come significato: il punto
di partenza non è, riduttivamente, il fatto, ma il fenomeno in quanto significa.
Allontanandosi dalla psicologia analitica e polverosa che s’insegnava alla
Sorbona, Sartre si avvicina con molte riserve alla psicanalisi, per la possibilità
che essa offre nella ricerca del significato delle malattie psichiche.
Sartre è perfettamente consapevole che l’interesse maturato nei riguardi
dell’emozione non è accidentale: l’emozione si configura infatti come un modo
di esistere della realtà umana, una modalità con cui la coscienza modifica e
comprende il suo Essere-nel-mondo.
Guardiamo rapidamente ai limiti della psicologia con cui Sartre ebbe a confrontarsi e che ritenne opportuno rigettare.
Essa si presentava anzitutto come una disciplina positiva, intenta a ricavare
le proprie risorse esclusivamente dall’esperienza.
La nozione di uomo che era in grado di delineare si limitava all’empirico.
Con ciò pretendeva d’essere una scienza ma invero altro non forniva che
una disordinata accozzaglia di fatti eterocliti la maggior parte dei quali non ha
alcun legame reciproco.
Ma l’esito non poteva essere meno penoso se si rammenta che basarsi sul
fatto significa, per definizione, basarsi sull’isolato, preferire l’accidente all’essenziale, il contingente al necessario, il disordine all’ordine.
Allo stesso modo i principi e i metodi dello psicologo, applicati allo studio delle emozioni, descriveranno l’emozione come mero accidente scan2 J-P Sartre, Idee per una teoria delle emozioni, cit., pag. 159.
Fenomenologia delle emozioni
83
sando volutamente l’indagine matura che si interroga sulle condizioni in cui
un’emozione è possibile.
È per reazione alle manchevolezze della psicologia e dello psicologismo che
è sorta la fenomenologia.
«Se vogliamo fondare una psicologia occorre risalire oltre lo psichico, oltre
la situazione dell’uomo nel mondo, fino all’origine dell’uomo, del mondo e dello
psichico: alla coscienza trascendentale e costitutiva cui perveniamo attraverso
la riduzione fenomenologica»3.
Ci sarà, conseguentemente, una fenomenologia dell’emozione che studierà
l’emozione come fenomeno trascendentale puro, senza rivolgersi ad emozioni particolari, mirando a cogliere l’essenza trascendentale dell’emozione come
tipo organizzato di coscienza.
Cosa sostanzialmente differenzia ogni ricerca sull’uomo dagli altri tipi di
problemi rigorosi?
Il fatto privilegiato che noi stessi siamo la realtà umana.
Questa assunzione di sé implica un’autocomprensione della realtà umana,
comprensione che è propriamente mia in quanto mia propria maniera d’esistere.
Naturalmente – specifica Sartre – non si tratta d’introspezione perché l’introspezione non incontra che il fatto ed inoltre la mia comprensione della realtà
umana è oscura e inautentica.
Detto questo, reso chiaro il più ampio orizzonte che con la fenomenologia ci
si dischiude innanzi, s’indagherà l’emozione domandandole non solo ciò che è
ma soprattutto ciò che ci rivela di un essere.
Per il fenomenologo ogni fatto umano è per essenza significativo.
Significare è indicare qualcosa d’altro.
Per lo psicologo l’emozione non significa nulla perché la studia come fatto
astraendola da tutto il resto.
In virtù del più corretto approccio fenomenologico l’emozione la si considererà, anzitutto, significante.
Alla sua maniera l’emozione significa il tutto della coscienza; non è un accidente in
quanto possiede la sua essenza, le sue strutture particolari, le sue leggi d’apparizione.
Giungo ora alla tesi che più mi sta a cuore.
Forzerò forse le prime intuizioni sartriane, opterò per un non proprio corretto connubio della teoria sartriana sulle emozioni con teorie più contemporanee, ma il nucleo di una siffatta argomentazione resta, penso, indiscusso:
l’emozione è fenomeno significante → è degradamento della coscienza,
3 Ivi, pag. 161.
84
Lucia Corrado
quindi modificazione disturbante del suo abituale approccio al mondo →significa, nonostante il degradamento avvenuto → significano tutte le emozioni, prescindendo dall’intensità dell’emozione stessa → significano i disturbi emotivi
sconfinanti nella patologia.
Significa quella che volgarmente chiamiamo follia (quando, ovviamente,
non si tratti di cerebrolesi).
I disturbi psichiatrici hanno le loro leggi di apparizione, una indiscussa logica che li sottende ma che va scoperta, non limitandosi al fatto che appare
(il comportamento assurdo del disturbato) ma interrogando, fenomenologicamente, l’intera coscienza del malato che nel disturbo trova, drammaticamente,
l’unico modo a lui congeniale per essere-nel-mondo.
Per quanto intenso voglia essere il disordine fisiologico cui l’emozione mette
capo, in quanto fatto di coscienza essa non è per nulla disordine o puro caos,
ma ha un significato nella misura in cui si pone come una certa relazione del
nostro essere psichico con il mondo.
Ogni tipo di relazione – sana o malata che sia – non è un legame caotico fra
me e l’universo, ma una struttura organizzata e descrivibile.
Sartre non manca di dare una descrizione – seppur generica – di disordini
emozionali intensi finalizzati alla liberazione da una determinata tensione.
Parla di accessi di collera, talvolta molto violenti, che si verificano in certe persone.
Avviene in tal caso, nella coscienza del collerico, una semplificazione strutturale: c’è nella collera (e in tutte le emozioni) un indebolimento delle barriere
che separano gli strati profondi e quelli superficiali dell’io, barriere che normalmente assicurano il controllo per mezzo dell’autodominazione.
Quale la finalità della collera nella descrizione sartriana?
La collera non è un istinto né un calcolo ragionato: si tratta della soluzione
brusca di un conflitto.
Non potendo trovare, in stato di alta tensione, la soluzione appropriata ad
un problema, agiamo su noi stessi trasformandoci in un essere tale che si appagherà di soluzioni grossolane e meno adeguate.
Dinamiche simili sono messe in atto dalla psicastenica che trova arduo dialettizzare il proprio disagio al terapeuta.
Per sfuggire alla tensione intollerabile che l’attanaglia la malata esagera la
propria debolezza, il proprio smarrimento.
Compaiono i singhiozzi, le crisi di nervi – e qui la funzionalità dell’emozione
è innegabile.
Non va però dimenticato che l’emozione, per quanto sia una condotta che il
soggetto decide di tenere, è ad un tempo subita.
Fenomenologia delle emozioni
85
Vi si aggiunge infatti la credenza e non si può uscirne a piacimento, noi non
possiamo fermarla.
Quella che si vive è una coscienza subita, vittima di se stessa, costretta dentro un’assurda odissea che lei stessa si è cercata.
Questa coscienza incatenata vive l’incontro magico con un mondo traboccante d’esistenza che secerne umori densi e fumosi come il sudore e le lacrime.
La coscienza subisce il suo stesso inganno: proprio perché vive il nuovo
aspetto del mondo credendovi, è trascinata dalla sua stessa credenza – come
accade nel sogno e nell’isteria.
*******
I fatti psichici sono dunque reazioni dell’uomo al mondo e presuppongono
l’uomo e il mondo.
Ne consegue che la psicologia, come scienza dei fatti psichici, non potrà mai
essere un punto di partenza.
Occupandosi dell’uomo nel mondo, dell’uomo in situazione, essa è subordinata alla fenomenologia.
Certo, la psicologia, ed in particolare lo studio delle emozioni e dell’immaginazione, potrebbe suggerire un possibile terreno d’incontro tra realtà concreta
e coscienza individuale.
E tuttavia – lo abbiamo già sottolineato – l’approccio allora dominante era
rigidamente positivista, non permetteva una lettura globale dei fenomeni psichici e non si rivelava utile a riconoscerne l’effettiva natura.
Sartre immediatamente intuì l’errore di quella psicologia: la convinzione
che i fatti concreti contenessero in se stessi significati univoci ed evidenti.
La critica al metodo scientifico riduttivo in psicologia fu per tutta la vita di
Sartre una costante ineliminabile e le sue intuizioni restano, ancora oggi, interessanti e stimolanti.
Naturalmente la soluzione metodologica ai dilemmi suscitati da una simile
presa di coscienza poteva venire a Sartre – e su questo punto pure abbiamo insistito – solo dalla fenomenologia la quale, respingendo in modo lucido e radicale
i presupposti principali della psicologia tradizionale, ha reso chiara l’impossibilità di studiare i fatti psichici come semplici fenomeni fisici.
Il metodo fenomenologico, guidato dal filo conduttore dell’analisi intenzionale, metteva infatti a disposizione un campo oggettuale di vastità immensa,
che sollecitava un’interpretazione metodico-critica.
86
Lucia Corrado
La fenomenologia, lungi dal porsi come un mero accumulo di materiale, ha
in assoluto contrassegnato il sapere obiettivante con quella sua metodica avanzata che induce a “far parlare” le cose esibendo le condizioni trascendentali del
loro stesso manifestarsi.
Questa inedita modalità esperenziale consente l’accurata indagine di quella
compagine strutturale che funge da principio regolativo della variabilità del
correlato coscienziale.
Al contempo non era però solo la fenomenologia ad arricchire di nuove dimensioni il contesto dell’esperienza, ma anche la prassi psicanalitica: Freud fu
infatti il primo a dare un fondamento esperenziale all’ermeneutica.
Ciò non toglie comunque che sia stata anzitutto la fenomenologia a garantire un atteggiamento essenzialmente obiettivistico sì da non incorrere in falsificazioni esiziali nel rivolgersi all’esistenza umana.
Ponendosi ad una distanza siderale dalle riduttive acquisizioni della psicologia, la fenomenologia ha successivamente consentito una fondazione gnoseologica dell’esperienza psichiatrica.
In tal senso Sartre è stato chiaramente lungimirante.
*******
L’attenzione del fenomenologo, quando sia rivolta alla comprensione della malattia mentale, la riconoscerà come reale e diversa modalità di esserenel-mondo e studierà intanto le esperienze interiori e i vissuti psicopatologici
dell’individuo, mai sradicandoli dal tessuto esistenziale in cui si è prodotta questa nuova dimensione di vita.
L’approccio fenomenologico s’impone anzitutto per la sua ferrea opposizione a tutto ciò che va sotto il nome di riduzionismo classificatorio.
La fenomenologia va oltre la conoscenza delle esperienze vissute dal malato
proponendo una percezione “sovrasensoriale”, una visione che si rivolge agli
aspetti essenziali dei fenomeni psicopatologici.
Comprendiamo ancora più chiaramente l’enorme importanza della fenomenologia (di cui Sartre scorse bene il valore) la quale implica un più ampio e prezioso
senso del comprendere che è afferrare l’essenza della persona sul piano dell’esistenza, costantemente riferendosi al fondo ontologico dell’essere umano.
Si è già detto che l’oggetto d’interesse non è il singolo io, ma il rapporto Iomondo, entro il quale significativo è poi l’incontro con l’altro.
Sulla scorta di questa constatazione la malattia mentale non può essere che
il fallimento di questo progetto esistenziale.
Fenomenologia delle emozioni
87
A questo punto, considerando l’ampliarsi dell’orizzonte fenomenologico
nelle avvenute acquisizioni in ambito psichiatrico, lo studio della coscienza si
identifica con lo studio dell’attività mentale: la coscienza è consapevolezza di se
stessi e del mondo fenomenico.
La malattia mentale interrompe questa linearità trasparente.
Ciò non significa però che norma e malattia siano, nella prospettiva fenomenologica, mere classificazioni per distanziare la normalità dalla patologia;
vanno piuttosto considerate come due modalità diverse di esistere.
Semplicemente, il malato agisce secondo canoni diversi dalla consuetudine.
Notevole è il passo in avanti che si è compiuto rispetto alla psichiatria dell’Ottocento e al suo naturalismo schematico, ed in parte anche rispetto all’impostazione positivistica della teoria freudiana che implicherebbe una visione di
uomo come macchina, ridotto alla sua naturalità (se si considera la troppa importanza da Freud accordata alla pulsione).
Il malato di mente viene liberato dalla costrizione in cui il positivismo l’ha
ridotto, mediante la rivalutazione di una presunta storia della vita interiore.
Ecco la grandezza della fenomenologia: la capacità di andare oltre il dato oggettivo
(il comportamento) al fine di evidenziare il progetto storico, singolare per ogni individuo, dell’esserci-nel-mondo sia come persona sana che come persona malata.
E torniamo a Sartre, e all’importanza da lui accordata alla coscienza nella
costruzione dei fenomeni psichici, importanza derivante dal suo tentativo di
attribuire alla coscienza e alla sua libertà uno statuto privilegiato nell’ambito di
una teoria dell’uomo.
Penso comunque che una moderna fenomenologia dell’emozione dovrebbe
ridimensionare il peso della libertà umana.
Ad ogni modo, malgrado gli evidenti (e forse necessari, considerando che
Sartre si è occupato di “tutto”, e non ebbe modo di esercitarsi a sufficienza su
questo punto) limiti dell’impostazione sartriana, certo il filosofo è stato lungimirante nel tratteggiare, nel suo breve saggio, quel tipo di emozione che, amplificandosi, genera patologia.
Sartre spiega come l’emozione sia in grado di consegnarci una qualità
schiacciante e definitiva della cosa che ci appare.
Può accadere che l’orribile che essa suscita non si limiti più allo stato attuale
della cosa, ma sia minaccia per il futuro, si estenda oscuramente sull’avvenire
facendosi rivelazione sul senso del mondo.
È vissuta in tal modo, emotivamente, una qualità che ci penetra e che, traboccando da ogni parte, fa sì che l’emozione si trascenda ed assurga alla nefasta
intuizione di un assoluto non-senso.
88
Lucia Corrado
Protraendosi – una intuizione siffatta - oltre il dovuto, vengono minati gli
abituali processi di pensiero, infiacchito lo spirito, ferita l’anima.
L’originaria emozione negativa, eccedendo pericolosamente se stessa, ha
reso malata la persona.
Quando l’emozione non sia solo leggera oscillazione del nostro stato fisico
subentra, ad esempio, la depressione (una condotta emotiva vale l’altra in questo esempio, purchè sia estrema) e a quel punto
«possiamo cogliere tutta la nostra vita come funesta. Il sinistro è totale e noi
lo sappiamo, è profondo ma per oggi lo intravediamo solamente»4.
Spendiamo ancora qualche parola sull’enorme importanza che l’approccio
fenomenologico ha assunto nelle scienze umane.
L’intento antiriduzionistico della fenomenologia, comportando la costante
apertura all’orizzonte di senso proprio di ogni accadimento psichico (normale
o abnorme), ha imposto agli psicopatologi in particolare, un confronto incessante col pensiero filosofico.
In tempi di assoluto dominio degli indirizzi chimico-nosografici e biologici,
e di crisi della stessa nozione di psychè, è possibile pensare alla Fenomenologia
come ad una permanente ed inesauribile apertura agli orizzonti critici cogliendo e descrivendo gli accadimenti morbosi anzitutto in chiave coscienziale.
Fino al secolo scorso lo psichiatra, orientato esclusivamente nella prospettiva positivistica e naturalistica, definiva il suo agire nel doppio movimento
di reificazione e spersonalizzazione, dissolvendo il paziente e la sua biografia
nell’anonimato di categorie etiopatogenetiche.
In tal senso la tesi “le malattie mentali sono malattie del cervello” veniva assolutizzata acriticamente in una prospettiva di radicale medicalizzazione della
sofferenza psichica.
Va comunque ribadita la questione decisiva del corpo come intermediario,
quel corpo che registra fedelmente gli inciampi dello spirito e su cui lo stesso Sartre ha appuntato l’attenzione discorrendo sul disordine fisiologico che
l’emozione provoca.
Il mio corpo è transizione da me al mondo e non è possibile immaginare una
condizione della mia mente che non sia associata ad uno stato del mio corpo.
Vi è ancora un’altra dimensione che la fenomenologia consente di fondare
adeguatamente: l’intersoggettività.
Di tale importanza il rapporto io-altri da aver caratterizzato anche la speculazione sartriana fin dalle prime opere.
4 Ivi, pag. 201
Fenomenologia delle emozioni
89
Già in La Trascendenza dell’Ego Sartre si era posto il problema del rapporto
della coscienza con i soggetti ad essa esterni ed aveva anche avanzato una critica decisa alla soluzione offerta da Husserl al problema in questione.
Sartre osservava giustamente che se per rapportarsi al mondo e agli altri
viene assunto come punto di riferimento una coscienza riflessiva consapevole
della sua identità con se stessa e della sua distinzione dagli oggetti del mondo
e dagli altri io, il tentativo di rapportarsi alla realtà esterna si riduce all’inglobamento di tutto ciò che è fuori della coscienza nell’orizzonte conoscitivo del
soggetto.
Con ciò si avrà, di fatto, una sterile riaffermazione del solipsismo.
Certo, non è facile aggirare lo scoglio del solipsismo e nelle enormi difficoltà
che esso implica Sartre si è imbattuto incessantemente.
È tuttavia possibile incontrare, nell’ambito della stessa descrizione dei modi
di coscienza, la possibilità di una evasione dal chiuso della propria egoità.
Basterebbe non tentare ad ogni costo un approccio al mondo esterno servendosi di strumenti puramente conoscitivi; l’analisi dell’intersoggettività andrà spostata dal piano della conoscenza al piano dell’essere.
Detto questo, aggiungiamo che alla base dell’intersoggettività non può non
porsi la questione decisiva del corpo come “intermediario”.
È a partire dal proprio corpo che l’altro si annuncia a noi (e nel reciproco riconoscerci
ci serviamo del prezioso strumento dello “sguardo”) come enigma, come mistero.
Una volta che la fenomenologia si sia arricchita come “fenomenologia
dell’intersoggettività” interviene la psicopatologia che si fa studio della coesistenza io-altri.
Ed è qui, esattamente, che l’approccio ai disturbi emotivi e psichici si rischiara di nuova luce, luce che getta un ponte sul mistero dell’ossessione, della
schizofrenia, dell’isteria ecc., disturbi che non potranno più essere letti come
mere deviazioni fisiologiche, ma come modalità coscienziali che instaurano
una relazione di segno negativo con le cose e le persone.
Può essere interessante osservare come lo stesso Sartre, in Immagine e coscienza – quasi avesse presentito le successive acquisizioni della psichiatria – parli ad
esempio dell’ossessione non come di un corpo estraneo che occupi la coscienza:
«l’ossessione è una coscienza: presenta quindi gli stessi caratteri di spontaneità e di autonomia di tutte le altre coscienze»5.
Si tratta, ovviamente, di una intuizione ancora acerba, ma il senso che si
vuol trasmettere penso resti chiaro.
5 J-P Sartre, Immagine e coscienza, trad. di E. Bottasso, Einaudi, Torino 1948, pag.228
90
Lucia Corrado
La psichiatria formatasi alla scuola fenomenologica studierà dunque le dimensioni più o meno distorte dell’incontro, e soprattutto l’uomo, nella sua capacità o incapacità di sentire, nelle molteplici forme di chiusura totale.
Il disturbo psicotico dell’incontro si impone quindi come disturbo modale,
come disturbo dell’ordinamento estetico dell’esperienza vissuta.
Lo studio di questi modi distorti, soffocati e abortiti dell’incontro, consente
di cogliere, con eccezionale penetrazione, tutta la portata pratica di quel mitsein che è costituito appunto dall’esserci-con-l’altro.
Torno per un momento alle pagine sartriane di Immagine e coscienza.
Sartre parla dello schizofrenico, e più in generale del sognatore morboso
che tenta di sostituire al contenuto reale della propria vita un contenuto irreale
adottando, di conseguenza, sentimenti e comportamenti “immaginari”, a causa
del carattere immaginario della sua stessa vita.
Lo schizofrenico desidera una vita fittizia, coagulata, rallentata.
E tuttavia, qualsiasi cosa il sognatore immagini, anche quando fosse esaudita, non corrisponderebbe mai alla sua originale aspirazione.
Il sogno è stato esaudito, ma il sognatore morboso non è in grado di far fronte a quella realtà piena e ricca di conseguenze.
Essa esigerebbe infatti uno sforzo di adattamento che il sognatore morboso
non è in grado di compiere.
Il reale è sempre nuovo, imprevedibile, ed impossibile è il connubio del cangiamento continuo con la solennità e rigidità che lo schizofrenico vorrebbe.
Quale, infine, il senso della “povertà essenziale” di siffatte immagini?
Anche qui straordinaria è l’intuizione di Sartre.
Diremmo noi oggi che si tratta di irrefrenabili moti psichici di difesa rispetto
ad una realtà (e ai molteplici aspetti di essa) che non si riesce a metabolizzare.
Significativamente Sartre scrive, portando l’esempio dell’amore:
«In breve, se lo schizofrenico immagina tante scene amorose, non è
soltanto perché il suo amore reale è stato deluso ma, anzitutto, perché
non è più capace di amare»6.
Allo stesso modo il sognatore morboso che immagina più prospettive di vita,
contesti abnormi (essere un re e disporre di un proprio regno), lo fa perché non
è più in grado di vivere.
6 J-P Sartre, Immagine e coscienza, cit., pag. 219
Fenomenologia delle emozioni
91
La relazione io-altri è bruscamente interrotta; la struttura del mondo non è
più compatibile con l’abnorme struttura che la mente del malato ha assunto.
E siccome il proprio essere-nel-mondo l’uomo non può estirparlo da sé, resta la possibilità estrema di reiventare la propria situazione.
La vita immaginativa reimposta la relazione con il mondo.
L’essere-nel-mondo rimane, ma la patologia ne ha stravolto le regole originali.
In sintesi: se filosofare significa scoprire il senso primo dell’essere e fare psicopatologia vuol dire scoprire il senso primo dell’essere-malato, non si filosofa,
né si fa psicopatologia se si abbandona la condizione umana.
Non c’è da stupirsi, in tal senso, se Merleau-Ponty ritiene che il sapere assoluto del filosofo sia la percezione: essa è a fondamento di tutto perché ci insegna un rapporto ossessivo con l’essere.
Non esiste – detto altrimenti – la possibilità di chiamarci fuori e di trattare
l’essere come se noi non vi fossimo implicati.
Allo stesso modo lo psichiatra, impegnato nell’arduo compito di spiegare i
bizzarri comportamenti del paziente, non è fuori di quel movimento emozionale
che lega l’uomo alla vita: le sue emozioni sono le emozioni rovesciate del paziente ma il terreno d’azione è loro comune.
Il paziente è potenziale alter-ego dello psichiatra, rappresenta un’alternativa
alle usuali dinamiche di relazione al mondo che lui, lo psichiatra, in quanto
uomo sano mette in atto.
*******
La perdita di distanza dal mondo che l’emozione implica, quella degradazione del Sé che rinuncia a mantenere la prospettiva mantenendosi tuttavia
come prospettiva, è ciò che Sartre continua a chiamare “coscienza”, intendendo
con questo termine la medesima ed irriducibile maniera d’essere ente dell’ente
uomo che Heidegger aveva tematizzato come Dasein.
Ebbene, questa coscienza commossa realizza di fatto una destrutturazione di quel
mondo che si dà a noi come qualcosa di rigidamente strutturato, che impone una
continua programmazione della nostra esistenza rendendola difficile e rischiosa.
Di tale quotidiana apprensione del mondo Sartre scrive:
«Il mondo che ci circonda, il mondo dei nostri desideri, dei nostri
bisogni e dei nostri atti, si presenta solcato da vie strette e rigorose che
conducono a questo o a quel fine determinato, cioè all’apparizione di un
oggetto creato. Naturalmente un po’ ovunque sono disseminati inganni
92
Lucia Corrado
e trabocchetti. Si potrebbe paragonare questo mondo ai piani mobili dei
bigliardini sui quali si fanno scorrere delle palline: ci sono percorsi delimitati da spilli e spesso dove s’intersecano questi percorsi si sono aperte
delle buche. È necessario che la pallina percorra un tragitto determinato,
seguendo percorsi fissati e senza cadere nelle buche»7
La condotta emotiva destruttura il mondo: non annulla difficoltà e problemi
nella realtà, ma annullando la nostra distanza dalla realtà le impedisce di prospettarceli, rendendoceli irriconoscibili.
Le definizioni di Sartre sono note e ci siamo tornati sopra più volte: condotta d’evasione, condotta magica.
Magica è un’apparenza della realtà inspiegabilmente diversa da quella abituale (si può notare, rapidamente, come non sia un caso che le visioni magiche
del mondo prevalgano nelle società primitive, le più impreparate ad affrontare
le difficoltà di un rapporto col mondo).
Il venire meno della nostra originaria distanza dal mondo è possibilità essenziale radicata nella nostra maniera d’essere e rappresenta una regressione
nella condizione di libertà.
Il punto è che la coscienza si trova gettata nel mondo, spontaneamente, ovvero senza che abbia potuto decidere se vivere o meno, e questa condizione di
spontaneità è in realtà una costrizione.
È una coscienza subìta perché si trova a vivere una situazione che non ha
scelto lei stessa e che deve affrontare trovandosi in situazioni dalle quali non
può fuggire se non con l’emozione, un atteggiamento anch’esso spontaneo e che
è la nuova condizione di questa coscienza che patisce il mondo.
La volontà di fuggire di questa coscienza imprigionata è di una intensità tale
che essa vuole costruirsi un altro mondo che sia però da lei significato e che
abbia dunque senso solo a partire dalla coscienza stessa.
L’incontro magico con questo nuovo mondo porta con sé l’apparenza di un
miracolo: è dalla realtà umana che si commuove che tutto parte.
Ovviamente il cambiamento che l’emozione apporta non è sostanziale, e tuttavia reale è l’illusione della propria libertà.
Volgarmente diciamo che l’uomo folle sia libero.
Per certi aspetti è vero.
Il folle per antonomasia è coscienza sciolta che ha compiuto un supremo
atto di rinuncia rispetto al proprio essere-nel-mondo.
7 J-P Sartre, Immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, cit., pp. 42-43
Fenomenologia delle emozioni
93
Che la rinuncia si consumi poi esclusivamente nella mente del malato è superfluo puntualizzarlo.
*******
Per concludere, quella ricerca che voglia proporsi come approfondita indagine sull’uomo, riguarderà forme e sviluppi psicologici, intendendo per “forme”
quelle strutture psicologiche che appartengono a diversi livelli di organizzazione, dai più semplici ai più complessi.
Esse comprendono entità psicologiche quali i sentimenti in generale, le
emozioni, le immagini, il linguaggio, il pensiero ecc.
È senz’altro vero che stati fisiologici o emozioni semplici, come la fame, la
sete, la fatica, gli impulsi sessuali, sono forze motivazionali potenti, e tuttavia
per una più matura indagine dell’essere-uomo è necessario andare oltre queste
emozioni primitive per guardare alle importanti forze psicodinamiche determinate dalla vita concettuale.
Ebbene, dal funzionamento di queste forze derivano i vari modi di sperimentare il mondo e il Sé.
Freud, per parte sua, non fu in grado di chiarire fino in fondo la funzione
delle emozioni; non a caso è proprio nell’affettività che troviamo gli aspetti più
controversi della sua teoria.
Nei suoi primi lavori Freud attribuì grande importanza ai fattori affettivi
visti come forze dinamiche dirette.
Successivamente collocò queste forze negli istinti o pulsioni, visti come
quantità di energia libidica.
L’emozione finì per avere, per Freud, una funzione di valvola di sicurezza
nello scaricare l’organismo dalla tensione pulsionale eccessiva.
Deduciamo che secondo le teorie di Freud le emozioni sono derivati delle
pulsioni ed hanno prevalentemente una funzione di valvola di sicurezza.
Un organismo che non può svilupparsi oltre il livello del principio di piacere non sperimenta sentimenti più complessi delle protoemozioni, emozioni
elementari la cui componente cognitiva è costituita soltanto dalla percezione di
una serie definita e circoscritta di stimoli.
Le emozioni più complesse – come l’angoscia, la collera, il desiderio, la depressione – si prolungano invece come stati esperenziali.
Sin dal sorgere della scuola psicanalitica l’angoscia è stata l’emozione che ha
94
Lucia Corrado
ricevuto la maggiore attenzione ma non vi è stato tuttavia un consenso unanime per quel che riguarda la sua definizione.
A prescindere dalle molteplici interpretazioni, essa è senz’altro reazione
emotiva all’attesa o alla previsione di un pericolo.
Ancora meglio – insegna Sartre – essa è risposta emotiva ad una esistenza
soffocata dall’eccesso di possibilità.
Ad ogni modo, assieme alla depressione l’angoscia viene spesso designata
come un dolore mentale.
Per certi aspetti queste due emozioni sono realmente simili al dolore.
Oltre ad essere spiacevole, l’angoscia è impellente, è centripeta, e tende ad
espandersi.
Quando quella tonalità spiacevole che ha investito il passato e il futuro raggiunge un punto di non ritorno, è disintegrata la maniera adeguata di esserenel-mondo e la persona è indotta a fare un uso errato dei concetti: le categorie
con cui si metabolizza il divenire hanno ormai assunto un carattere definitivo,
assoluto, patologico.
Tuttavia nemmeno quando il disordine che l’emozione provoca sembri travolgere completamente il soggetto bisogna pensare che la nuova condizione
patologica sia subita.
Ribadiamo, con Sartre, che l’emozione è un’azione rivolta a sé.
Non trovando, o non volendo trovare, una soluzione all’ostacolo, si agisce su
se stessi invece che sul problema.
Per Sartre non ci sono vittime passive dell’emozione perché la coscienza non
può essere vittima di se stessa e il timore sarà sempre una scelta rassegnata che
accetta il terrore come l’unica risposta adatta in quelle circostanze.
L’emozione non è mera tempesta fisiologica ma una risposta adatta alla situazione.
Non è dunque possibile che la coscienza, la quale organizza l’emozione
come un certo tipo di risposta adeguata ad una situazione che la sovrasta, non
sia essa stessa cosciente di questo adeguamento.
L’essere umano organizza gli eventi che sperimenta in forma di storie che
si sviluppano nel tempo attraverso l’evolversi più o meno articolato di cambiamenti in cui si è mossi da desideri, intenzioni, emozioni.
Queste narrazioni non corrispondono direttamente alla realtà ma sono il
frutto creativo dell’attribuzione di senso che il soggetto dà agli eventi attraverso
una personale rielaborazione che ha ammorbidito il duro contatto col reale con
il prezioso supporto dell’emozione-cuscinetto.
Fenomenologia delle emozioni
95
Le emozioni negative, in particolare, descrivono la sofferenza della persona
attraverso un linguaggio che esprime un desiderio rimasto eternamente tale.
Emozioni come la sofferenza, l’angoscia, il panico, sono l’effetto di una mancanza – quella «mancanza ad essere» che è categoria basilare dell’insegnamento
di Lacan e che indica lo statuto strutturalmente mancante del soggetto. Esistere
vuol dire mancare di qualcosa laddove l’emozione offre l’apparenza fragile di
una pienezza, sia essa di segno positivo o negativo.
Le emozioni consentono di evitare la perdita di integrità che può portare
alla morte, ma anche di scegliere una fonte di energia, di riparo.
Sartre, ponendosi lucidamente contro il riduttivo approccio psicologistico,
ha suggerito che le emozioni, lungi dall’essere ciechi meccanismi istintuali,
sono fondamentali per l’interazione tra sé e le cose del mondo, nonché capaci
di rivelare la complessità degli eventi.
A ben vedere sono l’imperfezione del mondo e la disillusione delle nostre
aspettative che spingono ad emozionarci.
96
Lucia Corrado
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
J-P SARTRE, Immagine e coscienza, trad. di E. Bottasso, Einaudi, Torino.
J-P SARTRE, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, trad. di E.
Bonomi, Bompiani, Milano 1962.
ALES BELLO A., Fenomenologia dell’essere umano, Roma, Città Nuova, 1992.
BINSWANGER L., Per un’antropologia fenomenologica, Milano, Feltrinelli,
1970.
BUBER M., Il problema dell’uomo, Bologna, Patron, 1972.
CALLIERI B., Aspetti antropologici dell’incontro: il “noi” tra psicoanalisi e metafisica, in “Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria”, 57, 477-485,
1996.
CARGNELLO D., Alterità e alienità, Milano, Feltrinelli, 1977¡.
MODELL A. H., Psicoanalisi in un nuovo contesto, Milano, R. Cortina, 1992.
Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
97
Verticalità e orizzontalità dell’amore:
Hannah Arendt interprete di Agostino
Memoria di Maria Letizia Pelosi
presentata dal socio naz. ord. res. Giuseppe Cantillo
(seduta del 26 febbraio 2009)
Abstract Vertical and horizontal Structure of Love: Hannah Arendt’s interpretation of Augustine
This study examines Hannah Arendt’s interpretation of love and Augustine’s philosophy
in her doctoral thesis written in 1928.
The reading reconstructs a relationship between Hannah Arendt’s and Augustine’s philosophy and underlines the Augustinian root in Arendt’s political and moral thought.
Arendt criticizes the possibility of love of neighbour to go beyond the solipsistic phenomenon of self-reflection because of the duality between loneliness of the individual in
God’s presence and his social and common nature.
Nevertheless, according to Arendt Augustine never stopped his quest to understand and interpret world and human existence in philosophical terms. Hence, his thought continues to
provide influential and eloquent arguments for contemporary ethics and politics.
I
Raramente i turbamenti e le incoerenze presenti nella storia di un’esistenza
investono in maniera così forte il pensiero, tormentato, controverso, aperto a
sollecitazioni molteplici, come avviene per Agostino d’Ippona. Quelle che sono
state definite le “incertezze metafisiche”1 di Agostino, le contraddizioni interne
al suo percorso filosofico e esistenziale, non soltanto hanno suscitato una molteplicità di interpretazioni, ma hanno reso ancor più necessario, per un approccio storiograficamente corretto alla sua opera, seguire l’evoluzione del suo pensiero e mettere in rilievo le circostanze che in particolare lo hanno orientato: la
lettura dell’Hortensius di Cicerone, l’influenza della tradizione neoplatonica, la
conversione al cristianesimo, l’esegesi biblica. La comprensione dello sviluppo
del pensiero di Agostino dev’essere fondata in primo luogo sul suo inserimento
nel contesto dello scontro tra la civiltà classico-pagana e quella cristiana. Oltre
1 Cfr. R. JOLIVET, Augustin et le néoplatonisme chrétien, Les Éditions Denoël et Steele,
Paris 1932.
98
Maria Letizia Pelosi
a ciò, Agostino occupa un ruolo decisivo all’interno della tradizione filosofica
occidentale, al punto da potere essere considerato un vero e proprio iniziatore
della vita spirituale moderna.2
Come ha messo in evidenza in particolare Karl Jaspers, il confronto con i
filosofi del passato dev’essere concepito come un dialogo vivente nella ricerca
della verità. Riflettendo sul modo in cui Jaspers si avvicina alla storia della filosofia si può, infatti, affermare che per Jaspers “l’appropriazione delle filosofie
del passato è […] una forma di relazione: non la relazione con dottrine astratte,
ma ogni volta con una personalità, con una vita filosofica, con un «grande»”.3
E proprio a proposito della riconfigurazione concettuale dei problemi di Agostino, Jaspers scrive: “nell’estensione smisurata della sua opera sono inesauribili le possibilità di ritrovamenti per il lavoratore paziente che ce le mostra”.4
Studiare il complesso dell’opera di Agostino può rivelarsi quindi un compito
inesauribile, ma si può certamente confrontarsi con il suo pensiero all’interno
di prospettive circoscritte, quali la chiarificazione dell’interiorità dell’anima, le
riflessioni sul tempo e la memoria, le considerazioni sulla libertà e la grazia o
quelle sull’origine e l’essere del mondo. La limitazione del campo della ricerca
non è una rinuncia alla problematicità, ma la condizione dalla quale emergono
quelle “grandi idee fondamentali intorno all’essere dell’uomo”5 che hanno il carattere dell’universalità: “in tutti i grandi tentativi agostiniani – scrive Jaspers
– credo di scorgere dei movimenti di pensiero filosofico, nella misura in cui si
fanno valere le questioni eterne del filosofare”.6 Così, nella prospettiva jaspersiana, per cui la ricerca della verità è contrassegnata da una costante, inquieta
problematicità, le incoerenze che pure è possibile rilevare in Agostino non rappresentano un punto debole all’interno di un sistema compiuto, ma un tratto
caratteristico della sua grandezza.
Allo stile di ricerca volto alla scoperta delle “vene d’oro e pietre preziose”7
contenute nella miniera delle opere di Agostino appartiene lo studio agostiniano di Hannah Arendt, vale a dire la dissertazione su Il concetto d’amore in Ago-
2 Un quadro sintetico delle discussioni intorno allo sviluppo biografico e speculativo di
Agostino, si trova nell’introduzione di Christine Mohrmann alle Confessioni, in SANT’AGOSTINO, Le confessioni, intr. di C. Mohrmann, trad. di C. Vitali, BUR, Milano 2006, pp. 23 e ss.
Per una ricognizione storiografica sulla presenza di Agostino nella filosofia del Novecento cfr.
AA. VV., Esistenza e libertà. Agostino nella filosofia del Novecento, 3 vv., a cura di L. Alici, R.
Piccolomini, A. Pieretti, Città Nuova, Roma 2000 e relativa bibliografia.
3 G. CANTILLO, Introduzione a Jaspers, Laterza, Roma-Bari, 20022, p. 152.
4 K. JASPERS, I grandi filosofi, a cura di F. Costa, Longanesi, Milano 1973, p. 408.
5 Ivi, p. 444.
6 Ivi, p. 468.
7 Ivi, p. 407.
Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
99
stino (discussa nel novembre 1928 e pubblicata nel 1929 per l’editore Springer
di Berlino); studio che fa sentire i suoi effetti attraverso la sua intera esperienza
intellettuale. L’analisi del testo dedicato ad Agostino mira quindi a verificare
quanto di questa esperienza giovanile di pensiero resta come fonte costante di
problematicità teorica.
Si può ricondurre in modo convincente la presenza di Agostino nel pensiero di Hannah Arendt a forti istanze etico-morali,8 il che, del resto, può trovare
conferma nei significativi riferimenti ad Agostino contenuti nelle lezioni tenute
tra il 1965 e 1966 alla New York School for Social Research e raccolte nel testo
intitolato Alcune questioni di filosofia morale9. In esso, partendo da una riflessione sui concetti di bene e male, Hannah Arendt affronta il problema dell’impossibilità di risalire all’infinito nell’ordine delle cause in un contesto etico-morale:
“già Agostino - sottolinea Arendt - lo aveva segnalato nel De libero arbitrio (3.
17)” 10, dove è scritto:
Siccome la volontà è la causa del peccato, e tu ricerchi la causa della
volontà stessa, se avrò potuto trovare questa, non andrai forse a cercare
la causa anche della causa che sarà trovata?11
Non si può dunque regredire senza limite alla ricerca di una causa. Posto
che la volontà deve essere causa di se stessa, si deve affrontare il problema del
perché si voglia il male e non il bene. Per Agostino “la radice di tutti i mali è
l’avidità, ossia volere di più di ciò che basta.”12 La volontà eccessiva sarebbe
allora la causa del peccato, cioè del male, e nessuna causa può venire prima
della volontà, quando si cerchino le ragioni dell’agire etico. Qui Arendt pone le
proprie obiezioni mettendo in evidenza quella che lei stessa chiama “una frattura nel seno della volontà”.13 La volontà infatti è libera di volere e non-volere
allo stesso tempo. Il suo carattere di causa originaria, nota Arendt, perde la
8 Cfr. i saggi di J. Vecchiarelli Scott and J. Chelius Stark, Rediscovering Hannah Arendt, in
H. ARENDT, Love and Saint Augustine, ed. and with an interpretive essay by J. Vecchiarelli
Scott and J. Chelius Stark, The University of Chicago Press, Chicago London, 1996, pp. 125134 e di S. MA. Kampowski, Arendt, Augustine, and the New Beginning Hannah Arendt’s Theory
of Action and Moral Thought in the Light of Der Liebesbegriff bei Augustin, Theses ad doctoratum in S. Teologia extractum, Pontificia Università Lateranense, Roma 2005.
9 H. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, in Id., Responsabilità e giudizio, a cura
di J. Kohn, Einaudi, Torino 2004, pp. 110 e ss.
10 Ivi, p. 110.
11 AGOSTINO, Il libero arbitrio, III, 17, 48.
12 Ib.
13 H. ARENDT, Alcune questioni di filosofia morale, cit., p. 111.
100
Maria Letizia Pelosi
sua plausibilità nel momento in cui ci si rende conto che la volontà è sempre
già preceduta da una scelta; in altri termini preceduta da un principio che, a
sua volta, la determina. Ed infatti, sostiene Arendt, già in Agostino “ciò che sta
dietro la volontà […] è il fatto che omnes homines beatus esse volunt”14, il fatto
che ogni uomo vuole essere felice. Bisogna quindi determinare cosa sia o cosa
significhi essere felice, ovvero, che cosa la volontà debba o non debba volere,
per agire bene o male. In questo modo la ricerca di un fondamento per l’agire
morale deve affidarsi ad un principio assoluto, che, secondo l’interpretazione
della Arendt, significa dare ragione della infelicità terrena tramite un’aspettativa di felicità eterna e in un mondo a venire.
II
Gli argomenti critici sollevati dalla Arendt in Alcune questioni di filosofia
morale nei confronti di Agostino, che non sarebbe riuscito a superare le difficoltà derivanti dalle aporie della volontà se non facendo ricorso ad un principio
esterno alla volontà stessa, non sono distanti da quelli già emersi nel suo lavoro di abilitazione. Anche qui Hannah Arendt affronta “le incongruenze”15 del
pensiero di Agostino, sollevando la questione del rapporto tra il sé e l’altro in
relazione ad una legge esterna alla coscienza “naturale” del soggetto. Alcuni interpreti hanno considerato la monografia su Agostino come punto di partenza
della riflessione sulla vita o sulla storicità dell’esistenza sviluppata successivamente dalla Arendt. “Quella prima ricerca astratta, – scrive Julia Kristeva nella
sua trilogia dedicata al genio femminile – puramente filosofica, interroga – nel
cuore di quel legame trascendentale che è l’amore cristiano – il legame plurale che unisce gli uomini nel mondo. È già tracciato il programma di un’opera
futura: il tema della vita, attraverso l’intermediazione del tema dell’amore, dà
struttura a questo lavoro d’esordio e ci permette di rileggere Agostino insieme
alla Arendt, alla luce del suo pensiero successivo”.16 L’esistenza che – come tempo vissuto tra passato e futuro, tra nascita e morte – si interroga sul proprio
essere-nel-mondo è, per la Kristeva, questione aperta, nella ricca e articolata
opera arendtiana, dal confronto con la filosofia di Agostino. L’essere temporale
dell’esistenza umana, la caducità della sua esperienza terrena, trova il suo con-
14 15 Ivi, p. 112.
H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, trad. e cura di L. Boella, SE, Milano 2001,
p. 19.
16 Cfr. J. KRISTEVA, Il genio femminile, Tomo 1, Hannah Arendt. La vita, le parole, trad. di
M. Guerra, Donzelli, Roma 2005, p. 45.
Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
101
trappunto ideale, nell’ambito della riflessione di Hannah Arendt, nella stabilità
e nella consistenza del mondo, il luogo dove l’essere degli uomini permane pur
nell’andirivieni delle singole esistenze. Ripercorrendo le tracce dello sviluppo
del tema della temporalità nel pensiero di Hannah Arendt, Alessandro Dal Lago
ha scritto che “la possibilità di sottrarsi alla dissoluzione del tempo, e quindi
di intrattenere un rapporto non fugace con il mondo degli affari umani, è già
centrale nella dissertazione Der Liebesbegriff bei Augustin”.17 In questo testo,
infatti, la duplice concezione agostiniana, per cui il mondo è da una parte mondo creato da Dio, dall’altra mondo amato dagli uomini (“Si chiama mondo in
effetti non solo la creazione di Dio, il cielo e la terra
ma analogamente tutti gli
abitanti del mondo sono chiamati mondo […] di conseguenza tutti coloro che
amano il mondo sono chiamati mondo”18), viene interpretata dalla Arendt nel
senso di considerare il mondo storico il luogo della comune origine – e quindi
comune appartenenza – degli uomini. Questo mondo resiste alla temporalità
finita delle vite dei singoli poiché esiste prima e dopo di esse e assicura loro
pertanto una stabilità di senso nel divenire incessante dell’esistenza. È questo
un tema affrontato ripetutamente dalla Arendt nel corso della sua riflessione,
che è possibile contestualizzare originariamente nel testo su Agostino e che, a
partire da esso, può essere analizzato nei suoi sviluppi successivi in riferimento
alla filosofia di Agostino.
Di fatto nei quaderni di lavoro risalenti agli anni tra il 1950 e il 1973 troviamo Agostino tra gli autori più spesso presi in considerazione dalla Arendt, in
particolare in relazione ai temi dell’inizio e della pluralità, ovvero della creazione e della politica19; altrettanto Vita Activa20 contiene importanti riferimenti
agostiniani, e così i frammenti postumi intitolati Che cos’è la politica?21. Infine,
occorre ricordare il commento alla frase di Agostino “Initium ut esset, creatus
est homo”22, che chiude Le origini del totalitarismo23. Il totalitarismo, come forma di governo che impone agli individui un isolamento e un’estraniazione tali
17 A. DAL LAGO, La difficile vittoria sul tempo. Pensiero e azione in Hannah Arendt, intr. a
H. ARENDT, La vita della mente, il Mulino, Bologna 1987, p. 19.
18 Cfr. H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 76; AGOSTINO, Commento alla
prima lettera di Giovanni, II, 12.
19 H. ARENDT, Quaderni e diari 1950-1973, ed. ted. a cura di U. Ludz e I. Nordmann; ed.
it. a cura di C. Marzia, Neri Pozza, Vicenza 2007.
20 H. ARENDT, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958 (Vita
activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 19974), in part. i §§ 1, 2, 7, 24.
21 H. ARENDT, Che cos’è la politica?, a cura di U. Ludz. Prefazione di K. Sontheimer, Edizioni di Comunità, Milano 19972, parte 1, cap. I, frammento 3b.
22 AGOSTINO, La città di Dio, XII, 21.
23 H. ARENDT, Le origini del totalitarismo, intr. di A. Martinella; con un nuovo saggio di S.
Forti, Ed. di Comunità, Milano 1999, p. 656.
102
Maria Letizia Pelosi
da provocare la perdita dell’identità, ha distrutto la capacità di dare inizio a
qualcosa di nuovo, propria appunto di ogni individuo. L’inizio è invece esattamente ogni uomo, come Agostino ricorda: prima dell’umanità infatti non vi è
inizio. Distruggendo la capacità di dare inizio a qualcosa, si distrugge in realtà
la condizione umana stessa.
Alcuni dei problemi affrontati da Agostino, in particolare la questione della
conoscenza come triade di memoria, intelligenza e volontà, segnano profondamente anche l’ultimo libro scritto da Hannah Arendt, La vita della mente, in
merito al quale è stato osservato che la lettura arendtiana di Agostino, sebbene viziata dai limiti della sua metodologia – quella sorta di enfasi selettiva che
complica e distorce la sua lettura delle fonti – è vivificata dalla sua intuizione
circa l’attualità e l’importanza, per le questioni più urgenti della teoria politica
novecentesca, di un pensatore come Agostino.24 Le riflessioni sul giudizio, che
non poterono essere portate a compimento per la sua morte improvvisa, ma
che possono trovare una sintesi teorica nelle lezioni sulla teoria del giudizio
politico, sono svolte dalla Arendt in dialogo non solo con Kant e Nietzsche, ma
con Agostino. “In questo contesto – è stato scritto – la domanda che si pone è
la seguente: Il mondo può essere una dimora adatta all’uomo, e in che senso,
dal momento che è essenzialmente un essere temporale venuto da un passato
sconosciuto e sul punto di partire per un futuro ignoto?”25 Il mondo è per la
Arendt lo spazio pubblico comune dove dimora la capacità degli uomini di vivere insieme e di dare inizio a qualcosa di nuovo; esso non esisterebbe senza
l’attività umana che lo produce ma senza di esso non sarebbe possibile alcuna
attività.26 Agostino e le sue considerazioni sul mondo e sui rapporti degli uomini con il mondo rimangono un riferimento essenziale per Hannah Arendt, e in
questo senso è stato osservato che il mondo e gli uomini che lo costituiscono
sono il “common locus”27 dove la Arendt incontra Agostino, nella distanza come
24 J. VECCHIARELLI SCOTT, Mediaeval Sources of the Theme of Free Will in Hannah
Arendt’s The Life of the Mind: Augustine, Aquinas and Scotus, in “Augustinian Studies”, 18,
1987, pp. 107-124.
25 R. BEINER, Il giudizio in Hannah Arendt. Saggio interpretativo, in H. ARENDT, Teoria
del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant, con un saggio interpretativo di R.
Beiner, ed. americana a cura di R. Beiner, il melangolo, Genova 2005, p. 203. Beiner ha dedicato al rapporto tra Arent e Agostino anche un saggio, dal titolo Love and Worldliness: Hannah
Arendt’s Reading of Saint Augustine, in L. MAY-J. KOHN (ed.), Hannah Arendt Twenty Years
Later, Mit Press, Cambridge - London 1996, in cui viene evidenziata la sostanziale continuità
di interessi teorici tra quella che viene considerata la prima fase del pensiero arendtiano, antecedente al trauma della seconda guerra mondiale, e la successiva produzione.
26 Cfr. H. ARENDT, Vita activa, cit., p. 18.
27 P. BOYLE, Elusive neighborliness: Hannah Arendt’s Interpretation of Saint Augustine, in
Amor Mundi. Explorations in the Faith and Thought of Hannah Arendt, Martinus Nijhoff Pub-
Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
103
nella prossimità. La relazione del singolo con il mondo, ampiamente trattata
nei lavori successivi di Hannah Arendt, prende le mosse proprio dal lavoro su
Agostino e sul concetto di amore del prossimo.28
Per risalire alle premesse dei punti tematici in cui la riflessione di Arendt si
intreccia con quella di Agostino, assieme alla tesi va ricordato l’articolo, pubblicato in Germania nel 1930, su Agostino e il protestantesimo. In esso la Arendt
mette in rilievo l’importanza di Agostino per la teologia protestante e considera
Agostino addirittura un precursore di essa “al confine tra l’antichità declinante
e il medioevo emergente”.29 Elisabeth-Young Bruehl, nella sua biografia dedicata a Hannah Arendt, ha evidenziato il carattere originale e al tempo stesso
provocatorio delle dichiarazioni della Arendt in merito al ruolo di Agostino
nella cultura protestante contemporanea. Secondo la Arendt il significato della
sua opera e della sua influenza, esaltato e celebrato all’interno della cultura cattolica, erano stati in gran parte dimenticati nel mondo protestante. Ma, come
osserva giustamente la Young-Bruehl, l’articolo, pubblicato su un giornale non
specializzato, non era rivolto agli autorevoli studiosi tedeschi di Agostino, bensì
“ai protestanti in generale, e aveva lo scopo di mettere in evidenza il debito di
Lutero nei confronti di Agostino”.30 Questo debito viene condensato da Arendt
nel problema della relazione del credente a Dio. Infatti, oltre a sottolineare la
continuità tra Lutero, il pensiero della Riforma e Agostino, e a giudicare significativo il legame, verso Agostino, del pietismo, la Arendt si sofferma su quegli
aspetti dell’opera di Agostino in cui viene espressa la relazione diretta dell’anima con Dio. L’enfasi sulla vita soggettiva e sulla coscienza personale che in
solitudine e senza intermediazioni si pone davanti a Dio sono, per la Arendt, il
segno dell’ampiezza e della ricchezza della filosofia di Agostino. Agostino, per
dirla con le parole della Arendt, aveva dischiuso le porte di quell’“impero della
lischers, Boston-Dordrecht-Lancaster, 1987, p. 101.
28 Scrive a tale proposito Gabriel Motzkin nel suo saggio su “Amore e Bildung per Hannah
Arendt”, che “loving the Divine can become loving one’s neighbor, loving the community, or
even loving humanity”. Cfr. G. MOTZKIN, Love and Bildung for Hannah Arendt, in Hannah
Arendt in Jerusalem, ed. by Steven E. Aschheim, University of California Press, Berkley-Los
Angeles-London, 2001, p. 284. Da una prospettiva simile Patrick Boyle si concentra sulla questione del rapporto del singolo con il mondo. Secondo Boyle “the topic of love in Augustinus
gave Arendt the possibility to confront philosophically the existential questions of her own life
and of the world in which she lived”. Cfr. P. BOYLE, Elusive neighborliness: Hannah Arendt’s
Interpretation of Saint Augustine, cit., p. 85.
29 H. ARENDT, Agostino e il protestantesimo, in Archivio Arendt 1, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano 2001, pp. 63-64.
30 E. YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt 1906-1975. Per amore del mondo, Bollati Boringhieri, Torino 1990, p. 112.
104
Maria Letizia Pelosi
vita interiore”31 che sarebbe giunto fino al gusto romantico per il romanzo autobiografico, trovando il culmine nell’“idea di autosviluppo autonomo”32 espressa
da Goethe. Come è stato scritto, l’articolo su Agostino e il protestantesimo può
essere considerato, per il percorso intellettuale di Arendt, un “ponte gettato fra
i suoi vecchi studi filosofici e l’attuale lavoro sui romantici”.33 Nel 1930 infatti
Arendt già lavora a quella che diventerà la biografia di Rahel Varnhagen, una
donna ebrea vissuta al tempo del romanticismo, in cui pure viene affrontata, in
termini ovviamente differenti, la dimensione dell’io che si racconta ovvero della
coscienza che si confessa.34
Il tema dell’intreccio tra la “solitudine” del pensiero autoriflessivo, o dell’io
che si pone di fronte a Dio, e la presenza ineludibile della realtà esteriore, chiama in causa il problema della dialettica soggetto/oggetto, in quella forma particolare del rapporto dove si manifesta un’esteriorità irriducibile del mondo
esterno alla vita interiore del soggetto. La relazione oppositiva tra il soggetto
che pensa o agisce e l’oggetto a cui il pensiero e l’agire si riferiscono può essere considerata, in prima istanza, un atto primordiale dell’esistenza umana,
mediante il quale l’uomo si pone come soggetto costituendo il mondo che gli è
davanti come oggetto. In questo modo l’oggetto che si oppone al soggetto è in
definitiva costruito dal soggetto stesso e partecipa di un’esistenza comune. Vi è
poi un secondo livello del rapporto soggetto/oggetto, in cui i due termini conservano una relazione, ma non all’interno di uno stesso piano; essi sono invece
del tutto indipendenti l’uno dall’altro, e l’oggetto esiste al di là e oltre il soggetto
che lo pone. L’esteriorità o alterità dell’oggetto costituisce la sua essenza, esso è
del tutto fuori dal mondo del soggetto. Questo “totalmente altro”,35 come scrive
Arendt, che “rende una vita degna di essere ricordata”,36 è la chiave di accesso
per una comprensione esauriente delle Confessioni: esso “non è – scrive Arendt
– un qualsiasi principio immanente in quella vita stessa”,37 ma è “la grazia di
Dio”,38 qualcosa venuto dal di fuori, esterno al mondo che il soggetto vede e
sente; ma non – ed è qui la grandezza di Agostino – fuori dalla vita interiore
dell’anima. Si tratta dunque di un fatto particolare e individuale, che diventa
esemplare nella sua comunicabilità – è infatti materia di racconto – e che può
H. ARENDT, Agostino e il protestantesimo, cit., p. 64.
Ivi, p. 66.
33 E. YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt 1906-1975, cit., p. 112.
34 H. ARENDT, Rahel Varnhagen. Storia di una donna ebrea, a cura di L. Ritter Santini;
postf. di F. Sossi, il Saggiatore, Milano 2004.
35 H. ARENDT, Agostino protestantesimo, cit., p. 65.
36 Ib.
37 Ivi, p. 65.
38 Ib.
31 32 Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
105
essere esperito da chiunque. Ciononostante, come la stessa Arendt mette in
luce, la scoperta agostiniana della vita interiore è tutt’altro che quell’idea di
autotrasformazione autonoma che la cultura successiva esaltò nel senso di una
ritrovata indipendenza dell’io; la vita interiore ha valore per Agostino “perché
era cattiva ed è diventata buona”,39 cioè, perché ha incontrato Dio e in Lui si è
redenta, si è realizzata. L’incontro con Dio è subordinato all’evento della grazia
in Agostino. Ma contemporaneamente all’affidamento a Dio, Agostino, secondo
Arendt, “non smise mai di cercare di comprendere e interpretare il mondo in
termini filosofico-cosmologici”.40 Ciò vuol dire che, insieme alla scoperta della vita interiore, toccata dalla grazia da Dio, in Agostino trova ancora spazio
una concezione del mondo che assegna ad esso il carattere di dimora unica
e permanente per gli uomini. In questo senso Arendt aveva già parlato delle
“contraddizioni” di Agostino, pensatore in bilico tra tradizione greco-romana
e cultura cristiana. Questa “ambiguità” di Agostino è sottolineata da Arendt sia
nell’articolo su Agostino e il protestantesimo che nella monografia su Agostino,
e può essere compresa aprendo la domanda intorno alla possibilità, per l’io
alla ricerca del senso del proprio esistere, di ri-trovarsi nel già esistente: la questione che Arendt pone all’“ambiguità” di Agostino è se sia possibile trovare il
senso originario dell’esistenza senza dover risalire a un principio trascendente
l’esistenza stessa, ma restando invece all’interno del proprio essere-nel-mondo.
La scoperta di sé, della propria verità in opposizione al senso di smarrimento cui è condannato l’animo umano a causa della sua inquietudine e finitezza,
avviene in Agostino attraverso un ritorno alla propria origine, un riferirsi all’indietro al principio creatore:
Io dunque non esisterei, mio Dio, non sarei assolutamente nulla,
se tu non fossi in me. O piuttosto, non esisterei se io non fossi in te:
perché da te, per te, in te ogni cosa esiste. […] Chiederlo a te, cercare
te, bussare a te bisogna: così – solo così – ci sarà dato, così si troverà,
ci sarà aperto.41
“Il trovare se stessi – scrive la Arendt ne Il concetto d’amore in Agostino –
coincide con il trovare Dio. Solo con l’aiuto di Dio inoltre posso trovarmi. Ma
ciò significa che, nell’istante in cui inizio a cercarmi, non appartengo già più
Ivi, p. 65.
Ib.
41 AGOSTINO, Confessioni, I, 2,2 e XIII, 38,53.
39 40 106
Maria Letizia Pelosi
al mondo […]”.42 In queste righe è sintetizzata incisivamente la problematica
all’origine dello studio di abilitazione al dottorato di Hannah Arendt: la domanda cioè intorno alla ragione per cui il soggetto che si interroga sul suo esserenel-mondo ha bisogno di una struttura di riferimento non mondana, non temporale, non materiale, trascendente la soggettività, e se la filosofia sia in grado,
da sola, di rispondere a questa domanda e in che modo.
III
Nel mettere in evidenza il carattere persistente e peculiare del rapporto di
Hannah Arendt con i testi di Agostino, credo sia importante segnalare che il
suo proponimento non è mai stato, nei confronti del pensiero di Agostino come
dell’intera tradizione filosofica occidentale, quello di offrire un’interpretazione
strettamente storiografica del suo pensiero, quanto piuttosto di decostruirlo:
decostruzione che qui si deve intendere nel senso letterale del termine, come
una scomposizione e analisi delle parti e degli ingranaggi di un intero impianto concettuale, il cui centro Arendt crede di individuare appunto nel principio
dell’amore. Non quindi una critica radicale del sistema della metafisica attraverso una “disseminazione” del senso delle sue strutture ontologiche, come si
può intendere oggi il termine “decostruzione”, quanto piuttosto (e seguendo
l’Heidegger di Essere e Tempo) una “distruzione” della storia di un particolare
ambito concettuale, al fine di aprire l’accesso all’esperienza originaria che ha
determinato quel particolare concetto, attraverso un “lasciar parlare le cose
stesse” e una comprensione del fenomeno concettuale per come si mostra. Questíintenzione risulta evidente ne Il concetto d’amore in Agostino, in cui è richiamato più volte il tratto proprio ed originale dell’esposizione, che la stessa autrice sintetizza con la formula efficace di “lasciar sussistere le contraddizioni, per
quello che sono, renderle comprensibili in quanto contraddizioni e cogliere ciò
che sta dietro di esse.”43
Il problema del rapporto dell’uomo con Dio, o con la trascendenza, viene
“tradotto” da Hannah Arendt, nella sua tesi, nel problema posto dalla domanda
dell’uomo sulla propria origine, ovvero, sull’Essere; una domanda, sottolinea
Arendt, essenzialmente filosofica. La scelta di attenersi ad un ordine filosofico,
e di escludere le implicazioni teologiche e dottrinarie, comporta il concentrarsi
H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 35.
H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino. Saggio di interpretazione filosofica, trad. e
cura di L. Boella, SE, Milano 2001, p. 19.
42 43 Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
107
dell’attenzione sulla questione della “rilevanza dell’altro”,44 cioè sull’amore per
il prossimo, cercando di ricondurre idee e linee di pensiero apparentemente
eterogenee ad un unico fondamento concettuale, costituito appunto dall’amore. Pur affrontando una serie di questioni collaterali, alcune delle quali si manterranno vive anche nel pensiero successivo della Arendt, lo studio si mantiene
aderente alla trattazione di un unico problema: che cosa significa amare Dio
e il prossimo come se stessi. Altrettanto non vengono particolarmente osservati i cambiamenti di rotta interni al percorso speculativo di Agostino, né le
evoluzioni teoriche determinate da quella particolare commistione di categorie
filosofiche greco-elleniche e di cultura biblica e cristiana che proprio la trattazione dell’amore fa emergere nel corso della sua opera. Certamente quella della
Arendt è una scelta che – consapevolmente – lascia fuori gioco un aspetto essenziale del pensiero di Agostino; quella unità tra riflessione sull’amore e riflessione teologica che è stata messa in rilievo, per esempio, da Raymond Canning.45
Secondo Canning la questione dell’amore di Dio e del prossimo è centrale per
comprendere lo sviluppo della teologia agostiniana. Canning dimostra che già
nel De Moribus, scritto immediatamente dopo la conversione, Agostino teorizza
l’unità dell’amore di Dio e del prossimo, fino a giungere, quasi trenta anni dopo,
nel Commento alla prima lettera di Giovanni, a fare dei due amori un unico
amore in Cristo: “probing love of neighbour – scrive Canning – not only reveals
the presence or absence of love for God but also whether or not a person still
has a living faith in the incarnation of Christ”.46 Il punto di partenza, per così
dire pratico e concreto, amare il prossimo nella vita presente e terrena, è molto
di più di un mero inizio alla conoscenza di Dio. È Dio stesso che diventa visibile e presente quando ci si ama gli uni con gli altri. Amare il prossimo significa
non solo vivere rettamente e seguire Cristo, ma desiderare che il prossimo viva
rettamente e segua Cristo; Dio e il prossimo sono amati dello stesso amore. In
questa unità la via dell’interiorità alla conoscenza di Dio viene a coincidere, secondo Canning, con la missione della Chiesa, nella quale è presente lo Spirito
di Dio che è amore. L’amore di Dio infatti non può far seguito a quello del prossimo, ma anzi lo preannunzia poiché è Cristo che viene amato nel prossimo. In
questo senso Canning parla dell’importanza dell’amore del prossimo per comprendere la teologia agostiniana nel suo complesso.
Ci si deve chiedere pertanto fino a che punto sia possibile fondare sull’espeIb.
Cfr. R. CANNING, The Unity of Love For God and Neighbour, “Augustiniana”, XXXVII,
1987, pp. 38-121.
46 Ivi, p. 73.
44 45 108
Maria Letizia Pelosi
rienza puramente umana il comandamento dell’amore, indipendentemente
dalla rivelazione divina, e in modo tale da svolgere un’indagine nei limiti di
una “sfera pre-teologica”.47 E, ancora, è l’estrazione fenomenologica di Hannah
Arendt, di quel tipo particolare di fenomenologia orientata verso la filosofia
dell’esistenza, ad indirizzare, al di là del rilievo specifico del pensiero di Agostino, le domande di fondo che la filosofa si pone nel libro su Agostino, oppure le
idee agostiniane sulla vita dell’uomo offrivano opzioni teoretiche di per sé ancora valide per le necessità sollevate da quelle determinate circostanze storiche
e spirituali in cui Arendt si trovava?48
In ogni caso l’“impenetrabile discorso fenomenologico”49 che aveva dato
luogo alla dissertazione su Agostino venne da più parti criticato al momento
dell’uscita del libro. Vi sono recensioni per niente favorevoli all’interpretazione
di Hannah Arendt, proprio in relazione alla sua distanza da una lettura ortodossa del grande filosofo.50 J. Hessen, per esempio, se non trova incongrua la
domanda posta da Arendt circa la possibilità di amare il prossimo al di fuori
della realtà mondana e nel puro rapporto con Dio, critica però la scelta di aver
deliberatamente ignorato la letteratura specialistica sull’argomento, che avrebbe potuto fornire alla ricerca supporti adeguati e più convincenti.51 A sua volta
J. Ternus individua nel lavoro di Hannah Arendt i segni di quella nuova tipologia di analisi fenomenologica, le cui giustificazioni di metodo appaiono poco
convincenti se messe di fronte al compito di comprendere la grandiosa sintesi
teologico-filosofica cui è approdato il pensiero di Agostino.52 In questo senso H.
Eger nega la possibilità di interpretare Agostino prescindendo dal vincolo teologico, e questo non solo per quanto riguarda il rapporto uomo-Dio, ma anche
tenendo presente l’importanza e il significato preciso che ha la morte nel pensiero di Agostino, come passaggio alla vita eterna.53
Probabilmente Hannah Arendt aveva trovato un sostegno critico per lasciare da parte le considerazioni di ordine teologico negli studi di Prosper Alfaric,
H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 16.
Per la curvatura originale dell’interpretazione arendtiana di Agostino nei confronti di
altre letture, si veda L. BOELLA, Hannah Arendt. Amor mundi, in AA. VV., Esistenza e libertà.
Agostino nella filosofia del Novecento, cit.
49 J. VECCHIARELLI SCOTT - J. CHELIUS STARK, Rediscovering Love and Saint Augustin, in H. ARENDT, Love and Saint Augustine, p. XIII.
50 Cfr. E. YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt 1906-1975, cit. , p. 105.
51 J. HESSEN, Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff bei Augustin, “Kant-Studien”, 36, 1931, p. 175.
52 Cfr. J. TERNUS, Der Liebesbegriff bei Augustin, von Hannah Arendt, “Philosophisches
Jahrbuch”, 43, 1930, pp. 407-408.
53 Cfr. H. EGER, Hannah Arendt, Der Liebesbegriff bei Augustin, “Zeitschrift für Kirchengeschichte”, XLIX, n. f. XII, 1930, pp. 257-259.
47 48 Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
109
il cui testo viene segnalato da lei come tra le migliori esposizioni dell’evoluzione intellettuale di Agostino.54 Alfaric può essere considerato uno dei nomi
principali di quella corrente critica che tendeva a separare il pensiero di Agostino in quanto speculazione razionale autonoma dagli aspetti dogmatici della
fede e della dottrina cristiana. Si possono considerare appartenenti a questa
corrente studiosi come Adolf von Harnack e Wilhelm Thimme, pure presi in
considerazione dalla Arendt nella sua bibliografia. Questa maniera “totalmente
antistorica”55 di interpretare gli scritti di Agostino, alla luce di una distinzione
pretestuosa tra ciò che è cristiano e ciò che non lo è, conduce giocoforza a trascurare quella sintesi tra l’elemento cristiano e quello neoplatonico che, secondo altri interpreti56, dev’essere considerato un tratto caratteristico dell’opera di
Agostino.
Alfaric insiste sull’inquietudine di Agostino, che lo porta ad “allargare continuamente il suo orizzonte”57 e che rende impossibile considerare i suoi scritti
come un’opera unica, in cui le parti si completano logicamente all’interno di
un sistema coerente. I diversi contesti sociali e culturali con i quali Agostino si
misura si intrecciano con la sua vita spirituale, agitata e in continua ricerca. In
questo senso, secondo Alfaric, un elemento tra gli altri fa luce sulla tendenza
critica del pensiero di Agostino, ed è la filosofia neoplatonica, più importante
addirittura della stessa conversione al Vangelo.
Senza entrare, ovviamente, in una ricostruzione della complessa storia dei
rapporti tra Agostino e la tradizione filosofica precedente, si può osservare però
che nelle correnti filosofiche antiche Agostino cerca modelli ed esempi che gli
consentano di esporre il proprio pensiero senza distaccarsi dalla fede cui fa
costante riferimento e che sta a fondamento della sua riflessione. Il che non gli
impedisce, appunto, di ritenere necessario il confronto con i filosofi greci e romani. Com’egli stesso scrive:
Ora, al contrario, si deve stabilire un confronto con i filosofi il cui
nome stesso tradotto in latino significa l’amore alla sapienza. Quindi se
Dio è sapienza, mediante la quale è stato creato l’universo, come ha ri-
Cfr. H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 17.
R. HOLTE, Beatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme dans la
philosophie ancienne, Études Augustiniennes, Paris 1962, p. 82.
56 Cfr. R. HOLTE, Beatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme
dans la philosophie ancienne, cit. e Ch. BOYER, Christianesime et Néo-Platonisme dans la formation de saint Augustin, Paris 1920.
57 P. ALFARIC, L’évolution intellectuelle de Saint Augustin, Émile Nourry éditeur, Paris
1928, p. III.
54 55 110
Maria Letizia Pelosi
velato la verità della divina tradizione, il vero filosofo è colui che ama
Dio. Ma il significato in sé, indicato da questo nome, non si trova in tutti
coloro che menano vanto del nome, perché non necessariamente coloro
che si dicono filosofi amano la vera sapienza. Pertanto fra tutti coloro,
di cui è stato possibile conoscere le teorie nella tradizione letteraria, si
devono scegliere quelli con cui si possa trattare convenientemente il problema in parola. Non ho infatti intenzione di ribattere in questa opera
tutte le errate teorie di tutti i filosofi ma quelle soltanto che sono attinenti
alla teologia, parola greca con cui s’intende indicare il pensiero ossia il
discorso sulla divinità.58
L’ideale della saggezza si realizza, per Agostino, nel cristianesimo. Se, alla
luce del rapporto unificante tra fede e filosofia di cui Agostino si fa testimone
nel passo appena citato, si considera Agostino come un continuatore di una
sintesi già elaborata dal cristianesimo primitivo tra cristianesimo e neo-platonismo, le distinzioni tra un Agostino teologo e un Agostino filosofo vengono
assorbite all’interno di un’unica grande figura teorica. In questa prospettiva la
separazione di teologia e filosofia in Agostino appare come una distorsione.
Ben diverse erano evidentemente le intenzioni della Arendt ed i suoi presupposti interpretativi. I due argomenti presentati da Alfaric, lo spostamento
continuo in Agostino dei limiti della riflessione e l’influenza della filosofia greca,
vengono assunti da Hannah Arendt per dimostrare che l’interesse originario del
pensiero di Agostino non riflette una vittoria dell’elemento cristiano su quello
platonico o viceversa, ma persiste lungo l’intero arco della sua evoluzione nella
forma dell’interrogazione filosofica. È questa interrogazione che lascia aperta
ad un’interpretazione pre-teologica la questione della rilevanza del prossimo
o, per dirla con Arendt: “come sia possibile che l’uomo, isolato da tutto quanto
è mondano, coram Deo nutra ancora un interesse verso il prossimo”.59 Di qui
l’analisi delle forme dell’amore, in corrispondenza delle direzioni verso le quali
esso si volge. Tali direzioni, determinate dall’oggetto a cui l’amore stesso è indirizzato, generano a loro volta tre diverse forme di amore: l’amore come desiderio, l’amore come rapporto fra l’uomo e Dio e l’amore per il prossimo.
Queste tre forme d’amore non sono altro, nella lettura arendtiana, che tre
diversi sistemi concettuali, emergenti proprio dalla coesistenza, in Agostino,
di diverse tradizioni filosofiche e intellettuali, e all’interno dei quali il concetto
58 59 AGOSTINO, La città di Dio, VIII, 1.
H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 19.
Verticalità e orizzontalità dell’amore:Hannah Arendt interprete di Agostino
111
d’amore gioca un ruolo decisivo. Tali sistemi concettuali danno il nome a ciascun capitolo del libro: “Amor qua appetitus”, ovvero l’ambito del desiderio o
del futuro, “Creator-creatura”, ovvero l’ambito del passato o dell’origine, e “Vita
socialis”, ovvero il mondo dell’essere insieme e della comunità degli uomini, in
cui il prossimo viene ad assumere un significato differente ma interdipendente
dai due contesti precedenti. Le tre linee di pensiero (futuro, origine, società)
non possono essere giustapposte o messe in relazione sistematicamente o antiteticamente. Esse sono tenute insieme soltanto dalla questione concernente la
rilevanza del prossimo, ovvero dalla lex scripta in cordibus nostris,60 che costituisce l’unitarietà delle due domande poste qui di seguito: la legge della coscienza,
ovvero la legge morale “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”, precede il comandamento divino “ama il prossimo tuo come te stesso”? Perché, per
il soggetto che riflette su di sé, sul senso della propria esistenza, sulla propria
origine, la legge divina è l’unica strada per pervenire alla propria verità?
Le definizioni che Agostino dà dell’amore vengono interpretate dalla Arendt
in direzione di tre linee concettuali: che cosa significa amare il prossimo in
relazione all’amore come appetitus, in relazione all’amore di Dio come ricerca
della propria origine, e in relazione alla comunità degli uomini. Quest’ultimo
punto costituisce un momento a sé, che guarda all’amore come possibilità del
singolo di accedere ad un’esperienza universale, ed è trattato nella terza parte
della dissertazione, in cui viene sottolineata l’importanza dell’“essere-insieme
degli uomini nella comunità umana”.61 Da esso inoltre Arendt trae il criterio per
far emergere, dalle precedenti trattazioni dell’amore, incongruenze e duplicità
che non solo testimoniano aspetti meno noti dell’opera di Agostino, ma che mostrano come, in Agostino stesso, siano presenti, interagiscano e si influenzino
intenzioni differenti, che precedono le interpretazioni teologiche e che chiamano in causa la posizione dell’uomo nel mondo. La condizione degli uomini è di
vivere in relazione gli uni con gli altri; e, conclude Hannah Arendt, la rilevanza
del prossimo per la propria esistenza si può comprendere e realizzare solo se
ci si considera appartenenti ad una comunità. Nella comunità ciascun singolo
uomo trova l’accesso alla dimensione dell’universalità. Per poter amare ed essere amati come singoli è necessario essere nella comunità, ma l’amore non è
possibile se non uscendo fuori dalla singolarità di se stessi per andare incontro
agli altri.
60 Cfr. H. ARENDT, Il concetto d’amore in Agostino, cit., p. 15 e AGOSTINO, Confessioni,
II, 4, 9.
61 Ivi, p. 131.
112
Maria Letizia Pelosi
La questione della relazione tra universale e particolare, ovvero tra comunità e singolarità, viene risolta in Agostino grazie alla capacità dell’amore di
essere universalizzato. L’amore agostiniano è il sentiero che conduce dal particolare all’universale, dall’isolamento alla comunità. Tuttavia, per poter amare
il prossimo, e costituire così una comunità, io devo riferire il mio amore a Dio.
Questo riferirsi ad una realtà ultramondana, intesa come origine, costituisce,
nell’interpretazione della Arendt, il tratto di maggiore complessità.
Nella revisione del testo giovanile su Agostino, la Arendt ritornerà su questo
punto, sostenendo che, nella caritas, il prossimo è amato “in sublime indifferenza per cosa o chi egli sia”;62 e non è sufficiente risolvere questo problema
riferendo l’amore del prossimo all’amore di Dio. È vero infatti che amando Dio
io amo il mio prossimo, chiunque egli sia, ma è anche vero che non posso considerare l’altro mio prossimo se non come membro di un genere umano che si
costituisce come tale da sé e all’interno della propria storia. Se la caritas agostiniana deve essere compresa come un principio (tanto etico quanto politico)
che non può fare a meno di Dio – se vogliamo restare alla interpretazione della
Arendt – non per questo essa non contiene una forza sociale in grado di trasformare il mondo. È questa possibilità di trasformazione a costituire l’unità di senso, non soltanto teorica, ma pratica e politica del concetto d’amore, nel quale è
manifesta l’indissolubilità del destino individuale da quello della comunità.
62 H. ARENDT, Love and Saint Augustine, ed. and with an interpretive essay by J. Vecchiarelli Scott and J. Chelius Stark, The University of Chicago Press, Chicago London, 1996,
p. 43.
Macchine Performative
113
Macchine Performative
La produzione tecnica del performativo in Jacques Derrida
Memoria di Mauro Senatore
presentata dal socio naz. ord. res. Aldo Trione
(seduta del 26 febbraio 2009)
Ce qui compte, me semble-t-il, c’est la scène du serment à ne pas
trahir, l’engagement performatif à ne pas parjurer ou abjurer. Cet appel me parait plus puissant et donc plus signifiant que la dimension
théorique ou constative d’une vérité à révéler ou à connaître.
(J. Derrida, Le ruban de la machine à écrire. Limited Ink II)
Abstract. The essay brings into focus a set of displacements that the analysis of technical production as an effect of the inscription of the sense into the mark, elaborated by
Derrida in Signature Evénement Contexte (Sec), causes within the metaphysical tradition
presupposed by the concept of performative utterance and the structure of the event the
performative adheres to more than any other utterance. The effects of Derrida’s analysis
are singled out within the reading of Austin’s work proposed by Derrida in Sec and within
the readings of the Austinian orthodoxy, of Augustine’s and Rousseau’s performatives
and of the style of de Man’s deconstruction deployed in Le ruban de la machine à écrire.
Limited Ink II. Derrida’s analysis of the paradoxical synthesis of singular and general,
articulating the structures of mark and work (oeuvre), is understood to put into relief the
irreducible conditions of the institution of the event in general, which the metaphysical
tradition conjures or removes by a certain determination of technical production.
Il dispositivo autoproduttivo del marchio
Nel progetto di generalizzazione e dislocamento del concetto classico di
scrittura messo in opera da Derrida in Signature événement contexte (Sec) l’elemento della produzione meccanica è introdotto come effetto della produzione
del marchio, che consiste, per definizione, nell’inscrizione del senso in una forma leggibile o identificabile. Questa produzione di senso presuppone un’operazione puntuale determinata dalla presenza ordinatrice o dall’assistenza dell’intenzione e, in ultima analisi, della coscienza di un io singolare e vivente. Dun-
114
Mauro Senatore
que il testo di Derrida connette la produzione meccanica ad una certa operazione singolare e presente come alla sua causa produttiva.
Ecrire, c’est produire une marque qui constituera une sorte de machine
à son tour productrice, que ma disparation future n’empêchera pas principiellement de fonctionner et de donner, de se donner à lire et à réécrire.
Quand je dis « ma disparition future », c’est pour rendre cette proposition
plus immédiatement acceptable. Je dois pouvoir dire ma disparition tout
court, ma non-présence en général, et par exemple la non-présence de mon
vouloir-dire, de mon intention-de-signification, de mon vouloir-communiquer-ceci, à l’émission ou à la production de la marque.1
Il marchio si presta alla lettura e all’identificazione future in modo da supplire la produzione di senso, della quale è l’effetto, il risultato o la traccia, e che
si presenta strutturalmente finita e inefficace a conservarsi oltre la propria occorrenza originale. L’inscrizione del senso nel marchio comporta la sua incorporazione in una forma, che si determina in vista di un’utilizzazione virtuale e,
in linea di principio, illimitata, e, dunque, risulta assolutamente altra rispetto
alla produzione singolare e presente, e sciolta dall’insieme delle presenze che
la organizzano2.
La forma-marchio individua un dispositivo macchinico autoproduttivo.
Poiché la prestazione del marchio si costituisce nello spazio della virtualità o
dell’utilizzazione a venire, al di là o a prescindere dalla presenza dell’io singolare e cosciente responsabile della produzione di senso, essa si sviluppa come lavoro di ripetizione automatica di un programma prestabilito, o dello stesso, che
la tradizione filosofica pensa come radicalmente opposto ed esclusivo rispetto
alla presenza e alla vita dell’intenzione e della coscienza. Individuando l’effetto
virtuale o futuro di questo lavoro, il marchio si configura come una macchina
dotata del potere di generare se stessa: esso assolve alla funzione di supplenza
o di conservazione del presente attraverso la sostituzione di sé con sé stesso, o
dello stesso. L’elemento macchinico e autoproduttivo rilevato nella struttura del
marchio è l’esempio o il concetto di una certa produzione meccanica o tecnica
1 J. Derrida, Signature événement contexte in idem, Marges de la Philosophie, Les Editions
de Minuit, Paris 1972 p. 376.
2 Per la dinamica dell’incorporazione del senso si rimanda agli studi su Derrida di Francesco Vitale. In particolare, sul nesso tra scrittura e produzione tecnica vedi F. Vitale, “Spettri
della singolarità. La vita, la tecnica, l’archiscrittura” in idem, Spettrografie. Jacques Derrida tra
singolarità e scrittura, Il Melangolo, Genova 2008 pp.79-106.
Macchine Performative
115
che esclude la produzione dell’io singolare e cosciente alla quale, ad un tempo,
rimanda come effetto o traccia.
Il marchio descrive, fin dalla sua origine, la struttura difficile da pensare del
nodo di articolazione, della giuntura o del cardine, tra la produzione originale,
singolare e presente, e la produzione meccanica, ripetibile all’infinito, entro la
quale si configura insieme come causa ed effetto, causa sui. In questa struttura
è prescritta la duplicazione o la scissione da sé della produzione singolare nella
prestazione di una macchina autoproduttiva. Ora, poiché il marchio e, in genere, l’incorporazione del senso in una forma indefinitamente utilizzabile individuano le condizioni irriducibili della produzione di senso, allora l’articolazione
paradossale alla produzione meccanica pertiene alla struttura stessa della produzione presente di un io singolare e cosciente.
Se il dispositivo macchinico autoproduttivo è sotteso al funzionamento della scrittura come struttura utilizzabile in genere, e, dunque, se ad esso si applicano i predicati essenziali di questa struttura, allora esso è necessariamente
implicato nel movimento filosofico per eccellenza che Derrida identifica con la
condanna platonica della scrittura.
Cette dérive essentielle tenant à l’écriture comme structure itérative,
coupée de toute responsabilité absolue, de la conscience comme autorité
de dernière instance, orpheline et séparée dès sa naissance de l’assistance
de son père, c’est bien ce que Platon condamnait dans le Phèdre. Si le
geste de Platon est, comme je le crois, le mouvement philosophique par
excellence, on mesure ici l’enjeu qui nous occupe3.
Il dispositivo macchinico rappresenta la condizione essenziale e irriducibile
della produzione di senso, a partire dall’elaborazione dell’esperienza dell’essere
come presenza e, dunque, dalla costituzione dell’immaginazione e della memoria
di un io singolare e vivente4. Seguendo il testo di Condillac, che in Sec è richiamato come esempio del trattamento filosofico e tradizionale della scrittura, Derrida
determina la genesi del primo segno come coessenziale alla genesi della memoria
e dell’immaginazione finite. Il segno supplisce l’idea causata dall’oggetto poiché
Sec p.376
Cfr. Sec, p.377: […] je voudrais démontrer que les traits qu’on peut reconnaître dans le
concept classique et étroitement défini d’écriture sont généralisables. Ils vaudraient non seulement pour tous les ordres des «signes» et pour tous les langages en général, mais même, au-delà
de la communication sémio-linguistique, pour tout le champ de ce que la philosophie appellerait
l’expérience, voire l’expérience de l’être, ladite «présence». Sulla capacità della scrittura di articolare la produzione di senso all’esperienza dell’io singolare e cosciente vedi Vitale, pp.103-4.
3 4 116
Mauro Senatore
si dispone all’utilizzazione a venire costituendosi nell’orizzonte della virtualità o
dell’autoproduttività macchinica inesauribile. La relazione di continuità o di analogia che annoda il segno all’idea presente insiste fin dal principio su un certo lavoro meccanico o tecnico.
Le signe nait en même temps que l’imagination et la mémoire, au
moment où il est requis par l’absence de l’objet à la perception présente
(«La mémoire, comme nous l’avons vu, ne consiste que dans le pouvoir
de nous rappeler les signes des nos idées, ou les circonstances qui les ont
accompagnées; et ce pouvoir n’as lieu qu’autant que par l’analogie des
signes [je souligne ce concept d’analogie, qui organise toute la systématique de Condillac, assure en général toutes les continuités et en particulier celle de la présence à l’absence] que nous avons choisis et par l’ordre
que nous avons mis entre nos idées des objets que nous voulons retracer,
tiennent à quelques-uns de nos besoins présents» 1, 11, ch.IV, 39).5
La lettura dell’ortodossia austiniana
Sec sviluppa l’analisi delle condizioni di possibilità dell’evento, considerato
sotto la determinazione tradizionale e filosofica di produzione presente e singolare, attraverso la lettura del concetto di performativo elaborato da Austin in
How to do things with words. La messa a fuoco del testo di Austin consente a
Derrida di isolare la struttura della specie di enunciato alla quale, più propriamente che ad ogni altra, aderiscono i predicati essenziali del concetto tradizionale di evento, presenza e singolarità, e la cui analisi propaga, dunque, in modo
esemplare i propri effetti sullo statuto generale e la logica dell’evento6.
L’enunciato performativo o, semplicemente, il performativo è determinato
da Austin, in opposizione all’enunciato constativo, poiché non descrive, riferisce, o constata, costituendosi dunque nell’orizzonte della verità o della verificazione referenziale, ma assolve allo svolgimento di un’azione che non è semplicemente riducibile all’operazione o all’atto del dire7.
Sec, p.373
Cfr. Sec, p.390: La différance, l’absence irréductible de l’intention ou de l’assistance à l’énoncé performatif, l’énoncé le plus «événementiel» qui soit, c’est ce qui m’autorise, compte tenu des
prédicats que j’ai rappelés toute à l’heure, à poser la structure graphématique générale de toute
«communication».
7 J. Austin, How to do things with words, Oxford Clarendon Press, London 1962 (Htw) p.5:
Utterances can be found, satisfying these conditions, yet such that: A. they do not ‘describe’ or ‘re5 6 Macchine Performative
117
Austin suggerisce di apprezzare lo scarto tra le due specie del constativo e
del performativo confrontando l’enunciato nel quale un io singolare e presente
descrive l’azione in cui è impegnato con l’enunciato che coincide con la stessa
azione presente di quell’io.
It seems clear that to utter the sentence (in, of course, the appropriate
circumstances) is not to describe my doing of what I should be said in so
uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do it. None of the
utterances cited is either true or false: I assert this as obvious and do not
argue it. […] To name the ship is to say (in the appropriate circumstances) the words ‘I name, &c.’. When I say, before the registrar or altar, &c.,
‘I do’, I am not reporting on a marriage: I am indulging in it8.
L’ipotesi, avanzata da Austin nella prima lezione, di ricorrere al termine operativo, considerato nella sua accezione tecnica, per denominare la specie del
performativo insiste sulla determinazione delle condizioni di singolarità e presenza come tratti essenziali alla produzione del performativo stesso9. Questa
specie di enunciato, come la parte essenziale del documento legale al quale rinvia il termine operativo, è vincolata per definizione all’effettuazione presente di
una transazione, ad opera di un io singolare e cosciente.
Austin elabora un modello di funzionamento corretto o felice del performativo in cui l’enunciazione richiede la soddisfazione di una serie di condizioni o
di elementi procedurali, tra i quali sono incluse le presenze che organizzano il
momento puntuale e singolare dell’enunciazione stessa, come la presenza di determinati pensieri e sentimenti o l’assistenza dell’intenzione nell’io che emetteeffettua l’enunciato-azione del performativo10.
port’ or constate anything at all, are not ‘true or false’; and B. the uttering of the sentence is, or is a
part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something.
Su questo testo, con riferimento alla lettura di de Man, vedi in particolare R. Gasché, “Setzung
and Ubersetzung” in idem, The wild card of reading: on Paul de Man, Harvard University Press,
Cambridge Mass. and London 1998 pp.11-47, in cui l’autore inscrive la teoria degli speech acts
entro la tradizione idealistica del porre (Setzen) rilevando nel concetto di atto performativo la
struttura fichtiana dell’auto-posizione dell’io (Ich).
8 Htw, p.6
9 Htw, p.7: One technical term that comes nearest to what we need is perhaps ‘operative’, as it
is used strictly by layers in referring to that part, i.e. those clauses, of an instrument which serves
to effect the transaction (conveyance or what not) which is the main object, whereas the rest of the
document merely ‘recites’ the circumstances in which the transaction is to be effected.
10 Htw, p.15: Where, as often, the procedure is designed for use by persons having certain
thoughts or feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on the part of any
participant, then a person participating in and so invoking the procedure must in fact have those
thoughts or feelings. And the participants must intend so to conduct themselves, and further must
118
Mauro Senatore
Nella prima lezione Austin determina l’intenzionalità del performativo come
serietà e, dunque, come opposizione al gioco o alla letteratura, che, secondo la
determinazione tradizionale dell’essenza degli opposti, intaccano la pienezza o
la presenza dell’intenzione alla produzione dell’enunciato. In questo passaggio
Austin si propone di astrarre l’enunciato serio, o assistito dall’intenzione, dalla
determinazione morale del performativo come segno esteriore di un atto interiore o spirituale.
Surely the words must be spoken ‘seriously’ and so as to be taken ‘seriously’? This is, though vague, true enough in general – it is an important commonplace in discussing the purport of any utterance whatsoever. I must not be joking, for example, not writing a poem. But we are apt
to have a feeling that their being serious consists in their being uttered
as (merely) the outward and visible sign, for convenience or other record
or for information, of an inward and spiritual act: from which it is but
a short step to go on to believe or to assume without realizing that for
many purposes the outward utterance is a description, true or false, of the
occurrence of the inward performance.11
La determinazione dell’intenzionalità del performativo viene approfondita
nella seconda lezione in cui la presenza dell’intenzione è riconosciuta come una
condizione essenziale dell’enunciazione e, dunque, l’analisi del performativo è
circoscritta all’uso serio del linguaggio.
è proprio attraverso l’analisi dell’intenzionalità dell’intenzione e della sua
opposizione essenziale ad una serie di termini equivalenti al gioco e alla letteratura che Derrida sollecita il testo di Austin. La lettura elaborata in Sec preleva nella struttura del performativo l’articolazione essenziale della produzione
puntuale e intenzionale e di un certo dispositivo autoproduttivo e, dunque, individua nell’elemento meccanico, tradizionalmente opposto all’intenzionalità
dell’intenzione, la condizione costitutiva del performativo stesso.
La serie dei casi esclusi dall’analisi del performativo può essere generalizzata nel termine della citazione, che presuppone l’uso non-serio, non-ordinario e
parassitario del linguaggio e, tuttavia, è portatrice di un’infezione la cui possibilità è prescritta nella struttura di ogni enunciato.
actually so conduct themselves subsequently.
11 Htw, p.9
Macchine Performative
119
Secondly, as utterances our performances are also heir to certain other
kinds of ill which infect all utterances. And these likewise, though again
they might be brought into a more general account, we are deliberately
at present excluding. I mean, for example, the following: a performative
utterance will, for example, be in a peculiar way hollow or void if said by
an actor on the stage, or if introduced in a poem, or spoken in a soliloquy. This applies in a similar manner to any and every utterance – a seachange in special circumstances. Language in such circumstances is in
special ways – intelligibly – used not seriously, but in ways parasitic upon
its normal use – ways which fall under the doctrine of the etiolations of
language. All this we are excluding from consideration. Our performative
utterances, felicitous or not, are to be understood as issued in ordinary
circumstances.12
La possibilità della citazione, o la citabilità, è riconosciuta da Austin
come legge di struttura o predicato essenziale di tutti gli enunciati. Individuando la disponibilità alla ripetizione a venire o l’utilizzabilità dell’enunciato al di là o a prescindere dalla presenza dell’intenzione, la possibilità della citazione pertiene alla struttura stessa dell’enunciato, che si scinde da sé o
si duplica in un certo dispositivo macchinico. Nella struttura dell’enunciato
citabile, che si inscrive, dunque, entro il paradigma del marchio, si accordano paradossalmente i termini della produzione singolare e puntuale e della
prestazione di una macchina efficace a generare se stessa. La disponibilità
virtuale alla citazione costituisce la condizione irriducibile della produzione
di senso in genere, poiché determina l’enunciato nell’ordine della virtualità
o dell’autoproduttività illimitata.
Questa chiave di lettura consente a Derrida di ricondurre l’operazione di
espulsione proposta da Austin entro l’orizzonte della tradizione filosofica della
rimozione della scrittura come possibilità costitutiva, o come legge di struttura,
della produzione di senso.
Austin exclut donc, avec tout ce qu’il appelle le sea-change, le «non-sérieux», le «parasitage», l’«étiolement», le «non-ordinaire» (et avec toute
la théorie générale qui, en rendant compte, ne serait plus commandée
par ces oppositions), ce dont il reconnaît pourtant comme la possibilité
ouverte à toute énonciation. C’est aussi comme un «parasite» que l’écri12 Htw, pp.21-2
120
Mauro Senatore
ture a toujours été traitée par la tradition philosophique. Et le rapprochement n’a ici rien de hasardeux.13
A questo punto si può ritenere inefficace la proposta di Austin di astrarre il
concetto di performativo, e i suoi predicati di intenzionalità e serietà, dalla giurisdizione dell’etica o della morale. Essa si fonda sulla determinazione dell’intenzionalità dell’intenzione come pienezza o presenza a sé e, dunque, come
esclusione del termine opposto dell’assenza di intenzione o dell’automatismo,
necessariamente implicato dalla legge della citazione e dell’uso non-serio del
linguaggio. Poiché l’elemento rimosso in favore dell’intenzione piena e presente pertiene alla struttura stessa dell’enunciato performativo come marchio, o
come traccia citabile e identificabile di una produzione presente e cosciente, allora si può rilevare nell’espulsione praticata da Austin una determinazione del
performativo che ne rimuove la condizione generale nel nome dell’opposizione
etica, teleologica, o generalmente filosofica, dell’intenzione alla macchina.
Est-ce qu’en excluant la théorie générale de ce parasitage structurel,
Austin, qui prétend pourtant décrire les faits et les événements du langage ordinaire, ne nous fait pas passer pour l’ordinaire une détermination
théologique et éthique (univocité de l’énoncé – dont il reconnaît ailleurs
qu’elle reste un « idéal » philosophique, p.93 –, présence à soi d’un contexte total, transparence des intentions, présence du vouloir-dire à l’unicité absolument singulière d’un speech act, etc.)?14
Derrida mette a fuoco la struttura necessariamente scissa o duplice di una
forma-enunciato che è, per definizione, l’effetto di una produzione presente e
singolare e, ad un tempo, causa sui, poiché si presta alla citazione o alla ripetizione di sé come di un programma dato fin dall’origine. Questa forma è identificata con un modello virtualmente utilizzabile, o una citazione, che conserva
l’effetto o la traccia della produzione singolare e presente assicurandola all’ordine dell’autoproduzione meccanica non saturabile15.
Poiché l’essenza del performativo è determinata dalla singolarità e dalla presenza della sua produzione, l’analisi del concetto di performativo è necessariamente
Sec, p. 387
Sec, p.387
15 Sec, pp.388-9: Un énoncé performatif pourrait-il réussir si sa formulation ne répétait pas
un énoncé codé ou iterable, autrement dit si la formule que je prononce pour ouvrir une séance,
lancer un bateau ou un mariage n’était pas identifiable comme conforme à un modèle iterable, si
donc elle n’était pas identifiable en quelque sorte comme «citation».
13 14 Macchine Performative
121
intrecciata con l’elaborazione dello statuto e della logica dell’evento. Derrida invita
a pensare l’evento a partire dall’articolazione paradossale di produzione originale,
instaurazione, istituzione, ecc. e produzione meccanica o tecnica, che costituisce
e, ad un tempo, duplica la struttura esemplare del performativo.
Il faut d’abord s’entendre ici sur ce qu’il en est du «se produire» ou
de l’événementialité d’un événement qui suppose dans son surgissement
prétendument présent et singulier l’intervention d’un énoncé qui en luimême ne peut être que de structure répétitive ou citationnelle ou plutôt,
ces deux derniers mots prêtant à confusion, iterable. Je reviens donc à
ce point qui me parait fondamental et qui concerne maintenant le statut
de l’événement en général, de l’événement de parole ou par la parole, de
l’étrange logique qu’il suppose et qui reste souvent inaperçue.16
Perché sia possibile una produzione minima di senso e, dunque, un evento,
che lascia un effetto o una traccia identificabile a prescindere dalla condizione
presente e singolare della sua istituzione o produzione inaugurale, è necessario
che essa si costituisca come un dispositivo dotato del potere di autogenerarsi
illimitatamente. Dunque l’elemento meccanico dell’enunciato-marchio, che è
opposto ed espulso dalla produzione singolare e presente, costituisce la condizione di possibilità del performativo come dell’evento in genere.
Nel caso esemplare dell’enunciato la conseguenza più immediata di questo
dislocamento delle opposizioni filosofiche tradizionali investe lo statuto dell’intenzione come anima dell’enunciato.
Surtout on aura alors à faire à différents types de marques ou de chaines de marques iterables et non à une opposition entre deux énoncés citationnels d’une part, des énonces-événements et originaux d’autre part.
La première conséquence en sera la suivante: étant donné cette structure
d’itération, l’intention qui anime l’énonciation ne serais jamais de part en
part présente à elle-même et a son contenu. L’itération qui la structure a
priori introduit une déhiscence et une brisure essentielles.17
Poiché l’intenzionalità o l’essenza dell’intenzione è costituita dalla pienezza o
dalla presenza a sé dell’intenzione e dalla sua divisione assoluta dall’automatismo e
16 Sec, p.388. Vedi ibidem: Un énoncé performatif serait-il possible si une doublure citationnelle ne venait scinder, dissocier d’avec elle-même la singularité pure de l’événement?
17 Sec, p.389
122
Mauro Senatore
dalla produzione meccanica, l’intenzionalità dell’enunciato individua la presenza o
l’assistenza dell’io singolare e vivente alla sua istituzione originale. Tuttavia, se l’effetto o la traccia della produzione singolare e presente è necessariamente articolato
ad una forma citabile, che si situa dalla parte dell’utilizzabilità virtuale e, dunque,
dell’automatismo, allora la produzione di senso pienamente intenzionale, o assistita dall’intenzione, non solo si scinde da sé e si duplica nella prestazione meccanica
di una forma-enunciato autoproduttiva, ma è costituita o resa possibile da questa
scissione e da questa duplicazione irriducibili18.
La forma trascendentale della firma
La lettura derridiana del concetto di firma elaborato da Austin nella quinta
lezione di How to do things with words rileva la logica del dispositivo macchinico che sottende necessariamente al prodursi dell’evento o della produzione
singolare e presente. Conservando, per definizione, l’effetto o la traccia della
produzione singolare e presente in un marchio o in una struttura virtualmente
leggibile e identificabile, la firma costituisce la forma più strettamente avvinta
alla singolarità e alla presenza della propria instaurazione originale, nella quale, pure, è già implicato l’elemento della produzione meccanica19.
L’elaborazione del concetto di firma in Austin è inquadrata entro la determinazione della forma verbale dell’indicativo presente attivo alla prima persona
singolare come la struttura essenziale dell’enunciato performativo.
Il rapporto privilegiato di questa forma al performativo è giustificato dalla determinazione del performativo come specie di enunciato esemplare della
produzione singolare e presente. Poiché quella forma verbale è individuata dal
rinvio o dal vincolo alla presenza o all’assistenza di un io singolare alla produzione dell’enunciato, essa costituisce necessariamente l’effetto o la traccia di un
enunciato performativo.
We said that the idea of a performative utterance was that it was to
be (or to be excluded as a part of) the performance of an action. Actions
can only be performed by persons, and obviously in our cases the utterer
18 Sulla struttura della vita tecnica vedi il testo di Derrida citato e la lettura relativa in
Vitale, pp.86-7.
19 Cfr. Sec p.390: Que toutes les difficultés rencontrées par Austin se croisent au point où il est
à la fois question de présence et d’écriture, j’en verrai un indice dans tel passage de la Cinquième
Conférence où surgit l’instance divisée du seing.
Macchine Performative
123
must be the performer: hence our justifiable feeling – which we wrongly
cast into purely grammatical mould – in favour of the ‘first person’, who
must come in, being mentioned or referred to; moreover, if the utterer
is acting, he must be doing something – hence our perhaps ill-expressed
favouring of the grammatical present and grammatical active of the verb.
There is something which is at the moment of uttering being done by the
person uttering.20
Austin determina la forma verbale alla prima persona dell’indicativo presente attivo come una struttura di rinvio all’origine del performativo, che è individuata dalla presenza e dall’intenzionalità della produzione. Essa conserva
l’effetto o la traccia dell’instaurazione originale in una struttura che, fin dall’origine, si scioglie dalla propria causa produttiva prestandosi alla ripetizione a
venire e all’autoproduzione meccanica. Dunque la struttura essenziale del performativo si determina come causa sui, cioè si presenta efficace a generare
indefinitamente se stessa, nonostante la determinazione tradizionale della produzione singolare e presente sulla quale insiste la performatività del performativo. Un certo dispositivo macchinico è al lavoro già a partire dall’istituzione o
dall’instaurazione originale del performativo, presupponendo la scissione da
sé e la duplicazione della traccia o dell’effetto lasciato da quella istituzione. La
firma individua, nella forma scritta dell’enunciato, l’equivalente della struttura
di rinvio all’origine, costituita dalla forma verbale alla prima persona dell’indicativo presente attivo. Tuttavia, essa è riconosciuta come un supplemento
necessario della presenza dell’io singolare e cosciente, cioè non può trovarsi in
forma implicita, come nel caso dell’enunciato orale, poiché la forma scritta presenta un vincolo meno forte alla propria origine o alla produzione della quale
è effetto o traccia.
Where there is not, in the verbal formula of the utterance, a reference
to the person doing the uttering, and so the acting, by means of the pronoun ‘I’ (or by his personal name), then in fact he will be ‘referred to’ in
one of two ways:
(a) In verbal utterances, by his being the person who does the uttering
– what we may call the utterance-origin which is used generally in any
system of verbal reference-co-ordinates.
(b) In written utterances (or ‘inscriptions), by his appending his signa20 Htw, p.60
124
Mauro Senatore
ture (this has to be done because, of course, written utterances are not
tethered to their origin in the way spoken ones are).21
A questo punto è possibile verificare gli effetti che una certa lettura produce sui concetti elaborati nel testo. La firma consiste, secondo Austin, in una
struttura di rinvio di secondo grado poiché si determina empiricamente in vista della lettura e dell’utilizzazione a venire, indipendentemente dalla presenza
dell’io singolare responsabile della sua produzione originale. Eppure, come ha
mostrato l’analisi della struttura essenziale del performativo, la firma, quale
marchio o forma virtualmente utilizzabile e, dunque, autoproduttiva, è già connessa alla produzione dell’enunciato orale e costituisce necessariamente la condizione generale di possibilità della produzione singolare e presente.
La lettura della forma della firma proposta da Derrida rimanda ancora alla scena della presentazione del marchio o dell’invenzione della scrittura dinanzi al re
Thamus, che rivendica la distinzione tra l’approvazione della tecnica inventata da
parte dell’autorità e il riconoscimento del suo carattere performante22.
Derrida rileva l’originalità enigmatica della forma della firma nell’articolazione irriducibile dei termini dell’evento e del dispositivo autoproduttivo, considerati nella loro purezza, o nel loro determinarsi l’uno a partire dall’opposizione e dall’esclusione dell’altro.
Par définition, une signature écrite implique la non-présence actuelle
ou empirique du signataire. Mais, dira-t-on, elle marque aussi et retient
son avoir-été présent dans un maintenant passé, qui restera un maintenant futur, donc dans un maintenant en général, dans la forme transcendantale de la maintenance. Cette maintenance générale est en quelque
sorte inscrite, épinglée dans la ponctualité présente, toujours évidente et
toujours singulière, de la forme de signature. C’est là l’originalité énigmatique de tous les paraphes. Pour que le rattachement à la source se
produise, il faut donc que soit retenue la singularité absolue d’un événeHtw, pp.60-1
Cfr. Platone, Fedro, (ed.it.) Bur, Milano 2006 274e-275b: O Theut, sommo esperto di tecniche, altro è la capacità di concepire una tecnica, altro è giudicare il danno e il vantaggio che essa
arreca a chi la adopererà. Quello che tu, in qualità di padre delle lettere dell’alfabeto, ora dici per
affetto nei loro confronti, è il contrario di quello che esse sono in grado di fare. Sul nesso tra la logica dell’invenzione tecnicamente legittimata, o della macchina performante, e la pretesa alla
certificazione di legittimità garantita dal giudizio dell’autorità si rinvia all’analisi dei tre testi
sull’invenzione della macchina aritmetica di Pascal elaborata da Geoffrey Bennington nella
prima parte di G. Bennington, “Aberrations: de Man (and) the Machine” in idem, Legislations.
The politics of deconstruction, Verso, London New-York 1994 pp.137-51.
21 22 Macchine Performative
125
ment de signature et d’une forme de signature : la reproductibilité pure
d’un événement pur.23
La firma si costituisce come l’effetto o il prodotto di una singolarità assoluta,
che consiste nell’evento inaugurale di un’instaurazione presente. Essa funziona
come un marchio, cioè assicura all’ordine della lettura e del riconoscimento a
venire il vincolo all’origine o alla produzione presente. Ma allora la ritenzione
del presente presuppone la prestazione o la mediazione di una forma virtualmente utilizzabile, generale e trascendentale, cioè data a priori o fin dall’origine, che rappresenta l’effetto o il programma di una macchina indefinitamente
autoproduttiva. Questa forma della ritenzione è, per definizione, assolutamente
altra e sciolta da qualsiasi relazione di causa-effetto all’instaurazione originale
della firma.
Da questa lettura si può rilevare come nella forma della firma siano articolati gli estremi opposti della forma autoproduttiva, che è ad un tempo macchina
e programma, e dell’effetto singolare e vivente dell’instaurazione presente. Questa struttura di articolazione si determina nel modo del vincolo o della fissazione, nella misura in cui la produzione singolare e presente della firma è resa
possibile proprio mediante la scissione da sé e la duplicazione del suo effetto o
della sua traccia nel dispositivo macchinico, causa ed effetto di se stesso.
Poiché l’elemento della produzione meccanica è strutturalmente implicato nella produzione singolare e presente della firma, allora la determinazione
dell’essenza della firma come assoluta o rigorosa purezza, che esclude dunque
il suo opposto, tradisce un’operazione etica o teleologica, filosofica per eccellenza, secondo Derrida, di rimozione dell’articolazione paradossale degli opposti,
costitutiva della possibilità stessa della firma.
La forma trascendentale e autoproduttiva in cui si scinde da sé l’effetto o
la traccia di una produzione singolare e presente e che, dunque, costituisce
l’elemento di alterazione prescritto nella struttura di quell’effetto o di quella
traccia, è determinata da Derrida come stessità, o prodursi dello stesso: essa
presuppone una produzione tecnica, in linea di principio, non saturabile, in cui
macchina e programma coincidono24.
23 Sec, p.391. Vedi anche ibidem: Les effets de signature sont la chose la plus courante du
monde. Mais la condition de possibilité de ces effets est simultanément, encore une fois, la condition de leur impossibilité, de l’impossibilité de leur rigoureuse pureté.
24 Sec, p.392 : Pour fonctionner, c’est-à-dire pour être lisible, une signature doit avoir une
forme répétable, iterable, imitable; elle doit pouvoir se détacher de l’intention présente et singulière
de sa production. C’est sa mêmeté qui, altérant son identité et sa singularité, en divise le sceau.
J’ai déjà indique tout à l’heure le principe de cette analyse.
126
Mauro Senatore
La struttura paradossale dell’opera
A questo punto ci si propone di mettere a fuoco come il nesso tra la lettura
del concetto austiniano di performativo e l’analisi delle condizioni costitutive
dell’evento e della produzione di senso in genere è sviluppato da Derrida in Le
ruban de la machine à écrire. Limited Ink II (Rme), testo cronologicamente molto distante da Sec e, pure, esplicitamente connesso, già a partire dal titolo25.
La lettura del performativo è introdotta per elaborare un’altra versione
dell’aporia dell’evento prodotto per mezzo della macchina, o dell’implicazione
paradossale della produzione di senso e dell’autoproduzione meccanica.
L’articolazione tra il vincolo alla produzione singolare e presente e il dispositivo
macchinico autoproduttivo, che pertiene alla forma essenziale dell’enunciato performativo, tiene insieme come compatibili o indissociabili gli elementi dell’evento
e della macchina, che la tradizione filosofica determina come i concetti antinomici della singolarità non programmabile, non calcolabile e non ripetibile e della
ripetizione automatica di un programma calcolabile o dato a priori. L’ortodossia
austiniana è richiamata nell’elaborazione di questa struttura aporetica sotto forma
dell’opposizione tra i predicati performativo e performante.
Que serait cette aporie ? On peut dire d’une machine qu’elle est productive, active, performante. Mais jamais une machine en tant que telle,
si performante soit-elle, ne pourrait, en stricte orthodoxie austinienne des
actes de langage (speech acts) produire un événement de type performatif. La performativité ne se réduira jamais à la performance technique.
La performativité pure implique la présence d’un vivant, et d’un vivant
parlant une seule fois, en son nom, à la première personne. De façon à
la fois spontanée, intentionnelle, libre et irremplaçable. La performativité exclut donc, en principe, dans son moment propre, toute technicité
machinale. Elle est même le nom de cette exclusion intentionnelle. Cette
forclusion de la machine répond à l’intentionnalité même de l’intention.
Elle est l’intentionnalité. L’intentionnalité semble forclore la machine.
Si de la machinalité intervient dans un événement performatif c’est toujours comme un élément accidentel, extrinsèque et parasitaire, en vérité
pathologique, mutilant voire mortel.26
25 Per la storia del testo vedi J. Derrida, “Le ruban de la machine à écrire. Limited Ink II”
in idem, Papier machine, Editions Galilée, Paris 2001 p.33
26 Rme, p.37
Macchine Performative
127
Il predicato performativo si applica alla specie di enunciato che risulta, per
definizione, dalla produzione puntuale di un io singolare e cosciente e, dunque,
più di ogni altro, descrive lo statuto e la logica dell’evento. Il predicato performante pertiene all’ordine tecnico del prodursi automatico e illimitato dello
stesso. Questo ordine, individuato dalla forma virtualmente utilizzabile o citabile di ogni enunciato, è bandito dall’analisi di Austin in nome dell’uso serio o
ordinario del linguaggio, cioè assistito dalla presenza dell’intenzione. Dunque
la determinazione dell’essenza del performativo, considerato nella sua pienezza
o purezza, è necessariamente marcata dall’esclusione o espulsione del termine
opposto dell’elemento tecnico o performante.
Derrida riconduce questa opposizione di performativo e performante alla
determinazione dell’intenzionalità dell’intenzione, o dell’essenza o del proprio
dell’intenzione, poiché, come si è visto in Sec, l’intenzione costituisce l’anima
dell’enunciato performativo, lo avvince alla produzione singolare e vivente come
alla sua causa produttiva, la sua origine, suo padre. Il concetto di intenzionalità
come assoluta presenza a sé dell’intenzione ed esclusione dell’automatismo della macchina ripete il movimento filosofico per eccellenza della rimozione etica
o teleologica dell’implicazione essenziale tra produzione singolare e presente
e produzione meccanica o tecnica e, dunque, delle condizioni costitutive della
produzione di senso in genere.
L’articolazione irriducibile di performativo e performante è rilevata da Derrida nella struttura dell’opera, che si inscrive entro la serie del marchio, della
citazione, della firma ecc., per il rapporto di derivazione o filiazione che la lega
alla produzione di senso singolare e presente.
J’insiste dans ce séminaire sur une certaine irréductibilité de l’œuvre.
Héritage possible de ce qui est d’abord un événement, l’œuvre n’a d’avenir virtuel qu’à survivre à la signature et à se couper de son signataire
supposé responsable. Elle suppose ainsi qu’une logique de la machine
s’accorde, si invraisemblable que cela paraisse, avec une logique de l’événement.27
L’opera costituisce l’eredità lasciata dall’evento, effetto, traccia o figlio della
produzione presente di un io singolare e vivente. Perché funzioni come struttura di rinvio alla propria origine, cioè conservi il rinvio o il vincolo ad essa in
vista della lettura o dell’identificazione virtuali o a venire, come si rileva nella
27 Rme, p.38
128
Mauro Senatore
struttura esemplare della firma, è necessario che sia assolutamente sciolta dalla propria origine e sia disponibile alla ripetizione indipendentemente dalla
produzione originale e dall’assistenza dell’io singolare che ne è il responsabile.
Dunque la prestazione dell’opera come eredità o traccia virtualmente leggibile
e identificabile dell’evento presuppone un dispositivo macchinico dotato del
potere di generare se stesso. Questa struttura dell’opera è la condizione costitutiva dell’evento come produzione di senso in genere, poiché consente di
scioglierne la traccia dall’ordine della sua occorrenza originale, immediata e
contingente, e di costituirla nell’ordine dell’utilizzabilità virtuale e inesauribile.
Poiché in essa si accordano paradossalmente le logiche contrarie dell’evento e
della macchina, l’opera assume su di sè l’aporia dell’evento prodotto per mezzo
della macchina.
Derrida preleva nell’ultimo paragrafo della seconda Promenade di Rousseau
l’esempio dell’articolazione paradossale di performante e performativo che determina la struttura e la logica dell’opera. Il testo di Rousseau segna il passaggio dal modello agostiniano, in cui la confessione rivolta ad un dio onnisciente
serve a chiedere perdono per la colpa confessata, ad un genere di confessione
che assolve allo scopo di giustificare o discolpare e di proclamare l’innocenza
del suo firmatario28.
Derrida rileva nella fede nell’ordine e nella giustizia divina una macchinazione di Rousseau, cioè l’instaurazione dell’opera della giustificazione, l’invenzione
di una tecnica o di una macchina scusante29. Il testo di Rousseau è ricondotto
alla scena paradigmatica dell’installazione del marchio come produzione singolare e presente di una macchina efficace a generare indefinitamente se stessa.
28 Per il testo di Rousseau, vedi J. J. Rousseau, “Rêveries d’un promeneur solitaire”, in
idem, Ouevres Completes, Balibon, Paris 1826 vol.XIX pp.153-4: Je ne vais si loin que Saint
Augustin qui se fut consolé d’être damné si telle eut été la volonté de Dieu. Ma résignation vient
d’une source moins désintéressée, il est vrai, mais non moins pure et plus digne à mon gré de
l’Etre parfait que j’adore. Dieu est juste ; il veut que je souffre ; et il sait que je suis innocent. Voilà
le motif de ma confiance, mon cœur et ma raison me crient qu’elle ne me trompera pas. Laissons
donc faire les hommes et la destinée ; apprenons à souffrir sans murmure ; tout doit à la fin
rentrer dans l’ordre, et mon tour viendra tôt ou tard. I testi di riferimento per la lettura derridiana del performativo delle scuse e delle sue molteplici articolazioni sono J. Austin, “A Plea
for Excuses” in Proceedings of the Aristotelian Society, 1956-7 e P. de Man “Excuses” in idem,
Allegories of reading. Figural language in Rousseau, Nietzsche, Rilke and Proust, Yale University
Press, New Haven and London 1979 (AR). pp.278-301. In particolare, nella prima parte del
testo indicato sopra, Austin sviluppa la distinzione rilevante tra la giustificazione e le scuse
in relazione al concetto di responsabilità: In the one defence, briefly, we accept responsibility
but deny that it was bad; in the other, we admit that it was bad but don’t accept full, or even any,
responsibility.
29 Rme, p.51: Telle serait la grâce mais aussi la machine de Rousseau. La grâce en tant que
machine: mhcanh@, ruse, ingénieuse invention, machination ou contre-machination.
Macchine Performative
129
Questa lettura consente a Derrida di mettere a fuoco nella logica dell’opera la
convergenza paradossale della logica del performativo, costituito dalla giustificazione e dalle scuse, e di quella sottesa ad una certa macchina performante,
che pertiene al lavoro e alla struttura dell’opera stessa.
«Tôt ou tard», cette patience du virtuel étire le temps par-delà de la
mort. Elle promet la survie à l’œuvre, mais aussi par l’œuvre comme auto-justification et foi dans la rédemption – non seulement la justification
de moi-même mais des hommes et du Ciel, la justification de Dieu, la
théodicée de Dieu qui retrouvera son ordre et sa justice irrécusable. Cet
acte de foi, cette passion de foi vient sceller en quelque sorte le temps
virtuel de l’œuvre. L’œuvre opérera d’elle-même. L’œuvre accomplira son
œuvre d’œuvre par-delà et sans l’assistance vivante de on signataire, quel
que soit nécessaire, quel que soit le temps à venir; car le temps lui-même
ne compte plus dans la survie de ce «tôt ou tard». Peu importe le temps
que cela prendra, le temps est donné, […] il est donné gracieusement en
échange du travail de l’œuvre qui opère toute seule, quasi machinalement, virtuellement, et donc sans travail de l’auteur : comme si, contrairement à ce qu’on pense souvent, il y avait entre le grâce et la machine,
entre le cœur et l’automatisme de la marionnette, une invincible affinité ;
comme si elle marchait toute seule, la machine à excuser, comme machine à écrire et, du même coup, à innocenter.30
La determinazione temporale del prima o poi individua il predicato essenziale dell’ordine del virtuale in cui si collocano la fede nella giustizia divina
e, dunque, l’opera della giustificazione. Nell’orizzonte della virtualità l’opera
si determina come marchio o traccia riconoscibile del performativo originale,
come una forma che si presta alla lettura e all’identificazione future o virtuali,
autoproduttiva e, dunque, assolutamente sciolta da qualsiasi vincolo o rinvio
ad un’origine o una causa produttiva singolare e presente. L’opera è l’effetto o la
traccia della giustificazione, che, per definizione, sono determinati dai predicati
della singolarità e della presenza, e, ad un tempo, il risultato di una prestazione
tecnica o meccanica. Poiché all’opera si applicano i predicati strutturali del
distacco assoluto dall’origine e dell’automatismo autoproduttivo, essa descrive
una certa macchina da scrivere, un marchio, cioè implica la logica della produzione tecnica o meccanica che organizza la prestazione della scrittura come
30 Rme, pp.50-1
130
Mauro Senatore
condizione costitutiva della produzione di senso in genere. Dunque la struttura
dell’opera come macchina scusante connette elementi tradizionalmente determinati come opposti quali la grazia e il cuore, che presuppongono l’operazione
presente di un io singolare e cosciente, e la macchina o la marionetta, che alterano o pervertono l’assoluta presenza a sé dell’intenzione o della coscienza31.
Perdono automatico, perdono-fantasma
La struttura paradossale dell’opera costituisce la chiave per sollecitare lo
statuto del performativo, considerato nei casi esemplari del perdono o delle
scuse, per risalire alle sue terrificanti condizioni costitutive e, dunque, per mettere a fuoco il luogo del pensiero aporetico dell’evento prodotto per mezzo della
macchina.
Derrida elabora il nesso tra l’istituzione dell’evento e la produzione dell’opera a partire dall’analisi della struttura e della logica della coupure. Innanzitutto
l’opera è necessariamente implicata nell’istituzione di un evento come marchio
o traccia identificabile dell’operazione presente di un operatore singolare e vivente: essa si costituisce come struttura di rinvio al presente, già a partire dai
segni di una memoria finita, situandosi, dunque, nell’orizzonte della sopravvivenza alla sua origine presente e della virtualità dell’identificazione futura.
Nous cherchons ainsi à progresser dans cette recherche au sujet de ce
qui dans le pardon, l’excuse ou le parjure, se passe, se fait, advient, arrive
et donc de ce qui, comme événement, requiert non seulement une opération, un acte, une performance, une praxis, mais une œuvre, c’est-à-dire à la
fois le résultat et la trace laissée d’une opération supposée, une œuvre qui
survit à son opération et à son operateur supposées. Lui survivant, étant
destinée à cette sur-vie, à cet excès sur la vie présente l’œuvre comme trace
implique dès le départ la structure de cette sur-vie, c’est-à-dire ce qui coupe
l’œuvre de l’opération. Cette coupure lui assure une sorte d’indépendance
ou d’autonomie archivale et quasi machinale (je ne dis pas machinale, je
31 I concetti della grazia e della marionetta, connessi attraverso la lettura del testo di
Rousseau all’instaurazione della macchina scusante, costituiscono i termini chiave del saggio
di de Man sul teatro di marionette di Heinrich von Kleist. In particolare, si veda il testo di
Kleist riportato da de Man in P. de Man, “Aesthetic formalization: Kleist’s Uber das Marionettentheater” in idem, The rhetoric of Romanticism, Columbia University Press, New York 1984
pp.263-90, in cui il grado più puro della grazia è individuato nel corpo che è assolutamente
privo di coscienza o che la possiede all’infinita potenza, nella marionetta o in dio.
Macchine Performative
131
dis quasi machinale), une pouvoir de répétition, de répétabilité, d’iterabilité,
de substitution sérielle de soi à soi. Cette coupure n’est pas tant effectuée
par la machine (bien qu’elle puisse en effet couper et répéter la coupure à
son tour) qu’elle n’est la condition de la production d’une machine. La machine est coupée autant que coupante, au regard du présent vivant de la vie
ou du corps vivant. La machine est un effet de coupure autant qu’une cause
de coupure. Et c’est l’une des difficultés dans le maniement de ce concept
de machine, d’une machine, d’une machine qui ressemble structurellement,
toujours, par définition, à une causa sui. Et là où l’on dit causa sui, la figure
d’un dieu n’est pas loin.32
La coupure è la struttura che divide, scioglie, stacca l’opera dall’operazione, cioè dalla condizione singolare e vivente della sua produzione originale, e,
dunque, la consegna all’ordine della sopravvivenza in vista dell’identificazione
o della lettura futura. Essa, dunque, pertiene all’essenza stessa dell’opera che
si determina come traccia identificabile o leggibile, cioè conserva la traccia o il
vincolo alla propria origine vivente al di là o a prescindere dalla sua presenza.
La scena della coupure è sempre la scena della produzione o dell’instaurazione
del marchio e dei suoi equivalenti: come l’instaurazione o la produzione singolare e presente, la coupure ha per effetto un dispositivo quasi macchinico,
efficace a generarsi o a sostituire sé con se stesso indefinitamente. L’introduzione del quasi marca la difficoltà di pensare una macchina autogenerativa come
effetto o traccia dell’operazione puntuale di un operatore singolare e vivente.
Dunque l’analisi della coupure rileva entro la struttura stessa del distacco o
dello scioglimento essenziale dell’opera dall’operazione l’articolazione paradossale del vincolo all’origine singolare e presente e del potere macchinico di
autoprodursi. Il dispositivo performante presuppone la struttura della coupure
come condizione della propria produzione e, nello stesso tempo, produce il
distacco dell’opera stessa dalla sua origine vivente determinandosi, per definizione, come causa ed effetto di se stesso. La coupure, come struttura pertinente all’essenza dell’opera, comporta nell’opera stessa l’articolazione di termini
opposti e l’accordo di logiche contrarie. Questo accordo paradossale individua
la condizione costitutiva dell’opera e, dunque, dell’istituzione dell’evento come
produzione o instaurazione di un’opera.
Poiché l’opera funziona come traccia riconoscibile dell’istituzione dell’evento, a partire dalla ritenzione nella memoria finita, allora essa ne costituisce la
32 Rme, pp.111-2.
132
Mauro Senatore
condizione essenziale già nel modo della possibilità o del progetto, comunque
prima della sua realizzazione tecnica effettiva o mondana.
Elle [toute œuvre survivante] garde la mémoire du présent qui l’a instituée mais dans ce présent, il y avait déjà sinon le projet, du moins la possibilité essentielle de cette coupure à dessein de sur-vie, de cette coupure en vue
de laisser une trace, de cette coupure qui assure parfois la sur-vie même s’il
n’y a pas dessein de survie. […] Elle marquait, telle une cicatrice, le présent
vivant originaire de cette institution – comme si la machine, la quasi-machine opérait déjà, avant même d’être techniquement produite dans le monde,
si je puis dire, dans l’expérience vive du présent vivant.33
L’opera si annuncia come possibilità essenziale o necessaria prescritta fin
dal principio nell’istituzione dell’evento, comportando tutta la sua ambiguità
costitutiva, individuata dall’accordo di logiche contrarie, e prelevata nella struttura della coupure. Dunque, come il marchio e le strutture ad esso equivalenti,
l’opera costituisce la forma essenziale delle molteplici articolazioni di senso
che si determinano nello spazio dell’identificazione o della ripetizione future e
virtuali. Questo spazio sottende la logica della produzione meccanica, o dell’autoproduzione illimitata, a prescindere dalla prestazione effettiva o mondana di
un dispositivo performante.
A questo punto Derrida immette la logica doppia e paradossale dell’opera
entro la struttura del perdono e delle scuse verificando gli effetti che essa produce su una certa tradizione di valori che condiziona la determinazione filosofica di questi enunciati performativi.
Questi effetti sono prefigurati nel testo di Derrida come un’aporia terrificante. Determinandosi strutturalmente come la traccia virtualmente utilizzabile e,
dunque, citabile del performativo, l’opera introduce nella scena del perdono e
delle scuse il lavoro di un dispositivo quasi macchinico e autoproduttivo. Lavoro che scinde da sé o duplica l’opera come effetto della produzione presente
di un io singolare e vivente, o come eredità del performativo, nel termine contrario e irriducibile dell’elemento tecnico e performante. Dunque l’implicazione necessaria dell’opera nell’istituzione del perdono e delle scuse consegue un
effetto di dislocamento di una certa tradizione filosofica sulla quale insiste la
determinazione del performativo come produzione singolare e vivente marcata
dall’esclusione radicale dell’elemento performante.
33 Rme, p.112
Macchine Performative
133
Terrifiante aporie car cette nécessité fatale engendre automatiquement une situation dans la quelle le pardon et l’excuse sont à la fois
automatiques (ils ne peuvent pas ne pas avoir lieu, indépendamment
en quelque sorte des «sujets» supposés vivants qu’ils sont censés engager), et donc nuls et non avenus, car en contradiction avec ce que
nous pensons, héritiers que nous sommes, de ces valeurs abrahamiques ou non, de pardon et d’excuse : des pardons mécaniques ou des
excuses automatiques ne sauraient avoir valeur de pardon ou d’excuse. Ou, si vous préférez, l’un des effets redoutables de cette automaticité machinale, ce serait de réduire toute scène de pardon non seulement à un processus d’excuse mais à l’efficacité à la fois automatique
et nulle d’un «je m’excuse» a priori, je me disculpe et auto-justifie a
priori ou a posteriori, d’un a posteriori a priori programmé et où le «je»
lui-même serait le «je» de n’importe qui, selon la loi d’une tromperie
ou d’un vol dont nous avons parlé.34
L’effetto di dislocamento della tradizione si propaga sulla forma propria che
il performativo assume nell’ortodossia austiniana, il verbo alla prima persona
singolare dell’indicativo presente attivo. Il modello dell’enunciato, quale opera
che ritiene la traccia dell’operazione staccandola dalla sua condizione singolare
e presente e consegnandola alla virtualità del riconoscimento o della citazione,
individua una forma assolutamente altra, effetto o risultato di una prestazione
quasi automatica. Questa forma è determinata come a priori, o trascendentale,
poiché costituisce il programma prestabilito o dato fin dal principio di una certa produzione meccanica. Dunque il modello dell’enunciato connette nella sua
forma la singolarità e la presenza della propria origine o causa produttiva e la
generalità o l’universalità di una struttura capace di generare se stessa all’infinito. La legge di questa connessione, che regola in modo paradossale il prodursi
delle scuse o del perdono, o la loro essenza, è identificata con la legge del furto
o della simulazione di un io singolare che, come si vedrà in seguito, Derrida
riprende da un’analisi di de Man e inscrive entro la propria lettura delle condizioni costitutive del performativo.
La lettura del caso esemplare del perdono o delle scuse mostra come la neutralizzazione prodotta dall’articolazione di singolarità e generalità, o autoproduttività, nella struttura essenziale dell’opera non è solo l’effetto di una pro-
34 Rme, pp.112-3
134
Mauro Senatore
duzione singolare e presente ma, ad un tempo la sua condizione paradossale
e necessaria35. Questa neutralizzazione investe il performativo come evento o
produzione di senso, applicandovi il tratto essenziale del quasi. Essa implica
la virtualizzazione dell’evento, il suo dislocamento entro la struttura del fantasma, dello spettro, del simulacro, ecc. non solo perché l’evento è strutturalmente articolato al suo opposto, un dispositivo quasi automatico e autoproduttivo,
che ne altera o perverte l’assoluta purezza o pienezza, ma anche perché questa
articolazione rende possibile l’evento stesso.
Là même où l’automaticité est efficace et me disculpe a priori, elle me
menace, donc. Car elle me coupe de ma propre initiative, de ma propre
origine, de ma vie originaire, donc du présent de ma vie, mais aussi de
l’authenticité du pardon et de l’excuse, de leur sens même, et finalement
de l’événementialité. Du coup on a l’impression que, en raison de cette
quasi-automaticité ou de cette quasi-machinalité de l’œuvre survivante,
on n’a plus affaire qu’à des quasi-événements, à des quasi-fautes, à des
fantômes d’excuses ou à des silhouettes spectrales de pardons. Avant toute autre souffrance, ou toute autre passion possible, il y a la blessure,
à la fois infinie et insensible, anesthésiée, de cette neutralisation par le
comme si, par le comme si de ce quasi, par le risque sans limite de devenir le simulacre ou l’inconsistante virtualité – de tout.36
La virtualità costituisce l’ordine in cui si determina la struttura duplice e
divisa dell’opera e, ad un tempo, in cui è dislocato l’evento come produzione
singolare e presente scissa da sé nella produzione tecnica o meccanica. Dunque le strutture che si collocano in questo ordine, dall’opera al fantasma, sono
costituite dalla logica paradossale che annoda performativo e performante, singolare e trascendentale.
La possibilità originaria dello spergiuro
Nella lettura dell’aporia terrificante che la struttura essenziale dell’opera immette nella scena del performativo in genere Derrida connette la legge del furto
35 Rme, p.113 : Cette neutralisation autodestructrice, suicide et automatique, que produit et qui
produit en même temps la scène du pardon ou la scène apologétique, pourquoi serait elle terrifiante ?
36 Rme, pp.113-4
Macchine Performative
135
o della simulazione dell’io singolare, e della sua usurpazione da parte dell’io
universale, alla logica che organizza l’articolazione di singolarità e universalità
nella struttura stessa dell’opera. La fonte per l’elaborazione di questa legge è
riconosciuta nell’analisi di Contrat social di Rousseau proposta da de Man nel
saggio Promises. Derrida riprende questa analisi in un altro luogo del testo mettendo a fuoco i concetti della macchina, o dell’automatismo del testo, e dell’ingiustizia originaria, o dell’ingiustizia della giustizia.
Il concetto di macchina entra in gioco nell’analisi di de Man con la determinazione della grammaticalità del testo, cioè del suo costituirsi come un sistema
di relazioni che funziona in modo automatico o indipendente dalla sua significazione referenziale.
The system of relationships that generates the text and that functions independently of its referential meaning is its grammar. To the
extent that a text is grammatical, it is a logical code or a machine.
And there can be no agrammatical texts, as the most grammatical of
poets, Mallarmé, was the first to acknowledge. Any nongramatical
text will always be read as a deviation from an assumed grammatical
norm. But just as no text is conceivable without grammar, no grammar is conceivable without the suspension of referential meaning.37
La struttura grammaticale assicura al testo il funzionamento automatico,
cioè la ripetizione di un programma o di un codice prestabilito, generale o trascendentale, che implica la prestazione di una macchina. Questo automatismo
del testo prevede lo scioglimento da qualsiasi legame con il particolare e l’individuale, che si esprime nella sospensione della significazione referenziale.
De Man deduce gli effetti che questa determinazione essenziale del testo
comporta nella costituzione della legge, quale specie particolare di testo38. La
sua analisi consente di rilevare un’incompatibilità o contraddizione fondamentale tra l’automatismo grammaticale, che non tiene conto dell’applicabilità ad
entità o individui particolari, e il testo della legge che si determina propriamenP. de Man, “Promises (Social contrat)” in AR, pp.268-9
Vedi AR, p.269: Just as no law can ever be written unless one suspends any consideration
of applicability to a particular entity including, of course, oneself, grammatical logic can function
only if its referential consequences are disregarded. On the other hand, no law is a law unless it
also applies to particular individuals. It cannot be left hanging in the air, in the abstraction of its
generality. Only by thus referring it back to particular praxis can the justice of the law be tested,
exactly as the justesse of any statement can only be tested by referential verifiability, or by deviation from this verification?
37 38 136
Mauro Senatore
te nell’applicarsi ad individui particolari e, dunque, nel sospendere la propria
generalità astratta. Questa contraddizione investe, dunque, il concetto della
giustizia della legge che è garantita dalla possibilità della sua verificazione referenziale o del suo rinvio alla prassi particolare e che si offre come paradigma
della giustezza di un enunciato o di un testo in genere.
L’analisi di de Man perviene in questo modo all’elaborazione dei concetti
della giustizia ingiusta e del furto o della simulazione dell’io particolare, che ne
costituisce la struttura essenziale.
The preceding passage makes clear that the incompatibility between the elaboration of the law and its application (or justice) can only
be bridged by an act of deceit. “S’approprier en secret ce mot chacun”
is to steal from the text the very meaning to which, according to this
text, we are not entitled, the particular I which destroys its generality; hence the deceitful, covert gesture “en secret”, in the foolish hope
that the theft will go unnoticed. Justice is unjust; no wonder that the
language of justice is also the language of guilt and that, as we know
from the Confessions, we never lie much as when we want to do full
justice to ourselves, especially in self-accusation.39
Nel testo di de Man, il furto della parola chacun, che consente di scavalcare
o supplire l’incompatibilità fondamentale, è determinato come appropriazione
di qualcosa a cui non si ha diritto, appropriazione abusiva o indebita della significazione o del rinvio alla particolarità, sospesi dall’automatismo grammaticale del testo.
Derrida rileva nella logica del furto l’articolazione paradossale di singolarità
e generalità che costituisce la struttura del pronome personale io. Questa lettura del testo di de Man presuppone l’analisi della quinta lezione di How to do
thing with words proposta da Derrida in Sec, in cui si rileva nell’io generale e
trascendentale la condizione essenziale della forma propria del performativo o
dell’enunciato singolare e presente per eccellenza.
Ce vol n’est pas l’appropriation de n’importe quel mot. C’est la substitution absolue, c’est le vol du sujet, plus précisément du mot chacun, en
tant qu’il dit à la fois le «je», la singularité, et la généralité de tout «je».
39 AR, pp.269-70
Macchine Performative
137
Rien n’est en effet plus irréductiblement singulier que «je» et pourtant
plus universel, anonyme et substituable. Cette tromperie et ce vol consiste à s’approprier le mot chacun.
Il pronome personale costituisce la forma più propria o pura della singolarità poiché conserva il vincolo ad un’origine singolare e vivente, la traccia lasciata
dalla produzione presente di un io particolare. Nello stesso tempo, poiché la
possibilità dell’utilizzazione futura e, dunque, della citazione costituisce un’infezione che riguarda la produzione di senso in genere, dall’evento al linguaggio, alla scrittura, allora il pronome personale io individua una forma citabile,
sciolta dall’origine o dalla causa produttiva singolare e presente, e illimitatamente autoproduttiva. Per queste ragioni strutturali, è anche la forma più pura
e propria dell’universalità: essa esclude qualsiasi relazione ad un io singolare e
vivente collocandosi all’estremo opposto della forma più propria e pura della
singolarità.
L’io generale o trascendentale è irriducibilmente implicato nell’io singolare come effetto o struttura di rinvio di una produzione originale, che, pure, la
tradizione filosofica invita a pensare, nella sua purezza o proprietà, a partire
dall’esclusione di qualsiasi elemento di generalità. Dunque, ammettendo la possibilità di costituire la causa e l’effetto di una produzione meccanica, la singolarità stessa si determina necessariamente nell’ordine della virtualità, si inscrive
nella struttura del fantasma, o di uno dei suoi equivalenti. Il furto o l’appropriazione abusiva si configurano nella lettura proposta da Derrida come principio
strutturale o fondamento della logica paradossale che pertiene all’essenza o al
prodursi della singolarità40.
Nella parte finale del suo testo de Man connette l’analisi sulla legge e la giustizia alla struttura di Confessions di Rousseau individuando il grado estremo
di simulazione dell’io particolare, e dunque di ingiustizia del testo, nella forma
apologetica dell’autodenuncia. Poiché la confessione richiede la massima singolarità dell’enunciazione, cioè l’applicabilità più immediata o il vincolo più
forte all’entità particolare individuata dall’io cosciente e responsabile della confessione stessa, essa implica necessariamente il furto più grave, l’usurpazione
più clamorosa da parte di una struttura grammaticale, generale e automatica.
A partire da questo passaggio Derrida sviluppa le conseguenze ineludibili che la
legge del furto o della simulazione produce entro la struttura dell’enunciazione
40 Su questa strategia di lettura insiste anche la determinazione del furto come condizione
costitutiva della giustizia. Vedi Rme, p.101: Cette tromperie et ce vol, donc, seraient constitutifs
de la justice (à la fois sans référence et applicable, donc avec référence : sans et avec référence).
138
Mauro Senatore
singolare e vivente, rilevando nello spergiuro, fin dalla sua possibilità essenziale, la struttura necessaria dell’enunciazione stessa.
La substitution du «je» au «je» est aussi la racine du parjure : je (le je)
peux(t) toujours en (m)(s’) adressant à (un [toi]), chacun ou chacune à
chaque une, substituer l’autre même «je» à ce «je»-ci, et changer la destination. (Un) «je» peux(t) toujours changer l’adresse en secret au dernier
moment. Comme chaque «je» est un «je» (le même et tout autre ; tout autre est tout autre comme le même), comme tout autre est tout autre, (le)
je peux(t) trahir sans que rien n’y paraisse en substituant l’adresse de l’un
à l’adresse de l’autre, jusqu’au dernier moment – dans l’extase amoureuse
ou dans la mort, l’une ou l’autre, l’une et l’autre.41
La logica paradossale dell’articolazione di singolarità e universalità, rinvenuta attraverso la lettura del testo di de Man, introduce fin dal principio
nella struttura dell’enunciazione l’elemento di alterazione o perversione costituito dallo spergiuro. Questa possibilità è assicurata dalla scissione da sé
o dalla duplicazione strutturale della forma più pura o propria della singolarità nella forma più pura o propria della generalità. Dunque lo spergiuro individua la condizione costitutiva stessa dell’enunciazione come produzione singolare e presente che presuppone la struttura doppia e scissa
di opera e simili. La determinazione temporale del fino all’ultimo momento
configura la possibilità essenziale dello spergiuro come la struttura generale
dell’enunciazione, individuando quell’ordine della virtualità in cui si costituisce necessariamente l’evento dell’enunciazione. Solo la determinazione
tradizionale o teleologica, che Derrida identifica con il movimento filosofico
per eccellenza, può giustificare l’esclusione della possibilità essenziale dello
spergiuro dall’analisi dell’enunciazione e, dunque, la rimozione di quell’elemento che rende possibile ogni produzione singolare e presente.
41 Rme, p.102
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
139
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo:
un percorso jaspersiano
Memoria di Antonello Petrella
presentata dal socio corr. naz. Renata Viti Cavaliere
(seduta del 28 maggio 2009)
Abstract. In Jaspers’ philosophical work, we can find a theoretic way: from the nihilistic
results of the contemporary age (rule of technique and political totalitarianisms) to a
new humanism. Particularly, Jaspers talks about the conditions of a new humanism in a
lecture of 1949: Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus. Jaspers
thinks the traditional ontology reduces the transcendence of the being in an object, and
this process has his greatest expression in modern technique, where the man is only a
functional object in technical machinery. If we want to evade all this, it needs a new
humanism which combines two ways: the assimilation of western humanism and the
struggle for human independence for every future possibility.
All’interno dell’opera jaspersiana è possibile individuare un percorso teoretico che partendo dagli esiti nichilistici dell’età contemporanea (ossia dominio
della tecnica e totalitarismi politici) giunge alla posizione di un nuovo umanesimo. Le condizioni e le possibilità di quest’ultimo, sono tracciate da Jaspers,
in una conferenza del 1949 tenuta a Ginevra, intitolata, per l’appunto: Per un
nuovo umanesimo:condizioni e possibilità. Tale conferenza è particolarmente
indicativa per quanto riguarda il senso che il filosofo tedesco conferisce alla
parola “umanesimo”, in anni in cui il dibattito circa la questione dell’umano e
degli “umanismi” era quanto mai vivo. Il breve itinerario interpretativo, che qui
si vuole proporre, non intende seguire una progressione cronologica all’interno
della produzione filosofica del pensatore tedesco, bensì logica. È ben nota la
proposta jaspersiana di una periecontologia contrapposta all’ontologia tradizionale, che appare agli occhi del filosofo di Oldenburg come un vero e proprio
occultamento della costitutiva trascendenza dell’essere. Essa, infatti, secondo
140
Antonello Petrella
Jaspers, avrebbe ridotto l’essere come Umgreifende1 ad oggetto di una conoscenza oggettiva. Il filosofo tedesco dà una propria definizione molto chiara di
“ontologia” nel suo scritto Sulla verità: «Il sapere che nel tentativo di realizzare
una conoscenza scientifica dell’essere, procede alla sua articolazione con la derivazione (deduzione e costruzione) di tutti gli enti a partire da principi oggettivamente e adeguatamente considerati, prende il nome di ontologia».2Ma un
sapere che si pone come conoscenza “scientifica” dell’essere, s’immette nell’ottica di quella scissione soggetto-oggetto, che prevede sempre la fissazione di un
oggetto per la conoscenza di un intelletto.
Cioè l’essere nella sua indeterminatezza viene ridotto a un ente determinato
per la conoscenza di un soggetto. Tale conoscenza avviene nei termini, dunque, di un adeguamento degli oggetti del conoscere a principi “oggettivamente considerati” dall’intelletto conoscente. Sulla base di ciò, nello scritto Sulla
verità, Jaspers articola proprio un confronto tra ontologia e periecontologia
che si svolge attraverso undici punti3. Da tale confronto (che non può essere
qui analizzato nel suo intero svolgimento) risulta che l’ontologia costruirebbe
un edificio di enti, disinteressandosi dell’essere nella sua trascendenza e nella
sua manifestatività.4 Ma se è possibile stabilire un quadro delle determinazioni dell’essere, occorre farle derivare da un Ente oltre il quale non sia possibile
retrocedere e che sia “condizione di possibilità” di tutti gli altri enti e del loro
essere: «nell’ontologia il Primum ontologico, ossia il principio di tutto l’essere,
è oggettivato e tematizzato […].
Per l’ontologia tutti gli enti sono derivati dal Principio»,5 cosa questa che
determina una differenza metodologica essenziale, perché mentre nell’ontologia è il soggetto che pone la questione in termini oggettivi di deduzione e di
determinazione del principio da cui tutto deriva, interpretando e fissando la
questione attraverso le categorie proprie della sua coscienza in generale, nella
1 Così si esprime Jaspers in Von der Wahrheit del ’47 circa l’Umgreifende : «L’essere col
progressivo manifestarsi di tutti i fenomeni che ci vengono incontro, come tale indietreggia.
Questo essere che non è oggetto, che è sempre delimitato, né una totalità che si configuri come
orizzonte, che sempre limita, noi lo chiamiamo Umgreifende. L’Umgreifende si annuncia come
ciò che, comprendendo di volta in volta ogni orizzonte, trascende di continuo tutti gli orizzonti, senza configurarsi esso stesso come orizzonte limitante». (K. Jaspers, Sulla verità, a cura di
U. Galimberti, La Scuola, Brescia 1970, p. 27).
2 Ivi, p. 67.
3 Ivi, pp. 66-79.
4 «È l’ulteriorità dell’essere ciò che Jaspers intende salvaguardare con la sua critica all’ontologia: salvaguardare l’ulteriorità dell’essere significa in altre parole rispettarne la trascendenza, vigilare contrastando ogni tentativo di farne un oggetto tra gli altri» (F. Miano, Appropriazione e dialogo. La storia della filosofia in Karl Jaspers, Ler, Napoli 1999, p. 38).
5 K. Jaspers, Sulla verità, op. cit., p. 77.
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
141
periecontologia, «l’uomo deve partire da quel primum fenomenologico»6 che è
«il presente storico della nostra esperienza della realtà, delle nostre idee, del nostro amore».7 Solo a partire da qui è possibile «tener presente che l’essere non
è quella costruzione che abbiamo edificato col nostro sapere, ma la presenza
di ciò che appare qui e ora»8, che si svela negli enti, ma non si coglie mai come
ente esso stesso. Tuttavia, l’ontologia occulta un tale svelarsi-celarsi dell’essere,
attraverso il suo impianto categoriale, e lo sistema in una totalità di enti di cui
l’uomo è assolutamente “signore”.
Tralasciando gli aspetti di un tale occultamento già presenti in germe nella cultura classica prevalentemente come allontanamento da una concezione
periecontologica dell’essere, si può dire che è con l’intellettualismo teologico
medioevale che si ha la prima vera riduzione della trascendenza a ente oggettivo, attraverso l’utilizzo delle categorie proprie della logica formale (che sono
specifiche di quella che Jaspers definisce coscienza in generale). È assolutamente indicativo, in quest’ottica, quanto scrive Jaspers a proposito di Tommaso
d’Aquino nel suo lavoro su I grandi filosofi, in cui sostiene che «le prove di Dio
non esigono in Tommaso altro pensiero che quello compiuto dall’intelletto in
generale. In questo modo, egli non perviene alla trascendenza, ma solo ad un
ente oggettivo»:9 Il pensiero di Tommaso parte dall’intuizione sensibile, da cui
è possibile giungere a conclusioni: «Dalla finalità nel mondo si conclude al suo
fondamento: i fenomeni della natura, pur senza coscienza né sapere, agiscono
in vista di un fine, ma ciò non è possibile se non li governa un essere cosciente,
cioè Dio, come causa che pone dei fini».10
Nel momento in cui Tommaso pensa Dio, come “causa che pone dei fini”,
la Trascendenza, che in sé non può essere colta con le categorie dell’intelletto,
viene, invece, pensata e ridotta alla categoria di causalità. Tramite le categorie
finite, proprie dell’intelletto in generale, si arriva a una conoscenza di Dio, ovvero a un’entificazione della Trascendenza dell’essere, che come tale l’annulla.
Si ha, insomma, a che fare con un Ente supremo che rende ragione del perché
e del come dell’essere, ma attraverso un procedimento logico attuabile dall’intelletto umano e dalle sue categorie. Con l’intellettualismo medioevale, l’uomo,
nella sua soggettività e con le sue facoltà, comincia ad assumere un ruolo preminente tra gli enti, fino a poter conoscere l’Ente supremo, perché riconosciuto
6 U. Galimberti, Il tramonto dell’Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers, Feltrinelli,
Milano 2005, p. 242.
7 K. Jaspers, Sulla verità, op. cit., p. 77.
8 Ibidem.
9 K. Jaspers, I grandi filosofi, a cura di F. Costa, Longanesi, Milano 1973, p. 830.
10 Ibidem.
142
Antonello Petrella
come quell’Ente che è Causa di ogni cosa. A conclusione dell’epoca medioevale, «il mondo occidentale creò in Europa la scienza moderna e con essa, dopo
la fine del XVIII secolo l’era della tecnica, il primo avvenimento interamente
nuovo nella sfera spirituale e materiale dopo il periodo assiale».11 Jaspers, in
vari luoghi della sua produzione, si sofferma sulle caratteristiche proprie della
scienza moderna, cioè: metodo, certezza e validità universale; ma l’indagine
scientifica diventa metodica quando «un piano preliminare e anticipatore del
pensiero trova verificazione, conferma o smentita, nell’esperienza. La volontà
di raggiungere la certezza accresce l’esattezza del pensiero che anticipa i suoi
piani, e, quindi, si rivela in primo luogo come tendenza a servirsi di schemi e
procedimenti matematici, e a ridurre tutto a rapporti quantitativi».12
Ciò che caratterizza, allora, il metodo delle scienze moderne, è, innanzitutto,
la sua struttura anticipante, che è posta dal soggetto conoscente, il cui ruolo, in
questo contesto, diventa centrale. Ed è esattamente qui che incontriamo Cartesio come emblema dell’epoca moderna. Jaspers vi dedica un lavoro nel 1937 intitolato: Descartes und die Philosophie13 in cui appare evidente che per il filosofo
tedesco sebbene Cartesio abbia cercato di radicalizzare il dubbio, dubitando di
ogni cosa al fine di raggiungere la certezza, questi non avrebbe assolutamente
dubitato del genere di questa stessa certezza. In altri termini il suo “dubbio”
non è assolutamente radicale, perché presuppone come data una determinata
certezza, quella matematica, a cui riconosce un’universale validità. In realtà,
quindi, se si riconosce una validità universale ad una certezza, ecco che non c’è
spazio per alcun dubbio, che viene spazzato via dal grandioso progetto di una
mathesis universalis, che è “l’universalizzazione del pensiero matematico e l’assunzione del suo metodo come valido per la totalità del sapere”.
Assistiamo, dunque, a un occultamento del senso dell’essere, poiché per Jaspers, la filosofia di Cartesio non cerca il senso dell’essere, ma di un certo tipo
di essere, quello matematico, quello cioè che il pensiero umano ha pregiudizialmente anticipato. Solo nella possibilità di un pensiero che pensa attraverso
anticipazioni matematiche, è possibile giungere al pensiero dell’uomo come
quella certezza indubitabile a partire dalla quale si possono conoscere tutte le
cose con metodo deduttivo matematico. Infatti, fa notare Jaspers, come anche
11 K. Jaspers, Origine e senso della storia, a cura di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità,
Milano 1965, p. 111.
12 K. Jaspers, La mia filosofia, trad.it. R. De Rosa, Einaudi, Torino 1964, p. 112.
13 Cartesio e la filosofia, trad. it. parziale (pp. 43-48) La natura intima di Cartesio in La mia
filosofia, op. cit., e Jaspers: la scienza cartesiana come deriva teologica e come anticipazione
dell’ateismo moderno, in U. Galimberti, Il tramonto dell’ Occidente nella lettura di Heidegger e
Jaspers (pp. 336-343).
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
143
Dio, nel metodo cartesiano, sia servito solo come fondamento della verità del
pensiero umano, fino al raggiungimento di una ragione universale e assoluta,
fiduciosa in se stessa, al punto da ritenere Dio stesso “fin dall’inizio del tutto superfluo.” Pertanto, la trascendenza è eliminata dalla posizione di una coscienza
in generale. È questo l’esito della scienza moderna, per la quale tutti gli enti
sono oggetti per un soggetto e per la sua rappresentazione anticipatrice, e oltre
tale rapporto il nulla.
Abbiamo dunque visto come il metodo cartesiano, per Jaspers, sia alla base
del pensiero scientifico moderno, perché si caratterizza come quel pensiero che
cerca la certezza e la validità assoluta su cui poter poi fondare la conoscenza.
Ma vi è anche un altro aspetto, a ciò connesso, che agisce in Cartesio e nella
scienza moderna, ossia la volontà di potenza: «Nella passione per quella certezza che s’impone e si fa valere per sempre e per tutti, si sente come una volontà
di potenza tutta particolare. Questa volontà di potenza, come l’autentica attitudine scientifica che nasce per le cose, non può accontentarsi delle conoscenze
particolari, dei piccoli e minuti risultati dell’indagine, che pure hanno un valore
che non va mai perduto, come si accontenta chi rimane nel campo della scienza
e nell’attitudine dello scienziato che viene determinata dall’amore per le cose.
La volontà di potenza di un pensatore vuole proprio raggiungere la piena totalità delle conoscenze e ciò che ha valore in modo definitivo anche nei riguardi dei
principi che gli servono di base»14. Questa volontà di potenza, insomma, ricerca la totalità delle conoscenze, attraverso principi posti alla base della ricerca
stessa, i quali devono fornire una stabilità che consenta di anticipare gli oggetti
della conoscenza e di effettuarne il pieno controllo incondizionato.
Un tale dominio, che sarebbe implicito nell’uomo occidentale, nella sua “illimitata presunzione”, trova il suo compimento massimo nella tecnica moderna. È evidente che Jaspers non condanni la scienza moderna in quanto tale,
ma l’esito determinato da quella volontà di potenza che sfocia nella tecnica,
e che sollecita il pensiero come sapere. Eppure, Jaspers dice: «Dominio della
natura, capacità, utilità, “sapere è potere”, ecco le parole d’ordine da Bacone in
poi. Egli e Cartesio abbozzarono le linee essenziali di un futuro tecnico».15Tale
futuro tecnico assume connotati abbastanza inquietanti ed esiti imprevedibili,
perché Jaspers «è convinto che non si tratti soltanto di problemi di competenza
a livello tecnico ma soprattutto del problema che riguarda il destino dell’uomo,
considerato nella sua singolarità»16. Il paragrafo secondo del capitolo Presente e
K. Jaspers, La mia filosofia, op. cit., p. 46.
K. Jaspers, Origine e senso della storia, op. cit., p. 121.
16 G. Penzo, Il comprendere in Karl Jaspers e il problema dell’ermeneutica, Armando, Roma
14 15 144
Antonello Petrella
futuro di Origine e senso della storia, è indicativo in questo senso. In esso, l’era
della tecnica è vista come una svolta, un secondo periodo assiale che però non
ha nulla della spiritualità del primo, anzi, appare, piuttosto, come un’epoca di
discesa verso la povertà di spirito, sebbene di grandezza per quanto concerne la
produzione scientifica e tecnica. Jaspers, tuttavia, si pone il problema di chiarire
questa grandezza, perché se da un lato è comprensibile l’entusiasmo dello scopritore o dell’inventore, dall’altro li si vede entrambi «funzionari nella catena di
un processo creativo fondamentalmente anonimo, in cui un anello si combina
con l’altro e i partecipanti non agiscono come esseri umani, nella grandezza di
un’anima tutto abbracciante. Malgrado l’elevato livello d’ispirazione creativa, il
paziente, tenace lavoro, l’audacia delle ipotesi sperimentali, il quadro d’assieme
ci dà l’impressione che lo spirito stesso sia stato risucchiato nel processo tecnologico, che addirittura subordina a sé le scienze».17Qui Jaspers, in maniera
chiara, mostra come sia lo stesso processo tecnico a presentarsi come anonimo,
tale da ridurre ogni individuo a elemento di un’unica catena impersonale.
Un tale procedimento sembra paradossalmente subordinare a sé anche le
scienze e l’elevato livello conoscitivo degli scienziati stessi. Pertanto, si verifica
una “reazione” del procedimento tecnico sull’uomo, il quale mette in atto un
tale processo. Infatti, scrive Jaspers (ed è questo un passaggio essenziale): «La
tecnica è il procedimento con cui l’uomo scientifico domina la natura allo scopo di plasmare il suo esserci, liberandosi dal bisogno e dando all’ambiente circostante la forma che più lo attrae».18 Ma, specificato cosa è la tecnica, Jaspers
immediatamente aggiunge: «L’aspetto dato alla natura dalla tecnica umana e la
reazione del procedimento tecnico sull’uomo, cioè la maniera in cui il metodo
e l’organizzazione del lavoro e il modellamento dell’ambiente modificano lui
stesso, costituiscono una delle linee fondamentali della storia».19La reazione
della tecnica sull’uomo è, per Jaspers, dunque, una linea essenziale della storia
dell’umanità.
Ma cosa comporta, concretamente, questa reazione della tecnica? Lo dice
Jaspers sempre nello stesso paragrafo: «La tecnica ha radicalmente trasformato
l’esistenza quotidiana dell’uomo nel suo ambiente; ha costretto modo di lavoro
e società in nuovi binari: la produzione di massa, la metamorfosi dell’intera esistenza in un meccanismo tecnicamente perfetto, la metamorfosi del pianeta in
una sola grande fabbrica. Così è avvenuto e sta avvenendo il distacco dell’uomo
1985, p. 107.
17 K. Jaspers, Origine e senso della storia, op. cit., pp. 129-130.
18 Ivi, p. 130.
19 Ivi, pp. 130-131.
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
145
da ogni radice. Egli diventa abitatore della terra senza patria. Perde la continuità della tradizione. Lo spirito si riduce all’apprendimento di nozioni e all’addestramento a funzioni utili».20Ecco, insomma, come il mondo intero venga
ridotto a fabbrica, dove le uniche categorie che possono effettivamente avere un
senso sono produzione efficiente e utilità. In quest’ambito, allora, è ovvio che
l’uomo, rompendo definitivamente col traditum storico-culturale del passato,
sia reso “senza patria”, chiuso in una realtà empirica che lo vuole recipiente
da riempire con nozioni e addestramenti atti a funzioni che vengono stabilite
come utili. Ma che ne è dell’individuo? Cioè l’uomo che mette in atto questo
processo, nelle singole individualità ne rimane sopraffatto perché lo vive come
qualcosa che, ormai, gli accade come un evento; egli è rassegnato a diventare
elemento funzionale e spersonalizzato della macchina, perde di vista l’orizzonte del suo passato e del suo futuro tutto compresso in un presente angusto,
si sente barattabile e utilizzabile per qualsiasi scopo che gli venga imposto.
Negato come esistenza possibile, quindi nella sua libertà e nella sua storicità,
l’uomo è reso elemento impersonale sostituibile, al punto che la sua unicità si
disperde in quello che Jaspers chiama il dominio della massa che accompagna
il dominio della tecnica.
Attraverso la riduzione dell’uomo a pura funzione di un meccanismo, di
un apparato, l’esserci “viene spogliato della sua particolarità storica”e, quindi,
come osserva Giuseppe Cantillo, «vive in un’alterata coscienza del tempo: contratto nel presente, senza memoria e perciò anche senza prospettiva e progetti
aperti al futuro».21 Insomma, attraverso il dominio della tecnica e della massa
assistiamo a quell’assolutizzazione del progetto scientifico-tecnologico che, posto dall’uomo occidentale a partire dai primordi della scienza moderna, finisce
per inghiottire l’uomo e nullificarlo come esistenza. Ecco, dunque, svelato l’esito nichilistico del pensiero occidentale, il quale, nel momento in cui, attraverso
l’ontologia classica, si è separato da una concezione dell’essere come Umgreifende, che salvava e tutelava sempre la costitutiva Trascendenza dell’essere, si
è trovato dapprima a nullificare l’essere riducendolo ad ente oggettivo e determinato e successivamente ha visto l’uomo stesso, fautore di un tale processo,
ridotto a mero “ingranaggio” di un’epoca in cui, dominando esclusivamente la
funzionalità tecnica, vi è la completa mancanza di senso e significato.
Posta la conoscenza scientifica e tecnica come conoscenza totale: «si rende
possibile una pianificazione totale, in cui l’uomo diventa per l’uomo un mate-
20 21 Ivi, p. 131
G. Cantillo, Introduzione a Jaspers, Laterza, Bari-Roma 2001, p. 115.
146
Antonello Petrella
riale conformabile e trasformabile secondo i propri scopi».22A causa della rigidità e della fissità della pianificazione totale in cui viene situata l’esistenza del
singolo individuo, quest’ultimo si trova nell’impossibilità di de-situarsi, ossia di
compiere quella decisione esistenziale che gli consente di passare dalla mera
chiusura dell’esserci empirico alla libera esistenza possibile. Non è un caso che
Jaspers definisca il totalitarismo (fenomeno in qualche modo connesso alla pianificazione tecnica) in questi termini: «Non intendo il problema della dittatura,
del marxismo, della teoria razziale, ma la struttura terroristica del sistema che
distrugge ogni libertà e ogni dignità umana».23
Ed è proprio la dignità quella nozione fondamentale su cui si regge la concezione dell’uomo di Jaspers esattamente in linea, in questo, con tutta quanta
quella tradizione culturale e di pensiero che va sotto il nome di “umanesimo”.
Insomma, anche il nuovo umanesimo di cui parla Jaspers nella sua conferenza
del ’49 non può assolutamente prescindere da tale nozione, né prende congedo
dalla tradizione umanistica anzi da essa emerge e in essa trova nutrimento.
Già dall’inizio della sua conferenza Jaspers riconosce, come uno dei possibili sensi che si possono attribuire alla parola “umanesimo”, «l’umanità come
riconoscimento della dignità umana in ciascuno»24 e subito problematizza
una tale acquisizione domandandosi se l’umanesimo colga «una precisa realtà
dell’uomo, oppure l’indefinita possibilità di ciò che nell’essere uomo non è mai
attingibile».25
È qui che si pone l’antitesi decisiva, ossia se l’uomo venga ridotto a mero
oggetto di un sapere ad esso relativo che tenti di racchiudere in sé ogni determinazione dell’umano, o se l’uomo venga inteso a partire proprio dalla sua costitutiva irriducibilità a un oggetto fissato una volta per tutte, quindi dalla sua
libertà e dal suo impulso a trascendersi. Ma nel momento in cui accade ciò, cioè
«se rinserro l’uomo in ciò che può essere saputo, dispongo di lui secondo i miei
progetti, pretendo presuntuosamente di conoscerlo totalmente, oppure opprimendolo in modo disumano».26 Ridotto a mero oggetto di un progetto di cui si
può disporre incondizionatamente, l’umanità e la dignità del singolo, irripetibile, uomo vanno in fumo ancor prima che egli stesso venga ridotto in cenere in
22 K. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla Rivelazione, a cura di F. Costa, Longanesi,
Milano 1970, p. 17.
23 K. Jaspers, La bomba atomica e il destino dell’uomo, trad. it. di L. Quattrocchi, Il Saggiatore, Milano 1960, p. 14.
24 K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, trad. it. R. Celada Ballanti,
in A.a.V.v. Etica e destino, a cura di D. Venturelli, il Melangolo, Genova 1997, p. 13.
25 Ibidem.
26 Ivi, p. 16.
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
147
un campo di concentramento o per tramite di una bomba atomica. Invece, solo
riconoscendo l’uomo nella sua libertà, lo colgo nella sua dignità, solo sapendo
che l’uomo è sempre qualcosa di più rispetto a ciò che di esso posso conoscere, prendo coscienza del suo ineliminabile impulso a trascendersi nelle infinite
strade della sua libertà, rompendo ogni tipo di fissazione in un determinismo
naturale cui, invece, sono sottoposte tutte le altre realtà mondane: «Sia come
esserci conoscibile sul piano della ricerca scientifica, sia come libertà, l’uomo
è un essere finito».
Ma libertà e trascendenza fanno della finitudine umana, rispetto alle altre
realtà mondane, qualcosa di unico: l’uomo si trova determinato dal suo concreto ambiente, dal suo popolo, dalla sua umanità, dalla sua terrestrità, dall’universo. Mentre è consapevole della propria finitudine, egli partecipa, all’interno di essa, dell’infinito. Così l’uomo, nella sua finitudine, in qualche maniera,
può trascendere la sua finitudine riempiendola all’infinito di contenuti sempre
nuovi».27 Questa libertà, che si basa, quindi, su questo rapporto tra finito e infinito, trova una sua lezione magistrale nell’esperienza della tradizione umanistica e in particolare in uno dei suoi più intensi manifesti, ossia l’Oratio de hominis dignitate del 1485-1486 di Giovanni Pico della Mirandola di cui non a caso
Jaspers riporta una parte saliente in una sua lezione del 1947 tenuta a Basilea:
«Pico della Mirandola, nella gioia del Rinascimento ancora cristiano, ritrasse
l’uomo così come Dio l’aveva idealmente concepito quando lo mise al mondo al
termine della creazione. Dio gli disse: Io non ti assegno alcun soggiorno determinato, né alcuna eredità particolare.
Tutti gli altri esseri della creazione li ho sottomessi a leggi precise. Tu solo
non sei costretto in alcun luogo, ma puoi scegliere d’essere ciò che decidi e vuoi.
Seguendo la tua volontà e il tuo onore, devi essere artefice e scultore di te stesso, formandoti in base alla tua scelta. Gli animali possiedono dalla nascita tutto
ciò che possederanno in seguito, mentre nell’uomo il padre ripone solo il seme
di tutto l’agire successivo e il germe della condotta».28 Jaspers fa suo, insomma,
uno dei precetti essenziali dell’Umanesimo tradizionale, ossia quella centralità
dell’uomo che lungi dall’essere una mera situazione di privilegio, è invece quella centralità a partire dalla quale l’uomo esercita il suo giudizio, la sua libertà,
la sua scelta. Una concezione del genere ovviamente interpreta anche l’avvenire
dell’uomo non come un evento che può essere calcolato e previsto, in quanto
processo naturale, ma sempre a partire dall’imponderabile spontaneità dell’uoIvi, p. 17-18.
K. Jaspers, La fede filosofica, a cura di U. Galimberti, Raffaello Cortina, Milano 2005,
p. 110.
27 28 148
Antonello Petrella
mo (anche l’illustre amica di Jaspers, Hannah Arendt, si esprimeva così: «Il fatto che l’uomo sia capace di azione significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile».29). Ma è
imponderabile solo se viene salvaguardato il rapporto costitutivo dell’uomo con
la trascendenza, ossia se viene salvaguardato lo spazio infinito delle sue possibilità. Tra i fattori che oggi determinano l’uomo attuale Jaspers, però, non può
non considerare innanzitutto la tecnica (insieme alla politica e alla decadenza
in Occidente di un vincolo comune) che inevitabilmente un tale spazio riduce.
Nell’età della tecnica, Jaspers vede «un’organizzazione del lavoro innaturale,
se comparata al lavoro artigianale, all’economia agraria o alle antiche professioni permeate di umanesimo».30 Se mettiamo a confronto questa espressione
con quella successiva della conferenza jaspersiana secondo la quale la cogente
monotonia caratterizzerebbe il lavoro nell’età della tecnica, rendendo l’uomo
mero ingranaggio sempre sostituibile, allora ci rendiamo conto che, in opposizione a ciò, quel che rende un lavoro impregnato di umanesimo è proprio
l’unicità del singolo lavoro. Si tratta dell’insostituibilità di ciò che l’artigiano è
capace d’imprimere nell’opera finita del suo lavoro. Il lavoro di un artigiano si
caratterizza per l’unicità insostituibile del pezzo creato. Egli non realizza mai
una sedia o un mobile uguale in tutto e per tutto ad altre sedie o mobili da lui
stesso realizzati.
Ogni pezzo è unico, rispetto agli altri, poiché in esso confluisce quel determinato momento di creazione, quel determinato impiego di energie e sforzo,
la riuscita minore o maggiore di una determinata operazione (come l’incisione
del legno, la piallatura..) al punto che se una di tali operazioni viene eseguita
erroneamente si è costretti spesso a utilizzare un nuovo materiale. Oltre all’unicità dell’oggetto creato, vi è l’unicità dell’artigiano che l’ha fabbricato, perché
quella determinata sedia di legno è così e presenta quelle caratteristiche proprio perché è stata fatta da quell’artigiano, in quel momento della sua vita, e
in quanto appartenente a quella specifica famiglia. Non è un caso, infatti, che
durante il ‘400 e in buona parte del ‘500, nelle botteghe degli artigiani il lavoro
veniva trasmesso di padre in figlio al punto che vennero fuori famiglie che si
caratterizzavano per la realizzazione di un particolare tipo di prodotto (cosa
questa ripresa nelle botteghe d’arte, si pensi alla famiglia Della Robbia che si
occupava esclusivamente di terracotte invetriate policrome). Insomma, nell’oggetto creato era possibile ritrovare un rimando costante non solo all’uomo che
29 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, trad. it. S. Finzi, Bompiani, Milano 2001,
p. 128.
30 K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, op. cit., p.18..
Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
149
l’aveva realizzato ma anche alla sua storia, alla sua appartenenza familiare. In
quel momento di realizzazione l’uomo era pienamente in sé al punto da riuscire a trasmettere all’oggetto del suo lavoro perfino la sua storia. Nell’età della
tecnica, invece, l’uomo è ridotto a ingranaggio di una macchina, è costretto ad
un oblio di sé e il suo lavoro non influisce minimamente sulle caratteristiche
essenziali dei prodotti generati da una catena seriale di montaggio. In questo
tipo di lavoro l’umanesimo è assente e la dignità dell’uomo viene occultata. Pertanto, un nuovo umanesimo che abbia consapevolezza della condizione in cui
si trova l’uomo attuale, non può prescindere, come sua stessa condizione, da un
«infinito affaticarsi intorno all’assimilazione e al controllo della tecnica, campo
illimitato dell’umana lotta»;31 in qualche modo si tratta di riuscire sempre a far
emergere l’uomo nella sua insostituibile irripetibilità, anziché farlo «correre
meccanicamente sui binari delle funzioni».32
Tuttavia l’uomo, per Jaspers, non vive solo le conseguenze del dominio della
tecnica, ma anche la connessione che oggi la tecnica ha con la politica. Come egli
dice nella conferenza del ’49 sull’umanesimo: «terrore, torture, deportazioni, stermini, tutto ciò, certo è esistito sin dagli Assiri e dai Mongoli, ma senza assumere le
dimensioni offerte dalle odierne possibilità tecniche».33 Emblema di ciò fu senz’altro il regime nazista, con il quale furono messe in questione delle acquisizioni che
nel tempo si era pensato di possedere circa i diritti appartenenti all’uomo per natura.34 Ciò, in particolare, perché coloro che erano stati resi vittime del regime erano
stati anzitutto spogliati del loro «orizzonte di un progetto di vita essendo stati resi
preda di apparati politici, che si presentavano formati da funzionari di una burocrazia spietata, per la quale l’uomo coincideva con una carta che, come strumento
d’identificazione, legittimazione, condanna, classificazione, gli consentiva l’esercizio dei suoi diritti, lo limitava, oppure lo annientava […] Se si voleva sapere chi comandava, non si giungeva a nessuna risposta. Sembrava che non vi fosse nessuno a
cui attribuire la responsabilità».35 L’uomo, insomma, spogliato della sua progettualità e quindi del suo rapporto con la Trascendenza, è ridotto a oggetto nelle mani
di un apparato politico all’interno del quale è impossibile riuscire ad attribuire a
Ivi, p. 20.
Ibidem.
33 Ibidem.
34 «Tutte le mostruosità che l’uomo può commettere, le più grandi follie di persone dotate
d’intelligenza, tutte le possibili infedeltà di cittadini apparentemente perbene, le sbadataggini,
tutta la miope ed egoistica passività della folla: tutto ciò divenne così largamente realtà che fu
necessario modificare le nozioni acquisite sulla natura dell’uomo. Insomma, cose sulle quali
prima non si era nemmeno riflettuto, ora erano non solo possibili, ma reali.» (K. Jaspers, Autobiografia filosofica, trad. it. E. Pocar, Morano, Napoli 1969, p.107-108.)
35 K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, op. cit., p. 21.
31 32 150
Antonello Petrella
qualcuno la responsabilità di ciò che si è costretti a subire. Pertanto, il passaggio è
immediato: dall’insostituibile particolarità e unicità del singolo individuo alla sua
riduzione a una “carta” che ne consente il riconoscimento, l’utilizzo e l’annientamento, attraverso criteri di funzionalità ed efficienza. Basta ricordare le inquietanti
risposte di Franz Stangl direttore generale del campo di sterminio di Treblinka alle
domande della giornalista Gitta Sereny, in particolare il passaggio in cui Stangl alla
domanda: «Lei non poteva cambiare tutto questo? Nella sua posizione, non poteva
far cessare quelle nudità, quelle frustrate, quegli orrori dei recinti da bestiame?»
risponde: «No, no, no…Il lavoro di uccidere con il gas e bruciare cinque e in alcuni
campi fino a ventimila persone in ventiquattro ore esige il massimo di efficienza.
Nessun gesto inutile, nessun attrito, niente complicazioni, niente accumulo. Arrivavano e tempo due ore erano già morti. Questo era il sistema. Funzionava. E dal
momento che funzionava era irreversibile».36 Per Jaspers, dunque, oggi non è più
possibile essere indifferenti verso la politica e denuncia l’assurdità di ogni pretesa
di un nuovo umanesimo che eluda la questione. Dice, infatti: «L’umanesimo non
potrà più restarsene in disparte. Esso si vede coinvolto nella vicenda politica e,
innanzitutto, in questa ineludibile alternativa: libertà dello spirito che lotta apertamente o pianificazione spirituale. L’umanesimo vive soltanto nel primo caso mentre è perduto nel secondo».37
A partire da ciò, capiamo il monito di Jaspers che sostiene che un umanesimo vitale deve allearsi con forze che vogliono promuovere il destino, le possibilità e la libertà per tutti nella consapevolezza che la libertà non è mai reale
come libertà del singolo, perché ciascun singolo è libero se e solo se anche gli
altri lo sono. Se, insomma, la politica è una prassi orientata dalla forza, è anche
vero che «essere uomo implica l’autolimitazione della forza attraverso la legge,
il diritto, il contratto, e dove la forza non ammette alcuna limitazione, non resta che opporvisi mediante l’impiego altrettanto incondizionato delle proprie
forze».38 Lungi dall’essere un guerrafondaio, Jaspers delinea quello che è il vero
problema destinale dell’umanità: «Combattere contro i draghi senza diventarlo
noi stessi e senza perdere la forza di dominarli»39. Non ci si vuole qui soffermare sugli scritti politici di Jaspers e sulle riflessioni relative alla colpa della Germania, ma è interessante notare, ai fini del nostro discorso, un passaggio della
conferenza del ‘49 fin ora presa in esame in cui Jaspers, evidenziando la connessione della politica con la “passione per il potere”, ossia una vera e propria
G. Sereny, In quelle tenebre, trad. it. A. Bianchi, Adelphi, Milano 1994, p. 271-272.
K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, op. cit., p. 21..
38 Ibidem.
39 Ibidem.
36 37 Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
151
volontà di potenza che si avvale di specifici strumenti e forze esaltatrici, oppone ad essa un «umanesimo capace di essere sobrio»,40 che sia, dunque, lontano
dal proclamare la fede nel raggiungimento di un periodo in cui possa emergere
l’uomo nuovo in una condizione libera e giusta (Jaspers critica apertamente le
concezioni marxiste e l’idea di una dittatura del proletariato capace di creare
una società senza classi). Di contro ad una tale posizione Jaspers è molto chiaro sostenendo che «nessuna organizzazione del mondo che si presenti come
giusta e definitiva può apparirci, perché non esiste. Occorre trovare la via per
la quale, sempre in situazioni nuove e diverse, libertà e ordine si concilino, affinché arbitrio e anarchia siano limitati».41 Insomma, Jaspers è perfettamente
consapevole che ogni progetto politico che abbia come obiettivo di imporre un
preciso ordinamento del mondo non può prescindere dall’utilizzo incondizionato della forza per violentare il divenire degli eventi storici annientando ogni
forza che si oppone alla realizzazione del progetto nella realtà.
Ciò finisce per giustificare «ogni belluinità e ferocia, ogni odio e il trionfo
della crudeltà».42 Perciò, come abbiamo visto, a questa pianificazione spirituale
Jaspers contrappone la libertà dello spirito quale ineludibile presupposto di un
umanesimo attuale che tenga conto di tutto questo e l’irrinunciabile e incessante ricerca della libertà per tutti in ogni situazione storica nella sua particolarità,
attraverso il dialogo e la comunicazione di tutte quelle potenze, che lottano e
lavorano per la pratica quotidiana della libertà, del rispetto e dell’assunzione
di responsabilità. Ma ciò non può non partire dalle singole esistenze nella loro
costitutiva apertura, al punto che Jaspers ne La questione della colpa del ’46
scrive: «La Germania può ritrovare se stessa soltanto se noi tedeschi riusciamo a trovare il modo di rimetterci veramente in comunicazione gli uni con gli
altri».43 Affinché insomma l’umanesimo futuro possa avere un senso, esso deve
rivolgersi a «ogni singolo, perché ogni uomo è un’anima, non un atomo, e solo
in quanto tale è membro umanamente efficace della comunità».44 Solo se in relazione agli altri, l’uomo può avvertire il senso della responsabilità politica delle
proprie azioni, per cui ne deduciamo che ogni apparato tendente a ridurre l’uomo ad atomo, a cosa, rende impossibile ogni forma di umanesimo, ogni forma
di comunità politica in cui ciascun individuo sia libero. Ora è interessante notare come Jaspers, avviandosi alla conclusione della conferenza del ’49, delinei
Ivi, p. 22.
Ibidem.
42 Ibidem.
43 K. Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, trad. it.
A. Pinotti, Cortina, Milano 1996, p. 98.
44 K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, op. cit., p. 25.
40 41 152
Antonello Petrella
la strada per la realizzazione di un nuovo umanesimo a partire da due vie che
gli appaiono come inseparabili e cioè: l’assimilazione dell’umanesimo occidentale quale punto di partenza ineludibile e la lotta per l’indipendenza dell’uomo
come presupposto di ogni possibilità futura. L’elemento decisivo per comprendere il senso dell’umanesimo jaspersiano sta proprio nel dichiarare inseparabili
queste due vie. Ciò significa che l’affermazione dell’indipendenza dell’uomo
nell’epoca attuale non può prescindere ed è del tutto inseparabile da un’assimilazione della lezione della tradizione dell’umanesimo occidentale. Tradizione
che, com’è noto, Martin Heidegger critica nella sua Lettera sull’“Umanismo”
(la cui prima edizione in appendice alla Dottrina platonica della verità risale al
1947, quindi due anni prima della conferenza ginevrina di Jaspers). La critica
di Heidegger si concentra sull’impostazione metafisica di fondo che sarebbe
propria di ogni forma di umanesimo tradizionale: «Il primo umanesimo, cioè
quello romano, e tutte le altre forme di umanesimo che sono via via emerse fino
ad oggi, presuppongono come ovvia l’essenza universale dell’uomo. L’uomo è
considerato come animal rationale. Questa determinazione non è solo la traduzione latina del greco zoon logon echon, ma è un’interpretazione metafisica.
Questa determinazione dell’essenza dell’uomo non è falsa, ma è condizionata
dalla metafisica».45 Per Heidegger, ogni impostazione metafisica prevede una
determinata interpretazione dell’ente e una determinata concezione della verità, dietro le quali si perde quella che è la questione metafisica per eccellenza,
ossia quella dell’essere, che è ridotto invece a ente, ossia ciò che propriamente
essere non è. Pertanto, Heidegger dice che «ogni umanismo o si fonda su una
metafisica o pone se stesso a fondamento di una metafisica. È metafisica ogni
determinazione dell’essenza dell’uomo che presuppone già, sia consapevolmente sia inconsapevolmente, l’interpretazione dell’ente, senza porre la questione
della verità dell’essere»46 e ciò perché «per quanto queste forme di umanesimo
possano essere differenti nel fine e nel fondamento, nel modo e nei mezzi previsti per la rispettiva realizzazione, nella forma della dottrina, nondimeno esse
concordano tutte nel fatto che l’humanitas dell’homo humanus è determinata
in riferimento a un’interpretazione già stabilita della natura, della storia, del
mondo, del fondamento del mondo, cioè dell’ente nel suo insieme».47 Ciò comporta quel passaggio fondamentale in base al quale la metafisica, per Heidegger, penserebbe l’uomo “a partire dall’animalitas e non in direzione della sua
humanitas” in quanto e-sistenza sempre desituata in quel suo costante esser
M. Heidegger, Lettera sull’“umanismo”, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2000, p. 43-44.
Ivi, p. 42.
47 Ibidem.
45 46 Dall’occultamento della trascendenza ad un nuovo umanesimo
153
chiamata dall’essere, ma come essenza determinata in base ad una determinata interpretazione della totalità dell’ente. Per cui l’esigenza di Heidegger non è
quella di condannare l’umanesimo tradizionale, ma è quella di porre in questione la metafisica stessa che ne sarebbe alla base e di riproporre in maniera più
essenziale la domanda sull’essere, cosa questa impossibile per l’umanismo «a
causa della sua provenienza metafisica».48 D’altronde il filosofo di Messkirch si
esprime chiaramente in un passaggio della Lettera: «la proposizione “la sostanza dell’uomo è l’e-sistenza” non dice altro che questo: il modo in cui l’uomo,
nella sua essenza propria, è presente per l’essere è l’estatico stare dentro nella
verità dell’essere. Con questa determinazione essenziale dell’uomo non vengono dichiarate false e rifiutate le interpretazioni umanistiche dell’uomo come
animal rationale, come persona, come essere composto di spirito, anima e corpo. Piuttosto, l’unico pensiero è che le supreme determinazioni umanistiche
dell’essenza dell’uomo non esperiscono ancora l’autentica dignità dell’uomo».
Da qui aggiunge in maniera chiara e definitiva: «in questo senso, il pensiero di
Sein und Zeit è contro l’umanesimo. Quest’opposizione non significa che tale
pensiero si schieri contro l’umano e propugni l’inumano, difenda l’inumanità e
svaluti la dignità dell’uomo. Si pensa contro l’umanismo perché esso non pone
l’humanitas dell’uomo a un livello abbastanza elevato».49
Ci troviamo, quindi, non di fronte alla celebrazione dell’inumano, bensì a
una radicale critica della metafisica occidentale che, essendo alla base di ogni
forma di umanismo, non consente a quest’ultimo di cogliere l’uomo come esistenza nella sua radicale apertura all’essere, nel ruolo quindi di suo “pastore”e
non di suo signore. Tuttavia questa considerazione dell’uomo in termini di esistenza, nel suo essere sempre qualcosa in più della sua semplice presenza, per
Jaspers già è presente in quell’enorme bacino della cultura umanistica e nelle
personalità di maggiore rilievo di essa, per cui nella formulazione di un nuovo
umanesimo non si può prescindere dalla lezione della tradizione: «L’autenticità
dell’essere uomo è in ogni tempo originaria, ma essa è tanto più profondamente attinta quanto più decisamente vengono assimilate le radici da cui proviene. Il nostro umanesimo è l’umanesimo occidentale. Esso implica due momenti strettamente connessi tra loro: la relazione con l’antichità greco-romana e
la volontà di realizzare l’autenticità dell’essere uomo».50 Ora, Jaspers insiste
sull’aspetto educativo dell’umanesimo (non è un caso che la paideia greca assuma valore di primo umanesimo anche a dispetto di quello romano) ma è ben
Ivi, p. 43.
Ivi, p. 55-56.
50 K. Jaspers, Per un nuovo umanesimo: condizioni e possibilità, op. cit., p. 26.
48 49 154
Antonello Petrella
lungi dall’“umanesimo dei letterati” che si «risolvono per la ricchezza caleidoscopica di giochi puramente intellettuali»,51 non crede che la mera conoscenza
filologica di testi del passato possa formare gli uomini, poiché «l’umanesimo
è soltanto il mezzo non la realizzazione dell’essere uomo»52. Laddove continua Jaspers «farne il fine ultimo significa rendere possibile una conservazione disincarnata del passato in un esserci divenuto irreale, poiché privato di
esistentività».53 Nulla di più lontano dal vero compito di un nuovo umanesimo
che è quello di «creare lo spazio spirituale nel quale ciascuno può e deve lottare
per la propria indipendenza»,54 sebbene esso non la realizzi mai né in una determinata concezione dell’essenza dell’uomo, né tantomeno in una determinata
epoca storica che segni l’inizio dell’indipendenza di ogni singolo uomo. Tale
lotta per l’indipendenza, per Jaspers non è mai compiuta e, pertanto, l’autentica indipendenza cui può aspirare il singolo uomo è la conquista di sé che non
ha fine e che non trova mai un punto fisso nella libertà. Il senso del percorso
jaspersiano qui proposto si riassume in un’espressione della conferenza del ’49
in cui traspare come la salvaguardia della trascendenza vada a coincidere con
la tutela dell’autentica libertà di ogni individuo: «Il senso della libertà riceve la
sua piena affermazione nel mondo e diviene realmente libera solo nel sapersi donata dalla Trascendenza. Altrimenti, essa si abbandona alle accidentalità
dell’esserci materiale e psicologico e, oltre a ciò non conserva altro che la rigida
fissità di un punto d’identità vuoto».55 Nel rapporto con la trascendenza, l’uomo
gioca un ruolo decisivo, attivo e non semplicemente passivo, perché come fa
notare Giovanni Santinello in una conferenza dal significativo titolo: Il pensiero
umanistico di Karl Jaspers, «la mediazione umana è l’essenziale condizione per
attingere la Trascendenza»56 a partire proprio da una «positività umanistica
che rende possibile il movimento del trascendere”,57 movimento che è proprio
dell’esistenza in quanto interprete inesauribile di quelle “cifre” che sono evocazioni della realtà della Trascendenza stessa.58
Ivi, p. 27.
Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ivi, p. 28.
55 Ivi, p. 30.
56 A.a.V.v. Karl Jaspers 1883-1969. Celebrazioni nel primo centenario della nascita. 1983, a
cura di G. Santinello, Istituto culturale italo-tedesco, Merano 1985, p. 9.
57 Ivi, p. 7.
58 «Ciò che si dissolve come oggetto per la coscienza in generale, assume valore e significato
per l’esistenza, diventa cifra, evocazione della realtà della trascendenza: è questo il movimento del
trascendere che è proprio dell’esistenza» (G. Cantillo, Introduzione a Jaspers, op. cit., p. 82).
51 52 Tra neokantismo e positivismo giuridico
155
Tra neokantismo e positivismo giuridico:
diritto e Stato nella riflessione giovanile di Carl Schmitt
Memoria di Alessio Calabrese
presentata dal socio corr. naz. Giuseppe Antonio Di Marco
(Seduta del 17 dicembre 2009)
Abstract. Carl Schmitt’s juridical thought moved its first steps studying thoroughly the
new-kantian philosophies of law. This paper aims to underline the crucial role of these
studies, from which the young jurist from Plettenberg elicits a critical view of the 800s
juridical positivism as well as a jus-normative construction of the State as the unique
concrete instance of the positive law.
Un tipo di pensiero normativista.
Interesse del presente lavoro è quello di mettere in luce il nesso tra diritto e
Stato che, nella genesi del pensiero del giovane Carl Schmitt, viene a strutturarsi muovendo dal confronto con le dottrine giuridiche di matrice neokantiana.
Nostro intento è quello di mostrare che è proprio sul terreno lasciato aperto
dalla filosofia del diritto neokantiana e da una sua conoscenza profonda1 che si
snodano e vengono alla luce le problematiche e la specificità della concezione
normativistica schmittiana; detto in altri termini, è da tale confronto che il giurista di Plettenberg trae un suo originale quanto controverso punto di vista sul
ruolo dello Stato e, in particolar modo, del suo rapporto con il diritto.
Ci occuperemo quindi in primo luogo della natura di questo rapporto carat-
1 Leggiamo in proposito un’affermazione di Schmitt rilasciata a F. Lanchester in un’intervista dei primi anni Ottanta: «Questo indirizzo scientifico (scil. il neokantismo) si può dire che
io lo conosca a memoria; nella mia fase formativa l’ho studiato con tanti professori» (F. Lanchester (a cura di), Un giurista davanti a se stesso. Intervista a Carl Schmitt, in «Quaderni Costituzionali», III, n. 1, Firenze 1983, pp. 16-17). L’importanza della discussione del rapporto tra
il giovane Schmitt e le dottrine giuridiche neokantiane era stata a suo tempo sottolineata da
L. Waldecker nella sua recensione allo scritto sul valore dello stato (L. Waldecker, Besprechung
der Schrift «Der Wert des Staates un die Bedeutung des Einzelnen» von Carl Schmitt (1916), ora
in C. Schmitt, Tagebücher, Oktober 1912 bis Februar 1915, hrsg. E. Huesmert, Akademie Verlag,
Berlin, 2005, p. 383).
156
Alessio Calabrese
terizzato, com’è noto2, da un dualismo irriducibile per cui, a parere di Schmitt,
«prima che si pensi ad appianare o a superare, a mo’ di ponte, le antitesi, le si
dovrebbe riconoscere in tutto il loro rigore e importanza»3. Questo significa che
la frattura tra Rechtsnorm e Rechtsverwirklichung si spinge ben oltre la classica
distinzione normativistica tra Sollen e Sein, attraversando invece tutta la realtà
giuridica: «Ciò che determina una proposizione giuridica – scrive Schmitt – e
la distingue, per esempio, da un regolamento di polizia, è che essa si basa su
un elemento di diritto originario, non statale, la cui più precisa determinazione
non entra nel quadro di questo lavoro e di cui (pur esponendosi al rischio di
un paradosso) si deve dire soltanto che deve subentrare come diritto naturale
senza naturalismo»4.
Come si vede da questa singolare affermazione5, se risulta evidente che l’or2 Tra le opere di letteratura critica che maggiormente hanno messo in luce l’originalità del
dualismo tra diritto e Stato nella fase giovanile schmittiana segnaliamo in primis il volume
di H. Hofmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt (1964), a cura
di R. Miccú, ESI, Napoli, 1999, cui va il merito di aver riscoperto l’importanza delle prime
opere di Schmitt per la genesi della sua produzione matura. In secundis, il riferimento va a M.
Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia politica di Carl Schmitt, Morcelliana, Brescia, 1990
nonché a C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno,
Il Mulino, Bologna, 1996. Molto interessante è anche il saggio di O. Beaud, Diritto naturale e
diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl Schmitt, in AA. VV., Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, a cura di A. Carrino, numero speciale della rivista «Diritto e Cultura», V,
1 (1995), pp. 83-114. Infine, vanno menzionati il lavoro di M. Kraft-Fuchs, Prinzipielle Bemerkungen zu Carl Schmitts Verfassungslehre, in «Zeitschrift für öffentliches Rechts», Bd. 9, 1930,
pp. 511-541 e le monografie di G. Schwab, Carl Schmitt, la sfida dell’eccezione (1970), a cura
di N. Piro, Laterza, Roma-Bari, 1986 e di H. Rumpf, Carl Schmitt und Thomas Hobbes. Ideelle
Beziehungen und aktuelle Bedeutung mit einer Abhandlung über die Frühschriften Carl Schmitts,
Duncker & Humblot, Berlin, 1972.
3 C. Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Mohr Siebeck, Tübingen, 1914, p. 109. Pur essendo al corrente che nel 2004 è uscita presso la Duncker & Humblot
la Zweite Auflage dello scritto sul valore dello Stato, avvertiamo il lettore che abbiamo fatto
riferimento alla prima edizione del testo dal momento che la più recente riedizione non ha
subito cambiamenti.
4 Ibid., p. 76.
5 Nella sua recensione a Der Wert des Staates, F. Weyr ha sostanzialmente ricondotto la
posizione schmittiana nell’ambito del giusnaturalismo moderno (cfr. F. Weyr, Besprechung der
Schrift „Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen” von Carl Schmitt, in «Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht» (1914), pp. 578-581). Al contrario, H. Hofmann
ha visto in tale locuzione una dipendenza di Schmitt dalla filosofia dei valori di H. Rickert, leggendo nell’intera opera giovanile schmittiana il tentativo di una comprensione giuridica dello
Stato «in termini di ‘razionalità secondo il valore’» (cfr. H. Hofmann, Legittimità contro legalità,
cit., p. 92, nota 101 e p. 107). O. Beaud sostiene invece che Schmitt sia erede dell’agostinismo
giuridico: infatti, dal momento che al diritto positivo viene concessa una relativa autonomia
rispetto a quello originario, quest’ultimo, in quanto diritto naturale, «sembra indispensabile
per unire le due Città e riannodare un legame tra l’ordine divino e l’ordine terrestre. Questa
necessità della mediazione senza sostanzializzazione di una giustizia naturale porta Schmitt a
riassumere il suo programma sotto la forma di uno slogan paradossale» (cfr. O. Beaud, Diritto
naturale e diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl Schmitt, cit., p. 113). Molto appropriata è anche la tesi di M. Nicoletti secondo cui la locuzione schmittiana «esprime la crisi
Tra neokantismo e positivismo giuridico
157
dinamento giuridico-normativo – il diritto originario – trascende e si oppone
all’ordinamento positivo dello Stato, è allo stesso modo chiaro che il contrasto tra i due non riguarda due ambiti differenti, ma caratterizza ogni singola
proposizione giuridica. In altre parole: richiamandosi la prassi statale ad una
norma originaria non posta, e in virtù della quale si legittima, il dualismo tra diritto e Stato più che indicare un’opposizione dialettica o un’irriducibilità ontologica, va inteso come inscindibilità di due elementi, quello normativo e quello
concreto, opposti l’uno all’altro nel senso di una dialettica polare. Essi rappresentano, nella riflessione schmittiana, i due poli che vengono ad essere oggetto
della scienza giuridica: quello dell’Idea giuridica e quello dell’istanza decisiva
predisposta alla realizzazione del diritto6.
Ora, prima di procedere a confrontare la posizione equidistante di Schmitt
sia dal neokantismo che dal positivismo giuridico, riteniamo opportuno provare ad analizzare singolarmente i due elementi che costituiscono la realtà giuridica e, successivamente, riflettere sulle conseguenze che derivano dal dualismo
tra diritto originario e diritto positivo.
Abbiamo dunque detto che per Schmitt il diritto originario, in quanto pura
e astratta immediatezza, rappresenta la forma ideale, l’Idea trascendentale del
diritto, alla quale non appartengono né il movimento, né l’influenza e l’efficacia:
del pensiero all’inizio del secolo: il rifiuto del positivismo, la consapevolezza della non percorribilità delle vie della metafisica, la ricerca di una nuova ‘forma’ capace di esprimere la trascendenza e al tempo stesso di dare ordine al reale (…); esprime (cioè) la realtà e la coscienza della
secolarizzazione, rivela la struttura del mondo consegnato a se stesso ma non in sé giustificato
e dunque continuamente aperto oltre se stesso» (M. Nicoletti, Trascendenza e potere, cit., p. 51).
Infine, per quanto riguarda la letteratura critica tedesca, va detto che, in generale, la posizione
schmittiana viene ricondotta o all’ambito della dottrina ufficiale cattolica sullo Stato (cfr. H.
Wohlgemuth, Das Wesen des Politischen in der heutigen neoromantischen Staatslehre. Ein methodischer Beitrag zu seiner Begriffsbildung, Emmendingen, 1933, p. 68, nota 58) o, tutt’al più,
questo «diritto naturale senza naturalismo» viene considerato «il punto di riferimento di una
costruzione metafisica» (cfr. H.R. Otten, Der Sinn der Einheit im Recht. Grundpositionen Carl
Schmitts, Gustav Radbruchs, und Hans Kelsens, in AA. VV., Metamorphosen des politischen.
Grundfragen politischer Einheitsbildung seit den 20er Jahren, hrsg. von A. Göbel, D. van Laak,
I. Villinger, Akademie Verlag, Berlin, 1995, p. 34).
6 Schmitt stesso, nell’Introduzione al suo libro sulla Dittatura scritto sette anni dopo Der
Wert des Staates, ritorna sul carattere antagonistico della relazione tra Rechtsnorm e Rechtsverwirklichung (cfr. C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta
di classe proletaria (1921), Laterza, Roma-Bari, 1975 pp. 12-13). A tal proposito, non siamo
del tutto concordi con H. Hofmann che vede in questa opposizione un tipo di «antinomia da
dominare dialetticamente» (cfr. Legittimità contro legalità, cit., p. 86); infatti, essa non solo
non viene dominata ma neanche superata dall’azione decisoria dello Stato, rispetto alla quale,
il diritto originario rappresenta più che altro una «polarità dialettica irriducibile» (cfr. M. Nicoletti, Trascendenza e potere, cit., p. 51). Quest’ultima tesi è sostenuta anche da C. Galli, per il
quale la discontinuità/continuità tra norma e fatto dimostra che non c’è mediazione né rapporto dialettico tra i due corni del dualismo, quanto piuttosto «un movimento di trascendimento
formativo del caso concreto» (cfr. C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 320).
158
Alessio Calabrese
«La norma non può essere soggetto di un effetto (Einwirkung) o la realizzazione di questo, né di conseguenza soggetto di un volere, né titolare di un fine; il diritto non è volontà, ma norma, non ordine, ma precetto (Gebot); rispetto a ciò,
il singolo uomo come oggetto del mondo reale viene dopo»7. Questo significa
che in sé una norma indica solo una prescrizione, la cui validità resta autonoma
rispetto all’osservanza dei singoli attori sociali: «Obbligo (Zwang) e coercizione
(Erzwingbarkeit) possono essere appresi soltanto dall’esperienza, la tendenza
all’obbligo non può che avere un’essenza empirica, ma non una pura norma»8.
Sebbene Schmitt, nelle prime pagine di Der Wert des Staates, avverta il lettore che «ai numerosi problemi che si ricollegano in particolare alla definizione
del diritto, si fa riferimento solo nella misura in cui era necessario alla spiegazione dell’essenza dello Stato»9, l’insistere su una definizione normativa e trascendentale del diritto, risulta centrale per distinguerlo dalla mera forza e, nello
stesso tempo, per consentire al giurista tedesco una critica dello Stato inteso
come potere cieco e arbitrario. Se a buon ragione Hasso Hofmann sottolinea
che «un esame e una critica del genere si muovono sempre necessariamente nel
quadro del riconoscimento in linea di principio del potere dello Stato di volta
in volta presente»10, è pur vero che per Schmitt non sono i fatti o gli organi esecutivi a conferire valore alle cose ma le idee, le norme del diritto. Cioè a dire: se
diversamente dal teologo e dal filosofo, alla base della formazione del giurista
vi è «una maniera completamente altra di comprendere e legittimare il mondo
così com’è»11, d’altro canto la presenza di una componente originaria del diritto
ci induce a metterne in luce la natura spirituale12.
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 37.
Ibid., p. 59.
9 Ibid., p. 14.
10 H. Hofmann, Legittimità contro legalità, cit., p. 107.
11 J. Taubes, In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt (1987), a cura di E. Stimilli,
Quodlibet, Macerata, 1996, p. 79. Questo atteggiamento è presente sin dalla tesi di laurea di
Schmitt dedicata al problema della colpa e dei tipi di colpa, dove per l’appunto leggiamo: «Noi
prendiamo le mosse dal diritto vigente; noi accettiamo il dato di fatto che c’è uno stato che
sotto determinate condizioni punisce» (C. Schmitt, Über Schuld und Schuldarten. Eine terminologische Untersuchung, Schletter’sche, Breslau, 1910, p. 19). In altre parole, come sottolineato da P.P. Portinaro, si tratta di un «atteggiamento di osservazione fenomenologica del diritto
(…) (che muove) dall’osservazione diretta del lavoro giuridico-scientifico e soprattutto della
prassi giuridica (…). Dall’osservazione diretta di tale prassi, e non da assunzioni metafisiche
relative all’essenza del diritto, si perviene all’identificazione dei concetti-chiave del pensiero
giuridico. Soltanto di qui si risale in un secondo tempo alla definizione della natura del diritto» (P.P. Portinaro, La crisi dello jus publicum Europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Edizioni di
Comunità, Milano, 1982, p. 44).
12 Secondo le riflessioni di A. Carrino, l’appartenenza del fenomeno giuridico ad un mondo
spirituale superiore alla realtà empirica rappresenta «una continuità sotterranea nel pensiero schmittiano sul diritto, una continuità che non viene di regola messa in rilievo» (cfr. A.
7 8 Tra neokantismo e positivismo giuridico
159
È con ciò evidente che, conferendo continuità al fenomeno giuridico, solo
l’Idea giuridica può essere fatta oggetto di una scienza filosofica del diritto13, capace di gettare uno sguardo sull’origine e sul modo in cui essa appare nel mondo. In tal senso, la concezione normativa schmittiana assume i tratti di una vera
e propria ideologia giuridica, di un pensiero che muove dalla considerazione per
cui «le idee dominano la vita»14: come ogni kantiano Schmitt «parte da concetti
aprioristici, appunto dalla sua ideologia del diritto. Solo che non si accontenta
di definire questi concetti per se stessi mettendoli in relazione fra di loro. Il suo
procedimento è diverso. Egli cerca di individuare i suoi concetti giuridici in forme statali esistenti e anche nella tradizione, in maniera progressiva, seguendo
i loro legami ultimi, seguendo la loro socializzazione nei confronti di tutte le
altre categorie superiori (filosofia, arte, teologia) (…). Una volta posta l’idea del
diritto, egli cerca di conferire continuità al dato di fatto innalzando al massimo
valore possibile il dono conferitogli. Non solo vorrebbe riconoscere l’idea giuridica ma, possibilmente, rappresentarla, essere egli stesso tale (…). La giurisprudenza, così come la interpreta Schmitt, è presenza razionale delle idee»15.
Una lettura nuova dello Stato in opposizione al positivismo dei giuristi ottocenteschi è qui presente: «Colui che stabilisce la tesi secondo la quale tutto il
diritto deve essere necessariamente positivo, colui che riduce la fondazione del
diritto alle procedure ‘prodotte’ del diritto positivo, si riconosce proprio nella
teoria del potere (Machttheorie), negando l’inconciliabile opposizione di diritto
e fatto»16. Viceversa, nella prospettiva schmittiana, lo Stato non viene inteso né
come la fonte di tutto il diritto, né ristretto al semplice ruolo di esecutore e di
apparato, bensì pensato come una realtà fenomenica che si trova ad essere tutta in funzione di quella noumenica del diritto. Così, in quanto realtà concreta,
lo Stato non soltanto resta separato dall’ordinamento originario non posto, ma
Carrino, L’Europa e il diritto. Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, in Id., Sovranità e
costituzione nella crisi dello Stato moderno: figure e momenti della scienza del diritto pubblico
europeo, Giappichelli, Torino, 1998, p. 130). Dello stesso parere è anche la studiosa americana
E. Kennedy, la quale insiste sul fatto che Schmitt concepisce sin dall’inizio del suo percorso
intellettuale «la scienza giuridica come una parte del grande movimento spirituale del nostro
secolo» (E. Kennedy, Politischer Expressionismus: die kulturkritischen und metaphysischen Ursprünge des Begriffs des Politischen von Carl Schmitt, in H. Quaritsch (a cura di), Complexio
Oppositorum. Über Carl Schmitt, Duncker & Humblot, Berlin, 1988, p. 234).
13 Cfr. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1821), trad. it. G. Marini, Laterza,
Roma-Bari, 2001, p. 19.
14 H. Ball, La teologia politica di Carl Schmitt (1923-1924), trad. it. in C. Schmitt, Aurora
boreale. Tre studi sugli elementi, lo spirito e l’attualità dell’opera di Theodor Däubler (1916), a
cura di S. Nienhaus, ESI, Napoli, 1995, p. 94.
15 Ibid., pp. 96-98.
16 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 20.
160
Alessio Calabrese
«non vi è alcuna trascendente (transzendente) armonia prestabilita dalla quale
risulta che ciò che lo Stato comanda sia sempre diritto»17. Infatti, dal momento
che la norma giuridica può solo avere un carattere predittivo e astratto, lo Stato non vi si richiama nel senso di una deduzione materiale di principi, poiché
nel farla trapassare come atto positivo la sua azione decisoria rompe e spezza il
«naturalismo» e la ripetizione meccanica della sussunzione logica tra norma e
caso concreto18.
Perciò nella succitata formula «diritto naturale senza naturalismo» riluce la
consapevolezza che per Schmitt ogni passaggio tra astratto e concreto avviene
con una caduta nel tempo, segno del perpetuarsi di un dualismo irrisolvibile
nella realtà che impedisce tanto una ri-soluzione giusnaturalistica, quanto una
positivistica del fenomeno giuridico. Se è vero, infatti, che l’autonomia e la sovranità del diritto naturale sono fatte salve perché da essa discende il criterio di
legittimazione del diritto positivo, è altrettanto vero che il «senza naturalismo»
della locuzione, indicando l’irreversibilità di una tale frattura, fa emergere l’importanza e l’autonomia del soggetto statale come «istanza decisoria»19.
È in questo punto preciso, ovvero nella centralità assunta dalla realtà dello
Stato, che si inserisce e si consuma per Schmitt la discussione delle tesi di alcuni esponenti del neokantismo tedesco dai quali, pur condividendo l’opposizione al positivismo giuridico in favore di una concezione normativa del diritto,
prende le distanze restando questi in un orizzonte trascendentale della ragione
giuridica che non consente loro di intendere in termini di frattura irreversibile
il rapporto tra Sollen e Sein. Di conseguenza, ai giuristi neokantiani è pressoché
estranea l’esigenza di porre al centro dell’indagine giuridica un criterio di legittimazione normativa dello Stato.
A voler schematizzare possiamo dunque dire che per un verso, in accordo
col neokantismo tedesco, Schmitt critica le concezioni positivistiche che riducono il diritto a forza, volontà o fine20, poiché esse si riconoscono nella teoria del
Ibid., p. 47.
Questo discorso, portato alle sue estreme conseguenze nella fase decisionista, spingerà
Schmitt a enfatizzare il ruolo eccezionale costituito dalla decisione sovrana, vero e proprio
punto di rottura nell’ordinamento concreto del diritto in cui «la forza della vita reale rompe
la crosta di una meccanica irrigidita nella ripetizione» (Id., Teologia politica. Quattro capitoli
sulla dottrina della sovranità, tr. it. in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera,
Il Mulino, Bologna, 1972, p. 41).
19 Cfr. O. Beaud, Diritto naturale e diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl
Schmitt, cit., p. 95.
20 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 17 e ss. A parere del giovane Schmitt una
teoria giuridica che fa del diritto una manifestazione del potere vigente non può distinguere
tra lecito e illecito poiché, in tal modo, il criterio di legittimità di un’azione non riposerebbe
più sul carattere astratto e indipendente della norma giuridica. Cioè a dire: tale teoria non
17 18 Tra neokantismo e positivismo giuridico
161
potere per la quale il fondamento di validità della norma positiva riposa sulla
volontà fattuale dello Stato21. In tal modo, nel contrapporsi ad una prospettiva
naturalistica del diritto22, Schmitt afferma che «non il diritto viene spiegato dal
potere, ma il potere a partire dal diritto»23. Per altro verso però, come vedremo
nel paragrafo dedicato al confronto con Hermann Cohen e gli altri esponenti
del neokantismo, Schmitt ritiene impossibile postulare una continuità razionale tra idea e prassi del diritto, facendo emergere la necessità dell’ «atto soggettivo e arrischiato, non garantito, della decisione»24. Insomma, assumendo fino in
fondo l’impossibilità di una risoluzione metodologico-trascendentale dell’idea
normativa nella sua realizzazione positiva, Schmitt ribadisce contro il neokantismo che tra «ogni astratto e concreto vi è un abisso che non può essere colma-
può distinguere sul piano dell’essenza «la forza dell’assassino nei confronti della vittima da
quella dello Stato nei confronti dell’assassino (…) (dal momento che esse) non sono di natura
diversa, ma differiscono solo per dei fenomeni esterni determinati da un’evoluzione storica»
(ibid., p. 16, il corsivo è mio). Inoltre, «diritto» non è neanche sinonimo di «volontà», poiché
le opinioni espresse da un’assemblea di uomini non possono costituire il fondamento di validità del diritto stesso, quanto piuttosto soltanto «un indizio per un valore» (ibid., p. 20). Ma
non solo: poiché la volontà è «un fenomeno che appartiene all’essere e non al diritto» (ibid.,
p. 35), lo stesso concetto di fine viene espunto dall’essenza del diritto, appartenendo esso alla
soggettività concreta dello Stato.
21 Ibid., p. 22. Già nella dissertazione di dottorato del 1912 intitolata Legge e giudizio,
Schmitt aveva criticato il dogma della «conformità alla legge» che sia il positivismo giuridico
sia il «movimento del diritto libero» (Freierechtsbewegung) ritenevano essere l’unico criterio
valido per ottenere una giusta decisione giudiziaria. Entrambe queste correnti, infatti, identificando il momento dell’interpretazione con quello della decisione, sostenevano che compito
del giudice fosse soltanto quello di conformare il suo giudizio alla volontà giusta e razionale
del legislatore espressa nella legge positiva. Tuttavia, per Schmitt, giustezza e razionalità non
vanno lette come qualità ontologiche del legislatore, essendo esse soltanto espedienti logici
utili al complesso della scienza giuridica: in questo senso, il legislatore stesso rappresenta una
finzione giuridica del diritto che non può derivare la sua legittimità giuridica né dall’essere
espressione della volontà di una maggioranza né da qualsiasi altra caratteristica empirica riferita allo Stato (Id., Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis (1912),
Beck Juristischer Verlag, München, 1969², pp. 29 e ss.).
22 Leggiamo in proposito quanto scrive Schmitt: «Dall’osservazione della natura, alla quale anche appartiene la vita in comune degli uomini, nella misura in cui tale fenomeno resta
unicamente una spiegazione e una constatazione delle scienze sociali, non si mostra alcun
diritto. Solo la fissazione di una norma fonda la distinzione tra diritto e non diritto (Unrecht),
non però la natura. Il sole brilla su ciò che è giusto e su ciò che è ingiusto» (C. Schmitt, Der
Wert des Staates, cit., p. 31). Quest’affermazione mostra il debito che la concezione giusnormativa schmittiana ha nei confronti del neokantismo di W. Windelband secondo il quale «il
sole della necessità naturale splende ugualmente sul giusto e sull’ingiusto. Ma la necessità
che avvertiamo nella validità delle determinazioni logiche, etiche ed estetiche, è una necessità
ideale, che non è quella del Mussen e del non-poter-essere-altrimenti, ma quella del Sollen e del
poter-essere-altrimenti» (W. Windelband, Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die
Philosophie, Tübingen 1911, IV ed., II volume, pp. 69 e ss., il corsivo è mio).
23 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 24.
24 G. Duso, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Polimetrica, Monza, 2007, p. 202.
162
Alessio Calabrese
to da nessun passaggio graduale»25, facendo del fenomeno giuridico la cifra di
una crisi epocale della ragione moderna26.
Se, dunque, il discorso che fa emergere la necessità della decisione statale è
di carattere logico, è allora nelle aporie della gnoseologia kantiana e postkantiana che va rintracciata la sua genesi27, essendo il nesso tra forma noumenica e forma concreta del diritto la trave portante della Rechtslehre kantiana. In
quest’ultima, però, a differenza del normativismo schmittiano, non sussiste una
vera rottura tra i due lati dell’origine del fenomeno giuridico, bensì prevale un
rapporto di continuità che poggia ad un tempo sul fondamento metafisico-giusnaturalistico e sul carattere sintetico-trascendentale della ragione. Viceversa,
Schmitt, afferma che «una grande estensione è solo simbolo o indizio di una
qualità (…). L’effetto psicologico che suscitano i grandi spazi e le estensioni
temporali, nonché la magnificenza di costruzioni colossali, sono esempi di una
tale rappresentazione della qualità attraverso la quantità. Ma con questo nell’essenza nulla è cambiato, perché ciò che è privo di senso non può mai innalzarsi a
senso, né mai ciò che è estraneo al valore in valore»28. In altre parole, è proprio
la coscienza del fallimento del carattere trascendentale della ragione giuridicocritica e la sua deriva positivistica che, sfuggendo al neokantismo tedesco, fa
emergere in Schmitt da un lato, l’importanza dello Stato come soggetto concreto, punto di congiunzione di due mondi contrapposti, dall’altro la necessità di
esperire il carattere trascendentale del diritto originario nella forma dell’eternità, ovvero come diritto naturale.
Decisiva è a tal proposito l’influenza del poema Das Nordlicht di Theodor
Däubler al quale il giurista tedesco riconosce di aver inquadrato «il più profondo problema di filosofia del diritto e dello Stato (…) (ovvero che) Ein Element,
nicht ein Befehl schafft Rechtsmomente»29. Schmitt afferma infatti che Däubler
è cosciente della rottura tanto del vecchio circolo metafisico quanto di quello
critico e dialettico della ragione moderna: «Il centro divino, il cerchio, si è perC. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 79.
Cfr. C. Galli, Genealogia della politica, cit., pp. 183 e ss.
27 In tutto il secolo XIX il rapporto tra filosofia e diritto riguarda la ricezione dell’idea kantiana di libertà e del soggetto morale nella Begriffsjurisprudenz positivista. La stesura del codice civile tedesco all’inizio del Novecento rappresenta il risultato più fecondo di quest’incontro
e, nello stesso tempo, può essere preso come esempio compiuto del positivismo giuridico,
ovvero di «un sistema puramente deduttivo che assumeva l’idea kantiana di libertà e trattava
la legittimità del diritto positivo come un problema logico: una questione di sussunzione di
concetti con la logica della legge» (E. Kennedy, Constitutional Failure. Carl Schmitt in Weimar,
Duke University Press, 2004, p. 61).
28 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 30 (corsivi miei).
29 Id., Aurora boreale. Tre studi sugli elementi, lo spirito e l’attualità dell’opera di Theodor
Däubler, cit., p. 65.
25 26 Tra neokantismo e positivismo giuridico
163
so trasformandosi in ellisse; il centro del cerchio si è sdoppiato nei due fuochi
dell’ellisse. Questa è l’espressione dell’universale dualismo del mondo visibile
che ritorna attraverso innumerevoli opposizioni (…) (per cui) chi intuiva il significato morale dell’epoca sapendosi anche figlio del proprio tempo non poteva che diventare dualista»30.
Così, dalla lettura del poema däubleriano, Schmitt ricava una filosofia della storia che è caratterizzata non tanto da una tensione dialettica tra pensiero
e essere, diritto e Stato, quanto, come abbiamo già visto, da un’opposizione
polare, vero e proprio gesto di «trasfigurazione» (Verklärung) della realtà che
va letta in contrapposizione all’Aufklärung illuministica31. Esempio di questa
trasfigurazione del reale empirico è per la scienza giuridica, in opposizione al
positivismo della ragione, il ruolo giocato dalla finzione, espediente ripreso dalla Filosofia del come se di Hans Vaihinger32: «La finzione – dice Schmitt – è un
artificio, una strada che l’umanità percorre mille volte in tutte le scienze, per
giungere attraverso false ipotesi al risultato esatto, un metodo che soprattutto
nella matematica e nelle scienze della natura ha mostrato a lungo la sua validità
e la sua giustificazione»33. Pertanto, i limiti e il fondamento di una sua legittimità non sono da rinvenire «nella sua vicinanza alla realtà effettiva, ma nell’utilità
che essa ha per la conoscenza»34: infatti, la caoticità dei singoli fatti empirici
viene sostituita da una trasfigurazione della realtà che ne consente un’immagine
unitaria come se fosse un termine ideale35.
Ibid., pp. 54 e 89.
Come osserva A. Bento, nel Nordlicht tale «trasfigurazione» (Verklärung) è espressione di una filosofia della storia «radicalmente antibenjaminiana», che cioè non si fonda sulla
«catastrofe del tempo», ma sulla fede del mito gnostico (cfr. A. Bento, Teologia e Mitologia
política. Um retrato de Carl Schmitt, reperibile sul sito www.bocc.ubi.pt/pag/ bento-antoniocarl-schmitt-teologia.pdf ).
32 La metodologia schmittiana che «fin dai suoi primi passi si muove con autonomia in
un ambito compreso tra neokantismo e idealismo» trova perciò nel programma dell’intera
speculazione filosofica di Vaihinger il «tentativo di conciliare le esigenze dell’idealismo con i
presupposti teoretici del positivismo, sulla linea di una mediazione resa possibile dalla revisione concettuale del criticismo kantiano» (R. Miccú, Legalità contro legittimità: una lettura
critica della filosofia schmittiana del diritto pubblico, in H. Hofmann, Legittimità contro legalità,
cit., pp. 330 e 332).
33 C. Schmitt, Finzioni giuridiche (1913), trad. it. in «Diritto e cultura», I, n. 1-2 (1991), p. 66.
34 Ibid.
35 Per definire che cosa fosse la finzione, Vaihinger aveva tratto ispirazione dalle idee trascendentali kantiane le quali, pur non avendo carattere oggettivo, funzionavano da criteri
regolativi per la conoscenza, al fine di farla procedere come se la totalità dell’esperienza fosse
possibile. In altre parole, Kant riteneva necessarie queste idee, sia perché altrettanto naturali
quanto le categorie dell’intelletto (poiché connesse con la ragione umana) ma anche perché
potevano stimolare l’uomo ad estendere il più possibile il dominio della propria esperienza,
conferendole il massimo grado di sistema e di unità. Kant ne raccomandava, dunque, un buon
uso, un uso critico che fosse attento a non scambiarle per realtà, altrimenti si sarebbero rive30 31 164
Alessio Calabrese
È qui evidente il motivo per cui «la vita del diritto deve numerosi progressi
alla finzione»36: se il suo utilizzo nella scienza e nella prassi è giunto ad avere
«una formulazione tecnica perfetta»37, ciò dipende dal modo in cui la realtà
giuridica può imporsi su quella naturale, aprendo un varco all’interno del quale
vada a costituirsi l’ordine dei fenomeni empirici.
In definitiva, il nesso che unisce la finzione giuridica al soggetto della realizzazione del diritto – cioè lo Stato – costituisce per il normativismo schmittiano
il tentativo di una rielaborazione e di un superamento del naturalismo della
ragione trascendentale38 che possa opporsi al positivismo e alla funzionalizzazione del diritto39.
late semplici concetti sofistici (dialettici). La trasformazione del significato dell’idea kantiana
nel termine «finzione» vaihingeriano sta ad indicare un duplice spostamento di prospettiva.
Da una parte, Vaihinger estende a tutta la conoscenza il carattere di non realtà, di essere tout
court una «logica dell’apparenza»; dall’altra ogni concetto, ogni ipotesi, ogni puro pensato si
rivela anche falso e contraddittorio, dal momento che i valori intellettuali vengono tutti subordinati alla vita. Influenzato dalla genealogia nietzscheana e dal pragmatismo anglosassone,
Vaihinger giunge a considerare l’utilità della finzione nel processo conoscitivo solo in quanto
questa può essere di aiuto a trovare giovamento nella vita pratica (cfr. H. Vaihinger, Filosofia del ‘come se’. Sistema delle finzioni scientifiche, etico-pratiche e religiose del genere umano
(1911), trad. it. parziale a cura di E. Voltaggio, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1967).
36 C. Schmitt, Finzioni giuridiche, cit., p. 66. La finzione giuridica, tuttavia, è stata lasciata
ai margini nella stagione più gloriosa del formalismo e del positivismo giuridico. Lo stesso
Hans Kelsen, infatti, occupandosi solo incidentalmente dell’opera di Vaihinger, riteneva che
l’utilizzo delle finzioni giuridiche doveva essere vietato proprio in conseguenza del fatto che
possono giustificare e rendere comprensibile il fenomeno giuridico in modo non rigoroso in
termini gnoseologico-critici (cfr. H. Kelsen, Sulla teoria delle finzioni giuridiche (1919), in Id.,
Dio e Stato. La giurisprudenza come scienza dello spirito, a cura di A. Carrino, ESI, Napoli,
1988, p. 256.
37 C. Schmitt, Finzioni giuridiche, cit., p. 65.
38 In uno dei suoi testi fondamentali che segnano il passaggio dalla fase giovanile a quella
del decisionismo giuridico Schmitt affermerà che «la filosofia moderna è dominata da un
dualismo fra pensiero ed essere, concetto e realtà, spirito e natura, soggetto e oggetto, a cui
neppure la filosofia trascendentale kantiana ha potuto fornire un’adeguata soluzione» (Id.,
Romanticismo politico (1919), a cura di C. Galli, Giuffrè, Milano, 1981, p. 86).
39 Pur polemizzando aspramente con gli esponenti del positivismo giuridico, il giovane
Schmitt cita con ammirazione le ricerche del primo Kelsen cui va il merito di aver estromesso il problema del fine dal concetto del diritto e di aver chiarito la distinzione tra metodo
normativo della giurisprudenza e metodo causale-esplicativo delle scienze sociali: «Un libro
apparso da poco (scil. gli Hauptprobleme di Kelsen) ha dato rilievo e con imponente coerenza
alla differenza tra modo di trattare sociologico e giuridico, causale-esplicativo e normativo,
e ha sottolineato che l’impiego di un sostanziale elemento finalistico sia ‘il più grossolano di
tutti gli errori metodologici’» (Id., Gesetz und Urteil, cit., pp. 56-57). Va detto, però, che negli
Hauptprobleme kelseniani sarebbe stato già possibile per Schmitt intravedere quel legame implicito tra la filosofia pura del diritto e il positivismo giuridico, ovvero l’identificazione operata
da Kelsen tra il concetto di Stato e l’ordinamento normativo valido positivamente. Quindi,
all’inizio degli anni ’10, pur sostenendo entrambi una concezione normativa del diritto, pur
ritenendo necessaria una separazione tra Sollen e Sein, le ricerche dei due giuristi danno esiti
profondamente diversi poiché dietro l’uso comune della parola «normativismo» si nasconde
il duplice senso in cui, durante il primo decennio del XX secolo, vengono sottoposti a critica i
principali problemi della filosofia kantiana e neokantiana del diritto. Detto altrimenti, se Kel-
Tra neokantismo e positivismo giuridico
165
Conviene allora procedere nell’analisi della concezione normativa del diritto
e dello Stato del giovane Schmitt, cominciando dalla lettura di alcuni passi di
Der Wert des Staates in cui il giurista di Plettenberg si confronta in maniera critica con la dottrina giuridica di Kant, considerata dai più il luogo d’origine del
formalismo giuridico moderno.
Il confronto con la Rechtslehre kantiana.
È senz’altro noto a tutti come nella prima parte della Metafisica dei costumi,
il criticismo kantiano abbia provveduto a fornire, analogamente a quanto fatto
per la scienza della natura, una distinzione tra la natura a priori e metafisicosistematica del diritto e la sua applicazione empirica40. Allo stesso modo tutti
sanno che pur essendo il diritto un concetto puro esso «è tuttavia orientato alla
pratica»41, avendo come oggetto la libertà dell’arbitrio. Attenzione, però: nonostante appartenga al mondo etico, al regno della libertà, il diritto necessita pur
sempre di un’immediata applicazione alla realtà empirica. Per questo motivo,
Kant precisa sin dalla prima pagina dello scritto che la Rechtslehre non costituisce un vero e proprio sistema metafisico, «dal momento che riguardo ai casi
a cui essa si applica, (…) ci si può attendere (…) soltanto un avvicinamento ad
esso»42. In tal modo, il filosofo di Königsberg prevede per i singoli casi empirici
soltanto dei principi metafisici della dottrina del diritto, ovvero non un sistema
tracciato a priori, ma un insieme di esempi il cui significato universale possa
fungere da punto di riferimento per un determinato comportamento43.
Ora, questo strettissimo legame che il diritto mantiene con l’esperienza già
lascia intravedere la differenza formale che esso intrattiene con la morale. Infatti, ogni legge etica, essendo a priori e necessaria, non solo non è deducibile
dall’esperienza, ma «comanda ad ognuno senza nessun riguardo alle speciali
inclinazioni»44. L’agire etico viene modulato non sulla base di inclinazioni o di
impulsi sensibili, come il piacere e la gioia, ma sulla sovranità della ragione la
sen negli Hauptprobleme spinge già in direzione di una gnoseologia teoretico-critica del diritto,
nel tentativo di epurare la dottrina kantiana dai suoi elementi giusnaturalistici, con lo scritto
sul valore dello Stato, Schmitt rivolge invece l’attenzione al problema della realizzazione pratica
del diritto (cfr. H. Hofmann, Legittimità contro legalità, cit., pp. 75 e ss.).
40 I. Kant, Metafisica dei costumi (1797), trad. it. di N. Merker, Laterza, Roma-Bari, 1973,
pp. 3-4.
41 Ibid., p. 3.
42 Ibid.
43 Ibid., pp. 3-4.
44 Ibid., p. 17.
166
Alessio Calabrese
quale è l’unica «a comandare come si deve agire, anche in assenza di ogni precedente esempio in proposito, e inoltre senza nessun riguardo al vantaggio che
si può derivare dall’adempimento del comando»45.
Kant perciò procede nel distinguere le leggi che regolano l’agire morale
da quelle che regolano l’agire giuridico, considerando le prime come «principi determinanti delle azioni», legate alla libertà interiore dell’individuo
dotato di ragione, riguardando viceversa le seconde solo le «azioni esterne»,
cioè l’«esercizio esteriore della libertà». Date queste premesse va da sé che
la legislazione morale differisce da quella giuridica, dal momento che quella
«erige un’azione a dovere e questo dovere nello stesso tempo a impulso»46,
mentre questa non necessariamente si fonda sull’unicità dell’idea del dovere. Potendosi fondare anche su impulsi di natura diversa derivati dall’esterno, essa riguarda esplicitamente l’azione esterna; insomma per il filosofo
tedesco non è importante se ciò che ci induce al rispetto di una legge giuridica sia la paura di una punizione o anche un premio, il raggiungimento di
un risultato che costruisca un interesse: è sufficiente la conformità esteriore.
Per questo motivo, aggiunge Kant, l’idea del dovere giuridico non è «motivo
determinante della volontà dell’agente»47.
Così, a ben guardare, dentro ogni legislazione si trovano due elementi: «in primo luogo una legge, che rappresenti oggettivamente come necessaria l’azione che
deve essere fatta, cioè che eriga l’azione a dovere; in secondo luogo un impulso, che
unisca soggettivamente con la rappresentazione della legge il motivo che determina
la volontà a questa azione, onde questo secondo elemento si riduce a ciò che la legge faccia del dovere un impulso»48. In altre parole, ogni legislazione può differire da
un’altra quanto agli impulsi. Da ciò, Kant chiama etica quella legislazione che erige
un’azione a dovere e, a chiudere il cerchio, che innalza questo dovere ad impulso.
La legislazione giuridica, invece, non comprende quest’ultimo caso, non consente
questo movimento di ritorno per cui si erige il dovere ad impulso e, perciò, può ammettere anche «un impulso diverso dall’idea del dovere stesso»49. Pertanto, riguardo alla legislazione giuridica, «si scorge facilmente (…) che questi impulsi distinti
dall’idea del dovere debbono essere necessariamente tratti dai motivi patologici di
determinazione della volontà che si riferiscono alle inclinazioni e alle avversioni, e
anzi, a preferenza, dai motivi che si riferiscono a queste ultime, perché si tratta di
Ibid.
Ibid., p. 20.
47 Ibid., p. 21.
48 Ibid, p. 20.
49 Ibid.
45 46 Tra neokantismo e positivismo giuridico
167
una legislazione la quale ha necessariamente un carattere coercitivo, e non uno che
possa allettare e attirare»50.
Ora è proprio in quest’ultima affermazione che secondo Schmitt l’intera costruzione normativa kantiana si rovescia in una forma di empirismo giuridico:
se per Kant, infatti, la legislazione giuridica – che in via di principio ha il suo
contenuto identico a quella morale – può derivare i suoi impulsi anche da «motivi patologici» che si riferiscono a «inclinazioni» e «avversioni»51, allora, afferma il giurista tedesco: «Un dovere giuridico può essere, secondo la terminologia
kantiana, solo un dovere ‘esteriore’, cioè un legame (Verbindlichkeit) a un’ ‘azione esteriore’. Da ciò emerge che per Kant la differenza tra etica e diritto rinvia
a una ‘legislazione’ differente, che nell’etica è interiore e nel diritto è esteriore.
L’opposizione di legislazione interiore ed esteriore sta nell’opposizione dell’impulso (Triebfedern), del motivo psicologico all’azione conforme al dovere»52. Da
questo punto di vista, Kant farebbe sua non solo una concezione empirica del
diritto, ma indurrebbe anche ad una sua psicologizzazione, dal momento che
la differenza del dovere giuridico rispetto a quello morale «non sta nel suo contenuto o nella sua autorità, ma in un motivo psicologico»53 distinto da quello
della pura rappresentazione del dovere propria della legge.
Ma non solo. Se infatti dalla Rechtslehre kantiana emerge la necessità di una
fondazione empirico-psicologica del diritto in opposizione all’autonomia del
soggetto morale, questa psicologizzazione apre ad un altro problema: quello
riguardante la posizione stessa del diritto all’interno dell’orizzonte noumenico
della libertà. In tal modo quella kantiana è sì una Metafisica della Sittlichkeit, al
cui interno però il diritto occupa una posizione subordinata rispetto all’etica, la
quale «si riferisce in generale a tutto ciò che è dovere»54.
Ibid.
Cfr. ibid., pp. 11 e ss.
52 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 57.
53 Il rifiuto schmittiano di una psicologizzazione del diritto è presente sin dalla dissertazione di laurea del 1910 dove egli, criticando la posizione del giurista Gustav Radbruch, sostiene
che la «colpa» (Schuld) non può essere un concetto psicologico puro né può dipendere dai suoi
«tipi» (Schuldarten), ovvero da «negligenza» e «intenzione» (Id., Über Schuld und Schuldarten,
cit., pp. 3 e ss.). Dal momento che tutta la costruzione giuridica di Radbruch si fonda su questo
falso presupposto, questi tende a confondere il concetto (la colpa) con il predicato (i tipi di
colpa) e, di conseguenza, a rendere naturalistica (e psicologica) la tensione normativa che ne
definisce il rapporto (ibid., p. 123).
54 I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., p. 21. In questo luogo, Kant sostiene che solo all’interno del soggetto che agisce è presente «l’impulso interno all’azione». Infatti, poiché l’idea del
dovere «non riguarda in nessun modo la legislazione esterna, essa non può essere affatto una
legislazione esterna (nemmeno quella di una volontà divina), quantunque invero essa medesima possa farci un dovere di prendere per impulsi certi doveri che si riferiscono a un’altra legislazione, vale a dire a una legislazione esterna» (ibid.) E ancora: «I doveri che si impone la legi50 51 168
Alessio Calabrese
Insomma, secondo Schmitt, in Kant non esiste una reale autonomia del diritto, ed è per questo che il filosofo di Königsberg lo lega alla facoltà di costringere, cioè alla forza. Questione non di poco conto questa poiché l’equivalenza
diritto/coercizione dà risalto alla diversa interpretazione dell’idea di dovere dei
due pensatori: idea che in Kant riguarda l’azione a cui qualcuno è obbligato,
laddove in Schmitt il dovere «come materia dell’obbligazione»55, risulta soltanto dall’azione reale dello Stato. Leggiamo in proposito: «Se i doveri giuridici
sono quelli per i quali un impulso differente dalla rappresentazione di un dovere non contraddice assolutamente l’idea di un dovere giuridico, e se l’autorità di
un dovere etico consiste nel fatto che esso lega gli uomini a priori ed incondizionatamente attraverso un’unica ragione, allora l’autorità di un dovere giuridico
può stare ancora nella loro ragionevolezza (Vernünftigkeit) e l’appendice della coercizione apparire come casuale. Nel caso di Kant la coercizione diventa
qualcosa di essenziale ed egli deduce da ciò che un dovere giuridico può essere
sempre solo un’azione esteriore – così la coercizione deve risultare dall’essenza del dovere giuridico, il che significa che un dovere giuridico è un dovere
che, secondo la sua essenza, incita alla costrizione. Poiché la coercizione si
può legare solo a ciò che è esteriore, al mondo empirico, questa sollecitazione,
questa tendenza avrebbe tuttavia una direzione sull’empirico, una conformità
all’esperienza. La coercizione non può emergere che dal contenuto concreto ed
empirico della norma; utilizzare questo contenuto per caratterizzare la stessa
norma giuridica deve essere indicato senza dubbio come il ‘più grosso e il più
dannoso degli errori’»56.
slazione giuridica possono essere soltanto doveri esterni, perché questa legislazione non esige
che l’idea di questo dovere, la quale è affatto interna, sia per se stessa motivo determinante
della volontà dell’agente; e siccome questa legislazione abbisonga pure di impulsi appropriati
alle sue leggi, essa non può ammettere che impulsi esterni» (ibid., il corsivo è mio).
55 Ibid., p. 25.
56 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 58-59. Perciò, continua Schmitt, la definizione
kantiana della contrapposizione tra etica e diritto «lascia senza risposta il problema più importante, in particolare quello della giustificazione (Berechtigung) dell’obbligazione giuridica
(…) (che) non può essere chiarita attraverso il riferimento all’obbligo, poiché essa così smetterebbe di corrispondere a una norma e sarebbe un derivato dei rapporti fattuali» (ibid., pp.
59-60). In altre parole, Schmitt sostiene che Kant, fondando il dovere giuridico su motivazioni
empirico-psicologiche, può distinguere l’illiceità di una banda di ladri solo sulla base della
legalità dell’obbligo statale. Al contrario, per il giurista tedesco si tratta di legittimare l’azione
concreta dello Stato – come istanza giuridica competente – muovendo dal riferimento ad una
norma sovrapositiva indipendente da rapporti fattuali: infatti, il carattere coercitivo della norma statale dipende dal suo contenuto empirico – contenuto che sta in relazione alla norma
stessa in modo accidentale, essendo esso posto dall’esterno in quanto positivo. Come si vede,
se il carattere essenzialmente costrittivo della legislazione giuridica porta Kant, a parere di
Schmitt, a tradire «il postulato della purezza del diritto» (ibid., p. 59), già nel giovane giurista
di Plettenberg giunge invece a maturazione – sulla scia di questo confronto con la Metafisica
Tra neokantismo e positivismo giuridico
169
Da quanto detto dovrebbe risultare chiaro ciò che, attraverso la lettura di
Kant, interessa davvero mettere in luce al giurista di Plettenberg: in primo luogo, lo si è visto, egli cerca di evitare quella concezione empirica del diritto che
deriva in Kant dalla fondazione della legislazione giuridica sull’autonomia del
soggetto morale. Nel tentativo di superare il presupposto kantiano dell’unità
della ragione pratica, Schmitt afferma al contrario che: «Poiché il diritto diventa indipendente dall’etica, esso riceve la sua dignità ex autou non da una
metousia con l’etica, e nessun rapporto di condizioni esterne è da riconoscere
alla libertà interna né un passaggio graduale di uno nell’altra. La conseguenza
che il diritto non può essere dedotto dall’etica, che Feuerbach pone in contrapposizione a Kant (…) trova l’obiezione di quei filosofi del diritto secondo i
quali la derivazione del diritto dai fatti è qualcosa lontana da loro»57. In questo
modo, la critica schmittiana a Kant rimane centrata nell’orizzonte giuridico e
questo perché, nel suo pensiero anche «la morale comincia con concetti di diritto sicuri»58. Inoltre, in secondo luogo, l’effetto di una mancata autonomia del
diritto dalla morale induce d’altra parte alla mancata discontinuità in Kant tra
diritto e Stato: per quest’ultimo, infatti, poiché «l’obbligazione giuridica non si
fonda su una motivazione etica, ma ‘si appoggia unicamente sulla possibilità di
una costrizione esterna’ che renda effettivamente possibile la ‘coesistenza degli arbitri’, la coazione giuridica viene a far parte integrante dell’obbligazione
giuridica»59.
Tale mancanza kantiana risulta ancor più chiara dall’analisi del rapporto di
continuità tra diritto naturale e diritto positivo. Nella Metafisica dei costumi, infatti, il diritto naturale è sì un diritto a priori, ma non un altro diritto, costituendo esso soltanto la forma del diritto positivo. Non è un caso che la differenza tra
stato di natura e stato civile è rappresentata soltanto dall’esistenza del sovrano,
cioè da un apparato coattivo che assolve una funzione giurisdizionale. In questi
termini, però, di fronte al diniego intorno alla domanda sull’origine del potere
dello Stato e spostando l’accento sulla sua necessità di intervento nel reprimere
dei costumi – il problema della norma indifferente alla fattispecie e, nello stesso tempo, dell’accidentalità del contenuto della decisione statale rispetto al diritto originario.
57 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 10-11.
58 H. Ball, La teologia politica di Carl Schmitt, cit., p. 99. A Schmitt non interessa rilevare
che anche in sede morale il formalismo kantiano possa rovesciarsi in una concezione materialistica dell’agire: per una posizione critica su questo punto si veda G. W. F. Hegel, Sulle maniere
di trattare scientificamente il diritto naturale, sulla posizione di esso nella filosofia pratica e sul
suo rapporto con le scienze giuridiche positive (1802-1803), in Id., Scritti di filosofia del diritto
(1802-1803), a cura di A. Negri, Laterza, Roma-Bari, 1971², pp. 23-160.
59 P. Costa, D. Zolo, E. Santoro, Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano,
2002, p. 102.
170
Alessio Calabrese
e garantire le condizioni della libertà esterna degli individui60, in Kant si assisterebbe, a parere di Schmitt, ad un capovolgimento tra fenomeno e noumeno
anche nel rapporto tra morale e diritto. Così, l’esistenza concreta dello stato
civile sembra diventare la condizione necessaria per lo sviluppo delle qualità
morali del singolo individuo, ovvero della libertà noumenica la quale, confondendosi in modo paradossale «con il fatto di una volontà generale ipostatizzata
nell’ordinamento positivo»61, finisce essa stessa per derivare dal potere di volta
in volta vigente.
La mancata distinzione tra diritto e morale e tra diritto e Stato conduce Kant
a prendere in esame la realtà del fenomeno giuridico confinandolo nell’ambito
dell’essere fattuale invece che mantenerlo in quello del dover essere. Qui, nonostante vi sia la ricerca del valore del diritto attraverso la deduzione trascendentale, la forma giuridica trova nella forza dello Stato la sua condizione di realizzazione, ovvero la salvaguardia e l’accordo della libertà negativa dei singoli individui62. In tal senso, nella Rechtslehre kantiana si assisterebbe, secondo Schmitt,
ad una modificazione della concezione della forma come risultava dall’ideale
critico della ragione, poiché il noumeno, l’idea di libertà, non vengono intesi né
come condizione né come elemento costitutivo del fenomeno giuridico, bensì
semplicemente come una generalizzazione di questo. In altre parole, l’orizzonte
intellegibile del diritto proprio perché si limita a con-formare e registrare la legislazione empirica particolare, si confonde con quello positivo vigente63.
60 I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., pp. 148 e ss. Non è possibile in questa sede discutere
un tema spinosissimo quale quello che, nella genesi del pensiero giuridico-politico di Kant,
caratterizza il rapporto tra diritto e politica in riferimento alla coazione statale. Ci limitiamo
ad osservare che Schmitt, coerentemente con la sua metodologia normativa, non prende in
considerazione il ruolo «prudenziale» svolto dalla politica nella Pace perpetua (in Id., Scritti
di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 190 e ss.). Qui
– e in generale per il formalismo giuridico kantiano – se l’applicazione del diritto è ciò che
compete alla politica, la coazione invece si riferisce più esplicitamente alla decisione statale.
In altre parole, vi è in Kant un’evidente discontinuità tra applicazione e decisione del diritto,
conformemente alle dottrine giuridiche liberali, mentre in Schmitt, al contrario, proprio il
momento della decisione non può essere eluso né distinto nella prassi del diritto, poiché esso
si trova racchiuso in ogni proposizione giuridica.
61 A. Negri, Alle origini del formalismo giuridico. Studio sul problema della forma in Kant e
nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802, Cedam, Padova, 1962, p. 81.
62 Scrive in proposito G. Solari: «Lo Stato giuridico di Kant non è solo un’esigenza razionale, ma è anche espressione di potenza, è forza coattiva a servizio della norma di ragione,
anche ciò in armonia con la concezione del diritto che si identificava con la coazione. Alla assolutezza della norma corrisponde l’assolutezza della coazione, intesa nei limiti e nella finalità
di quella. Perciò l’antitesi di libertà e coazione, diritto e Stato, che prima di Kant sembrava
non potesse risolversi se non con il sacrificio dell’uno o dell’altro termine, era superata da Kant
nella nozione stessa del diritto, che è sintesi di libertà empirica e di coazione razionale» (G.
Solari, La formazione storica e filosofica dello Stato moderno, Guida, Napoli, IV ed., p. 83).
63 A. Negri, Alle origini del formalismo giuridico. Studio sul problema della forma in Kant e
Tra neokantismo e positivismo giuridico
171
È evidente quanto sia distante la concezione giuridica schmittiana da quella
kantiana e da ogni altra di tipo giusnaturalistico: in Schmitt, infatti, il diritto
naturale non è più fonte e origine formale, come in Kant64, della norma di diritto positivo, poiché nel passaggio alla sua reale applicazione interviene l’attività
di un soggetto concreto, lo Stato, che ne trasforma il senso.
Proprio l’avere individuato l’importanza e l’evidenza di questa trasformazione del diritto naturale consente a Schmitt di eliminare dalla norma giuridica
anche il carattere formale dell’obbligazione, ovvero di distinguere il carattere
intelligibile e precettivo del diritto da quello fenomenico e costrittivo del diritto
positivo65. In questo senso, l’originalità della concezione schmittiana consiste
nell’avere messo in luce il problema del soggetto giuridico, dell’organo concreto
che presiede alla realizzazione del diritto. Per l’appunto, rispetto alla dottrina
giuridica di Kant – cui pure va il merito di aver svincolato l’idea del dovere da
una volontà divina sia in sede morale che giuridica66 – l’interpretazione della
norma giuridica come assoluto dovere essere astratto e l’ipotesi del soggetto
concreto che ha il compito di realizzarla, consente a Schmitt di affermare sia
l’autonomia del diritto, sia la relativa autonomia statale nei confronti del diritto
originario stesso.
Vediamo ora in che modo tale assunto viene fatto giocare rispetto ad alcuni
esponenti del neokantismo tedesco del primo Novecento, la cui polemica contro il positivismo ottocentesco appare a Schmitt debole e, soprattutto, inefficace incentrata com’è su una diversa lettura dei problemi aperti dal formalismo
giuridico kantiano.
nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802, cit., p. 78.
64 Cfr. I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., p. 27.
65 L’ambiguità kantiana per cui il diritto da un lato mantiene il suo carattere etico (trovandosi esso nel regno della ragione pratica), ma dall’altro rinuncia a fondarsi sull’autonomia
razionale della legge, sembra risolversi poiché esso (il diritto) continua a riferirsi al concetto
di libertà in quanto prescrive conformità alla legge del dovere. Come scrive A. Negri, questa
«conformità garantirebbe il carattere etico del diritto, anche prescindendo dall’autonomia. Ma
è appunto questo concetto di forma quale conformità che è estremamente equivoco. La forma
infatti, nel regno della ragione pratica, non può essere altro che espressione noumenica della
libertà, in riferimento all’autonomia razionale della legge: qui invece, mancando esplicitamente l’elemento dell’autonomia, la forma diviene un semplice involucro, rinunzia al suo carattere
formativo per autodefinirsi suggello e condizione dell’indipendenza. Questo carattere negativo
assunto dal concetto di libertà risalta a proposito del fondamento della coazione, fino al punto
in cui Kant rovescia lo stesso principio da cui s’era mosso per affermare che ‘lo stretto diritto
può anche essere rappresentato come la possibilità di una costrizione generale e reciproca,
accordantesi colla libertà di ognuno secondo leggi universali’» (A. Negri, Alle origini del formalismo giuridico, cit., pp. 73-74).
66 Cfr. C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 21.
172
Alessio Calabrese
Il tentativo neokantiano di una fondazione autonoma del diritto.
All’inizio del XX secolo la filosofia neokantiana aveva sostenuto con forza,
nel dibattito giuridico tedesco, la necessità di distinguere la validità normativa
del diritto (Sollen) dalla sua efficacia positiva (Sein); insofferenti del logicismo
empirico dei giuspositivisti e del legame che univa questi ultimi alla genesi del
Kaiserreich, gli esponenti del neokantismo riportarono alla luce la teoria universalistica del diritto naturale facendola giocare in opposizione all’idea che
il diritto fosse unicamente una creazione dello Stato sovrano. Viceversa, essi
affermavano la posizione preminente del diritto rispetto allo Stato e l’indipendenza della scienza giuridica dalla sfera politica, ovvero facevano propria l’irriducibilità tra jus e factum. Il modello analitico del positivismo ottocentesco nel
quale al giurista non restava che «sviluppare un’analisi sistematica ed empirica
di quelle norme giuridiche che esistevano negli statuti, nelle decisioni e nella
pratica»67, veniva osteggiato soprattutto da Hermann Cohen: egli infatti, interrogandosi circa la possibilità di una fondazione a priori della scienza giuridica,
operava in vista di una rielaborazione della metodologia critica kantiana, ampliandone l’ambito di applicazione e di ricerca anche alle categorie formali e
costitutive del fenomeno giuridico68.
A rendere interessanti agli occhi di Schmitt queste ultime considerazioni
coheniane, è sicuramente il fatto che da esse emerge il tentativo di una declinazione antipositivistica e dunque scientifico-normativa del formalismo giuridico. Ma non solo: esse inoltre rappresentano, per il giurista di Plettenberg, un
primo terreno di confronto con le conseguenze che scaturiscono da un simile
approccio teoretico alla giurisprudenza, evidente soprattutto nella riconfigurazione del rapporto tra diritto ed etica. Afferma infatti il giurista neokantiano:
«Nessuna scienza giuridica è pensabile o riconducibile ai suoi fondamenti ultimi se si disdegna il legame con l’etica. Il diritto naturale è il diritto del diritto, o
l’etica del diritto»69. Naturalmente, sarebbe impossibile esaurire in questa sede
un argomento così complesso; limitiamoci, piuttosto, a mettere in rilievo che
67 J.W. Bendersky, Carl Schmitt teorico del Reich (1983), a cura di M. Ghelardi, Il Mulino,
Bologna, 1989, p. 36. Secondo il giuspositivista P. Laband «il diritto è ciò che è la legge» e «la
legge è ciò che è promulgato in modo formalmente adeguato» (P. Laband, Das Staatsrecht des
Deutschen Reiches, Tübingen 1876, vol. I, pp. 87 ss.).
68 Per una discussione approfondita della filosofia del diritto neokantiana si veda C. Müller, Die Rechtsphilosophie des Marburger Neukantianismus. Naturrecht und Rechtspositivismus
in der Auseinandersetzung zwischen Hermann Cohen, Rudolf Stammler und Paul Natorp, Mohr
Siebeck, Tübingen, 1994.
69 H. Cohen, Etica della volontà pura (1904), trad. it. a cura di G. Gigliotti, ESI, Napoli,
1994, p. 53.
Tra neokantismo e positivismo giuridico
173
Cohen, e in generale la Scuola di Marburgo, tentano di coniugare assieme tanto l’esigenza che il fenomeno giuridico resti ancorato all’idea di libertà, quanto
la necessità che la scienza giuridica trovi un suo statuto autonomo in quanto
scienza di pari rango a quelle fisico-matematiche, rigorosamente fondate70.
A riprova di quanto appena detto basta fare qui un riferimento alle prime
pagine dell’Etica della volontà pura dove Cohen afferma, contro Kant, che sebbene sia necessario distinguere tra singolarità e unità, non è in ogni caso possibile dedurre quest’ultima dalla prima; nella sfera morale questo significa l’indeducibilità della norma giuridica da quella etica la cui osservanza, come è noto,
riguarda per Kant soltanto il singolo. Per Cohen, invece, non solo l’unità del
diritto positivo in quanto totalità (Allheit) non può essere dedotta muovendo
dal singolo, ma essa stessa risulta essere una sintesi superiore all’unità dei singoli messi insieme. Perciò, il concetto di individuo morale si presenta non più
autoriferito e originario in quanto essere che si dà kantianamente la legge da
se stesso, ma viene considerato come il risultato di una sintesi tra particolarità
e totalità; insomma, per un Cohen vicino allo spirito oggettivo hegeliano, se si
parte dall’individualità, si può arrivare soltanto ad una definizione psicologica
di uomo, non etica71.
Evidente qui la vicinanza a Schmitt, poiché similmente al giurista tedesco
è a questo punto che entra in gioco il ruolo della giurisprudenza: l’essere condizione trascendentale e, tramite lo Stato, reale dello sviluppo dell’etica singola.
Detto in altri termini, in quanto studia logicamente l’universale che ha nello
Stato il suo corrispettivo fenomeno reale, la scienza giuridica assume per l’etica
l’analogo significato che Schmitt le ha precedentemente attribuito nel suo confronto critico con Kant. Infatti, per Cohen, l’etica ha come contenuto il dovere
puro e viene costruita proprio sul fondamento della scienza giuridica ritenuta,
appunto, «matematica delle scienze dello spirito»72.
Dal canto suo, se l’unità logico-giuridica del concetto di Stato è il presup-
70 È evidente che il nesso stabilito tra gnoseologia e diritto conduce i neokantiani a distorcere la posizione che quest’ultimo possiede nella Metafisica dei costumi, e cioè al mondo etico
e della libertà (cfr. E. Kaufmann, Critica della filosofia neokantiana, in E. Kaufmann, W. Sauer,
G. Hohenauer, Neokantismo e diritto nella lotta per Weimar, a cura di R. Miccú, ESI, Napoli,
1992, p. 46). Tuttavia, il merito del neokantismo giuridico – ed in particolar modo quello marburghese – sta nel fatto che «provvide ad una giustificazione alternativa (a quella di Laband)
di concepire il sistema giuridico come sistema unitario. L’unità, veniva così argomentato, era
semplicemente la condizione trascendentale del giudizio giuridico» (G. Balakrishnan, The
Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, Verso, 2002, p. 14).
71 H. Cohen, Etica della volontà pura, cit., pp. 8 e ss.
72 Ibid., p. 50.
174
Alessio Calabrese
posto metodico dell’etica73, è soltanto il soggetto della volontà pura, in quanto
soggetto che agisce, a fare da tramite tra scienza giuridica e dottrina dello Stato,
tra la condizione trascendentale del diritto e la sua reale applicazione.
Fin qui, come si vede, le critiche di Schmitt e Cohen a Kant appaiono essere
in sintonia e trovarsi concordi con la necessità di un’autonomia del diritto che
funga da presupposto fondativo per una giustificazione logico-giuridica dello
Stato. Tuttavia, le cose non stanno proprio così poiché è precisamente in questo punto che prendono forma le perplessità di Schmitt rispetto al tentativo di
Cohen, e del neokantismo giuridico in generale, di ritenere possibile una sintesi
tra scienza giuridica e realizzazione concreta del diritto.
A voler schematizzare possiamo enucleare in tre snodi fondamentali la critica schmittiana: il primo, riguarda la possibilità di una gnoseologia giuridica
a partire dalla quale chiarire «le relazioni tra norma giuridica (Rechtsnorm) e
norma pratica (Rechtsleben) e (stabilire) le differenze tra teoria e prassi»74; il secondo, concerne la difficoltà di ricondurre diritto e etica ad una stessa legalità
che poggi sull’unità della ragione pratica; l’ultimo, il ruolo del singolo individuo
all’interno della compagine statale.
Per quel che concerne la prima questione vanno sottolineate, come Schmitt
stesso mette in luce, le contraddizioni alle quali si va incontro qualora si cerchi di fondare una scienza giuridica a priori (Rechtswissenschaft) che funga da
criterio esplicativo per una ricognizione dei singoli problemi di dottrina generale del diritto (Rechtslehre). «Prima di dare soluzione al problema kantiano e
copernicano della possibilità della scienza giuridica come scienza e prima che
venga formulato il problema delle sue categorie, è necessario – egli dice – innanzitutto trattare problemi di dottrina generale del diritto e il rapporto di un
singolo concetto giuridico l’uno all’altro»75. è evidente che Schmitt non può
concordare con l’importanza con la quale Cohen sostiene la necessità di una
scienza giuridica a priori equivalente alla matematica, condividendo l’insofferenza dei giuristi rispetto alla filosofia del diritto coheniana che finirebbe da un
lato con l’invertire mezzo e fine e dall’altro col derivare il sistema giuridico da
un malinteso utilizzo del concetto di azione (Handlungsbegriff).
Pur stando dalla parte dei giusperiti, Schmitt però concorda con Cohen sulla questione della centralità dell’Handlungsbegriff quale concetto principale della scienza giuridica. Tuttavia, ribadisce che «un’esposizione giuridica di questo
Ibid., p. 54 e 60.
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 12.
75 Ibid.
73 74 Tra neokantismo e positivismo giuridico
175
punto centrale, che avrebbe da sola una rilevanza scientifica, manca ancora»76;
infatti – egli continua – «la determinazione delle categorie giuridiche e di una
teoria della scienza giuridica non può avere successo senza una scienza giuridica perfetta; qualora essa faccia sul serio con la sua ‘purezza’, non può progettare in alcun punto una discesa verso le questioni particolari della scienza
del diritto positivo, poiché tale passaggio e discesa sarebbe la più mostruosa di
tutte le gradualità»77.
In questa affermazione è riassunto il senso che la critica schmittiana assume nei confronti del neokantismo giuridico. Detto in altri termini: come può
sussumersi sotto una categoria normativa puramente logica un caso concreto?
E ancora: come si può pensare di potere trattare non un fatto giuridico bensì
un’azione giuridica concreta, muovendo dall’universalità della scienza? Come si
può, insomma, verificare un passaggio, un’armonia prestabilita o anche solo un
legame unitario tra una sfera pura ed una sfera concreta se non premettendo
un’Idea giuridica valevole di per sé?78
È qui, a nostro parere, che risiede l’originalità e la forte discontinuità del
discorso schmittiano rispetto al neokantismo giuridico. Non solo l’aver assunIbid., p. 13. Su ciò cfr. H. Cohen, Etica della volontà pura, cit., pp. 55 e ss.
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 13-14.
78 Questa obiezione schmittiana costituisce il leit motiv di tutta la successiva critica alla
filosofia pura del diritto di Hans Kelsen: «Come può accadere – si chiede Schmitt – che una
quantità di disposizioni positive possa essere ricondotta con il medesimo punto di riferimento
ad un’unità, se si tratta non dell’unità di un sistema di diritto naturale o di una teoria giuridica
generale, ma dell’unità di un ordinamento avente efficacia positiva?» (Id., Teologia politica, cit.,
p. 46). In altre parole: il diritto non perde la sua natura normativa per una puramente autoritativa? E l’unità che il sistema persegue non rimane astratta? Certo, Kelsen potrebbe obiettare
che l’azione, l’effettività delle norme è garantita dalla loro stessa dinamicità, dalla tensionalità
del Sollen la cui natura sanzionatoria produce un effetto sul piano pratico dell’essere, neutralizzando la necessità di un’auctoritas intermedia: infatti, «l’azione giuridica è per definizione
originata da una norma e tendenzialmente incanalantesi in una norma» (A. Catania, Manuale
di teoria generale del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 49). Ma un rigore tecnico che permanga solo all’interno della scienza giuridica, non costituisce di per sé il fondamento dell’efficacia pratica del diritto, poiché le norme giuridiche non si applicano da sole e la coerenza
logica non giustifica l’unità concreta dello Stato, alla quale si riferisce pur sempre ogni costruzione giuridica che vuole dirsi positiva: «Solo da principi sistematici – continua Schmitt –, normativamente conseguenti senza riguardo alla vigenza ‘positiva’, cioè giusti in se stessi, in forza
della loro razionalità o giustezza, si può far derivare un’unità o un ordinamento normativo»
(C. Schmitt, Dottrina della costituzione (1928), trad. it. A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1984, p.
23). A tal proposito, come ha osservato G.A. Di Marco, per Schmitt, a rigore, il tipo di pensiero
normativista, si trova ad essere più vicino al giusnaturalismo che al positivismo giuridico (cfr.
G.A. Di Marco, Thomas Hobbes nel decisionismo giuridico di Carl Schmitt, Guida, Napoli, 1999,
p. 18). Da questo punto di vista, la dottrina giuridica kelseniana appare a Schmitt un controsenso proprio perché, secondo il giurista di Plettenberg, «il pensiero normativistico, quanto
più è puro, tanto più conduce ad una frattura sempre più drastica fra norma e realtà, fra dover
essere e essere, fra regola e comportamento» (C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico (1934),
trad. it. in Id., Le categorie del ‘politico’, cit., p. 256).
76 77 176
Alessio Calabrese
to come problema centrale quello del soggetto giuridico concreto richiede una
soluzione giuridico-pratica e non più puramente filosofica, ma tale operazione risulta possibile soltanto a partire da un metodo normativo che, cosciente
dell’impossibilità di una convergenza tra sfera astratta e sfera effettuale del
diritto, sia capace di legittimare l’azione concreta dello Stato quale unica esecutrice della norma giuridica. «Nella filosofia del diritto l’opposizione tra vita
e scienza è oggi espressa in modo particolarmente chiaro. L’idea che il diritto
non possa essere dedotto dai fatti è molto corrente. Al centro della discussione
si pone al giorno d’oggi il problema del diritto come norma indifferente alla
fattispecie, ma non il problema intorno allo Stato come una realtà (Realität). Al
contrario, l’interesse di questo libro (scil. Der Wert des Staates) verte sul problema dello Stato, mentre i riferimenti al diritto si limitano agli aspetti che conducono a una giusfilosofica definizione di Stato»79.
È evidente che è nella prassi dello Stato, in quanto forma concreta del diritto, che Schmitt vede riflessa, seppur in maniera obliqua, l’idealità astratta della
norma giuridica. In tal modo, osservare la concretezza giuridica non solo non
significa trattare il caso concreto in modo naturalistico, bensì rintracciare in
esso l’universale unità dell’Idea di diritto. Il teorico, il normativo, l’astratto vengono dunque ricompresi nella fatticità del singolo caso concreto in cui il diritto
s’incarna, mentre la forma concreta del diritto, lo Stato, assume «un valore fondante, una fiducia in sé che evidenzia il punto in cui si toccano teoria e prassi,
dal momento che la teoria della prassi trapassa nella prassi della teoria»80. Così,
muovendo dal dato reale e visibile del diritto, il giurista si fa necessariamente
filosofo e riesce a far giocare teoria e prassi giuridica nell’unità di un sistema
scientifico.
È bene ricordare che le riflessioni schmittiane sul neokantismo giuridico
non si fermano qui, procedendo in direzione di una discussione della Theorie
der Rechtswissenschaft di Rudolf Stammler, alla quale vengono dedicate importanti osservazioni81. È noto, infatti, che anche quest’ultimo, nel tentativo di
elaborare una dottrina pura del diritto nel senso trascendentale, riteneva necessario separarla dal suo legame con l’orizzonte metafisico in cui era stata inserita da Kant e in cui restava ancora nelle analisi di Hermann Cohen. Ponendo
il problema di un concetto giuridico puro e formale contro una sua definizione
empirica e positivista, Stammler si rifà alla Critica della ragion pura, distinId., Der Wert des Staates, cit., p. 10.
Ibid., p. 9.
81 Di uno studio approfondito della dottrina giuridica di Stammler ne abbiamo traccia
anche nel diario che Schmitt scriveva in quegli anni (Id., Tagebücher, cit., pp. 73-90).
79 80 Tra neokantismo e positivismo giuridico
177
guendo tra i contenuti materiali della realtà sociale e politica e le condizioni
trascendentali universalmente valide sotto le quali realizzare in generale le rappresentazioni giuridiche. In ogni proposizione giuridica viene così isolato il suo
contenuto materiale e filtrato attraverso il metodo logico-trascendentale che
Kant aveva utilizzato per l’indagine del mondo naturale. Stato, diritto e società,
quindi, non soltanto vengono considerati in analogia con i fenomeni naturali
ma, svincolati da una prospettiva metafisico-morale, perdono per Stammler il
loro contenuto noumenico.
Insomma, secondo il giurista neokantiano, leggere il fenomeno giuridico con
gli occhiali della ragione pura, fa sì che non se ne possa dare una definizione positiva bensì solo critica, dal momento che ogni legame fondativo con le idee della
ragion pratica viene reciso. In tal senso, la scienza del diritto puro stammleriana
reinterpreta il fenomeno giuridico mediante l’ideale critico-gnoseologico kantiano:
il concetto di Stato, quello di diritto e di società ritrovano il loro fondamento non
più sulla normatività dell’etica quanto su quella della logica formale.
Vero è anche che nella seconda parte della sua opera, accanto alla deduzione formale del concetto di diritto, egli fa riemergere l’Idea pura del diritto
come criterio regolativo e orientativo di tutta la sua ricerca. Così, assumendo un significato euristico e metodico, l’Idea del diritto rappresenta, sia il fine
della scienza giuridica, il suo valore, sia il punto in cui Stammler recupera un
rapporto con l’etica, dal momento che il contenuto di tale Idea è pur sempre il
«diritto esatto»82. Tutti i fenomeni giuridici, nella loro riduzione trascendentale
vengono indirizzati, da ultimo, verso un ideale di giustizia che va a corrispondere a ciò che egli chiama «comunità pura» o «diritto naturale a contenuto
variabile»83. In questo modo, salvando la natura formale e ideale insieme di
questo diritto, Stammler ritiene di porsi al riparo da una sua equivalenza empirica con il diritto positivo.
Analizzando la dottrina giuridica stammleriana, Schmitt ritiene che le contraddizioni della posizione del giurista neokantiano non appaiano soltanto alla luce di
una reintroduzione del problema etico, ma sono presenti già nella deduzione tra82 R. Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, a.d.S., Buchandlung des Waisenhauses,
Halle, 1911, p. 113. Nella prima parte della sua opera, coerentemente all’esigenza critica di
fondare una scienza pura del diritto, l’Idea del diritto – ciò che Stammler chiama «diritto
giusto» o «diritto naturale a contenuto variabile» – viene determinata soltanto negativamente
attraverso la legalità e la coercibilità delle regole esteriori e dell’eteronomia. Nella seconda
parte della sua reine Rechtslehre Stammler tuttavia ritiene di poter «veicolare non solo condizioni e oggetti del pensiero (concetti), ma anche valori e fini assoluti facendo leva su un’idea
che appartiene tanto alla ragion pura quanto alla ragion pratica» (C. Galli, Genealogia della
politica, cit., p. 296).
83 R. Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, cit., p. 109.
178
Alessio Calabrese
scendentale del concetto di diritto, dove si produce il fallimento di una definizione
formale di questo come norma del dovere, inteso come un puro «volere vincolante
autodominante e indistruttibile»84. A bene guardare, infatti, se la forma unificante
del diritto è data dalla sua capacità di tenere assieme la maggioranza degli individui, quella autodominante si riferisce al fatto che esso deve rimanere indipendente
rispetto alle loro volontà egoistiche. Dunque, quelle che Stammler presenta come
qualità formali non sono niente altro che realtà fattuali poiché il volere stesso si riferisce ad un’aspirazione umana, assumendo un significato assolutamente empirico.
Ma in questo modo, secondo Schmitt, il diritto non viene pensato da Stammler
come una forma esteriore, ovvero come la «cornice protettiva-funzionale dell’economia sociale»85? E, conseguenza di ciò, non è forse che la normatività del diritto
positivo non dipende più dalla sovranità statale ma dall’essersi im-posta sui singoli
in modo «psicologicamente efficace»86? Detto in altri termini: tale dottrina giuridica,
per Schmitt, lasciando indipendenti diritto giusto e diritto positivo, corre il rischio
di attribuire solo alla capacità coercitiva dello Stato il nesso normativo tra i due87.
Infatti, il diritto in quanto volere vincolante si riduce alla sola efficacia positiva; non essendo esso indipendente dalla realtà fattuale, non costituisce neanche «un’essenza universale (Gesamtwesen) sopra il singolo ma – afferma Schmitt – solo la condizione logica della cooperazione di più voleri vincolanti, che
perciò viene determinato come ‘mezzo messo al sevizio dell’uno e dell’altro’»88.
Ma non solo: il diritto per Stammler diventa un mezzo che deve garantire lo
sviluppo dei rapporti tra gli uomini in quanto ragionevoli; un mezzo rispetto al
quale la morale ritorna kantianamente ad essere la perfezione e il suo compimento ultimo89.
A ben guardare, in Stammler, l’Idea del diritto finisce così col riassumere il concetto kantiano del dovere, a non mettere in discussione l’unità tra etica e diritto e,
Ibid.
G. Hohenauer, Il neokantismo e i suoi limiti come filosofia sociale e giuridica, in E. Kaufmann, W. Sauer, G. Hohenauer, Neokantismo e diritto nella lotta per Weimar, a cura di R.
Miccú, ESI, Napoli, 1992, p. 132.
86 Ibid., p. 135.
87 R. Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, cit., p. 114. E. Kaufmann nota che Stammler «salva sì la validità normativa assoluta dei principi formali, ma fa dipendere la vera decisione di tutti i problemi giuridici dalla pura positività del diritto storico, senza però rendere
comprensibile come questo possa svolgere la funzione destinata alla comunità particolare»
(E. Kaufmann, Critica della filosofia neokantiana, cit., p. 16). Quest’ultima è uno «schema formale» che deve fornire una materia concreta ai principi astratti del diritto esatto; ma «tutte
queste forme e norme sono vuote e nessun ponte conduce da loro in basso, verso l’essere»
(ibid., p. 13).
88 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 61; cfr. Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, cit., p. 75.
89 R. Stammler, Die Lehre von dem richtigen Rechte, Guttentag, Berlin, 1902, p. 87.
84 85 Tra neokantismo e positivismo giuridico
179
per questo motivo, a dare una giustificazione normativa del diritto sulla base della
sua efficacia pratica. Quest’ultimo punto viene sottolineato da Schmitt quando afferma che per Stammler la differenza tra l’ordine interno della moralità e quello
esteriore del diritto riguarda il fatto che il primo «si riferisce al volere desiderante
(wünschende Wollen) dei singoli individui pensanti, mentre il secondo concerne il
volere effettivo (Wirkende Wollen), legando i fini di uomini diversi nel raggiungimento di un fine comune»90. È per questo motivo che Stammler – e in generale le
correnti neokantiane – non riescono ad andare oltre una definizione meramente
gnoseologica della scienza giuridica: perché la purezza, a rigore, dovrebbe essere
dapprima ricercata nei confronti della morale.
Al contrario, per Schmitt, la normatività e l’indipendenza del fenomeno giuridico non sono da ricercarsi muovendo dall’ambito teoretico: è, invece, sul
piano della ragione pratica che va formalizzata la sua separazione dalla morale, decostruendo il principio kantiano della priorità della norma etica su quella
giuridica. In tal senso, come abbiamo più volte ribadito, per l’autore di Der Wert
des Staates, la condizione necessaria per cui il diritto sia indipendente dai fatti –
cioè, il punto a partire dal quale ci si può opporre al positivismo giuridico – sta
nella discussione del principio kantiano dell’unicità della ragione pratica.
Simile critica Schmitt la rivolge anche alla concezione giuridica di Paul Natorp. Se è vero infatti che a quest’ultimo non sfuggono le difficoltà della Teoria
della scienza giuridica di Stammler, e se è vero che anch’egli tiene fermo il punto
secondo cui l’eteronomia delle norme giuridiche deve chiarirsi sull’autonomia
di quelle etiche, altrettanto vero è, a parere di Schmitt, che Natorp traduce la
contrapposizione stammleriana tra interiorità e esteriorità in quella tra autonomia e eteronomia, «due diverse direzioni della stessa originaria legislazione»91.
Per il filosofo marburghese, infatti, come in un gioco di specchi, diritto e morale si rimandano a vicenda: «La moralità tende dall’autonomia all’eteronomia
del diritto come il punto centrale del cerchio alla periferia mentre il diritto,
imboccando il cammino opposto, (tende) dall’eteronomia all’autonomia della
moralità»92.
Senza presupporre un’etica che funga da punto centrale di valore rispetto
alla sfera esterna e periferica del diritto, un simile passaggio graduale prospettato da Natorp appare a Schmitt molto problemtatico. Solo intesa in tal senso
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 61-62.
Ibid., p. 64. Schmitt rimanda a P. Natorp, Recht und Sittlichkeit, in «Kantstudien», vol.
XVIII, 1913, pp. 1 e ss.
92 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 64.
90 91 180
Alessio Calabrese
la legislazione giuridica «crea le condizioni esterne della moralità interna»93,
ovvero procura «all’uomo sicurezza necessaria per (realizzare) i progetti (Dinge) più importanti»94. In questo modo però, lo status del diritto e di conseguenza anche l’azione effettuale dello Stato vengono ridotti semplicemente alla loro
funzione di polizia. Se si parte dall’unicità della ragion pratica, il diritto finisce
per essere una mera costrizione su cui basare l’esigenza di sicurezza delle società liberali.
Insomma, le ricerche di Cohen, Stammler e Natorp – nel tentativo di purificazione della Rechtslehre di Kant dai suoi presupposti metafisici – falliscono il
loro scopo, secondo Schmitt, proprio perché continuano a tenere fermo il presupposto kantiano per cui l’unità della legislazione etica e giuridica scaturisce
dalla medesima ragione pratica.
Scorgendo, invece, la crisi della ragione moderna – sia nel senso di una mediazione dialettica, sia nel suo uso trascendentale – Schmitt ritiene che il diritto
vada pensato autonomamente dalla legislazione morale. L’esigenza di una loro
separazione «domina molto di più le visioni di molti secoli e dovrebbe lasciarsi
facilmente dedurre già dalla differenza tra libertà esteriore e libertà interiore e
dall’impossibilità di ricondurre sotto un unico concetto il visibile e l’invisibile, il
temporale e l’eterno»95. L’impossibilità di «ricondurre al medesimo principio diritto e moralità»96, spinge il giurista di Plettenberg ad estremizzare la dicotomia
tra essere e dover essere, portandolo ben oltre le ambigue conclusioni alle quali
era giunto il neokantismo giuridico. Pur inserendosi nella sua scia, il normativismo schmittiano si allontana dunque da questo nel sostenere l’insuperabilità
della frattura tra diritto e moralità97. Molto chiare in questo senso le seguenti
parole: «L’eteronomia non si lascia in alcun modo assimilare all’autonomia,
l’esteriorità all’interiorità, il niente non si chiarifica sul qualcosa, il concreto
non ‘tende’ all’astratto. Nessuna trasposizione, nessuna figura di stile aiuta a
superare ciò che è inconciliabile. Il singolo al quale si rivolge l’etica kantiana, e
i molti che giocano un ruolo nel diritto, non possono essere ricondotti a forza
sotto un concetto unitario superiore, neanche con l’aiuto di un solenne volere
che non appartiene a nessuna coscienza, o di un confuso concetto di fine che
ovunque nella giurisprudenza, e in particolar modo nell’ermeneutica giuridica,
Ibid., p. 65.
Ibid.
95 Ibid., p. 11.
96 Ibid., p. 67.
97 H.R. Otten, Der Sinn der Einheit im Recht. Grundpositionen Carl Schmitts, Gustav Radbruchs, und Hans Kelsens, cit., p. 35.
93 94 Tra neokantismo e positivismo giuridico
181
ha causato danni»98. Poiché il diritto è essenzialmente norma, il suo rapporto
con l’etica non risulta men che mai essere quello di una premessa esterna, in
quanto «una norma non può farsi esecutrice di un’altra, né può farsi spada nelle mani di un’altra norma»99. Così facendo, infatti, si ammetterebbe che essa
abbia un movimento, che sia capace di suscitare un’influenza anche solo di rinvio su un’altra norma (etica o giuridica che sia); ma il movimento reale appartiene alla sfera del concreto non a quella astratta, per cui nel riconoscere una
«premessa esterna» del diritto alla moralità si opera con un concetto di diritto
equivalente a quello di Stato.
Tale confusione concettuale si trova a fondamento della «teoria delle due
spade» contro la quale Schmitt conduce una feroce polemica sostenendo che
come l’opposizione di diritto e moralità non è da ricondurre a quella tra «autorità (Gewalt) e norma», così lo Stato (preso nel suo concetto normativo) viene
ad essere «più di qualcosa che pone ‘condizioni esterne’, poiché è tutto assorbito
nel diritto»100.
Allora, una volta ribadita l’autonomia del diritto dalla sfera etica, è in questa
direzione che bisogna muoversi per un approccio normativo al problema della
sua visibilità nel mondo, ovvero al problema dello Stato. È quindi nella sfera
pratica del diritto che la razionalità del fenomeno giuridico riacquista senso;
insomma, è soltanto nel taglio operato dalla decisione di un soggetto concreto,
lo Stato, che esso s’innalza dalla pura empiria alla razionalità del reale.
Decisione e ethos giuridico dello Stato.
Abbiamo visto che nonostante non si dia alcuna armonia prestabilita tra
Norm e Faktizität, la locuzione schmittiana «diritto naturale senza naturalismo» esprime nello stesso tempo sia l’irriducibilità tra l’ordinamento originario
e quello positivo, sia il loro reciproco co-appartenersi all’interno del fenomeno
giuridico. Si è inoltre ribadita più volte l’autonomia del diritto rispetto alla moralità, in modo da non far risultare, come conseguenza di una loro unione, la
posizione dello Stato identica a quella di un potere cieco. Riguardo a quest’ultima questione è possibile ritrovare un’assonanza tra la concezione schmittiana
e quella di Kant poiché in quest’ultima, sebbene il rapporto di derivazione della
legge morale rispetto all’individuo si mostra invertito, il singolo resta l’unico deC. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 66.
Ibid., p. 68.
100 Ibid., p. 68 (il corsivo è mio).
98 99 182
Alessio Calabrese
stinatario di tale legge; in ciò la filosofia pratica kantiana si inscrive a pieno titolo nella tradizione liberale dello Stato di diritto, il cui problema principale resta
l’autonomia del singolo di fronte all’abuso di potere della macchina statale.
Tuttavia le assonanze tra i due pensatori tedeschi si fermano qui, come mostra la seguente citazione: «Esiste un’autonomia nel diritto – dice Schmitt – ma
il suo titolare è solo lo Stato in quanto è l’unico soggetto dell’ethos giuridico
(…). L’autonomia significa nel diritto qualcosa di diverso che nell’etica in cui
l’individuo è visto come suo proprietario. Portare quest’ultimo tipo di autonomia a paragone con quella del diritto significa iniziare da false antitesi, quella,
cioè, che esiste tra diritto e individuo o quella più originaria tra Stato e individuo. Più correttamente, invece, l’individuo deve essere tagliato fuori e soltanto diritto e Stato devono essere contrapposti. Nessun individuo ha autonomia
nello Stato»101.
Come si vede, diversamente dalla dottrina giuridica di Kant in cui il singolo
è l’unica controparte della legge, il normativismo schmittiano è caratterizzato
dal predominio dell’ordinamento oggettivo, sia originario, sia positivo. «Soggetto giuridico» propriamente è solo lo Stato poiché esso è legato direttamente
al diritto; di fronte alla grandezza dello Stato, l’individuo appare come una fattualità empirica che sta in rapporto al diritto solo indirettamente. In tal senso,
l’individuo scorge nell’esistenza dello Stato un ostacolo, una prima contrapposizione che si dà nei termini di un’organizzazione sovrapersonale. Di fronte alla
giuridicità dello Stato, «il singolo individuo concreto scompare (…) poiché lo
Stato o è un servo dell’individuo o un servo del diritto. Dato che solo quest’ultima possibilità corrisponde al vero, lo Stato precede l’individuo come il diritto
è anteriore allo Stato e, come la continuità dello Stato risulta solo dal diritto,
così la continuità dell’individuo che vive nello Stato deriva soltanto dallo Stato
stesso»102.
È evidente che per Schmitt, contrariamente alle concezioni liberali di Staatstheorie, lo Stato non viene inteso come un potere che si legittima in base alla
salvaguardia dei diritti individuali preesistenti; se così fosse, infatti, si tratterebbe di far dipendere la sua dignità da un sostrato empirico, consistente soprattutto nella protezione di diritti di proprietà, cioè di interessi inerenti alla
soggettività del singolo quale essere di natura. Dal momento che il diritto, in
101 Ibid., p. 101 (il corsivo è mio). Secondo Schmitt, non è solo la filosofia trascendentale
kantiana che muove da «false antitesi» ma anche la dialettica hegeliana quando ritiene che il
diritto sia l’unità tra la regola impersonale e l’individuo empirico (cfr. ibid., p. 86).
102 Ibid., p. 85.
Tra neokantismo e positivismo giuridico
183
quanto norma astratta, «non conosce generalmente alcun singolo»103, dell’annientamento o della protezione «della libertà dell’individuo si può parlare solo
nel senso in cui lo Stato non viene inteso come fenomeno del pensiero giuridico, ma come complesso di potere»104.
Dunque, soltanto al soggetto giuridico per eccellenza è consentita una reale autonomia giuridica, non al singolo la cui autonomia può esistere solo in
senso etico-religioso: lo Stato – conferma Schmitt – è perciò «l’unico soggetto
dell’ethos giuridico, l’unico che abbia in senso eminente un dovere di fronte al
diritto; invece l’individuo concreto viene costretto dallo Stato e il suo dovere,
come la sua legittimità, sono solo il riflesso di una costrizione»105. L’unica e reale opposizione per la concezione normativa schmitiana è, quindi, quella tra il
diritto originario e quello posto dallo Stato.
Ma ciò vuol forse dire che per Schmitt l’individuo empirico come tale è «fuori discussione totalmente»106?
In un certo senso no poiché pur non essendo naturalmente un soggetto di
diritto, egli può tuttavia diventarlo dal momento che «la soggettività è un compito, una conquista che si raggiunge attraverso il trascendimento del sé in una
sfera ‘sovraindividuale’»107. Il singolo, cioè, non rimane passivo di fronte allo
Stato, ma può diventare soggetto giuridico nella misura in cui adempie il compito di rispettare le leggi positive, manifestazioni del diritto stesso. Insomma,
nell’osservare il diritto positivo, il singolo s’inscrive nel ritmo normativo dettato
dal diritto e mediato dallo Stato e si innalza in una sfera in cui emergono le sue
qualità di persona. Certamente, sono sempre le idee normative a dominare sulle qualità empiriche degli individui; ad esempio, il conferimento di un incarico
istituzionale trasforma le caratteristiche personali dell’individuo e le vincola
all’osservanza di qualcosa di più alto. In altre parole, di fronte all’ufficio, la
soggettività empirica si innalza alla sfera dell’Idea, e attraverso la finzione della
«personalità giuridica», garantisce «l’antinaturalismo del diritto»108: «Ogni va103 Ibid., p. 99. Contrariamente all’empirismo liberale e facendo suo il razionalismo normativo kantiano, Schmitt ritiene che l’individuo riceve tutto il suo valore non dalla natura ma
da quello che la legge stabilisce (cfr. ibid., p. 98); su ciò cfr. I. Kant, Fondazione della metafisica
dei costumi, a cura di P. Chiodi, TEA, Milano, 1997, p. 55.
104 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 99.
105 Ibid., p. 85.
106 Ibid., p. 86.
107 M. Nicoletti, Alle radici della teologia politica di Carl Schmitt. Gli scritti giovanili (19101917), in «ISIG», 10, Trento, 1984, p. 291.
108 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 103. Scissa dal legame con il diritto naturale
originario anche l’individualità del sovrano assoluto «non è al di sopra del diritto più di quanto
lo sia al di sopra della grammatica» (ibid., p. 95); infatti, «la dignità che egli esige e che gli è
attribuita non vale che per la sua funzione e non per l’uomo mortale. Grazie al tipo di somi-
184
Alessio Calabrese
lore – scrive Schmitt – che può essere connesso con il singolo uomo sta nella
dedizione al ritmo sovraindividuale di una legalità»109.
Dunque, il significato del singolo, la sua unità di persona, emerge solo da una
costruzione teorico-normativa e non da una empirico-causale, poiché «il criterio dell’individualità sta in un valore che è dedotto da una norma»110.
Ora, se origine e genesi dello Stato non dipendono dall’individuo empirico
ma, ancora una volta, è lo Stato a fare di ogni singolo uomo una «costruzione»111,
risulta chiaro che a Schmitt non interessa la realtà fattuale dello Stato stesso.
È per questo motivo che egli critica le teorie giuridiche di matrice contrattualistica, rinvenendo il loro errore non tanto nella costruzione del patto, quanto
piuttosto nell’accettazione di «individui empirici come parti del patto»112.
In particolare la critica schmittiana si rivolge contro le concezioni giuridiche
scaturite dagli ideali della Rivoluzione: contro quelle concezioni, cioè, che pur rifacendosi al concetto di «volontà generale» di Rousseau, contengono una confusione
tra jus e factum. Per il giurista tedesco, invece, gli individui empirici non sempre
sono capaci di essere soggetti di diritto: essi lo sono solo quando la loro volontà
non risulta viziata ma si conforma ad un ideale razionale e virtuoso. Emblematico, in tal senso, è il comportamento di Robespierre il cui ricorso alla sovranità
popolare intesa come «volontà generale» non venne fatto valere quando si trattò
di decidere della sorte di Luigi XVI; il voto popolare, infatti, non fu ammesso con
la scusante che la repubblica rappresentava il valore e la «virtù» suprema rispetto
alla quale nessuna maggioranza avrebbe potuto esprimersi in modo contrario. È
evidente che per Schmitt a risultare fondamentale per la singolarità resta sempre
il legame ad un mondo di valori che come «ordinamento giuridico» legittima non
glianza divina che il monarca assoluto ha in quanto ‘legge vivente’, egli è sottomesso al diritto,
come il Dio della teologia la cui volontà onnipotente non può volere nulla di male e di non
razionale» (ibid., p. 96). Di natura analoga è anche la sovranità papalina il cui ufficio infallibile, pur trascendendo tutto il diritto positivo, mantiene un esercizio limitato dal fatto che il
vescovo di Roma è solo «il servo dei servi di Dio» (ibid., p. 95, in nota).
109 Ibid., p. 93.
110 Ibid., p. 102.
111 Ibid., p. 93. Da questo punto di vista, questa affermazione ricalca la forte vicinanza tra
la filosofia del diritto hegeliana e la filosofia dello Stato schmittiana. Hegel, infatti, sostiene
che «giacché lo stato è spirito oggettivo, l’individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità soltanto in quanto è un membro del medesimo» (G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto
(1821), cit., p. 196, § 258). Per l’appunto, H. Hofmann ha sostenuto che sia stata l’influenza
della filosofia dello Stato hegeliana ad indurre Schmitt a vedere nel soggetto statale «il punto
di concrezione finale del diritto» (H. Hofmann, Legittimità contro legalità, cit., p. 87). Di conseguenza, lo stesso Hofmann è incline a ritenere che la concezione giovanile schmittiana sia
più una forma di «decisionismo teorico-giuridico» che di normativismo in senso proprio (cfr.
ibid., p. 57).
112 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 107.
Tra neokantismo e positivismo giuridico
185
tanto storicamente quanto normativamente la prassi dell’istituzione statale113. Questo significa che lo Stato, pur costituendo la forma mondana del diritto, è in primo
luogo una realtà concettuale di tipo normativo, un’ Idea, la cui relazione al diritto
non può mai essere esperita in termini empirico-causali114. Infatti, il permanere
della frattura tra norma e fattualità esplicita la discontinuità tra scienza giuridica
e scienza politica, rendendo possibile un esame del modo in cui lo Stato, in quanto
realtà ideale e normativa, si attualizza nel reale115. Tuttavia e ancora una volta, tale
critica razionale del potere statale viene da Schmitt ammessa non sulla base degli
interessi dell’individuo, quanto a partire dall’adempimento del dovere che lo Stato
ha nei confronti del diritto stesso.
Da quanto detto emerge la necessità che lo Stato abbia come suo compito l’unione dei due lati dell’origine, vale a dire che venga trasposto nell’idealità e che quindi,
in quanto «concetto», divenga una costruzione stessa del diritto e non un «oggetto
concreto della realtà»116. Perciò, la categoria del «compito» dà risalto alla posizione
particolare che lo Stato intrattiene nei confronti del diritto, poiché nell’attualizzazione della norma giuridica lo Stato perde la sua connotazione empirica avvicinandosi al mondo della normatività astratta: lo Stato – afferma Schmitt – «secondo la
sua Idea diventa portatore di un compito, la sua grandezza risiede nel fatto che è
nulla più di questo compito, la sua dignità deriva dal diritto e consiste nell’esclusività con la quale esso è afferrato e compreso dal diritto. Dominato dal diritto fin
nell’ultimo elemento, lo Stato può volere solo il diritto. Rinuncerebbe e negherebbe se stesso, se volesse richiamarsi alla pura e semplice forza, dal momento che vi
sarebbe una contraddizione totale nel poggiarsi ad un’autorità, ad una situazione
concreta, anziché ad una norma»117.
Così, pur non poggiandosi sul diritto come suo fondamento ontologico, lo
Stato, attraverso la categoria del «compito», si innalza nella sfera spirituale del
diritto, ne accoglie in sé l’ethos, la cui realizzazione lo porta ad essere non più
un meccanismo che vede i suoi scopi posti dall’esterno, bensì l’unica forma visibile dell’Idea di diritto. Infatti, per il giurista tedesco lo Stato deve essere definito a partire dal diritto poiché soltanto questo è «il creatore dello Stato»118
Tuttavia, secondo Schmitt, è bene non confondere la natura etica del diritto con una pretesa morale delle norme giuridiche: infatti, la componente
«etica» dello Stato consiste solo nella scelta, nella decisione per il compiIbid., pp. 105 e ss. .
Ibid., p. 39.
115 Ibid., p. 97.
116 Ibid., p. 43.
117 Ibid., p. 54.
118 Ibid., p. 46.
113 114 186
Alessio Calabrese
to attraverso il quale esso si legittima come Stato di diritto. In tal modo,
«Schmitt individua nello Stato soltanto l’azione politica che fa ‘precipitare’
l’Idea giuridica nella pratica, non la coincidenza, la mediazione compiuta,
fra statualità e diritto»119. Insomma, il concetto di Stato deve il suo prestigio
non alla sua massima potenza fattuale, ma al fatto che «viene coinvolto nel
ritmo di valori», dall’essere cioè «tributario della sua dignità ad una legalità che non è da esso originata, ma dalla quale al contrario deriva la sua
autorità»120. Dal canto suo, fondamento dell’autorità e dell’unità dello Stato,
la norma giuridica originaria precede la realtà empirica e la in-forma: il diritto, afferma Schmitt con un’espressione agostiniana, è per lo Stato «origo,
informatio, beatitudo»121. Per questo motivo un atto statale non è immediatamente atto giuridico, anche quando si tratta dell’espressione di una volontà popolare o semplicemente rappresentativa che, lo ribadiamo, sarebbe
costituita sempre da singoli individui i quali, esprimendo a maggioranza
la loro volontà, non per questo vengono ritenuti ancora soggetti di diritto,
«persone» nel senso di cittadini. In altre parole, la circolarità tipica delle
concezioni democratico-liberali per cui il legislatore è nello stesso tempo
origine positiva e destinatario reale della legge che produce e alla quale si
sottopone, può essere un indizio di valore, una finzione giuridica, ma mai il
criterio fondativo dell’unità e dell’autorità dello Stato122.
Schmitt rovescia, quindi, la concezione positivista secondo cui lo Stato sarebbe un complesso di potere sovrano che emana legalmente diritto: «solo quella che deriva dal diritto può essere massima autorità (Gewalt) (poiché) il diritto
non è nello Stato, ma lo Stato è nel diritto»123.
C. Galli, Genealogia della politica, cit., p. 319.
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 46.
121 Ibid., p. 53 (corsivi miei). L’espressione è tratta da Agostino d’Ippona, De Civitate Dei,
Libro XI, capitolo XXIV.
122 Schmitt riconosce il debito nei confronti della Filosofia del come se di Hans Vaihinger
con queste parole: «Ma ancora un altro risultato del libro di Vaihinger è di valore attuale per i
giuristi. Oggigiorno la volontà della legge viene generalmente considerata come fondamentalmente misurabile per l’interpretazione di una legge e decisiva per la giustezza di una sentenza.
Tanto per l’interpretazione estensiva, quanto per l’applicazione analogica ci si richiama alla
volontà della legge e si conferma il risultato dell’interpretazione con le parole: questa è la vera
(wirkliche) volontà della legge. Probabilmente non si tratta altro che di indicare come volontà
della legge quella imposta al giurista in immutabile determinatezza (…). Il metodo è questo: si
considera il risultato dell’interpretazione come se fosse la volontà della legge. Ne risulta perciò
la tendenza a considerare come realtà il pensato. Dal momento che si fa un’arbitraria e falsa
ipotesi per valutare la realtà effettiva, ma allo stesso tempo si deve rimanere sempre coscienti
di quest’arbitrarietà, si origina uno ‘scomodo stato di tensione’ dell’animo che si cerca di rimuovere attribuendo realtà (Realität) al pensato» (C. Schmitt, Finzioni giuridiche, cit., p. 67).
123 Id., Der Wert des Staates, cit., p. 48.
119 120 Tra neokantismo e positivismo giuridico
187
Come si vede, questa metodologia normativa conduce a considerare necessario il primato del diritto perché si possa giungere ad una definizione giuridica
di Stato che sia contrapposta ad una sociologico-politica, in cui esso si presenta
sempre e soltanto come stärkste Gewalt di fatto. Traendo invece la sua Bewertung dall’ordinamento normativo originario, lo Stato viene colto come höchste
Gewalt di diritto, ovvero come una «volontà compresa in un’unità ragionevole
(…), (come) una continuità»124.
Ha dunque ben ragione Olivier Beaud nel riscontrare nella produzione giovanile schmittiana una concezione istituzionalistica del diritto, una prima traccia della successiva e più compiuta elaborazione del pensiero dell’ordinamento
concreto degli anni ’30125; una concezione in cui il concetto di Rechtsstaat sta a
indicare «uno Stato che vuole diventare tutto funzione del diritto e, malgrado
esso stesso formuli anche le norme a cui si assoggetta, non le fa passare come
norme giuridiche soltanto perché le pronuncia»126. Se il diritto deve precedere
lo Stato ed essi vengono messi in relazione normativamente, allora lo Stato non
può che essere il servitore del diritto. E in quanto deve la sua legittimità solo
ad una norma di riferimento, ad un valore meta-statale, diventa esso stesso una
costruzione ideale e normativa che si innalza al di sopra della realtà empirica
e fattuale del potere. Così, il valore giuridico delle norme positive non proviene
dal fatto che lo Stato le certifica e pronuncia, ma dal riconoscimento che esse, in
se stesse, sono già diritto. Ciò significa, di nuovo, che una «concezione del diritto che scorge la fonte giuridica solo nella volontà dello Stato, non può spiegare
un tale processo (scil. di legittimazione) e lo deve ignorare per forza, poiché la
volontà e la sua esteriorità come legge diventa semplicemente un fatto»127.
Naturalmente il problema è molto più complesso poiché Schmitt sa bene
che lo Stato, di per sé, è pur sempre una realtà che, a differenza del diritto, opera nel mondo come un soggetto reale al quale appartengono volontà e imperatività. Insomma, nell’intento di esercitare «un’azione sull’essere nel senso delle
norme giuridiche»128, lo Stato si comporta come un potere effettivo che ha nei
confronti del diritto «una posizione del tutto analoga a quella che il concetto
di Dio – scaturito dalla necessità di una realizzazione della morale nel mondo
reale – assume riguardo all’etica»129.
Ibid., p. 48 (il corsivo è mio).
Cfr. O. Beaud, Diritto naturale e diritto positivo negli scritti giuridici giovanili di Carl
Schmitt, cit., p. 97.
126 C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., p. 50.
127 Ibid., pp. 50-51.
128 Ibid., p. 38.
129 Ibid., p. 55.
124 125 188
Alessio Calabrese
Sospeso sull’abisso che separa pensiero ed essere, lo Stato accoglie in sé quei
tratti caratteristici che nella Rechtslehre kantiana costituivano l’essenza del concetto di diritto. Schmitt ritiene perciò che la capacità coercitiva o la semplice
tendenza alla costrizione e alla forza, come anche l’obbligazione, siano effetti
reali sull’essere fattuale, i quali con il mondo della normatività astratta non
hanno niente a che fare: «per contenuto, forma e giustezza della norma giuridica – egli afferma – è indifferente come effettivamente appare nel mondo»130.
Pertanto, l’atto con cui la soggettività concreta dello Stato rende vigente il
diritto originario è una decisione il cui contenuto, proprio perché posto da un
soggetto concreto, non è determinabile attraverso un criterio logico-formale
ma deriva, invece, dalla necessità di realizzazione del diritto: nel porre in atto
una proposizione giuridica, lo Stato, decidendo, fa trapassare l’astratto contenuto della norma nella sfera concreta dei fenomeni.
Ora, in questo passaggio, non vi è una piena reversibilità tra i due poli, poiché, nonostante lo Stato resti tutto ancorato al diritto originario, esso introduce
pur sempre un elemento empirico nella norma giuridica, la quale subisce con
ciò una specifica modificazione: «lo Stato – dice Schmitt – (essendo) il mediatore del diritto, entra agendo nel mondo e vi si deve muovere secondo il suo
meccanismo di mezzo e fine. Nello stesso istante in cui esso utilizza il mondo
empirico, per farne qualcosa di determinato, questo reagisce su di lui con la forza, come il materiale sull’artista e in maniera simile alle impronte che i servitori
lasciano sui padroni»131.
Qui il giurista tedesco afferma con chiarezza che il diritto positivo viene inserito nella rete dei rapporti fattuali e per questo esso, come lo Stato stesso, è
soggetto alle leggi della temporalità. Insomma, l’Idea giuridica incarnata nella
rappresentazione statale viene costretta a seguire il meccanismo del mezzo e
del fine e dunque non si realizza mai come perfettamente giusta. Questo il motivo per cui Schmitt legge l’importanza che assume l’atto di decisione sovrana
dello Stato per il concetto di Verwirchlichung del diritto, in analogia al problema cristiano dell’impossibilità di ottenere una giustizia terrena che sia anche
pienamente compiuta: «La rinuncia – egli dice – ad una giustizia a-temporale e
la ricezione di un momento di indifferenza contenutistica sono la conseguenza
dell’enanthropesis (scil. incarnazione) del diritto, la vittima che deve essere sacrificata perché si possa venire a patti con le forze del mondo fenomenico reale.
Il precetto ‘ama il prossimo tuo’ non è una legge positiva né può mai diventarlo.
130 131 Ibid., p. 56 (il corsivo è mio).
Ibid., p. 74 (il corsivo è mio).
Tra neokantismo e positivismo giuridico
189
Se degli uomini capaci e virtuosi riescono, per un dato periodo, a trasformarlo
in un criterio di legislazione statuale, allora esso diventa un articolo di legge e
penetra in un’altra sfera»132.
L’ambito del diritto viene così per Schmitt a scindersi in un diritto positivo
e uno originario: il primo, deve all’autonomia decisionale dello Stato la sua realizzazione mondana; il secondo è il modello a cui l’azione decisiva dello Stato
deve pur sempre conformarsi. «Perciò – continua Schmitt – è necessario che
in ogni legge positiva questo momento del mero essere stabilito giunga a validità, in base al fatto che, in talune circostanze, è più importante che qualche
cosa diventi determinazione positiva, qualunque ne sia il contenuto concreto.
Questa indifferenza contenutistica – e con ciò è dato il collegamento con le argomentazioni della mia trattazione Gesetz und Urteil – si origina dallo sforzo di
realizzazione da parte dello Stato»133.
Insomma, questo processo di secolarizzazione dell’Idea giuridica ha come
sua necessità immanente la realizzazione di un ordine concreto; ciò significa
che il diritto, per Schmitt, trova la sua ragion d’essere solo nella positività della
realtà effettuale, ovvero nella visibilità della forma rappresentativa di esso134.
Da quanto detto sin qui è ormai chiaro che la forma giuridica schmittiana
non può essere un risultato o un presupposto di una scienza pura come in Kelsen, bensì è l’atto decisivo di un soggetto concreto che rende visibile (Sichtbarmachung) l’invisibilità di un diritto non posto, originario135. Perciò, l’aver isolato e posto come fondamentale il problema della definizione giuridico-formale
del caso concreto, porta Schmitt a riflettere sulla pubblicità del diritto: il decidere, infatti, presupponendo sempre una volontà concreta, pone in modo forte la
discontinuità tra istituzioni empiriche e principi a priori della ragione giuridica
e consente di inquadrare correttamente il problema della forma giuridica in
una prospettiva normativa. A tal proposito – utilizzando le parole di H. Ball – si
può affermare che già il giovane Schmitt abbia intuito quanto «forse la decisione comprend[a] il problema della forma in generale»136.
Ibid., p. 80.
Ibid., p. 79.
134 Esempio di «tipica purezza» e modello di questo «processo di secolarizzazione» dell’Idea
giuridica è per Schmitt, nuovamente, la Chiesa di Roma (ibid., pp. 81 e ss.).
135 Scrive in proposito G. Duso: «L’agire rappresentativo comporta il rapporto con ciò che
non è empiricamente presente (…). è proprio nella confutazione della possibilità di intendere
il piano fattuale e empirico come effettivamente reale (wirklich), e dunque nella comprensione
della necessaria implicazione dell’idea per poter parlare di realtà, che emerge come indispensabile il concetto di decisione» (G. Duso, La logica del potere, cit., pp. 198-199).
136 H. Ball, La teologia politica di Carl Schmitt, cit., p. 104.
132 133 190
Alessio Calabrese
Per concludere, l’importanza della riflessione giovanile schmittiana sta allora nel fatto che sono le pagine di Der Wert des Staates und die Bedeutung des
Einzelnen a fare emergere per la prima volta il nesso tra soggetto, decisione e
forma – nesso questo che costituisce l’asse portante di tutta la problematica intorno al decisionismo giuridico degli anni ’20. Detto altrimenti, Schmitt si rende conto, quasi dieci anni prima della pubblicazione della Teologia Politica, che
la posta in gioco, per quanto riguarda il diritto, significa la questione della sua
forma concreta nel mondo. Rielaborando il dualismo tra pensiero e essere che
caratterizza la specificità del mondo moderno e prevedendo il fallimento di una
sua possibile risoluzione razionale, il giurista tedesco afferma che «nelle epoche
della mediazione il mezzo diventa, per gli uomini, l’essenza, lo Stato diviene la
cosa più importante, ed essi non conoscono più altro diritto al di fuori da quello
mediato dallo Stato»137.
Tuttavia, il tentativo di una definizione giusnormativa dello Stato138 perseguito qualche mese prima dello scoppio della Grande Guerra non regge alla disfatta dello Jus publicum europaeum basato sulla centralità degli Stati sovrani.
Da questo punto di vista, Der Wert des Staates può essere letto come una metafora inconscia del salvataggio e della fine dell’ordine mondiale eurocentrico: con
esso, di conseguenza, Schmitt si congeda definitivamente da un tipo di pensiero
normativistico per arrischiarsi nell’orizzonte teorico e incommensurabile del
Politico.
C. Schmitt, Der Wert des Staates, cit., pp. 108-109 (il corsivo è mio).
K. Löwith osserva che nello scritto Der Wert des Staates «Schmitt sostiene ancora una
concezione dell’onnipotenza dello Stato estremamente giuridico-normativa» (K. Löwith, Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt (1935), in Id., Critica dell’esistenza storica, trad. it. A. L.
Künkler Giavotto, Morano, Napoli, 1967, p. 136, nota 61, il corsivo è mio).
137 138 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
191
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
Note e osservazioni su due delle più recenti posizioni intorno a un dibattito classico
Memoria di ANTONELLA MUZZUPAPPA
presentata dal socio naz. corr. GIUSEPPE ANTONIO DI MARCO
(Seduta del 17 dicembre 2009)
Abstract. This paper is devoted to one of the most discussed issues of Karl Marx’s
critical political economy. It deals with the problem of transforming values into production prices and with the critical debate on the subject. The work provides an analysis of
the transformation as it is exposed by Marx in the third volume of Capital and presents
the first and most radical criticisms to that approach, raised by Böhm-Bawerk and Bortkiewicz. Finally, it discusses two of the most important positions in the contemporary
debate on the issue. The first one is the Temporal Single-System Interpretation, the second
one is the neue Marx-Lektüre, particularly that of Michael Heinrich and his «monetary
theory of value».
1. Introduzione1
Tema del presente lavoro è la trasformazione dei valori in prezzi di produzione descritta da Marx nel Terzo libro del Capitale. Si tratta di uno dei problemi centrali della critica marxiana dell’economia politica e di una delle questioni
più discusse dai critici. Il dibattito sulla trasformazione, sviluppatosi dopo la
pubblicazione da parte di Engels del Terzo libro del Capitale, si è protratto per
1 Nel corso del presente lavoro le opere di Marx saranno citate dalla nuova edizione storicocritica delle opere complete di Marx ed Engels col consueto acronimo MEGA2 (K. Marx, F. Engels, Gesamtausgabe, herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus, Berlin/Moskau
1975 sgg.), indicando con la cifra romana la sezione e con le cifre arabe il volume e la pagina.
Faremo inoltre riferimento all’edizione delle opere complete di Marx ed Engels più diffusa e
conosciuta: K. Marx, F. Engels, Werke, herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus
beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, Berlin/Ost 1957 sgg. In
questo caso utilizzeremo l’acronimo MEW, seguito dall’indicazione del volume e della pagina.
Traduzioni ed edizioni italiane saranno indicate di volta in volta. Infine, non compare il riferimento MEGA2 per quei testi che ancora non sono disponibili nella nuova edizione.
192
Antonella Muzzupappa
più di un secolo ed è, ancora oggi, molto vivo. Studiosi ed economisti contemporanei continuano, infatti, a discutere della possibilità o meno di derivare i
prezzi di produzione dai valori, seguendo lo schema proposto da Marx.
La particolare rilevanza di questo tema è dovuta al fatto che la questione
specifica di se e come i prezzi derivano dai valori è immediatamente collegata
a temi più generali che riguardano l’interpretazione del valore, del denaro, del
rapporto tra produzione e circolazione all’interno del modo di produzione capitalistico nonché alla spiegazione dell’origine del profitto.
Quando si parla di trasformazione ci si riferisce immediatamente all’interpretazione marxiana del modo di produzione capitalistico, alla legge del valorelavoro e alla sua validità. Il nodo problematico della questione risiede nel fatto
che i prezzi di produzione, così come vengono definiti da Marx nel capitolo
nono del Terzo libro del Capitale, non coincidono con i valori, intesi come tempo di lavoro socialmente necessario a produrre le merci, su cui si era basata
tutta la precedente analisi marxiana del sistema capitalistico di produzione.
Attraverso il riferimento ad alcuni degli scritti di Marx precedenti il Capitale,
si cercherà di chiarire il punto di vista dell’autore sulla relazione generale tra
valori e prezzi e di mettere in evidenza la coerenza interna del discorso fino alla
trasformazione.
Concentreremo la nostra analisi innanzitutto sul «Quaderno I» dei Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 1857-1858, dove, nell’ambito della critica a Darimon e alla sua proposta di riforma delle banche, Marx
chiarisce il suo punto di vista sulla relazione tra valori e prezzi in generale. Si
tratterà, quindi, di esaminare l’interpretazione marxiana del denaro come necessità derivante dalla scissione tra valore d’uso e valore nel prodotto del lavoro
diventato merce e dell’esistenza del valore di scambio come prezzo.
Il centro del lavoro sarà poi dedicato alla descrizione dei passaggi più importanti della trasformazione dei valori in prezzi di produzione del Terzo libro
del Capitale e ai più rilevati problemi che essa pone.
Senza pretendere di essere esaustivi, né sulle difficoltà del procedimento di
trasformazione dei valori in prezzi, né sul dibattito che ne è scaturito, si illustreranno le prime e più radicali critiche venute al procedimento marxiano. In
particolare, la posizione di Böhm-Bawerk sul rapporto tra Primo e Terzo libro
del Capitale e quella di Bortkiewicz che per primo ha proposto il calcolo simultaneo come soluzione alle contraddizioni di quel procedimento.
In conclusione, si descriveranno le due posizioni che, a nostro avviso, rappresentano al meglio lo stato del dibattito contemporaneo. L’una che propone
un nuovo modello matematico col quale si riuscirebbe a giustificare tutto il
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
193
discorso di Marx sui prezzi di produzione; l’altra che, mettendo al centro del
discorso la «teoria monetaria del valore» di Marx, ritiene che il metodo di derivazione dei prezzi dai valori del nono capitolo costituisca un passo indietro di
Marx rispetto alla sua stessa «rivoluzione teorica».
2. Il prezzo come “espressione monetaria del valore”
Marx definisce il valore come uguale alla quantità di tempo di lavoro socialmente necessario a produrre una merce e il prezzo come l’espressione in
denaro di questa quantità di lavoro. Fin dai Grundrisse, però, insiste sul fatto
che valore e prezzo non coincidono mai e che la differenza tra i due termini è
assoluta ed essenziale e non solo nominale o accidentale.
Nell’ambito della critica a Darimon e alla sua riforma delle banche, Marx
chiarisce due questioni fondamentali che riguardano il suo punto di vista sui
prezzi e, in generale, sul denaro. Innanzitutto, il prezzo non è solo un nome
diverso del valore delle merci, e il denaro non è un accidente ma un elemento
necessariamente connesso alla produzione generalizzata di merci. Esso deriva
necessariamente dalla scissione che caratterizza il prodotto del lavoro diventato merce: la scissione tra valore d’uso e valore.
Il denaro è l’esistenza fisicamente separata del valore di scambio delle merci, è questo valore di scambio incarnato in una merce particolare che lo rappresenta per eccellenza, una sorta di valore di scambio puro. Non ricostruiamo
qui, nei particolari, tutto il discorso di Marx a proposito della contraddizione
della merce ma cerchiamo di chiarire brevemente soltanto in che senso il denaro sia una necessità e non un accidente, per poi ritornare al prezzo che in esso
si esprime.
Il denaro è necessario poiché ogni prodotto, nel momento in cui viene prodotto come merce, acquista una doppia esistenza: naturale ed economico-sociale. In quanto valori, quindi nella loro esistenza economico-sociale, le merci
sono tutte tra loro equivalenti e assolutamente intercambiabili; in quanto oggetti d’uso, invece, cioè nella loro esistenza naturale, esse sono assolutamente
differenti le une dalle altre e non vi è alcun criterio che permetta di stabilire in
quali quantità esse si possano scambiare le une contro le altre. La merce, insomma, è dotata di una doppia esistenza caratterizzata dall’assoluta contraddizione: il valore di scambio nega decisamente il valore d’uso e viceversa. La qualità
della merce di essere valore di scambio, deve acquistare, per Marx, un’esistenza
materialmente separata da quella della merce in quanto valore d’uso. «Perché?
Perché essendo le merci in quanto valori diverse l’una dall’altra soltanto quan-
194
Antonella Muzzupappa
titativamente, ciascuna merce deve essere qualitativamente diversa dal suo proprio valore.»2 Il valore di scambio, cioè, deve necessariamente acquistare, nel
denaro, un’esistenza fisicamente separata dalla merce. Non si tratta di una semplice possibilità, ma di una necessità essenziale derivante dalla scissione, nella
merce, tra valore d’uso e valore. Il denaro è l’esistenza puramente economica
della merce separata dalla merce stessa, «il valore di scambio della merce, come
esistenza particolare accanto alla merce stessa»3, «una lettera che sta al posto di
un rapporto di produzione»4.
Da questo punto di vista, dunque, il denaro non è un accidente, una circostanza esterna e casuale per il modo di produzione capitalistico, bensì il rappresentante del rapporto essenziale a questo modo di produzione. La stessa idea
si può esprimere in termini più generali riferendosi ai concetti di produzione
e circolazione, come del resto lo stesso Marx fa proprio nelle prime pagine del
«Quaderno I» dei Grundrisse quando discute la proposta di Darimon di riforma
delle banche: «Il problema, si dice, è di natura generale: è possibile rivoluzionare i rapporti di produzione esistenti e i rapporti di distribuzione ad esso corrispondenti mediante una trasformazione dello strumento di circolazione?»5.
Detto in altri termini: si può trasformare la circolazione senza toccare la produzione? Chiaramente, per Marx, questo non è possibile e il tema del rapporto tra
produzione e circolazione resta fondamentale in tutta la critica dell’economia
politica ed è di estrema rilevanza proprio per discutere il nostro problema del
rapporto tra valori e prezzi. Alla fine del Terzo libro del Capitale, in un capitolo
intitolato proprio Rapporti di distribuzione e rapporti di produzione, Marx ritorna in modo complessivo su questo tema e ribadisce, questa volta dopo l’analisi
della concorrenza, dei prezzi di produzione e di mercato, della rendita ecc., che
«i cosiddetti rapporti di distribuzione corrispondono […] a forme storicamente
determinate, specificamente sociali, del processo di produzione e dei rapporti
in cui gli uomini entrano nel processo di riproduzione della loro vita e derivano
da queste forme.»6 Le forme della produzione, i rapporti in cui gli uomini entrano per produrre ciò di cui hanno bisogno e riprodurre la loro stessa vita, sono
determinanti e fondanti per la circolazione e la distribuzione.
Dunque, il denaro, questo particolare strumento della circolazione capitali2 MEGA2, II/1.1, Berlin 1976, p. 76; MEW, Bd. 42, Berlin 1983, p. 76; tr. it. E. Grillo, Lineamenti
fondamentali della critica dell’economia politica, 1857-1858, Scandicci 1997, vol. I, p. 76.
3 Ivi, p. 77; ivi, p. 77; tr. it. cit., p. 77.
4 Ivi, p. 76; ivi, p. 76; tr. it. cit., ibidem.
5 Ivi, p. 57; ivi, p. 58; tr. it. cit., p. 52.
6 MEGA2, II/15, Berlin 2004, p. 855; MEW, Bd. 25, Berlin 1971, p. 890; tr.it. M.L., Boggieri,
Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro terzo, Roma 1994, p. 1001.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
195
stica delle merci, deriva necessariamente dalla stessa produzione delle merci e
dalla contraddizione tra valore d’uso e valore ed è il rappresentante materiale
di un rapporto di produzione, di un intero rapporto sociale, ossia del rapporto
che si stabilisce tra gli uomini e tra gli uomini e le cose nel particolare modo di
produzione capitalistico.
Il prezzo, poi, è l’espressione monetaria del valore ed è sempre assolutamente differente dal valore in quanto tempo di lavoro. Esso è «la forma mutata nella quale appare il valore di scambio delle merci in seno al processo di
circolazione»7. In quanto forma trasformata del valore, però, pur non coincidendo mai con esso, il prezzo mantiene col valore un rapporto strettissimo. «Il
prezzo – scrive Marx nei Grundrisse – si distingue dunque dal valore non soltanto come ciò che è nominale da ciò che è reale […] ma per questo motivo: che il
secondo si presenta come la legge dei movimenti percorsi dal primo»8. I prezzi,
quindi, sono sempre diversi dai valori, ma i valori rappresentano la base a partire dalla quale i prezzi si formano e variano e se «domanda e offerta determinano costantemente i prezzi delle merci […] i costi di produzione da parte loro
determinano le oscillazioni della domanda e dell’offerta».9 Certo, i termini della
questione non sono ancora quelli del Terzo libro del Capitale, ma si può notare
come fosse già presente a Marx il fatto che i valori sono ciò che sta dietro i prezzi e che in un qualche modo li determina, e che fattori come domanda e offerta
non vanno trattati come principi a partire dai quali si spieghino le oscillazioni
dei prezzi, in quanto, al contrario, le oscillazioni della domanda e dell’offerta si
spiegano a partire dai costi di produzione.
A proposito dell’analisi del prezzo a questo livello della trattazione marxiana, va fatta ancora una considerazione: nel prezzo, la trasformazione della
merce in oro è soltanto ideale; la merce viene solo rappresentata come denaro ma non è denaro reale. Per divenire denaro reale essa deve essere alienata,
venduta, scambiata, deve cioè avvenire quel passaggio nel quale il lavoro del
singolo indipendente, occorso a produrre quella merce determinata, diventa
lavoro generale astratto. In Per la critica dell’economia politica del 1859 si legge: «Nell’esistenza del valore di scambio come prezzo […] è contenuta in via
latente la necessità dell’alienazione della merce in cambio di oro sonante, e
la possibilità della sua non-alienazione, in breve è contenuta in modo latente
7 MEGA2, II/2, Berlin 1998, p. 141; MEW, Bd. 13, Berlin 1971, p. 51; tr. it. E. Cantimori
Mezzomonti, Per la critica dell’economia politica, Roma 1969, p. 47.
8 MEGA2, II/1.1, cit., p. 73; MEW, Bd. 42, cit., p. 73; tr. it. cit., p. 72.
9 Ibidem.
196
Antonella Muzzupappa
l’intera contraddizione»10. L’ «intera contraddizione» risiede nel fatto che tutto
ciò che deve realizzarsi può realizzarsi soltanto attraverso la propria negazione, attraverso la realizzazione del proprio opposto. Il valore di scambio, ad
esempio, viene realizzato solo se la merce diviene come valore d’uso, cioè se è
oggetto del bisogno di qualcuno e, per potersi realizzare, si nega come valore
di scambio e si afferma nella forma del prezzo. Nel momento in cui la merce
viene venduta, poi, il lavoro particolare del singolo individuo deve trasformarsi
nel suo opposto: in lavoro astrattamente generale. Esso, come sostanza sociale
del valore, non è un presupposto ma è il risultato del processo dello scambio
e, come tale, non esiste prima e fuori dello scambio. Del resto, il valore stesso
non è altro che un rapporto: esso è rapporto di valore o rapporto di scambio. In
quanto tale esiste solo nella relazione tra due merci e mai in una singola merce.
Quando Marx nel Primo libro del Capitale analizza in modo puntuale «la forma
di valore» (die Wertform) chiarisce questo punto, dicendo che parlare in modo
generale della merce come valore d’uso e valore di scambio è, a rigore, erroneo.
La merce, infatti, intanto si presenta in questa forma duplice in quanto il suo
valore esiste separatamente come valore di scambio e ciò non può accadere se
si considera la merce isolatamente, «ma sempre e solo nel rapporto di valore o
di scambio con una seconda merce, di genere differente»11.
Per concludere questa prima parte sul rapporto tra valori e prezzi, ritorniamo brevemente a Darimon e alla sua proposta di riforma delle banche. Il malinteso su cui, secondo Marx, i socialisti utopisti basano le loro proposte circa
le riforme da attuare nel modo di produzione capitalistico è essenzialmente
contenuto nel misconoscimento del nesso, a suo avviso necessario, esistente
tra merce e denaro e nella conseguente errata interpretazione dei prezzi delle
merci come solo nominalmente differenti dai loro valori.
I socialisti utopisti ritengono che poiché il lavoro è la misura immanente del
valore, non c’è bisogno che tale valore divenga prezzo e si esprima in denaro.
Dal loro punto di vista, il prezzo delle merci si può esprimere direttamente in
tempo di lavoro e la mediazione del denaro è superflua. Per Marx tutto questo
può verificarsi solo in un modo di produzione nel quale il tempo di lavoro sia
immediatamente sociale, e questo non è il caso del modo capitalistico di produzione. Il problema, infatti, risiede nel fatto che le merci sono i prodotti di lavori
privati indipendenti che attraverso lo scambio devono divenire lavoro sociale
generale. In sostanza, la socialità non è attributo immediato del lavoro, fino a
MEGA2, II/2, cit., p. 144; MEW, Bd. 13, cit, p. 54; tr. it. cit., p. 50.
MEGA2, II/10, Berlin 1991 p. 61; MEW, Bd. 23, Berlin 1972, p. 75; tr. it. D. Cantimori, Il
capitale. Critica dell’economia politica. Libro primo, Roma 1994, p. 93.
10 11 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
197
che si sia in condizioni capitalistiche di produzione. Qui, il lavoro per divenire
sociale deve negarsi come lavoro individuale. Il tempo di lavoro, quindi, non è
immediatamente sociale ma diventa sociale solo grazie alla mediazione dello
scambio. Se la produzione fosse l’attività di individui direttamente associati, le
cose starebbero diversamente, ma non si può, come secondo Marx vorrebbero
i socialisti utopisti, mantenere la produzione di merci e pretendere uno scambio di non-merci. Nelle condizioni di produzione capitalistiche la merce non è
direttamente denaro e il lavoro individuale non è direttamente sociale per cui
nessun tipo di cedola-orario può funzionare12.
3. La «trasformazione dei valori in prezzi di produzione» nel terzo libro del Capitale
Dopo queste poche battute sulla relazione generale tra valore e prezzo, passiamo adesso a considerare il procedimento della trasformazione descritto da
Marx nel capitolo nono del libro terzo del Capitale (Formazione di un saggio
generale del profitto (saggio del profitto medio) e trasformazione dei valori delle
merci in prezzi di produzione13).
12 Già nel 1847, in Miseria della filosofia, Marx aveva criticato il punto di vista dei socialisti utopisti, in particolare di Proudhon, sull’economia politica in generale. Egli aveva già
sottolineato il fatto che il punto d’arrivo di Proudhon fosse sostanzialmente identico a quello
cui erano giunti i socialisti inglesi: una sorta di conclusioni egualitarie desunte dalle teorie di
Ricardo su cui si erano basati i tentativi delle «banche di scambio», già miseramente falliti in
Inghilterra. E già in Miseria Marx critica a Proudhon di non aver compreso che il denaro non
è semplicemente una cosa, ma un rapporto sociale incarnato in una cosa. (Cfr. MEW, Bd. 4,
Berlin 1964, p. 107; tr. it. F. Rodano, Miseria della filosofia. Risposta alla “Filosofia della miseria”
di Proudhon, Roma 1998, p. 45).
13 Si tratta di un capitolo molto discusso in quanto la proposta marxiana di trasformazione
dei valori in prezzi di produzione è stata per più di un secolo aspramente criticata soprattutto
dagli economisti. Alle controversie sulla trasformazione si aggiungono, oggi, le discussioni di
carattere filologico suscitate dalla recente pubblicazione dei manoscritti originali di Marx per
il terzo libro del Capitale (Cfr. MEGA2 , II/4.2, Berlin 1992). Nonostante gli interventi di Engels, nelle parti del manoscritto che affrontano il problema della trasformazione, siano stati
minimi e limitati a migliorare lo stile e a rendere il testo più scorrevole, molti studiosi sostengono che egli abbia dato al manoscritto di Marx una forma complessivamente altra rispetto
all’originale. In questo modo avrebbe influenzato moltissimo le interpretazioni successive di
molti dei più importanti concetti della critica dell’economia politica e della stessa trasformazione dei valori in prezzi. Sul tema generale dell’edizione di Engels dei manoscritti di Marx
si può vedere: C. E. Vollgraf, J. Jungnickel, “Marx in Marx’ Worten”? Zur Engels’ Edition des
Hauptmanuskripts zum dritten Buch des Kapital, in «MEGA Studien», 1994/2, Berlin 1995,
pp. 3-55; C.E., Vollgraf, Kontroversen zum dritten Buch des Kapital: Folgen von und Herausforderungen für Edition, in «MEGA Studien», 1996/2, Berlin 1997, pp. 86-108; V. Vygodskij, Was
hat Engels in den Jahren 1885 und 1894 eigentlich veröffentlicht?, in «MEGA Studien», 1995/1,
Berlin 1995, pp. 117-20; D. Behrens, Ein Kommentar zum MEGA2-Band II/4.2, in «Beiträge zur Marx-Engels-Forschung». Neue Folge 1995, Berlin 1995, pp. 5-26; J. Jungnickel, C.E.
Vollgraf, Engels’ Redaktionsunterlagen zu Marx’ Manuskript von 1864/65, das 1894 als Buch
III des Kapital erschien, ivi, pp. 27-48. In particolare sull’influenza che Engels avrebbe avuto
198
Antonella Muzzupappa
Marx parte dalla seguente osservazione: se le merci vengono vendute ai loro
valori, si genera un assurdo per il modo di produzione capitalistico: il saggio
del profitto di ogni singolo capitale dipende dalla composizione organica particolare del capitale in questione e non dalla grandezza del capitale investito,
come invece, in realtà, succede. Il sistema capitalistico di produzione non può
convivere col fatto che capitali di uguale grandezza producono saggi del profitto diversi in relazione alla quantità di lavoro vivo che essi utilizzano14. Nel
caso della vendita delle merci ai loro valori, presupposto identico il saggio dello
sfruttamento (che poniamo, come Marx nel suo esempio, uguale al 100%) e
presupposti costanti i salari e la giornata lavorativa, il saggio del profitto dipende esclusivamente dal capitale variabile. Infatti, anche se si tratta di capitali
della medesima entità, le masse di plusvalore prodotte (e quindi i profitti) sono
diverse in relazione alle diverse masse di lavoro vivo che ogni capitale mette in
movimento. Il saggio del profitto è uguale al plusvalore diviso il capitale totale
(pv/C). Il plusvalore, nelle condizioni che abbiamo stabilito, cioè col tasso di
sfruttamento al 100%, è identico al capitale variabile per cui, se su un capitale
totale di 100, 80 rappresenta il capitale varabile, 80 sarà anche il plusvalore prodotto. Viceversa, se lo stesso capitale di 100, nelle stesse condizioni di sfruttamento e con la stessa giornata lavorativa, investe in termini di capitale variabile
solo 40, anche il suo plusvalore sarà uguale a 40. Nel primo caso il saggio del
profitto sarà dell’80% e nel secondo del 40%. «Se le cose stessero diversamente,
– dice Marx – valore e plusvalore dovrebbero essere qualche cosa di diverso dal
lavoro materializzato»15 e con ciò «l’economia politica sarebbe priva di qualsiasi base razionale».16
In queste condizioni, capitali di uguale entità avrebbero lo stesso saggio del
profitto solo se fossero investiti nello stesso ramo di produzione (in cui la composizione organica è data) o se, investiti in diversi rami di produzione, avessero
la stessa composizione organica17.
per l’interpretazione del rapporto valori-prezzi di produzione si può vedere: H.G. Backhaus,
H. Reichelt, Der politisch-ideologische Grundcharakter der Marx-Engels-Gesamtausgabe: eine
Kritik der Editionsrichtlinien der IMES, in «MEGA Studien», 1994/2 cit., pp. 101-118.
14 La questione viene sintetizzata benissimo dal seguente passaggio di Napoleoni: «Da un lato
la struttura di classe della società borghese suggerisce […] che il valore della merce prodotta dal
lavoro salariato dipende dalla quantità di lavoro complessivamente speso nella sua produzione;
dall’altro lato, il funzionamento del mercato capitalistico, ossia del meccanismo economico peculiare proprio di quella società, mostra invece che le merci non possono scambiarsi in conformità
ai lavori in esse contenuti, se la norma fondamentale dell’uguaglianza tra i saggi del profitto deve
ricevere realizzazione». (C. Napoleoni, Dalla scienza all’utopia, Torino 1992, p. 137.).
15 MEGA2, II/15, cit., p. 151; MEW, Bd. 25, cit., p. 158; tr. it. cit., p. 189.
16 Ibidem; ibidem; tr. it. cit., pp. 188-89.
17 Nel nostro discorso prescindiamo dalla durata della rotazione che, insieme alla compo-
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
199
Insomma, se le merci venissero vendute ai loro valori, come Marx ha presupposto nel corso di tutta la sua indagine, fino al capitolo nono del Terzo libro, nei diversi rami dell’industria si genererebbero saggi del profitto diversi
in conformità della diversa composizione organica dei capitali e, entro certi
limiti, anche in conformità dei diversi tempi di rotazione. «D’altra parte – conclude Marx – non vi è dubbio che nella realtà, a prescindere da differenze di
poco rilievo, accidentali e che si compensano a vicenda, la differenza dei saggi
medi di profitto fra i diversi rami dell’industria non esiste e non può esistere
senza annullare tutto il sistema della produzione capitalistica. Sembra quindi
che la teoria del valore sia inconciliabile col movimento reale; inconciliabile
con la reale fenomenologia della produzione, che bisogna perciò rinunciare a
comprendere».18
Siamo, a questo punto, al cuore del problema che riguarda la relazione tra
valori e prezzi, e tra teoria del valore e realtà del modo di produzione capitalistico o, per riassumere in termini in cui la questione è diventata famosa, al
problema della relazione tra Primo e Terzo libro del Capitale.
Partiamo dalla definizione di prezzo di produzione e cerchiamo di capire
quali sono i passaggi attraverso i quali Marx arriva a tali prezzi. Il prezzo di
produzione è uguale al prezzo di costo della merce più il profitto medio. Il prezzo di costo corrisponde a ciò che la merce costa al capitalista, esso è uguale a
c+v, cioè a tutto quello che il capitalista spende, sia in termini di capitale costante sia in termini di capitale variabile, per produrre una determinata merce.
Non entra nel prezzo di costo il plusvalore, in quanto esso non è pagato. Da
ciò risulta immediatamente che il prezzo di costo è sempre inferiore al valore
della merce. Il valore, infatti, è uguale alla quantità di tempo di lavoro occorso a produrre la merce e non soltanto alla quantità di tempo di lavoro (morto
e vivo) per il quale è stato pagato un equivalente. Il valore della merce si può
esprimere, dunque, come uguale a c+v+pv (capitale costante + capitale variabile + plusvalore). La differenza tra prezzo di costo e valore, in particolare il fatto
che il prezzo di costo, o spesa in denaro, è sempre inferiore al valore, o spesa in
lavoro, per la produzione di una merce, è molto importante perché dimostra,
già prima di parlare di trasformazione dei valori in prezzi di produzione, come
sia possibile, da parte dei capitalisti, vendere le merci al di sotto del loro valore
e, contemporaneamente, realizzare un profitto. «Fintanto che il prezzo di vensizione organica del capitale, è l’altro fattore che influenza il saggio del profitto. Per semplificare i calcoli e il discorso la supponiamo identica per tutti i capitali, visto che ciò non pregiudica
il ragionamento che stiamo facendo.
18 MEGA2, II/15, cit., p. 155; MEW, Bd. 25, cit., p. 162; tr. it. cit., p. 193.
200
Antonella Muzzupappa
dita, pur essendo inferiore al valore, supera il prezzo di costo, si realizza pur
sempre una parte del plusvalore contenuto nella merce, vale a dire si determina
pur sempre un profitto»19.
Il fatto che le merci possano essere vendute con profitto anche quando vengono vendute al di sotto dei loro valori è di enorme importanza, anzi «la stessa
legge fondamentale della concorrenza capitalistica finora incompresa dall’economia politica, legge che regola il saggio generale del profitto e i così detti prezzi di produzione determinati mercè quel saggio stesso, si fonda […] sulla enunciata differenza fra valore e prezzo di costo delle merci» e, in particolare, proprio su questa possibilità di far profitto pur vendendo al di sotto del valore20.
Veniamo ora al secondo elemento che compone il prezzo di produzione: il
profitto medio. Si è detto precedentemente che, in origine, i saggi del profitto
dei capitali investiti nelle diverse branche della produzione sono tra di loro
differenti secondo le diverse composizioni organiche dei diversi capitali. Ora,
per Marx, la concorrenza tra capitalisti agisce nel senso di comporre questi
diversi saggi del profitto in un saggio generale che rappresenta la loro media.
Se, sempre seguendo l’esempio di Marx, supponiamo di avere a che fare con
cinque capitali investiti in cinque diverse branche della produzione che hanno
diverse composizioni organiche e di conseguenza diversi saggi del profitto, il
saggio generale del profitto sarà dato dalla media dei cinque diversi saggi. Esso
(nell’esempio numerico di Marx ammonta al 22%) si andrà ad aggiungere ai diversi prezzi di costo delle merci fornendo i prezzi di produzione. Osservando i
risultati si vede che, nel complesso, le differenze tra valori e prezzi si annullano,
il che significa che ciò che vale al livello della merce singola, cioè il fatto che per
Ivi, p. 41; ivi, p. 47; tr. it. cit., p. 63.
Secondo Marx, Smith e Ricardo non comprendono la differenza essenziale tra prezzo
di costo e valore. Guardando dallo stesso punto di vista dei capitalisti, essi li identificano con
la conseguenza che il profitto viene spiegato come l’eccedenza del prezzo di vendita sul valore,
piuttosto che come l’eccedenza del valore sul prezzo di costo. Il plusvalore, da questo punto di
vista, avrebbe origine nella circolazione, scaturirebbe dalla vendita della merce, piuttosto che
essere lì solo realizzato. Si tratta anche qui, come altrove, per Marx, della domanda sull’origine
del profitto, che egli ha già posto relativamente ai socialisti utopisti. Anche nel Terzo libro,
infatti, troviamo a questo proposito la critica a Proudhon e alla sua Banca: «La superficiale
concezione che il prezzo di costo delle merci ne costituisca l’effettivo valore, e il plusvalore
derivi invece dalla vendita della merce a un prezzo superiore al valore […] è stata strombazzata da Proudhon, con la sua solita ciarlataneria ammantata di pretese scientifiche, come la
rivelazione di un segreto del socialismo. Tale riduzione del valore delle merci al loro prezzo
di costo costituisce infatti la base della sua Banca popolare.» (Ivi, p. 43; ivi, p. 49; tr. it. cit., p.
66). Se il valore si identifica col prezzo di costo e il profitto scaturisce dalla vendita, bisogna
allora intervenire sul meccanismo della circolazione e sulla posizione privilegiata dell’oro e
dell’argento rispetto alle altre merci, ed allora viene meno proprio l’elemento fondamentale
del meccanismo della produzione capitalistica, che è la produzione del plusvalore ad opera del
lavoro vivo, unica possibile fonte del profitto.
19 20 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
201
essa valore e prezzo non coincidono, non vale se si guarda al complesso di tutte
le merci: la somma dei valori corrisponde esattamente alla somma dei prezzi.
In sostanza, dal punto di vista del capitale sociale totale, nella circolazione si
è realizzato tanto valore quanto è stato prodotto, esso è stato soltanto ripartito
diversamente nelle singole merci rispetto a come era stato prodotto.
Cosa significa, per Marx, in ultima istanza, che le merci vengono vendute
non ai valori ma ai prezzi di produzione? Significa semplicemente che, tra i
capitalisti, interviene un particolare meccanismo di redistribuzione del plusvalore totale prodotto21. Essi, cioè, non ritirano dalla circolazione il plusvalore,
e quindi il profitto, prodotto nella loro particolare sfera di produzione, «ma
soltanto il plusvalore, e quindi il profitto, corrispondente a quella parte di plusvalore complessivo o di profitto complessivo […] che, per effetto di una eguale
ripartizione, tocca a ogni aliquota del capitale complessivo»22. I cinque capitali
che abbiamo preso in considerazione nel nostro esempio vanno praticamente
visti, coerentemente col punto di vista che Marx ha sempre espresso, come
cinque parti del capitale sociale totale considerato come un tutto. Da questo
punto di vista, «per quanto riguarda il profitto i vari capitalisti si trovano nelle
condizioni di semplici azionisti di una società per azioni»23 per cui le quote di
profitto a cui ognuno di essi ha diritto differiscono solo in relazione alla quantità di capitale che ognuno ha investito, «cioè a seconda della loro proporzionale
partecipazione all’impresa, ossia del numero delle loro azioni».24
Dunque, mentre le spese che ogni singolo capitalista ha sostenuto vengono
riprodotte e ritirate interamente, a seconda dei singoli capitali, non così accade
per il profitto. Esso, appunto, non dipende dalla massa di profitto prodotta dal
singolo capitale in una determinata sfera di produzione, ma dalla media che
tocca ad ognuno come rappresentate di un’aliquota del capitale complessivo
sociale. In questo modo i profitti non dipendono dalla composizione organica
del singolo capitale, bensì soltanto dalla grandezza del capitale investito; e soprattutto, come abbiamo già detto, dal punto di vista del capitale sociale totale
«la somma dei prezzi di produzione delle merci prodotte è pari alla somma dei
21 Secondo alcuni critici, infatti, la trasformazione dei valori in prezzi di produzione altro
non sarebbe che il meccanismo di redistribuzione del plusvalore totale prodotto tra i capitalisti, «nient’altro che la differenza tra valore prodotto e appropriato». (G. Carchedi, Il problema
inesistente: la trasformazione dei valori in prezzi in parole semplici, in L. Vasapollo (a cura di),
Un vecchio falso problema. La trasformazione dei valori in prezzi nel Capitale di Marx, Castel
Madama 2002, p. 54).
22 MEGA2, II/15, cit., pp. 159-60; MEW, Bd. 25, cit., p. 168; tr. it. cit., p. 199.
23 Ivi, p. 160; ibidem; tr. it. cit., ibidem.
24 Ibidem.
202
Antonella Muzzupappa
valori di esse»25, così come «la somma dei profitti di tutte le diverse sfere di produzione deve essere uguale alla somma dei plusvalori»26. In questo modo è evidente che, come Marx ha già sottolineato più volte, il lavoro vivo è l’unica fonte
della produzione di valore, e nuovo valore può essere prodotto solo nella sfera
della produzione e realizzato in quella della circolazione. Anche se per quanto
riguarda la singola merce si registra una differenza tra il valore e il prezzo, che
ci indurrebbe a credere che valore e plusvalore non siano dipendenti da lavoro e
pluslavoro, ad una più attenta analisi che non si fermi all’apparenza delle cose,
diviene chiaro che non è così.
Gli agenti della produzione, nonché gli economisti, si ingannano, secondo
Marx, proprio su queste questioni fondamentali perché fanno le loro riflessioni
a partire dalla superficie dei fenomeni senza penetrarli. Ma il modo capitalistico di produzione è tale che, più esso si sviluppa, più i fenomeni superficiali si
allontanano dalla loro vera natura e si produce un’apparenza che è praticamente rovesciata rispetto alla verità27. Del resto, se l’apparenza corrispondesse esattamente alla verità delle cose, non ci sarebbe alcun bisogno della scienza, il cui
compito è, appunto, quello di «ricondurre il movimento apparente, puramente
fenomenico, al movimento reale interno»28.
A livello di saggio medio del profitto e prezzi di produzione, poiché ogni capitalista ricava solo il profitto medio, e non il profitto relativo alla quantità di
plusvalore effettivamente prodotta nella propria sfera, plusvalore e profitto appaiono come assolutamente indipendenti e la loro differenza reale «nasconde
ora completamente la vera natura e l’origine del profitto non solo al capitalista
[…] ma allo stesso operaio».29 La trasformazione dei valori in prezzi di produzione, cioè, nasconde completamente la base su cui si fonda il valore, la sua
produzione e la sua determinazione. Il concetto di valore, in sostanza, sparisce
completamente30.
Ivi, p. 161; ivi, p. 169; tr. it. cit., p. 200.
Ivi, p. 173; ivi, p. 182; tr. it. cit., p. 215.
27 Già la categoria del prezzo di costo rappresenta un esempio di questo allontanamento
dei fenomeni superficiali dalla verità. Esso, infatti, pur corrispondendo solo al lavoro pagato
impiegato nella produzione di una merce, viene concepito come il valore della merce, che invece contiene anche il lavoro non pagato speso nella produzione; inoltre, i due elementi che lo
compongono (capitale costante e capitale variabile) vengono messi sullo stesso piano e trattati
come elementi identici, in quanto entrambi rappresentano, per il capitalista, una spesa. Si dimentica così che il lavoro vivo ha quella qualità particolare di produrre nuovo valore, qualità
che il lavoro morto invece non ha, e si mistifica l’origine del plusvalore e, quindi, del profitto.
28 MEGA2, II/15, cit., p. 306; MEW, Bd. 25, cit., p. 324; tr. it. cit., p. 375.
29 Ivi, p. 169; ivi, p. 177; tr. it. cit.; p. 209.
30 Il tema del capovolgimento e della mistificazione che si producono alla superficie del
modo di produzione capitalistico e che inducono a errate valutazioni e rappresentazioni di
25 26 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
203
La conclusione di tutto il discorso marxiano sui prezzi è che ogni loro variazione è da ricondurre, in ultima istanza, ad una variazione dei valori delle
merci, cioè a variazioni nella produttività del lavoro. Quando, a causa dell’introduzione di un macchinario nuovo, per esempio, la forza produttiva del lavoro sociale aumenta, il valore delle merci (il tempo di lavoro che occorre a
produrle) diminuisce e tale diminuzione agisce, più o meno direttamente, sui
prezzi di produzione.
Coerentemente con tutto il discorso fatto da Marx fino a questo punto, non
è necessario che diminuisca il prezzo della merce nella cui produzione sia intervenuta una variazione della forza produttiva. Variazioni di valore nel salario
degli operai o nella produzione di materie prime, infatti, possono influenzare i
prezzi di produzione di altre merci nella cui produzione questi fattori vengono
adoperati. In conclusione, quindi, «tutte le variazioni del prezzo di produzione delle merci si risolvono, in ultima analisi, in una variazione di valore; ma
non tutte le variazioni di valore delle merci si traducono necessariamente in
una variazione del prezzo di produzione, essendo questo determinato non solamente dal valore della merce particolare, ma dal valore complessivo di tutte
le merci»31.
A questo punto, però, ci si chiede: che ruolo ha la concorrenza nella formazione dei prezzi? Fino a questo punto, infatti, Marx non ha fatto cenno alla
domanda e all’offerta e alla loro funzione nel meccanismo di formazione dei
prezzi. Ovviamente ciò non è casuale e dipende semplicemente dal fatto che
egli ritiene che domanda e offerta non possano in alcun modo spiegare la formazione dei prezzi. Esse hanno certamente un ruolo, come abbiamo anche già
visto all’inizio del nostro discorso quando abbiamo citato la pagina dei Grundrisse relativa proprio al rapporto tra domanda e offerta da un lato, e costi di
produzione dall’altro, ma questo ruolo è del tutto relativo. Proprio a proposito
di quella pagina si è fatto notare come già in quegli anni fosse chiaro a Marx
esso è presente in tutta la critica dell’economia politica marxiana. Esso viene trattato dettagliatamente nel Primo libro del Capitale nel paragrafo sul feticismo della merce. Tale feticismo, poi,
trova il suo compimento ultimo nel momento più sviluppato dall’analisi del capitale, quando
questo diventa capitale produttivo d’interesse. Qui la mistificazione raggiunge il suo massimo
grado poiché, nel movimento D-D’, che caratterizza il capitale produttivo d’interesse, sparisce
ogni mediazione e il capitale appare come direttamente produttivo senza che vi sia bisogno
dell’intervento di altri fattori. Spariscono, a questo livello di sviluppo, tanto il processo di
produzione quanto quello di circolazione e sembra che il denaro sia in grado di produrre
più denaro per virtù intrinseca e in modo automatico. Il capitale produttivo d’interesse è il
«feticcio automatico» nel quale sparisce ogni traccia dell’origine del profitto ed è «il rapporto
sociale perfezionato come rapporto di una cosa, del denaro, con se stessa». (Ivi, p. 318; ivi, p.
405; tr. it. cit., p. 464).
31 Ivi, p. 204; ivi, p. 216; tr. it. cit., p. 252.
204
Antonella Muzzupappa
che domanda e offerta non potessero essere un punto di partenza per la spiegazione dei prezzi ma che esse stesse, in un qualche modo, dovessero essere
spiegate a partire dai valori.
Nel Terzo libro questo rapporto viene chiarito in modo più puntuale e viene
descritto qual’è l’ambito di influenza della domanda e dell’offerta e quale la relazione della concorrenza coi prezzi di produzione.
Il primo ambito di influenza della concorrenza è quello che riguarda le diverse sfere di produzione. Si tratta della concorrenza tra capitalisti per assicurarsi i migliori rami di investimento. Essa si traduce essenzialmente in un
movimento continuo dei capitali da una sfera di investimento all’altra, in un
«incessante trasmigrare da un ramo di produzione ad un altro»32, «da una sfera
di produzione dove il saggio del profitto è basso»33 ad una «dove il saggio del
profitto è più elevato»34. Questo movimento continuo dei capitali «crea un rapporto tale fra offerta e domanda, per cui il saggio medio del profitto si uguaglia
nei diversi rami di produzione e per conseguenza i valori si trasformano in
prezzi di produzione».35 Il prezzo di produzione, quindi, si basa sull’esistenza
di un saggio medio del profitto e tale saggio medio del profitto è il risultato dei
movimenti determinati dalla concorrenza tra capitali.
Di altra natura è la concorrenza che agisce sul mercato a livello della vendita
delle merci. In questo ambito la domanda e l’offerta possono soltanto regolare
gli scarti quantitativi tra il valore di mercato e il prezzo di mercato, ma non presiedono né preesistono alla trasformazione dei valori in prezzi di produzione.
Per di più, nella stessa misura in cui esse regolano gli scarti tra valori e prezzi
di mercato, vengono, a loro volta, regolate da quegli stessi valori di mercato.
Senza addentrarci troppo nella spiegazione del valore di mercato, della concorrenza e di tutto ciò che vi è connesso, cerchiamo soltanto dare il senso generale
del discorso di Marx su domanda e offerta, trattandosi di un punto di importanza cruciale per le critiche che gli saranno mosse a partire dal punto di vista
dell’utilità marginale.
Il nocciolo della questione risiede, a nostro avviso, proprio nel fatto che domanda e offerta non sono considerate come principi, bensì come conseguenze.
Esse non possono spiegare fenomeni ma sono, al contrario, fenomeni da spiegare. Il bisogno (la domanda), anzi il «bisogno sociale» come Marx lo definisce, dipende innanzitutto dai rapporti di classe che si configurano nella società
Ivi, p. 195; ivi, p. 206; tr. it. cit., p. 240.
Ibidem; ibidem; tr. it. cit., p. 239.
34 Ibidem; ibidem; tr. it. cit., p. 240.
35 Ibidem.
32 33 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
205
capitalistica. Posto, infatti, che il semplice bisogno, al contrario di quanto riterranno i marginalisti, non ha, per Marx, alcuna conseguenza economica; e
posto, quindi, che il bisogno, nella società capitalistica, è sempre «bisogno che
possiede la possibilità di pagare»36, è evidente che esso «dipende innanzitutto
dal rapporto fra il plusvalore complessivo ed il salario, ed in secondo luogo dal
rapporto fra le diverse parti, nelle quali si scompone il plusvalore»37. Quindi, il
rapporto fra domanda e offerta è esso stesso un risultato, la conseguenza degli
specifici rapporti sociali in cui gli uomini si trovano nell’ambito del sistema capitalistico. Il discorso, allora, si presenta rovesciato: non sono domanda e offerta a spiegare il prezzi di produzione, ma la base fondante il sistema capitalistico
di produzione può spiegare la domanda, l’offerta e i loro rapporti reciproci38.
Molto di più ci sarebbe da dire su questo tema e sulla critica che Marx, a
questo proposito, articola all’economia politica classica, ma bisogna adesso rivolgersi a discutere i problemi e le critiche suscitate dalle pagine del Terzo libro
del Capitale che, brevemente, sono state presentate.
Ivi, p. 181; ivi, p. 190; tr. it. cit., p. 224.
Ibidem; ivi, p. 191; ibidem.
38 Su questo punto molte sono le critiche di Marx agli economisti classici. Smith e Ricardo, infatti, trattano domanda e offerta come principi che non necessitano di ulteriore spiegazione, piuttosto che come conseguenze di determinati rapporti. Ma ancora più importante
è il fatto che, come i socialisti utopisti, anche gli economisti classici non ritengono che le
deviazioni dei prezzi dai valori siano qualcosa di essenziale e necessario al meccanismo della
produzione capitalistica. Partendo anche loro dal presupposto che la regola sia l’identità di
valore e prezzo, interpretano le deviazioni come fenomeni solo accidentali e temporanei, essenzialmente dovuti a variazioni nella domanda. Ricardo, per esempio, scrive: « Prendendo il
lavoro come base del valore delle merci […] non si deve supporre che si vogliano ignorare le
deviazioni accidentali e temporanee del prezzo effettivo o di mercato delle merci da ciò che è
il loro prezzo originario e naturale.» (D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and
Taxation, in The Work and Correspondence of David Ricardo, ed. by P. Sraffa, vol. I, Cambridge
1951, p. 88; tr. it. A. Bagiotti, Principi di economia politica e dell’imposta, in Id., Opere, a cura di
P. L. Porta, Volume primo, Torino 2006, p. 242). Del resto, essi partono dal presupposto che il
modo di produzione capitalistico sia caratterizzato dall’equilibrio tra domanda e offerta. Uno
squilibrio tra i due fattori rappresenta, per loro, soltanto un’eccezione che si elimina automaticamente nel giro di poco tempo. Quindi, se è vero che il «[il prezzo di mercato] può essere al
di sopra o al di sotto o esattamente uguale al […] prezzo naturale» (A. Smith, An Inquiry into
the Nature and Causes of the Wealth of Nations, in The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith 2, Oxford 1976, p. 73; tr. it. A. Bagiotti e T. Bagiotti, La ricchezza delle
nazioni, Torino 2006, p. 142) in relazione alle proporzioni che si hanno tra domanda e offerta,
è anche vero che «la quantità di ogni merce immessa sul mercato si adegua naturalmente alla
domanda effettiva» (Ivi, p. 75; tr. it. cit., p. 144). Per Marx, al contrario, la regola vigente nel
modo di produzione capitalistico è lo squilibrio tra domanda e offerta: esse «non si equilibrano mai, o se si equilibrano questo avviene solamente per caso» (MEGA2, II/15, cit. p. 189;
MEW, Bd. 25, cit., p. 199; tr. it. cit., p. 233), in quanto il capitalismo non controlla né regola in
anticipo la produzione, per cui il rapporto tra la produzione e bisogno (tra offerta e domanda)
«è semplicemente un rapporto casuale». (Ivi, p. 186; ivi, p. 196; tr. it. cit., p. 230).
36 37 206
Antonella Muzzupappa
4. Problemi e difficoltà del procedimento marxiano. Le critiche di Böhm-Bawerk
e Bortkiewicz
I passaggi sulla trasformazione dei valori in prezzi di produzione che abbiamo ricostruito nel paragrafo precedente, furono pubblicati per la prima volta
da Engels nel 1894, nel Terzo volume del Capitale, e suscitarono immediatamente un ampio dibattito.
Il pubblico europeo attendeva già da tempo la pubblicazione dei manoscritti
di Marx e la annunciata soluzione alle più spinose questioni economiche che la
scuola ricardiana aveva lasciato insolute.
Se, infatti, la scuola ricardiana non era riuscita a spiegare lo scambio tra capitale e lavoro e la formazione di un saggio generale del profitto sulla base della
legge del valore, e se il primo problema era stato risolto da Marx nel Primo libro
con l’introduzione del concetto di forza-lavoro, il secondo problema sarebbe
stato definitivamente risolto nel Terzo libro. «La soluzione – scrive Engels nel
1885 nella Prefazione al Secondo libro del Capitale – è data, secondo il piano del
Capitale, nel III libro»39.
L’attesa nei confronti della pubblicazione dei manoscritti di Marx era, dunque, elevatissima, tanto più grande in quanto Engels aveva più volte annunciato
di essere vicino alla fine dei lavori e invece aveva poi sempre dovuto rimandare la pubblicazione. Ancora nella Prefazione al Secondo libro egli scrive: «La
preparazione di questo libro [il terzo] per le stampe prosegue rapidamente.
Per quanto posso giudicare finora, esso in generale presenterà difficoltà soltanto tecniche, ad eccezione, certo, di alcune sezioni molto importanti»40. Questa
valutazione si rivelerà sbagliata e bisognerà aspettare ancora quasi dieci anni
dalla pubblicazione del Secondo volume per avere finalmente il Terzo.
Date queste premesse, non sorprende che la discussione sul Terzo volume,
sui temi e i problemi in esso affrontati e sul rapporto di esso col Primo volume
del Capitale, sia cominciata immediatamente dopo la sua pubblicazione e sia
stata anche particolarmente intensa.
Il primo lavoro che ha al centro il rapporto tra Primo e Terzo libro del Capitale e mette in discussione la soluzione al problema della trasformazione è
quello di Böhm-Bawerk. Pubblicato nel 1896, due anni dopo la pubblicazione
del Terzo libro, La conclusione del sistema marxiano, è concepito come un’ampia critica non solo al Terzo libro, ma alla teoria del valore in generale e al
39 MEGA2, II/13, Berlin, 2008, p. 21; MEW, Bd. 24, Berlin 1977, p. 26; tr. it. R. Panzieri, Il
capitale. Critica dell’economia politica. Libro secondo, Roma 1994, p. 26.
40 Ivi, p. 9; ivi, p. 13; tr. it. cit., p. 13.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
207
rapporto tra la legge del valore, esposta nel Primo volume, e la vendita delle
merci ai prezzi di produzione, esposta nel Terzo. In un suo scritto precedente41
Böhm-Bawerk aveva già criticato la teoria del valore e del plusvalore contenuta nel Primo libro del Capitale e aveva osservato che lì Marx, consapevole del
fatto che le merci sul mercato capitalistico non si vendono ai loro valori bensì
a prezzi che da essi divergono, prometteva di risolvere più tardi questo problema42. Già a quel tempo l’autore era convinto che Marx non sarebbe riuscito
a mantenere la sua promessa e il Terzo libro rappresentava per lui la prova
definitiva dell’impossibilità di rendere ragione dei prezzi di produzione sulla
base della legge del valore. Del resto Böhm-Bawerk era il più famoso rappresentante della teoria del valore soggettivo o dell’utilità marginale che in quegli
anni rapidamente si diffondeva in Europa. Possiamo dire, quindi, con Sweezy
che «mentre la reazione originaria del mondo accademico era stata di ignorare
Marx, divenne sempre più difficile conservare un simile atteggiamento […] [e]
la pubblicazione del terzo libro del Capitale offrì […] l’occasione opportuna e fu
del tutto “naturale” che fosse Böhm-Bawerk a guidare il contrattacco»43. Il testo
di Böhm-Bawerk divenne «la risposta ufficiale degli economisti di professione
a Marx ed alla scuola marxista»44, una risposta tanto più incisiva e decisiva in
quanto alla fine dell’800 la teoria del valore soggettivo godeva di grande fama
ed era accettata da molti importanti economisti accademici.
Una delle questioni più importanti che Böhm-Bawerk discute nel suo testo
del 1896 è proprio quella dei prezzi di produzione e della loro relazione con
i valori. Come si è già accennato, il testo è concepito come un’ampia critica
all’impianto complessivo della teoria marxiana e non solo come una critica al
41 Cfr. E. von Böhm-Bawerk, Geschichte und Kritik der Kapitalzins-theorien, Meisenheim/
Glan 1961; tr. it. E. Grillo, Storia e critica delle teorie dell’interesse del capitale, Roma 1986.
42 Che Marx fosse già da sempre consapevole del fatto che i prezzi divergono necessariamente dai valori, lo abbiamo visto seguendo i passaggi dei Lineamenti fondamentali. Nel
Primo volume del Capitale si trovano poi anche un paio di riferimenti più precisi in cui Marx
effettivamente rimanda la soluzione del problema al Terzo libro. Innanzitutto nella nota 31a
del capitolo sette si legge: «Questi calcoli valgono solo come illustrazione. Si è infatti supposto
che i prezzi siano eguali ai valori. Nel terzo libro vedremo che questa identificazione non si
può fare così semplicemente neppure per i prezzi medi». (MEGA2, II/10, cit., p. 198, n.; MEW,
Bd. 23, cit., p. 234, n.; tr. it. cit., p. 253, n.). Ancora, nel capitolo nove, leggiamo: «La legge sopra constatata assume quindi questa forma: la masse di valore e plusvalore prodotte da capitali
diversi, a valore dato ed essendo uguale il grado di sfruttamento della forza-lavoro, variano in proporzione diretta al variare delle grandezze delle parti variabili di quei capitali, cioè delle loro parti
convertite in forza-lavoro vivente. Questa legge contraddice evidentemente a ogni esperienza
fondata sull’apparenza. […]. Per risolvere quest’apparente contraddizione, occorrono ancora
molti termini intermedi». (Ivi, p. 276; ivi, pp. 324-25; tr. it. cit., p. 345)
43 P. M. Sweezy, Presentazione, in AA. VV., Economia borghese ed economia marxista, Firenze 1971, p. VIII.
44 Ivi, p. IX.
208
Antonella Muzzupappa
procedimento della trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Tuttavia,
tale problematica risulta centrale dal momento che, per il teorico del valore
soggettivo, l’economia deve spiegare i fenomeni dei rapporti di scambio così
come essi si presentano nelle concrete situazioni del mercato.
Come si vede, il punto di partenza di Böhm-Bawerk è assolutamente diverso da quello di Marx e rende immediatamente evidente il contenuto della sua
critica. Ma vediamo come è articolata questa critica alla teoria del valore, fatta
da Böhm-Bawerk, il cui testo rappresenta l’«esposizione sistematica del motivo per cui la teoria soggettiva del valore […] respinse totalmente il sistema
marxiano»45.
Dopo aver esposto, nei primi due capitoli del testo, la teoria marxiana del
valore e del plusvalore e quella del saggio medio del profitto e dei prezzi di produzione, Böhm-Bawerk entra nel merito delle sue argomentazioni critiche. Da
principio constata che la teoria del saggio medio del profitto non è assolutamente conciliabile con la teoria del valore: se esiste, ed esiste per la stessa ammissione di Marx, un saggio medio del profitto, le merci non possono essere vendute
ai loro valori, «l’uguale saggio medio del profitto si può formare solamente se e
perché non è valida la presunta legge del valore»46. A parere di Böhm-Bawerk,
quindi, «il terzo volume di Marx smentisce il primo. La teoria del saggio medio
del profitto e dei prezzi di produzione non si concilia con la teoria del valore»47
e ciò che era stato annunciato come la soluzione del problema si presentava,
invece, come l’«abdicazione […] alla legge del valore»48. Per potere dimostrare
l’esattezza di queste conclusioni, l’autore passa in rassegna le argomentazioni
di Marx per le quali dovrebbe esistere una dipendenza in «ultima istanza» dei
prezzi di produzione dai valori e le valuta una ad una.
Innanzitutto l’argomento per cui, anche se le singole merci vengono vendute
al di sopra o al di sotto dei loro valori, le differenze e le deviazioni si annullano
reciprocamente. Come abbiamo visto, infatti, per Marx, se si prende in considerazione la società nel suo complesso, la somma dei prezzi produzione deve
essere uguale alla somma dei valori delle merci prodotte. Böhm-Bawerk ritiene assolutamente insufficiente questo tipo di argomento in quanto il senso e il
compito della legge del valore dovrebbe essere di chiarire il rapporto di scamIvi, pp. XIII-XIV.
E. von Böhm-Bawerk, Zum Abschluß des Marxschen Systems, in F. Eberle (a cura di),
Aspekte der Marxschen Theorie 1. Zur methodischen Bedeutung des 3. Bandes des „Kapital“,
Frankfurt am Main 1973, p. 45; tr. it. G. Panzieri Saija, La conclusione del sistema marxiano, in
AA. VV., Economia borghese ed economia marxista, cit., p. 26.
47 Ivi, p. 46; tr. it. cit., p. 27.
48 Ivi, p. 47; tr. it. cit. p. 28.
45 46 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
209
bio tra i beni come esso si presenta nella realtà. Nella realtà, però, si scambiano
soltanto singole merci tra loro e quando si prende in considerazione la totalità
delle merci non ha più senso, per il critico di Marx, parlare di valore. «La “legge del valore” – allora – viene per ammissione smentita dai fatti, e nell’unica
applicazione in cui non viene smentita, non è più una risposta»49, ma diviene
semplicemente «una mera tautologia»50.
Le cose non migliorano per il fatto che Marx spiega che le leggi generali della produzione capitalistica non si presentano mai pure, ma si affermano solo
come tendenze nella forma di una media di oscillazioni incessanti. Pur ritenendo che questa sia una verità elementare che ogni economista conosce e riconosce, per Böhm-Bawerk Marx confonde «una media di oscillazioni e una media
tra grandezze costantemente e fondamentalmente diseguali»51. Nel caso dei prezzi
di produzione, infatti, non si può parlare, per il teorico del valore soggettivo, di
oscillazioni. Le divergenze dei prezzi dai valori sono necessarie e permanenti
e non hanno nulla a che fare con oscillazioni o leggi che si affermano come
tendenze. Infine, conclude Böhm-Bawerk, è sempre possibile fare una media
matematica e dire che le differenze si annullano quando si abbia a che fare con
grandezze diseguali, il punto è che tale media non ha alcun significato teorico
o conoscitivo.
Il secondo argomento che Böhm-Bawerk analizza è quello per cui, secondo
Marx, ogni modifica nel tempo di lavoro necessario alla produzione delle merci
modifica anche i prezzi di produzione, motivo per cui, come abbiamo visto, si
può concludere che la legge del valore domina il movimento dei prezzi. La contestazione di Böhm-Bawerk a questo tipo di argomentazione è particolarmente
importante, perché è la stessa che egli utilizza anche relativamente a questioni
di carattere più generale, come vedremo nel corso della nostra esposizione.
Nessuno vuol mettere in discussione, dice il critico, che se rimangono invariate le altre circostanze, una modifica nel tempo di lavoro necessario a produrre una merce modifica anche i prezzi di produzione. Ciò che non è legittimo,
però, è voler concludere che il tempo di lavoro è l’unica determinante dei prezzi. I prezzi si modificano, argomenta Böhm-Bawerk, anche in relazione ad altri
fattori che anche Marx riconosce ed allora, il tempo di lavoro è, insieme ad altri
fattori, una delle cause determinanti dei prezzi, ma non l’unica52.
Il terzo argomento preso in considerazione è quello della dominanza della
Ivi, p. 51; tr. it. cit., p. 32.
Ibidem.
51 Ivi, p. 52; tr. it. cit., p. 33.
52 Cfr. ivi, pp. 54-55; tr. it. cit., 35-36.
49 50 210
Antonella Muzzupappa
legge del valore negli stadi primitivi della produzione e della necessità, invece,
di rapporti capitalistici sviluppati per poter parlare di livellamento del saggio
del profitto. Böhm-Bawerk prende innanzitutto in considerazione l’esempio
di Marx nel quale egli suppone che i lavoratori siano proprietari dei mezzi di
produzione e cerca di mostrare che lo scambio delle merci ai loro valori si
realizza solo in stadi della produzione ancora poco sviluppati. Innanzitutto,
per Böhm-Bawerk, «Marx illustra, “suppone”, afferma, ma non fornisce alcuna
dimostrazione»53 e la sua resta un’ipotesi a cui si può credere oppure no e contro la quale «esistono gravissime obiezioni interne ed esterne»54. Se intrinsecamente essa è semplicemente improbabile, al confronto con l’esperienza diviene
insostenibile, in quanto non vi è esperienza diretta alcuna di un caso come
quello postulato da Marx. Inoltre, anche volendo seguire l’ipotesi marxiana, la
conclusione più plausibile secondo Böhm-Bawerk sarebbe comunque quella
per cui, anche quando i lavoratori fossero proprietari dei mezzi di produzione
e i rapporti capitalistici non fossero particolarmente sviluppati, i profitti tenderebbero ad essere proporzionali ai capitali investiti e non al capitale variabile
utilizzato. La legge del valore, quindi, non esercita la sua supremazia in regime
di capitalismo sviluppato, in quanto lì operano i prezzi di produzione, e non la
esercita neanche in condizioni primitive. Essa, quindi, non ha validità reale e
diretta in nessun luogo e in nessun tempo55.
Nel quarto argomento, infine, Böhm-Bawerk discute se la legge del valore
possa almeno indirettamente e «in ultima istanza» regolare i prezzi di produzione, come vorrebbe Marx.
Egli rileva in relazione al profitto medio ciò che ha già messo in evidenza
rispetto al tempo di lavoro: esso è una determinante dei prezzi di produzione
ma non l’unica. L’altra causa determinante sarebbe la somma dei salari pagati,
causa che Marx tralascia completamente, nella convinzione che variazioni nei
salari non abbiano conseguenze dirette sui prezzi di produzione ma solo sui
profitti. Anche il plusvalore complessivo, poi, che secondo Marx regola il saggio
medio del profitto, si presenta per Böhm-Bawerk solo come una causa determinante ma non come l’unica causa: «mentre come seconda causa determinante,
indipendente da esso e anche dalla legge del valore, opera la grandezza del capitale esistente nella società»56. Quindi, a prescindere dall’argomento già citato
dal critico e secondo il quale non ha assolutamente senso parlare di «plusvalore
Ivi, p. 58; tr. it. cit., p. 39.
Ivi, p. 59; tr. it. cit., pp. 39-40.
55 Cfr. ivi, p. 66; tr. it. cit., pp. 46-47.
56 Ivi, p. 72; tr. it. cit., p. 53.
53 54 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
211
complessivo», come non ha senso parlare di «somme complessive» dei valori
e dei prezzi perché non si scambiano totalità ma solo singole merci; a prescindere quindi dal fatto che «non ha nessun senso applicare concetto e legge [del
valore] ad una totalità che in quanto tale non potrà mai entrare in quei rapporti
[di scambio dei beni]»57, ciò che definitivamente sconfessa il ragionamento di
Marx è il fatto che nella determinazione dei prezzi di produzione entrano cause determinanti «del tutto estrane[e] alla legge del valore»58. Anche il salario,
infatti, come si è accennato, entra come causa determinante dei prezzi e, dal
punto di vista di Böhm-Bawerk, il salario rappresenta una variabile in parte indipendente dalla legge del valore, in quanto, per la stessa ammissione di Marx,
esso può divergere dalla quantità di lavoro incorporata nei mezzi di sussistenza
dell’operaio. Detto altrimenti, anche il prezzo della forza-lavoro non coincide
col suo valore.
La conclusione allora è la seguente: «la quantità di lavoro, che secondo la
legge marxiana del valore dovrebbe dominare i rapporti di scambio delle merci in modo totale ed esclusivo, dimostra in effetti di essere soltanto una causa
determinante dei prezzi di produzione accanto ad altre cause determinanti»59.
Risulta, quindi, dimostrato, secondo Böhm-Bawerk, che Marx nel Primo libro
sviluppa una teoria interamente basata sulla legge del valore, mentre nel Terzo
riconosce di fatto l’influenza di altre cause determinanti che però non analizza
ma mette da parte insistendo sempre solo su una di quelle, ossia sulla quantità
di lavoro.
Tuttavia, la critica di Böhm-Bawerk non si ferma alla constatazione che nel
ragionamento complessivo di Marx vi è un errore fondamentale, ma vuole andare oltre e chiedersi da dove provenga questo errore. Arriviamo, quindi, alla
parte conclusiva del ragionamento del critico che è anche quella più interessante. In essa, infatti, si chiarisce ancor di più la modalità complessiva delle
argomentazioni di Böhm-Bawerk. Non dovrebbe sorprendere, dopo ciò che si
è detto delle argomentazioni del teorico del valore soggettivo, che l’errore di
Marx vada cercato a monte della sua teoria, cioè nella legge del valore e nell’asserzione secondo la quale il valore di scambio ha origine e misura nel tempo
di lavoro incorporato nelle merci. Ciò che rende insostenibile questa tesi è,
per Böhm-Bawerk, il metodo seguito da Marx. Questi non motiva la sua tesi
in modo puramente empirico, non utilizza il modo psicologico per indagare i
motivi che spingono le persone a scambiare e a fissare i prezzi ma «preferisce
Ivi, p. 71; tr. it. cit., p. 52.
Ivi, p. 73; tr. it. cit., p. 54.
59 Ivi, p. 74; tr. it. cit., p. 55.
57 58 212
Antonella Muzzupappa
presentare un terzo tipo di dimostrazione […] una dimostrazione puramente
logica […], una deduzione dialettica dell’essenza dello scambio»60. Ciò che in
sostanza non funzionerebbe nel ragionamento di Marx è proprio il primo passaggio: la ricerca di quel «qualcosa di comune» in base a cui i prodotti del lavoro possono equipararsi e scambiarsi tra loro. Che il lavoro sia la sostanza comune a tutte le merci Marx riesce a provarlo innanzitutto solo negativamente e, in
secondo luogo, solo al prezzo di «un peccato mortale di metodo»61: escludendo
dal gruppo delle cose scambiabili tutti quei beni che non sono prodotti del lavoro ma che, dice Böhm-Bawerk «sono tra i più importanti oggetti di proprietà
e commercio»62. In sostanza, il concetto di merce di Marx sarebbe molto più
ristretto di quello di «bene scambiabile» e Marx non fornirebbe alcuna spiegazione adeguata del perché costruisce il suo concetto in questo modo. Quella di
Marx, quindi, non è né una spiegazione né una dimostrazione: egli ha un’idea
preconcetta di ciò a cui vuole arrivare e tutto il suo ragionamento si presenta
come «un’invenzione a artificiosa a posteriori»63. La sua dimostrazione, esclusivamente negativa, del fatto che il lavoro è la sostanza comune a tutte le merci
poggia sull’illegittima astrazione dal valore d’uso.
Secondo Böhm-Bawerk l’autorità dei classici avrebbe indotto Marx ad argomentare in questo modo. Egli, però, non poteva non motivare la legge del valore-lavoro, come Smith e Ricardo, perciò, «non potendo appoggiarsi ai classici:
costoro infatti non avevano motivato proprio nulla»64, e non potendo neanche
«appellarsi né all’esperienza né ad una motivazione psicologico-economica […]
si rivolse alla speculazione logico-dialettica»65.
Per quanto attiene, poi, più da vicino la questione dei prezzi di produzione,
la conclusione di Böhm-Bawerk, a cui si è già accennato, è quella per cui Marx
per due volumi interi chiude gli occhi di fronte alle incongruenze tra la legge del
valore e ciò che l’esperienza mostra e «agisce come se esse non esistessero»66,
astrae da esse e presuppone sempre che le merci si scambino ai loro valori. Alla
fine, però, deve «aprire gli occhi sui fatti della vita reale»67 e deve ammettere
che l’investimento di capitale è decisivo per la partecipazione al profitto medio
e, nello stesso tempo, deve cercare di mantenere «l’armonia del sistema»68. La
Ivi, p. 81; tr. it. cit., p. 62.
Ivi, p. 83; tr. it. cit., p. 65.
62 Ivi, p. 84; tr. it. cit., ibidem.
63 Ivi, p. 82; tr. it. cit., p. 63.
64 Ivi, p. 92; tr. it. cit., p. 73.
65 Ibidem.
66 Ivi, p. 98; tr. it. cit., p. 79.
67 Ivi, p. 101; tr. it. cit., p. 81.
68 Ivi, p. 102; tr. it. cit., p. 82.
60 61 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
213
spiegazione della trasformazione dei valori in prezzi di produzione rappresenta
proprio il tentativo estremo, e non riuscito, di salvare tale armonia.
Nel discutere direttamente la trasformazione dei valori in prezzi di produzione Böhm-Bawerk può finalmente discutere la «posizione della concorrenza
nel suo [di Marx] sistema»69. Con la concorrenza giungiamo ad uno dei punti
centrali del disaccordo tra Böhm-Bawerk e Marx. Come è possibile immaginare, la critica generale che il teorico del valore soggettivo muove a Marx è quella
di non avere considerato la centralità della domanda e dell’offerta per la formazione dei prezzi. Bisogna però tener presente cosa significa per Böhm-Bawerk
«concorrenza». Definito, infatti, come «una sorta di nome collettivo per tutti gli
impulsi e i motivi psichici che regolano il comportamento delle parti sul mercato e che perciò influenzano la fissazione dei prezzi»70, il meccanismo della
domanda e dell’offerta influenza la formazione dei prezzi anche quando le due
sono in equilibrio, al contrario di ciò che abbiamo visto pensa Marx. Per BöhmBawerk non si ha mai «una totale neutralizzazione dell’azione che scaturisce
dalla domanda e dall’offerta»71 e tutto il ragionamento di Marx sarebbe sbagliato, in quanto domanda e offerta non solo non cessano di agire quando sono in
equilibrio, ma agiscono proprio creando l’equilibrio.
Infine, poi, Böhm-Bawerk rileva un’ulteriore contraddizione che fa del capitolo decimo del Terzo libro del Capitale un «capitolo malaugurato»72: se da
un lato Marx fa di tutto per ridurre al minimo il ruolo della concorrenza nel
meccanismo della formazione dei prezzi, essa diviene di nuovo determinante
quando si tratta della formazione del saggio medio di profitto. Le molteplici
contraddizioni e confusioni sono dovute tutte al fatto che se Marx avesse voluto essere lucido e rigoroso nell’esposizione di questi passaggi avrebbe dovuto necessariamente rinunciare alla legge del valore. «Marx si esprime qui in
modo confuso e contraddittorio – conclude Böhm-Bawerk – perché non poteva
farlo con chiarezza e precisione senza incorrere in un’aperta contraddizione e
ritrattazione»73.
L’approccio di Bortkiewicz al problema della trasformazione è radicalmente
diverso rispetto a quello del teorico del valore soggettivo. Innanzitutto, Bortkiewicz discute in maniera diretta il procedimento della trasformazione ed è il
primo a mettere in evidenza un punto che resterà centrale nelle discussioni suc-
Ibidem; tr. it. cit., p. 83.
Ibidem.
71 Ivi, p. 107; tr. it. cit., p. 87.
72 Ivi, p. 111; tr. it. cit., p. 91.
73 Ivi, p. 112; tr. it. cit., p. 92.
69 70 214
Antonella Muzzupappa
cessive sul procedimento marxiano. Egli dubita che sia possibile che il saggio
medio del profitto abbia quella funzione di mediazione tra il mondo dei valori e
quello dei prezzi di produzione, ossia dubita che sia possibile calcolare il saggio
medio del profitto prima e indipendentemente dai prezzi di produzione.
Al contrario di Böhm-Bawerk, Bortkiewicz riconosce, fin dall’inizio, che
Marx era da sempre stato consapevole della contraddizione esistente tra la vendita delle merci ai loro valori e la realtà del saggio medio di profitto. Ogni critica che non riconosce tale consapevolezza viene perciò definita da Bortkiewicz
come ingenua. Essa «sottintende, infatti, che Marx non soltanto non aveva una
conoscenza specifica dei fatti economici che erano l’oggetto della sua ricerca, ma
neppure conosceva la letteratura economica»74. Bortkiewicz si riferisce in particolare a Ricardo che già prima di Marx aveva costatato l’esistenza di un saggio
medio del profitto impossibile a formarsi se le merci vengono vendute ai loro
valori. Tuttavia, il fatto che Marx fosse pienamente consapevole della contraddizione e che avesse anche più volte annunciato che essa sarebbe stata risolta
ad un livello superiore dell’esposizione, non significa che il rapporto tra valori
e prezzi di produzione nel sistema di Marx non racchiuda «una contraddizione
non soltanto apparente ma reale e gravissima per l’intero sistema»75. Ciò che c’è
di utile, secondo Bortkiewicz, nel sistema marxiano (e in quello ricardiano) è
la tesi secondo cui «il pluslavoro è l’unica fonte del profitto capitalistico»76. La
particolarità dell’approccio di questo autore, pertanto, sta nel fatto che egli ritiene di poter mantenere, anzi che si debba mantenere, la spiegazione marxiana
dell’origine del profitto pur rifiutando il procedimento della trasformazione dei
valori in prezzi di produzione.
Punto di partenza della sua argomentazione è il fatto che il valore in Marx è
innanzitutto l’«indice di un rapporto di scambio»77 e la sua grandezza «è determinata secondo la legge (marxiana) del valore»78. Il prezzo di produzione, dal
canto suo, è, esattamente come il valore, l’indice di un rapporto di scambio, che
però non si realizza in base alle legge del valore stesso, bensì in base alla legge
dell’uguale saggio del profitto. Valore e prezzo sono entrambi costruzioni teoriche che rappresentano due diversi gradi di approssimazione alla realtà. Il procedimento con cui Marx trasforma i valori in prezzi di produzione, e che abbiamo
74 L. von Bortkiewicz, Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen System, Lollar/Gießen 1976, p. 31; tr. it. G. Panzieri Saija, Calcolo del valore e calcolo del prezzo nel sistema marxiano, in Id., La teoria economica di Marx, a cura di L. Meldolesi, Torino 1971, p. 5.
75 Ivi, p. 33; tr. it. cit., p. 7.
76 Ivi, p. 76; tr. it. cit., p. 40.
77 Ivi, p. 78; tr. it. cit., p. 42.
78 Ibidem.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
215
descritto sopra, è per Bortkiewicz «errato, perché con esso non è possibile tenere rigorosamente separati i due principi del calcolo del valore e del calcolo del
prezzo»79. L’errore fondamentale di Marx starebbe nel fatto che nel suo procedimento della trasformazione egli esclude i capitali costanti e variabili investiti
nelle diverse sfere di produzione dalla conversione stessa. Il fatto che le differenze tra valori e prezzi si annullano vicendevolmente o la considerazione per cui
le leggi nel modo capitalistico di produzione si affermano solo come tendenze,
non aiuta, secondo Bortkiewicz, a salvare il procedimento marxiano. Per quanto
riguarda il primo punto, è possibile dimostrare che «la proposizione dell’uguaglianza tra valore totale e prezzo totale, è in generale errata»80 e, in riferimento al
secondo punto, è possibile dimostrare che le contraddizioni non sono inerenti al
complesso del sistema capitalistico ma «allo schema teorico in quanto tale»81.
La conclusione, quindi, è il rifiuto della derivazione dei prezzi di produzione dai valori così come Marx l’ha presentata, ma non «l’idea di questo doppio
calcolo»82. Si tratta, quindi, per Bortkiewicz, di cercare di correggere i calcoli
marxiani nella convinzione che «una soluzione corretta del compito teorico che
Marx aveva posto a se stesso permetterebbe […] di esaminare più a fondo importanti relazioni economiche»83 e, soprattutto, di dimostrare che, quand’anche
la trasformazione dei valori in prezzi di produzione sia sbagliata, è possibile
mantenere il più importante assunto di Marx, e cioè che l’origine del profitto
sta nel pluslavoro degli operai.
Bortkiewicz propone due tipi di soluzioni al problema della trasformazione.
La prima, contenuta nel saggio Calcolo del valore e calcolo del prezzo nel sistema
marxiano, segue le equazioni scoperte da Dmitrieff84 ed è definibile come «soluzione ricardiana»; la seconda, invece, si mantiene più vicina agli schemi teorici
di Marx in quanto si lega direttamente agli schemi della riproduzione.
Il punto più debole del procedimento marxiano starebbe, come si è accennato, nel fatto che nel suo calcolo Marx tratta il capitale costante e il capitale variabile investiti come valori e su questa base determina il saggio medio del profitto. «Non si può accettare come valida questa soluzione del problema – scrive
Bortkiewicz – perché qui vengono esclusi dalla conversione dei valori in prezzi
Ivi, p. 82; tr. it. cit., p. 45.
Ivi, p. 84; tr. it. cit., p. 47.
81 Ivi, p. 88; tr. it. cit., p. 51.
82 Ibidem.
83 Ivi, pp. 88-89; tr. it. cit., ibidem.
84 La soluzione algebrica di Dmitrieff è contenuta nel suo lavoro Studi economici, serie I,
Tentativo di una sintesi organica della teoria del valore del lavoro con la teoria dell’utilità marginale, pubblicato a Mosca nel 1904 (in russo).
79 80 216
Antonella Muzzupappa
i capitali costanti e variabili»85. Marx stesso, del resto, aveva osservato: «Questa
asserzione – riferendosi all’uguaglianza delle somme dei valori e dei prezzi –
sembra in contrasto col fatto che nella produzione capitalistica gli elementi del
capitale produttivo sono di regola acquistati sul mercato»86, acquistati, cioè, a
determinati prezzi (e non ai loro valori) e «per conseguenza il prezzo di produzione di un ramo dell’industria insieme col profitto che esso contiene entra nel
prezzo di costo dell’altro»87. Si tratta, però, secondo Marx, solo del fatto che «la
legge generale si afferma come tendenza predominante solo in un modo assai
complicato e approssimativo, sotto forma di una media, che non è mai possibile determinare, di oscillazioni incessanti».88 Marx, cioè, non ritiene che questa
questione possa inficiare il ragionamento complessivo, mentre proprio questo
punto viene messo al centro dai critici della trasformazione e considerato come
difficoltà insormontabile. La stessa cosa si può esprimere anche da un altro
punto di vista, dicendo cioè che la difficoltà della trasformazione dipende dal
circolo vizioso che si crea tra saggio medio del profitto e prezzi di produzione:
non è possibile determinare il saggio medio del profitto senza conoscere i prezzi e, viceversa, non è possibile conoscere i prezzi senza avere già determinato
il saggio medio del profitto. Nel Terzo libro del Capitale, del resto, si legge che
i prezzi di produzione «sono basati sul presupposto dell’esistenza di un saggio
generale del profitto»89 e, contemporaneamente, che «è solo la vendita [delle merci] a tali prezzi che rende possibile un saggio del profitto uniforme»90.
Marx però, come detto, conclude che tutto questo non inficia il ragionamento
generale e che l’indagine che si sta compiendo «non richiede che ci si addentri
in un esame più particolareggiato di questo punto.»91 Per Bortkiewicz, invece,
la difficoltà della trasformazione dipende proprio da questa interdipendenza
tra prezzi e saggio medio del profitto. Tale difficoltà può risolversi per l’autore
soltanto determinando simultaneamente i due fattori e facendo entrare nella
determinazione del saggio medio del profitto soltanto la produzione dei beni
che direttamente o indirettamente entrano nella produzione dei beni-salario
piuttosto che tutte le attività produttive, come nello schema di Marx. Questo
85 L. von Bortkiewicz, Zur Berechtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von
Marx im dritten Band des „Kapital“, in Id., Wertrechnung und Preisrechnung im Marxschen
System, cit., p. 158; tr. it. G. Panzieri Saija, Per una rettifica dei fondamenti della costruzione
teorica di Marx nel terzo volume del Capitale, in Id., La teoria economica di Marx, cit., p. 107.
86 MEGA2, II/15, cit., p. 161; MEW, Bd. 25, cit., p. 169; tr. it. cit., p. 200.
87 Ibidem.
88 Ivi, p. 162; ivi, p. 171; tr. it. cit., p. 202.
89 Ivi, p. 158; ivi, p. 167; tr. it. cit., p. 198.
90 Ibidem.
91 Ibidem.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
217
primo schema di Bortkiewicz, però, come osserva Luca Meldolesi, «non è capace di esprimere una caratteristica del sistema economico che Marx considerava
centrale, vale a dire la sua riproducibilità»92.
Partendo, allora, dall’osservazione di Marx secondo cui, nella produzione
capitalistica, anche i mezzi di produzione e la forza lavoro sono acquistati sul
mercato, cosicché anche i valori dei capitali anticipati devono essere trasformati in prezzi, Bortkiewicz costruisce un secondo schema: un sistema di tre
equazioni a quattro incognite e, per ottenere la quarta equazione necessaria
alla soluzione, pone il prezzo di una merce uguale a 1. Tale merce viene usata,
quindi, come «merce-misura». A questo punto l’autore dimostra la coerenza interna del modello e la possibilità di giustificare tanto la riproduzione semplice
quanto quella allargata, giustificazione che il modello di Marx non consentirebbe. Seguendo il modello di Bortkiewicz, però, il saggio del profitto non dipende
più, come in Marx, dal saggio del plusvalore e dalla composizione organica
media del capitale, bensì «soltanto dalle condizioni di produzione del capitale
variabile e costante»93. Con un esempio numerico, l’autore intende dimostrare
che «sono possibili dei casi in cui, dato il saggio del plusvalore, un medesimo
saggio del profitto è conciliabile con una differente composizione organica del
capitale sociale totale»94. Sarebbe troppo lungo e complesso riportare qui nel
dettaglio la dimostrazione di Bortkiewicz, del resto ci interessa semplicemente
osservare che il problema posto dall’autore a la sua soluzione rappresentano
nel dibattito sulla trasformazione un punto di svolta. È su questo tipo di schema, infatti, che Piero Sraffa95 avrebbe costruito la sua soluzione al problema
dei prezzi. Essa può essere considerata una generalizzazione dello schema di
Bortkiewicz che è valido soltanto in un’economia in cui non si producono più
di tre merci, una per ogni settore. Sraffa, allora, costruisce un sistema che ha
tante equazioni quante sono le merci prodotte e che può essere risolto sempre
ricorrendo all’equazione della merce-misura.
92 L. Meldolesi, Il contributo di Bortkiewicz alla teoria del valore, della distribuzione e dell’origine del profitto, in L. von Bortkiewicz, La teoria economica di Marx, cit., p. XXXVIII.
93 Ivi, p. XL.
94 L. von Bortkiewicz, Zur Berechtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von
Marx im dritten Band des „Kapital“, cit., p. 164; tr. it. cit., p. 113.
95 Cfr. P. Sraffa, Production of commodities by means of commodities: prelude to a critique of
economic theory, Cambridge 1960; tr. it., Produzione di merci a mezzo di merci. Premessa a una
critica della teoria economica, Torino 1991. Bisogna osservare che mentre Bortkiewicz propone
la sua soluzione come esplicita via d’uscita alle difficoltà della trasformazione marxiana, Sraffa non ha mai fatto alcun riferimento diretto a Marx. La sua critica, anzi, era diretta ai sostenitori dell’utilità marginale. Se il suo testo è diventato così famoso nell’ambito del dibattito sulla
trasformazione marxiana, ciò è dovuto all’utilizzo che di esso hanno fatto gli «sraffiani».
218
Antonella Muzzupappa
Ciò che a nostro avviso è determinante di questo approccio rispetto alla soluzione marxiana è il fatto che, a questo punto, le quantità di lavoro, che nello
schema di Marx sono determinanti per i valori di scambio, non hanno più nessuna funzione e possono essere sostituite dalle quantità fisiche delle merci prodotte. Ritorneremo su questo punto, in quanto è su di esso che si basa la critica
a Marx secondo cui la teoria del valore-lavoro sarebbe ridondante.
Ora, invece, vediamo quali sono le altre conseguenze immediate del calcolo simultaneo. Innanzitutto, se si calcolano simultaneamente i prezzi e il saggio medio
del profitto, non si può mantenere la relazione marxiana tra calcolo del valore e
calcolo del prezzo. Il saggio medio del profitto perde la caratteristica di essere l’elemento di mediazione tra i valori e i prezzi, e il plusvalore totale è diverso dal profitto
totale. Sembra, quindi, che il calcolo simultaneo metta in discussione i presupposti
più importanti dell’analisi marxiana, quegli stessi presupposti che, come abbiamo
visto, Bortkiewicz voleva mantenere in quanto parte migliore dell’analisi.
In sostanza, calcolando simultaneamente prezzi e profitto, ci troviamo in un
schema nel quale le merci si producono a mezzo di merci e il capitale produce
profitto grazie a sue «segrete qualità». In uno schema del genere, cioè, sembra
sparire completamente quella differenza, per Marx così importante, tra capitale
variabile e capitale costante: il capitale variabile perde la sua qualità specifica,
quella di essere capace di produrre nuovo valore, «il plusvalore deriva contemporaneamente da tutte le parti del capitale impiegato»96 e «si completa la mistificazione del processo di valorizzazione del capitale»97.
Tuttavia, proprio su questo punto la discussione è aperta e vivace, in quanto
non tutti gli studiosi sono concordi nel dire che il calcolo simultaneo sia inconciliabile con gli elementi di fondo dell’analisi marxiana. Del resto, lo stesso
Bortkiewicz intendeva correggere l’errore di Marx «senza però sovvertire la sua
impostazione del problema»98.
Ritorneremo su questo punto nelle nostre conclusioni, mentre ora passiamo a
discutere le due posizioni contemporanee sul problema della trasformazione.
5. Due punti di vista contemporanei sulla «trasformazione»
Böhm-Bawerk e Bortkiewicz rappresentano le prime due posizioni critiche
sul problema della trasformazione, i primi autori che, dopo la pubblicazione
MEGA2, II/15, cit. pp. 39-40; MEW, Bd. 25, cit., p. 46; tr. it. cit., p. 62.
Ivi, p. 38; ivi, p. 44; tr. it. cit., p. 60.
98 L. von Bortkiewicz, Zur Berechtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von
Marx im dritten Band des „Kapital“, cit., p. 156; tr. it. cit., p. 105.
96 97 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
219
del Terzo libro del Capitale, hanno discusso il procedimento marxiano mettendone in discussione, da punti di vista diversi, la validità. Se però Böhm-Bawerk
ha inteso criticare l’approccio complessivo di Marx all’economia, Bortkiewicz,
almeno nelle premesse, riconosce validità alla legge del valore-lavoro e mette
in discussione solo il procedimento della trasformazione, nella convinzione che
sia possibile correggerlo senza inficiare le basi della teoria di Marx.
Come si è accennato all’inizio, a partire da questi autori, si è sviluppato, durante tutto il Novecento e fino ad oggi, un vasto dibattito sul cosiddetto «problema della trasformazione» senza peraltro che le posizioni in gioco abbiano trovato una sintesi. Anche restringendo il campo al «marxismo», possiamo rilevare che gli studiosi non hanno raggiunto una posizione univoca né sul problema
specifico né tantomeno sull’importanza che la questione della trasformazione
ha nel complesso della teoria marxiana.
Non potendo evidentemente ricostruire l’intero dibattito sulla questione, ci
limitiamo qui ad analizzare due posizioni contemporanee a nostro avviso particolarmente significative.
Con tutti i limiti delle schematizzazioni possiamo dire che la prima posizione che prendiamo in considerazione è quella dei sostenitori del cosiddetto Temporal Single-System Interpretation (TSSI)99 e la seconda è quella della cosiddetta
neue Marx-Lektüre100.
99 Nel corso del nostro scritto lo citeremo nella traduzione italiana: «Sistema Singolo Temporale» (SST).
100 Con neue Marx-Lektüre intendiamo qui una corrente interpretativa per molti aspetti
diversa dal cosiddetto neomarxismo. Si tratta di un fenomeno soprattutto tedesco che vede
tra i suoi più importanti rappresentanti Hans Georg Backhaus, Helmut Reichelt, Heinz Dieter
Kittsteiner, e Michael Heinrich al quale ci riferiremo in modo particolare nella nostra esposizione. Bisogna precisare, inoltre, che anche l’interpretazione di questi autori non è univoca e
che vi sono, tra di loro, molte differenze. Essi tutti, però, partono da una critica complessiva
alla modalità con cui Engels ha interpretato tanto il cosiddetto materialismo storico quanto
la critica dell’economia politica di Marx. (Si veda, tra l’altro, H.G., Backhaus, Dialektik der
Wertform. Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik, Freiburg/Br 1997; E. Reichelt, Zur
logischen Struktur des Kapitalsbegriffs bei Karl Marx, Frankfurt/M 1970, tr. it. F. Coppellotti,
La struttura logica del concetto di capitale in Marx, Bari 1973; H.D. Kittsteiner, „Logisch“ und
„Historisch“. Über die Differenz des Marxschen und Engelsschen Systems der Wissenschaft, in
«Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschite der deutschen Arbeiterbewegung», 13. Jg., H. 1, Berlin 1977, pp. 1-47). Per ulteriori indicazioni sulla neue Marx-Lektüre,
anche in relazione alle altre interpretazioni e correnti del marxismo, si può vedere, tra l’altro:
I. Elbe, Marx im Westen. Die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965, Berlin 2008.
Una posizione vicina a quella della neue Marx-Lektüre è rappresentata in Italia da Roberto
Fineschi. Si veda, per esempio, R. Fineschi, Ripartire da Marx. Processo storico ed economia
politica nella teoria del «capitale», Napoli 2001. Vicine ad alcune delle posizioni di Michael
Heinrich sono quelle di Riccardo Bellofiore. (Si veda, tra l’altro, R. Bellofiore, Per una teoria
monetaria del valore-lavoro. Problemi aperti nella teoria marxiana, tra radici ricardiane e nuove
vie di ricerca, in Valori e prezzi, a cura di G. Lunghini, Torino 1993, pp. 63-117).
220
Antonella Muzzupappa
I sostenitori del Sistema Singolo Temporale pensano che il calcolo simultaneo, del quale abbiamo parlato in relazione a Bortkiewicz e Sraffa, sia assolutamente incompatibile con i presupposti dell’indagine marxiana e ritengono di
poter dimostrare, anche matematicamente, la validità complessiva del sistema
marxiano, compresa la trasformazione dei valori in prezzi di produzione, senza
fare ricorso al simultaneismo.
Dal loro punto di vista, il problema della trasformazione è un «falso problema» che si presenta come tale soltanto a chi interpreti il sistema marxiano in
maniera erronea o partendo da presupposti che, lungi dall’articolare una vera
e propria critica alla teoria di Marx, rappresentano semplicemente una teoria
diversa. Il punto centrale del sistema proposto da studiosi come Freeman, Kliman e Carchedi è nel fattore tempo e nell’utilizzazione di un differente formalismo matematico rispetto a quello abitualmente utilizzato dai critici di Marx.
Mettendo al centro il tempo che trascorre tra l’acquisto dei mezzi di produzione
e la vendita del prodotto finito è possibile, secondo i rappresentati del Sistema
Singolo Temporale, risolvere il presunto circolo vizioso di cui si è detto parlando
di Bortkiewicz. Il problema che discutiamo ha al centro il fatto che, nella soluzione proposta da Marx, il capitale variabile e il capitale costante investiti per la
produzione delle merci venivano calcolati in termini di valori pur trattandosi di
merci acquistate sul mercato. Gli studiosi che propongono il calcolo dei prezzi
insistendo sul fattore tempo sostengono che il problema non si pone nella misura in cui «i mezzi di produzione comprati e venduti all’inizio di un processo
non sono gli stessi mezzi di produzione comprati e venduti alla fine dello stesso
processo, e quindi non vi è nessuna ragione di supporre che abbiano lo stesso
prezzo»101. Mettendo da parte il fattore tempo, quindi, i critici di Marx eliminano un elemento fondamentale che, preso in considerazione, «toglie qualsiasi
incoerenza alla teoria di Marx»102. Inoltre, quando questi critici discutono della
modalità con cui Marx tratta il capitale costante e quello variabile investiti nelle diverse sfere di produzione, considerano le grandezze espresse da Marx in
termini percentuali come dei valori assoluti e soltanto per questo si trovano di
fronte a contraddizioni e problemi103.
Bortkiewicz, ad esempio, può parlare di errore insito nella teoria marxiana
soltanto perché non prende in considerazione il fatto che questa è essenzialmente una teoria del non-equilibrio, piuttosto che una teoria dell’equilibrio.
101 L. Vasapollo, La teoria del valore in Marx per l’attualità scientifica della critica al capitalismo, in Id. (a cura di), Un vecchio falso problema, cit., p. 29.
102 Ibidem.
103 Cfr. G. Carchedi, Il problema inesistente, cit., pp. 56-57.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
221
«Tutti gli errori e tutte le incoerenze – scrive Alan Freeman – non sgorgano
da Marx ma dal tentativo di interpretare Marx come se fosse un economista
dell’equilibrio»104.
Con questa osservazione, siamo ad un punto centrale dell’interpretazione
che questi studiosi danno di Marx e, in generale, ad un punto centrale e molto
discusso nell’ambito del marxismo. La questione «equilibrio» o «squilibrio»,
infatti, può essere espressa come la questione dell’origine delle crisi. Ciò su cui
i sostenitori del Sistema Singolo Temporale insistono è che in Marx, al contrario
che negli economisti e studiosi che lo criticano, la crisi è un fenomeno strutturalmente legato all’economia capitalistica. L’origine e la possibilità della crisi
non stanno fuori del sistema, la crisi non è un fenomeno esterno e accidentale
rispetto al capitale ma è prodotta dal capitale stesso. Ciò viene effettivamente
espresso da Marx in più punti della sua opera e a diversi livelli di esposizione.
Nell’ambito dell’analisi della merce e del denaro, per esempio, ad un livello
molto alto di astrazione, Marx mette in rilievo che nelle contraddizioni inerenti
la merce e il denaro è contenuta già la possibilità della crisi, in quanto la trasformazione della merce in denaro è, nello stesso tempo, necessaria perché il
processo funzioni, ma anche un «salto mortale»105 che potrebbe non avvenire.
Nel descrivere, poi, nel Terzo libro del Capitale, i fenomeni legati alla caduta
tendenziale del saggio del profitto, Marx scrive: «Il vero limite della produzione
capitalistica è il capitale stesso»106. Esso, infatti, per potere valorizzarsi deve
sviluppare enormemente le forze produttive della società ma tale sviluppo trova
ad un certo punto un limite nei rapporti di produzione orientati esclusivamente alla produzione del capitale. «Se il modo di produzione capitalistico – continua Marx – è quindi un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva
materiale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo
stesso la contraddizione costante tra questo suo compito storico e i rapporti di
produzione sociali che gli corrispondono»107. Nei teorici dell’equilibrio, invece,
la crisi viene sempre vista come il risultato di fattori esterni ed estranei alla
dinamica capitalistica che, quindi, possono essere corretti e regolamentati. Il
Sistema Singolo Temporale, al contrario, offrirebbe una spiegazione delle crisi
tutta interna alla logica del sistema marxiano, assumendone cioè i presupposti
fondamentali che, in sostanza, andrebbero assunti anche qualora si volesse cri-
104 A. Freeman, Valore e Marx: perché sono importanti, in L. Vasapollo (a cura di), La teoria
del valore in Marx, cit., p. 65.
105 MEGA2, II/2, cit., p. 159; MEW, Bd. 13, cit., p. 71; tr. it. cit., p. 69.
106 MEGA2, II/15, cit., p. 246; ivi, Bd. 25, cit., p. 260; tr. it. cit., p. 303.
107 Ivi, p. 247; ibidem; tr. it. cit., ibidem.
222
Antonella Muzzupappa
ticare quel sistema. Da un punto di vista generale, questi autori sostengono che
le critiche al procedimento marxiano vengono quasi sempre condotte adottando criteri e concetti estranei al punto di vista di Marx e «se si adotta un insieme
diverso di concetti, si ottiene – necessariamente – una teoria diversa»108. Come
si è accennato, questo tipo di osservazione metterebbe fuori gioco tanto le argomentazioni di Bortkiewicz quanto la fortunata generalizzazione che di esse
ha fatto Sraffa. Se l’autore di Produzione di merci a mezzo di merci non ha inteso
criticare Marx, i suoi seguaci, al contrario, hanno fatto della critica al Capitale
uno dei loro obiettivi più importanti e hanno articolato tale critica sempre partendo dalla procedura marxiana della trasformazione dei valori in prezzi. Alle
loro critiche, i sostenitori del Sistema Singolo Temporale rispondono, appunto,
rilevando che «impiegando un differente formalismo matematico […] – che
non sia il calcolo simultaneo – tutti i risultati della trasformazione del capitolo
9 del III libro del Capitale si sono rivelati dimostrabili in modo formalmente
rigoroso»109. Anche se questo non significa immediatamente che il procedimento marxiano sia esatto, dimostra però che vi è la possibilità di dimostrare l’interna consistenza della procedura marxiana se si rinuncia al calcolo simultaneo. Del resto, dimostrare la coerenza logica interna al discorso marxiano è uno
degli obbiettivi più importanti che questi autori si pongono nella convinzione
che non sia possibile sostenere che nel Capitale vi sono tutte quelle contraddizioni che i critici di Marx trovano. Le contraddizioni non sarebbero in Marx ma
«tra le teorie originarie e certe interpretazioni che non riescono a dare senso a
tali teorie»110. Intanto, sostengono questi autori, si possono scorgere contraddizioni nel sistema marxiano, in quanto vengono a priori rigettati i presupposti
più importanti di tale sistema, primo fra tutti la teoria del valore. Anche la valutazione simultanea, di fatto, si comporta in questo modo. Ciò che essa in prima
istanza nega è proprio la possibilità del cambiamento dei prezzi e dei valori
nel tempo, assunto invece fondamentale del sistema marxiano. «La valutazione
simultanea – scrive Kliman – in effetti impedisce ai cambi nella produttività
di influenzare il prezzo, o valore» con la conseguenza che, di fatto, il profitto è
completamente svincolato dal lavoro non retribuito dei lavoratori111.
A. Freeman, Valore e Marx: perché sono importanti, cit., p. 65.
P. Giussani, Sulla teoria economica di Piero Sraffa, in L. Vasapollo (a cura di), La teoria
del valore in Marx, cit., p. 82.
110 A. Kliman, Se è corretto non correggetelo, in L. Vasapollo (a cura di), La teoria del valore
in Marx, cit., p. 90.
111 Del resto, Dmitrieff, ai cui calcoli Bortkiewicz si richiama, aveva inteso proprio dimostrare che il profitto non richiede per nulla lavoro umano e cercò di immaginare una situazione nella quale le macchine producessero tutti i beni senza che fosse necessario il lavoro vivo.
In sostanza, egli provò a dimostrare che le macchine, al contrario di quanto sostiene Marx,
108 109 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
223
La conclusione a cui di fatto arrivano molte delle critiche mosse a Marx e al
procedimento della trasformazione, quindi, è quella della «ridondanza» della legge del valore. Come abbiamo visto, infatti, il calcolo simultaneo può prescindere
completamente dalle grandezze di valore espresse in termini di tempo di lavoro
e sostituirle con «quantità fisiche» dei beni. La conseguenza di questo tipo di approccio è che non ha più senso parlare neanche di deviazioni dei prezzi dai valori,
il problema del «trasformare» non si pone più e i prezzi sono semplicemente uguali ai valori. Tale conclusione dipende, secondo Kliman, proprio dalla valutazione
simultanea la quale rifiuta di ammettere che il valore non è costante, ma dipende
dalla produttività del lavoro. Per cui sarebbe l’approccio simultaneista a rendere
ridondante la legge del valore e non la legge del valore ad essere ridondante in sé.
Da un punto di vista più generale, i rappresentanti del Sistema Singolo Temporale insistono su un’altra questione molto importante. Se l’impianto teorico
marxiano cerca di spiegare il modo capitalistico di produzione insistendo sulla
sua storicità e quindi ci presenta la forma particolare che determinati rapporti
assumono in determinate condizioni storiche e sociali, l’approccio che mette al
centro il valore d’uso e la quantità fisica dei beni assimila immediatamente «la
società capitalistica […] ad un organismo naturale autoriproducibile»112. Il cosiddetto «calcolo fisicalista» sostituisce, infatti, il calcolo che in Marx è fatto a
partire dal valore e dall’espressione monetaria del valore, col calcolo in termini
di beni, per esempio grano. Questo grano, però, o qualsiasi altro bene si voglia
prendere in considerazione, non viene più considerato come merce, ma semplicemente come prodotto, come valore d’uso.
La domanda sulla specifica forma che il prodotto del lavoro assume all’interno di determinate condizioni viene completamente cancellata e tutte le categorie che, in Marx, sono categorie specifiche del modo di produzione capitalistico «divengono categorie naturali»113. Merce, valore, denaro, capitale, profitto,
ecc. non rappresentano più forme specifiche e storicamente determinate della
produzione, ma elementi della produzione tout court, che, per Marx, non esiste114, perché si dà sempre una forma di produzione storicamente determinata.
sono capaci di produrre nuovo valore. (Cfr. V.K., Dmitrieff, Saggi economici, tr. it. M. De Cecco,
Torino 1972)
112 A. Ramos, Teoria del valore e bancarotte, in L. Vasapollo (a cura di), Un vecchio falso
problema, cit., p. 110.
113 Ivi, p. 112.
114 Nell’Introduzione del 1857 si legge, ad esempio: «Quando si parla dunque di produzione,
si parla sempre di produzione ad un determinato livello di sviluppo sociale – della produzione
di individui sociali». (MEGA2 II/1.1, cit., p. 22; MEW, Bd. 42, cit., p. 20; tr. it. cit., p. 6). Si può
naturalmente utilizzare la categoria astratta «produzione in generale» ma soltanto «nella misura
in cui mette effettivamente in rilievo l’elemento comune, lo fissa e ci risparmia una ripetizione»
224
Antonella Muzzupappa
In sostanza, quindi, a parere degli esponenti del Sistema Singolo Temporale,
le cosiddette «teorie dell’equilibrio» che teorizzano un’economia senza tempo,
si presentano come una giustificazione ideologica dell’esistenza del capitalismo. Anche l’approccio simultaneista, come si è accennato, rappresenterebbe
un sistema in equilibrio quindi «funzionale alla teorizzazione di un’economia
capitalistica nella quale lo sfruttamento non esiste e […] senza crisi»115.
Per riassumere sulla specifica questione della trasformazione potremmo
dire che i sostenitori del Sistema Singolo Temporale rigettano completamente le
argomentazioni critiche che vengono da parte degli economisti dell’equilibrio
e ritengono che «l’approccio temporale riproduce tutti i risultati che sono stati
contestati dai critici di Marx. Nel caso specifico del problema della trasformazione, riproduce le sue due uguaglianze fondamentali e cioè quella tra il plusvalore totale e i profitti totali e tra il valore totale e i prezzi totali»116.
Alla cosiddetta «critica della circolarità», che riguarda il problema della
conversione in prezzi anche dei mezzi di produzione e dei salari investiti, abbiamo visto che questi studiosi rispondono sottolineando l’importanza del fattore tempo.
Alla critica della «regressione all’infinito», secondo cui per calcolare il valore
di un prodotto in un dato periodo bisogna conoscere il valore dei suoi mezzi
di produzione essi rispondono che «tale ragionamento renderebbe impossibile
qualsiasi scienza, compresa quella su cui si basa la critica»117. L’argomentazione secondo cui i mezzi di produzione che si utilizzano in dato periodo sono a
loro volta prodotti di un periodo precedente e quindi per conoscerne il valore
bisogna fare un ulteriore passo indietro non consentirebbe di individuare alcun
punto di partenza come dato, cosa di cui ogni scienza ha bisogno. Nel caso
del valore dei mezzi di produzione, inoltre, regredire all’infinito sarebbe anche
sbagliato in quanto il valore di una determinata merce corrisponde sempre a
ciò che essa vale nel presente e non a ciò che essa valeva in anni o periodi precedenti. «Il valore di un computer nel 2001 – scrive Carchedi – è dato da quello
(Ibidem; ivi, pp. 20-21; tr. it. cit., ibidem) e «le determinazioni che valgono per la produzione in generale devono essere isolate proprio affinché per l’unità […] non venga poi dimenticata la diversità
essenziale. In questa dimenticanza consiste appunto tutta la saggezza degli economisti moderni
che dimostrano l’eternità e l’armonia dei rapporti sociali esistenti». (Ibidem; ivi, p. 21; tr. it. cit.,
ibidem). Come si vede, Marx critica a Smith e a Ricardo proprio il fatto di rendere naturali e quindi eterni ed armonici rapporti che, invece, sono storicamente determinati e perciò suscettibili di
trasformazione.
115 G. Carchedi, L’arte del fare confusione, in L. Vasapollo (a cura di), Un vecchio falso problema, cit., p. 136.
116 Ivi, p. 121.
117 Ivi, p. 131.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
225
che l’economia ritiene che esso valga nel 2001 e non da quello che i suoi input
valessero nel 2000»118. Il valore a cui l’economia è interessata è il valore attuale
di una determinata merce e non il suo valore storico.
Concludendo, quindi, la trasformazione dei valori in prezzi di produzione
viene definita, in totale accordo con Marx, semplicemente come «una redistribuzione del plusvalore totale prodotto tale che i settori a basso tasso di profitto
vendono ad un prezzo che assicura il tasso medio di profitto e i settori ad alto
tasso di profitto vendono ad un prezzo che riduce il loro tasso alla media»119. A
rigore, quindi, la trasformazione non sarebbe veramente tale, cioè trasformazione di qualcosa in qualcosa di qualitativamente diverso, ma solo una diversa redistribuzione di tutto il valore prodotto. Essa rappresenterebbe semplicemente «la differenza tra […] il tempo di lavoro che è stato necessario a produrre
una merce […] e il tempo di lavoro socialmente necessario»120.
Vediamo, ora, come si presenta il punto di vista della neue Marx-Lektüre attraverso uno dei suoi più importanti rappresentanti.
Partendo da alcuni spunti metodologici di Althusser121, senza però accettare
l’intero punto di vista del filosofo francese, e partendo da alcune dalle analisi di Hans-Georg Backhaus122, Michael Heinrich sviluppa una lettura di Marx
e delle categorie centrali della critica dell’economia politica che insiste molto
sulla «forma» e sull’analisi dei rapporti qualitativi piuttosto che su quelli quantitativi. Uno dei punti più importanti della lettura che Heinrich fa della critica
dell’economia politica e che è determinante per l’interpretazione che egli dà
della trasformazione dei valori in prezzi di produzione, riguarda l’oggettività
del valore (Wertgegenständlichkeit) che, a sua volta, è legata all’interpretazione
della categoria del «lavoro astratto». «Le merci – scrive Heinrich – possiedono
Wertgegenständlichkeit non in quanto oggettivazione di lavoro concreto, bensì in quanto oggettivazione di lavoro astratto. Se però […] [il] lavoro astratto
è un rapporto di valore (Geltungsverhältnis) esistente socialmente solo nello
scambio, allora anche la Wertgegenständlichkeit della merce esiste solo nello
scambio»123. Solo all’interno di una relazione è possibile parlare di Wertgegenständlichkeit, in quanto il valore stesso non è una cosa, bensì un rapporto socia-
Ibidem.
Id., Il problema inesistente, cit., p. 54.
120 Id., L’arte del fare confusione, cit., p. 125.
121 Cfr. in particolare, L. Althusser, L’objet du «Capital», in AA. VV., Lire le Capital, Paris
1996, pp. 245-418; tr. it. F. Raimondi, L’oggetto del Capitale, in AA. VV., Leggere il Capitale,
Milano 2006, pp. 165-270.
122 Cfr. in particolare, H.G. Backhaus, Dialektik der Wertform, cit.
123 M. Heinrich, Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung, Stuttgart 2005, p. 51.
118 119 226
Antonella Muzzupappa
le che si presenta sottoforma di proprietà delle cose e che trova il suo migliore
rappresentante materiale nel denaro. La teoria del valore di Marx, viene allora
definita come una «teoria monetaria del valore» in opposizione a coloro i quali
la considerano come una «teoria sostanzialistica del valore»124.
La tesi di fondo che Heinrich presenta è la seguente: «certamente Marx entra in
un nuovo terreno scientifico […] ma nel suo discorso si ritrova anche il discorso dei
classici»125. Quindi, se da un lato si può parlare rispetto a Marx di una «rivoluzione
scientifica», dall’altro lato non bisogna dimenticare che tale rivoluzione, come ogni
rivoluzione scientifica, non è completa. Nelle categorie e nel discorso marxiano
restano, secondo Heinrich, molti elementi di Smith e Ricardo. Questa constatazione, tuttavia, non intende mettere in discussione la dirompente novità della critica
dell’economia politica, ma si propone di osservare attentamente le due teorie, quella marxiana e quella classica, «identificare gli elementi di questi due discorsi, per
eliminare le ambivalenze di categorie centrali e per distinguere i veri problemi da
problemi semplicemente apparenti»126.
Per quanto attiene più precisamente il problema della trasformazione dei
valori in prezzi di produzione, Heinrich ritiene innanzitutto che non è possibile
mantenere il presupposto marxiano dell’acquisto dei mezzi di produzione ai
loro valori e basare su questo il procedimento della trasformazione: «i prezzi
di costo non possono essere determinati prima dei prezzi di produzione perché
gli stessi prezzi di costo dipendono dai prezzi di produzione»127. La «critica
della circolarità», quindi, sarebbe fondata e «saggio medio del profitto e prezzi di produzione non si lasciano determinare l’uno dopo l’altro ma soltanto
simultaneamente»128. Da questo punto di vista, allora, e poiché, come abbiamo
accennato, si sono prodotti modelli matematici capaci di risolvere il problema
dei prezzi prescindendo completamente dalla legge del valore, anche Heinrich
dovrebbe concludere che essa è ridondante. Tuttavia, la specificità del contributo che i rappresentanti della «teoria monetaria del valore» danno alla questione che stiamo trattando sta proprio in questo punto. La teoria del valore non
è ridondante in sé, né tantomeno inutile per l’interpretazione e la critica del
modo capitalistico di produzione, tanto che lo stesso Heinrich sostiene che «il
124 «Teoria sostanzialistica del valore» significa per Heinrich appunto una teoria secondo
cui la Wertgegenständlichkeit è una proprietà che le singole cose possiedono a prescindere dalle
loro relazioni sociali.
125 M Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie
zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster 2006, p. 17.
126 Ibidem.
127 Ivi, p. 270.
128 Ibidem.
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
227
Capitale di Marx rimane, ora come allora, l’analisi più profonda e più completa
del modo di produzione capitalistico di cui disponiamo»129. Tuttavia, nelle argomentazioni che Marx utilizza nel Terzo libro del Capitale e, in particolare, nel
tentativo di dare una vera e propria giustificazione quantitativa del fatto che il
saggio medio del profitto si basa sul lavoro non pagato erogato dagli operai, la
legge del valore diventa di fatto ridondante. L’inutilità del concetto e della legge
del valore, cioè, è legata all’approccio quantitativo al problema della trasformazione. Seguiamo allora il ragionamento di Heinrich e cerchiamo di capire cosa
questo significhi.
Da principio si rileva una questione generale e comune, secondo l’autore,
a tutti i tentativi di risolvere il problema quantitativamente, cioè utilizzando
modelli lineari. Che si tratti di tentativi che vengono da parte neoclassica, per
esempio Sraffa, o di tentativi che vengono dal campo marxista, per esempio Dumenil, Foley, Lipietz130, tutte le soluzioni quantitative sono costrette ad astrarre dalla forma-denaro, che è, invece, un elemento fondamentale dell’economia
capitalistica e dell’interpretazione e critica che Marx ne fa. Ciò conduce immediatamente, che lo si voglia o no, secondo Heinrich, alla rappresentazione di
un’economia in equilibrio, cioè senza crisi. «Il problema centrale per la teoria
del valore di Marx, com’è possibile che prodotti del lavoro si relazionino gli uni
agli altri come merci, non viene tematizzato, e perciò anche il denaro non può
diventare oggetto di queste teorie»131. Trattandosi di un’impossibilità legata al
tentativo di risolvere la questione dal punto di vista quantitativo, questo tipo di
critica vale anche per il tentativo che Marx ha fatto nel Terzo libro del Capitale:
«Tutte queste obiezioni si lasciano senza dubbio sollevare anche nei riguardi
dell’esposizione nel Terzo libro del Capitale»132 e, aggiungiamo noi, anche nei
riguardi dei sostenitori del Sistema Singolo Temporale133.
Id., Die teoretische Unvollständigkeit des „Kapital“, manoscritto non pubblicato.
Foley, Lieptz e Dumenil sono i rappresentanti più importanti della cosiddetta New Interpretation. Negli anni Ottanta hanno proposto una modalità di approccio al problema della
trasformazione che, pur avendo aperto la strada a riflessioni molto interessanti, non sembra
distanziarsi molto, nella sostanza, dalla tradizionale interpretazione criticata da Heinrich. Nonostante l’introduzione della dimensione monetaria, infatti, anche questo approccio mantiene
l’esistenza di due sistemi di scambio: uno basato sui valori, l’altro basato sui prezzi. (Cfr. D.
Foley, The Value of Money, the Value of Labour-Power, and the Marxian Transformation Problem,
in «Revue of Radical Political Economics», vol. 14, 1980, pp. 37-47; G. Dumenil, De la valeur
aux prix de production, Paris 1980; A, Lipietz, The So-Called «Transformation Problem» Revisited, in «Journal of Economic Theory», vol. 26, 1982).
131 M Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, cit., p.277.
132 Ivi, p.278.
133 Anche Carchedi e gli altri, infatti, come già detto, affrontano il problema della trasformazione sul terreno quantitativo e sostengono un particolare modello matematico che, secondo loro, porterebbe agli stessi risultati cui era giunto Marx.
129 130 228
Antonella Muzzupappa
La soluzione quantitativa proposta da Marx nel Terzo libro presupporrebbe,
secondo Heinrich, l’esistenza delle grandezze di valore prima e indipendentemente dallo scambio e, quindi, senza riferimento al denaro. Nel Terzo libro
Marx argomenterebbe, esattamente come i neoricardiani, a prescindere dal denaro e nell’ambito di una «teoria della quantità di lavoro» sensibilmente diversa
dalla «teoria monetaria del valore» del Primo libro. «Le diverse argomentazioni
[…] – continua Heinrich riferendosi al Primo e al Terzo libro – non si lasciano
comprendere come diversi livelli di elaborazione, esse non esistono l’una dopo
l’altra, bensì l’una accanto all’altra»134.
Il problema della trasformazione dei valori in prezzi di produzione, allora, è proprio uno di quei passaggi attraverso cui Heinrich intende dimostrare la sua tesi generale della presenza di argomentazioni tipiche dell’economia classica nel discorso di Marx. Nell’ambito della trasformazione, infatti,
Marx avrebbe non solo cercato di risolvere un problema che era già stato di
Ricardo, bensì di risolverlo all’interno dei confini dell’argomentazione classica. «L’istanza quantitativa della trasformazione di Marx nel Terzo libro del
Capitale è il tentativo di una precisazione del discorso di Ricardo all’interno
del terreno dei classici»135. La stessa differenza tra lo scambio sulla base del
valore e quello sulla base dei prezzi di produzione esisteva già nel discorso
di Ricardo e, a partire da qui, Marx tenta di mediare valori e prezzi ma, secondo Heinrich, mettendo da parte la necessaria espressione monetaria dei
valori in denaro e facendo quindi un passo indietro rispetto alla rivoluzione
che la sua concezione della forma-valore e della forma-denaro avevano rappresentato rispetto a Ricardo. Se «il vero oggetto della teoria monetaria del
valore non è la grandezza di valore bensì la forma-valore, e la sua forma sviluppata, la forma-denaro»136 ne consegue che nel Terzo volume del Capitale
Marx argomenta nell’ambito di una teoria del valore non-monetaria o premonetaria, trattando quindi il valore e il plusvalore come sostanze, piuttosto
che come forme o rapporti.
Se si guarda, prosegue Heinrich, a ciò che Marx dice nel Primo libro del Capitale, e si seguono le indicazioni di una teoria monetaria del valore, non esiste
Wertgegenständlichkeit per nessun prodotto isolato ma solo per un insieme di
prodotti in relazione di scambio tra loro e lo scambio, a sua volta, è possibile
solo attraverso la relazione di tutte le merci col denaro. «Prima dello scambio
M Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, cit., p.278.
Ivi, p.279.
136 Id., Was ist die Werttheorie noch Wert? Zur neueren Debatte um das Transformationsproblem und die Marxsche Werttheorie, in «PROKLA 72», Nr. 3, Münster, 1988, p. 29.
134 135 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
229
e in astrazione dal denaro non ci può essere nessuna Wertgegenständlichkeit e
perciò neanche un sistema di valori determinato quantitativamente»137.
La conclusione, quindi, è che nell’ambito di una teoria monetaria del valore, quale quella di Marx sarebbe, il problema di una conversione quantitativa
dei valori in prezzi di produzione assolutamente non si pone. «La trasformazione dei valori in prezzi di produzione […] – allora – non è la conversione di
un sistema quantitativo in un altro, bensì [il] passaggio logico-concettuale tra
diversi livelli dell’esposizione»138, ossia l’ulteriore sviluppo, ad un altro livello
appunto, della determinazione formale della merce. Marx è partito dalla merce assolutamente astratta e l’ha via via sempre ulteriormente determinata dal
punto di vista formale, per arrivare, infine, alla merce come risultato dell’unità
del processo di produzione e di circolazione, cioè portatrice (Träger) non solo
di plusvalore, ma anche di profitto e, precisamente, di profitto medio. La vera
trasformazione dei valori in prezzi di produzione, quindi «consiste nell’ulteriore sviluppo della determinazione formale della merce»139. Dal punto di vista di
Heinrich, infatti, come si è già accennato, non esiste in Marx, almeno stando
all’analisi fatta nel Primo libro del Capitale, un sistema dei valori indipendente
dallo scambio, per cui non può esistere né una comparazione quantitativa di
valori e prezzi di produzione, né tantomeno «una determinazione quantitativa
del sistema dei prezzi di produzione attraverso […] un preesistente sistema dei
valori»140.
Tuttavia, dal punto di vista logico-concettuale, le categorie «valore» e «plusvalore» funzionerebbero come premesse necessarie per la comprensione delle categorie «profitto» e «prezzo di produzione»141. È evidente quindi che, per
Heinrich, la stessa categoria di «plusvalore» non ha importanza dal punto di
vista quantitativo bensì solo dal punto di vista formale, in quanto centrale per
Marx sarebbe non lo sfruttamento dei produttori immediati, o lo sfruttamento
in generale, ma la forma specifica che tale sfruttamento assume nell’ambito del
modo di produzione capitalistico.
Infine, per quanto riguarda la concorrenza tra le diverse branche del capitale, non è possibile, secondo i sostenitori di questo tipo di lettura, che essa conduca alla formazione di un saggio medio del profitto. Ancora una volta, infatti,
Id., Die Wissenschaft vom Wert, cit., p.280.
Id., Was ist die Werttheorie noch Wert?, cit., p.29.
139 Id., Die Wissenschaft vom Wert, cit., p 281.
140 Ivi, p. 282.
141 Con questa considerazione viene articolata anche una critica ai neoricardiani che ritengono di poter parlare di «prezzi» e «profitto» come di categorie che non hanno bisogno di
alcuna premessa.
137 138 230
Antonella Muzzupappa
bisognerebbe ritenere che c’è un momento, nell’ambito della concorrenza, in
cui i capitalisti hanno a che fare con valori ma, scrive ancora Heinrich, «nella
concorrenza i capitalisti non hanno mai a che fare un sistema di valore, bensì
sempre già con un dato sistema di prezzi di produzione»142. Ciò che la concorrenza tra le diverse branche produce, quindi, non è il passaggio dai valori ai
prezzi di produzione ma «la trasformazione di un sistema di prezzi di produzione “deformato” […] in uno che rende possibile approssimativamente lo stesso saggio del profitto per ogni branca»143.
6. Conclusioni
A questo punto dovrebbe essere chiaro che la determinata modalità con cui
si interpreta, almeno in campo marxista, il processo della trasformazione dei
valori in prezzi di produzione è immediatamente legata all’interpretazione che
si dà delle categorie centrali della critica dell’economia politica. Detto in altri
termini, determinante è la lettura che si fa del Primo libro del Capitale e, in particolare, delle prime categorie esposte da Marx: merce (forma-merce), valore
(forma-valore), lavoro astratto, denaro (forma-denaro).
Carchedi, ad esempio, sostiene: «Il valore è creato durante la produzione
[…] [e] esiste già al livello della produzione» anche se, a questo livello, esso non
è sociale, o meglio «è valore sociale ma solo potenzialmente […] [e] diventa valore sociale realizzato e quindi appare come valore sociale solo quando le merci
[…] sono vendute»144. Nello scambio, quindi, si rivela il carattere specificamente sociale del lavoro astratto, che però esiste già prima dello scambio. A parere
di Carchedi, questa nozione di lavoro astratto è stata molto spesso distorta, e
l’accusa varrebbe certamente anche per Michael Heinrich e i rappresentanti
della neue Marx-Lektüre. Per questi autori, infatti, il lavoro astratto rappresenta
un’«astrazione reale» che si compie, appunto realmente, nello scambio, cioè
nel momento in cui gli uomini realmente entrano in rapporto tra loro. È nello
scambio che concretamente si astrae dai diversi valori d’uso delle merci e dalla
concreta attività che le ha prodotte per cui «[il] lavoro astratto è un rapporto di
valore (Geltungsverhältnis): nello scambio il lavoro concreto erogato vale come
un determinato quanto di lavoro astratto che forma valore e, in questo modo,
anche come parte costitutiva dell’intero lavoro sociale»145. Da questo punto di
M Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, cit., p. 283.
Ivi, p. 284.
144 G. Caechedi, L’arte del fare confusione, cit., p. 120.
145 M. Heinrich, Kritik der politischen Ökonomie, cit., p. 49.
142 143 Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
231
vista, il lavoro astratto sarebbe tale solo nello scambio e il valore non sarebbe
«creato» durante la produzione, il che però, a nostro avviso, non significa immediatamente che esso sia «creato» durante la circolazione. Carchedi, invece, sembra ritenere che se il valore non esiste prima e indipendentemente dai
prezzi, ciò che, appunto, Heinrich ritiene impossibile, bisogna rinunciare alla
spiegazione marxiana dei prezzi di produzione. «Se i prezzi non possono essere
spiegati in termini di una ridistribuzione di valore già esistente e quantificabile
al livello della produzione, la via è aperta all’accettazione di una delle varie teorie dei prezzi alternative a quella marxista»146 e, per la posizione e il ruolo che la
teoria dei prezzi ha nella visione dei sostenitori del Sistema Singolo Temporale,
bisogna in realtà accettare non solo una teoria dei prezzi alternativa a quella
marxiana ma, in generale, un’intera teoria diversa da quella di Marx. La validità
della trasformazione dei valori in prezzi di produzione, anche nel suo aspetto
quantitativo, infatti, è immediatamente collegata a tutto il complesso dell’impianto marxiano, al contrario di quanto non sia per la neue Marx-Lektüre.
Il disaccordo tra i due punti di vista, può essere riassunto, a nostro avviso,
nella questione della relazione tra descrizione qualitativo-formale dei rapporti
all’interno del modo di produzione capitalistico e loro espressione quantitativa.
Mentre per i rappresentanti della neue Marx-Lektüre i due sistemi sono in
totale contraddizione tra loro, tanto che il calcolo quantitativo nega immediatamente la centralità dell’espressione monetaria del valore e, con essa, la necessità delle crisi, per alcuni dei sostenitori del Sistema Singolo Temporale sembra
non essere così. Luciano Vasapollo, infatti, da un lato ritiene che la scientificità
della teoria economica di Marx dipenda dalla possibilità di spiegarla quantitativamente147; dall’altro lato, in sostanziale accordo con Heinrich, scrive: «La
Critica dell’Economia Politica di Marx […] costituisce […] la formazione di un
nuovo campo teoretico, che modella un nuovo oggetto teoretico di analisi ed un
nuovo “paradigma” di argomentazione. A differenza della teoria del valore di
Ricardo, quella marxiana è una teoria della forma di valore del prodotto-merce
collegata perciò fin dall’inizio alla sua forma di denaro, e poi di prezzo, dunque
alla teoria monetaria. Il valore di una merce […] non può essere determinato in
G. Caechedi, L’arte del fare confusione, cit., p. 153.
Nella prefazione al testo sui prezzi dai lui curato, si legge: «La risposta […] alla supposta contraddizione nella teoria marxiana è molto importante perché rimette al centro il
meccanismo di creazione del profitto nel modo di produzione capitalistico basato sullo sfruttamento del lavoro salariato, dimostrando nel contempo che la categoria dello sfruttamento
non è valida e vera soltanto per un principio logico ed etico, ma l’intera teoria economica di
Marx regge perché è spiegabile da un punto di vista quantitativo e quindi è nella sua essenza
fortemente scientifica». (L. Vasapollo, La teoria del valore in Marx, cit., p. 30)
146 147 232
Antonella Muzzupappa
isolamento ma solo in relazione con tutte le altre merci nel processo di scambio. Tale relazione del valore di scambio si materializza con il denaro»148.
Per quanto riguarda le critiche articolate da Böhm-Bawerk149, vorremo fare
qualche piccola osservazione.
Come ci si ricorderà, all’inizio di questo scritto abbiamo ricostruito il punto
di vista di Marx sui valori e sui prezzi così come esso si presenta nei Lineamenti
fondamentali, prima ancora di discutere il procedimento della trasformazione.
Abbiamo inteso sottolineare che il rapporto tra valori e prezzi è sempre stato inteso da Marx come complesso e problematico. In particolare, come dimostrato
anche dal Primo libro del Capitale, pur supponendo che le merci vengano vendute ai loro valori, Marx non ha mai pensato che questo potesse corrispondere
alla realtà del mercato capitalistico. Egli ha chiarito, in vari punti della sua opera, che si trattava di una supposizione che funzionava relativamente al grado
di astrazione a cui in quel momento si argomentava. In più, Marx ha più volte
attirato l’attenzione del lettore sul fatto che, per rendere ragione della divergenza dei prezzi dai valori e spiegarne, nello stesso tempo, la dipendenza, occorrevano una serie di mediazioni che si sarebbero avute soltanto ad un livello più
alto dell’esposizione, e cioè nel Terzo libro. Se si considera, inoltre, che i manoscritti per il Terzo libro del Capitale erano già stati completati quando Marx
ha curato la pubblicazione del Primo libro, si può concludere, a nostro avviso,
che la critica di Böhm-Bawerk non coglie nel segno. Anche prescindendo dalla correttezza o meno del procedimento della trasformazione, non possiamo
condividere l’affermazione secondo cui Marx argomenterebbe per due interi
libri sulla base di una finzione e poi, improvvisamente, aprirebbe gli occhi di
fronte alla realtà. Riteniamo che la «realtà» a cui Böhm-Bawerk si riferisce, sia
sempre stata presente a Marx e che ciò che Böhm-Bawerk non condivide, è il
metodo che Marx ha utilizzato per rendere ragione di quella realtà e, in particolare, il fatto che la realtà del modo di produzione capitalistico fosse presentata
come storica e transitoria. La scuola del valore soggettivo, infatti, ha al centro
del proprio sistema la relazione individuale tra l’uomo e le cose piuttosto che la
determinatezza storica e sociale dei rapporti di produzione. Ci sembra, perciò,
di poter condividere l’opinione di fondo di Hilferding secondo cui «la scuola
148 Id., Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalistica,
Milano 2007, p. 25.
149 Una discussione articolata del saggio di Böhm-Bawerk fu fatta quasi immediatamente
da Rudolf Hilferding nel suo saggio pubblicato nel 1904. (Cfr. R. Hilferding, Böhm-Bawerks
Marx-Kritik, in F. Eberle (a cura di), Aspekte der Marxschen Theorie 1., cit., pp. 130-192; tr. it. G.
Panzieri Saija, La critica di Böhm-Bawerk a Marx, in AA. VV., Economia borghese ed economia
marxista, cit., pp. 111-175).
Valori, prezzi e «problema della trasformazione» in Karl Marx
233
psicologica dell’economia politica […] considera questa relazione [la relazione
tra l’uomo e le cose] dal punto di vista psicologico come naturale e subordinata a leggi immutabili»150. Da questo punto di vista essa sarebbe la negazione
dell’economia per cui, conclude Hilferding «l’ultima replica dell’economia borghese al socialismo scientifico è l’autodistruzione dell’economia politica»151.
In merito a Bortkiewicz e al calcolo simultaneo in generale aggiungiamo
solo che se molti studiosi, come abbiamo visto, ritengono impossibile la sintesi
tra il calcolo simultaneo e il complesso della teoria di Marx, ve ne sono altri che,
invece, sono persuasi che il tentativo di Bortkiewicz fosse fondato. In particolare, Luca Meldolesi ritiene che sia possibile dimostrare che anche nello schema
di Bortkiewicz «l’esistenza del profitto presuppone l’esistenza del plusvalore
prodotto dagli operai, vale a dire presuppone che la forza-lavoro sia retribuita
meno di ciò che essa stessa crea e che quindi gli operai, oltre al lavoro necessario, facciano anche un pluslavoro»152.
Da parte nostra, riteniamo che potrebbe essere fruttuoso spostare il centro
della discussione dallo specifico problema della trasformazione dei valori in
prezzi di produzione, alle questioni più generali cui si è fatto riferimento sopra.
Probabilmente, solo un’analisi attenta e rigorosa della parte iniziale del Primo
libro del Capitale, e la comprensione profonda del rapporto tra Marx e Ricardo153 possono consentirci di giungere ad una sintesi produttiva sulla questione
della trasformazione e della rilevanza che questa questione ha nel complesso
della critica dell’economia politica.
Un approccio di questo tipo, del resto, farebbe meno torto a quella che Roberto Fineschi descrive come la «complessità del suo [di Marx] modello come
tutto organico»154 e non ridurrebbe la teoria dei prezzi di Marx «alla seconda
sezione (se non addirittura al nono capitolo) del III libro, senza capire che essa
era comprensibile solo alla luce dello svolgimento complessivo»155. Si tratterebbe, quindi, non solo di analizzare il famoso «inizio» del Capitale, ma anche di
confrontarsi con l’incompiutezza da cui il Capitale nel suo complesso è carat-
Ivi, p. 192, tr. it. cit., p. 175.
Ibidem.
152 L. Meldolesi, Il contributo di Bortkiewicz, cit., p. LI.
153 Molte delle questioni sollevate rispetto alla trasformazione dei valori in prezzi di produzione, infatti, sono basate su un’interpretazione della teoria del valore di Marx come sostanzialmente identica a quella di Ricardo. Lo stesso Böhm-Bawerk, del resto, fonda la sua argomentazione proprio sul presupposto che Marx accetti le tesi di Smith e Ricardo a cui aggiunge
semplicemente il metodo dialettico. (Cfr. E. von Böhm-Bawerk, Zum Abschluβ des Marxschen
Systems, cit., p. 90-92; tr. it. cit., pp. 71-73).
154 R. Fineschi, Ripartire da Marx, cit., pp. 264-65.
155 Ivi, p. 256.
150 151 234
Antonella Muzzupappa
terizzato utilizzando anche i manoscritti originali di Marx che la MEGA mette
a disposizione156.
Infine, se si parte dal presupposto che insistere sulla relazione di valore e
sull’impossibilità di quantificare il valore stesso fuori di una relazione di scambio non debba immediatamente condurre a rifiutare la teoria dello sfruttamento o a sancire una supremazia della circolazione sulla produzione, si può aprire
un vasto campo di confronto su questioni scientifiche di interesse generale,
prima fra tutte quella tra l’approccio qualitativo-formale alle relazioni economiche e la loro espressione quantitativa. Questione che, tra l’altro, a nostro
avviso, incrocerebbe una riflessione complessiva sul metodo di Marx, sul significato profondo della critica dell’economia politica e del rapporto tra critica e
dialettica.
156 Cfr. MEGA2, II/4.1, Berlin 1988; MEGA2, II/4.2, cit.
Heidegger interprete di Marx
235
Heidegger interprete di Marx
Memoria di Anna Pia Ruoppo
presentata dal socio naz. corr. Giuseppe Antonio Di Marco
(seduta del 17 dicembre 2009)
Abstract. In Heidegger’s works there is no systematic reference to Marx’ thinking. However, scattered throughout his work, Heidegger refers to Marx in a number of contexts
and interprets several of its most prominent traits. The present article takes the perspective outlined in Heidegger’s Letter on Humanism as a point of departure in order to
establish a thematic connection between Marx and Heidegger that is mediated by the
concept of “alienation”.
1. I termini della questione
Nell’introduzione di una monografia, dedicata al confronto del pensiero di
Marx con quello di Heidegger, Gaio Petrovic´, studioso jugoslavo, noto per aver
fondato la rivista «Praxis», sosteneva che «l’alternativa per la modernità significa: o Heidegger o Marx»1 e che «se la filosofia contemporanea vuole essere
all’altezza del proprio tempo, si deve decidere se vuole partire da Marx o da
Heidegger (o forse da entrambi)»2. Egli intravedeva nel confronto fra i due pensatori la possibilità di una loro più appropriata comprensione. Nel suo tentativo di contrapporsi all’interpretazione “ufficiale” di Marx, incentrata sugli effetti concreti del materialismo storico, Petrovic´, però, troppo concentrato sulla
questione dell’umanesimo, inteso come tratto comune del pensiero di Marx e
di quello di Heidegger, non teneva conto del fatto che è proprio sulla base della
sua concezione “umanistica” dell’uomo che Heidegger criticava Marx, ponendolo all’interno della storia della metafisica3.
1 G. Petrovic’ , Heidegger e Marx, in Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandaufnahme,
Hildesheim, 1980, p. 215.
2 Ibid.
3 Gajo Petrovic’, Praxis und Sein, in «Praxis», 1965, pp. 26-40; Id., Der Spruch des Heidegger,
in Durchblicke. Martin Heidegger zum 80. Geburtstag, Frankfurt, 1970, pp. 412-436, (trad. it.
236
Anna Pia Ruoppo
È sulla base di tale sollecitazione che qui di seguito si vuole tentare di mettere Heidegger e Marx in dialogo. In questo caso, però, non si tenterà di basare
il confronto sulla contrapposizione o assimilazione dei due dispositivi di pensiero, rispetto al comune tema dell’umanesimo, sulla base della proposta di
Petrovic’. Piuttosto si procederà ad un confronto interno, basato sull’interpretazione del dispositivo di pensiero di Marx all’interno di quello di Heidegger4. Le
domande che fungeranno da filo conduttore della mia analisi possono essere
formulate in questi termini: come interpreta Heidegger il pensiero di Marx? E
quali risposte intende dare ai problemi da esso posti?
Nel pensiero di Heidegger non assistiamo ad una tematizzazione “sistematica” di Marx, come, per esempio, avviene per Nietzsche5. Tuttavia in un numero
considerevole di testi, Heidegger prende posizione rispetto al suo pensiero e
ne interpreta alcuni momenti fondamentali. Qui di seguito si prenderanno in
considerazione:
«In Marx centouno», n.3, novembre 1985); Id., Heidegger und Marx, in Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandaufnahme, cit., pp. 217-231; Id., L‘undicesima tesi di Marx su Feuerbach,
in «Paradigmi», 1983, pp. 593-606; Id., Heidegger und die Jugoslawische Praxis-Philosophie,
in Zur philosophischen Aktualität Heidegger, Bd. II, Frankfurt, 1991, pp. 219-239. Per una ricostruzione della posizione di Petrovic’ mi permetto di rimandare al mio breve saggio: A. P.
Ruoppo, Gaio Petrovic’ e i filosofi jugoslavi della prassi: proposta di un confronto produttivo fra
il pensiero di Heidegger e quello di Marx, in «Archivio di storia della cultura», anno XVIII, 2005,
pp. 273-277.
4 La possibilità di una dialogo fra Heidegger e Marx è stata affrontata anche nei seguenti
contributi: K. Axelos, Marx e Heidegger, Napoli, 1977; (di questo testo si veda, in particolare, l’introduzione di E. Mazzarella, Pensiero e Ideologia. Contributo ad un pensiero (del) futuro: «über» Marx e Heidegger, pp. 5-85); A. Schimdt, Herrschaft des Subjektes. Über Heideggers
Marx-Interpretation, in Martin Heidegger. Fragen an sein Werk. Ein Symposion, Stuttgart, 1977,
pp. 54-65; H. Künkler, «Riflessione è il rilucere della non-latenza». Considerazioni sul problema
dell’«uso» in Marx e Heidegger, in «Metaphorein», 4, 1979, pp. 59-70; J. R. Santander, Trabajo
y praxis en “El ser el tempo” de Martin Heidegger: un ensayo de confrontacion con el marxismo,
Puebla, 1985; T. Buogas, Das Ende der Philosophie bei Marx und Heidegger, in Zur philosophischen Aktualität Heidegger, cit., pp. 100-117; G. Traversa, La questione della tecnica e il dialogo
Marx-Heidegger, in «Il Cannocchiale», 1983, pp. 147-166. Per un inquadramento più generale della questione, si veda: H. Jakob, Krise der Freieheit: Hegel, Marx, Heidegger, Regensburg,
1958; C. Preve, Hegel, Marx, Heidegger. Un percorso di filosofia contemporanea, Pistoia, 1999; H.
D. Kittsteiner, Mit Marx für Heidegger – mit Heidegger für Marx, München, 2004.
5 Heidegger dedica attenzione al pensiero di Nietzsche già negli anni della sua formazione.
Per una trattazione “sistematica” del suo pensiero bisognerà attendere le lezioni dei semestri
dal 1936 al 1939, poi confluite nei dei volumi del Nietzsche (Stuttgart, 1961). Di recente pubblicazione sono anche il volume dei seminari dedicati da Heidegger alla seconda inattuale nel
semestre invernale 1938/39 e i seminari del 1937 e 1944. Si veda: M. Heidegger, Zur Auslegung
von Nietzsches II. Unzeitgemässer Betrachtung “Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das
Leben”(WS 1938/39), in Gesamtasugabe vol. 45, a cura di H.-J. Friedrich, Frankfurt a. M., 2003;
Id., Nietzsche. Seminare 1937 und 1944, in Gesamtausgabe vol. 87, a cura di P. von Rockteschell, Frankfurt a. M., 2004.
Heidegger interprete di Marx
237
1)La Lettera sull’«Umanismo», 19466.
2) Alcuni appunti di lavoro pubblicati recentemente nel volume 69 della Gesamtasugabe di Heidegger con il titolo Entwurf zu koi@non. Zur Geschichte des
Seins per la storia dell’essere, tradotti in italiano con il titolo Il comunismo e
la storia dell’essere (1939-40)7.
3) Alcune affermazioni contenute nella Prima conferenza del ciclo friburghese
Principi del pensiero, 19578.
4) Alcuni passi contenuti nei seminari di a) Le Thor (1969); b) Zähringen
(1973)9.
5)L’intervista televisiva con Richard Wisser, realizzata il 24 settembre del 1969
e mandata in onda dal secondo canale della televisione tedesca due giorni
dopo, in occasione dell’80° compleanno di M. Heidegger, e, in seguito, pubblicata con il titolo Gespräch mit Martin Heidegger10.
La prospettiva in cui avviene tale confronto e i termini della questione sono
chiariti, innanzitutto, nella Lettera sull’«Umanismo», testo scritto da Heidegger, nel dicembre 1946, in risposta a degli interrogativi rivoltigli, in una lettera
del 10 novembre, da un giovane studioso francese, Jean Beaufret11. La Lettera
nasce nel particolare clima culturale del secondo dopoguerra, caratterizzato
da una sempre più capillare diffusione dell’esistenzialismo di Sartre, non solo
in Francia, ma anche in Germania12. L’attenzione al pensiero di Heidegger deriva, certamente, in parte, dall’ammessa dipendenza dell’opera principale di
Sartre, L’essere e il nulla13 da Essere e Tempo14. Tuttavia a sollevare la questione
dell’Umanesimo, del suo rapporto con l’esistenzialismo, e quindi, in un certo
senso, del suo rapporto con il pensiero di Heidegger, è la famosa conferenza
6 M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», Frankfurt a. M. 1947, trad. it. a cura di F.
Volpi, Lettera sull’«Umanismo», Milano 1995. D’ora in poi: Lettera.
7 Id., M. Heidegger, Entwurf zu κοινον. Zur Geschichte des Seins, in Die Geschichte des
Seins (Gesamtasugabe vol. 69), a cura di P. Trawny, Frankfurt a. M., 1998, trad. it. parziale a
cura di D. Thöma, Il comunismo e il destino dell’essere, in «Micromega», …pp. 281-295.
8 M. Heidegger, Einblick in das was ist, in Bremer und Freiburger Vorträger (Gesamtausgabe
vol. 79), a cura di P. Jaeger, Frankfurt a. M. 1994, ed. it. a cura di F. Volpi, Sguardo in ciò che è,
in Conferenze di Brema e di Friburgo, Milano, 2002.
9 Id., Seminari, trad. it. a cura di F. Volpi, Milano 1992.
10 Id., M. Heidegger in Gespräch, a cura di R. Wisser, München, 1968.
11 Per un approfondimento del contesto, soprattutto in vista del confronto con Marx, si
veda anche: J. Beaufret, Dialogue avec Heidegger, Paris, 1973-1985.
12 Per una ricostruzione del clima culturale e delle circostanze in cui avviene la stesura
della Lettera sull’«Umanismo» si veda la nota introduttiva di F. Volpi alla traduzione italiana: F.
Volpi, Nota introduttiva, in M. Heidegger, Lettera sull’«Umanismo», trad. it. a cura di F. Volpi,
Milano, 1995, pp. 9-27.
13 J. P. Sartre, L’essere e il Nulla, trad. it. di G. del Bo, rivista da F. Fergnani e M. Lazzari,
Milano 1965.
14 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, 1927; trad. it. a cura di P. Chiodi, Milano 1976.
238
Anna Pia Ruoppo
che Sartre tenne a Parigi il 29 ottobre del 1945, dal titolo L’esistenzialismo è
un umanesimo15. In essa Sartre risponde alla critica mossagli, da parte marxista e da parte cristiana, di disimpegno politico, facendo riferimento all’idea di
un umanismo esistenzialista, in grado di assumere su di sé la responsabilità
dell’azione dell’uomo e della sua condotta di vita. Distinguendo il filone dell’esistenzialismo cristiano da quello ateo, egli include, insieme agli esistenzialisti
francesi, esplicitamente, in quest’ultimo, anche Heidegger. In questo modo egli
pone quel complesso insieme di problemi che vede contrapposti il marxismo
e l’esistenzialismo intorno alla questione dell’umanesimo e quella dell’azione.
Tale nucleo problematico rappresenta il terreno sul quale anche Heidegger, in
una prospettiva sua personale, interna alla comprensione della storia del dispiegamento dell’essere come storia della metafisica occidentale, affronta la
questione dell’umanesimo e della possibilità dell’azione. La Lettera sull’«Umanismo», però, non si può considerare semplicemente come una sorta di scritto
d’occasione, pensato solo in risposta alle questioni poste da Beaufret e dettato
dal desiderio di reinserirsi nella discussione culturale e intellettuale del tempo, dopo la fine della guerra. Esso, infatti, offre ad Heidegger la possibilità di
puntualizzare questioni che gli stanno a cuore, come quella dell’azione e della definizione dell’essenza dell’uomo, traducendole nella propria prospettiva di
pensiero.
La problematica che Heidegger affronta nella Lettera prende spunto dalle
questioni affrontate nella conferenza di Sartre sull’umanesimo. Tuttavia, mentre Sartre contrappone una teoria dell’azione esistenzialista basata sull’umanesimo, al marxismo, Heidegger, con un’operazione tipica del suo pensiero,
pone sullo stesso piano Sartre e Marx, sottoponendoli alla medesima critica di
essere espressione di un pensiero di carattere “umanista”, ovverosia metafisico.
Che tuttavia tutta la Lettera debba essere pensata come un tentativo di dialogo
intorno alla questione dell’agire, sia con l’esistenzialismo, corrente della quale
Heidegger non ritiene di fare parte16, sia con il marxismo, diviene evidente se si
tiene conto del suo attacco. Qui Heidegger afferma: «noi non pensiamo ancora
in modo abbastanza decisivo l’essenza dell’agire»17. Tale essenza non consiste,
a suo parere, nel “produrre effetti”, ma nel “portare a compimento”. Tuttavia,
poiché “portare a compimento” vuol dire producere, ovverosia dispiegare qualcosa nella pienezza della sua essenza, può essere “prodotto” e dispiegato, in
questo senso, solo ciò che già è. Ma ciò che già è, dice Heidegger, è l’essere,
J.P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanesimo, Milano, 1963.
Lettera, p. 54.
17 Ibid., p. 31.
15 16 Heidegger interprete di Marx
239
quindi l’azione porta a compimento il riferimento dell’essere all’essenza dell’uomo. Questa affermazione diviene chiara, solo se si comprende che per Heidegger “Azione” vuol dire “Pensare” e che il pensiero non provoca tale riferimento,
ma si limita ad offrirlo all’essere attraverso il linguaggio. Sostenendo che «il
pensiero non si fa azione solo per il fatto che da esso scaturisce un effetto o
un’applicazione»18, ma che «il pensiero agisce in quanto pensa»19 e cioè quando
porta a compimento, attraverso il linguaggio, il rapporto dell’uomo all’essere,
Heidegger delinea subito il campo all’interno del quale è possibile, dal suo punto di vista, un confronto con Marx.
Tuttavia prima di arrivare a porre la questione in tali termini, bisogna ricostruire il filo dell’argomentazione heideggeriana nella Lettera e il significato del
suo riferimento a Marx.
2. Dall’essenza della tecnica al comunismo
Nella Lettera sull’«Umanismo», Heidegger cita Marx tre volte: nella tematizzazione dell’essenza dell’uomo e nella sua critica all’umanismo20 (in questa circostanza Heidegger afferma che Marx comprende l’essenza dell’uomo in modo
umanistico); nella tematizzazione dell’essenza dell’essere e del suo modo di
darsi metafisico21 (qui Heidegger sottolinea come Marx abbia rovesciato insieme a Nietzsche la metafisica assoluta di Hegel); nella tematizzazione della dimenticanza dell’essere, intesa, con i termini di Hölderlin, come “spaesatezza”22,
(in questo contesto Heidegger individua la possibilità di un dialogo produttivo
con il marxismo nell’alienazione e indica nella questione della tecnica lo sfondo
su cui deve avvenire questo dialogo, concludendo con la tesi secondo la quale il
comunismo non è un partito o una visione del mondo, ma deve essere compreso a partire dalla storia della metafisica).
Due sono le tesi fondamentali. In primo luogo, Heidegger ritiene che il pensiero di Marx si collochi all’interno della storia della metafisica. In secondo
luogo, egli individua nell’alienazione la dimensione essenziale della storia che
fornisce ad Heidegger un terreno per affrontare un dialogo produttivo con il
marxismo. A sostegno della prima tesi, Heidegger fornisce argomenti differenti.
Ibid., p. 31.
Ibid.
20 Ibid., pp. 40-43.
21 Ibid.,p. 64.
22 Ibid., pp. 69-70.
18 19 240
Anna Pia Ruoppo
Il pensiero di Marx si muove all’interno della storia della metafisica, per il suo
modo umanistico di determinare l’essenza dell’uomo; perchè il suo pensiero
rappresenta un rovesciamento della metafisica assoluta di Hegel; per la sua
concezione materialistica, in cui si esprime l’essenza della tecnica moderna,
che, in quanto modo del disvelamento, è un momento della storia dell’essere.
Da ciò deriva che, se il comunismo – inteso come umanistico, come rovesciamento della metafisica assoluta di Hegel e come espressione dell’essenza della
tecnica - è un momento della storia della metafisica, esso non può essere considerato un partito o una semplice visione del mondo.
Ma procediamo per piccoli passi, analizzando le singole tesi, separatamente
e a partire dai concreti riferimenti testuali. La prima tesi sostenuta da Heidegger riguarda l’appartenenza del pensiero di Marx alla storia dell’essere, intesa
come metafisica. Heidegger colloca Marx all’interno della storia della metafisica, innanzitutto, per la sua concezione umanista dell’uomo. Umanistica, secondo Heidegger, è ogni determinazione dell’essenza dell’uomo che avviene a partire da un’interpretazione dell’ente nella sua totalità, senza mettere in discussione l’appartenenza dell’essere all’ente. Per questo motivo «ogni umanismo si
fonda o su una metafisica o pone se stesso a fondamento di una metafisica»23.
Heidegger individua il tratto distintivo di ogni umanismo sull’accordo intorno
al fatto che in esso «l’humanitas dell’homo humanus è determinata in riferimento ad un’interpretazione già stabilita della natura, della storia, del mondo,
del fondamento del mondo, cioè dell’ente nel suo insieme»24. Anche Marx determina in modo umanistico l’essenza dell’uomo: «Marx pretende che l’”uomo
umano” venga conosciuto e riconosciuto. Egli lo trova nella “società”, per lui
l’uomo “sociale” è l’uomo “naturale”. Nella “società” la “natura” dell’uomo, cioè
la “totalità dei bisogni naturali” (nutrimento vestiario, riproduzione, sussistenza economica) è assicurata in modo uniforme»25. A differenza degli altri umanismi quello di Marx non ha bisogno di alcun ritorno all’antico
Marx viene collocato all’interno della storia della metafisica, inoltre, per il
suo rovesciamento della metafisica assoluta di Hegel. Heidegger afferma:
«La metafisica assoluta [di Hegel] con i rovesciamenti che ne hanno
fatto Marx e Nietzsche, appartiene alla storia della verità dell’essere. Ciò
che da essa proviene non può essere colpito o eliminato mediante confutazioni, ma si lascia solo assumere riportando in modo più iniziale la
Lettera, pp. 42-43.
Ibid.
25 Ibid., p. 40.
23 24 Heidegger interprete di Marx
241
sua verità al riparo dell’essere stesso e sottraendola all’ambito delle mere
opinioni umane»26.
In che senso il pensiero di Marx sia un rovesciamento della metafisica assoluta di Hegel e, quindi, in che modo esso appartenga alla storia della verità
dell’essere, diviene più chiaro attraverso un’ulteriore ricostruzione della posizione di Heidegger; in particolare, attraverso la sua definizione del materialismo:
«L’essenza del materialismo non sta nell’affermazione che tutto è solo
materia, ma piuttosto in una determinazione metafisica per la quale tutto l’ente appare come materiale da lavoro. L’essenza del lavoro secondo la
metafisica moderna è pensata in anticipo nella Fenomenologia dello spirito come il processo autorganizzantesi della produzione incondizionata, cioè come oggettivazione del reale ad opera dell’uomo esperito come
soggettività. L’essenza del materialismo si cela nell’essenza della tecnica, di cui si parla molto e si scrive poco. Nella sua essenza la tecnica è
un destino entro la storia dell’essere, della verità dell’essere che riposa
nell’oblio»27.
L’essenza del materialismo deve essere compresa a partire dall’essenza della
tecnica. Materialismo significa che tutto l’ente è divenuto materiale da lavoro.
Pertanto, in quanto espressione dell’essenza della tecnica, il marxismo si colloca sul piano della storia dell’essere.
La riduzione di tutto il reale a materiale da lavoro, propria del materialismo
di Marx, deve essere intesa, come Heidegger afferma, a partire dalla tematizzazione del termine ‘lavoro’ presente nella Fenomenologia dello Spirito, ovverosia come il processo autorganizzantesi della produzione incondizionata, intesa
come oggettivazione del reale ad opera dell’uomo, compreso come soggetto. Se
è assunta in questi termini, “la riduzione di tutto l’ente a materiale da lavoro”
implica una riduzione di tutto l’ente a prodotto della produzione dell’uomo.
Un’ulteriore chiarificazione in questo senso si può ricavare dal riferimento al
pensiero di Marx contenuto nella Prima conferenza del Ciclo di Friburgo. Qui la
tecnica viene pensata a partire dall’autoproduzione dell’uomo e questa autoproduzione viene pensata a partire dal concetto hegeliano di lavoro:
26 27 Ibid., p. 64.
Ibid., pp. 70-71.
242
Anna Pia Ruoppo
«In uno scritto giovanile pubblicato postumo, Karl Marx spiega che “tutta la cosiddetta storia del mondo non è altro che la generazione dell’uomo
mediante il lavoro, nient’altro che il divenire della natura per l’uomo” (Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Torino, 1968,
p. 125). Molti respingeranno questa interpretazione della storia mondiale
e la rappresentazione dell’essenza dell’uomo che ne sta a fondamento, però
nessuno può negare che oggi la tecnica, l’industria e l’economia, in quanto
lavoro dell’autoproduzione dell’uomo, determinino in modo decisivo tutta
la realtà del reale. Sennonché con questa constatazione cadiamo già fuori
dalla dimensione del pensiero in cui si muove l’asserzione di Marx circa la
storia mondiale in quanto “lavoro dell’autoproduzione dell’uomo”. Infatti
la parola “lavoro”, qui non significa la mera attività e operatività. Tale concetto parla nel senso del concetto hegeliano di lavoro, che è pensato come
il tratto fondamentale del processo dialettico mediante il quale il divenire
del reale sviluppa la sua realtà. Il fatto che Marx, in contrasto con Hegel,
veda l’essenza della realtà non nello spirito assoluto che comprende se stesso, bensì nell’uomo che produce se stesso e i suoi mezzi di sussistenza, lo
pone senz’altro in estremo contrasto con Hegel, eppure proprio in virtù di
tale contrasto egli rimane all’interno della metafisica del suo antagonista;
infatti la vita e il dominio della realtà sono ovunque il processo lavorativo
inteso come dialettica, cioè come pensiero, sia esso inteso e realizzato come
metafisico-speculativo o come scientifico-tecnico, oppure come miscuglio e
imbarbarimento di entrambi»28.
Con ciò viene confermato che la concezione dell’autoproduzione dell’uomo
è alla base del dispiegamento della tecnica e che, nel pensiero di Marx, avviene
il capovolgimento della metafisica assoluta di Hegel, in quanto l’essenza della
realtà non è più identificata nello spirito assoluto che comprende se stesso, bensì nell’uomo che produce se stesso.
Con l’analisi delle motivazioni in base alle quali il pensiero di Marx deve
essere compreso a partire dalla storia della metafisica, e, soprattutto, comprendendo il marxismo a partire dalla questione della tecnica, Heidegger, come abbiamo anticipato, giunge alla conclusione che il comunismo non deve essere
inteso come un “partito” o una “visione del mondo”, quanto come una fase del
dispiegamento dell’essere nella storia della metafisica. Heidegger afferma:
28 M. Heidegger, Grundsätze des Denkens, in Bremer und Freiburger Vorträger, cit., ed. it.,
pp. 126-127.
Heidegger interprete di Marx
243
«In quanto forma della verità, la tecnica ha il suo fondamento nella
storia della metafisica. Questa, a sua volta, è una fase eminente della
storia dell’essere, e finora la sola che possiamo abbracciare con il nostro
sguardo. Si possono prendere varie posizioni sulle dottrine del comunismo e sulla loro fondazione, ma sul piano della storia dell’essere resta
fermo che in esso si esprime un’esperienza fondamentale di ciò che è la
storia del mondo. Chi prende il “comunismo” solo come “partito” o come
“visione del mondo” pensa in modo altrettanto angusto di coloro che
pensano che con il termine “americanismo” si indichi, solo e per giunta
in modo spregiativo, un particolare stile di vita»29.
Il confronto con il marxismo va cercato, pertanto sul piano, metafisico e non
politico. Questa prospettiva emerge ancora più decisamente se ci si sofferma,
ulteriormente, sull’identificazione di materialismo e tecnica e sulle paradossali
conseguenze derivanti dallo slittamento del pensiero di Marx sul piano del dispiegamento dell’essere.
L’interpretazione secondo la quale il comunismo non rappresenta né un partito né una visione del mondo è confermata dalla tematizzazione del comunismo messa a punto nello scritto Il comunismo e il destino dell’essere30. Qui
Heidegger, sancendo definitivamente lo spostamento della tematizzazione del
comunismo sul piano metafisico, afferma:
«Il contrassegno metafisico del compimento dell’età moderna è storicamente l’ottenimento essenziale della potenza da parte del “comunismo” a costituzione dell’essere dell’epoca della compiuta mancanza di
senso»31.
Secondo Heidegger, nell’epoca in cui si afferma il comunismo, «l’enticità (essenza dell’ente) si è dissolta nella pura macchinazione, attraverso di essa l’ente
giunge alla potenza illimitata e l’abbandono da parte dell’essere intraprende
il suo “dominio” nascosto. Questo non deriva da quella potenza della macchinazione, bensì scaturisce dalla storia nascosta dell’essere»32. Da ciò deriva che
Lettera, p. 71.
M. Heidegger, Entwurf zu koi@non. Zur Geschichte des Seins, in Die Geschichte des Seins (Gesamtasugabe vol. 69), a cura di P. Trawny, Frankfurt a. M., 1998, trad. it. parziale a cura di D. Thöma, Il comunismo e il destino dell’essere, in «Micromega», in XIII (1999), n. 4, pp. 281-295.
31 Ibid., p. 286.
32 Ibid., p. 287.
29 30 244
Anna Pia Ruoppo
«il comunismo non consiste dal punto di vista del pensiero, nel fatto che tutti
hanno da lavorare, guadagnare, consumare e divertirsi in misura uguale»33. Il
materialismo su cui il comunismo si basa è caratterizzato da un’essenza spirituale. Dalla mancata comprensione della sua essenza deriva il suo pericolo.
Heidegger afferma: «Questo “materialismo” è “spirituale” nel senso più alto,
in modo così deciso che in esso si deve riconoscere il compimento dell’essenza
spirituale metafisica dell’Occidente. […]. E perciò il “pericolo” del comunismo
non consiste nelle conseguenze economiche e sociali, quanto piuttosto nel fatto
che la sua essenza spirituale, la sua essenza in quanto spirito non viene riconosciuta e il confronto reciproco viene posto ad un livello che assicura completamente il suo predominio e la sua irresistibilità»34. Dalla consapevolezza della
sua essenza spirituale, ovverosia dalla sua appartenenza alla storia dell’essere,
Heidegger deduce che il superamento del comunismo non può avvenire attraverso un qualsiasi “impegno” piccolo borghese, ma solo se si tiene conto che «il
comunismo non è una mera forma statale, e neppure solo un tipo di ideologia
politica, bensì la costituzione metafisica nella quale si trova l’umanità moderna
non appena il compimento dell’età moderna inizia la sua ultima fase»35.
Dall’identificazione dell’essenza del materialismo con lo spirito, e dalla dislocazione del pensiero di Marx sul piano del dispiegamento dell’essere deriva,
addirittura, la possibilità di sovrapporre il macchinismo, inteso come essenza
della tecnica e la macchina, intesa da Marx come quel dispositivo che, nella fase
suprema del capitalismo determina e regola l’attività dell’operaio. Ma ciò implica che, con l’identificazione di tecnica e materialismo, Heidegger arrivi nel
suo pensiero, ad una sorta di paradosso, secondo il quale il marxismo piuttosto
che essere «il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente»36 diviene
un momento dello stesso dispositivo di funzionamento della tecnica, ovverosia
un’imposizione e una coercizione, che si impone attraverso il meccanismo di
funzionamento della macchina. Questa tesi è confermata dall’analisi della determinazione dell’essenza della tecnica, intesa come macchina, con la quale
Heidegger, come abbiamo visto, identifica il materialismo.
È nella conferenza del 1949 dal titolo Ge-stell37 che Heidegger esplica la circolarità del processo in cui la tecnica si dispiega attraverso il riferimento alla
Ibid.
Ibid., pp. 288-89.
35 Ibid., p. 290.
36 K. Marx, L’ideologia tedesca, p. 25.
37 M. Heidegger, Das Ge-stell, in Bremer und Freiburger Vorträger, cit., ed. it., pp. 45-70.
33 34 Heidegger interprete di Marx
245
macchina. Egli sottolinea come la tecnica moderna venga normalmente identificata con «la tecnica delle macchine motrici»38. Questa definizione, seppur
esatta, secondo Heidegger, non coglie l’essenza della tecnica moderna: «[essa]
non è ciò che è attraverso la macchina» ma, al contrario, «la macchina è solo
ciò che è e come è, a partire dall’essenza della tecnica»39. Fra la tecnica e la macchina vi è un rapporto di coappartenenza. Questo significa che non è la tecnica
a derivare dalla macchina, né la macchina a derivare dalla tecnica. Piuttosto
è il Ge-Stell ad eseguire e riprodurre l’essenza della macchina e il suo funzionamento autonomo. Esso, infatti, si impone attraverso un processo circolare, e riproduce l’essenza dell’ingranaggio, il quale, in quanto è la circolazione
dell’impiegare, «esegue in sé stessa l’essenza della macchina»40. Non solo la
tecnica esegue la circolarità del meccanismo di funzionamento della macchina,
ma anche la macchina deve essere pensata a partire dall’essenza della tecnica.
Solo in base ad essa, la macchina è ciò che è. «La macchina non è qualcosa
che esiste separatamente. Essa non è assolutamente un tipo più complicato di
strumento o apparecchiatura, solo un ingranaggio (Räderwerk) che si aziona da
solo a differenza dell’arcolaio della contadina»41. La macchina non è nemmeno
un oggetto, cioè qualcosa che è posto lì di fronte a noi e ha una sua autonomia: essa è solo «nella misura in cui funziona» e funziona «nel meccanismo
del funzionamento»42, che a sua volta si aziona come il marchingegno dell’ordinare dell’ordinabile (der Umtrieb des Bestellens des Bestellbaren). Le macchine
funzionano «all’interno di un macchinismo», (Maschinerie), determinato, a sua
volta, dal circolo dell’ordinare attraverso il quale il Ge-Stell ordina il reale come
fondo. La macchina, quindi, è solo un piccolo ingranaggio del meccanismo di
funzionamento del Ge-Stell, che ordina ogni aspetto del reale come fondo, imponendogli di stare sempre al suo posto a disposizione per un ulteriore ordine.
Dalla dislocazione del pensiero di Marx sullo stesso orizzonte di dispiegamento
della tecnica deriva che Heidegger finisce per attribuire, dal punto di vista metafisico, al marxismo, quel dispositivo che Marx, nella sua concezione economico-politica, attribuiva al modo di funzionamento del capitale.
Spostando la questione della tecnica su un piano metafisico, Heidegger colloca la concezione marxiana dell’uomo come autoproduzione, nell’ambito del
dispiegamento dell’essere come tecnica, che è solo l’ultima fase di quella dimen-
Ibid., p. 33.
Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid, p. 35.
42 Ibid.
38 39 246
Anna Pia Ruoppo
ticanza dell’essere, di cui la concezione dell’uomo come radice di se stesso è un
momento. Quelle che “genericamente” da Heidegger vengono definite come le
“coercizioni” a cui la realtà odierna costringe, e che assumono in Marx lo specifico carattere del furto del lavoro altrui da parte di un esponente di una classe
rispetto all’esponente di un’altra classe, vengono interpretate, da Heidegger a
partire dal dispiegamento del Ge-Stell, da Marx a partire dal dispiegamento del
capitale, il quale, però, nella prospettiva di Heidegger, è interno al dispiegamento dell’essere, e, quindi, assume una dimensione metafisica.
Tale dimensione emerge con chiarezza nel seminario tenuto a Zähringen nel
197343. Qui Heidegger analizza il pensiero di Marx come una posizione posta
agli antipodi della propria, circa il problema del rapporto fra essere e uomo.
Mentre Heidegger parte dal problema dell’essere, Marx pone al centro la questione dell’uomo. In tale contesto, Heidegger individua il nucleo di tutto il marxismo nella frase di Marx secondo la quale «essere-radicale vuol dire cogliere le
cose alla radice. Ma la radice, per l’uomo, è l’uomo stesso». Così negli appunti
del seminario:
«Heidegger apre il volume e legge la seguente frase: “essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice per l’uomo è l’uomo stesso”. Su questa tesi spiega Heidegger, poggia tutto il marxismo.
Quest’ultimo pensa infatti partendo dalla produzione: produzione sociale della società (la società produce se stessa) e autoproduzione dell’uomo
come essere sociale. Pensando in questo modo, il marxismo è appunto
pensiero di oggi, il pensiero che corrisponde alla situazione in cui regna
semplicemente la autoproduzione dell’uomo e della società»44.
Da ciò deriva che il marxismo, in quanto autoproduzione dell’uomo, è un
pericolo. Gli appunti continuano:
«Vorrei sostenere, o piuttosto supporre, che l’autoproduzione dell’uomo dà origine al pericolo dell’autodistruzione. Che cosa vediamo in verità? Che cosa domina oggi in quanto determina la realtà dell’intero pianeta? La coercizione a progredire. Questa coercizione esige una coercizione
a produrre, che è abbinata verso una coercizione verso bisogni sempre
nuovi. E quest’ultima, la coercizione verso bisogni sempre nuovi è tale,
43 M. Heidegger, Zähringen 1973, in Id., Seminari, cit., pp. 145-180. D’ora in poi: Zähringen
1973.
44 Zähringen 1973, p. 164.
Heidegger interprete di Marx
247
che tutto ciò che è coercitivamente nuovo è altrettanto immediatamente
invecchiato e superato, rimosso dal “più nuovo” e così via»45.
Heidegger interpreta il significato di “coercizione”, dal punto di vista ontologico, riducendo le coercizioni al Ge-Stell. Nei Seminari, infatti, leggiamo:
«Heidegger definisce l’insieme [della “coercizione”] nella parola impianto (Ge-stell). L’impianto è la raccolta, l’insieme di tutte le modalità del porre, che si impongono all’essere umano nella misura in cui quest’ultimo esiste oggi. Così l’impianto non è in alcun modo il prodotto della macchina
umana: è al contrario la figura estrema della storia della metafisica, cioè del
destino dell’essere. In questo destino l’uomo è passato dall’epoca dell’oggettività nell’epoca dell’ordinabilità: in questa nostra epoca a venire tutto sarà
disponibile per mezzo di una calcolo di un ordine. In termini rigorosi non
c’è più alcun oggetto, ma solo “beni di consumo” a disposizione di qualsiasi
consumatore, collocato lui stesso nel mercato di produzione e consumo.
L’uomo secondo Marx, quell’uomo che è per se stesso la sua propria radice,
è appunto l’uomo di questa produzione e del relativo consumo. Questo è
l’uomo della nostra epoca presente»46.
A tale proposito, Heidegger si chiede se l’uomo sia in grado di liberarsi da
tali coercizioni:
L’uomo di quest’epoca, l’uomo che si comprende come produttore di
tutta la realtà e agisce di conseguenza, l’uomo che oggi si vede impigliato nella rete che si stringe sempre più strettamente delle “coercizioni”
socioeconomiche (sulle quali, viste dalla prospettiva della storia dell’essere, si riverbera l’impianto), può questo stesso uomo produrre i mezzi
per uscire dall’oppressione delle “coercizioni”? Come potrebbe riuscirci
senza rinunciare alla sua propria determinazione di produttore? E inoltre è possibile una tale rinuncia nell’ambito della realtà attuale? Quale
significato avrebbe in verità? Si tratterebbe di rinunciare al progresso
stesso e di acconsentire a una limitazione generale del consumo e della
produzione.
45 46 Ibid., p. 165.
Ibid., pp. 165-166.
248
Anna Pia Ruoppo
Il superamento delle “coercizioni” è possibile attraverso il raccoglimento nel
nuovo ambito dell’essere. Tale raccoglimento è possibile attraverso il pensiero, ma
non è “provocato” da esso, in quanto ciò implicherebbe un dominio della sua dimensione produttiva. Il pensiero può solo preparare le condizioni di tale raccoglimento. Tuttavia la possibilità di “superamento” delle coercizioni attraverso il
pensiero è solo un aspetto della questione. Heidegger mette a fuoco il terreno su
cui si può affrontare la questione di tale “superamento” e quindi anche quella del
confronto produttivo con il marxismo nelle riflessioni che seguono.
«La mia interpretazione di Marx, spiega Heidegger, non è politica.
Essa pensa guardando all’essere e al modo in cui l’essere si destina. In
quest’ottica e in questa prospettiva posso dire: con Marx si è raggiunta
la posizione del nichilismo estremo. Questa frase non significa altro che
questo: nella teoria che spiega esplicitamente che l’uomo è l’essere supremo per l’uomo, viene in definitiva fondato e confermato il fatto che
l’essere in quanto essere non è più niente per l’uomo. Se la frase di Marx
[essere radicale vuol dire cogliere le cose alla redice, ma la radice per
l’uomo è l’uomo stesso] viene intesa in senso politico, ciò significa allora far diventare la politica uno dei modi dell’autoproduzione – cosa che
concorda perfettamente con il pensiero di Marx. Ma come si può leggere
questa frase diversamente, come si può leggerla in chiave metafisica?
Facendo attenzione allo strano salto con cui Marx passa oltre un anello
mancante. Che cosa dice effettivamente la frase? “essere radicale vuol
dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice per l’uomo è l’uomo stesso”.
Qui osserva Heidegger, manca un pensiero intermedio che renda possibile passare dal primo pensiero al secondo. È il pensiero che l’uomo sia la
cosa in questione. Per Marx fin da principio è deciso che l’uomo e unicamente l’uomo (e nient’altro) sia la cosa in questione. Da dove viene questa decisione? In che modo? con quale diritto? In base a quale autorità? A
queste domande si può rispondere ritornando alla storia della metafisica.
La frase di Marx, perciò, va intesa senz’altro come frase metafisica»47.
In quanto Marx pone al centro la questione dell’uomo, affermando che l’uomo è l’essere supremo per l’uomo, egli conferma che l’essere, in quanto essere,
non è più niente per l’uomo e raggiunge, in questo modo, la posizione del nichilismo estremo e dell’estrema dimenticanza dell’essere.
47 Ibid., pp. 170-171.
Heidegger interprete di Marx
249
Tuttavia il carattere metafisico del pensiero di Marx non si limita alla centralità in esso assegnata alla “questione dell’uomo”, ma dipende dal modo in cui esso
viene compreso in quanto “autoproduzione”. Come abbiamo già visto nell’interpretazione della Lettera sull’«Umanismo», l’uomo, inteso come autoproduzione, è,
secondo Heidegger, alla base del dispiegamento metafisico della tecnica. Per questo, in quanto individua l’essenza dell’uomo nell’autoproduzione, il marxismo corrisponde alla situazione in cui regna semplicemente l’autoproduzione dell’uomo
e della società, ovverosia a quella che Heidegger altrove identifica con l’essenza
della tecnica. È a partire da tale essenza che bisogna comprendere il marxismo, in
quanto, come Heidegger afferma, in modo emblematico, in un’intervista televisiva
della fine degli anni ’70, non è «a partire dal marxismo» che «può essere compresa
l’essenza della tecnica»48. È a partire dall’essenza della tecnica che, al contrario,
può essere compresa l’essenza del marxismo.
3. Alienazione e spaesamento
Se il seminario di Zähringen ci invita a pensare la svolta, attraverso il pensiero e individua nella metafisica e non nella politica il piano sul quale deve
avvenire il confronto produttivo con Marx, è alla Lettera sull’«Umanismo» che
dobbiamo ritornare per comprendere, in senso ampio, la prospettiva all’interno
della quale Heidegger intende impostare tale confronto, in particolare all’affermazione, secondo la quale l’alienazione rappresenta il terreno per un possibile
dialogo con il marxismo. Heidegger sostiene che Marx, esperendo l’alienazione,
penetra in una dimensione essenziale della storia e che l’alienazione affonda le
sue radici nella spaesatezza dell’uomo moderno. Cosi Heidegger:
«La spaesatezza diviene un destino mondiale. Per questo è necessario pensare questo destino in relazione alla storia dell’essere. Ciò che
Marx, partendo da Hegel, ha riconosciuto in senso essenziale e significativo come alienazione dell’uomo affonda le sue radici nella spaesatezza
dell’uomo moderno. Questa viene provocata dal destino dell’essere nella
forma della metafisica, che la consolida e nello stesso tempo la occulta
come spaesatezza. Poiché Marx nell’esperire l’alienazione penetra in una
dimensione essenziale della storia, la visione marxista della storia è superiore ad ogni altra “storiografia”. Ma siccome né Husserl, né per quello
48 M. Heidegger in Gespräch, p. 74.
250
Anna Pia Ruoppo
che vedo fin ora Sartre, riconoscono l’essenzialità della dimensione storica dell’essere, né la fenomenologia, né l’esistenzialismo pervengono a
quella dimensione in cui soltanto diventa possibile un dialogo produttivo
con il marxismo»49.
È a partire da queste due tesi fondamentali che qui di seguito ci si pone la
domanda sulla possibilità e sulla modalità di tale dialogo.
Per una sua impostazione bisogna tener conto della peculiarità della prospettiva di Heidegger. Anche in tale pensiero è possibile individuare una figura che si può definire dell’alienazione. Tale figura è una figura formale che si
riempie di contenuti diversi nelle varie fasi del suo pensiero. Essa riguarda la
comprensione dell’intero e della sua articolazione interna, quindi il rapporto
che, di volta in volta, in contesti differenti, si instaura fra parti e tutto, ed è una
costante del pensiero di Heidegger, visibile sin dalla prima formulazione programmatica di esso.
Nella prima determinazione del suo pensiero Heidegger si propone di comprendere la vita nella sua complessità, nella sua interezza e movimento, senza
ridurla ad oggetto e con categorie che derivino dalla vita stessa. In una lezione
degli anni ’20, egli descrive questo programma nei termini di un ritorno della
filosofia alla vita dalla alienazione. In polemica con la filosofia del Neokantismo, Heidegger afferma: «è in gioco il riportare la filosofia in dietro a se stessa
a partire dalla sua estraniazione (Entäusserung)»50. Per comprendere cosa intenda qui Heidegger con alienazione, in quanto oggettivazione della vita nella filosofia, bisogna partire dalla differenza fra Gegenstand, “ciò che mi sta di
fronte”, termine con cui si traduce “oggetto” e Objeckt, che è anche “oggetto”,
in senso, però, meramente negativo. Heidegger afferma: «Objekt e Gegenstand
non sono lo stesso. Tutti gli Objekte sono Gegenstände, non tutti i Gegenstände
sono Objekte»51. Ogni comprensione oggettiva è sempre comprensione oggettiva di qualcosa che sta fuori di me e di fronte a me, ma non tutto ciò che mi sta
di fronte deve essere compreso oggettivamente. Cosa si intenda per “oggettivazione” è evidente a partire dalla vita e dalla sua articolazione interna. Heidegger
comprende la vita come un intero significativo, in movimento. La vita è un oggetto nella misura in cui è fissata, bloccata e estrapolata dalle sue connessioni
Lettera, pp. 69-70.
M. Heidegger, Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung (SS 1920), in Gesamtausgabe vol. 59, a cura di C. Strube, Frankfurt
a. M., 1993, p. 29.
51 Id., Phänomenologie des religiösen Lebens, in Gesamtausgabe vol. 60, a cura di M. Jung-T.
Regehly-C. Strube, Frankfurt a. M., 1995, p. 55.
49 50 Heidegger interprete di Marx
251
significative. Per descrivere tale fenomeno Heidegger usa un insieme di termini
molto suggestivi. In quanto ridotta ad oggetto, la vita è smembrata (zerschlagen), ridotta ad un cumulo di cose (senza connessioni). L’oggettività deriva da
un processo di distillazione (herausdistilliert) del mondo circostante, in cui il
contesto è cancellato con un colpo di spugna (ausgelöscht). L’oggettività è devitalizzata, privata della vita (ent-lebt), del significato (ent-deutet), della storia
(ent-geschichtlicht). In quanto oggettiva, la vita è ‘ridotta in pezzi’ (zerstückeln).
Attraverso questa descrizione, Heidegger non intende invitare ad un “superamento” dell’oggettività, ma intende mettere in evidenza come essa debba essere
compresa a partire dalla vita che si dà come un tutto, fatto di connessioni significative. A tale proposito è estremamente significativo l’esempio, apportato da
Heidegger, dell’esperienza vissuta della situazione di una lezione universitaria.
Entrando in un aula uno studente non vede prima la superficie bianca, un forma determinata e poi riconosce la cattedra, ma entra in un contesto significativo e vede immediatamente la cattedra. Secondo Heidegger, anche l’esempio di
un senegalese - che entra in un’aula e si trova di fronte a qualcosa con cui non
sa da dove cominciare, mette in evidenza che il mondo ci viene sempre incontro
in un insieme significativo. Se guardiamo l’esperienza fattuale della vita nella
direzione del contenuto esperito, allora indichiamo ciò che è esperito come
mondo e non come oggetto. Il mondo è qualcosa in cui posso vivere, l’oggetto
no. L’oggettività deve essere compresa a partire da questo contesto significativo e cessa di essere una devitalizzazione della vita, se è compresa la sua genesi
in essa. L’oggettività è un modo derivativo, cioè un modo che deriva dalla vita
nella sua complessità nel momento in cui si estrapola una parte di questa complessità, la si blocca dirigendo la propria attenzione ad esso. La vita nella sua
oggettivazione deve essere compresa a partire dalle connessioni significative,
come parte della vita e non come pezzo, isolato dal suo contesto significativo.
Attraverso tale descrizione, Heidegger, però, non intende superare l’oggettivazione tout court, ma tenta di comprendere tale oggettivazione a partire dal tutto
e dalle sue articolazioni e soprattutto dalla sua attuazione in essa.
Per dimostrare come il confronto con la questione della tecnica e, in un certo modo, con il marxismo sia implicito già nel modo di intendere la vita oggettivata come un cumulo di cose e di pezzi, e come quindi, al di là di differenze di
impostazione, vi sia un filo rosso che collega il pensiero di Heidegger, intorno
alla questione dell’intero e della sua articolazione, è possibile fare riferimento
ad un passo, in cui lo sgretolamento dell’intero della vita e delle sue connessioni di significato è letto nell’ottica di una “socializzazione” e “comunizzazione”,
messa in comune di “pezzi di significatività”. In una lezione degli anni ’20, in
252
Anna Pia Ruoppo
cui è centrale la tematica del ritorno della filosofia alla vita, Heidegger afferma: «Nella modificazione della vita fattuale, che abbiamo indicato come un
“prender conoscenza” eravamo diretti, in una rimozione radicale, alla determinazione di una connessione, che è completamente staccata dalla connessione
dell’esperienza fattuale. La tendenza della vita e la tendenza del prender conoscenza continuano a sussistere, si continua a comprendere la realtà, ma il
senso specifico della realtà dell’esperienza è perduto. I pezzi di significatività
sono derubati dell’intero della significatività; essi sono “socializzati” (sozializiert), o “comunizzati” (kommunisiert) e cioè posti tutti sullo stesso piano»52.
Rotta l’unità delle connessioni significative, la vita è compresa come un oggetto, estrapolato dall’intero della significatività, come un pezzo intercambiabile,
messo sullo stesso piano, socializzato, messo in comune. In queste affermazioni è implicita la critica fondamentale che Heidegger muoverà al comunismo,
a partire dalla sua sovrapposizione con l’essenza della tecnica, all’interno della
storia dell’essere intesa come metafisica. La tecnica, infatti, riduce il reale ad un
cumulo di pezzi interscambiabili53.
Sintetizzando, nella critica all’oggettività è possibile scorgere l’opposizione
ad una comprensione della vita, la quale blocca una parte di essa, rendendola
come un pezzo privo di contesto significativo, quindi, scissa dal suo intero. Se
si considera solo la figura formale che poi si ripete con contenuti diversi, la critica all’oggettività implica il rifiuto di una comprensione di una parte scissa dal
tutto, che non tenga presente l’articolazione fra parte e tutto e il loro rapporto.
Anche nell’analitica esistenziale si può trovare la stessa figura fondamentale
nella dinamica dell’esistenza autentica e inautentica. Il “Si” costituisce il modo
di essere quotidiano e si muove come contraffazione della verità originaria,
resa possibile dalla struttura stessa dell’Esserci. Esso è il velamento della verità
originaria, in quanto apertura e si dà nella presunzione di possedere il tutto.
Tale presunzione lo rende prigioniero di se stesso e della propria inautenticità. La deiezione, infatti, non solo è la contraffazione della verità dell’Esserci
(come intero), ma è anche la dimenticanza stessa di questa contraffazione data
nella presunzione di possedere e raggiungere il tutto. Tale presunzione chiude
l’Esserci sempre più in se stesso, facendolo cadere nel gorgo dell’inautenticità. Il superamento di questa inautenticità è possibile attraverso il recupero del
52 M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie (WS 1919-1920), in Gesamtausgabe
vol 58, a cura di H.-H. Gander, Frankfurt a. M., 1992, p. 223.
53 Attraverso tale riferimento è possibile evidenziare come, per quanto Heidegger abbia assunto alcune linee fondamentali per la tematizzazione dell’essenza della tecnica da Jünger, già
nella sua impostazione di pensiero fossero presenti gli elementi per comprendere la riduzione
tecnica del reale come pezzi di fondo.
Heidegger interprete di Marx
253
«poter-essere-un-tutto» da parte dell‘Esserci. Anche qui ci troviamo di fronte ad
una dinamica che riguarda il rapporto fra una parte, la vita inautentica che si
identifica con il mondo ed è la contraffazione della sua apertura originaria, e il
tutto, il mondo compreso come un intero e un essere un tutto. In uno schizzo
programmatico del ’22, noto come “Natorp-Bericht”54 Heidegger utilizza ancora il termine “alienazione”; questa volta per definire la deiezione. La tendenza
alla deiezione, infatti, è definita come “estraniante” “alienante”, perché la vita
fattuale (termine con il quale è indicato l’esserci) assimilandosi al mondo di cui
si prende cura, diviene sempre più estranea (alienata, Entfremdent) a se stessa
e perde di vista la sua motilità e interezza, credendo di essere la vita. Heidegger afferma: «In quanto tranquillizzante, la tentazione che caratterizza la tendenza alla deiezione è estraniante. Questo significa che la vita effettiva diviene,
nel suo aprirsi al mondo di cui si cura, sempre più estranea a se stessa e che
la motilità del curare, lasciata a se stessa e convinta di essere la vita, sottrae
ad essa sempre di più la possibilità effettiva di assumere, nell’inquietudine, se
stessa nello sguardo e con ciò di porsi, in questo modo, come meta di un ritorno che si riappropria di sé»55. La tendenza alla deiezione è alienante, in quanto
assume la sua assimilazione al mondo, come il tutto della motilità della vita.
La deiezione, o se vogliamo dirlo nei termini utilizzati da Heidegger in questo
schizzo programmatico, l’alienazione, è una motilità fondamentale della vita,
la quale non può essere superata, se non a partire dalla comprensione della
vita come essere un tutto. La stessa dinamica e la stessa figura fondamentale si
possono riscontrare anche nella analisi della storia della metafisica. Il sottrarsi
di una parte al tutto rappresenta, infatti, l’essenza stessa dell’essere, che si dà
in un susseguirsi di epoche, che devono essere comprese a partire dalla storia
del destinarsi dell’essere. Anche la tecnica, intesa come l’essere dell’ente nel suo
più esteriore e probabilmente ultimo destino, viene considerata da Heidegger
come un pericolo, non come strumento mal utilizzato, ma in quanto essa è una
modalità dell’essere che si impone come l’unica modalità, lasciando indietro
(nach-stellen), nella dimenticanza, ogni altro modo di darsi dell’essere stesso.
Cioè essa è solo un’epoca in cui l’essere si dispiega, ma non l’unica epoca o l’unica modalità. La tecnica quindi è il pericolo in quanto è l’essere, e l’essere è il
pericolo della propria essenza, in quanto nel suo darsi in modi diversi rimuove
54 M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Ausarbeitung für die
Marburger und die Göttinger Philosophische Fakultät, a cura di G. Neumann, trad. it. a cura
di A.P. Ruoppo, con un saggio di G. Figal, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele. Elaborazione per le facoltà filosofiche di Marburgo e di Gottinga, Napoli 2005. D’ora in poi: NatorpBericht.
55 Natorp-Bericht, p. 20; trad. it., p. 24.
254
Anna Pia Ruoppo
se stesso come totalità, posponendo un modo del disvelamento all’altro56. Anche se Heidegger qui non usa più il termine “oggettivazione”, “inautenticità” o
“alienazione”, ma “pericolo”, (altrove userà “spaesatezza”, “nichilismo”) siamo
di fronte al medesimo problema, ovverosia la comprensione dell’intero e della
sua articolazione interna, del suo modo di darsi e della possibilità della sua
comprensione ed espressione nel linguaggio.
Se la dimensione in cui deve avvenire il “dialogo produttivo’” con il marxismo, quindi, è quella aperta dalla questione dell’alienazione, e se l’alienazione
si presenta nell’epoca della tecnica nel pericolo e nella spaesatezza dell’uomo,
e se, ancora, è a partire dalla tecnica che va compreso il marxismo, allora la
possibilità del confronto è data dal modo in cui Heidegger intende la svolta e
il superamento della spaesatezza dell’epoca moderna, caratterizzata dal dispiegamento dell’essere nella tecnica, nel quale rientra lo stesso materialismo comunista. La questione del superamento va affrontata a vari livelli ed in ambiti
diversi.
4. Se e come é possibile superare le coercizioni a cui è sottoposto l’uomo
In prima istanza, il superamento, come una svolta nella e dall’epoca della
tecnica, avviene ad un livello strutturale, interno alla storia dell’essere. Se si
tiene conto che la tecnica è pericolo, solo in quanto è una modalità dell’essere,
che viene compresa come l’unica modalità; se si tiene conto che la tecnica rappresenta un pericolo, solo in quanto essa è l’essere che, dispiegandosi in una
successione di epoche, insiste su una singola epoca, considerandola scissa dal
tutto; se si considera che il pericolo è l’essere stesso che scindendosi in mondo
e Ge-stell, pospone l’uno all’altro, dilacerandosi nella sua interezza e volgendosi
contro di essa nella dimenticanza della sua contraffazione, allora la svolta deve
essere colta come un soggiornare che coglie il tutto dell’essere. Per spiegare tale
svolta, interna all’essere e nel suo modo di dispiegarsi, Heidegger usa il termine
“einkehren”, che in tedesco vuol dire “soggiornare”, fermarsi in una locanda,
durante un viaggio, e allo stesso tempo, svoltare57. La svolta è un soggiornare
nella verità o nell’apertura dell’essere. Secondo Heidegger, la possibilità di tale
M. Heidegger, Die Gefahr, in Bremer und Freiburger Vorträger, cit., ed. it., pp. 71-95.
Il termine ‘einkeheren’ indica nella lingua corrente il sostare, l’alloggiare, il soggiornare.
Nella sua struttura però esso richiama la direzione ‘ein’ del volgersi ‘kehren’. Nella traduzione
ho è tentato di rispettare entrambe le sfumature di significato, mettendo in particolare evidenza il richiamo al soggiorno (Aufentahlt). La svolta infatti è possibile solo nella permanenza, nel
soggiorno nella verità dell’essere.
56 57 Heidegger interprete di Marx
255
svolta si nasconde nella stessa essenza del pericolo. Essa avviene nell’istante
in cui «la dimenticanza dell’essenza dell’essere si volta in modo che, con questa svolta (Kehre), la verità dell’essenza dell’essere soggiorna-svolgendosi (einkeheren) propriamente nell’ente»58. Pertanto la svolta è il soggiorno nella verità
dell’essere, in cui l’essere si dà come interezza, prima di inviarsi in un altro
destino. Così come suggerisce la duplicità del termine ‘einkehren’ che indica il
soggiornare e lo svoltare, la svolta è possibile solo in quanto l’essere, soggiornando nella sua verità, si svolge in un altro invio. Quest’invio è una nuova epoca
dell’essere che va compresa a partire dal suo destinarsi. Esso non rappresenta
una salvezza definitiva, perché l’errare, il nascondimento, il pericolo sono costitutivi dell’essenza dell’essere.
Questa preliminare comprensione della svolta e del superamento interno al
mondo tecnico ci permette di circoscrivere l’ambito di un possibile intervento
dell’uomo. L’epoca della tecnica rappresenta il destino dell’uomo, in quanto è
un invio epocale dell’essere, dal quale l’uomo non può prescindere. Il superamento di tale destino è innanzitutto nelle mani dell’essere. Tale superamento
coincide con l’invio di un altro destino. La tecnica pertanto non si lascia governare attraverso un semplice fare umano. Ciò nonostante, però, l’essere non
può compiere la svolta senza l’uomo. Il superamento della sua essenza non si
realizza con un mutamento di atteggiamento, il quale, in quanto tale, si muoverebbe ancora nell’orizzonte della calcolabilità e della prevedibilità tecnica; né
tanto meno con una semplice presa di posizione che condanni tutto ciò che è
tecnico come inumano, rifiutando qualsiasi approccio ad esso. «La tecnica la
cui essenza è l’essere non si lascia oltrepassare attraverso l’uomo»59. Tuttavia,
allo stesso tempo, il destino dell’uomo non è quello di stare semplicemente a
guardare. L’uomo può preparare la svolta e, contemporaneamente, ha la possibilità di assumere un contegno appropriato al dominio tecnico. Heidegger
afferma: «Poiché l’essere si è destinato come essenza della tecnica nel Ge-stell, e
all’essenza del Ge-stell appartiene anche l’essenza dell’uomo, nella misura in cui
l’essere ha bisogno dell’uomo per restare salvaguardato in quanto tale secondo
la propria essenza nel mezzo degli enti, ed essere così essenzialmente in quanto
essere, allora l’essenza della tecnica non può essere condotta alla trasformazione del suo destino senza la collaborazione dell’uomo»60.
Il contributo dell’uomo, però, non può arrivare attraverso un’etica che dia
delle indicazioni sul comportamento e sugli atteggiamenti da assumere. NelM. Heidegger, Die Kehre, in Bremer und Freiburger Vorträger, cit., ed. ted., p. 71.
Ibid., p. 69.
60 Ibid.
58 59 256
Anna Pia Ruoppo
la parte finale della Lettera sull’«Umanismo, Heidegger pur riconoscendo che
«il desiderio di un etica si fa tanto più urgente, quanto più il disorientamento
manifesto dell’uomo, non meno di quello nascosto, aumenta a dismisura»61 e
che «al vincolo dell’etica bisogna dedicare ogni cura, in un tempo in cui l’uomo
della tecnica, in balia della massificazione, può essere portato ancora ad una
stabilità sicura solo mediante un raccoglimento e un ordinamento del suo progettare e del suo agire, nel loro insieme, che corrispondano alla tecnica»62, rifiuta il ricorso ad un’etica, intesa in senso tradizionale. L’etica, infatti, in quanto è
una disciplina del pensiero, nasce quando il pensiero si «ritira dal suo elemento», perdendo di vista l’essere. Tuttavia nel medesimo contesto, Heidegger pensa, «in conformità al termine ethos», l’”etica” come soggiorno e «quel pensiero
che pensa la verità dell’essere come l’elemento iniziale dell’uomo in quanto esistente»63 come «l’etica originaria»64. Egli, infatti, ritiene che il pensiero può
trarre delle utili indicazioni soggiornando nell’essere ed afferma: «Solo in quanto l’uomo, e-sistendo nella verità dell’essere, all’essere appartiene, può giungere
dall’essere stesso l’assegnazione di quelle consegne che devono divenire legge
e regola per l’uomo»65. Pertanto, secondo Heidegger, «più essenziale di ogni
fissazione di regole è che l’uomo trovi il soggiorno nella verità dell’essere. Solo
questo soggiorno concede l’esperienza del mantenibile. Il sostegno per ogni
contegno lo dona la verità dell’essere»66. Da tale soggiorno Heidegger fa derivare le leggi fondamentali del pensiero. La prima legge viene identificata nella
«con-venienza del dire dell’essere come destino della verità, e non [nel]le regole
della logica che possono diventare regole solo in base alla legge dell’essere»67.
A ciò segue «il rigore della meditazione, la cura del dire, la parsimonia delle
parole»68.
Ponendo fine alla sue considerazioni sull’etica, Heidegger afferma: «é tempo
di disabituarsi a sopravvalutare la filosofia e quindi chiederle troppo. Nell’attuale situazione di necessità del mondo è necessaria meno filosofia ma più attenzione al pensiero, meno letteratura ma più cura della lettera delle parole»69.
E che una risposta alla situazione di alienazione e di spaesamento dell’uomo
Ibid., p. 88.
Ibid.
63 Ibid., p. 93.
64 Ibid.
65 Ibid. p. 99.
66 Ibid.
67 Ibid., p. 102.
68 Ibid., p. 103.
69 Ibid.
61 62 Heidegger interprete di Marx
257
contemporaneo debba venire dal pensiero e, soprattutto, di quale tipo di pensiero si tratti, diviene evidente negli ultimi due testi, qui presi in considerazione, in cui Heidegger si confronta con il “problema Marx”.
Centrali a tale proposito sono un’intervista televisiva con Richard Wisser, e un
seminario tenuto a Le Thor nel 1969, i cui protocolli sono pubblicati nel volume
dedicato agli ultimi seminari di Heidegger. Nell’intervista televisiva Heidegger viene esplicitamente interrogato sulla possibilità di un compito sociale per la filosofia. La risposta di Heidegger è molto chiara: «No! In questo senso non si può
parlare di un compito sociale! Se si vuole trovare una risposta a questa domanda,
bisogna prima chiedersi „che cosa è società?“, e bisogna riflettere sul fatto che la
società di oggi è solo l’assolutizzazione della soggettività moderna e che a partire
da qui una filosofia che ha superato il punto di partenza della soggettività non può
immischiarsi»70. La possibilità di pensare un compito sociale per la filosofia deve
passare per la comprensione dell’essenza di ciò che si vuole trasformare. A ciò si
connette la problematicità della modalità della trasformazione. Nella sua risposta
Heidegger continua:
«Un’altra questione è fino a che punto si può parlare di un cambiamento
(Veränderung) della società. La questione della richiesta di una trasformazione del mondo (Weltveränderung) ci riporta ad una frase di Marx più volte
citata: “I filosofi hanno soltanto interpretato il mondo in modo diverso, adesso si tratta di cambiarlo”. Citando e seguendo questa frase non si tiene conto
che una trasformazione del mondo presuppone un cambiamento della rappresentazione del mondo (eine Änderung der Weltvorstellung) e che una rappresentazione del mondo si può ottenere solo nel momento in cui il mondo
è interpretato in modo esaustivo. Questo significa: Marx si basa su una determinata interpretazione del mondo per richiedere il suo “cambiamento” e con
ciò questa frase emerge come priva di fondamento. Essa dà l’impressione
che si parli in modo decisivo contro la filosofia, mentre nella seconda parte
della frase si presuppone implicitamente la richiesta di una filosofia»71.
A tale proposito Heidegger rileva una contraddizione nel pensiero di Marx. L’affermazione secondo la quale il mondo è stato sufficientemente interpretato e che
bisogna passare alla sua trasformazione implica una priorità dell’azione rispetto
alla semplice interpretazione. Ma tale affermazione non può che basarsi che su una
70 71 M. Heidegger in Gespräch, p. 69.
Ibid.
258
Anna Pia Ruoppo
preliminare interpretazione che riconosce come fondamentale l’azione dell’uomo
e ne determina il carattere. Come emerge dalla lettura degli appunti del seminario
di Le Thor72, alla scissione e alla contrapposizione fra azione e interpretazione,
Heidegger intende contrapporre un’idea di interpretazione che è in se stessa già
trasformazione. Qui Heidegger si riferisce al marxismo come a quel pensiero che
ha saputo individuare «le due sole realtà dell’epoca attuale: lo sviluppo economico
e l’armamento che esso richiede»73 e che addirittura è saputo andare oltre, proponendo una trasformazione del mondo. Anche a tale proposito Heidegger riporta
l’undicesima tesi su Feurbach e ne propone un’interpretazione critica.
«“I filosofi hanno solo interpretato diversamente il mondo; si tratta di
trasformarlo”. Per un esame critico di questa tesi: c’è una vera e propria
antitesi tra interpretazione e trasformazione del mondo? Non è forse ogni
interpretazione già una trasformazione del mondo – posta che questa interpretazione sia il risultato di un pensiero genuino? E d’altra parte, ogni
trasformazione del mondo non presuppone forse, come strumento, una
preliminare visione teoretica?»74.
In Marx c’è una determinata nozione teoretica dell’uomo che «conia il concetto
di produzione in quanto produzione dell’uomo mediante se stesso»75. Quest’idea
si basa sulla concezione hegeliana della vita come processo ed è tutta interna alla
storia della metafisica. Essa deriva da uno specifico modo di intendere la teoria in
contrapposizione alla prassi. Heidegger sottolinea come, invece, nell’Etica Nicomachea la teoria fosse «la più elevata prassi umana»76. Al contrario la teoria significa
oggi «porre la natura come calcolabile e dominabile alla maniera di Galileo»77. Tale
teoria si pone in completa opposizione alla prassi.
5. Heidegger in risposta a Marx? Le tracce di un dialogo
Tuttavia, come abbiamo già accennato, fin dalla prima formulazione del suo
pensiero, Heidegger intende superare la scissione fra teoria e prassi, opponendosi al predominio del teoretico, e considerando ogni sapere, non come teoria,
M. Heidegger, Le Thor 1969, in Id., Seminari, cit., pp. 89-144. D’ora in poi: Le Thor 1969.
Ibid., p. 121.
74 Ibid., p. 122.
75 Ibid.
76 Ibid., p. 123.
77 Ibid., p. 124.
72 73 Heidegger interprete di Marx
259
ma come “interpretazione”, e, solo in quanto tale, come “trasformazione”.
Un tentativo di comprendere come si debba intendere tale “interpretare” e
tale “trasformare”, deve partire dall’originario orientamento di Heidegger alla
filosofia di Aristotele. Non dobbiamo dimenticare che le radici del pensiero di
Heidegger sono da collocarsi nell’ambito problematico posto dal Neokantismo
e dalla Fenomenologia e che Heidegger si pone, sin dall’inizio, il problema del
“dire” i fenomeni nel modo in cui essi si manifestano. Alla ricerca di un modello di filosofia “non oggettivante”, egli critica quello che chiama “il predominio”
del teoretico, nel tentativo di comprendere la vita nella sua vitalità. Con questa
finalità egli analizza il rapporto fra teoria e prassi attraverso l’interpretazione
del VI libro dell’Etica Nicomachea, assumendo come modello della teoria e della prassi quelle che per Aristotele sono due delle virtù dianoetiche, la sophia e la
phronesis78. Attraverso questa analisi Heidegger mette in evidenza come in Aristotele la teoria sia ancora in grado di comprendere la vita, pur conservando in
se stessa una tendenza alla deiezione, ovverosia una tendenza a perdere di vista
la vita in cui essa si radica79. L’opposizione fra teoria e vita, però, si ha solo con
lo spostamento della teoria nell’ambito delle ipotesi e delle dimostrazioni, tipico, secondo Heidegger, dell’impostazione di pensiero neokantiana. Per opporsi
al predominio di tale teoria, nella formulazione del suo pensiero, avvenuta nelle
lezioni del primo periodo friburghese (1919-1923), Heidegger orienta la filosofia alla phronesis. Questo orientamento ha un motivo meramente “metodologico”. La phronesis, infatti, è la capacità di mediare l’universale nel particolare,
l’intuitivo nell’orizzonte della comprensione. Essa, in quanto tale, offre la base
per la comprensione della vita come intero. Per quanto la sua funzione sia innanzitutto metodologica, l’orientamento della filosofia alla phronesis, tuttavia,
ha come conseguenza l’introduzione in essa di un momento “pratico”. La filosofia, in quanto interpretazione, infatti, non contempla il mondo, lasciandolo
immutato, ma nel comprenderlo, lo trasforma.
Attraverso un ulteriore confronto con Aristotele e con il suo concetto di
prassi è possibile comprendere come sia da intendersi tale trasformazione. Per
Aristotele la prassi è il movimento nel quale è contenuto il fine, è il portare a
compimento che non si risolve nella creazione di qualcosa di esterno ed estraneo. Il pensare e il comprendere non “producono effetti”, ma agiscono nel portare a compimento il pensiero e la comprensione stessa. L’orientamento della
filosofia alla phronesis acquisisce un senso ancora più profondo, se si considera
78 79 Natorp-Bericht, pp. 47-67.
Ibid., p. 66.
260
Anna Pia Ruoppo
che, nelle primissime fasi del suo pensiero80, per pensare la relazione dell’intuizione con la comprensione, prima ancora di orientarsi ad Aristotele, Heidegger
si orienta ad Hegel e alla sua concezione della dialettica81. Nella misura in cui
rinuncia al momento dialettico a favore della phronesis, egli esclude dalla sua
prospettiva di pensiero la possibilità di pensare la trasformazione. Non a caso,
pertanto, quando parla del contegno dell’uomo nell’epoca della tecnica, egli
parla del suo “soggiornare” nell’Aperto o del suo “abbandono”. E non a caso
questo abbandono è descritto come un “insistere” nell’Aperto, che è un sì e un
no alla tecnica, intesa nella prospettiva del dispiegamento dell’essere.
Il dialogo di Heidegger con Marx può essere impostato solo all’interno di
questi confini. E se è certo vero che, considerando il pensiero di Marx un momento del dispiegamento della storia dell’essere, Heidegger manca esattamente
il proprium del marxismo, ovverosia l’affermazione scientifica della sua capacità rivoluzionaria di sovvertire lo stato di cose presenti, è pur vero che, assumendo il punto di vista di Marx, non si può chiedere ad Heidegger di offrirci
risposte circa la trasformazione politica del mondo. A partire dal suo dispositivo di pensiero, egli non è in grado di darci una risposta in tal senso, se non
ricorrendo alla poesia, al pensiero rammemorante, ma ciò non avviene, certo,
nella prospettiva e nelle intenzioni di Marx.
80 Si pensa in questo momento soprattutto alla lezione del semestre invernale 1919/1920
dal titolo Grundprobleme der Phänomenologie, cit.
81 A proposito dell’orientamento di Heidegger, nella lezione citata, alla dialettica di Hegel
si veda: A. P. Ruoppo, “Si può apprendere più da Hegel che da Zaratustra”. La formulazione heideggeriana di una fenomenologia della vita in dialogo con Heinrich Rickert, in «Archivio di storia
della Cultura», anno XX, 2007, pp. 155-177.
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
261
ELENCO E RIPARTIZIONE DEI SOCI
PER ORDINE DI ANZIANITà
CONSIGLIO DIRETTIVO
Tessitore Fulvio, Presidente
Villani Pasquale, Vice Presidente
Assante Franca, Segretario
Massimilla Edoardo, Tesoriere
SOCI EMERITI (posti 4)
SEZIONE DI SCIENZE MORALI
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 14)
1) Guarino Antonio, prof. emerito di Diritto romano nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Aniello Falcone, 403/ter - 80127 Napoli (tel.
081.667729).
2) Masullo Aldo, prof. emerito di Filosofia morale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Viale Michelangelo, 21 - 80129 Napoli (tel.
081.5568328).
3) Del Treppo Mario, già prof. ord. di Storia medioevale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 228 - 80123 Napoli (tel.
081.7691432).
4) Casavola Francesco Paolo, già prof. ord. di Storia del Diritto romano
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Vincenzo Padula, 2 - 80123
Napoli (tel. 081.5756522).
5) Ajello Raffaele, già prof. ord. di Storia del Diritto italiano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 63 - 80078 Pozzuoli (NA) (tel.
081.5262554).
6) Venditti Antonio, già prof. ord. di Diritto commerciale nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Petrarca, 40 - 80122 Napoli (tel.
081.5755436).
262
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
7) Cantillo Giuseppe, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via San Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno (tel.
089.790821).
8) Lissa Giuseppe, prof. ord. di Filosofia morale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via A. Trucillo, 34 - 84100 Salerno (tel. 089.230853).
9) Di Vona Piero, già prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Salita Arenella, 19 -80129 Napoli (tel.
081.366107).
10) Trione Aldo, prof. ord. di Estetica nell’Università di Napoli “Federico
II” - Via Pietro Castellino, 141G - 80131 Napoli (tel. 081.5451035).
11) Vitolo Giovanni, prof. ord. di Storia medioevale nell’Università di
Napoli “Federico II” - Piazza Annunziata, 45 - 80142 Angri (SA).
12) Rao Annamaria, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Napoli
“Federico II” - Vico Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel.
081.5648805).
13) Lomonaco Fabrizio, prof. ord. di Storia della Storiografia filosofica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Pietro Giannone, 33/a 80141 Napoli (tel. 081.457603).
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Federici Vescovini Graziella, prof. ord. di Storia della Filosofia
nell’Università di Parma - Via dei Renai, 11 - 50122 Firenze (tel.
055.243019).
2) Vegetti Mario, prof. ord. di Storia della Filosofia antica nell’Università di
Pavia - Via Giambattista Bassoni, 6 - 20123 Milano (tel. 02.4694384).
3) Cotroneo Girolamo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Messina - Via Maffei, 15 - 98100 Messina.
4) Cesa Claudio, prof. emerito di Storia della Filosofia nella Scuola Normale
di Pisa - Via Martiri di Scalvaia, 19 - 53100 Siena (tel. 0577.283687).
5) Nuzzo Enrico, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Salerno - Piazza Porta Rotese, 18 - 84100 Salerno.
6) Levra Umberto, prof. ord. di Storia del Risorgimento nell’Università di
Torino - Via Casale, 143/2 - 10099 S. Mauro Torinese (TO).
7) Lenoci Michele, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università Cattolica di Milano - Corso Genova, 16 - 20123 Milano.
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI 263
(posti 14)
1) Labruna Luigi, prof. ord. di Storia del Diritto romano nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Chiaia, 149/A - 80121 Napoli (tel.
081.425885).
2) De Lorenzo Renata, prof. ord. di Storia contemporanea nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Mosca, 4 - 80129 Napoli (tel. 081.5564464).
3) Figliuolo Bruno, prof. ord. di Storia medioevale nell’Università di Udine
-Parco Carelli, 62 -80123 Napoli.
4) Di Marco Giuseppe Antonio, prof. ord. di Filosofia della Storia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Gradini S. Nicola da Tolentino,
7 - 80135 Napoli (tel. 081.400202).
5) Viti Cavaliere Renata, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Donizetti, 1/e - 80127 Napoli (tel.
081.5789878).
6) Montano Aniello, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Salerno -Via Montessori, 19 - 80011 Acerra (NA) (tel. 081.5201483).
7) Pellegrino Bruno, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Lecce
- Via delle Bombarde, 20 - 73100 Lecce (tel. 0832.309410).
8) D’agostino Guido, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Napoli “Federico II” - Parco Comola Ricci, 23 - 80122 Napoli (tel.
081.642217).
9) Muto Giovanni, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Ligorio Pirro, 20 - 80129 Napoli (tel.
081.5783609).
10) Musi Aurelio, prof. ord. di Storia moderna nell’Università di Salerno Via Canalone all’Olivella, 21 - 80135 Napoli (tel. 081.5496170).
11) Rambaldi Feldmann Enrico, già prof. ord. di Storia della Filosofia morale
nell’Università di Milano - Viale Argonne, 41 - 20133 Milano.
12) Giugliano Antonello, prof. ord. di Storia della Filosofia contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Strada Gianturco Emanuele,
36 - 80055 Portici (Na) - (tel. 081.471053)
13) Verde Giovanni, prof. ord. f.r. di Diritto processuale civile nell’Università
Luiss Roma - Via T. Angelini, 21/c - 80129 Napoli.
SOCI STRANIERI (posti 7)
1) Nowicki Andrej, prof. di Storia della Filosofia nell’Università di LublinSowinskiego 7 m. 25 - 20040 Lublino (Polonia).
2) Trinidade Santos José Gabriel, prof. di Filosofia nell’Università Nova di
264
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
Lisbona - Rua Soeiro Pereira Gomes, Ed. America, Bloco A, ap. 405 1600 Lisboa (Portogallo)
SEZIONE DI SCIENZE POLITICHE
SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 13)
1) Galasso Giuseppe, prof. emerito di Storia medievale e moderna
nell’Università di Napoli “Federico II” - Via Napoli, 3/d - 80078 Pozzuoli
(NA) (tel. 081.5262947).
2) Tessitore Fulvio, prof. ord. f.r. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli“Federico II” - Via Santo Strato, 14 - 80123 Napoli (tel.
081.5755411).
3) Villani Pasquale, prof. emerito di Storia contemporanea nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via F. Cilea, 183 - 80127 Napoli (tel.
081.5604368).
4) Abbamonte Giuseppe, già prof. ord. di Diritto amministrativo
nell’Università di Napoli “Federico II” - Viale Gramsci, 6/a - 80122
Napoli (tel. 081.663383).
5) Villone Betocchi Giulia, già prof. ord. di Psicologia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via dei Mille, 61 - 80121 Napoli (tel.
081.415741).
6) Cacciatore Giuseppe, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via L. Cassese, 12 - 84100 Salerno (tel.
089.222848).
7) Casertano Giovanni, prof. ord. di Storia della Filosofia antica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Salita Sant’Antonio a Tarsia,
28 - 80135 Napoli (tel. 081.5445089).
8) Assante Franca, prof. ord. f.r di Storia economica nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Manzoni, 132 - 80123 Napoli (tel.
081.7145844).
9) Mazzarella Eugenio, prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Napoli “Federico II” - Via Orazio, 27 - 80122 Napoli (tel. 081.666279).
10) Acocella Giuseppe, prof. ord. di Etica sociale nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via S. Giovanni Bosco, 47 - 84100 Salerno.
11) Massimilla Edoardo, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Matteotti, 18 - 80078 Pozzuoli (Na).
12) Conte Domenico, prof. ord. di Teoria e storia della storiografia
nell’Università di Napoli “Federico II” - Traversa Antonio Pio, 64 - 80126
Napoli (tel. 081.7281122).
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
265
SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)
1) Giarrizzo Giuseppe, prof. emerito di Storia moderna nell’Università di
Catania - Via Orto dei Limoni, 60 - 95125 Catania.
2) Bertolino Rinaldo, prof. ord. di Diritto ecclesiastico nell’Università di
Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino.
3) Rossi Pietro, già prof. ord. di Filosofia della Storia nell’Università di
Torino -Via Carlo Alberto, 59 - 10123 Torino.
4) Sasso Gennaro, già prof. ord. di Filosofia teoretica nell’Università di
Roma “La Sapienza” - Via Sant’Alberto Magno, 1 - 00153 Roma.
5) Graziani Augusto, prof. ord. f.r. di Economia Politica nell’Università
di Roma “La Sapienza” - Via Ascensione, 5 - 80121 Napoli (tel.
081.418329).
6) Talamo Giuseppe, prof. ord. f.r. di Storia del Risorgimento Università di
Roma “Terza Università”, Via Alpi, 8/A - Roma (tel. 06.8554970).
7) Scarcia Amoretti Bianca Maria, prof. ord. f.r. di Islamistica nell’Università
di Roma “La Sapienza”, Via Cameria, 3 - 00179 Roma.
SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)
1) Rascio Raffaele, già prof. ord. di Istituzioni di Diritto privato
nell’Università di Napoli - Parco Comola Ricci, 21 - 80122 Napoli (tel.
081.660632).
2) Savignano Aristide, prof. ord. di Istituzioni di Diritto pubblico
nell’Università di Firenze - Corso Mazzini, 15 - 50132 Firenze (tel.
055.2476301).
3) Barbagallo Francesco, prof. ord. di Storia contemporanea
nell’Università di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 207 80121 Napoli (tel. 081.408346).
4) Gaetani D’aragona Gabriele, già prof. ord. di Economia agraria
nell’Università di Napoli Parthenope - Piazza S. Maria degli Angeli, 1 80132 Napoli (tel. 081.7645732).
5) Mazzacane Aldo, prof. ord. di Storia del diritto italiano - Via Orazio,
22 - 80122 Napoli.
6) Di Costanzo Giuseppe, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Girolamo Santacroce, 25 - 80129 Napoli
(tel. 081.5563963).
266
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
7) Papuli Giovanni, già prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università di
Lecce - Via Vecchia Manifattura Tabacchi, 34 - 73100 Lecce.
8) Scocozza Antonio, prof. ord. di Lingua, cultura e istituzioni dei paesi
di lingua spagnola nell’Università di Salerno - Via Delle Filande, 24 84080 Pellezzano (SA) (tel. 089.274189).
9) Mascilli Migliorini Luigi, prof. ord. di Storia moderna nell’Università
“L’Orientale” - Via A. D’Isernia, 31 - 80122 Napoli (tel. 081.661334).
10) Russo Luigi, prof. ord. di Estetica nell’Università di Palermo - Via
Giovan Battista Lulli, 4 - 90145 Palermo.
11) Donadio Francesco, prof. ord. di Storia della Filosofia nell’Università
di Napoli “Federico II” - Via Castiello, 20 - 80024 Cardito (NA) (tel.
081.8321387).
12) Mazzetti Ernesto, prof. ord. di Geografia politica ed economica
nell’Università di Napoli “Federico II” - Piazza Donn’Anna, 9 - 80123
Napoli (tel. e fax 081.7646467).
13) Santoni Francesco, prof. ord. di Diritto del lavoro nell’Università
di Napoli “Federico II” - Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli (tel.
081.7611341).
14) Jossa Bruno, prof. ord. f.r. di Economia politica nell’Università di Napoli
“Federico II” - Via G. Pisciscelli, 77 - 80121 Napoli (tel. 081 668326).
SOCI STRANIERI
(posti 6)
1) Stein Peter, prof. ord. di Storia del Diritto romano nel Queen’s College
di Cambridge - Queen’s College, Cambridge CB3.9ET (Gran Bretagna).
2) Vovelle Michel, prof. emerito di Storia moderna nell’Università di
Paris-Sorbonne - 3 avenue Villemus, 13100 Aix en Provence (Francia).
3) Kaufmann Matthias, prof di Etica nell’Università di Halle-WittenbergBurgerstrasse, 57 - D91054 Erlangen (Germania)
4) Sevilla Fernández José Manuel, prof. ord. di Filosofia nell’Univerisità di
Siviglia - c/ Ganado, 20, 2°A - 11500 - El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
(spagna) (tel. 0034 666745878).
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
267
Indice
Donatella Nigro, L’umanesimo notturno del Giuseppe e i suoi
fratelli di Thomas Mann.................................................................. pag. 5
Maria Della Volpe, In margine alla recente pubblicazione degli
Scritti di Benedetto Croce su Francesco De Sanctis...................... »
25
Salvatore Principe, Descartes e la filosofia trascendentale: a
proposito di Lauth lettore di Cartesio.............................................. »
47
Chiara Russo Krauss, Il tema della reine Erfahrung nella prima
edizione delle Grenzen di Heinrich Rickert..................................... »
63
Lucia Corrado, Fenomenologia delle emozioni.............................. »
77
Maria Letizia Pelosi, Verticalità e orizzontalità dell’amore:
Hannah Arendt interprete di Agostino............................................. »
97
Mauro Senatore, Macchine Performative. La produzione tecnica
del performativo in Jacques Derrida................................................ » 113
Antonello Petrella, Dall’occultamento della trascendenza ad un
nuovo umanesimo: un percorso jaspersiano........................................ » 139
Alessio Calabrese, Tra neokantismo e positivismo giuridico:
diritto e Stato nella riflessione giovanile di Carl Schmitt................ » 155
Antonella Muzzupappa, Valori, prezzi e «problema della
trasformazione» in Karl Marx......................................................... » 191
Anna Pia Ruoppo, Heidegger interprete di Marx............................ » 235
268
Elenco e ripartizione dei soci per ordine di anzianità
Regist. Tribunale di Napoli n. B/2317 del 14 agosto 1954
Officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli S.p.A.
Proprietà della testata: Accademia di Scienze Morali e Politiche,
via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli
Direttore responsabile: accademico Aldo Trione
Finito di stampare nel mese di gennaio 2010