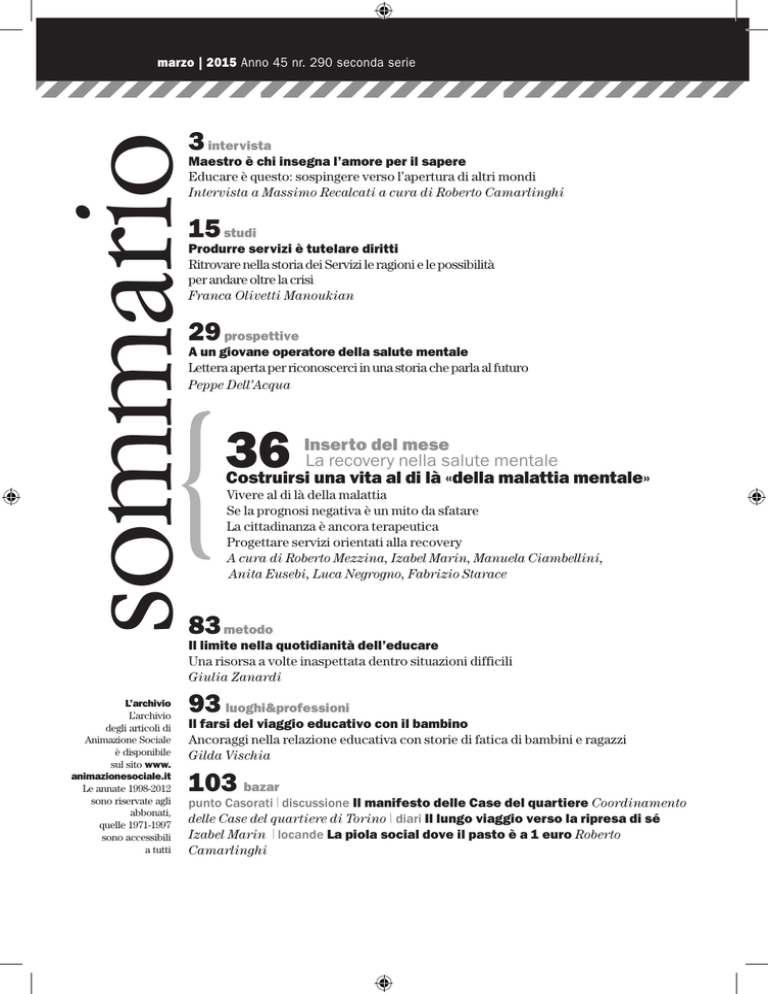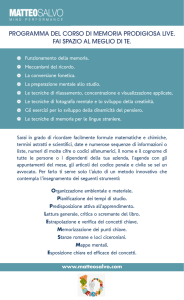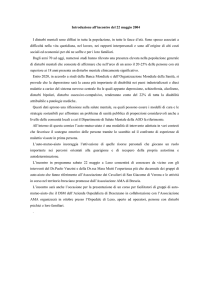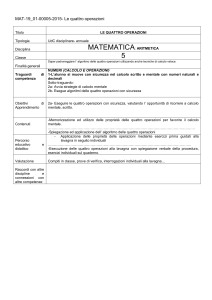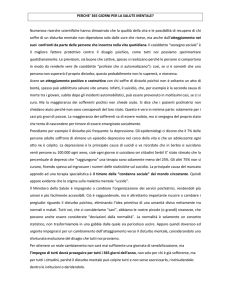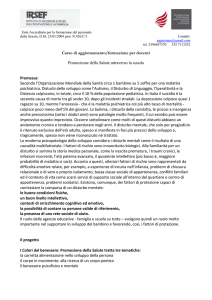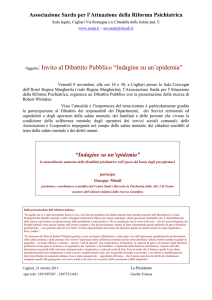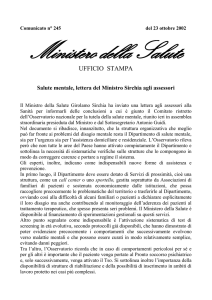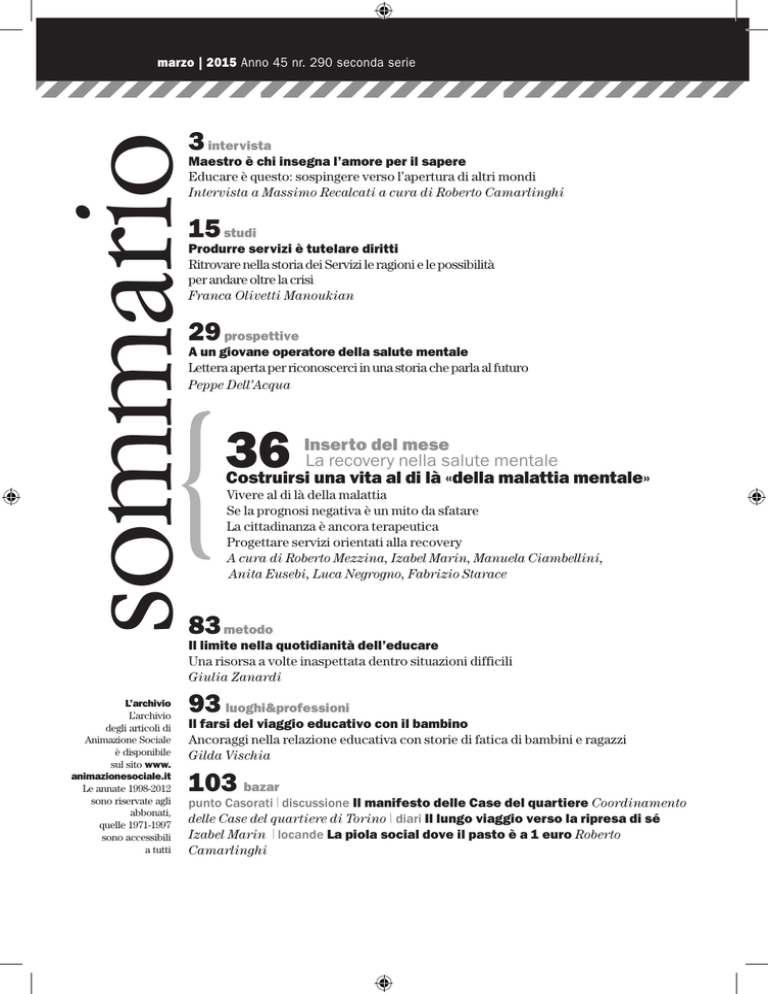
marzo | 2015 Anno 45 nr. 290 seconda serie
sommario
3
intervista
Maestro è chi insegna l’amore per il sapere
Educare è questo: sospingere verso l’apertura di altri mondi
Intervista a Massimo Recalcati a cura di Roberto Camarlinghi
15
studi
Produrre servizi è tutelare diritti
Ritrovare nella storia dei Servizi le ragioni e le possibilità
per andare oltre la crisi
Franca Olivetti Manoukian
29
prospettive
A un giovane operatore della salute mentale
Lettera aperta per riconoscerci in una storia che parla al futuro
Peppe Dell’Acqua
36
Inserto del mese La recovery nella salute mentale
Costruirsi una vita al di là «della malattia mentale»
Vivere al di là della malattia
Se la prognosi negativa è un mito da sfatare
La cittadinanza è ancora terapeutica
Progettare servizi orientati alla recovery
A cura di Roberto Mezzina, Izabel Marin, Manuela Ciambellini,
Anita Eusebi, Luca Negrogno, Fabrizio Starace
83
metodo
Il limite nella quotidianità dell’educare
Una risorsa a volte inaspettata dentro situazioni difficili
Giulia Zanardi
L’archivio
L’archivio
degli articoli di
Animazione Sociale
è disponibile
sul sito www.
animazionesociale.it
Le annate 1998-2012
sono riservate agli
abbonati,
quelle 1971-1997
sono accessibili
a tutti
93
luoghi&professioni
Il farsi del viaggio educativo con il bambino
Ancoraggi nella relazione educativa con storie di fatica di bambini e ragazzi
Gilda Vischia
103
bazar
punto Casorati | discussione Il manifesto delle Case del quartiere Coordinamento
delle Case del quartiere di Torino | diari Il lungo viaggio verso la ripresa di sé
Izabel Marin | locande La piola social dove il pasto è a 1 euro Roberto
Camarlinghi
Fondato nel 1971 da Aldo Guglielmo Ellena
ABBONAMENTI 2015
290
Rivista edita da Edizioni Gruppo Abele
corso Trapani 95 - 10141 Torino
tel. 011 3841048 · fax 011 3841047
[email protected]
www.animazionesociale.gruppoabele.org
facebook.com/animazione.sociale
Direzione e redazione
Franco Floris (direttore responsabile - [email protected]), Ro­ber­to Camarlinghi (vice
direttore - [email protected]), Laura Carletti ([email protected]),
Francesco Caligaris ([email protected]), Francesco d’Angella (francesco.dangella.as@
gmail.com).
Segreteria di redazione
Gianluca Borio ([email protected]), Daniele Croce (daniele.croce.as@
gmail.com)
Comitato di redazione
Eleonora Artesio, Paolo Bianchini, Lucia Bianco, Elisabetta Dodi, Michele Gagliardo, Elena Granata,
Riccardo Grassi, Andrea Marchesi, Michele Marmo, Roberto Maurizio, Francesca Paini, Norma
Perotto, Ennio Ripamonti, Franco Santamaria, Simone Spensieri.
Consulenti
Marco Aime (interazioni tra mondi culturali), Roberto Beneduce (psichiatria transculturale),
Pier Giulio Branca (processi di partecipazione), Massimo Campedelli (politiche di welfare),
Ugo Corino (cura della gruppalità), Mauro Croce (prevenzione delle dipendenze), Duccio
Demetrio (educazione degli adulti), Norma De Piccoli (logiche dell’empowerment), Ota de
Leonardis (culture e istituzioni delle politiche sociali), Italo De Sandre (professioni sociali),
Leopoldo Grosso (pedagogia delle dipendenze), Marco Ingrosso (promozione della salute),
Gioacchino Lavanco (sviluppo di comunità), Vanna Iori (pedagogia delle emozioni), Ivo
Lizzola (antropologia della cura), Sergio Manghi (epistemologia delle relazioni sociali), Nicola
Negri (contrasto della povertà), Franca Olivetti Manoukian (formazione degli operatori), Mario
Pollo (animazione culturale), Fulvio Poletti (processi dell’educare), Piergiorgio Reggio (pedagogia interculturale), Dario Rei (terzo settore), Claudio Renzetti (auto-organizzazione della
cura), Francesca Rigotti (analisi dei processi culturali), Chiara Saraceno (politiche per la
famiglia), Paola Scalari (comunità educante), Gabriele Vacis (processi culturali e artistici).
La rete
Silvia Brena (Bergamo), Daniele Bruzzone (Piacenza), Elena Buccoliero (Ferrara), Salvatore
Cacciola (Catania), Lorenzo Canafoglia (Milano), Ettore Cannavera (Cagliari), Franco Chiarle
(Torino), Luigi Colaianni (Milano), Maurizio Colleoni (Bergamo), Barbara D’Avanzo (Milano),
Riccardo De Facci (Sesto S. Giovanni), Giuseppe De Robertis (Andria), Stefano De Stefani
(Rovigo), Alessandra Di Toma (Bologna), Barbara di Tommaso (Milano), Graziella Favaro (Milano),
Max Ferrua (Torino), Osvaldo Filosi (Trento),Alessandro Forneris (Torino), Marina Galati (Lamezia
Terme), Claudia Galetto (Pinerolo), Raffaella Goattin (Venezia), Claudio Gramaglia (Padova),
Alain Goussot (Bologna), Riccardo Guidi (Lucca), Pierpaolo Inserra (Roma), Giacomo Invernizzi
(Bergamo), Giovanni Laino (Napoli), Roberto Latella (Roma), Raffaello Martini (Lucca), Giorgio
Macario (Firenze), Gino Mazzoli (Reggio E.), Michele Marangi (Torino), Laura Molteni (Milano),
Meme Pandin (Venezia), Paolo Peruzzi (Arezzo), Salvatore Pirozzi (Napoli), Silvio Premoli (Milano),
Emiliano Proietto (Firenze), Paola Scarpa (Venezia), Paola Schiavi (Legnago), Chiara Sità
(Verona), Giorgio Sordelli (Milano), Nicoletta Spadoni (Reggio E.), Matteo Villa (Pisa), Tommaso
Vitale (Milano), Carla Weber (Trento), Boris Zobel (Torino).
Progetto grafico: Avenida grafica e pubblicità (Mo) - Disegni di copertina: Francesco
Casorati - Impaginazione: Centro Grafico Gruppo Abele - Stampa: Stampatre (To)
Issn 0392-5870 - Registrato al Tribunale di To­ri­no il 12.1.1988 nr. 3874. Iva assolta
dall’editore ai sensi art. 1 decreto Ministero delle finanze 29.12.1989 - I dati personali sono
trattati elettronicamente e utilizzati esclusivamente dall’Associazione Gruppo Abele (Onlus) per
l’invio di informazioni sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art. 13, L. 675/96 sarà possibile
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e far cancellare i dati personali, scrivendo a: Asso­ciazione Gruppo Abele, Responsabile Dati, corso Trapani 95, 10141 Torino.
La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla L. 07.08.90, nr. 250.
• Privati: annuale € 48
biennale € 87 - triennale € 127
• Enti pubblici e privati, associazioni,
cooperative: annuale € 75
biennale € 144 - triennale € 208
• Sostenitore € 100
• Studenti (attestato di frequenza) € 36
• Estero € 100
• Cumulativo Animazione Sociale +
Narco­ma­fie: Privati € 71 - Enti pubblici
e privati, associazioni, cooperative € 93
Estero € 180
Ufficio abbonamenti
Da lunedì a venerdì, ore 10-13 e 14-17
tel. 011 3841046 - fax 011 3841047
e-mail: [email protected]
Modalità di abbonamento
• Conto corrente postale: conto nr.
155101 - Gruppo Abele Periodici - corso
Trapani 95 - 10141 Torino.
• Carta di credito on-line (Visa, Mastercard):
collegarsi al sito: www.animazionesociale.
gruppoabele.org
• Bonifico bancario: presso Banca Po­
polare Etica - Filiale di Torino - conto nr.
000000001803 - intestato a Gruppo
Abele Onlus - Iban: IT21 S050 1801 0000
0000 0001 803. Specificare nominativo
e causale di versamento.
• La richiesta di fattura va fatta al momento dell’abbonamento.
Condizioni di abbonamento
• L’abbonamento decorre dal mese successivo al versamento. Chi sottoscrive
l’abbonamento nel corso dell’anno e desidera farlo decorrere da gennaio, deve
specificarlo nella causale e versare € 5
aggiuntivi per l’invio degli arretrati.
• I fascicoli non pervenuti devono essere
reclamati entro 30 giorni dal ricevimento
del fascicolo successivo. Oltre, dovranno
essere acquistati a prezzo di copertina.
Una e-mail, un fax o un sms.
E sei già abbonato
Invia una e-mail ad [email protected] o un fax a 011 3841047 in
cui dichiari che ti abboni. Oppure un sms
a 331 5753851 scrivendo «mi abbono
ad Animazione Sociale»; entro 48 ore ti
contatteremo per attivare l’abbonamento.
Mentre tu provvedi a pagare, ti inviamo il
numero in uscita della rivista.
inter vista | studi | prospettive | inchiesta | metodo | str umenti | luoghi&professioni | bazar
Maestro è chi
insegna l’amore
per il sapere
Educare è questo:
sospingere verso
l’apertura di altri mondi
Intervista a
Massimo Recalcati
a cura di
Roberto Camarlinghi
Se c’è qualcosa che resta insostituibile
della scuola, è la funzione di animare
il rapporto del soggetto con il sapere.
La posta in gioco dell’insegnamento è
ancora tutta qui: nell’introdurre l’allievo
in un rapporto vitale con il sapere. Nel
rendere il sapere un oggetto in grado
di muovere il desiderio: il desiderio di
sapere, di approfondire, di capire. Se
nella nostra vita ciò è accaduto, è perché
abbiamo incontrato un maestro, un
insegnante che ha amato il sapere e –
amandolo – ce lo ha reso desiderabile.
Un maestro che è stato capace di
generare in noi quel trasporto amoroso
verso la cultura che rimane il più grande
antidoto per non smarrirsi nella vita.
4 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
D
alle scuole elementari all’università,
tutti gli insegnanti che portiamo con
noi nella memoria hanno un tratto
fondamentale che li accomuna e che prescinde dai contenuti del loro insegnamento: amavano il sapere e – amandolo – ce
lo hanno reso desiderabile. I maestri che
hanno lasciato un segno nella nostra vita
sono quelli che – incarnando il desiderio di
sapere – hanno mobilitato in noi il desiderio
di apprendere. Perché il gesto del maestro
non è mai riempire le teste come recipienti,
ma produrvi il vuoto e mantenere vivo il
desiderio di sapere.
Per questo è insensato l’approccio che distingue l’istruzione dall’educazione. Educare è sospingere verso l’apertura di mondi,
promuovendo in ognuno – bambino o ragazzo – la ricerca della propria via singolare
di accesso al sapere e al mondo. Educare è
accendere il desiderio, quel desiderio che
non è da confondere con il godimento immediato, ma con l’amore per l’altro, per il
sapere, per l’altrove.
Sono i temi della ricerca di Massimo Recalcati, tra i più noti psicoanalisti in Italia,
contenuti nel suo ultimo libro L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, edito
da Einaudi. Lo abbiamo seguito in alcune
recenti conferenze, provando a cogliere le
linee essenziali della sua ricerca.
Perché la scuola
è centrale nell’educare
Negli ultimi tempi lei si è dedicato al tema
della scuola, a come possiamo immaginarla, alla funzione educativa che malgrado tutto riveste. Inizierei da qui, dalla sua
idea di educazione...
Il problema dell’educazione è «come si
diventa soggetti». E la scuola svolge una
funzione decisiva nell’aiutare bambini e ra-
gazzi in questo percorso. Provo a spiegarmi
partendo da un episodio che mi ha molto
turbato.
Una collega francese mi ha raccontato che,
in un asilo francese di periferia, un’educatrice aveva portato con sé il figlio molto
piccolo. Lo aveva messo in una stanza a
fianco a quella dove si svolgevano le attività
quotidiane del gruppo classe, ma quando è
rientrata nella stanza lo ha trovato morto,
ucciso da un altro bambino che era stato
lasciato fuori dalle attività.
Perché parto da questa scena? Perché esiste
oggi una cattiva retorica che investe il tema
dell’educare. La cattiva retorica consiste nel
ritenere che il bambino sia già un soggetto.
Invece non è così e quest’episodio lo mostra bene: il bambino lasciato solo è Caino,
ammazza il fratello. I bambini – lo dico in
modo brutale – non sono soggetti e il problema dell’educazione è rendere possibile
la loro soggettivazione, a partire da una posizione che ci fa esistere inizialmente come
oggetti, con tendenze che non riusciamo a
governare, dove la violenza è parte costitutiva dell’essere umano.
Nella scena dell’asilo non dobbiamo vedere
semplicemente una regressione dall’umano
al bestiale, ma la presenza nell’umano di
qualcosa che si manifesta come tendenza
aggressiva, spinta all’odio invidioso, alla distruzione dell’altro. Il punto scabroso è che
uccidere il proprio fratello non appartiene
al mondo animale, ma al mondo umano.
E allora cos’è l’educazione se non educare
a rinunciare alla violenza come soluzione
delle difficoltà dei rapporti? Se non educare
a passare dalla violenza alla conversazione,
dalla legge brutale della forza a quella dialogica della parola?
Questo è il movimento dell’educazione o,
come preferisco dire, il movimento dell’umanizzazione della vita, da cui dipende il
nostro poter diventare soggetti. La nostra
Animazione Sociale marzo | 2015 intervista | 5
vita si umanizza nella misura in cui rinuncia
alla violenza e accoglie la legge della parola.
È uno dei compiti più difficili che incombe
sugli esseri umani: saper rinunciare alla violenza in nome del riconoscimento dell’Altro
come prossimo, come essere singolare. È
un riconoscimento che non è mai indolore
perché ci obbliga ad accettare che «Io non
sono tutto», che la mia vita non esaurisce
quella del mondo e degli altri. Significa sopportare quella che Freud considerava una
«frustrazione narcisistica», necessaria per
riconoscersi appartenenti a una comunità
umana.
Dal chiuso della famiglia
all’aperto del mondo
In questo cammino di umanizzazione la
scuola – lei dice – esercita una funzione
insostituibile.
Sì, la funzione fondamentale della scuola
risiede nel promuovere la legge della parola,
l’incontro con altri mondi. Ed è qui che assume un senso la sua dimensione obbligatoria.
La scuola – si sa – è scuola dell’obbligo. Si
manifesta come obbligazione, dunque come
trauma. Per tutti noi la scuola è stata un
trauma, un trauma obbligatorio: il trauma
della separazione dalla famiglia, il trauma
– direbbe Jaques Lacan – della «dematernalizzazione della lingua». Andare a scuola
significa infatti riconoscere che la lingua
materna non esaurisce il mondo. E dunque
la scuola è innanzitutto questo taglio traumatico, simbolico, che introduce il soggetto
dal legame intimo, di sangue – che pure è
fondamentale alla vita – a una dimensione
più allargata di legame. La scuola sancisce
l’obbligo di rivolgersi al mondo, staccandosi
dal clan di appartenenza.
Il trauma della scuola è dunque un trauma virtuoso, benefico e necessario, perché
obbliga il soggetto a decentrarsi, a non restare incapsulato nel proprio Io. La scuola
porta dal chiuso della famiglia all’aperto
del mondo, in cui tocca imparare a vivere.
È veramente un passaggio – se si può dire
così – dalla lingua materna all’alfabeto. C’è
un libro di uno scrittore che amo molto,
Andrea Bajani, che è proprio su questo valore straordinario delle lettere dell’alfabeto.
S’intitola La vita non è in ordine alfabetico. Imparare le lettere dell’alfabeto – dice
Bajani – significa imparare mondi, imparare a costruire mondi. L’apprendimento
dell’alfabeto è lo svezzamento, è il vero
svezzamento; avere in bocca non la tetta,
ma la parola.
Allora la scuola non è solo il trauma di abbandonare la lingua materna, ma è anche la
possibilità dell’incontro. Incontro con che
cosa? Incontro con altri mondi, altre voci,
altre parole. Qui sta veramente l’importanza della scuola, di ciò che resta della scuola,
di ciò che deve restare della scuola.
Noi ci formiamo
attraverso gli incontri
La scuola è fondamentalmente un luogo
di incontri. E gli incontri sono decisivi
per la nostra vita perché – lei ha detto
recentemente – la forma della nostra
vita è il risultato degli incontri che abbiamo fatto.
Che cosa dà forma a una vita? Attraverso
cosa ci siamo formati? La vita si forma attraverso la contingenza pura degli incontri. Noi
abbiamo la forma che gli incontri che abbiamo avuto hanno fabbricato. Ancora più
precisamente, noi siamo – tutti noi siamo – il
modo attraverso il quale abbiamo dato una
forma agli incontri che ci hanno formato.
Da questo punto di vista, la scuola è luogo
elettivo della formazione. Perché a scuola si
6 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
fanno incontri tra le generazioni, si fanno
incontri con le istituzioni, si fanno incontri
tra pari. La scuola è luogo di incontri, però
gli incontri non sono tutti buoni. Ci sono
buoni e cattivi incontri e sia i buoni che i cattivi incontri lasciano un segno. Noi siamo
il segno che ha lasciato su di noi l’incontro
buono o cattivo.
Se dovessimo dare una definizione molto
semplice dell’incontro buono e dell’incontro cattivo, potremmo dire che il cattivo incontro è fondamentalmente l’incontro che
chiude il mondo, che chiude la possibilità
di accesso al mondo. Quando facciamo un
cattivo incontro il mondo perde ossigeno,
perde l’orizzonte. Il buon incontro invece è l’incontro che allarga l’orizzonte del
mondo, cioè mi fa vedere – attraverso chi
incontro – che il volto del mondo è un altro
rispetto a quello che fino a quel momento
avevo conosciuto.
Il buon incontro – e bisogna essere disponibili a fare buoni incontri – è l’incontro che
apre e moltiplica i mondi. Da questo punto
di vista ogni buon incontro è un incontro
d’amore. Gli incontri formativi, gli incontri
che danno forma alla vita, i buoni incontri,
sono sempre incontri d’amore, perché sono
incontri che, spalancando i mondi, spalancano la nostra vita. La nostra vita non è più
come prima.
Questi incontri nella scuola si fanno attraverso gli insegnanti innanzitutto, ma si fanno
anche attraverso i libri. La lettura di un libro
può essere in sé un incontro che lascia il segno. Dopo la lettura che feci da ragazzino
del mio primo libro, Il sergente nella neve di
Mario Rigoni Stern, ho ancora nelle narici
l’odore di grasso che lasciava la mitragliatrice arroventata. Quel libro per me è stato
il libro che mi ha insegnato che esistono i
libri, che esiste la letteratura, cioè che esiste
la possibilità di fare esistere più mondi.
Dunque il buon incontro apre i mondi,
li spalanca e spalancando i mondi apre la
nostra vita.
Insegnare che il sapere
si può amare
In questo contesto è fondamentale l’incontro con il maestro, con l’insegnante.
Colui che ha la funzione insostituibile
di mediare l’incontro con qualcosa di
decisivo nel nostro percorso di umanizzazione: il sapere.
Insegnante significa «colui che sa lasciare
il segno». C’è insegnamento quando qualcuno lascia in noi un segno: un segno che
dà forma alla nostra vita. Ma di cosa è fatto
questo segno, così decisivo nella formazione della vita? Di cosa è fatto il segno che
un insegnante sa lasciare nell’allievo? Noi
sappiamo che questo segno non è fatto di
sapere. Cioè non è un contenuto, un concetto, una nozione, non è un oggetto teorico.
Gli insegnanti che non abbiamo dimenticato, quelli che abbiamo incontrato e che
hanno avuto un ruolo decisivo nella nostra
formazione, noi li ricordiamo non per quello che ci hanno insegnato, non per il «cosa»
hanno insegnato, ma per la forma con cui
hanno insegnato, per lo stile con cui hanno
insegnato.
Quello che è indimenticabile, negli insegnanti che non abbiamo mai dimenticato, nei segni che il loro insegnamento ha
impresso nelle nostre anime, è il loro stile.
Un insegnante che lascia un segno, un insegnante degno di questo nome, è un insegnante che innanzitutto ama quello che
insegna, cioè entra in un rapporto fisico,
corporeo, erotico con il sapere. E dunque
fa del sapere non qualcosa di astratto, aereo, semplicemente intellettuale, mentale,
ma fa del sapere un corpo, fa del sapere un
corpo erotico.
Animazione Sociale marzo | 2015 intervista | 7
Questa è una delle grandi doti di un insegnante: trasformare tutti gli oggetti teorici
che trasmette ai suoi allievi – la serie di Fibonacci, la deriva dei continenti, una lingua
straniera, le poesie di Giovanni Pascoli, i
sette re di Roma... – in corpi erotici. Se questa trasformazione avviene, se avviene nella
parola dell’insegnante, genera una seconda trasformazione che accade questa volta
nell’allievo. L’allievo non è più un recipiente
da riempire, la sua testa non è una zucca
vuota da colmare, ma l’allievo – grazie alla
trasformazione del libro in corpo, dell’oggetto teorico in corpo erotico – si trasforma
a sua volta in amante.
Chi di noi non ha vissuto almeno una volta
quest’esperienza: sentirsi amante del sapere che il maestro trasmette? Amante non
significa «essere riempito», ma «essere
svuotato e messo in movimento». Quando
c’è un incontro – a qualunque livello – che
è formativo per noi, noi ci sentiamo messi
in movimento. Dove c’è un buon incontro
c’è messa in moto della vita, la vita si anima.
Allora l’allievo si forma attraverso il vuoto
più che il pieno. Questo mi pare un punto
importante.
La scena inaugurale
del gesto del maestro
La buona scuola, scrive infatti nel suo
libro, è quella che «sa testimoniare non
soltanto di sapere il sapere, ma anche
che il sapere si può amare, si può trasformare in corpo erotico» (p. 35).
Sì, il buon insegnante è colui che sa fare del
sapere un oggetto del desiderio in grado di
mettere in moto la vita, di allargarne l’orizzonte. È colui che introduce gli allievi in
un rapporto vitale con il sapere, che rende
possibile l’incontro con la dimensione erotica del sapere. In questo – credo – consiste
gnante
Il buon inseere
un
fa del sapel desiderio
oggetto d i mettere in
in grado dita e di
moto la ve l’orizzonte.
allargarn e anche
Qui risied e la scuola
il ruolo chre nella
può gioca ne.
prevenzio
tutta la posta in gioco della partita dell’insegnamento. E direi anche – ma su questo
possiamo tornarci dopo – il ruolo che la
scuola può giocare nella prevenzione delle
tossicomanie o di qualunque altra forma di
godimento immediato.
Nell’incontro tra insegnante e allievo, non si
tratta di riempire le teste con un sapere già
costituito, ma di aprire dei buchi in quelle
teste perché si metta in moto un movimento
verso il sapere. Questa è la strategia educativa fondamentale, che trova la sua matrice
nel gesto che Socrate compie nei confronti
di Agatone. Noi in Occidente, nella nostra
tradizione, abbiamo infatti questa scena
madre, da cui scaturisce veramente il gesto del maestro, il gesto dell’insegnante.
La si trova in apertura di uno dei più bei
e giustamente famosi dialoghi di Platone,
Il Simposio.
Agatone dà un banchetto dove invita artisti, teatranti, intellettuali, scrittori, filosofi a
parlare dell’amore, del mito di Eros. Socrate è uno degli ospiti più attesi, ma mentre si
sta recando al banchetto si perde. Accade
ogni tanto ai filosofi di perdersi nei propri
pensieri. Socrate si è perduto in un cortile
perché la Verità, come gli capitava spesso,
lo ha visitato. Un servo assiste alla scena e
riferisce ad Agatone. Così, quando Socrate
8 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
arriva al simposio, Agatone sa il perché del
ritardo. La verità gli ha parlato, dunque Socrate sa. Perciò Agatone chiede a Socrate di
sedersi vicino a lui affinché il sapere che la
verità gli ha trasmesso possa essere travasato nella sua testa: «Stai vicino a me – gli dice
Agatone – e parlami e travasa in me tutta la
potenza del tuo sapere».
Questa è l’illusione che tutti noi, in quanto
allievi, abbiamo attraversato con i nostri
maestri. Questa è anche l’illusione della
scuola quando pensa che la trasmissione
del sapere sia fondamentalmente un’attività di riempimento. Ma Socrate – ecco il
gesto – risponde ad Agatone: «Guarda che
io sono vuoto come te, e come te desidero
sapere». Socrate si offre dunque ad Agatone come amante del sapere, non come
detentore del sapere. Ed è questo passaggio
– dalla proprietà al desiderio, dal detenere
il sapere al tendere al sapere – che costituisce il maestro. Agatone si trasforma così da
coppa vuota ad amante del sapere: questo
è il miracolo dell’insegnamento. Dove c’è
insegnamento l’allievo diventa amante del
sapere.
Il miracolo
dell’ora di lezione
Questo miracolo può avvenire – e spesso avviene – nell’ora di lezione, che lei
individua come «il vero cuore della scuola» (p. 7), fatto appunto di incontri col
sapere che possono essere avventure
profonde, esperienze non solo intellettuali
ma emotive.
Sì, se dovessi dire che cosa rimane insostituibile della scuola, qual è il suo nucleo
resistente, direi che è il tempo dell’ora di
lezione. Perché il tempo dell’ora di lezione è il tempo dell’incontro, perché l’ora di
lezione spalanca i corpi, spalanca le porte,
spalanca le finestre, spalanca i libri, spalanca la vita. Un’ora di lezione può davvero
cambiare la vita.
Spesso l’obiezione che raccolgo è: ma come
si può far nascere il desiderio nel campo
dell’obbligo? È un grande tema della scuola
questo. Perché la scuola è sempre scuola
dell’obbligo in fondo, però è lì che si gioca la
partita del desiderio. Come si può far esperienza della libertà, dell’erotismo del sapere, laddove ci sono i programmi, ci sono i
calendari, ci sono le verifiche, laddove esiste
un dispositivo, un automaton, che imprigiona sia gli allievi che gli insegnanti? Come far
emergere la luce dell’incontro nel grigiore
del dispositivo obbligatorio?
Eppure, per quanto l’ora di lezione segua la
scansione imposta dai programmi, non è mai
prevedibile, nei suoi effetti, da nessun regolamento. Se noi esaminiamo più da vicino
questo tema dell’insegnamento, dobbiamo
riconoscere che il miracolo può sempre avvenire, nella misura in cui il maestro ama il
sapere e – amandolo – lo rende desiderabile
all’allievo, lo trasforma in corpo erotico. È la
dimensione dialettica della didattica, capace
di mobilitare il desiderio di sapere.
Invece cosa succede a volte nella scuola?
Che valutiamo ottimi – parlo adesso come
professore universitario – quegli esami in
cui gli allievi riproducono, clonano, plagiano il sapere che devono studiare. A chi
diamo 30? A chi riferisce con esattezza le
mie parole o le parole del testo che ha studiato. La valutazione nella scuola si fonda
sul modello del plagio, del conformismo. Ma
in questo modo non c’è nessuna possibilità
per gli allievi di apprendere in modo singolare, soggettivo, il sapere che viene trasmesso. La devianza, l’irregolarità, l’anomalia, la
bizzarria, la stramberia, cioè lo stile singolare viene soffocato da questa modalità di
concepire la valutazione. E invece dovrebbe
essere valorizzato.
Animazione Sociale marzo | 2015 intervista | 9
Favorire l’emergere
dello stile singolare
Lo stile singolare, le attitudini, le vocazioni,
le anomalie sono i punti di forza del soggetto, lo psicoanalista lo sa bene. Penso a uno
dei miei primi casi: la madre che portava il
figlio adolescente mi diceva: «Guardi, non
fa altro che pensare alla morte, me lo faccia
smettere di pensare». E io le rispondevo:
«Signora, smettere di pensare è peggio
della morte». Ecco, la ruminazione di questo ragazzo sulla morte, che può sembrare
sintomatica, se non viene normalizzata, ma
presa e girata nel verso giusto, si trasforma
in un punto di forza.
I punti in cui le piante sono storte, non allineate, non sono i punti che noi dobbiamo
raddrizzare, come riteneva una vecchia
pedagogia autoritaria che aveva trasmesso
questa rappresentazione botanica dell’educazione: raddrizzare le viti storte. Al contrario noi dobbiamo amare la stortura, amare
l’anomalia, la bizzarria, la stramberia dei
nostri figli perché lì c’è un tesoro. Lo dice
anche il poeta: «Dai diamanti non nasce
niente, dal letame nascono i fiori». In fondo
l’educazione è dare la parola alla vite storta,
non è produrre un tipo uniforme.
Il modello botanico dell’educazione era il
modello a cui dichiarò di ispirarsi il mio
maestro supplente di seconda elementare.
Io sono stato forse uno degli ultimi bocciati
agli esami di seconda elementare, allora esistevano ancora. E ho in mente quest’uomo
che, il primo giorno in cui è entrato in classe, ci ha guardati – all’epoca eravamo solo
bambini, non c’erano ancora le classi miste,
tutti con la giubba nera – e ci ha detto: «Voi
siete delle viti storte, io sono il paletto e il
filo di ferro che vi raddrizzerà!».
Questo supplente non era da meno dell’altra maestra, una donna severa, sempre vestita di nero, che incarnava tutto quello che
non deve fare un bravo insegnante. Ricordo
che un giorno, nel tempo della conversazione, ci chiese: «Bambini, secondo voi che
cosa rende bello il fuoco?». E allora ci fu un
dibattito tra di noi, c’era chi alzava la mano
e diceva «il fuoco è bello perché permette di
stare attorno e di parlare», «il fuoco è bello
perché si fanno le caldarroste», «il fuoco è
bello perché porta la luce nel buio». Lei con
disprezzo a ogni risposta scuoteva la testa
e diceva «no, no, no». Scartava ogni tipo
di interpretazione della bellezza del fuoco
perché ci indicava di possedere lei la sola
risposta possibile. Che alla fine, con aria
saccente, ci svelò: «Il fuoco è bello... perché
si muove!».
Cito questi due episodi perché sono esempi
di un modello disciplinare, io dico botanico
per riprendere la metafora della pianta della
vite da raddrizzare. Questo modello – che
era il modello educativo psicopedagogico
pre ’68 – contiene in sé l’idea che la soggettivazione sia mettere la divisa. Raddrizzare
tutte le viti significa annullare la stortura
che rende la vite – ma potremmo dire la
vita – una vita unica.
Amare la stortura
della vite
Il modello botanico per certi versi è tornato in auge nell’ultimo periodo. Del resto
l’avversione per ciò che ha rappresentato
il ’68 è stata più volte dichiarata da chi
ha fatto le recenti riforme della scuola...
Il ’68 ha introdotto una discontinuità – per
come la giudico io – vitale, positiva, fondamentale. Una generazione di figli ha preso
la parola e ha introdotto nell’educazione il
tema della libertà. Questo è stato un tempo
decisivo nella nostra storia, sebbene in effetti l’eredità di questo grande passaggio si
sia snaturata recentemente. Perché nel post
10 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
’68 – gli anni ’70 in particolare – la scuola
era un luogo di sperimentazione straordinario, un luogo di grandi trasformazioni collettive. Mentre oggi questa grande eredità
del ’68 è stata tradita.
Oggi siamo di fronte alla scuola delle «tre
i», come sbandierava qualche tempo fa un
ministro della Repubblica che fa il paio
con i miei maestri delle elementari. Ma direi che nella scuola delle «tre i» – impresa,
informatica, inglese – al centro non sono
più tanto le viti storte da raddrizzare, ma
le informazioni da immagazzinare. Il nuovo modello educativo psicopedagogico è
fondato sul principio di prestazione: l’obiettivo è rafforzare le competenze a risolvere
i problemi piuttosto che a saperseli porre.
È un modello che implica una rappresentazione – diciamo così – computeristica della
soggettivazione: le teste funzionano come
computer e bisogna immettervi più files
possibili. In questo modello il sapere non
ha più rapporti con la vita, ma deve solo trasmettere le competenze per rendere quella
vita capace di prestazioni.
Nella scuola di oggi abbiamo l’esasperazione del principio di prestazione, dove non
c’è posto per la singolarità nel processo di
apprendimento, ma predomina un sapere
anonimo e robotizzato da assimilare. Qual
è l’alternativa secondo me vitale? L’alternativa – dicevo – è amare la stortura della
vite, pensare che là dove ciascun allievo è
anomalo rispetto alla misura, lì è il tesoro.
Questo è un grande insegnamento con i nostri ragazzi: dove un bambino, un ragazzino,
mostra di essere diverso dagli altri, lì è il suo
potenziale. Dove il soggetto soffre nei suoi
sintomi, lì è la sua verità.
Si tratta di ribaltare la prospettiva con cui
si guardano i bambini, i ragazzi, i giovani.
L’educazione non è condurre l’anomalia
alla normalità, ma l’educazione è potenziare
l’anomalia, potenziare il sintomo, poten-
ziare la stortura, potenziare la differenza.
Ecco perché quando vedo ragazzi che
hanno 10 in tutte le discipline resto sempre perplesso; per me quello è il segno che
è in atto una macchinizzazione del sapere.
Gli esseri umani hanno sempre attitudini
e talenti, non possono eccellere in tutte le
materie. Quando accade, è il segno che c’è
un problema: un problema di prestazione,
di conformismo, di far felici i genitori, di
non saper tollerare una frustrazione.
Allora direi che uno dei compiti della scuola è far emergere i talenti, far emergere le
attitudini, far emergere le differenze, far
emergere i desideri. Favorire cioè una soggettivazione del sapere e non un’assimilazione passiva e conformistica.
Memorizzare il sapere e
sospendere la memoria
A questo proposito nel libro lei richiama
i due tempi fondamentali della didattica:
la memoria e l’oblio: «Il movimento della
conoscenza implica la memoria», ossia
l’acquisizione del sapere che ci viene
trasmesso, «ma solo al fine di sospenderla
per rendere possibile un atto nuovo, una
soggettivazione inedita del sapere» (pp.
61-62). Può spiegarci di più?
C’è un gesto di un grande pittore, Emilio
Vedova, che merita qui raccontare. Vedova
è stato anche professore all’Accademia di
Belle Arti di Venezia. Quando notava uno
dei suoi allievi paralizzato di fronte alla tela
vuota, interveniva intingendo lo spazzolone
in un secchio di colore e dando un deciso
colpo sulla tela. Questo aveva l’effetto di
mettere in moto l’allievo. Prima del colpo di
spazzolone l’allievo era intimidito, oppresso, inibito dal bianco della tela. Dopo il colpo di spazzolone qualcosa si disinibisce, si
mette in movimento, comincia a respirare.
Animazione Sociale marzo | 2015 intervista | 11
Che cosa fa Vedova? Che cos’è questo gesto? Non è semplicemente un modo per
togliere quel senso di venerazione che il
soggetto ha nei confronti della tela bianca.
Non è semplicemente questo, è qualcosa di
più sottile. Il principio da cui Vedova parte
è pensare che la tela vuota, come la pagina
bianca – la tela vuota per un pittore, la pagina bianca per uno scrittore, il silenzio per
un musicista – sono in realtà stracolme. Per
uno scrittore la pagina non è mai bianca, ma
nella pagina bianca si deposita tutta la storia
della letteratura: Kafka, Joyce, Proust… E
dunque l’inibizione è un effetto di questa
stratificazione.
Come posso io scrivere qualcosa se tutto è
già stato scritto? Se prima di me c’è Beckett,
c’è Dante... Lo stesso vale per la pittura:
come posso io osare dipingere se prima di
me ci sono stati Picasso, Klee, Tintoretto?
Impossibile! E allora l’operazione di Vedova è fare in modo che questo bianco sia
davvero bianco, che questo vuoto sia davvero vuoto, che questo silenzio sia davvero
silenzio. Rende dunque possibile il gesto
creativo, perché qual è la condizione del gesto creativo? Non è la memoria di tutto quello che è stato fatto, perché se noi ricordiamo
tutto il rischio è di non poter generare mai
niente di nuovo.
Pennac sostiene che «è bello insegnare
ai bambini le poesie a memoria». Io ero
un bambino che non aveva mai voluto
impararne una, però capisco la bellezza
dell’imparare a memoria oggi. Imparare a
memoria – dice Pennac – è come gettare i
nostri figli nel fiume della lingua; non importa il contenuto, importa che capiscano
che noi apparteniamo alla dimensione del
linguaggio, che abbiamo una provenienza,
una casa comune. Va bene, purché non si
pensi che imparare a memoria esaurisca
l’apprendimento. Anzi potremmo dire che
per apprendere davvero bisogna dimenti-
care ciò che si impara. Perché ci sia davvero
apprendimento bisogna che tutto ciò che
abbiamo appreso a un certo punto venga
disattivato per rendere possibile un gesto
singolare, un gesto creativo.
Questa idea la troviamo in tanti diari. Van
Gogh, Klee conoscevano perfettamente la
storia dell’arte. La loro tela era popolata
da una ragnatela di nomi, di citazioni, di
opere già viste. Ma per poter generare il
nuovo occorre che tutta questa memoria
venga ad un certo punto disattesa. Questo
riguarda anche i temi dei ragazzi al liceo o
le tesi di laurea.
Finché è troppo presente l’ombra del padre, finché è troppo presente l’ombra della
memoria, è impossibile generare il nuovo.
E dunque la condizione della creazione è
la possibilità di accedere ad un oblio, ad
un punto di dimenticanza, che è ciò che
Vedova realizza attraverso questo gesto.
Apprendere non è
fare come il maestro
Ogni processo creativo, di apprendimento
singolare – lei dice – eredita la memoria,
ma non la ripete, bensì la sospende per
provare a dire qualcosa di proprio.
Sì, potremmo esprimere questo punto anche dicendo che ci vuole un maestro, ma
l’apprendimento non è fare come il maestro. Questo mi pare un punto decisivo. Il
bravo insegnante non è colui che chiede di
imitarlo, ma colui che promuove un accesso
soggettivo al sapere.
C’è una scena sull’apprendimento che si
trova in un grande libro di filosofia, Differenza e ripetizione, di Gilles Deleuze. La
scena è questa. Sulla spiaggia c’è un maestro
di nuoto con il suo piccolo allievo. Il maestro spiega al bambino gli stili: la rana, lo
stile libero, il dorso. Il bambino ripete i mo-
12 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
vimenti – l’apprendimento è fatto anche di
questo: trasmissione di competenze, di tecniche, di sapere. Però poi arriva il momento
in cui il maestro dice al bambino: «Adesso
entra nel mare». È questo momento, in cui
il bambino sperimenta l’impatto con l’onda,
che davvero gli fa acquisire il sapere che il
maestro gli ha trasmesso.
Questo significa che non esiste trasmissione
del sapere se l’allievo fa come il maestro.
Non può fare come il maestro. Perché quando arriva l’onda cosa accade? Che l’allievo
deve resettare tutto il sapere che ha immagazzinato, farlo proprio e rispondere – nella contingenza dell’incontro – all’onda che
scompagina il sapere astratto della trasmissione. Chiaramente l’onda è un’immagine
della vita. Noi abbiamo imparato sì gli stili,
ma inventiamo un nostro stile – un nostro
modo di fare la rana, il dorso, lo stile libero
– solo quando impattiamo l’onda.
Allora ne deduciamo che non c’è trasmissione del sapere senza maestro, ci vuole il
maestro; ma non c’è apprendimento se la
trasmissione è fare come il maestro. Il maestro è fondamentale, ma non si tratta di fare
come il maestro; si tratta di inventare un
proprio stile, cioè di dimenticare – mentre lo
riconosciamo – il maestro. Noi non possiamo fare senza il maestro, la formazione non
è uccidere il maestro, come dicono alcuni.
Fare a meno del maestro è qualcosa a cui
possiamo arrivare solo se abbiamo avuto
un maestro. Allora benedetto sia il maestro,
benedetto sia l’incontro con un maestro, almeno uno nella vita, dalle scuole elementari
sino all’università.
Devo dire che nella mia pratica di professore una delle cose che più mi emoziona ancor
oggi è quando, nelle tesi di laurea o di dottorato, sento che qualche mio allievo – che
io riconosco come allievo, dunque che parla
la mia lingua fondamentalmente, nelle cui
parole riconosco le mie fatalmente – a un
tratto pronuncia parole nuove. Ci sono dei
momenti in cui alzo gli occhi perché sento
che lui parla, lei parla in un’altra lingua. A
partire dalla mia lingua può parlare un’altra
lingua. E questa è una grande emozione per
un maestro, per un professore. L’emozione
più grande è quando sentiamo sorgere dalla
lingua della didattica un’altra lingua che è la
lingua del soggetto, che è il soggetto come
differenza assoluta.
Non aver paura
di inciampare
Su questo punto lei, citando Pier Aldo
Rovatti, afferma che «l’insegnamento
ha a che fare con la soggettivazione»
e che «insegnare significa, né più né
meno, insegnare a qualcuno a divenire
un soggetto» (p. 110). Questo significa
che l’impronta del maestro non è e non
dev’essere un calco, sebbene ogni insegnamento porti con sé questo rischio.
Come evitarlo?
Direi trasmettendo, insieme al sapere, la
consapevolezza che non si potrà mai dire
né sapere tutto. Un bravo maestro sa, mentre trasmette il sapere, preservare il limite
del sapere. Limite da intendere non come
insufficienza del sapere, ma come condizione profonda, umana del sapere. Un bravo
maestro, mentre insegna, mentre trasmette il sapere, coltiva questo punto centrale, questo mistero che abita il sapere, cioè
l’impossibilità di sapere tutto il sapere. Che
non si risolve assimilando tutti i libri di tutte
le biblioteche del mondo, ma mantenendo
una tensione costante verso il sapere. Perché se anche sapessimo a memoria tutti i
libri di tutte le biblioteche del mondo, non
avremmo comunque realizzato una appropriazione esaustiva del sapere. Perché il limite del sapere non è esterno al sapere. Il
Animazione Sociale marzo | 2015 intervista | 13
limite del sapere abita il sapere, è un punto
interno al sapere.
Un grande allievo di Lacan, Moustapha Safouan, racconta che un bravo insegnante si
distingue da come reagisce quando, prima
di salire in cattedra, inciampa. È un test,
dice. C’è l’insegnante che immediatamente
si ricompone, facendo finta che non sia accaduto nulla. Questo, dice Safouan, non è
un modello interessante. Poi c’è l’insegnante che si ricompone e, nel mentre si ricompone, con sguardo sadico cerca nell’aula chi
si è permesso di sorridere per bacchettarlo.
Nemmeno questa, dice, è la posizione auspicabile. Il bravo insegnante, conclude,
è quello che inciampa e fa dell’inciampo
il tema della lezione. Ecco, qui abbiamo
la qualità dell’insegnante. I bravi maestri
sanno inciampare. Non temono la propria
insufficienza, anche perché la mancanza,
come detto, non è loro, ma del sapere. È il
sapere che manca. E l’insegnante custodisce
la mancanza del sapere.
Per questa ragione Giovanni Gentile ha
potuto affermare che, solo quando usciva
dall’aula con la sensazione di aver appreso
qualcosa che a lui stesso sfuggiva prima di
cominciare, poteva considerare che quella
era stata davvero un’ora di lezione.
L’inciampo
mette in ricerca
A proposito di questo inciampo voglio
fare un’ultima, personale evocazione di
maestro. Ricordo che quando entrai all’università Statale di Milano, agli inizi degli
anni ’80, volevo assolutamente frequentare
il corso di Mario Dal Prà. Lui insegnava
storia della filosofia, io arrivavo a filosofia
con un curriculum scolastico tormentatissimo: bocciato più volte, con un diploma
di esperto in coltivazioni di piante tropicali in serre calde, insomma un percorso
totalmente irregolare. Mi si diceva che Dal
Prà fosse all’ultimo anno di insegnamento,
così inserii il suo corso sebbene la guida
dell’università lo indicasse come «vivamente sconsigliato per le matricole».
Il corso era sulla Scienza della logica di Hegel e io che arrivavo dalla floricoltura non
avevo gli strumenti concettuali per affrontare un simile argomento. Però decisi di frequentare lo stesso e ricordo questo omino
piccolo, che arrivava con sottobraccio i testi
di Hegel – in tedesco e in italiano – e li commentava. E il commento del maestro, come
sempre accade, illumina anche il testo più
incomprensibile. Dove c’è insegnamento,
c’è la luce, bisogna diffidare degli insegnanti
oscuri. Il bravo insegnante è chiaro, strutturalmente chiaro, perché porta la luce sul
testo. E allora anche il testo più denso, più
tortuoso, come la Scienza della logica, nelle
parole di Dal Prà si scioglieva e diventava
luminoso.
Ma non tutto, ecco la grandezza del maestro.
C’erano dei momenti – mentre commentava
il testo – in cui si fermava, alzava gli occhi
al cielo e poi diceva: «Qui dobbiamo fermarci. Chissà Hegel cosa ha visto...». E non
proseguiva, inciampava sul testo. L’effetto
su di noi era che, appena finita la lezione, ci
precipitavamo sul punto dove il maestro era
inciampato. Perché l’inciampo rende prezioso l’oggetto su cui si inciampa, ancora
più dell’oggetto che si trasmette. Perché è lì
che si gioca la vera partita. Allora la forza del
maestro è, per un verso, portare la luce nel
testo, per l’altro preservare l’impossibile da
dire nel testo. Ma è questo impossibile che
mantiene vivo il desiderio di sapere.
La cultura
al posto della droga
Per concludere, lei prima accennava che
una scuola capace di rendere il sapere
14 | Animazione Sociale marzo | 2015 intervista
un oggetto di desiderio è una scuola
che fa prevenzione. Può argomentare
quest’idea?
Dicevo prima che il primo miracolo che
ogni insegnamento degno di questo nome
opera è trasformare gli oggetti teorici in
corpi erotici. Il bravo maestro è quello capace di erotizzare il rapporto con il sapere,
di incarnare il desiderio di sapere, di trasformare il libro in un corpo, di far venire
voglia di toccarlo, penetrarlo, annusarlo.
Questo genera una seconda trasformazione: l’allievo diventa amante del sapere. Il
maestro, incarnando il desiderio di sapere, mette in movimento l’allievo. Questa
trasformazione dell’allievo in amante del
sapere è fondamentale nell’insegnamento.
L’ultima metamorfosi rappresenta la vera
posta in gioco della formazione: trasformare i corpi in libri. È questa la sublimazione
che accompagna le grandi e straordinarie
trasformazioni dell’adolescenza.
Forse è un po’ visionario quello che dico.
Cosa vuol dire far diventare un corpo un
libro? Vuol dire che il corpo dell’altro – sia
esso il corpo sessuale della mia compagna di
banco, sia esso il corpo del mondo, il corpo
della città, ogni legame – diventa qualcosa
che merita la nostra attenzione, la nostra cura,
che non si può leggere in fretta, che non si
può ridurre a strumento per il mio godimento immediato, ma bisogna dedicargli tempo.
La lettura di un libro non è un mangiare ingordo, la lettura esige tempo, sospensione,
pausa, e soprattutto cura. Allora trasformare
il corpo, il corpo di chi amo, il corpo del
mondo in un libro è l’effetto più alto di una
formazione. E questo è – se vogliamo – un altro nome dell’amore, che in fondo è il nome
più alto dell’incontro.
Pasolini diceva che c’è droga, cioè uso strumentale e dissipativo del corpo, dove non
c’è cultura. La droga viene al posto della
cultura, la droga è l’esito di un «desiderio
di morte» che si afferma sullo sfondo di un
grande «vuoto di cultura». Quando non c’è
cultura, non c’è linguaggio, non c’è parola,
non c’è insegnamento, noi abbiamo la droga. La droga come simbolo di una relazione
con il corpo orientata solo dal godimento
dissipativo. La funzione della scuola allora è
mettere la cultura sopra la droga. È un podio
strano, la cultura sopra la droga. Eppure
educare è questo: mettere l’amore per l’eteros, per l’altro, per il sapere, per l’altrove
in cima a tutto. Riccardo Massa, che è stato
un grande pedagogista in Italia, insisteva su
questa etimologia del termine educare: portare altrove, cioè sospingere verso l’eteros,
verso l’apertura di mondi.
Allora direi che veramente, se c’è un ruolo
che la scuola può giocare nella prevenzione,
non è dato dai corsi e corsetti che si fanno sulle tossicomanie e sull’anoressia. Né
è dato dal professore che si mette a fare lo
psicologo con i ragazzi – questa è un’altra
retorica cattivissima del nostro periodo.
Ma a un professore direi: spiega Ungaretti,
spiega Montale, spiega le equazioni, spiegale
bene! Fa’ in modo che questi oggetti siano
vivi, appassionino, tengano sveglie le persone! Così previeni, così salvi. Non metterti a
raccogliere in classe i segreti dei tuoi alunni,
come ho sentito dire da un insegnante. No,
spiega Hegel, spiega Spinoza, fa’ in modo
che l’insegnamento di Hegel e Spinoza sia
un insegnamento vivo. Questo salva, per
come vedo io le cose. Non l’insegnante psicologo del disagio, ma l’insegnante testimone del carattere erotico della cultura. Questa
è per me la prevenzione primaria.
Massimo Recalcati psicoanalista, è membro
dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi, direttore scientifico dell’Irpa (Istituto
di ricerca di psicoanalisi applicata) e docente
all’università di Pavia.
inter vista | studi | prospettive | inser to | metodo | str umenti | luoghi&professioni | b a z a r
Produrre
Servizi è
tutelare diritti
Ritrovare nella storia dei Servizi
le ragioni e le possibilità
per andare oltre la crisi
di
Franca Olivetti
Manoukian
I Servizi sociali e sanitari da troppi anni
sembrano affannati da varie crisi
collegate a riduzioni di finanziamenti e di
organici, a delegittimazioni e
contrapposizioni ideologiche, a nostalgie
di un welfare mai raggiunto e incitamenti
verso ri-organizzazioni di cui non si vede il
senso. A chi sta dalla parte dei Servizi, a
chi pensa che possano contribuire alla
qualità della vita di singoli e famiglie,
tocca oggi raccogliere idee, motivazioni,
cooperazioni per andare oltre questa
lunga epoca di crisi e per riaffermare la
centralità dei Servizi pubblici e privati nel
progetto di una società democratica.
Perché produrre Servizi – non
dimentichiamolo mai – è tutelare diritti.
16 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
P
rodurre servizi, tutelare diritti: due
verbi e due complementi oggetto
che potrebbero, dovrebbero in
modo immediato sintetizzare in che cosa
consistono le funzioni dei Servizi sociali
territoriali, le ragioni della loro esistenza.
Sono scritti separati da una virgola. Viene
così simbolizzato che appaiono come due
aspetti giustapposti. Potrebbero essere
congiunti da una lettera «e»: connessione
assai leggera, che pesa più o meno come una
virgola. Preferirei inserire una «è», terza
persona dell’indicativo presente del verbo
essere che ha un significato affermativo.
Produrre servizi è tutelare diritti.
La tutela di diritti
è un bene per tutti
Questa è l’ipotesi che mi propongo di assumere e sviluppare: oggi più che mai, in
tempi di trasformazioni che ci sovrastano,
di crisi più subite che capite, ciò che i Servizi
sono in grado di produrre costituisce un
contributo centrale rispetto alle possibilità
di garantire i diritti soggettivi, quelli più visibilmente violati perché inscritti in «indecenti» situazioni di svantaggio e quelli più
normalmente disattesi per impliciti, taciti
accordi di mantenere silenzio.
La salvaguardia di quelli che vengono anche
qualificati come diritti umani (human rights,
droits de l’homme) poggia solo in casi estremi su sanzioni (che comunque non possono
intrinsecamente restituire l’integrità fisica
e psichica della persona che porterà su di
sé segni indelebili delle violazioni subite).
Le modalità repressive con cui si tende in
altri campi a ottenere il rispetto dei diritti
hanno meno peso in questo ambito, proba* | Volentieri anticipiamo alcuni contenuti del volume di Franca Olivetti Manoukian, Oltre la crisi.
Cambiamenti possibili nei Servizi socio-sanitari, in
bilmente perché le prove di comportamenti
lesivi sono più sottili e opinabili e varie e
variabili (secondo le diverse culture) sono
anche le stesse interpretazioni di ciò che è
stato compiuto.
Per lo più accade che la tutela dei diritti soggettivi venga attivata in situazioni singolari,
ma è bene ricordare che non è soltanto a
vantaggio di un’unica situazione: riguarda
tante situazioni analoghe, ma soprattutto
costituisce una riaffermazione che ha un
peso sociale e ha ricadute per tutta la società. Eppure siamo continuamente interpellati sulla domanda di quanto nelle nostre
vite collettive sia diffusa la convinzione che
la tutela dei diritti soggettivi riguarda tutti e
non può trovare effettivo mantenimento e
sostegno se non nel riconoscimento dell’esistenza di legami intrinseci e di una cultura
condivisa inscritta nelle stesse differenze e
dissimmetrie.
Un nuovo
progetto sociale
I Servizi territoriali nelle loro diverse articolazioni sono stati istituiti con la finalità di
tutelare diritti che, scritti nella Carta costituzionale italiana del 1948, non trovavano,
con il trascorrere degli anni, effettiva considerazione e applicazione. Erano – e sono –
diritti indicati nei principi fondamentali (art.
2, 3, 4) e ribaditi nei rapporti etico-sociali
(in particolare art. 32 finalizzato alla tutela della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività),
ma la loro traduzione doveva misurarsi con
un quadro sociale fortemente perturbato e
segnato da blocchi e contrapposizioni di
schieramenti cristallizzati per decenni.
uscita presso Guerini e Associati, Milano 2015. Ringraziamo l’autrice e l’editore per la disponibilità e
collaborazione.
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 17
Nel secondo dopoguerra, grazie anche alle
nuove configurazioni delle relazioni internazionali, si andavano mobilitando aperture a evoluzioni modernizzanti rispetto agli
assetti sociali consolidati, orientate allo
sviluppo economico e politico in senso democratico.
In questo quadro, avanzano e si condensano tensioni verso una concezione più democratica della vita sociale. Un primo indizio
di attenzione ai modi di vivere dei cittadini
è presente in quella legge Fanfani del 1958
con cui la tutela della salute viene affidata a
uno specifico Ministero (scorporata quindi
dal Ministero dell’Interno).
L’istituzione della Scuola media unica agli
inizi degli anni ’60 dà un segnale forte di
una scelta politica collettiva di rimuovere
le barriere tendenti a separare, già nell’iter
scolastico di base, le appartenenze a una
classe sociale e a predefinire le scelte successive verso un lavoro operaio o impiegatizio
modesto o verso studi e carriere professionali più elevati.
Alla fine di quel decennio viene approvato
il decreto di liberalizzazione degli accessi
all’università, grazie al quale qualsiasi titolo di scuola media superiore consente di
iscriversi a tutte le facoltà universitarie. Le
contestazioni studentesche e gli scioperi
del ’68 e ’69 sono espressioni e conferme di
movimenti che introducono e sostengono
cambiamenti decisivi negli assetti legislativi
e istituzionali tendenti a garantire a «tutti» i
cittadini la tutela dei diritti di cittadinanza.
Si rende più legittima e improrogabile la
definizione di un nuovo quadro normativo
che renda più pregnante l’obbligo di considerare gli esseri umani «uguali», degni di
godere delle stesse prerogative di dignità e
di rispetto, al di là delle differenze di genere
(uomini e donne), di età (adulti e «minori»),
di integrità fisica e mentale, di razza e collocazione sociale; un quadro che dia nuova
esigibilità ai cosiddetti diritti soggettivi – al
lavoro, alla casa, alla salute, alla crescita e
all’educazione e istruzione.
La ricostruzione e la ripresa economica nel
nostro Paese hanno contribuito a maturare
e promuovere una maggiore attenzione a
come questi diritti potessero effettivamente
essere esercitati: goduti.
1 | Una lettura delle premesse ideali e culturali da
cui hanno preso vita i Servizi e una analisi dell’avvio
delle loro attività è stata proposta da me stessa in un
libretto a cui sono affezionata: Stato dei Servizi (il
Mulino, Bologna 1988).
La nascita
dei Servizi territoriali
I Servizi nascono entro questo clima sociale (1). Hanno pertanto le loro radici entro
movimenti sociali evolutivi e costituiscono
elementi di innovazione entro una dinamica
sociale rivolta all’instaurare nuove interazioni, a socializzare nuovi modelli di convivenza, a introdurre nuove forme di regolazione
dei rapporti tra singoli e gruppi.
Compaiono come istituzioni che hanno
come scopo prioritario quello di dare consistenza e rappresentatività a forze vive presenti nel contesto sociale perché sia possibile creare e mantenere nel tempo un nuovo
ordine che ci si propone di realizzare. Sono
espressione e deposito di valori che marcano modi di pensare e di agire individuali e
insieme tendono a rappresentare quello che
è considerato «bene comune».
Con le forti spinte ideologiche che li sostengono, i Servizi in quegli anni rappresentano
effettivamente la volontà diffusa di realizzare una società più umana e giusta, capace
18 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
di contrastare emarginazioni e devianze e
di promuovere inclusione e partecipazione verso un ben-essere accessibile a tutti:
un sogno, un progetto sociale ideale e luminoso. Rappresentano e presentano forti
istanze di trasformazione in particolare nei
confronti di istituzioni educative, sanitarie
e assistenziali, amministrative.
Non a caso si pongono e sono visti da vari
gruppi come protagonisti di cambiamenti
sociali: in particolare di cambiamenti rispetto ai modi con cui la società affronta
– affrontava o non affrontava – devianze,
emarginazioni, esclusioni, distanze dalla
«normalità». Lottano per l’affermazione e
la realizzazione di modalità più umane di
trattare il disagio, per la creazione di condizioni più rispettosamente attente alle persone e alle dimensioni relazionali. Pongono
in primo piano la tutela dei diritti di tutti
coloro che sono portatori di «diversità», di
mancanze-menomazioni rispetto alla «normalità», i diritti di tutte quelle persone che
la società tende a porre ai margini e quindi
a escludere dalla partecipazione.
L’idea guida è quella di contrastare delle
pratiche tradizionalmente adottate per
trattare situazioni di disabilità, come la cecità o la sordità, malattie mentali, disturbi
dell’apprendimento e maltrattamenti in
ambito familiare, discriminazioni e violenze
sulle donne, tossicodipendenze, ecc. Non
si deve più ricorrere a repressione e reclusione, istituzionalizzazione e isolamento; va
contestata ogni impostazione amministrativa e tecnicistica, vanno esclusi interventi
«autoritari», strutturalmente non rispettosi
dei diritti alla crescita personale, alla partecipazione sociale, alla salute, al lavoro, alla
famiglia. I Servizi si devono rivolgere a tutti:
non solo ad alcune categorie sociali (2).
2 | Per una analisi della complessa funzione sociale
delle istituzioni segnalo il libro di Ota de Leonardis, Le istituzioni. Come e perché parlarne (Carocci,
Roma 2001).
3 | È proprio in quegli anni che ha tanto successo
la traduzione italiana, curata da Franco e Franca
Basaglia, del libro di Ervin Goffman, Asylums. Le
istituzioni totali: meccanismi dell’esclusione e della violenza (Einaudi, Torino 1968). Parallelamente, finisce
per essere posta in secondo piano la funzione positiva
delle istituzioni, quella che consente di vivere in una
società che non sia del tutto in balìa di rapporti di
forza, che qualifica come civile la convivenza perché
accetta l’esistenza dell’altro.
Una alternativa
alle istituzioni totali
Allo «stato nascente» i Servizi socio-sanitari
territoriali si pongono come istituzioni antiistituzionali, come nuove formazioni sociali
intermedie che tendono alla demolizione
delle istituzioni più tradizionali e consolidate, chiuse e ingabbiate entro schemi di
funzionamento dominati dalle esigenze di
sottomissione dei singoli e di controllo totale
dei comportamenti, di inibizione e schiacciamento di ogni autonomia e iniziativa individuale.
Appare più evidente che le varie istituzioni
che si occupano di disagi sociali, nelle configurazioni rigide e autoritarie via via assunte
nel tempo, sono sempre più lontane dalle
evoluzioni culturali che si vanno affermando: tendono all’autoconservazione più che
alla funzione di regolazione dei rapporti e di
mantenimento di valori collettivi (3).
Per chi si trova a lavorare nei Servizi ogni apparato organizzativo rimanda agli assetti con
cui le istituzioni funzionano e intervengono.
Per contrastare le istituzioni sembra imprescindibile rifiutare disegni e funzionamenti
organizzativi su cui si reggono quotidianamente i trattamenti dei disturbi, i rapporti
con gli utenti e tra gli operatori, le attività
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 19
interne e con l’esterno. In questo senso, nella
nascita dei Servizi sono inscritte diffidenze
verso tutto ciò che presentifica la funzione
repressiva delle istituzioni: la struttura organizzativa ne è la più immediata traduzione
che va demolita o di cui si può fare a meno,
per evitare di esserne condizionati.
Qualificare questi nuovi Servizi come «territoriali» esprime la scelta di ancorarli a
una prossimità che possa rendere la loro
attività ben vigile e pronta. Insediandosi
nei diversi contesti sociali è possibile per i
Servizi tradurre concretamente la tutela dei
diritti soggettivi in iniziative collettive ben
identificabili, di per se stesse «rivoluzionarie» rispetto all’esistente. Anche a fronte di
interessi e posizioni contrastanti si tratta di
abolire le scuole speciali, di chiudere orfanotrofi e brefotrofi, di svuotare gli istituti, di
demolire i manicomi. Si tratta di instaurare
modalità relazionali più aperte e simmetriche con le donne, con le famiglie e con i
bambini stessi.
In prima linea sono i Servizi socio-sanitari
come i consultori (istituiti con una legge
specifica nel 1975) e in seguito i Servizi di
salute mentale e quelli per le tossicodipendenze, che riuniscono professionisti di varie
provenienze ed estrazioni: assistenti sociali,
medici, psicologi, infermieri, psichiatri, a
volte pedagogisti e sociologi. E si va anche
a tentare di promuovere integrazioni tra
sociale e sanitario.
Si costituiscono a livello locale, in qualche
area del Nord Italia, alcuni Consorzi sociosanitari di zona; si sostengono collegamenti
tra Servizi dei Comuni e neo-nate Unità sanitarie locali; si attivano e vengono sostenute
cooperative a cui vengono affidate attività
da svolgere in strutture diurne e semi-residenziali ritenute opportune e necessarie
per particolari situazioni, ad esempio di
ragazzi difficili, di tossicodipendenti o di
malati mentali.
La poca attenzione
ai fattori organizzativi
Nelle considerazioni che sto aprendo sul
decollo dei Servizi nel nostro Paese ho più
volte fatto ricorso, non a caso, alle parole istituzione e organizzazione. Non sono sinonimi. Senza addentrarmi in approfondimenti,
mi pare comunque opportuno indicare una
distinzione di massima tra i due concetti.
Consideriamo le istituzioni come entità aventi un’esistenza sovra-individuale,
collettiva, caratterizzate da una intrinseca
permanenza, indipendente dagli individui
che nel tempo le hanno fondate e ne fanno
parte; rappresentano un immaginario in cui
è depositato un bene comune; definiscono
confini e appartenenze, cornici simboliche
che strutturano comportamenti e interazioni. Esse tuttavia lasciano molti vuoti che
diventano aree di marginalità ed esclusione
sociale e nel loro perpetuarsi tendono a distanziarsi dalla realtà che cambia in modo
disordinato e accelerato.
Possiamo riferirci alle organizzazioni come
realtà sociali costituite da relazioni tra singoli e gruppi finalizzate al raggiungimento
di obiettivi collegati ai mandati istituzionali in modi che possono variare nel tempo.
Sono pertanto più direttamente connesse al
produrre e a come produrre, e più esposte
alle contingenze, al mutare di condizioni
economiche e culturali, di competenze e
tecnologie e all’esigenza di verificare il proprio funzionamento attraverso riscontri e
rimandi rilevabili nel contesto sociale.
Nelle fasi iniziali di vita dei Servizi nel nostro
Paese appare prevalente e dominante l’investimento per solidificare la loro esistenza
sul piano istituzionale. È importante che ci
siano e che in tal modo dimostrino l’impegno per la tutela dei diritti di tutti i cittadini,
anche dei «diversi». Quello che producono
è scontato, comunque positivo.
20 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
Non so se questa ipotesi che sto proponendo sia percorribile. Si può comunque constatare come il lavoro attribuito ai Servizi,
tanto complesso e impegnativo per chi è
direttamente implicato, in quegli anni sia
ben poco considerato dal punto di vista organizzativo. La possibilità di introdurre azioni
e interventi decisamente differenti da quelli
tradizionalmente messi in atto sembra immediata, affidata alle condivisioni ideali e
alle motivazioni militanti.
La sola articolazione per l’organizzazione
del lavoro a cui si fa esplicito riferimento
nelle definizioni normative è l’équipe, che
viene richiamata e raccomandata come se
fosse un dispositivo-chiave per il funzionamento del Servizio. Non è chiaro, tuttavia,
quanto sia vista come dispositivo operativo
necessario per lo svolgimento delle attività o
quanto esprima l’idea di un funzionamento
di gruppo concorde e armonico.
Non va dimenticato che in quegli anni
il gruppo, il piccolo gruppo di lavoro, il
gruppo faccia a faccia, è nell’immaginario collettivo la traduzione più immediata
(privilegiata e da privilegiare) della possibilità di interagire in rapporti simmetrici,
di prendere parte attiva, di riconoscersi ed
emanciparsi e di sperimentare micro contesti «democratici» e anche di produrre in
modo creativo ed efficace insieme. Sono
diffuse varie idealizzazioni. Si sottolinea la
centralità del riconoscersi «noi» come determinante per il buon lavoro.
Gli operatori sono animati da intense motivazioni ideali, che soprattutto nei primi
tempi sembrano quasi poter sopperire a
competenze professionali approssimative. Si
teorizza persino l’opportunità che nei Servizi
venga individuato un operatore unico, a garanzia di interazioni aperte ed empatiche con
gli utenti, non condizionate da distanziazioni
e asimmetrie che rischiano di riproporre prescrizioni e interventi autoritari.
Probabilmente all’epoca (4) ci si è appoggiati
e fermati all’idea che per la tutela dei diritti
fosse essenziale e decisivo realizzare e mantenere l’esistenza dei Servizi, la loro articolazione decentrata e diffusa, le sedi e le dotazioni
di organici di cui potevano disporre, il sostegno che ottenevano dagli amministratori
locali, la loro legittimazione: non altrettanti
investimenti sembra che siano stati indirizzati a considerare gli aspetti di realizzazione del
lavoro «produttivo di servizi» e delle relative
esigenze di coordinamento e controllo.
4 | Mi riferisco in particolare alle concettualizzazioni
introdotte dal libro di Richard Norman, La gestione
strategica dei servizi (Etas, Milano 1985), e che ho
ripreso nel mio Produrre servizi (il Mulino, Bologna
1998).
La moltiplicazione
di disagi e di servizi
Agli inizi degli anni ’90 quando a livello politico e amministrativo sembra che si vada
concretizzando la possibilità di instaurare
anche in Italia un welfare state di cui si parla
da anni come meta da raggiungere, gli assetti di prosperità economica cominciano a
manifestare alcune crepe. La società mostra
sempre più fragilità, squilibri, contraddizioni e mostra soprattutto l’emergere di fenomeni poco o nulla governabili.
Cresce il disagio; o meglio, non sappiamo
bene se cresca in realtà o se non sia la sua rilevazione a essere più attenta, grazie anche alla
diffusione dei Servizi sociali e socio-sanitari.
Infatti, quando si diffondono dei modelli
di benessere, di salute, di vita familiare, di
successo lavorativo, si notano molto di più
e si sopportano sempre di meno carenze,
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 21
disfunzioni e malesseri. Aumenta la percezione del disagio e corrispondentemente
cresce la richiesta di eliminarlo.
In questo quadro va diffondendosi anche
la produzione di divulgazioni di saperi di
tipo medico, psicologico, pedagogico.
Paradossalmente, il diffondersi di conoscenze in strati molto larghi di popolazione
non porta maggiori capacità e competenze
nell’affrontare la complessità di varie situazioni relazionali e familiari difficili, o meglio
induce una acculturazione ambigua.
I disagi che si fanno avanti premono per una
crescita dei Servizi, per un loro potenziamento attraverso sedi più numerose e adeguate, dislocazioni sempre più accessibili,
attraverso l’apertura di nuovi e più specifici
ambiti di intervento collegati a problematiche emergenti (consultori per la menopausa,
per i disturbi del comportamento alimentare, per adolescenti, per preparazione alla
nascita, per percorsi di Ivg...), dotazioni di
competenze professionali più approfondite
e di strumentazioni più sofisticate .
L’accesso ai Servizi di persone e famiglie con
disturbi e patologie gravi, disabilità motorie
e intellettive notevolmente invalidanti, maltrattamenti e abusi – e non solo in condizioni
di deprivazione economica e culturale – richiede competenze consistenti di operatori,
assistenti sociali ed educatori dotati di motivazioni e capacità relazionali empatiche,
ma anche specialisti preparati in campo
diagnostico e terapeutico, psicologi, medici,
psichiatri e neuropsichiatri, nonché terapisti della riabilitazione. Il funzionamento in
équipe si va frammentando in diversi interventi specialistici, in ambulatori, ciascuno
strutturato secondo specifiche impostazioni
metodologiche e collocato più o meno implicitamente entro gerarchie che riservano
maggior peso a chi ha posizioni professionali
e istituzionali più forti e elevate.
Chi lavora nei Servizi si trova così investito
sempre più di richieste, perché la società,
l’opinione pubblica, «vede» queste difficoltà e insieme presenta pretese, esige «risposte adeguate». Questa locuzione (risposte
adeguate) diventa quasi una parola d’ordine
in tutti i Servizi, ma è carica di elementi ambigui. Nel complessificarsi delle situazioni
di disagio che arrivano ai Servizi e, parallelamente, nella diversificazione dei servizi
per farvi fronte, gli interventi rischiano di
«rispondere» al destinatario che l’operatore tende a privilegiare perché questo corrisponde al mandato del Servizio in cui lavora.
Ma in quest’ottica di individualizzazione
scivola via l’attenzione alla tutela dei diritti,
intesa come costruzione di condizioni sociali in cui tutti possano ritrovarsi considerati
soggetti a pieno titolo.
La strada
dell’aziendalizzazione
Per quel che mi è possibile ricostruire,
credo che le leggi 502/1992 e 517/1993
segnino un punto di svolta nella vita dei
Servizi socio-sanitari nel nostro Paese.
Vengono emanate effettivamente come
«riforma della riforma sanitaria». Più che
per le singole definizioni in esse contenute
sono significative per l’impostazione che le
caratterizza. Esprimono una sorta di inversione di tendenza per molti aspetti riconducibile a una crescente preoccupazione
per l’espandersi della spesa pubblica e per
l’esigenza di porvi freno.
Non si intende rinunciare a una ipotetica politica di welfare, ma la si incanala su
due binari che sembrano da un lato mantenere linee strategiche congruenti con la
scelte passate e dall’altro corrispondere
alle nuove esigenze. Si ridisegna per tutta l’area sanitaria e socio-assistenziale un
governo decentrato, affidato alle Regioni,
e al tempo stesso si definisce per i Servizi
22 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
un assetto organizzativo/amministrativo in
grado di esercitare funzioni di controllo
della spesa e di verifiche di efficienza, in
modo analogo a quello che accade nelle
imprese industriali e commerciali.
È a questo punto che si registra una più
consistente attenzione all’organizzazione dei
Servizi sanitari e socio-assistenziali. Già ci
si era avviati su questa strada quando, tra la
fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90,
da parte di alcuni Comuni si era delegata
l’attività qualificabile come sanitaria alle
Unità socio-sanitarie locali e quando alcune Regioni si orientavano a togliere dalla
denominazione degli enti l’aggettivazione
«socio». È tuttavia diventata più visibile
dopo le leggi 502 e 517 che richiedevano
la trasformazione delle Ussl o Usl in Asl,
aziende sanitarie locali, separandole dalle
aziende ospedaliere. In seguito si è avuto
un succedersi di disegni e ridisegni organizzativi collegati ad accorpamenti, a ritiri
delle deleghe, a varie esternalizzazioni a enti
e cooperative, a costituzione di aziende speciali con declinazioni differenti.
In questo clima si è diffusa una sorta di
acculturazione all’impostazione organizzativa dominante in aziende industriali; si
sono acquisiti nel linguaggio corrente dei
termini come «obiettivi», «budget», «flow
chart», «lay out», «core business», «vision»
che presentificano la cosiddetta aziendalizzazione. La stessa parola «azienda» rimanda
immediatamente a una sorta di assimilazione della produzione di servizi a qualsiasi
tipo di produzione industriale, produzione
di beni con uso di impianti e macchinari. E
questo ha un duplice risvolto. Si assume e
si diffonde un’impostazione complessiva
che è incardinata su un modello fordista,
5 | Norman R., Ridisegnare l’impresa. Quando la mappa
cambia il paesaggio, Etas, Milano 2002.
impregnato di razionalità astratta, incentrato sulla divisione a tutti i livelli, in settori, in
uffici, in competenze operative a seconda
delle categorie e degli inquadramenti, sulla definizione di regolamenti e procedure
sempre più minute, sui controlli formali,
sul privilegiare le comunicazioni dall’alto al
basso e scoraggiare le interazioni orizzontali: un’impostazione verticistica che induce
deresponsabilizzazioni diffuse.
L’altra ricaduta è una sorta di apprezzamento idealizzato del funzionamento delle
organizzazioni «private» come garante di
efficienza e di capacità di innovazione/
adattamento, e parallelamente una delegittimazione del «pubblico» come imprigionato in una corazza di inerzie e adempimenti inderogabili, inevitabilmente statico
e autoreferenziale.
Ambedue questi aspetti si può ipotizzare
che per alcuni anni abbiano contribuito a
non sostenere le identificazioni degli operatori a livello di base con i Servizi pubblici,
con i Comuni e con le Asl come enti locali
finalizzati a tutelare salute e benessere. È
come se si fosse alimentata una scissione tra
«privato efficiente» e «pubblico inefficiente» e si fosse sottovalutata la centralità – per
chi lavora in un’organizzazione che produce
servizi – del condividerne le finalità, i valori
che danno senso e qualità all’operare quotidiano con i destinatari.
È forse interessante ricordare che, nelle
stesse imprese produttrici di beni, alla fine
del secolo scorso si cominciava a mettere
in discussione il modello aziendale tradizionalmente acquisito per ricercare assetti
meno rigidi, più mobili e aperti, per introdurre e sviluppare una nuova cultura (5).
Allora perché è stato tanto privilegiato il
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 23
riferimento all’azienda? Perché si è assunto
un modello che stava per essere superato?
Forse chiamare azienda una qualsiasi organizzazione produttiva significa imprimere
un’impostazione in cui il risultato economico deve essere assunto come assolutamente prioritario.
Ma è questa la maggiore finalità delle organizzazioni dei Servizi, che anche quando
sono private hanno comunque una funzione pubblica?
La divaricazione
dell’area sanitaria
È andata individuandosi un’area di Servizi qualificabile come «sanitaria» che, con
differenze tra le diverse Regioni, è stata
in vari modi separata e orientata in senso
più specificamente aziendalistico. Essa ha
un mercato entro cui sono presenti diversi soggetti privati e pubblici che erogano
un’ampia gamma di attività, anche avvalendosi di competenze specialistiche, altamente specialistiche, a cui i cittadini si
rivolgono potendo scegliere liberamente.
Il funzionamento organizzativo di quest’area è fortemente regolato da disposizioni
normative cogenti che dovrebbero garantire la qualità dei servizi forniti da ospedali
e case di riposo, da comunità e Servizi ambulatoriali. Per usufruirne è necessario che
i cittadini seguano le procedure previste
e dimostrino di avere le prerogative e le
documentazioni che confermino le loro
richieste.
Entro questa impostazione si erogano prestazioni, azioni/risposta entro un rapporto
interindividuale tra singolo destinatario e
singolo operatore che – psicologo o fisioterapista o infermiere della salute mentale – è
comunque qualcuno che «cura» e pertanto
prescrive, inquadra, definisce, decide. Al
contempo, è proprio in questo contesto che
si aprono nuove elaborazioni sui contenuti
dell’attività sanitaria, verso una concezione
olistica, che mette al centro la persona e
che distingue il «curare» come mettere in
campo terapie finalizzate alla guarigione e
il «prendersi cura» come mobilitazione di
ascolti e attenzioni in una comunicazione
ravvicinata tra operatore e persona che soffre e che è portatrice di disturbi e problemi
di salute fisica e psichica.
Non solo. Mentre si rafforzano regolamentazioni e moltiplicazioni dei controlli
finalizzati a migliorare la produttività, cioè
a ottenere a tutti i livelli interventi qualitativamente accettabili col minimo dei
costi, ci si scontra con rigidità sostenute
da varie istanze anche sindacali. Là dove
per le inerzie inscritte nel settore pubblico
risulta difficile introdurre variazioni specifiche nell’organizzazione del lavoro e nella
retribuzione o in genere nel trattamento
del personale, si ricorre alle cosiddette
«esternalizzazioni».
Con questo neologismo (anche un po’
astruso) si vuole indicare quella produzione che viene posta fuori dall’ambito in
cui finora è stata realizzata. Gli interventi
nei confronti di situazioni di sofferenza
e malessere possono essere spostati dai
Servizi pubblici per essere delegati ad altri sistemi produttivi, privati, gestiti con
criteri di maggiore efficienza, ricorrendo
ad altri contratti di lavoro, spesso precari,
e a selezioni sommarie con scarse verifiche
delle competenze professionali. Si pone
l’interrogativo se questa sia una sorta di
«privatizzazione che priva», nel senso che
trascura il mandato istituzionale della tutela della salute psico-fisica e degli altri diritti
soggettivi, o se sia invece una consegna di
finalità pubbliche ad altri attori sociali con
cui si collabora proprio per poterle realizzare in modo più efficace.
24 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
Le ambivalenze
nelle regolamentazioni
Le diverse sfaccettature delle configurazioni che si vanno consolidando nei Servizi sono rese più evidenti dall’ampliarsi
e complessificarsi delle malattie croniche,
delle disabilità permanenti, delle patologie
oncologiche, di tutte quelle situazioni in
cui si vive con esigenze di cure molteplici
e diversificate, messe a disposizione da più
professionisti, specialisti, collocati anche in
sedi differenti e con modalità di lavoro tra
loro disomogenee per stili e strumenti, per
documentazioni e orari. Vengono proposte
e sviluppate, in più ambiti e da più gruppi, iniziative rivolte alla umanizzazione dei
Servizi come se fosse necessario contrastare il funzionamento vigente per realizzare
quello che sostanzialmente è il compito
primario di queste organizzazioni.
In quest’area, cosiddetta della cronicità,
che col passare del tempo, proprio grazie ai
progressi della medicina, sta crescendo (e
che secondo le stime dell’Oms costituisce
circa la metà delle richieste di cura presenti
oggi nella società occidentale), si avverte
più chiaramente l’importanza dell’integrazione tra Servizi di cura e di riabilitazione,
tra professionisti di area strettamente sanitaria e professionisti di area psico-sociale,
tra ospedale e territorio, tra Servizi pubblici che forniscono attività diagnostiche,
interventi su patologie in fasi acute e Servizi tendenzialmente messi a disposizione
da cooperative per assistenza domiciliare,
ospitalità residenziale o semi-residenziale
di persone anziane e disabili.
Contemporaneamente ci si orienta anche
ad attribuire a chi si rivolge ai Servizi contrattualità e capacità e, riservando soltanto
alle situazioni più strettamente ospedaliere
la denominazione di pazienti, si introduce
l’idea che siano dei clienti, non tanto per-
ché debbano avere sempre ragione, quanto
per modificare il sostantivo più tradizionalmente utilizzato – utenti (denominazione
più connotata entro una cultura amministrativa) – e richiamare uno stile di lavoro
e di rapporto più simmetrico, più attento
e sollecito.
Nell’evoluzione del sistema organizzativo dei Servizi sanitari sembrano pertanto
presenti delle componenti ambivalenti se
non quasi contrastanti: tra impianti lavorativi rivolti a standardizzare da un lato e
iniziative per umanizzare e personalizzare
dall’altro, tra spinta a modificare le organizzazioni pubbliche e adottare affidamenti di interventi al privato, tra classificazioni
di categorie di destinatari e valorizzazione
delle loro capacità di scelta.
Accanto a questi movimenti oscillanti va
segnalato anche che da un lato si tendono a
modificare i rapporti tra Servizi e cittadini
per fare in modo che questi ultimi abbiano
maggior voce in capitolo, siano più ascoltati nei loro desideri e nelle loro attese, siano sempre più «persone al centro»; d’altro
lato gli operatori che sono poi in contatto
diretto con loro sono inquadrati in tempi
sempre più compressi, in procedure sempre più codificate, funzionali a verifiche e
valutazioni ed esposte al rischio di diventare impersonali.
E la tutela dei diritti che i servizi sono
chiamati a produrre, come si realizza in
questo quadro? La domanda resta aperta.
Probabilmente si è andata infiltrando una
divaricazione tra produrre servizi e tutelare
diritti.
La legge 328
e la riforma del Titolo V
La legge 328 del 2000, arrivata dopo molti
anni di attesa di un atto istituzionale che riformasse tutto il sistema socio-assistenziale,
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 25
costituisce una presa di posizione forte per
la legittimazione degli attori e degli interventi che si occupano di difficoltà sociali e
per la definizione di orientamenti più aperti
alle complessità che si tratta di affrontare. Si
disegna un «sistema integrato di interventi
e servizi sociali» e quindi è ben presente
l’importanza di riconsiderare nell’insieme
tutto ciò che si agita in questo campo. Al di
là del richiamo ai diritti di cittadinanza che
forse è un po’ formale e un po’ rapido, alcuni elementi mi sembrano da sottolineare
come particolarmente rilevanti:
• la considerazione e il riconoscimento
dell’esistenza nel contesto sociale di più
soggetti istituzionali e non, pubblici e privati che possono farsi parte attiva nel contrasto ai disagi sociali;
• la gestione degli interventi in diverse
forme, dirette e indirette;
• la valorizzazione delle iniziative e delle
risorse che possono essere messe in campo
da più parti e in più forme;
• la rappresentazione degli interventi nel
sociale come realizzazioni che richiedono
delle progettazioni, ovvero degli investimenti in idee ed elaborazioni, e anche delle
verifiche e valutazioni di impatto;
• la centralità dell’integrazione tra diversi
attori sociali e tra diversi interventi.
Si ha qui una ricomposizione di dimensioni
istituzionali e organizzative che sembrerebbe poter orientare o ri-orientare positivamente delle ricomposizioni feconde per
l’operatività dei Servizi. Costituisce un
passaggio innovativo che probabilmente ha
avuto ricadute meno importanti e penetranti di quel che ci si sarebbe potuti aspettare
per diverse ragioni.
Soltanto un anno dopo, nel 2001, veniva
promulgata la riforma del Titolo V della
Costituzione che ricolloca sostanzialmente
la legge 328 in un nuovo assetto istituzionale e ne indebolisce la portata e la pregnanza.
L’area socio-assistenziale viene attribuita
alle competenze delle Regioni che sono legittimate ad assumere delle scelte diverse
anche rispetto alla allocazione delle risorse
e alla definizione e programmazione degli
interventi. Ogni Regione, dopo alcuni anni,
predispone una legge di riordino delle politiche sociali che riprende e traduce la 328
con definizioni e interpretazioni differenti,
ispirate a diversi indirizzi e rivolte a diverse
declinazioni attuative, spesso orientate dai
modelli di welfare già praticati e da visioni
condivise dalle diverse componenti partitiche presenti nel governo locale.
La sorte
dei Piani di zona
Ci si può chiedere quanto i Servizi e gli operatori, quelli appartenenti agli Enti pubblici
ma anche quelli del terzo settore o del cosiddetto privato sociale e del volontariato,
abbiano colto le componenti innovative del
nuovo dettato istituzionale e abbiano visto
la possibilità di farne leva per incrementare
e migliorare i sottosistemi organizzativi e gli
stessi interventi.
Pensiamo in particolare a un dato che potrebbe apparire un dettaglio, ma anche un
indizio a cui ripensare: quanto e come è stata
assunta la realizzazione del Piano di zona,
un dispositivo in cui si condensano in modo
significativo elementi caratterizzanti di una
rinnovata prospettiva con cui intervenire
nel sociale? Un Piano traduce in termini
operativi delle linee di indirizzo rilevanti
per dare nuovo impulso alla considerazione
e alle strategie di azione rispetto ai problemi
sociali: la prima è quella di ancorarsi al territorio, ovvero alla realtà socio-economica
e culturale in cui si vive, di cui si può avere
una conoscenza ravvicinata e con cui si può
attivare e mantenere rapporti continuativi
nel tempo. Questo dà confini all’operare ma
26 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
al tempo stesso facilita connessioni.
Il termine Piano può rimandare a processi
di programmazione gerarchizzati e rigidi,
ma si può anche ipotizzare che intenda
esprimere l’importanza di una formalizzazione scritta di un lavoro programmatorio
a cui nel testo si dà più volte il nome di
progettazione. Si danno esplicite indicazioni
per organizzare i servizi, per rilevare dati,
per «stimolare le risorse locali di solidarietà
e auto-aiuto», per «responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
dei servizi», per realizzare integrazioni a
livello operativo e di sistema.
Mi risulta, tuttavia, che i Piani di zona
siano stati visti con diversi atteggiamenti:
inizialmente, soprattutto da alcuni, con entusiasmo e con impegno a darne traduzione
operativa, da altri come adempimenti a cui
era necessario sottostare o come tavoli su
cui cercare di attribuire (o accaparrare) risorse finanziarie. Ci si è scontrati con varie
difficoltà, con Comuni portatori di interessi
non univoci, con rapporti tra cooperative e
Onlus influenzati da giochi di potere, con
associazioni di volontariato poco propense
a inserirsi con contributi specifici.
Forse soltanto in alcuni casi felici, attraverso i Piani di zona, si è riusciti – mi sembra – a
costituire un ambito realistico di ridefinizione di condizioni per garantire per tutti
più adeguate tutele dei diritti soggettivi,
proprio attraverso una migliore e più mirata organizzazione concordata e integrata.
Si può considerare questo un indizio con
cui interrogare i Servizi?
Nel corso del tempo, sedimentate, affievolite e cristallizzate le originarie motivazioni
ideali, non si è forse depositata una cultura
in cui le dimensioni istituzionali hanno assunto un peso, più nel senso di mantenere
attese di trovare sostegni e legittimazioni
che di suscitare idee e iniziative, di far cogliere possibilità di intraprendere?
Le ricadute
della «crisi»
Intorno al 2008 dagli Stati Uniti rimbalzano
in Europa e nel nostro Paese una serie di
fenomeni che vengono complessivamente
descritti come «crisi» e che danno ulteriore
accelerazione e ampiezza a trasformazioni
già in corso, che scuotono un ordine sociale
a cui si è abituati e che collegano immediatamente accadimenti a livello globale con
vicende della quotidianità.
A livello individuale e familiare si avvertono
come imminenti e possibili perdite di ricchezza, di collocazione sociale per sé e per i
propri figli: si percepiscono con angoscia rischi incombenti del venir meno di condizioni di abitazione e di lavoro e anche di salute
propria o dei propri parenti anziani. È serpeggiante un malessere sociale che sempre
meno è prerogativa soltanto di alcuni strati
sociali: sul piano collettivo tende a essere
minimizzato o impacchettato (vi si dedicano
infatti a livello governativo vari «pacchetti»
di misure); ciascuno individualmente cerca
di contrastarlo, anche di negarlo, in attesa
che prima o poi il ciclone passi.
Tutto questo si riversa sui Servizi in termini
di maggior numero di persone e famiglie
che ad essi accedono (o cercano di accedere), di pesantezza dei problemi che vengono
portati (intrecci di difficoltà economiche e
relazionali), di diversi rapporti tra operatori
e destinatari (manifestazioni di rivendicazioni cariche di aggressività), di attese che
non trovano risposte. Forse soprattutto
si richiede ai Servizi di cambiare. Da parte
dei vertici organizzativi vengono sollecitate e talvolta anche imposte modificazioni
sostanziali rivolte a ridurre la spesa e a far
fronte comunque al malcontento diffuso.
Da parte della gente sono sempre più forti
le pretese di veder soddisfatti i propri diritti, da quelli di essere tempestivamente
Animazione Sociale marzo| 2015 studi | 27
ascoltati nelle proprie difficoltà a quelli di
essere difesi dagli sfratti, aiutati a pagare
un mutuo, ottenere un sussidio. I Servizi,
costituitisi come fautori di cambiamenti per
realizzare maggiore equità, diventano uno
degli avamposti più attaccati per esprimere
risentimenti e impotenze.
A fronte di un’esigenza di contenimento del
debito pubblico tutte le organizzazioni dei
Servizi vengono inglobate indistintamente entro quel sistema – o quell’aggregato
– chiamato welfare, per anni considerato
come una méta da raggiungere per ogni
paese democratico e che oggi non appare
più edificabile. Si cerca di qualificarlo in
altri modi (welfare locale, welfare mix, welfare di comunità, welfare territoriale), forse
per rendere meno laceranti tagli e riduzioni
di spesa o anche per richiamare confini e
riaggiustamenti con cui prospettare il raggiungimento di una maggior efficienza.
Gli irrigidimenti
nel funzionamento
La riforma del Titolo V della Costituzione,
che dà ampio spazio alle autonomie locali,
se da un lato crea opportunità per nuove
combinazioni, dall’altro ha avuto esiti imprevisti rispetto alle attese: le Regioni si
sono rivelate nel tempo organismi governativi troppo distanziati dalle problematiche dei diversi territori e soprattutto troppo
differenziate nell’ampiezza, nelle risorse da
investire e negli orientamenti, creando disparità nelle possibilità di fruizione dei servizi da parte dei cittadini e probabilmente
rendendo ancor più evidenti squilibri tra
territori, inadempienze e assenze.
L’adozione del cosiddetto modello «aziendale» attraverso interventi di razionalizzazione definiti (imposti) dall’alto un po’ in
tutti gli enti pubblici e importato anche in
cooperative e fondazioni, ha portato irri-
l modello
L’adozione»daettraverso
«aziendaledi
interventizazione
razionalizha portato
dall’alto, enti nel
a irrigidim ento,
funzionam
timento
all’appesannta
zioni,
di rendicoi di tipo
a controll vo/formale.
quantitati
gidimenti nel funzionamento, appesantimento di rendicontazioni e controlli di
tipo quantitativo/formale, attenzioni alle
esecuzioni di quanto prescritto.
In particolare credo si sia sottovalutato
quanto in tutto questo assetto abbia influito
la considerazione dei singoli come variabile dipendente: personale classificato in
categorie collocate entro linee gerarchiche
e anche utenti, pazienti, clienti individuati
per patologie e disturbi dei diversi organi
e per aree corrispondenti a caratteristiche strutturali (anziani, adulti, minori...).
L’investimento nelle relazioni con i destinatari rischia di essere deviato verso la
preoccupazione di non conformarsi a procedure e protocolli, di essere colti in fallo e
di subirne spiacevoli conseguenze.
A che cosa sono ispirati questi mutamenti
organizzativi con cui ci si attrezza per rispondere ai mutamenti più generali?
È come se fossero acquisiti culturalmente
come positivi e risananti dei criteri istituzionali e organizzativi già presenti e utilizzati.
Non pare abbiano ottenuto riscontri interessanti – nel senso anche di aver segnalato
scelte da scoraggiare –, ma si continua a
privilegiare, confermare e quasi rinforzare:
• il ridimensionamento delle funzioni pubbliche, minimizzandone e sottovalutandone
28 | Animazione Sociale marzo | 2015 studi
la portata per la vita di tutti: si sostiene una
sorta di spostamento di attività dai Servizi
pubblici perché le medesime attività possono essere svolte da Servizi privati con
maggiori competenze e soprattutto con
maggiore attenzione ai costi. Il risparmio
rimane il criterio per il funzionamento dei
Servizi e la privatizzazione diventa la garanzia di una buona gestione. La funzione
sociale di integrazione e ricomposizione
resta in secondo piano;
• la centralità della produttività: si esige efficienza o più efficienza e non solo da parte
dei vertici dell’organizzazione, che hanno il
compito di promuoverne un buon funzionamento, ma anche da parte dell’opinione
pubblica al cui giudizio direttamente o
indirettamente l’organizzazione è esposta;
per questo è necessario dimostrare tangibilmente che le spese diminuiscono o non
aumentano e da qui si decidono limitazioni
e valutazioni. È irrilevante se questo comporta gravi disconoscimenti dei diritti soggettivi e ricadute in termini di aumento di
tensioni e stratificarsi di conflittualità.
Inedite prospettive
di pensiero e azione
Contemporaneamente l’impoverimento
generalizzato con cui si è costretti a confrontarsi apre altri scenari. Arrivano segnali di nuove iniziative che introducono
inedite e inaudite prospettive di pensiero
e azione in diversi territori, che costituiscono sperimentazioni molto interessanti
e costruttive.
Nell’orizzonte generale, rispetto a quel che
ho richiamato fin qui, sembrano avere un
peso limitato perché appaiono come frammenti, come esperienze circoscritte sostenute da alcuni fattori, in particolare di tipo
culturale e relazionale. Sono esperimenti
di cui tenere attentamente conto per trar-
ne apprendimenti. In particolare credo che
abbiano messo in luce che:
• il lavoro nel sociale implica una centratura
sul territorio, riguarda tutti coloro che lo
abitano: è lì che si manifestano i disagi ed
è lì che sono presenti risorse non pensate e
non immaginate mobilitabili, generative di
ulteriori risorse; questo porta a «scoprire»
che tra Servizi e cittadini sono possibili diverse interazioni, diversi scambi tra ciò che
può essere messo a disposizione e ciò di cui
si può usufruire con vantaggio reciproco;
è pertanto cruciale l’investimento nelle relazioni di fiducia e nelle comunicazioni tra
cittadini e Servizi e tra Servizi;
• i problemi di singoli e famiglie vanno identificati, distinti con specifici accorgimenti
conoscitivi e collegati a questioni trasversali
con diverse elaborazioni: questo consente
di disporre di rappresentazioni più realistiche delle difficoltà, di attivare responsabilizzazioni a livello individuale e collettivo,
motivazioni e cooperazioni;
• sono pensabili e sviluppabili connessioni tra gruppi e aree anche molto diverse e
distanti tra loro; vanno costruite convergenze per affrontare i problemi perché si
può apprezzare l’efficacia (e non soltanto
l’efficienza) di ciò che viene intrapreso
solo attraverso visioni orientate da valori
sufficientemente condivisi; la costruzione
di legami è in divenire e va accompagnata
nella ricerca di un «bene comune», che non
si osa quasi neppur più nominare.
È a partire da riconsiderazioni e riletture di
questi orientamenti che mi sembra possibile
aprirsi a proposte evolutive.
Franca Olivetti Manoukian, psicosociologa,
è formatrice e consulente dello studio Aps
di Milano: [email protected]
inter vista | studi | prospettive | inser to | esperienze | metodo | luoghi&professioni | bazar
A un giovane
operatore della
salute mentale
Lettera aperta
per riconoscerci in una storia
che parla al futuro
di
Peppe Dell’Acqua
Nel numero 286 di Animazione Sociale,
Eugenio Borgna, maestro di una
psichiatria dell’ascolto e del colloquio, ha
invitato a «rifondare la psichiatria come
scienza umana». E ha rivolto il suo
appello alla nuova generazione di
operatori della salute mentale, senza il
cui apporto – ha detto – «la grande
rivoluzione basagliana rischia di svuotarsi
e di perdere le sue ragioni d’essere».
Come rivista, ci è subito venuto in mente
di chiedere a un altro maestro, Peppe
Dell’Acqua, di proseguire il discorso. Ne è
nata questa «lettera aperta», rivolta a
chiunque operi nel campo della cura e
anche a tutti i cittadini e le cittadine con
cui sempre più bisogna imparare a parlare.
30 | Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive
M
arco Cavallo, che tu forse conosci, ha insistito molto perché
ti scrivessi. Di recente abbiamo fatto visita agli internati dei sei Opg
(Ospedali psichiatrici giudiziari) che ora
stanno per chiudere, siamo stati in viaggio
per due settimane e abbiamo incontrato
tantissime persone.
Sono più di quarant’anni che andiamo in
giro e di cose ne abbiamo viste, di storie
ne abbiamo ascoltate, di persone belle e
generose ne abbiamo conosciute tante.
Abbiamo condiviso con loro l’attesa del
cambiamento, la sorpresa per le impensabili scoperte, la commozione delle storie
ritrovate.
Continuiamo a incontrare persone, e soprattutto giovani, che raccontano delle difficoltà quotidiane, di chiusure, di assenze,
di vuoti, di solitudini. Ci dicono di rinnovate resistenze a un cambiamento semplicemente urgente e quanto mai ovvio.
Lamentano la mancanza di una qualsiasi
tensione etica, che suppongono essere stata
il motore delle lotte di quegli anni.
La lettura della recente intervista a Eugenio
Borgna sul numero 286 di questa rivista (1)
mi ha stimolato a scriverti. Con Borgna
condivido l’indignazione per una psichiatria indifferente ai valori dell’interiorità,
ridotta alle psicofarmacologie, distante dai
luoghi, dalle voci, dalla vita delle persone.
L’insostenibile grigiore
delle psichiatrie
È da tempo che sento parlare del grigiore delle psichiatrie che oggi tengono
il campo. «Le mani alla gola degli schizofrenici», per dirla con David Cooper,
continuano a soffocare emozioni, parole,
1 | Borgna E., La terza rivoluzione che serve alla psichiatria, in «Animazione Sociale», 286, 2014.
passioni. Una scena, questa, che oggi si
mostra quasi ovunque senza veli e senza
vergogna alcuna.
I giovani, più degli altri, rischiano di essere
annientati (o di svanire) in questo scenario.
Parlo dei giovani che vivono l’esperienza
della psicosi e dei tanti giovani che come
te si apprestano a fare questo mestiere. I
primi rischiano la vita, i secondi, anche! E
non ho bisogno di dirti cosa voglio intendere. Studenti di medicina, di psicologia,
specializzandi, infermieri, tecnici, educatori quando scelgono di occuparsi dei malati
di mente sono entusiasti, curiosi, disposti a
mettersi in gioco.
Li vedo generosi e desiderosi di cogliere il
senso etico, politico e umano di questo lavoro. Hanno occhi che guardano e orecchie che ascoltano.
Accade che al primo impatto con le accademie, con i servizi di salute mentale vuoti e
insensati, come troppo spesso accade, con
diagnosi e cura che divengono bunker e ricorrono routinariamente alla contenzione,
con strutture residenziali e sedicenti comunità terapeutiche, dove domina la miseria
della gerarchia, dell’infantilizzazione e
dell’intrattenimento senza fine sono tentati
di fuggire. Possono restare solo a costo di
perdere la luce dei loro sguardi, diventare
sordi e accettare la condanna a pratiche
indicibili e alla solitudine quotidiana.
Nel corso del tempo, un tempo sempre più
breve, rischiano di perdere ogni curiosità,
ogni desiderio. Arrivando nei luoghi della
psichiatria, sperimentano lo sgomento
dell’assenza. Per poter sopravvivere, sono
costretti a prendere distanza. L’inferno che
si presenta quotidianamente ai loro occhi
diventerà invisibile. Non si può sopportare
di stare in quella scena se non c’è mai un
Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive | 31
povero diavolo o un buon cristiano che
condivide con noi quel dolore, quella fatica, che ci aiuti a continuare. Non si può
che impedirsi quella visione, l’inferno non
può che essere cancellato alla nostra vista e
l’accettazione delle cose così come sono,
immutabili e impenetrabili, diventa l’unica possibilità per sopravvivere. Ecco, per
questo Marco Cavallo mi spinge a scriverti.
Le cose che voglio dirti mi assalgono e rischio di essere confuso e di annoiarti. Ma
un qualche punto in premessa devo segnarlo: riconoscerci in una storia che possiamo
condividere e cogliere insieme il senso di
quanto negli anni passati è accaduto.
Chissà se ti hanno
mai parlato di Gorizia
Allora dicevo, nel corso del viaggio abbiamo attraversato 10 regioni e siamo stati
accolti in 16 città. Nelle università, nelle
piazze, negli ospedali abbiamo incontrato persone. Parlato e ascoltato tantissimi
giovani che ci chiedevano di questo nostro
mestiere desiderosi di cominciare. Il loro
valore è inestimabile e pure, nella trascuratezza e nella disattenzione, rischiano di
perdersi, di divenire invisibili. Avrebbero
bisogno, per non scomparire nel grigiore
delle psichiatrie, di sentirsi vicini gli uni
agli altri. Fanno fatica a trovare luoghi e
modi per raccontarsi; per dirsi delle incertezze, delle frustrazioni, dei successi inaspettati e della gioia che sempre il lavoro
quotidiano con le persone è capace di restituire. Avrebbero bisogno di trovare parole
intorno alle quali costruire un dialogo, un
conflitto, uno scontro, la capacità stessa di
confrontarsi, di condividere, di opporsi,
di disobbedire. Abbiamo bisogno tutti di
riflettere sulle nostre storie, di frequentare esperienze e conoscere pratiche che ci
aiutino a vedere che «si può».
Ecco mi piacerebbe parlare con te, di come
ricominciare. È urgente.
Ma forse prima sarebbe bene che tu mi
dicessi delle tue esperienze, delle tue conoscenze, dei tuoi punti di vista. Chissà
se ti hanno mai parlato di Gorizia. Nelle
facoltà di medicina, di psicologia, di infermieristica, di assistenza sociale e nelle
scuole di specializzazione e di riabilitazione psichiatrica è difficile trovare corsi,
seminari, ricerche legati alla storia del
cambiamento, alle possibilità di cura e di
emancipazione che sono nate dalle prime
porte aperte dell’ospedale goriziano. I riferimenti vengono cercati altrove, si studiano
malattie, modelli di servizi, assetti sociali e
politici che non tengono conto della scelta di campo che il nostro Paese ha fatto
abbandonando il modello manicomiale,
restituendo diritti, e scommettendo sulle
possibilità dei singoli. Ovunque si insegna La Psichiatria e ovunque domina la
freddezza del paradigma medico, troppo
spesso mutuato da assetti culturali e sanitari di altri paesi.
Chissà cosa ti hanno raccontato della storia
della malattia mentale? E del malato? Della
legge 180? Della chiusura dei manicomi?
Dei diritti? Delle ritrovate cittadinanze?
La salute mentale
è altro dalla psichiatria
So per certo che nelle nostre scuole è raro
sentire parlare di salute mentale, che non
è psichiatria! L’insegnamento dominante
delle psichiatrie la ignora, oppure la incorpora e la snatura. Così il dipartimento di
salute mentale, in alcune regioni, diventa
dipartimento di psichiatria e i servizi territoriali di salute mentale, ambulatori di
psichiatria. È chiaro che non è la stessa
cosa. I nomi tradiscono la persistenza di
modelli che avremmo dovuto abbandonare
32 | Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive
e comunque una sorda resistenza al cambiamento.
Salute mentale è mettere in campo le persone con le loro singolari esistenze; cogliere
l’insieme delle relazioni, delle tensioni, dei
conflitti di una comunità; portare le risorse
e le cure dalle istituzioni, dagli ospedali (mi
riferisco qui alle strutture residenziali, ai
«repartini» ospedalieri e non ultimo oggi
agli Opg) nel territorio; spostare l’attenzione dalla malattia all’individuo (alla persona, al cittadino) e alle sue peculiari dis/
abilità; muovere da azioni individuali ad
azioni collettive nei confronti delle persone
con disturbo mentale e dei loro contesti.
Incontrare e «creare» esistenze.
Quando ti parlo di cambiamento voglio
intendere che i manicomi non ci sono più
e siamo oggi impegnati, con la chiusura
degli Opg, ad abbandonare per sempre
gli ultimi residui dei dispositivi di internamento ottocenteschi; le persone che vivono
l’esperienza del disagio mentale possono
contare, se pure tra mille ostacoli, sui loro
diritti riconquistati; le imprese sociali, le
cooperative, nate proprio dalle macerie del
manicomio, dove riescono a tener fede alle
ragioni della loro origine e sono in grado
di stare sul mercato e produrre lavoro,
rendono concrete le speranze di crescita e
di emancipazione di tantissimi; ovunque,
bene o male, i servizi territoriali sono stati
organizzati ed è possibile trovare Centri di
salute mentale attivi e presenti quotidianamente a sostegno della vita delle persone;
le associazioni di persone con disturbo
mentale creano protagonismo, partecipazione e ripropongono la dimensione politica delle esperienze, delle diversità, delle
fragilità; in tanti luoghi dell’abitare e in
tanti laboratori, è possibile oggi coltivare
il valore della relazione, la bellezza degli
spazi e degli oggetti; la qualità dei lavori
e delle produzioni dimostra che è possibi-
le curare senza contenzioni, con le porte
aperte, con programmi abilitativi personalizzati, con percorsi di formazione e di
inserimento lavorativo reali, con il sostegno
e il coinvolgimento dei familiari, con l’appoggio puntuale, anche economico, nella
vita quotidiana, con la possibilità per le
persone di vivere identità plurali. Con la
possibilità di guarire.
Perché la legge 180
fa così fatica?
Molti mi chiedono: ma cosa è accaduto veramente, come mai dopo tanti anni la legge
180 fa tanta fatica, perché tante differenze?
Non è semplice rispondere, ordini di discorso diversi si sovrappongono e creano
grovigli difficili da sciogliere.
Che cosa è stata la riforma dell’assistenza psichiatrica in Italia, o meglio che cosa
avrebbe dovuto essere se non un simultaneo tentativo di attraversare la dimensione
etica, disciplinare, politica e amministrativa? Che cosa vediamo oggi, o dovremmo
vedere, se non il radicale cambiamento
delle organizzazioni del lavoro e delle pratiche, dei luoghi e dei tempi, delle tecniche
e degli indirizzi disciplinari, della disposizione strategica delle risorse in campo?
A ben guardare, è la disposizione incerta,
incompleta, approssimativa dei servizi di
salute mentale nel territorio la chiave di
lettura di ciò che è accaduto e accadde.
La distanza (o la vicinanza) dalla vita delle
persone, i riferimenti culturali e disciplinari im/mutati, in una sola parola l’organizzazione e le sue forme permettono di cogliere
il senso e le ragioni delle buone pratiche (e
ancora meglio dei fallimenti).
Ho avuto la fortuna di vivere a Trieste
l’attenzione quotidiana, frenetica e ossessiva allo smontamento dell’ospedale
psichiatrico.
Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive | 33
La rassicurante stabilità del sistema manicomiale si è dovuta tradurre nella ricerca
incerta di modi e parole differenti, nella
«banalità» del lavoro quotidiano, nel riconoscimento prima di tutto dell’irruzione
dei bisogni delle persone sulla scena. I soggetti non potevano più essere accantonati.
È a partire da qui che sono nati i servizi di
salute mentale e la loro capacità di radicarsi
nel territorio e di operare criticamente sui
modelli medici e psicologici dominanti,
di produrre davvero protagonismo, di vedere la «persona non la malattia». È qui,
credo, che bisogna giocare per uscire dal
grigiore e dal pessimismo che oggi tanto
si respira nei servizi e nelle accademie.
L’organizzazione del lavoro ha dovuto piegarsi alla presenza dei soggetti e i linguaggi
del quotidiano hanno cominciato a tessere
un lessico familiare, capace di riconoscere
e sostenere le molteplici identità, di ascoltare, di accogliere.
Il dottore domina
ancora la scena
Sono sempre più convinto che è necessario trovare indirizzi, percorsi, visioni da
condividere, alleanze e reti per formare
associazioni, lavorare sempre insieme agli
altri, fare gruppo. Bisogna avere la capacità
di convergere e orientare lo sguardo verso
orizzonti etici che insieme si riconoscono.
I giovani operatori, al contrario, vengono
avviati allo specialismo esasperato, all’accettazione acritica di tecniche e modelli, a
«difendersi» all’ombra di mansionari, di
posizioni di garanzia, di protocolli. L’idea
che tu debba diventare il bravo dottore è
ancora profondamente radicata nelle scuole e nei servizi. Si propone e si riproduce quotidianamente nella separazione di
compiti e funzioni, in un circolo vizioso
che porta a pensare che i centri di salute
mentale debbano essere poco più che uno
studio medico associato con un infermiere
che risponde al telefono e tiene gli appuntamenti.
Per fortuna il tempo non è passato invano e le persone oggi chiedono di guarire. Mettono impietosamente in luce il
fallimento di questi sistemi. Richiedono
consapevolmente un ascolto singolare e
un altrettanto singolare percorso di cura
e di emancipazione. Chiedono di vedere
valorizzati i loro faticosi e unici percorsi di
ripresa. Vogliono essere aiutati e sostenuti
nell’attraversare cruciali e rischiosi punti
di svolta nella loro esistenza. Cominciano
a disegnare, con la loro domanda, servizi
popolati da una molteplicità di operatori,
servizi che essi pretendono orientati alla
guarigione, alla ripresa appunto, al sostegno delle loro vite e dei loro sogni. Anche
nel tempo lungo.
In molti professionisti della salute mentale l’adesione entusiastica al processo di
chiusura dell’ospedale psichiatrico si materializzò in un rafforzamento arrogante
del modello medico, delle tecniche, dei
farmaci, del dottore che domina la scena:
finalmente psichiatri, psicologi, infermieri
(con i loro sindacati) potevano liberarsi dal
fardello del controllo sociale, proprio della
psichiatria (manicomiale), della pericolosità, delle ruvidezze che da questo momento
dovevano essere delegati a un confuso e
misero sociale. Potevano finalmente ritrovare la purezza della psichiatria medica
nel camice bianco inamidato di fresco, nei
servizi ospedalieri, negli ambulatori, nelle
cliniche private, negli istituti residenziali. Potevano affermare con l’ingannevole
credibilità scientifica appena conquistata,
fuori dal manicomio, l’indispensabile e
irrinunciabile ricorso alle porte blindate,
alle contenzioni, alle dosi eroiche dei trattamenti farmacologici.
34 | Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive
entario
Nell’armavm
i
che i gio ,aen gli
ri
to
opera
in
psichiatrire
,
la
o
ic
rt
pa
uelle
in
portano onqc’è
trincee nlcuna di
traccia a di parole,
persone, mentale.
di salute
Le evidenze contano più
delle scelte di campo
Mi chiedi dei risultati oggettivi, degli esiti
dei trattamenti, se le persone stanno meglio. Vuoi poter valutare i vantaggi dei modelli che ti vado proponendo. Mi richiami
spesso all’evidence based per uscire dalle
incertezze e dalle perplessità che ti assalgono.
Le possibilità nuove ed estese di ripresa,
di integrazione, di emancipazione sono
quanto mai evidenti. La presenza sulla
scena, sempre più evidente, delle persone che vivono l’esperienza del disturbo
mentale allude a prospettive inaspettate.
Forme originali di abitare, di lavoro e di
socialità possono realizzarsi ovunque. Ma
più che le evidenze, sono le scelte di campo
che danno conto dei cambiamenti e dei risultati. Potrei dirti per brevità della «porta
aperta». La porta aperta, dicevamo in manicomio, e continuiamo a dire nel mondo
di fuori, per l’esercizio della cittadinanza.
La porta aperta per un’etica della dignità,
dell’inviolabilità del corpo, del rifiuto della
violenza. La porta aperta per un lavoro di
cura che (finalmente) può farsi nella considerazione dell’altro, nell’incontro, nella
conversazione.
I libri di psichiatria che devi studiare parlano di un mondo pulito, silenzioso, geometrico. La Ragione domina la follia dal
giorno stesso della nascita della psichiatria.
Nella copiosa letteratura psichiatrica non
si trova ombra di una sofferenza, di un dolore umanamente comprensibile, non un
odore, non un grido, non una voce, non
un silenzio. Non una prepotenza subita o
esercitata. Emozioni e sentimenti raggelano nel linguaggio della clinica, i sintomi si
sostituiscono alle persone. Si costruiscono
così spazi e trattamenti nella stessa rarefatta atmosfera di irrealtà dei manuali di
psichiatria. La quotidianità dei luoghi dove
vivono veramente gli operatori, chiusi negli
ambulatori e impegnati in prima linea ad
affrontare la domanda di aiuto delle persone con disturbo mentale scompare. I
giovani vengono avviati a questo mestiere
come uno scalcinato esercito mandato al
fronte della normalità per difendere tutti
noi dalla follia in trincee fangose, fredde e
ingenerose. Nell’armamentario che i giovani operatori, e gli psichiatri in particolare,
portano in quelle trincee non c’è traccia
alcuna di persone, di parole, di salute mentale. Soltanto la presenza incontrastata di
una Psichiatria che vuole apparire «moderna» senza riuscire a liberarsi dalle antiche
impresentabili origini.
La non oggettivazione
è il confine invalicabile
Bisognerebbe ampliare conoscenze sui
diritti, sugli assetti normativi e legislativi,
sulle politiche di salute mentale; si dovrà
sempre più valorizzare il sapere disciplinare collegandolo a quanto accade in termini
trasformativi nella realtà dei servizi; occorrerà essere capaci di attraversare gli ambiti
scientifici anche per proporre visioni che si
allontanino dall’abusato ricorso al paradig-
Animazione Sociale marzo | 2015 prospettive | 35
ma clinico-medico. Bisogna muovere dalla
consapevolezza delle nostre esperienze e
dichiarare che molti dei servizi di salute
mentale, così come sono organizzati oggi,
hanno scarsa valenza di cura e non sono in
grado di dispiegare le enormi potenzialità
dimostrate dalle buone esperienze innovative e da un assetto legislativo unico al
mondo.
Ti sto dicendo che devi finalmente rischiare di diventare protagonista. Una vasta
schiera di giovani operatori non ancora
del tutto «contaminata» dalla psichiatria,
deve poter entrare in gioco e maturare conoscenze anche in opposizione alla formazione accademica grigia e, per tanti di voi,
mi dite, insoddisfacente.
Ci sono azioni, trattamenti, posizioni che
segnano drammaticamente il campo e bisogna scegliere da quale parte stare. Il rifiuto ostinato della contenzione, della «porta
chiusa» e più in generale di tutte le forme
inerti e stupide di oggettivazione rappresenta il discrimine, il confine invalicabile.
Con umiltà e abbandonando la confortevolezza dei luoghi comuni occorre tornare
sulle parole, ora a rischio di sparizione, che
dettero inizio ai grandi cambiamenti negli
Stati Uniti, in Europa e nel nostro paese. A
fronte delle conoscenze certe apprese dallo
studio della clinica dei disturbi mentali, bisogna ripensare al mondo dell’esperienza,
a quanto accade veramente nella nostra
quotidianità, alla fatica dell’incontro con
l’altro. La messa tra parentesi della malattia, per esempio, ha restituito allo sguardo
e all’ascolto uomini e donne nel divenire
della loro esistenza; ha reso possibile narrare e ascoltare.
Essere con le persone rende finalmente comprensibile la loro sofferenza. Le
sottrazioni e le miserie di tanti servizi di
salute mentale, una volta svelate, non possono non diventare il punto di partenza,
faticoso e contraddittorio, per impegnarsi
in pratiche di cambiamento intorno alla
corporeità, alla materialità, alla tangibilità
delle persone.
Cerchiamo insieme
come ricominciare
Uno psichiatra, ed è la prima volta che accadeva, cerca di prendere le distanze dalla
cultura e dal paradigma biologico-clinico
(che ha prodotto e riprodotto il manicomio). Insieme ad altri giovani, si sta interrogando sulla in/comprensibilità del malato
di mente reso muto dalla rozzezza della
persistenza dell’armamentario positivista.
Quando gli toccherà di entrare nel manicomio non potrà non vedere.
Il 16 novembre 1961, Franco Basaglia
entra nel manicomio di Gorizia.
Per me è l’inizio del cambiamento che sto
cercando di dirti. Una storia che tutte le
volte che la racconto si traduce in presente
e comincia a parlarmi di futuro.
Peppe Dell’Acqua, psichiatra, collaboratore
di Franco Basaglia dal 1971, per molti anni
direttore del Dipartimento di salute mentale
di Trieste, insegna psichiatria sociale all’Università di Trieste ed è direttore della Collana
«180. Archivio critico della salute mentale»
dell’editore alpha beta Verlag di Merano: [email protected].
36 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Quest’inserto esplora
un concetto innovativo
nella salute mentale:
la recovery, un termine di difficile
traduzione, ma di grande pregnanza. In
italiano si può esprimere con «ripresa
di sé». Non significa necessariamente
guarigione clinica, bensì enfatizza il
viaggio che ciascuno compie nel
costruirsi una vita al di là della malattia.
Proprio qui è il potenziale innovativo
racchiuso in questo termine. Anche se i
sintomi permangono, si può comunque
star meglio, migliorare la propria vita.
Come? A dircelo sono le stesse persone
con esperienza di disturbo mentale
severo: accettando la propria condizione,
ridefinendo un senso di sé, imparando a
chiedere aiuto nei momenti in cui si sente
la crisi arrivare, negoziando coi servizi le
cure, partecipando alla vita sociale con il
lavoro e altre forme di inclusione.
Com’è intuibile, il concetto di recovery
non nasce dalla psichiatria biologica,
oggi dominante, di cui anzi rappresenta
la sfida più grande. Nasce invece dal
movimento degli ex utenti, dall’ascolto
dei racconti delle persone che hanno
fatto i conti con la sofferenza, dal
riconoscere dignità ai mille modi con cui
i soggetti provano a superare le loro crisi,
psicotiche o depressive. È dunque un
concetto che dalle frontiere della salute
mentale prova a farsi strada. Incontrando
fatalmente la resistenza della psichiatria
medica, purtroppo ancora preda di
quello che nell’inserto viene definito
«pessimismo kraepeliniano».
Emil Kraepelin è lo psichiatra tedesco
che, tra ’800 e ’900, ha sostenuto
l’oggettività della malattia mentale,
ritenendo irrilevante (ai fini della
comprensione e della cura) il modo in cui
essa viene soggettivamente interpretata.
«Kraepelin – ha scritto Eugenio Borgna –
è rimasto estraneo all’arcipelago infinito
della vita interiore dei pazienti.
Nell’orizzonte kraepeliniano del discorso,
la schizofrenia si trasforma in una
malattia, in una realtà clinica, che segue le
sue proprie leggi naturali: insensibile,
dolorosamente insensibile a qualsiasi
articolazione, a qualsiasi sollecitazione,
ambientale e interpersonale,
psicoterapeutica e socioterapeutica».
Le «leggi naturali» della malattia mentale
sono quelle della «prognosi negativa» e
della «cronicità». Due miti che la
recovery sfata, illuminando come le
persone interagiscano attivamente col
proprio disturbo (e nell’interagirvi ne
influenzino il decorso) e coltivino il
desiderio di costruirsi una vita oltre e
nonostante il disturbo mentale. Per i
servizi di cura è oggi vitale confrontarsi
su questi terreni, per continuare a porsi a
servizio della salute delle persone e dei
territori.
Le riflessioni di quest’inserto riprendono
e rielaborano i contenuti del prezioso
volume Guarire si può, curato da Izabel
Marin e Silva Bon (uscito presso l'editore
alpha beta Verlag, nella collana «180»).
38 | R. Mezzina
Vivere al di là
della malattia
48 | I. Marin
Se la prognosi negativa
è un mito da sfatare
62 | M. Ciambellini, A. Eusebi,
L. Negrogno, F. Starace
La cittadinanza è
ancora terapeutica
71 | I. Marin
Progettare servizi orientati
alla recovery
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto | 37
Costruirsi
una vita
al di là della
«malattia mentale»
A cura di
Roberto Mezzina,
Izabel Marin,
Manuela Ciambellini,
Anita Eusebi,
Luca Negrogno,
Fabrizio Starace
Nella storia della salute e della malattia
mentale, è successo che a un certo punto
abbiano cominciato a parlare i diretti
interessati. E quando i soggetti portatori
del problema riescono a farsi sentire, il
problema viene a ridefinirsi. Dai loro
racconti emerge che il disturbo psichico è
un’esperienza attraversabile e dunque la
cronicità non è un destino. Che la salute
mentale è la capacità di riprendere in
mano la propria vita e non per forza
l’assenza di sintomi. Che se è difficile
arrivare alla guarigione clinica, è
comunque indispensabile perseguire una
miglior qualità della vita. E – non da ultimo
– che ai servizi di salute mentale spetta
accompagnare le persone nei loro
viaggi verso la «riconquista di sé».
Un’idea potente, che in questi anni
abbiamo imparato a chiamare «recovery».
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Inserto del mese
La recovery nella salute mentale
38 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Roberto Mezzina
Vivere
al di là
della malattia
Il viaggio
per riprendersi
la propria vita
Nella salute mentale si
è fatta strada in questi
anni l’idea di recovery.
Significa «ripresa di
sé» e rimanda al
viaggio compiuto da
ciascuno per costruirsi
una vita al di là del
disturbo mentale,
anche severo. È un
concetto che nasce
dall'ascolto delle
persone che hanno
imparato a convivere
con la propria
sofferenza, senza
farsene inchiodare ma
prendendo coscienza
dei margini di libertà
che comunque sempre
rimangono.
Costituisce una sfida
all'ideologia medica
perché non si focalizza
sulla malattia, ma
mette in luce quel che
occorre per vivere
fuori dalla sua ombra.
Come tale interroga
oggi i servizi, gli
operatori, le politiche.
Il concetto di recovery attraversa oggi culture e pratiche della salute mentale e rappresenta la sfida più grande all’ideologia medica, nel momento in cui sottolinea
il ruolo attivo delle persone e i fattori di significanza
connessi alle loro storie, alle loro vite.
È un concetto ormai entrato con forza nelle politiche e
nei documenti ufficiali, anche dell’Oms (dalla Mental
Health Declaration di Helsinki 2005 al nuovo Action
Plan europeo), e appare centrale nel saldare le esperienze nate dalla deistituzionalizzazione della psichiatria
e delle sue istituzioni, con il sapere che emerge dai
processi di empowerment (acquisizione di potere) ed
emancipazione delle persone.
A partire dalla deistituzionalizzazione, a Trieste come
in altre esperienze sul territorio nazionale, gli utenti dei
servizi hanno infatti riguadagnato non solo un livello
di potere, ma anche la possibilità di «dire», di avere la
parola. E oggi chiedono che sia riconosciuto il valore
dell’esperienza sofferente, sia pure come diversità.
Cosa si intende
con recovery?
Vi sono miriadi di definizioni di recovery, che fanno
sì che il significato del termine di volta in volta muti
sulla base delle intuizioni di studiosi, ricercatori, operatori, esperti «per esperienza», familiari e formatori.
In inglese il verbo to recover significa riaversi, ripren-
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
39
dersi, recuperarsi. E recovering è il percorso o processo che si compie. In italiano,
nonostante l’origine latina del termine, non vi è nessuna parola che abbracci e in
un lampo ci faccia cogliere questa accidentata polisemia.
Si tende a identificare recovery con «guarigione», ma è corretto? In realtà la parola
guarigione rimanda a un concetto forse ancora troppo medico, che non contiene
nulla del senso dello star male. Benché la guarigione rappresenti la più alta aspirazione di coloro che soffrono, di qualunque malattia si tratti, questa parola rischia di
risultare fuorviante in psichiatria in quanto nessuna lesione biologica o alterazione
anatomica è dimostrata.
La psichiatria risulta inadeguata se propone una comprensione del fenomeno ancora all’interno del modello medico-biologico di malattia-menomazione (illnessimpairment) e disabilità (disability). La sregolazione di alcuni circuiti neurotrasmettitoriali non spiega infatti nulla della complessa condizione di disturbo severo,
della sua esperienza soggettiva e del suo oggettivo corso o decorso.
Da cosa si dovrebbe guarire ancora non è chiaro. Dalla malattia mentale, dalle
psicosi, dalla schizofrenia in particolare? O dall’esperienza dell’essere paziente,
ovvero dallo stigma, dagli esiti negativi e dagli aspetti disumanizzanti che i trattamenti psichiatrici troppo spesso comportano?
Guarigione richiama alla mente soprattutto un esito finale: un accadere biologico,
favorito o addirittura determinato da terapie e cure, il che ripropone un nesso
causale col lavoro terapeutico che non solo è difficile da dimostrare, ma che diventa
ingiusto misconoscimento della complessità di tutti i fattori in gioco, in particolare
di quelli soggettivi. In tal senso il concetto di guarigione mostra i suoi limiti, e
giustamente la psichiatria inglese sottolinea che recovery non è cure, cioè non è il
prodotto delle terapie psichiatriche quali esse siano.
Recovery è il viaggio nel ricostruirsi una vita al di là della malattia
Anche in senso psicodinamico, la psichiatria ha spesso delineato, utilizzando il
suo linguaggio e i suoi codici, una psicogenesi della malattia. Ma non è descritto il
processo attraverso cui la guarigione si realizza, e il tempo della guarigione rimane
misterioso ancor più di quello dell’ammalamento. Su queste questioni non possiamo
far altro che emettere ancora dei balbettii.
Cos’è allora recovery? Potremmo dire che questo termine enfatizza il viaggio compiuto da ciascuno nel ri-costruirsi una vita al di là della malattia. La recovery è
presa di coscienza di sé e dei propri problemi, ma soprattutto dei propri obiettivi
di esistenza. Il che significa uscire dal modello medico, di delega totale del corpo
e della psiche ai tecnici per il trattamento della malattia.
Si tratta dunque di un concetto che dobbiamo riconoscere come emergente al di
fuori del mondo professionale, che ci piaccia o no, e che solo in un secondo tempo
e con non poche forzature si può inquadrare nei codici della psicologia o della
psichiatria.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Recovery non è la guarigione clinica
40 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Riguadagnare controllo sulla propria vita
Quali sono gli indicatori della recovery? Scomparsa dei sintomi, oppure fiducia in
se stessi, autostima, autodeterminazione, empowerment?
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Alla base un diverso rapporto con il sintomo
Al di là della definizione medica di guarigione, il concetto di recovery pone il
tema del cambiamento del rapporto col proprio problema o col proprio disturbo:
riguadagnare il controllo su ciò che ti accade e in senso più ampio sulla tua vita,
migliorarne la qualità, vivere la vita più positivamente. «Progetto di sé» è forse
l’espressione che descrive nel modo migliore tale processo.
Il contributo scientifico maggiore all’idea di questo tipo di percorso lo si deve a
John Strauss, che ha descritto il processo di elaborazione dell’esperienza psicotica
come rapporto tra il sé e i sintomi, tra la soggettività del malato e l’oggettività, in
un certo senso, della malattia. Nel percorso di recovery la persona in sé è il fattore
determinante, con le sue capacità di coping, di resilienza e di affrontamento della
malattia, ma anche di cambiamento personale, di accettazione di sé e di contemporanea assunzione di responsabilità.
A riguardo scrive Larry Davidson (1)
L’esperienza di recovery dalla malattia mentale implica un processo di recupero o
di sviluppo di un ruolo valido e di un senso di identità positivo al di là della propria
disabilità, e quindi la ricostruzione della propria vita nella comunità più ampia nonostante le limitazioni imposte da tale disabilità.
È questa forse una delle migliori definizioni: in essa si compie il passaggio dal «riprendersi dal disturbo» al «riprendersi la propria vita», scompaginando le carte
della psichiatria. Eppure nemmeno questa riesce a esprimere a fondo la complessità
e la ricchezza del termine, l’ampio alone semantico di un oggetto scientifico che
corre talora il rischio di essere interpretato come un costrutto contraddittorio,
ambiguo e nebuloso.
Lo sviluppo di un nuovo senso del sé
La questione della recovery rende più chiaro il modo in cui i soggetti si relazionano
alla malattia, la direzionano, non vi soggiacciono più passivamente. Vivere «fuori
dalla malattia», dal suo alone, dalla sua ombra, ne è l’obiettivo vero. Anche nella
catastrofe vissuta della crisi, nell’abisso dello star male, vengono descritti dalle
persone come dialetticamente compresenti sentimenti positivi e ricostruttivi: la
ripresa è già contenuta nella lotta contro la malattia, o meglio nelle capacità del
soggetto di affrontarla.
Se la malattia è invariabilmente descritta come non-libertà e non-scelta, come trappola per il soggetto, la recovery non può che consistere in un processo di apertura
1 | Davidson L., Strauss J. S., Sense of Self in
Recovery from Severe Mental Illness, in «British
Journal of Medical Psychology», 65, 1992, pp.
131-145.
di possibilità. Vengono apprezzate le cose importanti per tutti: riavere una famiglia,
avere amici con cui uscire, saper affrontare le relazioni interpersonali. E questo non
coincide necessariamente con il superamento definitivo dei sintomi e con la sospensione delle terapie. Coincide invece con il riprendersi in mano la vita, ri-acquistare
potere, assumere un nuovo ruolo come quello di «ex» paziente, quindi mettere
alle spalle ma anche fare tesoro dell’esperienza, valorizzarla. Il tutto nel mentre si
va a sviluppare «un nuovo sé» o meglio un «senso del sé», come afferma Strauss.
Spesso capita che questo processo comporti il lottare per la propria autoaffermazione anche contro la psichiatria: il malato «che si mette di traverso» al servizio
rappresenta questa posizione in modo esemplare. Occorre in tal caso per gli operatori accogliere il conflitto come elemento di trasformazione, capire e negoziare,
trovare altre strade.
Dove emerge il soggetto, dove si vede la persona e si assottiglia la malattia (e la
psichiatria), si intravede così la possibilità di ridare valore all’esperienza sofferente
come percorso personale e come significato interpersonale rivolto alla nostra vita
sociale e alle possibilità di coesistenza.
Fenomenologia del percorso di recovery
Qual è la fenomenologia del percorso di recovery?
La recovery è un processo, come la vita
La recovery non è un esito, ma un processo, come la vita. Niente è definitivo, tutto è
una lotta. Prima ancora che essere un costrutto psicologico o clinico, fa riferimento
a elementi di base dell’esperienza umana, a ciò che ci unisce e ci rende partecipi
dell’esperienza altrui. La recovery è il percorso che la gente compie nel superare
eventi gravi dell’esistenza come lutti, malattie, separazioni: tutto ciò che cambia la
vita in maniera irreversibile e rispetto a cui siamo chiamati a cambiare.
È un cambiamento, anche parziale ma definitivo, del rapporto con la malattia: i punti
di svolta sono rappresentati di solito da eventi precisi, ma anche da cambiamenti
di atteggiamento. La recovery non è pertanto un processo graduale e progressivo,
ma va avanti a salti, a volte retrocede, per poi ripartire; ciò che conta è la corrente
che spinge.
C’è dunque una direzionalità, ma non una linearità, ossia ci sono molte strade
diverse che conducono a un diverso rapporto con la «malattia». La difficoltà per
le persone, ma anche per chi cura, è saper riconoscere e valorizzare i passaggi, i
salti qualitativi del percorso. Anche quando la persona sembra ferma, si arresta
o arretra, può voler dire che sta raccogliendo le sue energie, in una progressiva
accumulazione di risorse e di miglioramenti minimali non visibili, che rendono
possibile poi un salto.
BOX
DOPO MESI DI SILENZIO GIANFRANCO INIZIA A RACCONTARE
È il caso dell’esperienza emblematica e straordinaria di Gianfranco, che dopo otto mesi di
silenzio totale, improvvisamente, senza alcun motivo apparente e nessuna nostra aspet-
41
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
42 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
tativa, inizia a parlare e a raccontare come ha passato il suo tempo a guardare la vita che
scorreva davanti ai suoi occhi e le persone che frequentavano il Centro. Questo l’ha aiutato
a pensare a se stesso e poi a maturare il salto, a essere pronto a tornare. Abbiamo ripreso
la sua narrazione stupefacente in una lunga video-intervista in cui ricapitola la sua vita
e le sue relazioni, e ci dice quanto sia stato importante per lui quel periodo di apparente
passività e immutabilità.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Il soggetto riemerge dalla malattia
I racconti delle persone, e a volte la nostra stessa esperienza nel lavoro che facciamo,
sembrano così illuminare, in modi talora intuitivi, che cosa voglia dire ripresa, e in
un certo senso guarigione.
Forse, in maniera pre-riflessiva, possiamo dire che la recovery «si vede» dal riemergere del soggetto, delle sue speranze, aspettative di vita, sogni, progetti. Pensiamo
a tutte le volte che vediamo emergere delle persone dalla malattia, che sembra
quasi assottigliarsi e scomparire. Ci sono persone che vediamo migliorare inaspettatamente, dopo molto tempo e molte sofferenze; e persone che prendono
coscienza dei propri problemi e finalmente sono in grado di analizzarli e situarli
nella propria storia. E poi ci sono i mille modi che le persone dimostrano di avere
per uscire da una crisi, chiudendo capitoli della propria vita o riconnettendosi a
temi lungamente dimenticati. A volte ci sorprendono, uscendo dal linguaggio dei
sintomi e presentandoci una lunga lista di consapevolezze.
L’idea di recovery, ossia l’emersione del soggetto come evento che segna una svolta
nel percorso terapeutico o nel rapporto col servizio o nella sua stessa esistenza, ci
ha affascinato da quando a Trieste, postazione d’avanguardia delle trasformazioni
anche della fenomenologia della domanda psichiatrica, abbiamo visto in essa l’esito
di quella che Franco Rotelli ha chiamato la «deistituzionalizzazione della malattia»
e non solo degli istituti che contenevano e oggettivavano il malato.
Che cosa rende possibile la recovery?
Si possono individuare diversi livelli che rendono possibile la recovery:
• personale: la recovery è qui vista come imparare a vivere «nonostante i sintomi», o
comunque minimizzandone l’impatto, tentando di autogestirsi. «La vita nonostante
i sintomi» era uno dei grandi insegnamenti della scuola della deistituzionalizzazione: le persone pur all’interno di condizioni di malattia e di diversità potevano
stare nella comunità, avere una vita normale, avere diritto a una risposta ai propri
bisogni primari e di relazione;
• familiare: questo livello sottolinea l’importanza del coinvolgimento della famiglia
in un percorso di cambiamento che non riguarda soltanto il «paziente designato» ma
i suoi familiari, che riconoscono che «il suo problema è – in qualche modo – anche
il nostro». Spesso questo percorso mostra lo sviluppo di importanti consapevolezze
sociali, partecipative e comunitarie, se non politiche in senso lato;
• comunitario: l’accento è qui sul riconoscimento della valenza partecipativa, del
contributo di integrazione e di solidarietà che ogni membro di una comunità o di
una data società può dare verso chi soffre o ha sofferto di problemi di salute mentale;
• servizi e operatori: le indicazioni al riguardo sono quelle di cambiare atteggiamenti,
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
43
sviluppare sensibilità, affiancare un percorso personale alla formazione professionale, ribellarsi a ciò che è dato per scontato, alle condizioni di lavoro talvolta
disumanizzanti, all’istituzionalizzazione delle persone, alla lesione dei loro diritti
difendendoli attivamente insieme alle persone stesse.
L’attraversare le esperienze dentro alvei protetti e aperti rappresenta per molti il
terreno favorevole della recovery. Questo chiama in causa i servizi, i loro atteggiamenti, ciò che dovrebbero soprattutto garantire.
Il potere, tema ben noto in psichiatria
Oggi s’impone certamente un’ottica più ottimistica, una visione fondata sulla certezza che esistono opportunità che i servizi devono poter garantire, utili a favorire la
«ripresa». Ne sono esempi le situazioni di convivenza promosse dai servizi di salute
mentale, il sostegno spontaneo di pazienti ad altri in crisi, la presenza qualificata
dei familiari come interlocutori, l’alto grado di coinvolgimento di tutti gli attori
nei programmi terapeutici.
Queste opportunità chiedono ai servizi di muoversi oltre la relazione istituzionale, perché solo così si apre la possibilità per chi è curato di recuperare una reale
decisionalità riguardo alla propria vita. Ciò implica dover affrontare la questione
del potere: un tema ben noto in psichiatria – fin dal passaggio fondamentale dal
rapporto di dominio/controllo all’assistenza e alla relazione terapeutica – ma che
non smette mai di riproporsi.
Nel solco della deistituzionalizzazione, il rapporto istituzionale – soggetto-oggetto
di trattamento, curante-curato – è diventato gradualmente un’interazione sempre
più complessa. Si sono favorite tutte le modalità di partecipazione informale alla
vita dei nuovi servizi di comunità, sulla base di una tendenziale reciprocità nei
rapporti, includendo via via nel campo tutte le figure che potessero rendere più
articolata tale bipolarità (familiari, cittadini, volontari...).
Così i servizi oggi spesso tessono una rete partecipativa a partire da sé: è un network
di scambi e di processi di «adozione», dove sono scambiate non merci ma valori
d’uso e relazioni, mettendoli a disposizione e facendoli arrivare a chi per solito ne
è escluso. Del resto, solo una pratica psichiatrica in cui le persone siano valorizzate
come soggetti, dotati di una loro contrattualità, e in cui i loro bisogni, le loro aspettative, i loro obiettivi siano la sostanza dei progetti terapeutici, può produrre consenso alle cure, fiducia, collaborazione, coinvolgimento nei programmi individuali
da parte di ciascuno e dunque (ulteriore passaggio) opportunità di partecipazione
collettiva alla vita di un servizio e alla sua trasformazione.
C’è una recovery dalla malattia, ma anche dai trattamenti
Il flusso comunicativo che viene così favorito nel servizio, in particolare nel Centro
di salute mentale (nei momenti formali dei colloqui, degli incontri, delle riunioni,
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
La recovery pone il tema del potere
nel rapporto con i servizi
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
44 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
nel lavoro terapeutico individuale, familiare o di gruppo, oppure in una molteplicità
di situazioni e occasioni informali), innesca sicuramente forme di partecipazione.
Si creano momenti di aggregazione spontanea ai quali si affiancano momenti di
auto-aiuto tra persone, in cui spesso il servizio mette in campo risorse integrative.
Il «bisogno di relazioni» si pone ormai come centrale. E nella dimensione della
relazione, che sia formalmente definibile come terapeutica o di aiuto, il punto è
adoperarsi a trattare in modo paritario e reciproco. L’assunzione del rischio, del
trattare la persona «come se» fosse fino in fondo in grado di stare nelle regole della
relazione, è spesso necessaria.
Al riguardo ha scritto Shula Ramon che c’è una recovery dalla malattia ma anche
dai trattamenti, dalla mancanza di capacità personali ma anche dalla carenza di
opportunità per attività valide. L’attenzione dei servizi va così alle esperienze vissute che si oppongono ai saperi degli esperti, al guardare le persone come attori,
al considerare la qualità della loro vita sociale, con particolare riferimento alla vita
quotidiana che è la dimensione dove accade la recovery.
Costruire l’accesso ai diritti
In tal senso la recovery non può essere vista come un percorso solo individuale,
altrimenti vi sarebbe di nuovo sottesa un’etica del riscatto dell’individuo da una
condizione, la malattia, vista ancora come colpa. Non diversamente da come – nel
linguaggio del potere – la riabilitazione è rieducazione.
Nonostante l’enfasi sulla singolarità e sulla soggettività, recovery è certamente un
fatto interpersonale e sociale. Proprio in quanto attiene all’individuo, si colloca
nella globalità della sua esperienza di vita dentro un contesto sociale e culturale
determinato. La dimensione sociale e partecipativa, in queste storie, indica che la
persona sta emergendo dall’isolamento, dalla rottura di significato e comunicazione
che si traduce in de-socializzazione.
Si può percepire allora l’emergere di un sé sociale, una condizione di cittadinanza
«vissuta» che è l’intima natura sociale della recovery. Ovviamente (ma non tanto
per la psichiatria) le risorse materiali – il reddito, la casa, il lavoro – ne sono veicolo
fondamentale (neanche a dirlo) perché rappresentano opportunità e costruiscono
identità e contrattualità sociale.
Ecco perché è preferibile legare insieme «recovery ed emancipazione», per sottolineare l’aspetto di non-libertà che è connesso alla condizione di malattia e di
assenza di diritti. Benché forme di recovery siano possibili ovunque e anche nelle
condizioni più estreme, essa si compie e s’invera solo là dove la libertà ha i suoi
prerequisiti fondamentali (ossia in uno stato di godimento di diritti). Ecco perché
«cittadinanza» è la parola che ormai viene più frequentemente associata a recovery
per dotare il processo di senso e qualità.
Quanto devono ancora modificarsi i servizi?
Il problema è come oggi le pratiche di salute mentale e di riabilitazione possano
contribuire alla piena realizzazione del diritto a una cura che non sia sanzione, del
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
45
diritto a un reddito, a una casa, a un lavoro, a una partecipazione attiva alla vita
civile e sociale. Quanto debbono ancora modificarsi i servizi perché siano davvero
«centrati sull’utente»?
Il lavoro di trasformazione delle pratiche e delle discipline appare lungo: è necessario stabilire forme di partecipazione attiva degli utenti ai servizi di comunità e
rafforzare i legami con le istanze e i soggetti della vita sociale, per un pieno coinvolgimento nella promozione di salute mentale (dai familiari agli operatori dei servizi
sociali, sanitari e giudiziari, via via fino al corpo sociale). Non è un’operazione
indolore perché va a toccare il nodo dei poteri e deve pertanto partire dal riconoscimento che la prospettiva dell’utente, come soggetto e attore del proprio percorso
di integrazione sociale e di emancipazione, è di fondamentale orientamento.
Nessuno spiega a sufficienza come buone linee guida basate sulla recovery siano in
grado di trasformare i servizi, che sono istituzioni dominate in modo materiale dalla
loro logica interna e dalle loro strutture di potere, ma soprattutto dal paradigma
medico-biologico. Cosa occorre dunque per un loro cambiamento? Una buona dose
di senso comune? Scelte etiche? Una formazione ad hoc? La sola risposta, a mio
avviso, è ancora una volta nella possibilità di agire una deistituzionalizzazione, forse
in forme nuove e differenti, basate sul riconoscimento del contributo dell’utente
nel servizio e sulla spinta delle energie trasformative verso la salute possibile. Ma
non è ancora abbastanza.
Assumere come centrale la qualità della vita
In servizi orientati alla recovery, i concetti di inclusione sociale e cittadinanza sono
centrali. La partecipazione, i diritti, il potere e l’inclusione sociale sono strettamente
intrecciati col ruolo dei servizi di salute mentale comunitari nel supportare i cambiamenti individuali, come agenzie che forniscono o catalizzano risorse e opportunità.
Mentre l’approccio tradizionale al trattamento e alla guarigione enfatizza il sollievo
dai sintomi e la prevenzione delle ricadute, per l’approccio orientato alla recovery
la qualità della vita diventa centrale e il miglioramento sintomatico al contrario ha
un ruolo variabile.
Certamente va precisato che la recovery può accadere con o senza l’aiuto professionale, o addirittura nonostante questo. I punti di svolta delle persone spesso
coincidono comunque con aspetti dell’intervento del servizio, o del programma
terapeutico personalizzato, o della presa in carico. E ciò ha certo a che fare con
le opportunità offerte e le risorse messe in moto; ma si può inverare un senso terapeutico e riabilitativo solo se il servizio riesce a sostenere e potenziare il senso di
autodirezione e responsabilità della persona nel percorso.
Diventare servizi «attraversabili»
Il servizio è orientato alla recovery se è «attraversabile», se cioè in esso la persona
trova non le regole istituzionali che impoveriscono, sminuiscono e comprimono il
soggetto in crisi, ma dei punti e delle persone di riferimento, un’accoglienza calda e
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Riconoscere la prospettiva dell’utente
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
46 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
partecipe, una disponibilità a occuparsi dei problemi di vita e non solo dei disturbi.
L’attraversamento del servizio è connesso alla recovery, nel senso che l’offerta
terapeutica e di risorse strumentali è orientata a dare degli stimoli, che però, se
non si è in grado di cogliere, restano imposti, estrinseci. Il servizio può allora fare
emergere una rete di supporto e renderla utilizzabile oltre che visibile, sviluppando
un intervento di mediazione importante, per attivare l’aiuto e fare avvicinare la rete.
La cura implica a sua volta l’assunzione di me operatore come soggetto che opera
in un campo comune (mio e dell’altro), dove l’altro può «avanzare» e acquistare
potere. Ma ciò comporta accettare che questi sia depositario di un sapere di trasformazione, e quindi un mettersi di lato, di fianco, per permettere una soggettivazione dell’altro. Perché emerga il soggetto, occorre che si metta in discussione
il terapeuta, con le sue certezze.
Ciò che deve guarire è allora innanzitutto la relazione tra chi assiste e chi è assistito.
Recuperare il significato del termine assistenza: far da testimone, da segnapassi,
da registratore del percorso, e al tempo stesso aiutare, sostenere. Non agire su, ma
agire con. Per Basaglia tale «reciprocità» si basa sul fatto che il terapeuta è messo in
discussione dal malato, come il malato dal terapeuta. Occorre che ognuno si renda
riconoscibile all’altro, che anche l’operatore si metta in gioco e si soggettivizzi con
il malato, uscendo dal rapporto istituzionale.
Mantenere un’apertura sul possibile
Agire la deistituzionalizzazione è cambiare i rapporti di potere: si dà centralità ai
bisogni dell’utente, senso ai suoi gesti, e «per vederli» si riduce la distanza nella relazione curante-curato. Perché la soggettività dell’utente emerga, quella dell’operatore deve entrare in gioco, confrontarsi con essa: il progetto terapeutico-riabilitativo
nasce all’interno di una nozione nuova di contratto tra l’utente e il servizio.
Per i servizi di salute mentale tutto ciò si traduce in accessibilità e flessibilità, tali
da garantire un lungo periodo di sostegno se necessario, continuità di relazione e
accesso a possibilità di scelta e opportunità (anche quelle di fallire e ritentare). Una
relazione ispirata dunque non alla distanza «terapeutica», ma al coinvolgimento e
alla personalizzazione nel cercare insieme un senso, al dare fiducia, al «rischiare»
insieme e quindi al mantenere un’apertura sul possibile. Il che vuol dire offrire
speranza e aspettative, ma anche riconoscere le competenze, i desideri e i valori.
La recovery non consiste nell’insegnare nuove tecniche in un processo di oggettivazione e omologazione dell’esperienza individuale in qualche modello preformato di
guarigione, come hanno cercato di fare in questi anni tentativi maldestri di «meccanizzare» in un dispositivo semplice e schematico le «fasi del viaggio». L’idea che
vi sia una sorta di «sciamano» o perfetto insegnante dev’essere rigettata: dobbiamo
credere nella recovery come nella verità personale di ciascuno (2).
2 | È bene riflettere su come la recovery rischi di
diventare una definizione accattivante, usata per
creare l’illusione del cambiamento, e perciò una
bella favola, un’ideologia (o peggio una sorta di
religione), mentre i servizi psichiatrici restano
chiusi nei loro paradigmi. Una parola aggiunta
all’equivoco della riabilitazione, come riparazione dal danno iatrogeno operato dalle psichiatrie.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
47
Saper riconoscere la salute nella malattia
Se la guarigione avviene, si tratta della guarigione di un corpo ignaro di sé, dei propri
bisogni, delle proprie malattie e della propria salute, privato di ogni possibilità di
partecipare e lottare per ottenerla […]. Una cura diversa non può che muoversi in
questa direzione, offrendo una terapia che sia contemporaneamente stimolo a una
riappropriazione di sé e alla comprensione della misura in cui abbiamo incorporato
la logica che ci determina. Perché l’unica premessa a una possibilità di cura per la
malattia dell’uomo è un rapporto diverso, soggettivo, partecipato nella vita e, quindi,
nella malattia. Solo comprendendo che il valore dell’uomo – sano o malato – va oltre
il valore della salute e della malattia, si può capire come la malattia, al pari di ogni
altra contraddizione umana, può essere usata come strumento di appropriazione o
di alienazione da sé, quindi come strumento di liberazione o di dominio (3).
Ciò che è peculiare per gli esseri umani, diceva Franco Basaglia, è che la salute e la
malattia sono in una continua relazione e tensione dialettica. Saper riconoscere la
salute nella malattia: in questo senso «una psichiatria di vita e non di morte» deve
riconoscere la soggettività delle persone e aiutarle a scoprire un senso nella loro
esperienza. Aiutarle non solo a recuperare un nuovo senso della propria vita, ma
anche a chiedersi come si inscrive la malattia, come «crisi», nella propria storia e in
quale continuità si pone, invece di intenderla come una frattura, come alienazione
da se stessi.
Una persona con esperienza di disturbo psichico una volta ha detto: «La guarigione
non esiste, esiste il miglioramento della propria vita». Queste parole ci indicano
la strada da percorrere.
3 | Ongaro Basaglia F., Salute/malattia. Le parole
della medicina, Edizioni alpha beta Verlag, Me-
rano (Bz) 2012, pp. 66-76.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Il processo dialettico della recovery/guarigione non accade senza rimarcare una linea d’ombra, un chiaroscuro, in una totalità d’esperienza, dove c’è salute e malattia,
il cui fulcro è la possibilità di riappropriazione di entrambe da parte del soggetto.
Salute e malattia: parole importanti, pilastri concettuali che rimandano al celebre
testo di Franca Ongaro Basaglia: Salute/malattia. Le parole della medicina. In esso
l’autrice afferma che la clinica ha precluso la presenza partecipe della soggettività
del malato; e la malattia ha sostituito nella medicina la globalità sano-malato che
siamo, ovvero ha separato la malattia dalla vita e dall’ambiente. Dice:
48 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Izabel Marin
Se la prognosi
negativa è un mito
da sfatare
Gli elementi
fondamentali del
processo di recovery
Le pratiche della
psichiatria sono
ancora spesso ispirate
dal famigerato
«paradigma
kraepeliniano»,
secondo il quale la
schizofrenia è una
malattia cronica e la
prognosi è un
deterioramento
progressivo. In realtà,
già negli anni della
deistituzionalizzazione,
alcune importanti
ricerche hanno messo
in luce come la
cronicità e la prognosi
negativa siano miti da
sfatare. Ma è stato
soprattutto quando
hanno cominciato a
prendere parola i
diretti interessati che
si è compreso quanto
sia sbagliato
congelare le persone
nel ruolo di «malati».
Dai loro racconti i
servizi possono,
debbono imparare.
Il termine inglese recovery ricopre un’ampia gamma
di significati: per l’Oxford Dictionary spazia dal concetto di «riguadagnare possesso o controllo» a quello
di mettersi al sicuro per via legale, fino a definire «il
riprendersi» o «il riaversi», come quando si dice di
una persona che dopo uno svenimento «si è riavuta»
o dopo un’esperienza disabilitante «si è ripresa». In
questi casi, in inglese si usa dire che la persona ha avuto
una «recovery».
Quello che intendiamo oggi con recovery nel campo della salute mentale è un’idea di riappropriazione
in prima persona del processo che porta le persone
con un disturbo mentale severo ad attraversarlo e a
superarne le maggiori difficoltà esistenziali, sociali,
psichiche.
È un’idea emersa a partire dagli anni ’90, che si è poi
diffusa e consolidata nel primo decennio di questo
secolo, entrando in uso a pieno diritto nell’ambito della
salute mentale. Tant’è che si parla oggi di recovery da
un disturbo mentale grave con un valore programmatico che la distingue dalle nozioni più tradizionali,
come quella di «guarigione clinica».
* | I due articoli di Izabel Marin ospitati nell’«Inserto» riprendono e
rielaborano contenuti pubblicati nel volume Guarire si può, curato insieme a Silva Bon e pubblicato dall’editore alpha beta Verlag di Merano
nella collana «180. Archivio critico della salute mentale». Ringraziamo
l’autrice, l’editore e i direttori della collana (in particolare Peppe
Dell’Acqua) per la collaborazione nel produrre quest’inserto (NdR).
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
49
Gli studi epidemiologici di riferimento
L’attenzione al processo in prima persona e all’impegno del soggetto costituisce la
novità e la particolarità dell’idea corrente di recovery, ma è bene ricordare quale sia
stato il terreno preparatorio su cui si è innestata questa nuova prospettiva.
Di recovery in salute mentale, infatti, si parlava già prima che emergesse la declinazione attuale di tale concetto; basti ricordare la celebre ricerca di Richard Warner
(1991), intitolata Recovery from Schizophrenia e ormai considerata un classico. Ma in
cosa si distingue l’uso della parola recovery da parte di Warner, nella stagione delle
grandi ricerche epidemiologiche degli anni ’80, dal significato attuale del termine?
La differenza è che, allora, si parlava di «guarigione» dal punto di vista del ricercatore, cioè di un osservatore esterno che aveva il problema di definire in qualche
modo una «misura di esito», di outcome. E infatti si adottavano criteri – condivisi
tra i ricercatori – per definire la «funzionalità» di una persona o da un punto di
vista clinico («guarigione clinica», misurata in base alla scomparsa di certi sintomi)
o da un punto di vista sociale («guarigione sociale», secondo criteri occupazionali,
abitativi o di autosufficienza).
In ogni caso, la definizione di recovery in quel contesto era un problema del ricercatore (epidemiologo, clinico o sociologo che fosse). Cionondimeno quella stagione
di ricerca è stata molto importante come terreno preparatorio per il cambiamento
di mentalità che ci interessa. Le ricerche di quel periodo, infatti, come quelle di
Warner e Ciompi, Harding (1) , Strauss, Carpenter, sono state una specie di colpo di
grazia, dal punto di vista scientifico, all’idea di «cronicità» e/o di esito degenerativo
come destino associato alla diagnosi di schizofrenia.
La cronicità è un «artefatto sociale»
Si può dire, insomma, che il famigerato «paradigma kraepeliniano» – la concezione
della schizofrenia come malattia cronica per la quale la prognosi è un deterioramento progressivo – sia stato scientificamente affossato proprio in quegli anni.
Sempre nello stesso arco di tempo (seconda metà degli anni ’80), studiosi come
Ciompi e Harding hanno discusso l’idea di cronicità come «artefatto sociale» e
McGlashan ha potuto concludere, sulla base di una revisione selettiva dei più importanti studi di follow-up del periodo (gli studi sul decorso a lungo termine), che
«un gran numero di pazienti guarisce dalla schizofrenia» e che «la certezza della
prognosi negativa nella schizofrenia è un mito».
1 | Lo studio condotto da Harding è il più lungo
realizzato negli Stati Uniti. La ricerca è durata 32
anni e ha coinvolto 269 persone con disturbo psicotico severo, attraverso interviste periodiche nel
loro contesto di vita e nell’ambito dei programmi di riabilitazione. I ricercatori hanno trovato
che circa due terzi dei soggetti corrispondevano
ai criteri oggettivi della recovery (che sono: la
persona non assume farmaci, non presenta più
sintomi né comportamenti che potrebbero indicarla come «paziente con disturbo mentale»; la
persona lavora, ha buone capacità relazionali con
gli altri e non è ricoverata in ospedale psichiatrico) e/o del miglioramento significativo (per
cui le condizioni della persona rispettano tutti i
suddetti criteri di inclusione tranne uno).
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
La cronicità non è un destino
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
50 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Nella loro analisi della nozione di «cronicità», Harding e i suoi collaboratori (1987)
evidenziano la difficoltà di separare gli effetti residuali del disturbo mentale – ad
esempio i sintomi negativi come l’apatia o il ritiro sociale – da una miriade di fattori
ambientali e psicosociali, che vanno dagli effetti del processo di istituzionalizzazione
all’identificazione con il ruolo del malato, dal mancato accesso ai programmi di
riabilitazione alle ridotte opportunità economiche e sociali, dagli effetti collaterali
dei trattamenti farmacologici al ruolo delle aspettative sfavorevoli degli operatori.
Il pessimismo kraepeliniano continua a funzionare come una profezia che si autoavvera: la perdita della speranza costituisce il contesto esistenziale delle persone
con disturbo mentale.
Un concetto emerso sull’onda lunga della de-istituzionalizzazione
Non va dimenticato che questa apertura di possibilità positive in campo scientifico ha risentito del clima di apertura di possibilità pratiche legate ai processi di
de-istituzionalizzazione avviati in precedenza con la crisi del «paradigma dell’internamento».
Occorre inoltre sottolineare che, una volta che si sono aperte, tanto sul piano
scientifico quanto sul piano pratico, le possibilità di uscita dalla rassegnazione,
dalle stanze ammuffite e bloccate della «cronicità» e della istituzionalizzazione, il
problema inevitabilmente si è spostato.
Non si tratta più di un problema di ricerca o di osservazione esterna su un «esito»,
un outcome (per quanto sia importante anche questo aspetto). Non è più soltanto
un problema di cosa possano fare i soggetti di cura – i servizi, gli operatori – per
colmare di buoni interventi quegli spazi di possibilità positive (sebbene anche questo sia rilevante). Ma è un problema che investe chi diventa soggetto, protagonista
attivo e non ricettore, capace di muovere i passi necessari per sottrarsi al «mito»
della cronicità e della «prognosi negativa» per il disturbo mentale severo.
Ed è qui, su questo punto, che si innesta l’emergere dell’idea di recovery come
assunzione su di sé del percorso necessario per uscire dalla propria difficoltà, da
parte del soggetto che vive in prima persona l’esperienza del disturbo mentale.
L’esperienza personale è oggi la prima fonte degli studi sulla recovery
A dare impulso all’idea della recovery come visione (e prassi) trasformativa è stato
il movimento degli ex-utenti psichiatrici. La comparsa sulla scena sia di racconti
di esperienze vissute in prima persona, sia dell’organizzazione degli utenti (con la
costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto e di empowerment collettivo) ha inciso
fortemente su quella che oggi si può definire una pratica orientata alla recovery.
Quando si leggono gli scritti di una pioniera del movimento americano dei «sopravvissuti psichiatrici»(2) o ex utenti, come Judi Chamberlin, o di protagonisti
2 | Negli Stati Uniti il termine survivor (sopravvissuto) è stato utilizzato dal movimento degli ex
utenti psichiatrici per distinguerlo dai termini
«paziente» o «malato di mente», e connotarlo
con una valenza attiva e politicizzata nella lotta
contro lo stigma e gli effetti iatrogeni dell’istituzionalizzazione psichiatrica, di cui essi si sono
sentiti profondamente vittime.
nell’elaborazione e diffusione dell’idea di recovery come Patricia Deegan o Ron
Coleman, si percepisce la forza di persuasione di argomenti e analisi radicati nel
profondo dell’esperienza vissuta.
Così, la prima fonte della letteratura sulla recovery è oggi colui o colei che ha
attraversato dall’interno difficoltà mentali e ha trovato la strada per venirne fuori.
Sono le persone stesse che, avendo vissuto sulla propria pelle prima l’esperienza
della malattia e della istituzionalizzazione, poi l’esperienza del faticoso impegno
per uscirne, hanno cominciato a descrivere l’esperienza e a comunicarla agli altri.
D’altro canto, anche gli operatori che hanno cominciato a scrivere sul tema hanno
sottolineato la decisività dell’ascolto, da parte loro, delle testimonianze in prima
persona dei soggetti in recovery.
Cosa vuol dire essere in recovery?
La nozione di recovery da un disturbo mentale severo è diventata centrale in alcune esperienze innovative negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, influenzando un
cambiamento nella cultura dei servizi.
Un percorso di ridefinizione di sé
In un documento inglese di indirizzo programmatico degli anni ’90 si legge la
seguente definizione:
La recovery da un disturbo mentale severo si riferisce a un processo attivo, dinamico
e altamente individuale attraverso cui una persona assume la responsabilità della
propria vita e sviluppa uno specifico insieme di strategie rivolte non solo a fronteggiare i sintomi, ma anche le minacce secondarie della disabilità, che comprendono
stigma, discriminazione ed esclusione sociale. Un aspetto critico di tale processo è
(…) lo sviluppo di un senso di se stessi come «altro dall’essere disabile».
Questa definizione di recovery offre dunque due importanti indicazioni: da un
lato, i tentativi e le strategie per fronteggiare i sintomi e le difficoltà sono intesi
come modalità attive sviluppate dal soggetto; dall’altro, tali modalità attive sono
viste come parte di un più ampio insieme di abilità soggettive, dove il fuoco del
problema si sposta dai «sintomi» in quanto tali alla possibilità che la persona ha di
riappropriarsi di un’identità personale e sociale che vada oltre quella definita dal
ruolo di «malato mentale» o «disabile».
Per usare le parole di Patricia Deegan (1988), leader del Mental Health Consumer
Movement negli Stati Uniti, il processo di recovery non implica che le persone vengano «aggiustate», come si aggiusta una macchina; si tratta piuttosto di ristabilire
attivamente un nuovo modo di ridefinirsi come persone. Il percorso di ridefinizione
di sé è segnato da una nuova consapevolezza delle proprie condizioni, che non comporta il ripristino di quelle precedenti il disturbo, né tantomeno l’accettazione passiva
del disturbo e delle sue limitazioni. I racconti «dal di dentro» dell’esperienza della
sofferenza psichica indicano come sia possibile, nonostante il disturbo, riconquistare
una identità sociale significativa e riprendere in mano la propria vita.
51
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
52 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
«Io non sono guarita: io ho vinto»
In questo cambio di prospettiva, sono le persone stesse a poter giudicare meglio
l’estensione del loro processo di recovery. Per gli autori del movimento degli ex
utenti o survivors, la «disabilità» psichica è soltanto uno degli aspetti dell’intera
vita della persona. Nasce così l’espressione «essere in recovery» in riferimento alle
persone con una condizione di disturbo mentale severo e prolungato che hanno
superato del tutto o in parte gli effetti devastanti che ne conseguono, anche se non
sono completamente scomparse le manifestazioni sintomatiche.
William Anthony (1993), uno dei primi ricercatori nel campo della riabilitazione
psichiatrica a diffondere l’idea di recovery come valore programmatico per i servizi
di salute mentale, la definisce così:
La recovery è un modo soddisfacente di vivere la propria vita che comporta lo
sviluppo di nuovi significati e motivazioni, nel crescere come persona al di là degli
effetti catastrofici del disturbo mentale.
Questi effetti sono spesso di natura sociale e includono le barriere imposte da una
condizione di svantaggio e di stigma, che vanno dalla mancanza di accesso alle
opportunità, alla perdita di un ruolo socialmente valido, alla rottura dei legami
affettivi più significativi. Per Sally Clay, che lavora come «difensore» (advocate)
e sostenitrice del movimento degli ex utenti psichiatrici negli Stati Uniti, la lotta
contro lo stigma è un elemento caratterizzante del proprio percorso. Lo stigma,
scrive, non deve essere una vergogna per chi ne è segnato, ma un distintivo d’onore:
L’esperienza della follia è una ferita che ha cambiato la mia vita e mi ha permesso
di aiutare gli altri e di conoscere maggiormente me stessa. Sono orgogliosa di tali
risultati. Io non sono guarita: io ho vinto.
Il paradosso della guarigione nonostante il persistere della malattia
Molte persone con esperienza di recovery indicano che il maggiore guadagno che
hanno avuto nel loro processo di ripresa è stato quello di accettare il proprio disturbo e di incorporare la propria esperienza all’interno di un ridefinito senso di
sé. Emblematico è l’esempio riportato da Patricia Deegan, docente e ricercatrice
sul tema della recovery e dell’empowerment. Basandosi sulla propria esperienza
condivisa con altre persone, afferma (1988, p. 98):
Il nostro percorso di guarigione è profondamente segnato dall’accettazione delle
nostre limitazioni. Ma adesso, invece che essere disperati, troviamo nelle limitazioni
personali il terreno dal quale far nascere le nostre uniche possibilità. Questo è il
paradosso della guarigione: accettando quello che non possiamo fare o essere,
iniziamo a scoprire cosa possiamo fare e chi possiamo essere
Il ridefinirsi come persona implica la ridefinizione del problema mentale come parte
integrante della propria vita. Lo sviluppo di una nuova percezione di se stessi e di
una propria identità diventa uno degli aspetti chiave su cui verte tutto il processo
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
53
di guarigione. Il senso di sé è una componente fondamentale dell’essere umano
ed è caratterizzato dallo sforzo attivo che le persone compiono per far fronte agli
eventi e alle difficoltà, per sviluppare nuove competenze maturate dalla propria
esperienza e per vivere la propria vita in modo soddisfacente.
Se il disturbo mentale severo è stato descritto come «la malattia del sé», caratterizzata non soltanto da un profondo sconvolgimento cognitivo ed emotivo, ma
anche da una trasformazione della propria identità percepita interiormente da sé
ed esteriormente dagli altri (Estroff, 1989), nel processo di recovery la riscoperta
e la riconquista di un sé attivo costituisce uno dei passaggi necessari da compiere.
Alla base un nuovo senso di sé
In una ricerca che è stata una pietra miliare in questo campo, condotta da Davidson e
Strauss nel 1992 presso l’Università di Yale (in cui sono state intervistate 66 persone
con diagnosi di schizofrenia), si è sottolineata l’importanza della ricostruzione del
senso di sé nel processo di recovery da un disturbo mentale severo. Nell’articolo
a compendio dell’intera ricerca (Davidson, Strauss, 1992) gli autori riprendono la
nozione di «senso di sé» da un insieme di studi degli anni ’80 in diversi settori che
comprendono la psicologia medica, sociale e antropologica.
Queste ricerche suggeriscono, in particolare, che il senso di sé svolge una funzione
nel modo in cui si affrontano malattie somatiche, eventi di vita stressanti e depressione. Un rafforzato senso di sé può aiutare a migliorare vari aspetti del disturbo e
sostenere gli sforzi per fronteggiare e adattarsi a un contesto di malattie croniche
o di eventi di vita critici; in questi casi, la persona sente di poter realizzare qualcosa
(senso di autoefficacia), di avere un controllo sulle proprie emozioni (luogo interno
di controllo) e di avere stima di sé.
Ma se ciò è vero nel caso di patologie non psichiatriche, a maggior ragione diventa
imprescindibile esplorare questi elementi all’interno delle condizioni di interesse
psichiatrico, visto che «lo scenario del sé» è il luogo stesso della sofferenza mentale.
Gli autori sottolineano (ivi, p. 132):
Lungi dall’essere soltanto una nozione teoretica (...), il senso di sé si presenta come
la componente principale nell’esperienza quotidiana di chi soffre di un disturbo mentale grave. È una componente che le persone con questi disturbi spesso descrivono
come un fattore chiave nei processi di sviluppo del disturbo e del suo cambiamento.
Scoprire parti di sé non toccate dal disturbo
Un primo aspetto del senso di sé nel processo di guarigione riguarda il fatto che
la persona si rende conto di poter avere un senso attivo di sé anche se continua a
esperire una disfunzione dovuta al proprio disturbo. Per alcune persone ciò può
significare una riscoperta di parti di sé non toccate dal disturbo e che possono essere
quindi utilizzate indipendentemente da esso.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Il processo che porta alla riconquista di sé
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
54 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Questo graduale risveglio comporta un’intuitiva apertura, un rudimentale «avvertire se stessi». La traccia comune nelle varie esperienze è una nascente consapevolezza
di questi aspetti di se stessi finora sconosciuti, che può includere la sensazione di
poter fare qualcosa di più e di meglio di quello che si sta facendo. In questa scoperta
contano le piccole cose che accadono, come uscire dalla stanza dove si era rinchiusi
a causa della propria paura e dei sintomi, guardarsi intorno, accettare un aiuto da
parte delle persone «significative», come operatori, familiari, amici.
Tutto ciò è importante per rafforzare la fiducia nelle proprie potenzialità: una nuova
consapevolezza di sé come persona potenzialmente capace comporta il progressivo
sviluppo di un senso di speranza, che apre la strada alla sensazione di poter migliorare la propria condizione che accompagnerà poi l’intero processo di recovery.
Fare un inventario delle proprie forze e debolezze
Un secondo aspetto è il procedere a una sorta di inventario delle proprie forze e
delle proprie debolezze: «prendere le misure» di quello che si può o non si può
fare e sentirsi più sicuri nell’affrontare nuove situazioni che possono rappresentare
una sfida. Un inventario personale si può fare inizialmente a livello elementare,
immaginandosi in un’azione semplice («posso uscire dalla stanza e partecipare alla
riunione?»), fino a un livello più elevato di riflessione («posso riprendere a lavorare
a tempo pieno?»). Ciò può determinare l’inizio di un percorso in cui raffigurarsi
mentalmente il proprio futuro o il recupero di abilità dimenticate, come per esempio
riprendere in mano un progetto interrotto prima del disturbo. In questa situazione
la persona incomincia a fare le «provviste di forze» e si attrezza gradualmente con
gli «ingredienti necessari» per raggiungere i propri obiettivi, talvolta anche quelli
all’apparenza più semplici.
Questo aspetto del processo di recovery, che rappresenta la preparazione a un’azione successiva, può anche avere un periodo di evoluzione lenta: dalla consapevolezza
di poter essere una persona attiva alla realizzazione di un obiettivo desiderato. Il
punto critico è rappresentato dal sostegno degli altri, in quanto la persona è ancora
vulnerabile e ha bisogno di tempo, di essere compresa e sostenuta.
Esercitarsi nelle azioni e riflettere sui risultati ottenuti
A questo punto, il processo di riscoperta delle proprie capacità di riattivarsi comporta l’esercitarsi nelle azioni e il riflettere sui risultati ottenuti, incorporandoli
nelle azioni successive. La persona può scoprire di essere capace di prendersi
cura di sé e agire a proprio beneficio, smettendo di essere soltanto il «recettore»
della volontà altrui. Comincia a percepire di essere una persona capace di scopo,
azione e responsabilità mettendosi alla prova e svolgendo piccoli compiti che,
anche se all’apparenza semplici o ordinari, implicano la scoperta di abilità e di
aree di efficacia.
Sebbene il processo di scoperta di sé come persona più attiva e autonoma non
appaia stabile e costante nella vita di chi attraversa un disturbo mentale severo, i
piccoli successi agiscono a favore di una graduale costruzione di autonomia. Attraverso le esperienze di successo, la persona può scoprire di avere la capacità, anche
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
55
inaspettata, di allargare la propria rete di conoscenze, di condividere momenti di
socialità, di prendere iniziative che riguardano la propria vita.
Come negli altri aspetti sopra indicati, lo sviluppo di una nuova capacità di avvalersi
della propria esperienza serve come strumento prezioso per monitorare, governare
e compensare il disturbo nel proprio contesto sociale. Sentirsi più solidi perché
sostenuti dalla propria esperienza può avere la funzione di «rifugio» dal disturbo,
per evitare di stare nuovamente male, oppure può servire per combattere gli effetti
secondari come l’ansia, lo stress e lo stigma nel contesto sociale in cui si vive. Imparare dalla propria esperienza a distinguere se stessi dal disturbo porta a riconoscere
quelli che possono essere definiti i «segnali» (o i «campanelli di allarme») derivanti
dalla tensione e dai fattori di stress nello sforzo interattivo con gli altri.
Come nel campo delle malattie fisiche, il ruolo del senso di autoefficacia, del controllo sulle proprie emozioni e dell’autostima aiuta a combattere stati prolungati
di disturbi somatici e di eventi di vita stressanti, così anche per la persona con un
disturbo mentale severo l’autopercezione di essere capace di gestire l’ansia e lo
stress può contribuire ad aumentare le competenze nel prendere parte più attiva
nel proprio progetto di vita, nello sviluppare strategie quotidiane per fronteggiare
i problemi, nell’imparare a esercitare autocontrollo sui sintomi, incrementando le
proprie capacità di mantenere gli impegni nel contesto sociale e lavorativo.
Un cambio di atteggiamento
verso il proprio disturbo
John Strauss è stato uno dei primi ricercatori a sostenere la cruciale importanza
del ruolo attivo delle persone con un disturbo mentale severo nell’interagire e
influenzare il decorso del loro disturbo.
Non ci si considera più vittime impotenti della malattia
In un suo recente scritto (2008), Strauss sostiene che sta ancora cercando di rispondere alla domanda che gli aveva posto, quindici anni prima, una donna intervistata
per la sua ricerca: «Perché il medico non mi chiede mai cosa faccio «io» per aiutare
me stessa?», vale a dire perché si informa soltanto sui sintomi, il lavoro, le relazioni
sociali, il trattamento, senza chiederle mai quale sia il suo apporto personale nel far
fronte al problema? Ecco il commento di Strauss:
Questa donna ha sollevato la questione della soggettività. Non considera se stessa
una vittima impotente della malattia, né tanto meno un oggetto i cui sentimenti e
le cui azioni sono irrilevanti per il proprio percorso, sia nei momenti di crisi sia nel
processo di ripresa.
L’autodeterminazione e la volontà di stare meglio sono entrambi elementi nello
sviluppo di un senso di sé attivo e possono rappresentare un punto di svolta nel
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Imparare a conoscere e gestire le proprie risposte emotive
56 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
processo di recovery. Questi aspetti di se stessi, sostiene Strauss, possono essere
considerati come un cambiamento di atteggiamento verso il proprio disturbo: molte
persone «dopo un prolungato periodo di sofferenza non si sono semplicemente
rassegnate a dover convivere con un disturbo, ma desideravano costruirsi una vita
oltre e nonostante il proprio disturbo mentale».
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Si prende parte attiva alle decisioni che riguardano la propria salute
Nell’affrontare la questione del cambiamento nel modo di percepire se stessi in
rapporto alla propria vita, ai propri sintomi e alle proprie condizioni, Ron Coleman considera «la scelta» una delle pietre miliari dell’esperienza di guarigione.
Incrementare le decisioni che riguardano se stessi, assumere i rischi delle scelte
che si fanno sono aspetti di un atteggiamento propositivo nell’interazione con i
propri problemi, come pure nell’interazione con gli altri. Scrive Coleman (2001):
Dobbiamo avere fiducia nello smettere di essere malati per cominciare a essere in
guarigione. La strada della guarigione richiede non solo che facciamo le nostre scelte,
ma anche che prendiamo la responsabilità di tutte le nostre scelte, buone e cattive.
Affinché le persone possano avere controllo sulla propria vita, in modo da riguadagnare un ruolo propositivo ed efficace, tuttavia, devono essere fornite loro
opportunità di scelta e di contrattazione nel rapporto con i servizi e con le persone
coinvolte nel processo di aiuto. Parlando dell’utilizzo dei farmaci nel suo percorso
di recovery, Pat Deegan (2007) riassume così la sua visione delle cose: «l’esperto
medico» e «l’esperto cliente» sono entrambi seduti in una stanza e nessuna delle due
parti è meno importante dell’altra, devono condividere le informazioni in modo da
poter arrivare alla migliore decisione possibile sul trattamento da intraprendere.
Le persone devono quindi essere coinvolte in tutti gli aspetti della pianificazione,
dello sviluppo e dell’implementazione dei servizi che le riguardano, così come
devono essere coinvolte anche negli aspetti della vita sociale che esulano dal
trattamento e dalla riabilitazione. Solo questo coinvolgimento sostanziale può
portare a un empowerment e a un senso di controllo sul proprio ambiente e sulla
propria vita.
Il ruolo degli «altri significativi»
«La recovery è un’esperienza profondamente umana, facilitata dalle risposte profondamente umane degli altri», scrive William Anthony (1993). Se la comprensione
del ruolo svolto dalla persona è essenziale per comprendere il suo processo di
guarigione, è altrettanto fondamentale capire come gli altri possano avere un ruolo
rilevante in tale processo.
Il sé non esiste senza la convalida degli altri
Nelle diverse ricerche sulla recovery, la presenza degli «altri significativi» è un
denominatore comune per la capacità che essi hanno avuto di stimolare, sostenere
e mantenere una presenza costante, anche nei momenti più critici della vita delle
persone che stanno lottando per riprendersi: «Il sé non esiste senza la convalida
da parte degli altri», afferma Coleman.
Per le persone con esperienza di recovery i fattori decisivi dell’aiuto risultano essere il contenuto e la qualità percepita delle relazioni di vicinanza, sia per quanto
riguarda i familiari che gli amici. I familiari rappresentano talvolta l’unico contatto
sociale conservato dalla persona in grave difficoltà, che vive una condizione di
isolamento.
Il sostegno dei familiari, anche quando è difficile da riconoscere, può essere d’aiuto nel superare la resistenza alla socialità (per esempio, vincere la vergogna di
«essere diventate persone con una sofferenza mentale»), così come può essere utile
nel cercare di ristabilire un contatto scandito dai semplici gesti della quotidianità
ordinaria (anche se le circostanze non sono ordinarie).
Il supporto emotivo come fattore di svolta
Gli aspetti pratici, come base elementare del sostegno, vanno messi in relazione
con i significati emotivi della presenza dell’altro. Molte persone con esperienza di
recovery hanno sostenuto che la cosa più importante per loro nella relazione con
un parente, un operatore sociale o un amico è avvenuta quando «si sono sentite
prese sul serio» (Strauss, 2008).
In una prospettiva di reciprocità, il supporto emotivo viene a essere determinante
quando il familiare è stato capace di cambiare se stesso durante il processo di
recovery, sentendosi «maturare in qualche modo assieme» al proprio parente,
mettendosi direttamente in gioco, in un percorso di crescita che coinvolge entrambe le parti.
Sia dalla letteratura sulla riabilitazione psichiatrica, sia da quella sulle esperienze
vissute, risulta che uno dei «fattori di svolta» – tanto centrale quanto periferico –
nel processo di recovery sia stata la presenza di persone capaci di «trasmettere la
speranza». Saper trasmettere la speranza è quanto definisce la relazione di aiuto,
che si tratti di familiari, amici, operatori o pari.
Come racconta Patricia Deegan (1993, p. 97):
Potrei ricordarmi un momento specifico in cui una piccola e fragile fiamma di speranza e coraggio ha illuminato la nostra oscurità e la nostra disperazione. Anche
quando abbiamo ceduto, là stavano quelli che ci amavano e che non cedevano. Loro
non ci hanno mai abbandonato. (...) Il loro amore per noi è stato come un costante
invito, un richiamo a essere qualcosa di più della nostra autocommiserazione e
disperazione. Il miracolo è che gradualmente abbiamo incominciato a sentire e a
rispondere a questo amorevole invito.
L’efficacia dell’approccio del sostegno paritario
L’«altro significativo» è rappresentato spesso dalla figura del «pari» (peer support),
cioè dalle persone che hanno vissuto l’esperienza di un disturbo mentale e si sono
riprese o si stanno riprendendo, e offrono il loro aiuto, appunto paritario, attraverso
la testimonianza e la condivisione della propria esperienza.
57
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
58 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
L’efficacia dell’approccio del sostegno paritario passa attraverso l’esempio, che
rende presente e concreta la speranza di farcela. Le persone che raccontano di
questo aspetto dell’aiuto sottolineano come diventi molto difficile continuare a non
nutrire speranze quando si è circondati da altre persone ugualmente in difficoltà
che stanno facendo passi in avanti nel loro processo di guarigione.
Anche per Coleman (2001) la dimensione «condivisa» ha giocato un ruolo fondamentale nel proprio percorso, dal momento in cui è arrivato nel gruppo degli
uditori di voci:
Ho sentito valorizzato il mio sé. (...) Credo che il più grosso cambiamento che mi sia
capitato nel gruppo sia stato che ho smesso di essere Ron Coleman lo schizofrenico
e sono diventato Ron Coleman che sente le voci, e per quanto questo fosse solo
l’inizio del processo di guarigione, era già un buon inizio.
Gli operatori non come tecnici,
ma come alleati
Per quanto riguarda l’aiuto ricevuto dagli operatori di un servizio, nel racconto delle
persone con esperienza di recovery, è determinante l’attenzione ricevuta, genuina
e diversa rispetto a quella considerata convenzionale o formale, perché diretta alle
persone in quanto tali e non come «pazienti». Come sostiene Davidson (2003):
Il prendersi cura di qualcuno in modo genuino non è qualcosa che può essere
prescritto, richiede che l’operatore offra se stesso in un modo che non deriva
soltanto dalle sue responsabilità come operatore, ma è basato sul suo rendersi
conto dell’umanità comune di entrambe le persone. Sebbene questa distinzione
possa sembrare sfuggente o astratta, essa fa la differenza per chi si trova dal lato
di chi riceve l’aiuto.
Per Alain Topor (2006), l’operatore fa «qualcosa di diverso» rispetto al ruolo
atteso se stabilisce un rapporto di reciprocità e di condivisione di responsabilità e
di interessi comuni. Significa che l’operatore va oltre quello che può essere considerato il suo compito istituzionale, non si comporta secondo un copione atteso, o
secondo la solita routine formalizzata, bensì si mette in gioco sul piano personale
e fa conoscere aspetti di se stesso. In altre parole, gli operatori sono considerati
d’aiuto «quando costruiscono un rapporto positivo con la persona, un rapporto
spesso descritto come di amicizia».
In ogni caso, quel che sembra caratterizzare l’aiuto dell’altro nel percorso di guarigione di una persona è la possibilità di diventare un suo «alleato», che si tratti di
un pari o di un operatore.
Per spiegare il ruolo degli operatori nel gruppo di uditori di voci di cui fa parte,
Ron Coleman (2001) scrive:
Quando gli operatori conducono il gruppo, la cosa che cerco sempre di fargli comprendere è che loro sono «parte» del gruppo; se non sono uditori di voci, allora il
loro ruolo è di essere degli alleati. Non sono lì come tecnici, sono lì come alleati.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
59
Il ruolo delle risorse materiali e sociali
Nella letteratura recente, è stata sottolineata l’importanza dei fattori sociali e ambientali come facilitatori nei processi di recovery.
Come possono le persone riguadagnare potere sulla loro vita e un ruolo nella società, se non hanno adeguate possibilità materiali, risorse economiche e culturali
per ricostruire la propria identità sociale?
Come scrive Peppe Dell’Acqua (2013), per chi soffre di un disturbo mentale severo
è molto difficile soddisfare l’elenco dei «normalissimi bisogni» che tutti abbiamo:
avere un reddito o svolgere attività significative; avere una sistemazione abitativa;
lavorare con soddisfazione; essere parte della comunità; non essere discriminati;
dare senso alla propria esistenza.
I contesti sociali, nella misura in cui ostacolano l’accesso ai diritti di cittadinanza,
favoriscono il processo di interiorizzazione del ruolo di malato e la condivisione
dei pregiudizi della società. Di conseguenza, le persone diventano più isolate socialmente e più esposte allo stigma. Come afferma Deegan, riferendosi alla diagnosi
di schizofrenia ricevuta a 18 anni:
La mia identità era ridotta a una malattia agli occhi delle persone che si occupavano
di me. Era soltanto una questione di tempo perché incominciassi a interiorizzare
questa visione stigmatizzata e disumana di me stessa.
Il processo di identificazione nel ruolo del malato mentale è un processo sociale e
interpersonale: implica che una persona che «ha» un disturbo mentale finisce per
«diventare» il proprio disturbo.
Questa progressiva perdita di ruolo e di identità è segnalata come un cambiamento
significativo da molte persone che attraversano un prolungato periodo di malessere. Le persone cessano di lavorare, si ritirano dalle scuole, perdono contatti con
la famiglia e con gli amici. In questo modo perdono i loro ruoli sociali validi e le
identità accettabili che ne derivano. Talvolta, quello di paziente è uno dei pochi
ruoli che rimangono.
La centralità del lavoro nel percorso di recovery
Perciò, nel concettualizzare il processo di recovery, bisogna prestare attenzione
anche alla dimensione sociale del processo di ricostruzione materiale dei diritti di
cittadinanza. Essere disoccupato, non avere una casa, non avere una fonte minima
di reddito costituiscono evidenti ostacoli per le persone che stanno lottando per
riprendersi.
In questa prospettiva, il lavoro può essere considerato uno dei più importanti
fattori di facilitazione del processo di guarigione: costituisce una risorsa estremamente importante in quanto permette alla persona di uscire dallo status di malato
e di assistito. Il lavoro provvede non soltanto a un guadagno economico, ma offre
struttura e scopo, opportunità di socializzazione e di sviluppo di nuove relazioni
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Spesso le persone subiscono una perdita di ruolo e identità sociale
60 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
sociali, di valori e significati e di piena cittadinanza (3). Nel riguadagnare un senso
di appartenenza nella comunità, va anche sottolineata l’importanza degli impegni
delle persone nei «compiti di sviluppo sociale»: la lotta per fare fronte allo stigma
e alla discriminazione sociale, l’aiuto agli altri e il lavoro di volontariato, la partecipazione a gruppi di auto-aiuto e per lo sviluppo e il cambiamento delle politiche
in salute mentale sono attività altrettanto gratificanti e significative.
La guarigione come
processo dinamico e aperto
In quanto detto finora, è implicita una concezione della recovery come processo
aperto, complesso, che richiede del tempo. In contrasto con la dicotomia statica
guarito/non guarito, si delinea un’idea di recovery come processo che concerne
l’intera vita della persona.
La recovery è un processo, come la vita
Questa visione è stata sostenuta da un numero consistente di ricercatori, molti dei
quali con un’esperienza personale di disagio mentale. Per esempio Rae Unzicker,
nel suo resoconto autobiografico (1989), quando le chiedono che cosa le abbia
cambiato la vita, risponde:
Per me, e credo per molti altri, è raramente una sola cosa. La recovery è un processo,
così come lo è la vita.
Nella prospettiva delle persone che hanno attraversato l’esperienza del disturbo
mentale e di quanti hanno superato nel lungo periodo l’esperienza della istituzionalizzazione, la guarigione non è intesa quindi come un prodotto finale, ideale o
statico. Spesso è descritta come un’attitudine, un modo di vivere e di sentire, una
visione o un’esperienza, anziché un ritorno alla normalità o alla salute (Davidson,
2003). Questo modo di definire la recovery come un processo vitale e dinamico è
espresso frequentemente, nella letteratura del movimento degli ex utenti psichiatrici, con l’espressione essere in recovery piuttosto che essere recovered, cioè essere
guariti. Come sottolinea Patricia Deegan (1993), la recovery
è un processo non perfettamente lineare, a volte il nostro percorso è fatto di errori
e fallimenti, si scivola indietro, ci si riorganizza per ripartire da capo. L’obiettivo è
affrontare la sfida delle nostre difficoltà e stabilire un nuovo e rafforzato senso di
integrità e di scopo nella vita, all’interno e oltre i limiti del disturbo.
3 | Le opportunità di lavoro, di perseguire i propri interessi e disporre di denaro sufficiente per
invitare un amico a cena, ad esempio, possono
essere elementi di grande supporto. I movimenti
per la deistituzionalizzazione hanno sottolineato
l’importanza della restituzione dei diritti di citta-
dinanza e della costruzione di alternative nei contesti reali di vita delle persone. Perché quanto più
le persone hanno accesso ai diritti di cittadinanza,
tanto più possono ricostruire una identità sociale
e riguadagnare un ruolo nelle relazioni sociali.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
61
E, come la vita, può implicare passi avanti e ricadute
Secondo quanto afferma anche William Anthony (1993), parlare di processo dinamico e aperto offre un’immagine di costruzione continua, di percorsi basati su
una serie di passi progressivi che possono
Ma è nella concettualizzazione di Ron Coleman che l’idea di processo viene argomentata in modo più esplicito, quando l’autore propone la distinzione tra recovery
e mantenimento (maintenance). Con quest’ultimo termine Coleman si riferisce alla
pratica istituzionale della psichiatria, secondo cui l’esito migliore è visto come una
condizione sostanzialmente statica, in cui la preoccupazione del servizio non va
oltre la riduzione del rischio di «ricaduta» del paziente, «congelandolo» in tal modo
nel ruolo di malato. Al contrario, la recovery come processo dinamico comporta
lo sviluppo delle persone verso nuovi traguardi di appropriazione di sé e perciò
anche di riduzione della dipendenza dal servizio.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
•Anthony W., Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health
service system in the 1990s, in Cohen M. et al. (a cura di), Assessing and Developing
Readiness, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston 1993.
•Coleman R., Guarire dal male mentale, manifestolibri, Roma 2001.
•Davidson L., Strauss J., Sense of Self in Recovery from Severe Mental Illness, in «British
Journal of Medical Psychology», 65, 1992.
•Davidson L., Living Outside Mental Illness. Qualitative Studies of Recovery in Schizofrenia, New York University Press, New York 2003.
•Deegan P. E., Recovery: The lived experience of rehabilitation, in Cohen M. et al., op. cit.
•Deegan P. E., The Lived Experience of Using Psychiatric Medication in the Recovery
Process and a Shared Decision-Making Program to Support It, in «Psychiatric Rehabilitation Journal», 1, 2007.
•Dell’Acqua P., Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale per un
uso ottimistico delle cure e dei servizi, Feltrinelli, Milano 2013.
•Estroff S. E., Self, Identity, and Subjectivity Experiences of Schizofrenia. In Search of
the Subject, in «Schizofrenia Bulletin», 2, 1989.
•Harding C. M., Zubin J., Strauss J. S., Chronicity in Schizofrenia: Fact, Partial Fact,
or Artifact?, in «Hospital and Community Psichiatry», 5, 1987.
•Strauss J., Prognosis in Schizophrenia and the Role of Subjectivity, in «Schizofrenia
Bulletin», 2, 2008.
•Topor A., Others: The Role of Family, Friends, and Professionals in the Recovery
Process, in «American Journal of Psychiatric Rehabilitation», 9, 2006.
•Unzicker R., On My Own: A Personal Journey through Madness and Re-emergence,
in «Psychosocial Rehabilitation Journal», 1, 1989.
•Warner R., Schizofrenia e guarigione. Psichiatria ed economia politica, Feltrinelli,
Milano 1991.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
implicare crescita e ricaduta, periodi di veloci e di lenti cambiamenti. Mentre la
tendenza può essere verso l’alto, l’esperienza del giorno per giorno non è sempre
direzionata. Intensi sentimenti possono sopraffare improvvisamente, così come
momenti di introspezione o periodi di crescita possono accadere inaspettatamente.
Il processo di recovery è tutt’altro che sistematico e pianificato.
62 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Manuela Ciambellini, Anita Eusebi,
Luca Negrogno, Fabrizio Starace
La cittadinanza
è ancora
terapeutica
L’esperienza
del Social point
a Modena
Da Basaglia in poi
abbiamo imparato a
vedere le persone che
vivono il dolore della
mente come persone e
non come diagnosi,
come malattia.
Persone che
faticosamente
guadagnano margini, a
poco a poco più ampi,
di libertà. Libertà
intesa come
possibilità di godere di
diritti, di esprimere
bisogni, di alimentare
desideri, di scoprire i
propri sentimenti, in
una parola di vivere.
Questa libertà è il
singolare prodotto di
quella stagione ed è
quanto di più salutare
si possa immaginare.
«La libertà è
terapeutica», si diceva
allora. Oggi potremmo
dire che lo è «la
cittadinanza», la parola
che meglio esprime
l'idea di recovery.
Nella vita quotidiana delle persone con disagio psichico, dei loro familiari e degli operatori che lavorano
per la salute mentale di comunità, temi come il lavoro, l’abitare, la qualità delle relazioni di vicinato e del
«capitale sociale» assumono un ruolo fondamentale
nel determinare un migliore decorso della malattia
mentale.
A sua volta, il conseguimento di prognosi positive per
la persona ha effetti trasformativi sull’immagine collettiva della malattia e della persona con disabilità, non
più considerata un peso, ma una potenziale risorsa.
È quindi indispensabile costruire progetti di cittadinanza, orientati alla recovery e al miglioramento della
qualità della vita. Come Social point.
Un progetto
d’inclusione nella comunità
Attivo a Modena dal 2006, Social point è un progetto
nato dall’iniziativa delle realtà del terzo settore, attualmente finanziato dal Dipartimento di salute mentale e
dipendenze patologiche (Dsm-Dp) dell’Azienda Usl
di Modena (dopo un periodo di sperimentazione quadriennale, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena). L’Ausl ne ha assegnato la gestione al
Consorzio di solidarietà sociale, in partnership con il
Centro servizi del volontariato, l’associazione di familiari e amici di pazienti psichiatrici «Insieme a Noi»,
l’associazione di utenti «Idee in circolo» e l’Arci. Inizialmente operativo solo nei
comuni di Modena, Sassuolo e Castelfranco, dall’aprile 2012 è stato esteso a tutti
i Distretti della provincia.
Nella fase di avvio l’obiettivo era creare proposte di socializzazione e tempo libero
per gli utenti dei servizi di salute mentale la cui condizione non consentiva percorsi
riabilitativi di tipo occupazionale, in modo da alleggerire il carico assistenziale dei
centri diurni e delle famiglie. Negli anni successivi, Social point si è confrontato a
tutto tondo sulla salute mentale come tema che riguarda non solo pochi «addetti
ai lavori» o qualche utente e i suoi familiari, ma tutti i cittadini. Il progetto si è così
sviluppato su tre livelli di intervento:
• facilitazione dell’inclusione sociale di persone con disagio psichico tramite attività
di volontariato e tempo libero, mirando a valorizzare risorse individuali e collettive
in modo che l’identità non sia monopolizzata dall’esperienza di malattia;
• sensibilizzazione, formazione e informazione del territorio sui temi legati alla
salute mentale;
• diffusione di un’idea positiva di salute mentale come oggetto di responsabilità
collettiva e creatrice di capitale sociale per il territorio.
Se dunque inizialmente il progetto rispondeva al bisogno di una riduzione del «carico», in una seconda fase si è diffusa la cultura per cui il tempo libero e la cittadinanza
attiva sono opportunità da offrire alla popolazione che accede ai servizi di salute
mentale, indipendentemente da quanto i singoli pesino sui servizi e sulle famiglie.
Da utenti dei servizi a volontari del territorio
Parallelamente a questa presa di consapevolezza da parte degli operatori, è stata
necessaria una riflessione sulle modalità di lavoro sia con gli utenti che con il territorio. La prassi insegna che, se gli operatori del servizio vogliono lavorare in ottica
di empowerment e recovery, sono inevitabilmente indotti a rivedere il modello
operativo.
L’evoluzione del modello di lavoro ha riguardato innanzitutto gli obiettivi condivisi
con gli utenti. Il cittadino con disagio psichico che arriva al servizio Social point
è chiamato a riflettere – insieme agli operatori – sui propri interessi, su ciò che gli
piace fare, sugli ambiti in cui sente di avere più esperienza.
In un primo incontro si valuta l’interesse a partecipare alle attività proposte dalle
realtà del territorio; quindi si procede all’attivazione della rete di soggetti dell’associazionismo presente in modo capillare nella comunità (circoli, polisportive,
associazioni di volontariato anche non direttamente interessate ai temi della salute
mentale), verificando la possibilità di inserimento di nuovi volontari.
In termini di finalità, viene facilitato un processo di empowerment, costruendo con
l’utente una proposta di impegno attivo del tempo libero e valorizzando la scelta e la
responsabilità individuale.
Gli operatori favoriscono momenti in cui l’utente «mette tra parentesi» la propria
situazione critica (che lo definisce in maniera univoca come soggetto di bisogno e
oggetto di cure) e arricchisce la propria autorappresentazione attraverso momenti
63
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
64 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
di libero sviluppo di attitudini personali creative, in un contesto paritario e di
«normalità».
Contemporaneamente, l’operatore lavora per promuovere e radicare nel territorio
e nei servizi in rete un pensiero diffuso volto a valorizzare il sapere e le risorse, e non
solo a evidenziare i problemi dei cittadini con disagio psichico. È fondamentale –
in queste occasioni di incontro con le realtà del territorio – parlare di «guarigione
possibile» e di «miglioramento della qualità di vita». Obiettivi – questi – che il
lavoro degli operatori di Social point mostra essere concretamente raggiungibili.
Se infatti ci si prende cura dei contesti relazionali in cui le persone vengono inserite,
si osserva come emergano da parte loro particolari abilità, risorse, capacità attive e
propositive. Ciò fa sì che anche gli utenti portatori delle condizioni patologiche più
gravi possano trarre grande beneficio, oltre che dalla realizzazione di progetti riabilitativi individuali, dal mutamento di percezione che il contesto sociale ha di loro.
Il lavoro con la rete delle risorse territoriali
L’operatore di Social point è chiamato quindi a intervenire sulla facilitazione di
processi piuttosto che sulla creazione di singoli progetti, come accadeva prevalentemente in precedenza. Centrale diventa in questo senso il lavoro con la rete delle
risorse territoriali.
Aiutare le associazioni ad accogliere le persone con disagio psichico
Un primo tema su cui ci si è concentrati nel lavoro con le risorse territoriali è stato
l’accoglienza del disagio. Dai volontari delle organizzazioni aderenti emergeva la
richiesta di approfondimento e sostegno.
In questa fase, in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato, si sono
svolti interventi formativi finalizzati alla decostruzione degli stereotipi sul disagio
e a valorizzare la persona inserita in attività di volontariato.
Le associazioni di volontariato, superati i timori iniziali, hanno mostrato un significativo miglioramento delle modalità relazionali e di accoglienza. Si è reso evidente
come le esperienze di cittadinanza attiva degli utenti abbiano permesso di costruire
una competenza sul disagio psichico che diviene poi patrimonio del territorio e si
restituisce alla comunità come capitale sociale permanente.
Questo crea una risorsa che il mondo del volontariato impiega per la propria
mission: coltivare le proprie competenze relazionali permette infatti di essere più
efficaci nel costruire comunità solidali e coese. Spesso, gli inserimenti di persone
con disagio, in virtù dell’incremento di riflessività che richiedono sulle modalità
comunicative dell’organizzazione, finiscono per aumentare lo «stato di salute»
dell’organizzazione di volontariato stessa.
Emerge così la doppia finalità del lavoro di Social point: da un lato realizzare
l’empowerment della persona con disagio psichico costruendo insieme a lei, con
la massima personalizzazione possibile, una proposta di impegno attivo del tempo;
dall’altro restituire consapevolezza al territorio della responsabilità condivisa nei
confronti della salute della comunità.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
65
La funzione di «facilitatore di spazi relazionali» reali è diventata sempre più determinante nel qualificare la prassi operativa di Social point. Pur partendo da invii da
parte dei Centri di salute mentale (Csm) – cui storicamente è affidato un mandato
volto a evidenziare le «carenze» dell’utente, il dis-funzionamento, la dis-abilità –
l’operatore di Social point lavora secondo un diverso approccio, volto a valorizzare
le capacità invece delle disabilità delle persone e a lasciare spazio a ciascuno per
esprimere scelte e responsabilità (1).
Questo cambio di approccio è avvenuto gradualmente da parte degli operatori
di Social point. E quando è stato condiviso con gli operatori dei servizi di salute
mentale nei tavoli di coordinamento (dove si definiscono le modalità di erogazione
del servizio e si determinano le caratteristiche dei soggetti beneficiari, cioè si «oggettiva» il bisogno su cui si interviene) si è presentata talvolta una certa difficoltà
di comunicazione.
In ambito psichiatrico è ancora diffusa una considerazione delle attività di socializzazione come strumenti per riempire il tempo di utenti dei centri diurni o come
alternative a inserimenti lavorativi non praticabili. Una sorta di «intrattenimento»,
così come efficacemente descritto da Benedetto Saraceno (2). Ma quest’ottica è sempre più stridente rispetto a una metodologia globale di progettualità sociosanitaria,
coerente con i principi dell’empowerment e della recovery.
Inoltre in alcuni operatori dei servizi era presente l’idea secondo cui alcuni utenti,
caratterizzati da un funzionamento troppo compromesso, non avrebbero mai potuto fruire delle possibilità offerte da Social point, «poco protette» perché realizzate
sul territorio e non nei centri, e troppo «difficili» perché esposte alla partecipazione
di «normali» cittadini, portatori di aspettative troppo alte rispetto alle «social
skills» delle persone con disagio. Considerazioni e valutazioni che segnalavano,
da un lato, una resistenza culturale e organizzativa al processo innovativo in corso,
dall’altro una modalità assistenziale che rischiava di cristallizzare gli utenti ai livelli
di disabilità associati alla malattia, anche quando la malattia era in remissione.
Certo è innegabile che alcune attività, che richiedono oggettivamente particolari
caratteristiche per essere svolte, risultano inadatte per alcune persone. Nondimeno
anche persone dalle abilità sociali gravemente compromesse hanno evidenziato gli
effetti positivi dello sviluppo di una soggettività costruita sulle proprie risorse e sulla
propria partecipazione attiva. Questo non ha invalidato le valutazioni tecniche e
mediche sul funzionamento delle persone, ma le ha corredate di altre importanti
considerazioni e prospettive (3).
1 | Il Dsm-Dp di Modena ha incluso il Progetto
Social point in un più ampio programma di orientamento dei servizi alla recovery e di acquisizione e applicazione dei principi dell’International
Classification of Functioning.
2 | Saraceno B., La fine dell’intrattenimento. Manuale di riabilitazione psichiatrica, Etas, Milano
1995.
3 | Anche alcuni inserimenti in progetti collettivi
molto «difficili» per competenze richieste hanno
ottenuto effetti inaspettati con persone segnate
da diagnosi funzionali gravi, considerate «senza
speranza» dagli operatori più «conservatori».
Significativa in tal senso l’esperienza di emancipazione delle persone collocate in soluzioni
abitative nell'ambito «Progetto residenze».
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Promuovere una diversa concezione del tempo libero
66 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Tutti chiamati in causa come persone
In un percorso orientato a sostenere l’accesso ai diritti di cittadinanza attiva da
parte dei cittadini con disagio psichico, è cruciale che questi possano riappropriarsi dell’esperienza che vivono, riconoscendosi soggetti e non semplicemente
utenti del percorso.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Oltre lo stigma dell’identità di utente
Ciò costituisce una sfida assolutamente critica per la persona con disagio poiché,
già nella costruzione sociale della propria «malattia», entrano in gioco elementi
che definiscono in maniera asimmetrica la sua relazione con il contesto circostante,
che sia familiare o di cura.
L’«identità» di utente porta con sé una carica stigmatizzante della quale il mondo
della malattia mentale è inevitabilmente permeato: per questo, sul piano culturale, non ci si può esimere dall’affrontare le rappresentazioni collettive della salute
mentale e della malattia.
In Social point, lontano dalle abitudini «istituzionalizzanti» che si sviluppano nei
setting assistenziali di salute mentale tradizionali, le persone con disagio, indipendentemente dal loro «livello di funzionamento» e dalle loro etichette diagnostiche,
sono stimolate e guidate nella realizzazione di finalità concrete e «vere», utili e positive, condivise da altri cittadini che partecipano a tali attività. In questi contesti tutti
sono chiamati in causa in quanto «persone», al di là di una loro eventuale malattia.
E ciascuno, in quanto consapevole della propria esperienza e di un proprio sapere,
può contribuire a innescare un processo di cambiamento culturale.
Da utenti a soci: nasce «Idee in circolo»
In linea con queste premesse, si è sempre più accentuata, negli anni, la consapevolezza da parte degli operatori di Social point che il lavoro di sensibilizzazione,
promozione, formazione e informazione del territorio non poteva più fare a meno
del coinvolgimento diretto degli utenti, in particolare di quelli definiti «esperti»,
ossia di coloro che hanno attraversato l’esperienza di malattia e sono ora in grado
di metterla a disposizione della comunità.
Così, nel 2011, si è deciso di costituire l’associazione «Idee in circolo», fondata e
gestita da cittadini in maggior parte con disagio psichico, per promuovere assieme
a chiunque abbia voglia di collaborare una cultura di inclusione e cittadinanza
attiva nel territorio modenese. La decisione è maturata sulla base delle assemblee
periodiche di un gruppo di lavoro, denominato «Le parole ritrovate» (4) , composto
da utenti, operatori, volontari, familiari.
Le assemblee sono state il luogo in cui, forse per la prima volta, utenti del servizio
4 | Nel 2009 Social point è entrato nel movimento
«Le Parole ritrovate», nato a Trento nel 1993 con
l’idea che «non si tratta semplicemente di dare la
parola a chi non l’ha sinora avuta, si tratta piuttosto di ritrovare assieme le parole». Dal 2009
Social point partecipa ai coordinamenti nazionali
e agli incontri annuali, organizzando a Modena
assemblee e convegni (www.leparoleritrovate.
com).
di salute mentale hanno sentito di poter pubblicamente e liberamente esprimere
le proprie esperienze in maniera incisiva e determinante per gli altri. E la grande
carica del movimento è cresciuta man mano che sono aumentate le occasioni di
confronto: sapere che l’apporto di ciascuno modifica sensibilmente il risultato del
lavoro di gruppo ha costituito un importante elemento di spinta per mettersi in
gioco personalmente.
Il confronto di gruppo ha provocato inoltre un’apertura e una consapevolezza del
peso delle proprie parole che risulta essere una novità dirompente nell’esperienza
di alcuni degli utenti coinvolti: le parole assumono «un peso specifico», per alcuni
mai provato.
Potenza delle assemblee: si ritrova insieme la voce
La dimensione assembleare e paritaria, come metodologia, influisce positivamente
sul livello di stigma esterno e internalizzato, e dunque sulla capacità dei cittadini
con disagio psichico di riappropriarsi di un proprio progetto di vita complessivo.
Il confronto collettivo (5) permette infatti di sottrarre il «sintomo» all’oggettivazione
tecnica e di ricostruirne il senso in un percorso di vita collettivamente dotato di
significato, condiviso, dialettizzato dalla lettura e dall’ascolto comune, alla pari.
Le esperienze personali, una volta raccontate e messe in circolo, diventano vettori
di consapevolezze collettive nuove, che vanno a «scomporre» gli oggetti costruiti
dalle istituzioni.
Accanto a questi momenti assembleari, gli operatori di Social point hanno cercato di
facilitare anche l’avvio di alcuni gruppi di auto mutuo aiuto, con l’idea di formare, nel
tempo, utenti facilitatori. Il metodo di base, definito del «fareassieme», costituisce
una forza trasformatrice perché permette a ciascuno di realizzare quella partecipazione responsabile al lavoro collettivo e di aprire la propria visuale sull’altro come
persona da accogliere con la propria esperienza.
Il recupero di una contrattualità sociale
Questo approccio rende protagonisti i soggetti coinvolti ed evita la riduzione degli
utenti e della loro sofferenza a semplici «oggetti» nelle mani delle pratiche assistenziali. Di qui è maturata la consapevolezza sempre che il lungo e difficile percorso
della cura verso la guarigione (recovery) non passa solo attraverso la presa in carico
da parte dei servizi, ma anche attraverso il recupero di un proprio ruolo sociale.
L’azione sul contesto sociale e culturale di riferimento, che vede proprio i soggetti
«esclusi» come protagonisti attivi, dotati di contrattualità sociale e impegnati a
svolgere vari livelli di interlocuzione per realizzare iniziative di promozione della
5 | Nelle assemblee – sempre aperte a tutti e
sempre in cerchio per potersi reciprocamente
ascoltare – il confronto verte su temi scelti dalle
persone, dentro un filo rosso che per il 2015 è
«resistere». Nelle assemblee si dà voce alle storie delle persone, alle loro emozioni e forme di
espressione, alle loro angosce e disperazioni, ma
anche alle loro speranze e guarigioni possibili.
Il confronto collettivo permette di distruggere
l’infinita serie di pregiudizi e incomprensioni con
cui si tende a svuotare di animo le esperienze di
vita di chi attraversa la sofferenza psichica. Smarcandosi dal destino che l’etichetta di «persona
con malattia mentale» disegna per molti.
67
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
68 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
propria condizione, è allora un’azione importante che ricolloca i soggetti deboli
in una chiara posizione di cittadinanza attiva.
Il protagonismo di cui si è fatta e si continua a fare concretamente esperienza nelle
assemblee diventa stimolo costante alla rivendicazione di una posizione di rilievo
nei confronti di tutta la cittadinanza e di un ruolo di sensibilizzazione nei confronti
della comunità. Nelle riflessioni collettive, l’attenzione passa così dalla malattia
alle condizioni sociali, culturali ed economiche che favoriscono l’emarginazione e
l’isolamento: diventa progressivamente chiaro a molti che lo sforzo per la riappropriazione della propria salute passa per un esercizio collettivo di organizzazione e
di sensibilizzazione volto ad aumentare la coscienza comune.
Su questo terreno germogliano le iniziative pubbliche e si sviluppano le progettualità rivolte alla comunità, in cui gli utenti iniziano a esprimersi pubblicamente,
portando il punto di vista dei cittadini che usufruiscono dei servizi di salute mentale.
Per una settimana in città
si parla di salute mentale
Significativo, da questo di vista, il progetto «Màt - Settimana della salute mentale»,
promossa dal Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl
di Modena dal 2011 è collocata a cadenza annuale nella seconda metà di ottobre.
Si tratta di una settimana di dibattiti, conferenze, eventi artistici e culturali aperti
a tutta la cittadinanza, dislocati in diverse aree di Modena e della provincia, per
sensibilizzare il territorio sui temi della salute mentale e implementare la lotta al
pregiudizio e allo stigma che gravano su chi soffre di disagio psichico.
La costruzione partecipata dell’iniziativa
L’evento si svolge sulla base di un percorso di progettazione partecipata, in collaborazione con le associazioni Idee in circolo e Insieme a Noi, e vede il coinvolgimento
di partner istituzionali e di un’ampia rete di soggetti dell’associazionismo di utenti,
familiari e operatori dei servizi di salute mentale, del volontariato, del privato sociale
e imprenditoriale, della scuola e dell’università, delle fondazioni.
La prima edizione ha visto per la prima volta operatori del servizio di salute mentale
e volontari delle associazioni collaborare fianco a fianco nelle fasi di ideazione,
progettazione e realizzazione dell’iniziativa. L’edizione successiva ha registrato la
definizione di una vera e propria convenzione tra il Dipartimento di salute mentale
e le associazioni di utenti e familiari al fine di sviluppare un percorso partecipativo
finalizzato alla costruzione «comunitaria» dell’evento, secondo una formula organizzativa via via più strutturata e organica.
L’iniziativa si pone come forma di «innovazione sociale» di grande importanza
per il territorio: si tratta di un percorso di costruzione partecipata che ha stimolato empowerment organizzativo nel Dipartimento di salute mentale e promosso
processi di integrazione tra i servizi pubblici e i soggetti del territorio a vario titolo
interessati al tema della salute mentale nei suoi aspetti tecnici, scientifici, politicosociali, artistici e culturali.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
69
La Settimana rientra tra gli strumenti messi in campo per intervenire innanzitutto
sulle rappresentazioni negative e stigmatizzanti della malattia mentale e delle persone che ne soffrono. La malattia mentale, di fronte agli utenti e ai familiari che si
organizzano per promuovere eventi culturali e di sensibilizzazione, smette di essere
un tabù per la comunità. Il disagio diviene piuttosto una condizione attraversabile,
«che può colpire tutti» (6), dalla quale si può uscire facendo affidamento sulle risorse
tecnico-professionali e solidaristiche presenti sul territorio.
Màt costituisce un’occasione per sperimentare e mostrare pubblicamente la possibilità di percorsi di «empowerment» per le persone seguite dai servizi. È il momento
culminante in cui assumono visibilità i progetti personalizzati di inclusione sociale
e i progetti collettivi di cittadinanza attiva, rivolti a utenti, che quotidianamente
arricchiscono il lavoro clinico e terapeutico dei servizi di salute mentale, conferendogli ampiezza di respiro e di prospettiva.
Più in generale, l’iniziativa si colloca all’interno di un’azione che va così a modificare
la rappresentazione sociale dei disturbi mentali e l’espressione stessa della domanda
di salute mentale da parte della popolazione.
Si delineano nuove politiche di salute mentale
Dal lavoro si è sviluppata una nuova consapevolezza delle pratiche rivolte all’inclusione di individui e gruppi in condizioni di esclusione sociale. È emersa una
modalità nuova di rilevazione dei bisogni e di confronto pubblico sulle politiche di
salute mentale, in cui il dialogo tra erogatori e utenti delle prestazioni risulta decisivo
per la costruzione di politiche pubbliche più incisive e orientate alla promozione
dell’inclusione sociale delle persone con disagio.
Dall’analisi condivisa dei bisogni è emerso infatti che l’articolazione tradizionale
dei servizi terapeutici e riabilitativi non è ancora sufficientemente orientata a una
reale «ri-contrattualizzazione» delle persone con disagio (ossia a sostenere la loro
contrattualità) e queste spesso, anche anni dopo gli episodi più acuti, continuano a
restare «a carico» delle famiglie o comunque «cronicizzate» in situazioni segnate da
impossibilità di esercitare diritti di cittadinanza, da difficile accesso alle opportunità
del territorio, da scarso capitale sociale, da esclusione dal mercato del lavoro, da
poca disponibilità di beni e di risorse durevoli, da condizioni gravi di esclusione
sull’asse della casa e del lavoro.
Insomma, per le persone trattate dai servizi psichiatrici c’è ancora il rischio che si
prospettino traiettorie esistenziali fatte di cronicità, esclusione sociale, povertà, in
una «spirale del disagio» che finisce spesso per inghiottire la maggior parte delle
famiglie.
La Settimana, ma più ancora il lungo processo che porta alla sua costruzione, ha
dunque anche l’obiettivo di incidere sui decisori pubblici. Mostrando che le poli6 | In effetti in questi anni nel territorio modenese vi è stato un incremento costante del numero
di cittadini trattati dai servizi di salute mentale
(fonte, Relazione annuale, Dipartimento salute
mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di
Modena).
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
La malattia mentale smette di essere tabù
70 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
tiche più adatte per affrontare la malattia mentale non sono l’istituzionalizzazione
e la moltiplicazione di posti letto in istituzioni pubbliche o private, o residenze
«protette» in cui collocare gli utenti per tutta la vita, bensì la creazione di luoghi,
opportunità e competenze di inclusione sociale.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
I segni di un nuovo welfare
La Settimana costituisce il laboratorio e la sintesi degli elementi di innovazione e
cambiamento culturale che il Dipartimento di salute mentale ha condotto negli
ultimi anni.
Màt è il prodotto concreto di quei principi di «sussidiarietà orizzontale e verticale»
che dovrebbero caratterizzare il nuovo volto dei sistemi di welfare; sistemi capaci
di superare impostazioni tradizionalmente (e sempre più insostenibilmente) assistenzialistiche e di implementare forme di partecipazione orientate alla promozione
attiva del benessere collettivo. Il passaggio cioè da prestazioni «sanitarizzanti» a
prestazioni indirizzate alla progettazione di comunità, alla creazione di prodotti
relazionali e sociali, è il futuro cui allude questa sperimentazione.
L’impatto sulla riduzione dello stigma e sul cambiamento culturale nella comunità è perseguito a partire dal metodo ideativo, progettuale e organizzativo degli
eventi, secondo cui utenti, volontari e familiari delle associazioni hanno assunto
una posizione di protagonismo e insieme di collaborazione con gli operatori del
Dipartimento di salute mentale.
Per i servizi si tratta di un modello di lavoro nuovo: coloro che ricevono prestazioni
non sono più solo fruitori passivi, consumatori di prestazioni e determinanti di costi
per l’amministrazione pubblica, ma divengono essi stessi promotori di processi,
collaboratori dei servizi, figure di mediazione tra i professionisti e i cittadini che
portano al servizio la loro domanda di salute.
L’impostazione di tale percorso di costruzione partecipata ha dovuto confrontarsi
con gli inevitabili aspetti inerziali espressi da alcuni segmenti delle istituzioni, ma
ha condotto allo sviluppo di una nuova forma di riflessione condivisa sui bisogni
espressi e sulle prassi attraverso cui si erogano i servizi sanitari, di interlocuzione
con chi direttamente fruisce di tali servizi, con setting e finalità diverse da quelle
tradizionali della «cura», e la conseguente riformulazione della relazione tra tecnici
e utenti.
Sempre più i servizi che vogliano rispondere ai nuovi bisogni di salute mentale
dovranno essere accessibili a tutti, non evocare il timore associato all’immagine
stereotipata del «paziente psichiatrico» socialmente escluso e pericoloso. La sperimentazione dei progetti di inclusione sociale sviluppati «dal basso», dalle associazioni di utenti e familiari, ha mostrato che un approccio non fondato sulla disabilità
ma sulla valorizzazione della libertà di scelta e del recupero della contrattualità
sociale riduce significativamente il livello di esclusione e attiva percorsi innovativi
di socializzazione. È questo l’orizzonte verso cui incamminarsi.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
71
Progettare
servizi orientati
alla recovery
Come i servizi
possono favorire
la «ripresa di sé»
Le persone con
disturbi mentali anche
gravi raccontano come
sempre, persino nei
momenti più bui,
permanga comunque
una parte di sé che
resiste alla malattia,
che cerca i modi per
contenerne gli effetti
catastrofici, che prova
a ricercare nuove
possibilità di vita.
Questi racconti
offrono indispensabili
indicazioni ai servizi,
che sempre più
devono saper
accompagnare il
viaggio che le persone
compiono per
costruirsi una vita
dentro e oltre la
sofferenza. Orientarsi
alla recovery significa,
per un servizio,
consentire ai soggetti
di negoziare la propria
cura, includersi nella
società, abitare
identità differenti.
C’è ancora molto da imparare sui processi di recovery e sui servizi orientati a sostenere le persone in tali
processi. Tuttavia, in questi anni abbiamo iniziato a
capire meglio che cosa favorisce e che cosa ostacola
il possibile cambiamento nella vita delle persone, in
particolare rispetto alla pratica dei servizi di salute
mentale.
Se infatti da una parte le persone devono attingere alle
proprie personali risorse per determinare un miglioramento della propria condizione, dall’altra un servizio
consapevole di quali siano gli strumenti più utili da
offrire faciliterà e renderà più rapida la loro ripresa.
Pertanto ci focalizzeremo ora sui fattori relazionali
e sociali che sono apparsi più rilevanti nel contesto
triestino, tenendo conto del ruolo che hanno avuto
i servizi (1).
Il riferimento, oltre all’esperienza pratica dei servizi di
salute mentale, è alle ricerche condotte in questi anni
sulla recovery, basate sull’ascolto delle persone con
esperienze di sofferenza mentale (2).
1 | Nel patrimonio di esperienze della deistituzionalizzazione a Trieste – dalla chiusura dell’ospedale psichiatrico in poi – si possono
ritrovare alcuni prerequisiti per il funzionamento di un servizio
territoriale orientato ai processi di ripresa e di guarigione.
2 | Nella rubrica «I diari degli operatori» di questo numero sono
riportati alcuni stralci di storie di persone in recovery. Per una lettura
più ampia e articolata si rimanda al volume Guarire si può. Persone e
disturbo mentale (Edizioni alpha beta Verlag, Merano 2013), curato
da Izabel Marin e Silva Bon (NdR).
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Izabel Marin
72 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Assumere un’altra idea
di guarigione
Nella definizione che i soggetti intervistati danno della propria recovery è determinante l’aspetto processuale, che la caratterizza come «un cammino di ricerca e di
costruzione ancora aperto», «un processo lungo, doloroso, e possibile».
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Non più il contrario di malattia
Le persone si percepiscono nettamente migliorate rispetto a una condizione iniziale
di perdita di sé, si ritrovano con una capacità nuova di vivere la propria realtà e le
relazioni sociali.
Tra i significati che assume la recovery c’è quindi la capacità di controllo sulle
crisi – e perciò dei sintomi – in un processo in cui si impara a «convivere con una
debolezza». La guarigione non è più contrapposta a uno stato di «malattia». La
ridefinizione di se stessi come persone, di cui il disturbo mentale è semplicemente
una parte, può essere inteso come uno degli aspetti più profondi della recovery.
Quello che accomuna tutte le testimonianze raccolte è il ruolo del servizio di salute
mentale nel sostenere e nello stimolare gli sforzi personali verso un processo di
cambiamento della propria condizione. Dai racconti emerge che il servizio ha avuto
un importante ruolo come promotore di processi ri-abilitativi, di empowerment,
di svolte significative per la ripresa.
I punti di svolta sono associati spesso a eventi di natura sociale: incontri significativi con altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza, ma anche con un
operatore, uno psichiatra, un amico. Oppure sono legati a fattori strutturali, per
esempio aver trovato un lavoro soddisfacente o aver ripreso un ruolo lavorativo
abbandonato con la comparsa del disturbo, avere una casa per sé o essere tornati
a vivere in famiglia.
Guarire è stare bene nel sociale
È altrettanto importante osservare quanto sia rilevante la dimensione sociale della
recovery in tutti gli aspetti che riguardano la ricostituzione di uno stato di benessere
psichico. La recovery non avviene nella solitudine: è un processo intersoggettivo in
continuo cambiamento. È nel contesto sociale che la dimensione più strettamente
soggettiva si convalida e diventa sostanziale.
Come viene rilevato da recenti ricerche in questo ambito, i contesti comunitari sono
ambiti di potenziale sviluppo della partecipazione attiva che fanno guadagnare
senso di appartenenza, diventando quindi fattori di recovery. I contesti di «rete»
e di «comunità» rappresentano supporti sociali fondamentali dove sentirsi inclusi,
accettati, agenti attivi e cittadini.
Per la maggior parte delle persone, la ricostruzione di una rete sociale avviene, in
un primo tempo, a partire dal Centro di salute mentale (Csm): per alcuni, la rete di
conoscenze si allarga poi effettivamente al di fuori del contesto del servizio, mentre
altri hanno ancora bisogno di usufruire del suo supporto.
La dimensione sociale acquista significato in relazione al ruolo dei servizi nella
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
73
misura in cui essi riescono a sostenere le persone nel loro contesto di vita, sia
nell’attivare l’aiuto della propria rete di persone significative, sia nell’attrarre risorse
umane e materiali per la creazione di opportunità sociali miranti all’inserimento
in contesti di normalità (3).
Il primo contatto con un servizio psichiatrico è descritto dalla maggior parte degli
intervistati come un’esperienza drammatica, perché strettamente connessa alla
presenza di pregiudizi per i luoghi di cura, spesso percepiti come stigmatizzanti.
La persona sembra andare incontro a una sorta di catastrofe personale prima di
accettare un aiuto.
Questa esperienza, che può significare «varcare una soglia» e sancisce il proprio
timore di essere pazzi, pone il servizio di fronte al bisogno di attrezzarsi per accogliere la domanda di aiuto in cui la costruzione di un rapporto di fiducia, necessario
a stabilire un’alleanza terapeutica, è l’elemento essenziale.
In tal senso, un servizio orientato al dialogo e all’ascolto «va incontro» alla persona
avvicinandosi concretamente ai suoi bisogni e la considera come soggetto attivo e
corresponsabile nel trattamento, che passa attraverso una corretta informazione e
una negoziazione su programmi e scelte terapeutiche da intraprendere.
I luoghi del contatto, nell’andare «verso la persona», sono i suoi luoghi di vita:
l’abitazione, il quartiere, il posto di lavoro; i contenuti della presa in carico sono
l’insieme di soggettività, rapporti sociali, condizioni materiali di vita (4).
Nel momento in cui la persona entra in contatto con il servizio di salute mentale,
nonostante la drammaticità del vissuto di mancata speranza e di isolamento sociale in cui si trova, si apre nei suoi confronti una nuova costellazione di risposte
necessarie per cominciare a ricomporre i tasselli della propria storia e a infrangere
«il muro nella comunicazione con il mondo».
Questo spiraglio rappresenta spesso un punto di svolta nella propria condizione. Se
il momento drammatico è caratterizzato dall’isolamento, la guarigione incomincia
nella riscoperta della possibilità di comunicare.
Favorire l’accettazione del disturbo
In relazione allo stigma percepito nei confronti dei luoghi di cura, man mano che
si sviluppano possibilità concrete e condivise sul piano dell’aiuto la drammaticità
dell’impatto si attenua. Si deve anche tener conto del fatto che, nel linguaggio in uso
3 | Il ruolo dei servizi di salute mentale in relazione alla dimensione sociale della recovery è
sottolineato in un documento importante, curato
da Larry Davidson e colleghi: A Practical Guide
to Recovery-Oriented Practice. Tools for Transforming Mental Health Care, Oxford University Press, Oxford 2008. Il documento individua
principi guida per la pratica dei servizi orientati
alla recovery.
4 | Cfr. Dell’Acqua P., Mezzina R., Risposta alla
crisi. Strategie ed intenzionalità dell’intervento nel
servizio psichiatrico territoriale, in «Per la salute
mentale», 1, 1988.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Attrezzarsi per accogliere la domanda di aiuto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
74 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
nei servizi triestini, non ha un ruolo determinante quello che da Basaglia in poi si è
chiamato «etichettamento» diagnostico. Ciò vuol dire che il problema dello stigma
non è strettamente associato all’ «etichetta» clinica sovrapposta alla singola persona.
La situazione è diversa pertanto da quella prospettata nella tradizione anglosassone discussa dalla labeling theory. In quel caso, l’autostima della persona dipende
dall’accettazione o dal rifiuto della diagnosi in quanto etichetta clinica: tra i soggetti
che accettano l’etichettamento (diagnosi) si verifica una bassa autostima; per contro,
nei soggetti che rifiutano la diagnosi del disturbo mentale grave, sono riscontrabili
livelli più alti di autostima e maggiore indifferenza ai livelli dello stigma (5).
Se invece non prevale lo stigma «da etichettamento» diagnostico, la percezione
della persona presa in carico può focalizzarsi sulle limitazioni concrete che il disturbo pone alla propria autostima e sulle difficoltà relazionali che possono essere
affrontate nell’interazione con operatori che non hanno bisogno della tipica distanza
difensiva rappresentata dall’etichettamento diagnostico.
Questo non vuol dire che le persone non possano scontrarsi con il rischio di invalidazione o discriminazione che anche all’interno di questo rapporto si genera.
Tuttavia, il contesto più dialettico e diretto – non mediato dalla «distanza» diagnostica – permette che l’accettazione e la consapevolezza del disturbo e dei limiti
a esso correlati aumentino in qualche misura la capacità di autodeterminazione
e il senso di autocontrollo, nel riconoscimento e nella gestione delle difficoltà sul
piano della funzionalità sociale.
Ricollocare la persona in una
dimensione intersoggettiva e di opportunità
Un esempio di attenuazione dell’impatto con il servizio è dato dall’esperienza di
Matteo, che per un periodo lavora come centralinista presso il Csm che lo ha in
carico. Quell’esperienza a Matteo è servita per «sdrammatizzare il muro contro
muro», dal momento che lui stesso diventa parte del servizio.
La nuova prospettiva permette di rompere e scardinare la resistenza tradotta nella
polarità semplificata «psichiatra contro malato». Matteo rivendica la sua collocazione di «malato lontano dal credo psichiatrico», e tuttavia quella vicinanza attutisce
il suo impatto con l’istituzione:
Col tempo, iniziando a conoscerli, ho visto che sono meno fermi in questa loro
convinzione, e lentamente anch’io ho attenuato i miei pregiudizi nei confronti della
psichiatria.
Non per questo Matteo è meno critico rispetto ai suoi diritti e ai suoi problemi. Non
per questo tutti devono lavorare come centralinisti in un Centro di salute mentale.
5 | Warner R. et al., Acceptance of the Mental Illness Label by Psychotic Patients. Effects on Functio-
ning, in «American Journal of Orthopsychiatry»,
3, 1989.
Le risposte del servizio, oltre al supporto medico farmacologico (6), vanno nella
direzione dell’offerta di aiuti materiali, di mezzi e strumenti, di contesti e occasioni
di aggregazione e di socializzazione, posti in connessione tra luoghi, attività e persone significative. Questi aspetti dell’aiuto, che determinano in parte il processo
di ricostruzione di un «ritorno alla vita», sono mirati a ricollocare la persona in
una dimensione intersoggettiva e di opportunità in cui compiere un percorso di
riappropriazione di sé. Significano ritrovare un senso della possibilità di riavere
ruoli e competenze sociali: per esempio aiuto nella ricerca o nel mantenimento di
un lavoro, utilizzo del sussidio economico finalizzato alla formazione, supporto
giuridico per la tutela della genitorialità.
Il servizio, nell’attivare e attrarre risorse materiali, umane e sociali, vuole offrire
opportunità che la persona può cogliere e utilizzare, in una sorta di «attraversamento» personale che la stessa fa del servizio, in cui alcune risorse vengono «apprese»
e utilizzate nel proprio percorso, e altre no. Attraversare il servizio può significare
provare a fare un inventario personale delle proprie forze e delle proprie debolezze
che, come affermano Davidson e Strauss (7), costituisce uno degli aspetti principali
dello sviluppo del senso di sé: «prendere le misure» di quello che si può o non si
può realizzare, per sentirsi più sicuri nell’affrontare nuove situazioni che possono
rappresentare una sfida.
Sostenere le reti sociali informali
Circa il ruolo delle persone significative nel processo di recovery, è importante
considerare i vari e diversi livelli di supporto della rete sociale. La chiave per comprendere il ruolo dell’altro sembra essere la qualità e l’intensità della relazione.
Se parliamo della rete sociale estesa, la sua importanza va considerata in quanto
«potenzialità» di rapporti e possibilità di scambio che la persona riconosce come
un valore in particolari momenti di bisogno.
Ma la rete sociale ampia non è necessariamente una garanzia di supporto sociale.
Il supporto dell’altro significativo spesso avviene all’interno di una relazione che
ha componenti di intimità, spontaneità, durevolezza. Quando, all’interno di una
rete, qualcuno viene considerato come persona significativa, si potrebbe dire che
6 | In relazione all’utilizzo degli psicofarmaci come
supporto al percorso di ripresa, è importante conoscere, dal punto di vista delle persone, se e come
sono stati utili per il loro miglioramento. Quello
che risulta importante dai racconti è il modo in cui
l’utilizzo dello psicofarmaco diventa una risorsa terapeutica: quando viene indicato come strumento
di consapevolezza sul proprio percorso; quando
esiste la possibilità di scegliere e decidere assieme
al medico il dosaggio o la sospensione a seconda
del bisogno; quando l’assunzione permette di avere una qualità di vita soddisfacente. Il racconto
di Nina riassume tutte queste caratteristiche: «I
farmaci di per sé, se non vengono usati bene o se
vengono usati come unico aiuto, servono a ben
poco. Però inseriti in un percorso di psicoterapia, o in un rapporto positivo con lo psichiatra,
sono fondamentali, perché ti danno la possibilità
di riuscire a fermarti e riprendere quel minimo di
lucidità che serve per uscire dalla crisi. Quando
uno non capisce assolutamente niente, ha delle
allucinazioni, non può vivere la comprensione».
7 | Sono concetti sviluppati nel mio precedente articolo contenuto in quest’«Inserto»: Se la prognosi
negativa è un mito da sfatare.
75
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
76 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
si è stabilita una relazione di confidenza, considerata come fattore di protezione
della salute mentale.
Dai racconti emergono alcune figure che presentano tali caratteristiche relazionali:
l’amica di Nina «che c’è e ci sarà sempre», il padre di Nicola e quello di Anna, come
figure che offrono protezione e allo stesso tempo sono capaci di cambiare il proprio
atteggiamento, creando situazioni di confidenza, di «intimità» e di «calore». Anche
gli operatori sono menzionati quando riescono a stabilire una relazione autentica
con la persona all’interno di un complesso di risposte ai bisogni, producendo, a
partire dalla relazione, uno scatto nella situazione circostante.
Dalle capacità del servizio di innescare percorsi di inclusione sociale emersi dai
racconti e, in generale, dalle esperienze delle persone in recovery che troviamo
nelle pubblicazioni, si comprende la chiara necessità di continuare a sostenere le
reti sociali informali e di rendere centrale lo sviluppo dell’empowerment di chi
usufruisce o ha usufruito di un servizio.
Promuovere gruppi di condivisione
Nelle relazioni interne alla dimensione del servizio, per alcune persone è stato
importante partecipare a momenti di interazione e di scambio informale, piccoli
gruppi spontanei o facilitati dalla presenza attiva degli operatori. Questo contesto
di accoglienza e di reciprocità permette alla persona di riaprirsi gradualmente, di
guardarsi attorno, di misurarsi con gli altri attraverso il confronto e il dialogo, di
riattivarsi come soggetto.
I momenti di incontro quotidiano possono svilupparsi nell’organizzazione di piccoli
gruppi di auto-aiuto, dove poter condividere le proprie esperienze e trovare percorsi
comuni per far fronte ai problemi. Le risorse che il servizio mette a disposizione per
promuovere aggregazione e socializzazione sono state apprezzate quando hanno
permesso ad alcune persone di sviluppare nuove conoscenze e amicizie, e di conseguenza maturare relazioni che esulano dal contesto stesso del servizio.
I gruppi talvolta possono diventare risorse sociali importanti per le persone in alcuni
momenti del loro processo di recovery; possono inoltre svilupparsi in forme più
organizzate di supporto tra pari.
Queste reti informali di sostegno reciproco nascono, si allargano, si differenziano
e nell’evoluzione di questo processo includono e si fanno attraversare da chi ha
bisogno di fare un percorso collettivo, di acquisire potere. I club di volontariato, i
gruppi sportivi e culturali, e in particolar modo il gruppo di volontariato di donne
hanno avuto un’importante risonanza per le persone: hanno significato ritrovarsi in
una dimensione di accettazione e di condivisione di «orizzonti comuni» favorevoli
alla ridefinizione di sé.
Supportare la rete familiare
Quanto agli interventi relativi alla rete familiare, essi possono essere incisivi fin dai
primi contatti con le diverse situazioni.
Il contributo dei familiari è fondamentale per la ricostruzione della storia di vita
del loro parente in quanto conoscono il «prima» del disturbo e possono aiutarlo
a ricostruire un «dopo», il loro futuro.
Anche se sostenere i propri cari può rappresentare un’esperienza positiva, l’impatto
in termini di gravosità, soggettiva e oggettiva, è molto alto. In User Empowerment
in Mental Health, documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2010,
è stato rilevato che il 95% dei carers sono familiari, di cui l’82% donne (per il 90%
madri). Il 29% dei carers familiari è impegnato nelle attività di supporto per più
di cinquanta ore settimanali.
I familiari hanno dunque bisogno di sostegno, di informazioni condivise e di affidabilità. Il familiare può essere orientato all’inserimento in specifici programmi di
supporto, come nel caso del gruppo di familiari di persone con disturbo mentale
severo. Questi programmi possono essere utili, innanzitutto, per permettere di
uscire da un isolamento della propria situazione e per con-dividere problemi in
comune con gli altri familiari. In tal senso, l’aiuto alla famiglia va nella direzione di
un orientamento psico-educativo, per favorire uno sviluppo di adeguate strategie
per far fronte ai problemi, che permettano loro di poter avere:
• una migliore gestione dello stress relativo ai momenti di marcata difficoltà del
proprio parente;
• un aumento della consapevolezza e del controllo sulle proprie capacità di dare
risposte e sulle proprie emozioni;
• una riflessione sul proprio stile di vita e di relazione;
• la possibilità anche di prendere distanza da quei problemi che non sono capaci
di risolvere da soli.
Il lavoro di supporto ai familiari di persone considerate ad alto carico è strutturato,
oltre che da colloqui e consulenze, attraverso un programma di formazione e di
riflessione a carattere psico-educativo, svolto in gruppo. Ogni anno il Dsm di Trieste,
oltre a curare la pubblicazione di manuali e opuscoli informativi, organizza due
corsi di formazione per circa venti familiari di persone con una storia più lunga di
disturbo mentale, che durano ognuno dieci incontri con cadenza settimanale. Da
circa dieci anni almeno una volta all’anno si organizza un corso di formazione e
sostegno anche per familiari di persone all’esordio.
In particolare, nell’intervento con i familiari va considerato come specifico tema di
intervento lo stigma connesso al disturbo mentale, per due motivi fondamentali:
in primo luogo perché lo stigma può essere percepito dalla persona all’interno del
proprio nucleo familiare, e in secondo luogo perché la famiglia può diventare protagonista nella lotta allo stigma e alla discriminazione, includendo la partecipazione
e la promozione di attività orientate a modificare i pregiudizi e affermare il pieno
diritto all’inclusione sociale dei propri parenti nella comunità.
Per una Carta dei servizi orientati alla recovery
In conclusione, desideriamo riportare l’esito di un lavoro che ha coinvolto – in un
confronto ripetuto nel tempo – diversi soggetti che partecipano alla vita dei quattro
77
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
78 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Centri di salute mentale del Dsm di Trieste: utenti, operatori, familiari e volontari.
Risultato del lavoro è stata nel 2014 la realizzazione di un testo intitolato Carta della
Recovery. I servizi di salute mentale e la guarigione (8).
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Uno strumento per ripensare i servizi nel movimento della società
La Carta della Recovery vuol essere «un nuovo strumento dei servizi di salute
mentale che si rinnovano, per rispondere alle nuove domande delle persone e alla
realtà che si trasforma». Appare infatti necessario ripensare ai servizi di salute
mentale nel movimento di una società in continua trasformazione. Servono una
nuova creatività e capacità di progettare, di agire.
I ruoli e i bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie si sono
modificati nel tempo, grazie anche alle forme di associazionismo di utenti e familiari.
Domande di aiuto più esplicite e chiare e la consapevolezza dell’importanza di
tutelare i propri diritti sono effetti del cambiamento. Il protagonismo di persone e
famiglie è parte integrante della complessità di un servizio orientato alla guarigione,
e arricchisce l’offerta delle risposte che esso può dare. I servizi devono essere capaci
di aiutare le persone ad attivare e utilizzare le risorse individuali e quelle esterne
per conquistare uno stato di salute generale. Il tal senso, la guarigione diventa un
diritto e acquista una dimensione sociale e politica.
Occorrono allora servizi, e i cittadini devono rivendicarli laddove essi non esistono
o sono inefficienti, che garantiscano un’accoglienza e un percorso di cura adeguati, relazioni di aiuto fondate sulla reciprocità, risorse economiche per favorire
inserimenti nella società, politiche sociali e culturali che contrastino lo stigma e la
discriminazione, il pregiudizio tuttora dominante che l’individuo sofferente di un
disturbo mentale sia «pericoloso», «incomprensibile», «inguaribile», «improduttivo» e «irresponsabile». È questa la dimensione sociale del concetto di recovery.
Una Carta nata dal desiderio di diffondere salute mentale
La Carta della Recovery nasce per essere uno strumento applicato dai servizi che
si rinnovano a fronte di una maturazione delle persone conquistata nel tempo, che
è pure maturazione delle domande, e delle risposte.
Nasce dai racconti delle persone le cui esperienze fanno capire che cosa aiuta e
che cosa ostacola il processo di ripresa. Nasce dal fatto che nel tempo le persone
siano riuscite ad assumersi delle responsabilità, a ricavare degli spazi di confronto
riconosciuti, affrontando sfide come l’organizzazione del convegno annuale «Impazzire si può». Nasce dall’incontro con persone provenienti da altri paesi dove si
parla di empowerment e di recovery non da ieri. Nasce dalla suggestione di creare
un documento che si completi con le idee di molti e che possa servire a tutti.
8 | La Carta della Recovery è frutto di una ricerca
partecipata iniziata nel 2011 quando a Trieste si
imbastiva la seconda edizione del convegno annuale «Impazzire si può - viaggio nelle guarigioni
possibili», condotta da un gruppo composto da
esperti per esperienza ed esperti per professione.
Nel 2013 i contenuti della Carta sono stati discussi
e validati in un percorso di formazione congiunta nei quattro centri di salute mentale triestini,
prendendo a modello il metodo del focus group,
con la partecipazione di circa cento persone, per
la maggior parte fruitori dei servizi.
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
79
Le dodici caratteristiche di un servizio orientato alla recovery
La Carta individua in dodici punti chiave le caratteristiche del servizio orientato
alla recovery, ripercorrendo e riassumendo in modo efficace diversi argomenti di
cui si è trattato poco sopra.
1. | I servizi centrati sulla persona Il servizio di salute mentale orientato alla recovery privilegia la soggettività della persona (utente) e interviene utilizzando un
ampio ventaglio di risposte personalizzate. Il progetto personalizzato che mira a
un cambiamento importante deve essere un «vestito tagliato su misura», che fa
suoi i bisogni, i valori, le preferenze della persona. Condivisione del percorso e
assunzione della responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti sono punti di
forza del progetto. I servizi devono attrezzarsi per mettere in campo le necessarie
risorse materiali, umane e relazionali affinché ogni decisione utile al processo di
emancipazione della persona sia condivisa.
2. | L’accoglienza Il servizio di salute mentale orientato alla recovery si interroga
quotidianamente sui luoghi, i modi, i gesti, le parole, i significati dell’accoglienza.
Accogliere è aprire una porta, materiale o simbolica, e farlo in maniera accogliente è
far sentire chi entra il benvenuto, in un posto ospitale, dove possa essere a suo agio.
3. | La crisi e la ripresa Il servizio di salute mentale orientato alla recovery è attrezzato
per affrontare la crisi, quel momento quando la persona è sicura di non farcela.
Fronteggiare la crisi è offrire accoglienza, vicinanza, ascolto, condivisione, aiuto
farmacologico accompagnando la persona fino alla ripresa. È far sentire che ci si
può appoggiare, che non si è soli, che è possibile uscirne.
4. | La formazione per tutti Il servizio di salute mentale orientato alla recovery investe
nella formazione e la promuove. La formazione per tutti i soggetti coinvolti nei
servizi intreccia i saperi e le pratiche, da quelli professionali acquisiti dagli operatori
a quelli risultanti dall’esperienza diretta delle persone che hanno provato il disagio
mentale. È necessario inserire nell’agenda della formazione per gli operatori dei
moduli formativi che prevedano la partecipazione di «persone con esperienza»
in veste di docenti, per condividere i saperi (sulle leggi, sui diritti, sulla comunicazione, sull’accoglienza, sulla valutazione dei servizi). L’operatore deve inoltre
poter accedere a un tipo di formazione che lo stimoli ad ascoltare la persona senza
determinarne i bisogni a priori, a usare parole che portino rispetto e non infantilizzino, e a investire passione e amore nel proprio lavoro. È necessario creare e
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
Nasce da questo periodo complicato nel mondo che cambia velocemente e che
porta via cose conquistate in tanti anni, con passione e fatica. Nasce dal desiderio di
conoscere le realtà del nostro Paese dove le leggi per la salute mentale sono applicate
in maniera disomogenea, determinando divergenze nelle pratiche a volte molto
marcate. Nasce dal desiderio che la salute, compresa la salute mentale, rimanga
pubblica, gratuita e per tutti.
Nasce per poter domandare che cosa pensano della guarigione anche ai più difficili,
i ribelli, i riottosi, che non stanno poi così «meglio», i disperati.
80 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
finanziare corsi formativi specifici per le persone con disagio mentale. In questo
modo il sapere e gli strumenti tecnici rafforzano le conoscenze acquisite attraverso
l’esperienza diretta, e si può creare una vera e propria professionalità.
5. | L’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale Il servizio di salute mentale orientato
alla recovery sostiene e promuove una cultura del lavoro vero, qualificato e remunerato, e dell’inclusione sociale. Le offerte lavorative per le persone che sono inserite
in percorsi di formazione/lavoro devono ampliarsi e poter soddisfare le diverse
capacità individuali. Il lavoro va quindi ulteriormente diversificato. Bisogna liberarsi
dal preconcetto che le persone fragili siano destinate a svolgere lavori semplici.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario educare i potenziali datori di lavoro
all’importanza di promuovere una cultura di inclusione all’interno del sistema lavorativo. Solo rinunciando a preconcetti stigmatizzanti il datore di lavoro è capace
di scegliere bene anche per se stesso. Per le persone che attraversano l’esperienza
del disagio mentale, inclusione sociale significa anche assumere un ruolo attivo
rispetto agli strumenti e alle risorse necessarie a ricostruire una propria identità
sociale e un senso di appartenenza e partecipazione alla vita della comunità, al di
fuori dal contesto dei servizi di salute mentale.
6. | Lo stigma e l’oppressione interiore Il servizio di salute mentale orientato alla
recovery deve saper contrastare situazioni in cui prevale lo stigma e il pregiudizio.
Il pregiudizio sul disturbo mentale – e lo stigma che ne deriva – rimane un fenomeno devastante nella vita delle persone che stanno affrontando questo disagio.
È talmente radicato nella società e nel modo di vedere e percepire le persone con
problemi mentali, che le stesse lo interiorizzano come se fosse reale, convivendo
con una sorta di oppressione interiore. I servizi devono perciò sviluppare una
cultura della fragilità come risorsa, investendo nella formazione degli operatori,
creando opportunità reali di inserimento nel lavoro e nella comunità, diffondendo
la speranza che dal disturbo mentale si può guarire.
7. | La rete sociale e le persone significative Il servizio di salute mentale orientato
alla recovery deve essere capace di sollecitare la formazione di una rete di persone
significative attorno alla persona con disagio mentale, favorendo così la ricostruzione dei legami sociali. Supportare le persone nello sviluppare relazioni di fiducia
e renderle in grado di recuperare il senso di appartenenza a una comunità, deve
essere uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dal servizio. Gli operatori di un
servizio di salute mentale sono parte integrante della rete sociale degli utenti. L’attenzione offerta deve essere genuina e differire da quella considerata convenzionale
o formale. Gli operatori sono di aiuto quando non danno risposte automatiche e
predefinite, ma cercano di conoscere le persone, di venir loro incontro. I familiari
vanno supportati come parte integrante del processo di ricostruzione di capacità
relazionali e di aiuto genuino. L’importanza della dimensione collettiva del reciproco aiuto è ampiamente riscontrata nella letteratura sulla recovery. L’amicizia è parte
di questa dimensione: occuparsi di qualcuno è il primo passo verso una relazione
di reciprocità. Avere una relazione di amicizia, passare del tempo assieme, dedicare
Animazione Sociale marzo | 2015 inserto |
81
8. | Il sostegno tra pari Il servizio di salute mentale orientato alla recovery deve
offrire spazi di ascolto e di accoglienza dove le persone che frequentano i servizi
quotidianamente, e quelle che vi sono accolte temporaneamente, possano sentirsi
a proprio agio e aprirsi al dialogo, recuperando la volontà di partecipare alla vita
di gruppo. Le persone con esperienza di disagio mentale possono collaborare con
i servizi in qualità di «facilitatori», mettendo a disposizione le proprie conoscenze
e i saperi acquisiti al fine di aiutare chi sta compiendo i primi passi verso la guarigione. Il supporto tra pari (peer work) non si sostituisce, ma si affianca al servizio.
Si agevola così la costruzione di un ponte comunicante tra la persona e il servizio,
tra il dentro e il fuori, per tramite di un linguaggio più immediato e condiviso
nella pratica. I gruppi di auto mutuo aiuto sono spesso fondamentali nel processo
di guarigione. Permettono alle persone di imparare a raccontarsi, confrontarsi e
condividere le proprie difficoltà con gli altri. Consentono inoltre di ricostruire reti
sociali e legami di amicizia e di vincere il senso di inadeguatezza e di oppressione
interiore. I servizi dovrebbero perciò favorirne l’avvio prevedendo la presenza di
persone con esperienza che fungano da facilitatori.
9. | Gli spazi Il servizio di salute mentale orientato alla recovery ha tra le sue priorità
la questione degli spazi. Gli spazi sono una conquista di libertà, come un luogo
sempre aperto a tutti, dove però ciascuno può ritagliarsi un proprio angolo di
intimità se sta male, può sentirsi protetto e al sicuro. Uno spazio dovrebbe essere
bello e decoroso. Dovrebbe essere un ambiente di condivisione continua di interessi
e passioni. Dovrebbe essere divertente, offrire possibilità di svago e distrazione,
ma anche di impegno culturale e creativo che si conformi ai desideri di ognuno. È
qui che si possono vincere la solitudine e la noia, investendo sia umanamente che
economicamente nell’offerta di varie attività all’interno dei servizi. I servizi possono
essere vissuti/visti come luoghi stigmatizzanti. Si sente la necessità di analizzare e
mettere criticamente in discussione la percezione generale e culturale che «all’esterno» si ha del disagio mentale e delle persone che ne soffrono.
10. | L’utilizzo degli psicofarmaci Il servizio di salute mentale orientato alla recovery
incoraggia le persone a fare un utilizzo consapevole dei farmaci, considerati un
dispositivo transitorio del percorso. C’è una differenza tra l’assumere un farmaco, e
utilizzarlo. L’assunzione implica passività, utilizzare è farne uso con consapevolezza,
per stare meglio. Serve una farmacologia adeguata ai bisogni della persona, che non
ne annulli i desideri e la volontà anche nel momento di crisi. Serve una farmacologia
che non impedisca di esprimere i propri sentimenti, i propri pensieri, che permetta
di crearsi la propria indipendenza senza soggiacere all’arbitrio di estranei.
11. | L’advocacy e l’associazionismo Il servizio di salute mentale orientato alla re-
covery promuove e sostiene la creazione di gruppi trasversali di protagonismo,
le associazioni di cittadini utenti e di familiari, i comitati di partecipazione come
interlocutori per il rinnovamento dei linguaggi e degli strumenti del lavoro nel
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
la propria attenzione all’altro, sono tutti aspetti fondamentali per la persona che
ha un’esperienza di prolungato disturbo mentale.
Inserto del mese I Costruirsi una vita al di là della «malattia mentale»
82 | Animazione Sociale marzo | 2015 inserto
campo della salute mentale. È indispensabile che le istituzioni competenti tutelino
i diritti delle persone che soffrono di un disagio mentale. Le associazioni di utenti
e di familiari che si occupano della difesa dei diritti e della lotta per la promozione
della salute mentale, sono cruciali per denunciare per esempio i soprusi, i servizi
inefficienti, le misure di sottrazione e di contenzione. Nel processo di guarigione
è di fondamentale importanza per le persone, soprattutto nei momenti di grave
difficoltà, poter avere fiducia negli operatori dei servizi e nelle figure di supporto
più significative. La persona deve poter scegliere di affidare a queste figure la cura
dei propri figli, dei propri beni e la tutela delle proprie volontà da far rispettare nei
momenti in cui non è in condizione di farlo da sé.
12. | I comitati etici Il servizio di salute mentale orientato alla recovery promuove
e sostiene la costituzione di comitati etici formati anche da persone esperte per
esperienza, che possano indicare e valutare che cosa faciliti e che cosa ostacoli i
percorsi di guarigione, e garantire in tal modo il rispetto dei diritti delle persone
negli interventi di salute mentale. Una delle attività del comitato etico dovrebbe
essere quella di favorire una ricerca partecipata – esperti e persone con esperienza e
loro familiari insieme – sui temi della salute mentale. Una ricerca critica e innovativa
che aiuti a migliorare la comprensione dei problemi che riguardano da vicino le
persone e, più generalmente, il funzionamento dei servizi stessi.
In conclusione, il testo vuole rappresentare un primo passo nel lungo percorso
della definizione di linee guida che raccolgano idee, principi e pratiche condivise
nei servizi orientati alla recovery/guarigione. Ci auguriamo che possa essere un
viaggio che molti avranno voglia di intraprendere, nella convinzione che molto c’è
ancora da imparare, condividere e mettere in pratica.
GLI AUTORI
Manuela Ciambellini è coordinatrice del Social
point di Modena: [email protected]
Izabel Marin è assistente sociale nel Servizio
abilitazione e residenze del Dipartimento di
salute mentale di Trieste: izabel.marin@aas1.
sanita.fvg.it
Roberto Mezzina è direttore del Dipartimento
di salute mentale di Trieste dell’Azienda per
l'assistenza sanitaria (Aas) 1 triestina: roberto.
[email protected]
Luca Negrogno è dottorando in sociologia presso
l’Università di Urbino: [email protected]
Fabrizio Starace è direttore del Dipartimento di
salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Ausl
di Modena: [email protected]
Anita Eusebi è giornalista scientifica freelance,
collabora con Forum Salute Mentale e Màt: anita.
[email protected]
L’editing dell’«Inserto» è stato curato da Anita
Eusebi insieme alla redazione di Animazione
Sociale.
IL PROGETTO
Nel documento base del ii Appuntamento nazionale degli operatori sociali (convocato da
Animazione Sociale a Torino l'8-9 novembre
2013), pubblicato nel nr. 277 del 2013, si legge:
«La logica della mancanza, del deficit, del danno
ha creato distanze enormi. Per cui oggi chi ha un
problema molte volte viene ai servizi solo se è
costretto... perché la risposta che rischia di sentirsi
dire è “adesso ti dico dove non funzioni”. Ma le
persone sanno già dove non funzionano, piuttosto
hanno bisogno di sentirsi chiedere “dimmi in
quale momento della tua vita sei riuscito a fare
delle cose”. Oggi allora diventa cruciale costruire
interazioni che sostengano processi di capacitazione nei destinatari dei nostri servizi. Per cui
chiediamoci: che spazio facciamo al loro sapere
informale nel costruire i nostri servizi? Quanto li
coinvolgiamo nel comprendere i loro problemi e
nel cercare le risposte?» (p. 27). In questa logica di
lavoro il concetto di recovery si rivela fecondo per
riformulare le pratiche professionali quotidiane.
inter vista | studi | prospettive | inser to | metodo | str umenti | luoghi&professioni | b a z a r
Il limite
nella quotidianità
dell’educare
Una risorsa
a volte inaspettata
dentro situazioni difficili
di
Giulia Zanardi
Chi svolge un lavoro educativo è spesso
confrontato con i limiti: quelli emergenti
nella propria storia, quelli dei contesti
in cui opera, quelli delle persone con
cui lavora quotidianamente in una
prospettiva educativa. Di fronte ai limiti
che nascono da un reale che ci resiste,
per tutti il rischio è duplice: quello di
negarli chiusi in un narcisismo
onnipotente, ma anche di subirli in modo
passivo. Ci può essere una terza via
da percorrere come educatori, dotata di
maggiore generatività, ed è quella di
sostare nei limiti, esplorarli con lucidità,
da ricercatori attenti a intravedere le
possibilità non viste in ogni situazione,
per aprirsi a nuovi mondi relazionali.
84 | Animazione Sociale marzo | 2015 metodo
Q
uello del limite è divenuto solo di
recente oggetto di una maggiore
attenzione e di una comune riflessione su come, in quanto uomini e donne,
possiamo misurarci con il reale e le sue
resistenze alla nostra azione.
Osservando i contesti nei quali ci muoviamo risulta infatti evidente come il limite
costituisca un tema «caldo» e assolutamente attuale, che chiama in causa, attraversa
e interroga tanto le relazioni tra persone,
gruppi e culture, quanto gli attuali stili di
vita e il sistema socioeconomico su cui questi si reggono.
Per la nostra società, dunque, il limite costituisce un tema col quale è necessario
confrontarsi e un varco da riconoscere e
attraversare per poter immaginare scenari
futuri possibili e sostenibili, uscendo da
atteggiamenti di onnipotenza ma anche di
impotenza.
In quest’ottica, le pagine che seguono vogliono essere un contributo alla riflessione
sulla valenza attivante e generativa che il
limite può assumere, in particolare in riferimento all’azione di quanti – come operatori sociali, e in particolare come educatori – si misurano quotidianamente col limite: quello che caratterizza i contesti di lavoro e le storie delle persone incontrate,
ma prima ancora quello che impregna i
loro vissuti umani e professionali.
Una riflessione al fianco di chi educa, dunque, alla luce della nuova ricerca multidisciplinare che, anche nell’ambito delle
scienze umane, sempre più vede nel limite
il doppio volto della «barriera insuperabile» e della «soglia di ingresso».
Fragili in quanto umani
e figli del tempo
1 | Il termine deriva dal latino limes, vocabolo utilizzato
dai romani per indicare le pietre – considerate sacre
e inamovibili – che segnavano i confini, e dunque la
frontiera, la linea di demarcazione oltre la quale non
era lecito spingersi; al contempo limes era la via che
consentiva di penetrare nei territori di recente conquista o da conquistare. In questa accezione, si lega
anche al latino limen, che indica la soglia.
2 | Iori V. (a cura di), Quaderno della vita emotiva,
FrancoAngeli, Milano 2009, p. 43.
Il termine limite richiama, già nella sua etimologia (1), due dimensioni solo apparentemente inconciliabili: barriera e ingresso; via
inaccessibile e via d’accesso privilegiata;
invalicabilità e possibilità di superamento.
Si tratta delle due facce del limite con cui
chiunque è chiamato, prima o poi, a confrontarsi nei diversi ambiti, individuali e
collettivi, della propria vita.
Tale doppio volto assume una grande rilevanza per chi, come l’educatore, lavora a
stretto e quotidiano contatto con situazioni
di estrema fragilità e delicatezza: in questi
contesti, diventa fondamentale che l’incontro-scontro con la propria limitatezza – e
con la percezione che il limite ci avvolge,
ma al contempo ci apre ad altro – avvenga
consapevolmente e sia accompagnato da
quella capacità riflessiva che consente di
fare della propria esperienza soggettiva,
sociale e lavorativa un’imprescindibile fonte
di conoscenza. Questo nella convinzione
che «per guardare ai vissuti degli altri è indispensabile avere consapevolezza dei propri» (2): l’educatore deve avere chiara l’importanza di lavorare innanzitutto su se
stesso prima ancora che con l’altro.
Prima di addentrarci nello specifico della
riflessione, per delinearne meglio i confini è
importante ribadire che il limite si configura
al tempo stesso come carattere fisiologico
della condizione esistenziale umana (quindi
intima e biografica) e come attributo del
contesto socio-culturale nel quale come uomini e donne ci muoviamo.
Animazione Sociale marzo | 2015 metodo | 85
Dentro la fragilità
prende forma l’esistenza
«I limiti sono propri di qualsiasi forma di
esistenza» (3). Così scriveva nel 1993 Piero
Bertolini, padre della pedagogia fenomenologica, sottolineando con forza gli elementi di contingenza e necessità storica
che caratterizzano ogni forma di vita.
L’uomo è sempre e comunque un essere
storicamente collocato e la sua libertà di
scelta deve scendere a patti con l’insieme
delle condizioni sociali e culturali, in fondo
esistenziali, in cui si trova immerso (4).
La limitatezza, secondo Bertolini, è il fondamento della natura sociale dell’uomo,
poiché evidenzia che egli non basta a se
stesso e che l’altro gli è in qualche misura
necessario per conoscere sé e la realtà
esterna.
La tendenza a ricercare la relazione con
l’altro sarebbe conseguenza e prova della
«impossibilità per il singolo individuo di
esistere autonomamente, ovvero al di fuori
di un qualsiasi rapporto con l’altro» (5), poiché «è dall’incontro con l’altro che l’Io è
in grado di cogliere o di comprendere
tanto la realtà di se medesimo quanto la
realtà del mondo» (6).
La nostra quotidianità, intessuta di relazioni, grida dunque sempre il nostro bisogno
dell’altro. Per usare il linguaggio di
Vittorino Andreoli, la fragilità è «origine
della voglia di legame, di comprensione, di
solidarietà e di amore» (7).
Lo scenario delineato chiama in causa l’educatore, fragile per professione in quanto
inserito in una quotidianità lavorativa fatta,
per l’appunto, di relazioni e in cui la rela-
Il limite in una società
che chiede perfezione
Se la limitatezza si configura come una caratteristica che accomuna tutti gli esseri
umani, sorge spontanea una domanda:
perché mai risulta oggi così difficile accettarla come parte integrante di sé?
Fra le molte motivazioni, una, alla quale
molti autori (8) rivolgono la propria attenzione, spicca per importanza e influenza:
si tratta dell’illusione di onnipotenza che
abita e corrode ogni ambiente di vita.
Esiste infatti un’implicita (anche se non
così tanto) richiesta di perfezione da parte
di una società impostata sull’idea che «vai
bene» solo se hai successo, se spicchi fra i
tanti.
Per rispondere alla domanda di perfezione
(e meritare dunque affetto, stima, considerazione), si vive come «sotto la presenza di
un giudice implacabile» (9), apprendendo
fin dalla più tenera età a mascherare le proprie zone d’ombra e tutto ciò che in sé è
indice di debolezza e fragilità.
3 | Bertolini P., Caronia L., Ragazzi difficili, La Nuova
Italia, Scandicci 1993, p. 81.
4 | Bertolini P., L’esistere pedagogico, La Nuova Italia,
Scandicci 2002, p. 154.
5 | Ivi, p. 191.
6 | Ibidem.
7 | Andreoli V., L’uomo di vetro, Rizzoli, Milano 2008.
8 | Si veda Augelli A., Tonalità emotive e paesaggi
interiori nell’esperienza educativa, in «Animazione
Sociale», agosto/settembre, 2007, pp. 59-60.
9 | Peter R., Onora il tuo limite, Cittadella, Assisi
1997, p. 8.
zione diviene il principale e «debole» –
poiché non prescrittivo – strumento di
intervento. «Limitato» in quanto essere
umano e in quanto professionista dell’aiuto che si confronta quotidianamente con
circostanze e storie di vita che lo mettono
duramente alla prova, non è infrequente
che l’educatore sperimenti un senso di inadeguatezza e impotenza, di fallimento e
sconfitta: la percezione di fragilità può
emergere prepotentemente per uno sbaglio, un percorso di recupero fallito, una
scelta dell’utente non condivisa.
86 | Animazione Sociale marzo | 2015 metodo
rato e speesssao,
In un dispeti
o di dif
vano tentacovrazze
si creano no barriere
e si erigo o proteggere.
che paionsi frappongono
In realtà li altri,
fra sé e g o la capacità
intaccandnarsi.
di relazio
Si tratta di meccanismi che lavorano in
profondità e di cui raramente si è consapevoli e che fanno sì che, anche quando si
raggiunge un certo grado di consapevolezza, riscoprire le parti di sé più scomode
costituisca comunque una sofferenza: il
limite, quando riemerge, può divenire totalizzante, poiché ci si identifica a tal punto
con esso da non essere più in grado di vedere e valorizzare le risorse e gli aspetti
positivi di sé, come anche dei contesti in
cui si opera.
Volti del limite
nel lavoro dell’educatore
Anche la quotidianità dell’educare e del
prendersi cura dell’altro è fatta di una complessità di sentimenti ed esperienze che
espongono l’educatore all’incontro con le
proprie fragilità. Ragionando attorno alla
difficile presa d’atto di questa nudità interiore, Alessandra Augelli (10) individua alcuni dei volti che il limite assume nella
pratica dell’educare.
• Il prevalere del senso di impotenza. Si ma-
10 | Augelli A., Tonalità emotive e paesaggi interiori,
cit., pp. 59-60.
nifesta nelle situazioni in cui ci si sente
privi di strumenti e risorse, dunque impreparati ad affrontare le richieste del contesto lavorativo. Come evidenzia Daniele
Bruzzone, «non sempre si può fare tutto
(non sempre, anzi, si può fare qualcosa),
non sempre tutti ce la fanno» (11), e ciò genera una diffusa sensazione di inutilità e
inadeguatezza.
• L’inganno del dono totale di sé. Può accadere, soprattutto agli inizi del percorso
professionale, di venire talmente coinvolti
dalle storie che si incontrano da spendersi
totalmente per l’altro, dimenticando di
tutelarsi e di avere cura anche di se stessi.
È la questione della «giusta distanza». Un
equilibrio (sempre da re-inventare) fra eccessivo coinvolgimento e freddo distacco
– in altre parole, la capacità di tracciare
sani confini fra sé e l’altro – è necessario
per la riuscita di ogni percorso, oltre che
per la salvaguardia della propria salute
psicofisica.
• L’abbandonarsi a sensi di colpa. Non tutti
i percorsi che un educatore intraprende
hanno esito positivo. Concedersi di sbagliare, accettare anche le sconfitte è forse
l’aspetto più difficile e controverso dell’educare. Si ha la sensazione di non aver
fatto abbastanza e ci si assume in toto la
responsabilità dell’accaduto, alimentando
un’ansia di fallimento che porta a ingigantire gli ostacoli più che a favorire crescita
e consapevolezza di sé.
• La frustrazione per un «grazie» che non
arriva. Se in ogni relazione è insita la necessità di ricevere un riscontro rispetto al
proprio manifestarsi in quanto persona, un
ringraziamento è conferma e riconoscimento del lavoro svolto, la prova che si è
11 | Iori V., Quaderno della vita emotiva, cit., p. 155.
Animazione Sociale marzo | 2015 metodo | 87
agito correttamente. Quando i «grazie»
vengono a mancare, la sensazione può divenire di grande frustrazione per l’educatore che, faticando a scorgere il risultato
del lavoro, vede indebolirsi entusiasmo e
motivazione e, di conseguenza, fiducia nel
proprio quotidiano operare.
• Il sentirsi falliti nel prendere atto delle
scelte altrui. L’educatore può offrire un’opportunità di cambiamento, ma esso si concretizza solo se l’utente accetta e sceglie di
accoglierlo. L’azione educativa non può
mai essere imposta con la forza e ciò implica, per l’educatore, la non scontata capacità di attenersi alle scelte fatte dall’utente anche quando non le condivide. In altri
termini, la capacità di riconoscere all’altro il
proprio spazio di autonomia e azione.
• Il lasciarsi travolgere dalla mancanza di
senso. La sofferenza spesso rimane priva di
senso e viene percepita come ingiusta e inaccettabile. Perché accadono certe cose? E
perché a lui/lei e non a me? Sono domande
che dicono la paura, la fragilità, la difficoltà
di guardare in faccia un dolore che, privo di
un perché, richiama al fatto che chiunque,
educatore compreso, può esserne colpito.
Rassegnazione e rinuncia all’azione si rivelano spesso diretta conseguenza dell’inconscio rifiuto di una sofferenza alla quale lo
stesso educatore può rivelarsi impreparato.
che porta a ignorare il proprio sentire, a
metterlo a tacere e a comportarsi come se
niente fosse. Qual è la conseguenza di questa modalità di relazionarsi col limite, in
altre parole con un’immagine di sé che non
coincide con le proprie aspettative? Augelli
sostiene che
l’esperienza del limite e della fragilità, quando non è assunta, quando non è profondamente compresa, crea corazze, che apparentemente danno sicurezza e protezione, ma in realtà
rischiano di fare ancor più male. (12)
Le esperienze e i sentimenti elencati in
precedenza sono fortemente destabilizzanti, mettono cioè in crisi la propria immagine di sé, rendendo concreto il rischio di
«rompersi». Di fronte a tale rischio, la reazione più frequente e immediata è la fuga,
In un disperato e spesso vano tentativo di
difesa, si creano corazze e si erigono barriere che apparentemente proteggono ma
in realtà si frappongono fra sé e gli altri,
intaccando la capacità di relazionarsi. Dal
momento che, come visto, è proprio la relazione a richiamarci alla nostra umanità,
e dunque alla nostra insufficienza, risulta
chiaro che l’unico modo per preservare
una determinata immagine di noi stessi
sembra negare la relazione stessa, e con
essa il nostro bisogno degli altri.
Queste corazze, per quanto riguarda il
ruolo educativo, possono assumere forme
diverse, come l’isolamento, la spersonalizzazione (che porta a dare una risposta meramente tecnica ai bisogni delle persone),
la deresponsabilizzazione (che, di fronte
agli insuccessi e agli ostacoli, porta a ricercarne le cause fuori da sé e per cui, di fatto,
è sempre colpa di qualcun altro) (13).
L’esito comune è l’accumularsi di un malessere che rischia di compromettere la
capacità di agire con consapevolezza il
proprio ruolo. Non è un caso che questa
professione sia oggi annoverata fra quelle
maggiormente a rischio di burn-out, una
sindrome da affaticamento ed esaurimento
12 | Ivi, p. 150.
13 | Gherardi V., Le vie di fuga dalla professionalità,
in Gherardi V., Manini M., Didattica generale, Clueb,
Bologna 2001, pp. 28-30.
Osservare sé e l’altro
con tenerezza
88 | Animazione Sociale marzo | 2015 metodo
psicofisico fra le cui cause possiamo immaginare un sentire negativo che, non trovando uno sbocco verso l’esterno e una possibilità di elaborazione, finisce per influenzare negativamente gesti, scelte e relazioni.
Fare del limite una chiave
di comprensione dell’uomo
Cosa ha a che fare tutto questo con la professione educativa?
Un educatore che non sappia farsi carico
delle proprie fragilità non sarà in grado di
guardare con tenerezza alle fragilità dell’altro. Riconciliandosi con la propria umanità e debolezza saprà invece farsi vicino a
chi soffre. Infatti, «perché uno si fermi
vicino a un ammalato deve sapere di potersi ammalare» (14).
Non c’è modo di incontrare l’altro e di
comprenderne il dolore, la sofferenza, le
difficoltà se non riconoscendo la propria
fragilità, il fatto che in quella stessa situazione ci si sarebbe potuti, ci si può e ci si
potrà trovare a propria volta.
«Fuori del limite l’uomo perde ogni possibilità di comprensione» (15), infatti
si può capire che un altro si senta debole,
fragile, diverso, tremante di sgomento, solo
lasciando affiorare il ricordo di tutte le volte – o
di almeno una volta – nelle quali noi stessi ci
siamo sentiti deboli, fragili, diversi, tremanti di
sgomento. (16)
mente con se stesso egli potrà stare serenamente con gli altri. L’accettazione del limite, in quest’ottica, è presupposto di relazioni sane, legami autentici, capacità di stare
insieme. Etty Hillesum, in un contesto e in
un’epoca diversi da quelli attuali, scriveva:
«Avevo imparato a leggere in me stessa, e
così ero in grado di leggere anche negli altri»
(17)
. L’educatore è chiamato a «leggere» se
stesso, a intraprendere un percorso che, se
portato a compimento, gli consentirà di
comprendere dentro uno sguardo e un moto
di tenerezza le persone che incontra.
In questo senso, il prendersi cura del proprio limite si presta a una doppia lettura:
una interna (accogliere la naturale debolezza e fragilità che ci contraddistingue
personalmente in quanto esseri umani) e
una «esterna»: il limite, infatti, è anche il
confine che separa e differenzia le persone
le une dalle altre, e come tale richiede di
essere accettato e rispettato, riconoscendo
che si è tutti portatori di visioni del mondo,
schemi mentali, valori assolutamente parziali e soggettivi, che possono anche non
essere condivisi. Significa riconoscere che
esiste qualcuno o qualcosa di «altro» da
me, le cui caratteristiche ed esperienze di
vita possono portare a scelte e comportamenti altri rispetto a quelli per me più
adeguati.
L’uomo «perfetto», che sottostà alle regole
della società della perfezione, non è in
grado di accogliere la propria e l’altrui fragilità, perché la fragilità è un’esperienza che
gli è estranea. Ecco allora l’importanza,
anche per l’educatore, di accettare i propri
limiti: solo imparando a convivere serena-
L’intervento educativo
accetta il vincolo che è l’altro
L’educatore deve essere consapevole del
fatto che le persone che incontra e accompagna possiedono le proprie caratteristiche
di personalità, le proprie idee e convinzioni, i propri valori di riferimento, che possono anche (e spesso accade) non coinci-
14 | Andreoli V., cit.
15 | Peter R., Onora il tuo limite, cit., p. 17.
16 | Iori V. (a cura di), Quaderno della vita emotiva,
cit., p. 119.
17 | Hillesum E., Diario 1941-1943, Adelphi, Milano
1985, p. 208.
Animazione Sociale marzo | 2015 metodo | 89
dere con i suoi. Il suo compito non è trasformare l’altro nella persona che crede
debba essere, ma, invece, aiutarlo a trovare in sé gli strumenti e la forza per cambiare, in una direzione che non è l’educatore
a stabilire, ma che il soggetto, pur accompagnato, dovrà trovare da solo.
In questo senso, il fallimento, il rifiuto, una
scelta della persona non condivisa sono da
leggere come espressione di un’alterità e di
un’autonomia mai ingabbiabili .
La competenza dell’educatore implica la
capacità di riconoscere che l’altro non è
mai una «tabula rasa», un vaso vuoto da
riempire o un pezzo di argilla da modellare, ma un soggetto che concorre nel determinare il risultato del percorso educativo:
quest’ultimo, dunque, non dipende solo
dall’azione dell’educatore, ma anche e soprattutto dalla disponibilità della persona,
delle persone a co-partecipare, dal loro
desiderio di cambiare, dai loro tempi di
maturazione.
Riconoscere questo significa rinunciare alla
presunzione di onnipotenza con cui tanti
operatori si vivono in relazione alle persone che accompagnano, per restituire ad
esse il ruolo di protagoniste del proprio
percorso umano.
«Perché il suo lavoro si riveli efficace»,
scrive Bertolini in riferimento ai «ragazzi
difficili» (ma il discorso è estendibile ai
diversi campi d’azione), l’educatore «deve
riconoscere nel ragazzo, nel ragazzo concreto e in carne e ossa, il primo vincolo ai
suoi progetti e alle sue azioni» (18).
Ancora una volta siamo chiamati a rispettare i confini posti dalla natura e, fra essi,
la libertà di scelta e le specificità delle decisioni prese dalle singole persone che affianchiamo.
Il fragile equilibrio
fra superamento e accettazione
Finora si è argomentata l’importanza di
rispettare i propri limiti naturali, di accettare di non poter sempre dare il meglio o
fare ciò che ci si era prefissati. Ciò che si è
voluto suggerire è che passare dal riconoscimento e dall’accettazione della propria
limitatezza costituisce, per chi educa, una
tappa imprescindibile della propria crescita umana e professionale. Tale predisposizione accettante non può, tuttavia, divenire pretesto per l’immobilità o per la passiva
rassegnazione nei confronti degli eventi.
Come evidenziato, infatti, il termine «limite» sottende, oltre all’idea di invalicabilità,
anche quella di soglia, passaggio e, dunque,
di possibile evoluzione, spostamento, attraversamento. Se è innegabile che il limite sia costitutivo della condizione umana
– e dunque non possa mai essere del tutto
colmato – tuttavia è proprio il limite a delineare uno spazio in cui l’educatore può
intervenire con passione e competenza per
favorire l’evoluzione delle situazioni e alleggerirne le fatiche.
La constatazione della propria limitatezza,
allora, non deve diventare una scusa, una
giustificazione che esonera dallo spendersi in ciò che si fa, ma, al contrario, essa
implica l’interrogarsi su cosa è possibile
fare delle proprie fragilità, con l’obiettivo
di imparare a discernere le situazioni in cui
i limiti riservano uno spazio di intervento
– e possono dunque essere «spostati» – da
quelle in cui è preferibile non interferire,
poiché ciò costituirebbe una forzatura.
Di fronte al limite, insomma, l’educatore
può scegliere «tra lo slancio del superamento e la prudenza dell’accettazione» (19).
Anche «arrestarsi di fronte a un limite non
18 | Bertolini P., Caronia L., cit., p. 82.
19 | Iori V. (a cura di), Quaderno della vita emotiva,
cit., p. 158.
20 | Ibidem.
90 | Animazione Sociale marzo | 2015 metodo
è sempre indice di impotenza: talvolta
esprime una sapienza che solo l’esperienza
pensata della cura sa generare» (20).
In altre parole, invece che essere vissuto
come un peso di cui disfarsi o farsi carico,
il limite può diventare qualcosa di generativo, a patto, però, di guardarlo in faccia e
lasciarsi interrogare, per comprendere
come esso possa essere «maneggiato» e
messo a frutto.
Alla luce di ciò, la consapevolezza del limite può costituire fonte di equilibrio rispetto ai rischi del delirio d’onnipotenza e del
senso d’impotenza. Non esistono ricette o
formule universalmente valide che consentano di raggiungere tale equilibrio; ognuno
dovrà trovare la personale misura fra le due
spinte opposte: l’impulso a oltrepassare i
propri limiti da un lato e la capacità di capire quando fermarsi dall’altro.
sviluppare una riflessione sugli interventi
educativi realizzati e sui loro effetti (positivi e negativi), sul proprio modo di relazionarsi con le persone in situazioni difficili,
sui sentimenti, le fatiche, i successi e gli
insuccessi, in modo che ogni aspetto del
lavoro possa divenire fonte di crescita personale e professionale.
Promuovere la riflessione rispetto alla propria azione consente di prendere atto dei
propri limiti, allo scopo di gestirli con attenzione e «tenerli sotto controllo». Ciò
implica non fermarsi alle apparenze, ma
scavare nelle cose e negli eventi e coglierne
l’essenza, il significato più profondo.
Tale capacità va allenata e messa alla prova.
A tal fine, l’educatore dispone di strumenti che implicano un continuo travaso tra
riflessione in solitudine e lavoro di gruppo.
Alla luce di quanto detto, risulta evidente,
per l’educatore, l’esigenza di prendersi cura
di sé per poter aiutare gli altri. Questo implica un occhio di riguardo per i risvolti
emotivi del lavoro, allo scopo di acquisire
sempre più dimestichezza nel muoversi
all’interno dei propri «paesaggi interiori» (21).
Micaela Filippini descrive la cura di sé come
«un percorso di crescita interiore che spinge l’educatore a ripartire da sé per rilanciarsi nel mondo del lavoro educativo» (22).
È, dunque, innanzitutto un percorso di
autoanalisi, che fa dell’esperienza soggettiva dell’educatore un’imprescindibile fonte
di conoscenza. Concretamente significa
Condividere con altri
l’esperienza del limite
Un primo strumento è la supervisione professionale, che dà la possibilità a un’équipe
di riprendere e rielaborare – periodicamente e sotto la guida di un esperto – il
proprio operato, riflettendo sulle situazioni, sulle emozioni di difficile espressione,
sui fallimenti e sugli eventuali intoppi verificatisi. È un luogo di vera e propria «manutenzione» (23) che «permette di gestire
consapevolmente le proprie azioni, affiancando alla dimensione del fare quella del
pensare insieme suggerita dal gruppo di
lavoro» (24). Si rivela quindi uno strumento
prezioso per lavorare in gruppo sul limite,
fino a creare un clima di apertura e disponibilità fra gli operatori, essenziale affinché
ciascuno si senta libero di esprimere dubbi
21 | Augelli A., cit., p. 57.
22 | Filippini M., Aver cura di sé, in «Note di pastorale giovanile», aprile, 2009.
23 | Biolcati R., Sagliaschi S., Promozione del benes-
sere e prevenzione, in Pani R., Biolcati R., Sagliaschi
S., Psicologia clinica e psicopatologia per l’educazione
e la formazione, il Mulino, Bologna 2009, p. 203.
24 | Ivi, p. 204.
Quali strumenti
per la cura di sé
Animazione Sociale marzo | 2015 metodo | 91
e difficoltà, senza paura di mostrare le proprie debolezze.
La condivisione delle fragilità può aprirsi
anche a eventuali occasioni di confronto
esterne al contesto lavorativo, con persone
e gruppi non direttamente connessi al lavoro educativo. Le possibilità possono essere molteplici: una psicoterapia, un percorso spirituale, la pratica di una disciplina
orientale, tutto ciò che risulti funzionale
all’acquisizione di una maggiore familiarità
con la natura umana del proprio limite. Può
essere arricchente anche il confronto con
le realtà sociali che si muovono alla ricerca
di varchi per andare oltre, mettendo in discussione gli attuali stili di vita e di sviluppo
socio-economico.
Un inesauribile
percorso di apprendimento
Non meno importanti sono gli strumenti di
autoanalisi: chi opera a contatto con la sofferenza e il disagio sociale, infatti, non può
esimersi dal «lavorare» su se stesso. La scrittura è il primo, per importanza ed efficacia,
di questi strumenti: la pratica del diario
professionale è non a caso diffusa fra i professionisti dell’educazione. Oltre alle esigenze di natura pratica cui risponde, la scrittura ha una valenza formativa: trasferire sulla
carta i pensieri e le emozioni consente, infatti, di dar loro una forma, di definirli con
maggiore chiarezza, di guardarli dall’esterno
e secondo nuove prospettive, di riprenderli con maturato distacco.
Secondo Duccio Demetrio, ripercorrendo
la propria storia è possibile comprendere
l’inevitabilità del dolore, la finitudine dell’umano e, in definitiva, riappacificarsi con se
stessi, che non vuol dire mettere a tacere
dubbi e inquietudini, ma piuttosto dare loro
voce, esternarli per comprenderli nella loro
25 | Filippini M., Aver cura di sé, cit.
essenza. L’autobiografia, insomma, come
rivisitazione dei propri vissuti, riconciliazione con gli stessi e occasione di miglioramento, trasformazione e crescita personale.
La costante auto-formazione dell’educatore, tuttavia, non si limita al fare luce nei
meandri della propria interiorità, ma guarda anche all’esterno, alla necessità di formazione permanente che caratterizza ogni
ruolo che richieda una preparazione – la
quale non può esaurirsi sui banchi di scuola o sui testi universitari, ma necessita di
essere costantemente aggiornata e messa in
discussione. In particolare, per quanto riguarda l’educatore, si tratta di documentarsi sui bisogni sociali e culturali emergenti, sulle situazioni di maggiore urgenza,
sulle normative che regolano gli interventi,
sulle teorie e sui modelli educativi recenti.
Un tempo per pensare
nelle organizzazioni
Alla luce di quanto sottolineato, risulta
fondamentale che le strutture lavorative
immaginino e predispongano spazi, tempi
e modalità che permettano agli operatori
– che quotidianamente si fanno carico di
parte delle sofferenze di chi accompagnano – di esprimere i propri vissuti. In altre
parole, uno spazio di rielaborazione di
quanto incontrato e sperimentato. Spesso
e volentieri la centralità di questa dimensione non viene colta, e il lavoro dell’educatore si riduce a un qualcosa di meramente esecutivo e prestazionale. È invece rilevante che gli educatori rivendichino un
tempo per pensare e riflettere, per interrogare quello che si fa e discernere. Un tempo
per pensare, non solo i singoli atti, bensì la
relazione che li lega, che intreccia ogni filo del
lavoro nel tessuto, intelligente e affettivamente
connotato, della cura. (25)
92 | Animazione Sociale marzo | 2015 metodo
Il limite da peso
a risorsa nel lavoro
In conclusione, alla luce delle riflessioni
proposte, è possibile identificare tre principali modalità attraverso cui il limite può
divenire risorsa del lavoro educativo.
Accettare la vulnerabilità Come più volte
sottolineato, esiste un rapporto profondo
e indissolubile fra vulnerabilità e relazione,
per cui non esiste vera relazione senza previa e continua accettazione della vulnerabilità. Ciò significa che riconoscere la propria umanità – e con essa la possibilità della
sofferenza e del fallimento nella propria
vita – è l’unico vero modo per farsi vicini
a chi soffre e, dunque, relazionarsi autenticamente. Solo imparando a stare serenamente con se stesso, e accettando la propria piccolezza e le proprie insufficienze,
l’educatore potrà sviluppare un atteggiamento di autentica compassione (dal latino
cum e patior, «patire con» l’altro) nei confronti dell’altrui fragilità.
Valorizzare il fallimento «A volte un limite
o un fallimento ci dicono su cosa dobbiamo lavorare» (26): modi di dire, un po’ inflazionati ma certamente veritieri, vogliono
che sia cadendo che si impara a rialzarsi e
sbagliando che si impara a correggersi.
Anche per l’educatore è importante comprendere e accettare che il suo percorso è
un continuo «errare», fatto di successi, ma
anche necessariamente di cadute – errori,
insicurezze, sentimenti negativi – e che
ciascuno di questi elementi è fondamentale per costruire e riaggiustare in itinere la
prassi lavorativa. L’errore, allora, non è
26 | Contini M., Figure di felicità, La Nuova Italia,
Scandicci 1988, p. 63.
27 | Ivi, p. 177.
sbagliare, quanto piuttosto non trovare
alcun valore nel fallimento. Il limite, se
accolto, può aprire potenziali spazi di riflessione e mobilitazione delle proprie risorse in vista di un miglioramento, dinamiche di cui non ci sarebbe alcun bisogno se
tutto andasse sempre per il meglio.
Aprirsi all’indefinitezza È importante sviluppare un atteggiamento di «autentica
disponibilità all’esistenza» (27) e agli avvenimenti, belli e brutti, che possono caratterizzarla: l’assunzione del limite impone
una rinnovata visione del mondo e delle
cose, a partire dalla presa di coscienza che
non è possibile tenere sempre tutto sotto
controllo. Tale consapevolezza è centrale
per l’educatore, poiché apre alla possibilità di vivere la progettazione educativa non
come un qualcosa di definito meccanicamente, di stabilito dall’alto e calato sull’utente, ma come un evolversi continuo,
aperto alle possibilità, ai mutamenti e alle
deviazioni determinate da una molteplicità di variabili: prima fra tutte la presenza
stessa delle persone nei loro contesti di
vita, con le loro caratteristiche, scelte e visioni del mondo.
La missione dell’educatore, in definitiva, è
educare al limite se stesso e, conseguentemente, l’altro, dando il proprio contributo
affinché i soggetti incontrati sentano come
importante e concreta la prospettiva di un
cambiamento, ma allo stesso tempo sappiano anche amare la propria limitatezza,
in quanto massima espressione della loro
umanità. E vedere in essa non più una
mancanza, ma la propria forza.
Giulia Zanardi, studentessa del Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione
dell'intervento educativo nel disagio sociale,
presso l'Università di Bologna: [email protected]
inter vista | studi | prospettive | inser to | metodo | str umenti | luoghi&professioni | bazar
Il farsi del viaggio
educativo
con il bambino
Ancoraggi nella relazione
educativa con storie di fatica
di bambini e ragazzi
di
Gilda Vischia
Se ogni viaggio è un’esplorazione
della vita, che viaggio è quello
di un educatore professionale a fianco
di bambini e ragazzi segnati da difficoltà?
Per attraversare il corso dell’età evolutiva
il bambino cerca adulti significativi
che si mettano a servizio del suo
irrinunciabile andare incontro al futuro.
Dove sta la specificità del viaggio
a fianco di un «adulto altro» come
un educatore, e come si integra con la
diversità degli interventi di altri operatori
in un contesto sanitario?
Quale mappa orienta le scelte
dell’educatore nel cercare la strada
insieme al bambino, se ogni viaggio
di crescità è una storia da costruire?
94 | Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni
D
a circa vent’anni svolgo la mia attività in un servizio sanitario pubblico territoriale di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, rivolto alla
fascia evolutiva compresa tra gli 0 e i 18 anni
con disagio nella relazione e nell’apprendimento e problematiche comportamentali.
L’ esperienza professionale –, nell’aver osservato e accompagnato lo spirito iniziatico
dei bambini, dai 3 agli 11 anni, e le tappe del
loro processo di crescita che, tra gli 11 e i 14
anni, si apre all’adolescenza – ha suscitato in
me domande, dubbi e pensieri nei termini
di una viva interrogatio. Credo che la brezza
del desiderio di testimoniare la complessa
condizione umana di chi cerca la propria
strada identitaria sia scaturita dall’esperienza di legame con loro.
Attingendo da questo sentimento di gratitudine, mi sono avvicinata a questo lavoro
di ripensamento, di significazione:
In fondo quello che dobbiamo fare per apprendere è diventare esploratori, e lo scopo
dell’esplorazione non è di scoprire se l’esplorazione è una buona cosa, ma di ricavarne informazioni su ciò che si esplora. (Bateson,1984)
Volevo ripercorrere la mia mappa di viaggio e ripensare ai «naviganti», ai luoghi e
alle storie incontrate.
Interrogarsi per dare
senso alla relazione
Il termine educatore dà adito a una rosa
di possibilità di intendimenti o a un mare
magnum di fraintendimenti. Educare a che
cosa? Sembra ancora ignoto, misterioso,
l’agognato complemento. Potrebbe essere
semplice: l’educatore fa educazione. Ma
questo non ci definisce ancora, condizionati dal fatto che oggi numerose strutture, oratoriali e ricreative, non poche volte
usano il nome «educatore» per indicare un
adulto che intrattiene i bambini: un adulto
intrattenitore.
In questi anni si sono fatti vari bozzetti e
ritratti dell’educatore professionale, a seconda del contesto in cui opera e a seconda
delle trasformazioni avvenute nel panorama
sociale o sanitario.
A volte, per «comodità», l’identificazione
dell’educatore professionale è collocata
dentro un ruolo pensato nel binomio educatore-attività, cosicché l’azione educativa
viene fatta corrispondere a un elenco, una
declinazione di «cose da fare». Il contenuto dei progetti educativi stilati corrisponde
a un mansionario di operazioni e attività,
dove la persona in crescita viene suddivisa
in obiettivi ed elenchi di sotto-obiettivi a
breve, medio e lungo termine, perdendo
così di vista la globalità della persona e il
suo tragitto personale di crescita. Fotocopie dell’essere umano, di cui si pietrificano
aspirazione e desiderio. Di un ideale di essere umano.
Ma è davvero questo il senso del lavoro
educativo? Stilare una cronaca di azioni?
Sembra già tutto previsto dall’adulto, come
in una biografia già tracciata.
Distinguere
dove porta la corrente
La risposta delle istituzioni sanitarie e sociali, di fronte alla complessità di questa funzione educativa, si è orientata allo sforzo, a
volte, di annacquarla, altre di demonizzarla,
altre ancora di caricaturarla: l’educatore è
quello che «bada all’altro» andando a domicilio, quello che fa fare i lavoretti, quello che
accompagna sul territorio, che aiuta a fare i
compiti e così via, con l’assegnazione di un
ruolo di custodia. L’educatore ha avuto in
alcuni casi e in alcuni ambiti le vicissitudini
istituzionali dello «straniero» da integra-
Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni | 95
re, con la sua cultura sconosciuta e quindi
sospetta. In altre esperienze lavorative, l’educatore è stato inteso come un tuttologo
dell’inventiva e del divertimento.
Queste sono alcune delle «onde emotive»
che fremono nel viaggio educativo e che
accomunano gli educatori. Non è sufficiente ripetere che educare è una questione complessa, possiamo dire invece che è
complessa perché fa sviluppare intorno
una complessità di movimenti, fantasie,
aspettative, ideali, realtà, luoghi comuni,
stereotipi. Onde in superficie che hanno
in realtà correnti e mulinelli sotterranei,
meno visibili ma più profondi, che fanno
parte della vita professionale. In fondo, la
profondità di una professione è data dallo
spessore che le si evidenzia intorno.
La pluralità di queste domande ci sta aiutando sempre più a mettere a fuoco che il
lavoro di definire e distinguere per individuarci è veramente un lavoro impegnativo.
Sembra che le rappresentazioni mentali che
ruotano intorno all’educatore, a volte, siano
rimaste cristallizzate e abbiano influenzato le possibilità di un cambiamento reale.
L’ambivalenza che ne deriva in alcuni casi
non è rimasta solo a livello di rappresentazione mentale, ma ricade anche sulla realtà
operativa della professione.
Se un educatore cammina sul filo delle
rappresentazioni istituzionali e assume nel
suo operato una posizione di ambivalenza,
rischia di non avere un suo spazio interno
chiaro, disponibile ad accogliere i movimenti evolutivi reali del bambino, costitutivi per la sua crescita. Il costante «mandato»
del far fare attività, legato all’educatore, ci
muove una domanda fondamentale che
proviamo a esplorare: come si pone l’educatore nella relazione con il bambino? Cosa
ne fa delle comunicazioni del bambino?
Cosa ne fa dell’inattività del bambino, della
iperattività? Che tipo di modello gli offre?
Il farsi soggetto
di ogni bambino
Penso che l’educatore possa mettersi in
contatto con le comunicazioni del bambino
solamente quando riesce a tenere distinte
dentro di sé le sue emozioni e le emozioni
del bambino.
Il continuo lavoro di distinguere è quello
che aiuta a differenziare via via l’adulto dal
bambino, il bambino dall’adulto e a mantenere la relazione di legame. Legame che si
specifica e si definisce nella sua vicinanza e
distanza e nella sua temperatura.
Il lavoro educativo è fatto da questa capacità di entrare nel livello della comunicazione
del bambino e uscire, cioè identificarsi per
aiutare il bambino a cercare e a trovare i
suoi spazi di definizione e disidentificarsi
per mantenere un pensiero sulla relazione.
Viene rovesciata la prospettiva dell’intervento educativo: il bambino, in quest’ottica,
non sarà «oggetto» destinatario di esperienze ludiche pensate e proposte dall’adulto,
ma sarà il soggetto autore di esperienze e
pensieri. Il bambino non sarà «a servizio»
di atelier o laboratori strutturati, ma sarà
l’adulto «a servizio» della relazione come
esperienza: di come il bambino si separa e
si ricongiunge con gli adulti, di come il bambino si mette in relazione con gli oggetti, del
suo rapporto con il gioco, di come esprime
i suoi moti d’animo, emozioni e sentimenti,
di come si mette in relazione con l’adulto, di
come utilizza il suo linguaggio espressivo,
quale canale sceglie per investire le sue rappresentazioni, il corpo, il disegno, la parola,
se interagisce con il gruppo dei pari.
I «materiali» educativi, gli «strumenti operativi», individuabili in questa nostra ricerca, sono quindi da rintracciare nelle dimensioni relazionali che si mettono «in gioco»
e nei pensieri che via via vengono fuori e si
costruiscono nel farsi della relazione.
96 | Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni
È interessante notare come oggi spuntino
tante figure professionali che si occupano
di relazione. Come se la relazione fosse il
male oscuro che ci preoccupa e ci fa sentire
inadeguati, impreparati, incapaci e allora
culturalmente ci «togliamo fuori» dalla relazione continuando a delegare esperti. Abbiamo comunque capito che la relazione
è un bene su cui dobbiamo investire. E la
relazione è qualcosa che sta in mezzo fra il
bambino e l’adulto.
Per comprendere
ci vuole risonanza
Allora, riprendendo il compito che ci siamo
dati, possiamo delineare un adulto che vada
verso una dimensione dell’ascolto. Un educatore che sia capace di mettere in sordina lo strumento verbale a vantaggio, per
esempio, di modalità espressive corporee
dei bambini. Non un educatore quindi che
suggerisca norme di condotta o anticipi soluzioni per correggere il disagio o appianare la difficoltà, ma un educatore empatico
che si metta in contatto con la sua capacità
di risonanza e la utilizzi per comprendere
cosa sta avvenendo, all’interno della comunicazione, attraverso la manifestazione
della difficoltà del bambino. Un educatore,
potremmo dire, che abbia il compito di accordare le corde dello strumento-relazione
attraverso un’attitudine all’ascolto.
La scommessa e la complessità del lavoro
dell’educatore professionale consistono in
un delicato e paziente lavoro di tenere distinti e insieme i diversi livelli che si mettono
in moto in una professione d’aiuto, il livello personale e il livello professionale che
vengono messi «in gioco» nella dimensione
relazionale.
In questo affascinante e complesso mestiere
la cosa fondamentale è tenere viva la disposizione ad andare incontro all’Altro. Principio
fondante delle professioni d’aiuto. Essere
interessati all’Altro quindi, investendolo di
un’aspettativa a ritrovare il suo corso d’acqua. Che c’è, sempre. Magari da sgelare o da
far emergere, come un fiume carsico.
Costruire la competenza relazionale dell’educatore professionale significa essere disponibili a guardare dentro i livelli della
relazione per ri-generarsi in atti di chiarezza, per scrollarsi di dosso quelle pigrizie e
quegli indugi mentali che arrugginiscono i
pensieri, rendendoli a volte anacronistici.
Attraverso questi atti di riformulazione si rispetta il flusso di nuove forme di identità e si
accolgono i cambiamenti e le metamorfosi
che si generano dal di dentro della relazione, inaspettate e insospettate, cioè nuove:
«Sono complessi i processi mentali che si
devono compiere perché l’osservare diventi
fonte di apprendimento» (Bick, 1964).
Dato lo strapazzamento e l’abuso della
parola «educare», nell’intento di dar fede
alla sua complessità, teniamo come punto
di partenza la sua etimologia, che vuole dire
«tirar fuori».
L’attesa è l’incipit
di un pensiero fecondo
Nel corso della mia esperienza mi sono
trovata più volte a chiedermi quale fosse,
quale potesse essere, quale avrebbe dovuto
essere, quale sarebbe diventato l’ob-jectum
da tirar fuori.
Tradurlo, nel suo obiettivo e nella sua possibilità di dinamica, mi faceva pensare a un
contenitore e a un contenuto, a una persona accolta e a una che accoglie. Istituzionalmente, a qualcuno che arriva da fuori
e a qualcuno che aspetta dentro. A due.
Metaforicamente, a un ambiente e a una
materia. Una materia e una forma in un flusso continuo, in una vicendevole influenza
costitutiva. Diceva Michelangelo che nella
Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni | 97
pietra è già inscritta la forma. Rispettare la
vena della pietra, nella relazione di cura,
significa respectare nel senso pieno etimologico: volgersi a guardare il volto dell’Altro.
Il maieuta falegname Geppetto non ha forse
«tirato fuori» dalla materia del legno suo
figlio Pinocchio? Non è questo il senso di
dare alla luce? Non è questa l’azione del
tirar fuori quando Geppetto scolpisce i
sensi a Pinocchio? Geppetto fa Pinocchio
partendo dall’ascolto della voce-sonorità
del legno. È nell’accogliere quello stupore,
quei picchiettii sonori, nel registrarlo dentro di sé, nel tenerlo in considerazione, nel
tendere l’orecchio a dove proviene quella
voce, nell’interrogarsi sul chi è che parla.;
è dentro questo sussulto, questo stupore,
questo sentimento di incredulità e di meraviglia, di sorpresa e di attesa, l’incipit di
un pensiero educativo fecondo.
Poi, in un tempo successivo a questo, Geppetto comincia a osservare la materia legno
da vicino. Solamente dentro queste premesse ha inizio l’atto creativo di intaglio della
gemma educativa a lasciare che l’altro sia
con la venatura del suo legno.
Ecco che allora l’attesa assume un valore, un
senso. Non è forse l’azione educativa un’attesa? Qui si sustanzia la funzione educativa.
Riconoscere i movimenti
trasformativi
Attualmente circola una cultura «educativa» che inseguendo performances è impegnata a sottolineare continue mancanze, a
vedere il mezzo bicchiere vuoto, e trascura
la consapevolezza di che cosa abbiamo e
delle tappe di cammino che abbiamo percorso. Come osserva Donata Fabbri:
Forse non si è ancora a sufficienza capito
che la complessità non è un qualcosa di così
inoffensivo e tranquillo come altre teorie scientifiche, non si è ancora capito che la comples-
sità tocca quello che c’è di più profondo o doloroso in noi: il nostro modo di ragionare e di
conoscere. (Fabbri, 1990, p. 29)
La collocazione degli educatori professionali nel comparto terapisti della riabilitazione, quali psicomotricisti, logopedisti,
fisioterapisti, ha costituito un’altra tappa
di messa a fuoco del ruolo educativo. Nei
cambiamenti legislativi c’è dentro anche
quello che ci si aspetta da un ruolo. Siamo
invitati a fare un altro atto di de-costruzione per cercare di vedere, con l’aggiunta del
compito riabilitativo, i pezzi di cui è fatto
questo puzzle professionale.
Lo suggerisce la definizione stessa dell’azione di ri-abilitare, rendere abile, che
potremmo decodificare orientativamente
come rendere capace. Capacità è anche l’unità di misura di un liquido. Liquido pensato quindi dentro a qualcosa che contenga,
dentro un contenitore. Contenitore che ha
una forma propria. Liquido, quindi, che ha
una misura. Aldo Carotenuto, nel libro Le
rose nella mangiatoia, si chiede:
Cosa significa raccogliere acqua in un’ampolla? Raccoglierla in un’ampolla significa delimitare l’illimitato, dare forma a ciò che non
ne ha, plasmare in una forma. La differenza tra
l’uomo e l’animale risiede nel fatto che solo
per il primo lo sforzo evolutivo è consistito
nell’ordinare il mondo, nel dargli una forma.
(Carotenuto, 1990, pp. 142-143)
Capacità di avere una forma significa definirsi: non una forma costretta e imposta
da condizionamenti, ma che prende corpo
e si sviluppa nelle trasformazioni che si generano nel processo di cura. Processo che,
teniamolo bene in mente, ha quindi una
sua dinamica, ha un dentro e un fuori, parti
visibili e forze invisibili, qualcosa di chiaro
e qualcosa di misterioso, qualcosa che capiamo e qualcosa che si nasconde, qualcosa
che vediamo e qualcosa che sentiamo. Può
98 | Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni
onforto ale.
Non c’è ilacrt
ito music
di uno spacro
è
Il testo s a con la verità
la person storia,
della sua o sono le
lo spartit che, come
emozioni el mare,
le onde dranno
si muove viaggio della
durante il educativa.
relazione
aiutarci il linguaggio del cinema: c’è uno
spazio inquadrato e c’è un fuori campo che
dialogano con lo spettatore. Questi movimenti dialoganti del dentro e del fuori,
nel processo di cura, sono la sua dinamica.
La fiducia per non
perdere la rotta
La meta del compito educativo, da segnare
sulla mappa del viaggio di cura, è quella di
essere d’aiuto alla persona a trovare la propria capacità, l’unità di misura. La propria
definizione-limite, che ne è anche il proprio
contenuto. Il ruolo professionale educativo,
in questo ambito istituzionale sanitario, è
un ruolo di accompagnamento all’evoluzione dell’identità. Ribattezzare con se stessi
questo patto educativo ci aiuta ad andare
alla fonte del nostro compito professionale,
per riattingervi una forza di consapevolezza
che è il senso più vero e faticoso, doloroso
e gioioso nell’esperienza del viaggiare con
la storia degli altri.
Credo, con convinzione, che il sentimento che accompagna e caratterizza questa
specifica professione d’aiuto sia, prendendo a prestito il titolo di un libro, navigare
l’incertezza per farcene qualcosa. Non c’è
una procedura delineata, il conforto di uno
spartito musicale da seguire o di una ricetta.
Il testo sacro, viene da dire, è la persona che
incontreremo con la verità della sua storia,
lo spartito sono le emozioni che, come le
onde del mare, si muoveranno durante il
viaggio della relazione educativa. Incontreremo sentimenti di sconcerto, di spiazzamento, ci sentiremo destabilizzati, inquieti,
ma siamo chiamati a navigare tenendo il
timone della barca, non perdendo di vista
la rotta, e avendo cura dei passeggeri naviganti. Non ci è dato di sapere se l’imprevisto
sarà una tempesta o una bonaccia di vento.
Non si può sapere, a priori, la variabilità
delle condizioni del mare durante l’intero
viaggio. Non si sa quante volte dovremo
buttare l’ancora e ormeggiare la barca. E
aspettare, tremanti dell’incognita anche,
ma fiduciosi.
Sappiamo che dentro a ogni persona esiste
un bambino autentico e lì dobbiamo curare
l’orientamento del nostro intervento educativo affinché diventi per ciascuno «evento
educativo» di avveramento. In ciascuno di
noi, bambino e adulto, esistono dei luoghi
da cercare per ascoltarli e farli parlare, per
poter comunicare e poterci capire.
Ciò che abbellisce il deserto, disse il piccolo principe, è che nasconde un pozzo in qualche
luogo... (Saint-Exupéry, 1987, p. 104)
Questa fiducia di base è il sapere della
premessa educativa dell’educatore professionale.
Il legame
spazio dell’autonomia
Il paradigma del lavoro educativo è la competenza relazionale costituita dall’ascolto
empatico, dalla capacità di distinguere,
dalla capacità di attesa, dalla consapevo-
Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni | 99
lezza e dall’assunzione dell’incertezza.
Costruire la competenza relazionale del lavoro educativo vuol dire aprire la prospettiva di una professione maieutica. L’identità dell’educatore poggia sulla competenza
relazionale. Una relazione che educe, cioè
«tira fuori» tracce, segni, forme, disegni,
significati, punti di approdo, paesaggi mentali. Una relazione che riconosce le intenzioni, cioè le «tensioni verso» la coscienza del
rappresentarsi dentro le differenze necessarie per individuarsi, cioè per riconoscersi come individui: io, io con l’altro, l’altro
e non io, io e non l’altro, noi, l’altro, lui.
Una relazione che accompagna i passaggi
evolutivi della dipendenza, indipendenza e
interdipendenza, volti a differenziarsi per
individuarsi.
Dentro l’istituzione sanitaria il ruolo pensato come «specifico» per far raggiungere
l’autonomia e la socializzazione del bambino è il ruolo dell’educatore. Se l’autonomia è qualcosa da raggiungere, è necessario
pensare a un luogo di partenza da cui uscire,
da cui muoversi, da cui partire. Il primo
pensiero che ho incontrato in questi anni
è stato questo pensiero-scoglio. Scoglio che
può essere un luogo di partenza, di arrivo, di sosta o di salvataggio, a seconda del
punto in cui il bambino si trova nella sua
traversata.
Se l’autonomia è luogo di approdo, è
impensabile non figurarsi un «da dove
vengo?». Ecco, in questi anni mi è stato necessario accompagnare i bambini a cercare
quel luogo di partenza, a vedere se c’era,
se c’era stato, se c’era ancora, se rimaneva
una traccia consapevole. Ancora un luogo
di legame: l’attaccamento.
È in questa fase che l’educatore si può
trovare fra due sponde: da una parte il bisogno del bambino, dall’altra il mandato
di autonomia e socializzazione di cui, pur
prescritto come punto di arrivo, non si scor-
ge nemmeno l’orizzonte. Ci si può sentire
come impigliati dentro una rete di bisogni:
del bambino, dell’istituzione e del ruolo
educativo. Come se la sopravvivenza di
un bisogno dovesse farne morire un altro.
Ci si sente dibattuti, come un pesce fuor
d’acqua.
Qui si gioca la responsabilità dell’azione
educativa che ha la funzione di fare da ponte
tra, possiamo dire, il mandato istituzionale assegnato e il bisogno emotivo espresso
dal bambino in quel momento. È necessario, quindi, porci domande sul bambino e
sull’adulto: su quale bambino abbiamo in
mente (che sia) e su quale adulto abbiamo
in mente (di essere).
Una relazione è educativa e d’aiuto quando
è portatrice consapevolmente della possibilità trasformativa ed espressiva del bambino
in crescita, la accompagna, la sostiene e la
riconosce.
Il rispetto per
l’andatura del bambino
Per essere d’aiuto al bambino è necessario
anche saper tenere emotivamente nella relazione: si profila un educatore che affina la
capacità di sopportare i momenti di confusione, di sostare nei momenti di vuoto e nelle
apparenti incrostazioni delle non ispirazioni, di accogliere gli intagli delle contraddizioni, le lacerazioni dei «non so», del patire
i tempi morti, le densità dei silenzi come
nebbie padane, la comparsa dei punti di
luce, gli andirivieni delle incertezze, di cavalcare «il peregrino dubbio», di indossare
le rabbie della solitudine, il timore del bello.
La relazione educativa è fatta da tutti questi traghettamenti reali e interiori, tra esitazione e trepidazione, tra struggimento e
felicità.
Orientarci a questo livello di riflessione
aiuta a trasformare i luoghi comuni in
100 | Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni
luoghi di senso per ridefinire la tappa di
percorso evolutivo del bambino e specificare il progetto educativo, discutendolo e
confrontandolo, passo dopo passo, con gli
operatori coinvolti. È necessario rispettare
l’andatura del bambino per evitare il rischio
di uno scollamento fra quello che hanno in
mente gli adulti e quello che sta già facendo
il bambino.
Mi viene alla mente, per esempio, tutto il
lavoro che fa il bambino nella fase iniziale
di messa alla prova della relazione, quando
è impegnato a «studiare» l’adulto, la sua
affidabilità e capacità di tenuta: il bambino
a volte esce ripetutamente dalla stanza, abbandonando l’adulto per andare a rifornirsi
affettivamente della presenza del genitore
o accompagnatore; spesso chiede di portare a casa un oggetto per sé, chiede che il
suo gioco rimanga intatto e custodito per
la volta seguente.
All’insegna di queste comunicazioni del
bambino, l’educatore ha una funzione
precisa da svolgere: creare una base sicura
all’interno di un sentimento di continuità
relazionale. Un lavoro educativo che legga
costantemente i bisogni emotivi del bambino e che attraversi, simbolicamente, le
prove della storia del «lupo e i tre porcellini», per sentire se la relazione tiene. E la
relazione tiene solo dopo che si sono create
queste condizioni di base: di stabilità e di
sicurezza e un ambiente di fiducia di cui
il bambino fa esperienza e in cui si sperimenta.
Nuovi significati verso
nuove rappresentazioni
Ci sono delle tappe da percorrere prima di
arrivare all’autonomia e perché questa autonomia sia un pensiero su di sé che parta
realmente dal bambino: sono le tappe costitutive del processo di crescita del bambino.
La funzione educativa nella relazione con il
bambino si sostanzia, inoltre, nel prendere
in considerazione il gesto stereotipato del
bambino per muoverlo alla rappresentazione.
Come guardare con uno sguardo nuovo la
rappresentazione del bambino?
Per fare l’esperienza di questo sguardo «in
movimento» è necessario ascoltare, con un
orecchio interiore, il riverbero emotivo che
il bambino ci com-muove. Questo riverbero
diventa spazio di immagini, di significati
che inaspettatamente emergono e si affacciano nella relazione. E la nutrono e la fanno
vivere, la fanno esistere. Questo spazio di
significati è il punto vitale della relazione
educativa: il nodo d’innesto.
Possiamo pensare, per esempio, al momento in cui spontaneamente un oggetto di un
gioco ricorrente, un segno grafico reiterato,
una parola ripetuta, una mimica ostinata,
muove una suscitazione o un’associazione
inaspettata e insospettata, nuova. Come
se quel «solito», quello «stesso» oggetto o
segno o parola o silenzio o mimica si sganciano, si liberano dalla capsula, dal giogo
di un significato, e ricevono la luce di uno
sguardo nuovo che fa gemmare un’intuizione e risplendere un altro significato di
senso: un senso trovato.
Di frequente, se si pensa all’esperienza
educativa, si presentano momenti o incontri che paiono infiniti, dentro a un noto e
conosciuto, come imprigionati in un fermo
immagine, come se «nel gesto in cui ciascuna fu sorpresa, in quello restò fissata»,
come disse il poeta Ovidio.
Momenti che sembrano risentire di un
significato-incantesimo, dove il tempo, il
bambino e l’adulto paiono cristallizzati.
A questo punto, dobbiamo essere prudenti perché a volte i nostri stereotipi, i nostri
sguardi spenti o stanchi, le nostre paure,
le nostre difese ottuse, le nostre emozioni
Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni | 101
congelate, ci impediscono di cogliere i movimenti insiti nella relazione o, semplicemente, di leggere il fermo immagine. Può esserci
d’aiuto Eugenio Montale quando scrive:
Non domandarci la formula che mondi possa
aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come
un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò
che non siamo, ciò che non vogliamo.
È proprio a questo punto che, per tacitare questi turbamenti, a volte spuntano le
parole-targhette come palette di un vigile
ammonitore: aggressivo, reattivo, ipercinetico, non collaborante e via di questo
passo. Oppure è a questo punto che entriamo in contatto con questo spazio congelato
in attesa che si sgeli. Come suggeriscono
alcuni autori:
Questo spazio impone capacità di manutenzione e di salvaguardia e in cambio ci dà informazioni e testimonianze che nessuno strumentario scolastico di osservazione sistematica e
di valutazione oggettiva potrà fornire. Gli elementi che permetterà di incontrare non potranno essere esportati se non dopo essere stati
interrogati, compresi. (Cerioli, Antonietti, 1995,
p. 96)
È accompagnando questo tempo di «sgelamento» che potremo rinvenire il bambino: la funzione dell’intervento educativo a
volte è nel riconoscere semplicemente che
«per il momento è così», lasciando aperta
però la possibilità di un cambiamento.
Per accompagnare i passaggi di crescita del
bambino è necessario anche all’educatore
osservarsi nei suoi cambiamenti, svilupparsi, crescere perché in una relazione educativa avviene una trasformazione per entrambi:
il bambino e l’adulto. Questo paziente lavoro mentale di «ri-costruzione» va nel senso
di far uscire una forma di rappresentazione
condivisa e utile, affinché il bambino possa
sapere dove mettersi e si possa «ritrovare».
Tenere presenti e insieme questi piani dif-
ferenti ci aiuta a vedere la complessità e la
ricchezza di cui «è fatto» un bambino impegnato nell’impresa di crescere.
Un gruppo per pensare
la progettualità
È necessario pensare al contesto in cui è
inserito l’intervento educativo. Se l’istituzione sanitaria ha previsto l’inserimento
dell’educatore nell’organico, ci sta in fondo
dicendo che la strada della tutela della salute mentale deve integrare la via medicoclinica e la via educativa per andare verso
la storia del bambino e comprenderla, per
un progetto di cura pensato in funzione del
suo processo di crescita.
La responsabilità dell’azione educativa non
si esaurisce nel rapporto con il bambino,
ma riguarda anche i «momenti di scalo» tra
gli operatori coinvolti, per tenere a mente
una rotta di navigazione che non perda di
vista il bambino intero. Interagendo e confrontando in una dimensione dialettica e di
reciprocità le differenze operative, si coltiva, all’interno dell’istituzione sanitaria, una
cultura reale della diversità come risorsa,
della differenza come occasione di arricchimento, come espressione della unicità
e della molteplicità.
È auspicabile un gruppo di lavoro che si
assuma la funzione di pensare ed elaborare.
Quando il gruppo di lavoro, come quello
a cui qui si fa riferimento, è composto da
ruoli eterogenei, ha da tenere insieme più
linguaggi: quello medico-clinico, quello
educativo, quello tecnico-riabilitativo. Il
lavoro di pensare, nella pratica operativa,
si trasforma in un lavoro di «tenere nella
mente» e di apprendere la differenza che
fa la ricchezza e la ricchezza che fa la differenza. Sarà una responsabilità democratica, individuale e collegiale, nei confronti
del gruppo operativo, fondata sul dialogo,
102 | Animazione Sociale marzo | 2015 luoghi&professioni
sull’ascolto e sulla pazienza per «fare una
mente» intorno al progetto di cura. Una
responsabilità non fondata sulle contrapposizioni, rigidità e atteggiamenti di potere
e di disparità, ma che si mette in gioco in
una relazione dinamica flessibile e trasformativa, che può crescere.
I bambini ci raccontano
storie di vita
Uno strumento basilare nel lavoro educativo è il lavoro di scrittura: una trascrizione come atto di ripensamento, di rimessa
a fuoco e di progettualità. Dov’è finito il
taccuino delle annotazioni, fedele compagno di viaggio degli artisti di un tempo, di
scrittori o poeti dell’anima? Chi parlerà più
della biografia dei processi educativi?
Il lavoro educativo è, abbiamo visto, qualcosa che si costruisce nel tempo. Non avvalendoci di protocolli scientifici che ricavano
un dato numerico tecnico espresso in percentuale, a servizio del processo personale
svolto e compiuto dal bambino, sembra una
fatica di Ercole individuare uno strumento
riconosciuto a misurare quantificamente,
quindi visibilmente, l’intervento educativo
in ambito sanitario.
Scrivere ci consente di convertire l’esperienza vissuta in una forma di rappresentazione perché ci permette di de-scrivere le
sequenze del processo di costruzione del
bambino. Attraverso questo delicato lavoro
di montaggio dei movimenti, delle scoperte,
delle soste, degli andirivieni, degli spostamenti, dei paesaggi mentali del bambino,
documentiamo la sua evoluzione e gli restituiamo la sua storia. In quest’ottica, il ruolo
educativo circostanzia, attraverso il mezzo
della scrittura, la sua funzione di costruire e
restituire senso. Quindi una narrazione che
utilizza un linguaggio che non assolutizzi il
bambino, ma accompagni le sue immagini,
le sue parole-frasi, i disordini, la confusione
e la chiarezza, le difficoltà e le conquiste, che
avvalori l’impresa del bambino che smonta e rimonta, disfa e costruisce. L’utilizzo
della metafora, che fa lavorare insieme due
mondi vicini e accosta campi di conoscenze,
può essere nel nostro lavoro una risorsa per
far nascere qualcosa che possiamo vedere
figurativamente e per aiutarci a comunicare
e condividere il processo del bambino.
Una narrazione, possiamo dire, che sostenga lo sforzo conoscitivo del bambino e rispetti il suo personale e autentico processo
di crescita. In questa nostra riflessione la
metafora del navigare è stata d’aiuto per
cercare di individuare e non perdere «ancoraggi» possibili.
Il nostro viaggio ha esplorato la mappa della
relazione che «si fa» ambiente educativo
accompagnando le possibilità evolutive del
bambino che «gioca» con i suoi pensieri,
che si trasformano in punti di vista, idee,
concetti e valori per crescere e comunicare.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
• Bateson G., Mente e natura, Adelphi, Milano
1984.
• Bick E., L’esperienza della pelle nelle relazioni
oggettuali precoci, in Bonaminio V., Iaccarino B. (a
cura di), L’osservazione diretta del bambino, Boringhieri, Torino 1964.
• Carotenuto A., Le rose nella mangiatoia, Raffaello
Cortina, Milano 1990.
• Cerioli L., Antonietti A. (a cura di), AnalogicaMente: pensare pensarsi apprendere, Irrsae Lombardia, Milano 1995.
• de Saint-Exupéry A., Il piccolo Principe, Bompiani, Milano 1987.
• Fabbri D., La memoria della regina, Guerini,
Milano 1990.
Gilda Vischia, educatrice professionale, lavora nell’Unità operativa di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza di Varese:
[email protected]
bazar | punto Casorati | discussione | diari | libri | segnalazioni | locande
punto
Illustrazione e testo di
Francesco Casorati
Collina imbrigliata, 1996,
matita e penna.
Non ho mai capito la differenza tra un
quadro astratto e uno figurativo.
Per me la pittura è sempre la stessa e
quando guardo un quadro di un artista
o dipingo una tela quello che conta
sono la composizione delle immagini,
i rapporti dei colori fra di loro, l’idea
pittorica nel suo insieme e guardare il
quadro da molto vicino per godermi
l’andamento delle pennellate.
E se qualcuno mi domandasse perché
io non faccia allora della pittura
astratta, gli risponderei che forse non
ne sarei capace, che sento la necessità
di usare delle figurazioni, che, in fin dei
conti, mi piace raccontare delle cose ed
usare delle immagini tratte non dalla
realtà ma da antiche memorie
sovrapposte e che arrivano non so
come nella mia testa.
104 | Animazione Sociale marzo | 2015 bazar
«Case» della coesione sociale nei territori/1
Il manifesto
delle Case del quartiere
Coordinamento delle Case del quartiere di Torino
SOSTE DI DISCUSSIONE
La coesione sociale è una costruzione collettiva nei territori, nella quale convergono
l’investimento pubblico, la competenza degli operatori professionali, la disponibilità
delle reti sociali che innervano i territori, l’allestimento di luoghi fisici che i cittadini
vedono come simboli della vivibilità dei territori. Il «manifesto delle Case del quartiere»
di Torino ci permette di aprire un confronto, al di là delle etichette, tra le molteplici
sperimentazioni in Italia.
N
egli ultimi anni a Torino
sono stati aperti spazi comuni, laboratori sociali e culturali in cui s’incrociano attività
e persone, luoghi nei quali si
esprimono pensieri e vissuti
collettivi, che avviano esperienze di partecipazione, coinvolgimento e auto-organizzazione,
spazi che oggi hanno un nome:
Case del quartiere.
Luoghi che si abitano, si vivono
e si usano, che nascono da una
storia di una città attiva e creativa, che ha visto già nei decenni
precedenti sperimentazioni di
luoghi capaci di innescare pensieri e progetti e di coinvolgere
parte della cittadinanza. Alla
fine degli anni Novanta, dalle
proposte di politiche urbane
innovative e dagli stimoli delle
istituzioni europee che spingevano ad adottare approcci nuovi, nascono spazi di uso pubblico che superano le politiche
settoriali e lavorano insieme ai
cittadini per mettere in comunicazione centri e periferie.
La Città di Torino raccoglie
questi stimoli e nel 2007 nasce,
in una zona periferica della città, la prima Casa del quartiere:
Cascina Roccafranca. Negli
anni seguenti si sviluppano
nuove esperienze in altri quartieri della città, attraverso storie
e percorsi diversi ma con una
base comune: spazi a uso pubblico riqualificati, grazie alla
collaborazione tra istituzioni
pubbliche, fondazioni bancarie, imprese sociali, associazioni e cittadini, luoghi che diventano spazi per la cittadinanza.
Da maggio 2012 la Città ha
invitato i soggetti gestori delle Case a riunirsi intorno a un
tavolo con il proposito di coordinare le attività attraverso
il consolidamento di una rete
per mettere in comune saperi,
esperienze e progetti.
Presente e futuro
in un documento-manifesto
Un primo risultato del percorso
di costruzione della rete è la stesura del «Manifesto delle Case
del quartiere». Un documento
che raccoglie gli elementi che
caratterizzano questi nuovi
spazi nella città, riaffermando
l’importanza di pratiche sociali
e culturali consolidate, ma soprattutto evidenziando quegli
aspetti d’innovazione che le
rendono caratteristiche e uni-
che nel ricco panorama delle
offerte culturali che la città offre. Un manifesto che racconta
il presente e nello stesso tempo
le prospettive per il futuro, un
utile strumento di lavoro, che
consente alle Case di confrontarsi tra loro con quel che hanno
realizzato fino a oggi e di tracciare un percorso per crescere
e svilupparsi in futuro.
L’idea delle Case nasce da una
convinzione: le persone sono
portatrici di bisogni, ma anche
di competenze e disponibilità
che possono essere messe a disposizione della comunità per
soddisfare esigenze collettive.
Sono esigenze che nascono dalle difficoltà di vivere in modo
dignitoso, da bisogni primari
insoddisfatti come il lavoro e
la salute, dall’essere soli nell’affrontare le difficoltà della vita
quotidiana, dalla mancanza
di relazioni significative, dalla
necessità di dare senso e significato alla propria vita; ma anche dal desiderio di continuare
a sentirsi attivi, di partecipare
alla socialità del quartiere, di
essere protagonisti della propria vita, di poter contare nelle
decisioni che riguardano la
Animazione Sociale marzo | 2015 bazar | 105
Comunità, di vivere uno spazio
politico dove costruire soluzioni possibili e condivise.
Le Case possono contribuire a
creare una coscienza collettiva
che renda consapevoli le persone della propria situazione,
e possa stimolarle a essere cittadini attivi, autonomi, solidali
e responsabili.
Essere cittadini oggi è, infatti,
uno dei modi in cui si partecipa
alla cosa pubblica, una modalità
nuova che si realizza non nella
sfera della rappresentanza istituzionale, bensì nel fare cose
concrete, nella partecipazione
alla soluzione dei problemi che
interrogano il singolo e la collettività, nel cercare di dare risposte
non solo alle proprie necessità,
ma partendo da queste per comprenderle in quelle di altri.
Questo nuovo modo di concepire il rapporto fra città e cittadini, non più fondato sul rapporto dare/avere, operatore/
utente, ideatore/utilizzatore,
ma sullo scambio di competenze ed esperienze, trova espressione nelle Case in cui attività e
iniziative non sono solo «per»
i cittadini, ma anche «con» i
cittadini, che si prendono cura
dei propri bisogni, integrando
le risorse pubbliche con quelle
di tempo, di capacità, di relazioni, di vissuti e di idee di cui
sono portatori.
Veniamo dunque ai dieci punti
del Manifesto così come sono
emersi da molteplici momenti
di confronto fra gli operatori.
1 | Luoghi aperti
a tutti i cittadini
Le Case sono organizzate per
accogliere, attraverso attività
interculturali, tutti i cittadini
dai più piccoli agli anziani, sen-
za discriminazione di genere,
nazionalità, estrazione sociale
e appartenenza religiosa. Si impegnano a soddisfare esigenze
differenti, con un’attenzione
specifica ai diversi livelli sociali
e culturali delle persone. Esse
promuovono iniziative popolari, curando la qualità delle
proposte e coniugando cultura
con socialità. Non si rifanno a
un’ideologia con riferimenti a
simboli, bandiere e movimenti,
ma rispettano i differenti orientamenti culturali. Si riconoscono, invece, in valori universali
come la libertà di espressione,
il diritto di partecipare alla vita
sociale e politica, l’uguaglianza
tra le persone, la giustizia sociale, lo spirito di solidarietà e il
rispetto dei diritti umani.
2 | Spazi
di partecipazione attiva
Le Case promuovono la partecipazione alla vita sociale e culturale dei quartieri attraverso
differenti forme di cittadinanza
attiva e di volontariato. Sono
luoghi in cui si ricercano e si sperimentano nuovi modi di fare
welfare, sviluppando le reti di
prossimità, attraverso la ricerca
pratica di soluzioni collettive a
bisogni e attese comuni.
Sono spazi capaci di accogliere
e sostenere: la singola persona,
valorizzandone le competenze
e sostenendone il mettersi in
gioco; i gruppi informali che
sviluppano interessi comuni, favorendone la nascita, la crescita
e l’autonomia; le associazioni, i
gruppi di associazioni, gli enti
e le istituzioni, rafforzandone
l’identità e la missione.
3 | Luoghi accessibili
e generativi di incontri
Le Case possono re
contribuire a crea
una coscienza
oli
collettiva che stimre
se
es
gli abitanti a
cittadini attivi, sabili.
solidali e respon
Accoglienti, curate e attrattive,
le Case del quartiere sono innanzitutto costruite attorno a
criteri di accessibilità.
• Economica, anzitutto. Offrono attività gratuite e praticano
prezzi popolari e contenuti.
• Organizzativa, poi. Sono organizzate in modo «leggero»,
permettono cioè un accesso
libero alle strutture, un contatto diretto con gli operatori
e la possibilità di ottenere informazioni in modo semplice
e non burocratico.
• Culturale, infine. Hanno una
visione aperta, non ideologicamente schierata, rispettosa dei
diversi orientamenti politici
democratici, delle diversità
culturali e di genere.
Trattasi dunque di luoghi della
quotidianità, che permettono
di sentirsi a casa, in una dimensione sociale aperta, dove
è possibile «stare» socializzando e dove si può «fare» partecipando alle attività o diventando i promotori di progetti e
iniziative.
Nell’insieme favoriscono in
modo intenzionale le relazioni
fra le persone, la conoscenza,
l’incontro e il confronto fra le
realtà che vi operano, fra i progetti che si realizzano, e creano
le condizioni per far nascere
sinergie e collaborazioni.
106 | Animazione Sociale marzo | 2015 bazar
4 | Spazi di tutti ma sede
esclusiva di nessuno
Come una piazza, aperta e
ospitale, ogni centro accoglie
numerose organizzazioni dando loro uno spazio per attività
e incontri, con l’attenzione che
non prevalga un uso esclusivo.
I locali e gli spazi sono organizzati e strutturati per rispondere
alle differenti necessità degli
utilizzatori, mentre le attività
dei gruppi si svolgono in libertà
e autonomia, contribuendo nel
loro insieme alla progettualità
complessiva e alla costruzione
di un’identità comunitaria.
5 | Contenitori
di progettualità molteplici
Come vivi contenitori, pensati
e organizzati, le Case sono in
grado di raccogliere e valorizzare un mix di attività e iniziative
culturali, artistiche, sociali e
ricreative, sportelli d’informazione e consulenza, corsi a
pagamento, laboratori gratuiti,
servizi per famiglie, spettacoli,
conferenze, mostre.
Le strutture accompagnano e
supportano i soggetti che intendono promuovere al loro interno progetti ed eventi, mettendo a disposizione competenze,
spazi, idee e risorse perché questi possano realizzarsi in modo
adeguato e soddisfacente, con
un sempre maggiore livello di
autonomia e auto organizzazione. Più da vicino, sono un punto di formazione e promozione artistica e culturale, poiché
riconoscono nella creatività e
nell’espressione artigianale uno
strumento potente per generare comunità e futuro.
Le diverse realtà della rete
trovano la loro forza negli elementi che le uniscono e che le
diversificano come la specificità
che nasce dalle singole storie,
territori e persone.
6 | Gli operatori
competenti artigiani sociali
Ogni Casa è gestita da gruppi di
lavoro in grado di svolgere funzioni progettuali e organizzative, coordinati da figure di responsabilità in grado di curare
la regia complessiva attivando
modelli gestionali partecipati.
Gli operatori sono artigiani sociali, che agiscono e sviluppano
la propria professionalità attraverso l’apprendimento che nasce dall’esperienza e dalla sua
analisi, da percorsi formativi,
dall’attivazione di scambi e sperimentazioni. Essi sono stimolati a sviluppare competenze in
diversi ambiti: sociale, relazionale, culturale, organizzativo e
amministrativo, sviluppando le
capacità di accogliere, ascoltare, accompagnare e motivare i
cittadini a essere protagonisti
della vita socio-culturale della
comunità.
7 | Luoghi intermedi
fra il pubblico e il privato
Le Case sono il risultato di
azioni di «amministrazione
condivisa» per la rigenerazione di beni comuni urbani,
frutto della collaborazione tra
Amministrazione comunale e
cittadini attivi.
In tal modo svolgono un’importante funzione pubblica,
essendo luoghi privilegiati di
sviluppo di cittadinanza e di
costruzione di reti sociali, di cui
le Amministrazioni pubbliche
condividono le azioni, le linee
guida e le modalità di lavoro.
Luoghi di aggregazione ma
anche strumento per costruire
nuovo «welfare urbano», le
Case del quartiere sono spazi
condivisi in cui i bisogni personali possono essere soddisfatti
in modo collettivo, in cui viene
dunque sollecitata la partecipazione e la relazione, dove è più
che mai evidente la produttività
del fare insieme.
8 | La sostenibilità economica
fa leva sull’intraprendenza
Le Case sono progettate per
tendere alla sostenibilità economica. In tale logica sviluppano
competenze imprenditoriali
nella gestione delle risorse,
nella lotta agli sprechi, nello
sviluppo di attività commerciali accessorie e funzionali al
progetto, nel coinvolgimento
diretto dei cittadini, promuovendo iniziative di fundraising
e di contribuzione collettiva.
Non sono, però, interessate a
raggiungere la completa autosostenibilità economica, che
comporterebbe il rischio di
cadere in logiche economiche
di mercato e di snaturare la vocazione popolare e sociale del
progetto. Per queste ragioni e
per la funzione pubblica che
esse svolgono, è indispensabile un sostegno da parte di enti
pubblici e privati nel finanziare
parte dei servizi che rispondono ai diritti di uguaglianza e
pari opportunità.
9 | Il radicamento
e le collaborazioni territoriali
Le Case fanno parte del territorio in cui nascono e si determinano. Sviluppano – al loro
interno e con le realtà con cui
s’incontrano, siano esse profit
o no profit –­ la capacità di generare ponti, confrontare pensieri e metodi, attivare sinergie
Animazione Sociale marzo | 2015 bazar | 107
nuove. Esse creano l’ambiente
adeguato per costruire relazioni e legami sociali: privilegiano
l’attivazione delle reti attraverso il fare insieme, lo sviluppo
di progettualità comuni, la relazione tra le persone, i gruppi
e i progetti.
Nell’ottica di allargare la propria azione a tutto il territorio,
esse cercano la collaborazione
con le realtà e le strutture presenti nel quartiere in una prospettiva progettuale di «casa
diffusa», capace di esprimersi
al di là dei propri spazi.
10 | Governance condivisa
con gli attori locali
Le Case sono gestite da diversi
soggetti radicati nel territorio:
associazioni di primo e di secondo livello, fondazioni o cooperative, in alcuni casi frutto
di un vero e proprio percorso
partecipativo che ha coinvolto
nella fase istitutiva numerosi
attori locali.
Sono strutture organizzative
in grado di contribuire alla
riqualificazione del quartiere
coinvolgendo le diverse realtà
locali, valorizzandone il lavoro, le iniziative, la capacità di
rapportarsi con i cittadini, riconoscendo tutto questo come
un effettivo patrimonio spendibile per costruire in modo
corresponsabile una risposta
locale orientata a migliorare e
sviluppare il territorio.
In definitiva, una Casa è un
modello gestionale capace di
apprendere dall’esperienza, di
verificare costantemente la rispondenza delle varie iniziative
attivate, di cogliere e analizzare
bisogni e aspettative, di aggior-
nare continuamente il proprio
progetto adattandolo alle nuove esigenze.
Le Case del quartiere, attualmente nove, coprono quasi completamente il territorio della città
di Torino: Cascina Roccafranca a
Mirafiori Nord (www.cascinaroccafranca.it), Casa del quartiere di
San Salvario (www.casadelquartiere.it), Bagni pubblici di via Agliè
in Barriera di Milano (https://
bagnipubblici.wordpress.com),
Hub Cecchi Point nel quartiere
Aurora (www.cecchipoint.it), Casa
nel Parco a Mirafiori Sud (www.
casanelparco.it), SpazioQuattro
a San Donato (www.piuspazioquattro.it), Barrito in zona Nizza
Millefonti (www.barrito.to.it), Bossoli83 nella zona Lingotto (www.
bossoli83.it) e Casa di quartiere
Vallette (http://i74010.wix.com/
casadiquartiere).
Storie di recovery
Il lungo viaggio
verso la ripresa di sé
A cura di Izabel Marin
Le persone che hanno vissuto
su di sé l’esperienza del disagio
mentale hanno cose importanti
da dire: sui propri percorsi individuali, sui momenti frammentati
di malessere e di benessere,
sull’esperienza acquisita attraverso la propria sofferenza. Da
qui l’importanza di ascoltare le
loro storie. Ne proponiamo due
– quella di Silva e quella di Pietro – raccolte dopo e durante le
loro esperienze di cura nei Centri
di salute mentale di Trieste. Per
quanto diverse, raccontano la
possibilità di riconquistare la pro-
I DIARI DELL’OPERATORE
pria «salute mentale». Per un’ampia raccolta di storie si rimanda
al volume Guarire si può (a cura
di Izabel Marin e Silva Bon), nella collana «180. Archivio critico
della salute mentale» dell’editore
alpha beta Verlag di Merano (Bz).
Silva e l’importanza
dell’agenda
I
l trauma della mia vita è stata
la separazione. Ho sempre
dato molta importanza alla fa-
miglia, e quindi, se fosse dipeso
da me, non avrei mai rotto il
matrimonio. In coincidenza
con la separazione c’è stato il
primo episodio di ricovero in
ospedale.
Avevo incominciato ad avere un senso di insicurezza, a
sentire voci, come se gli altri
mi parlassero, mi guidassero.
Tutto ciò è degenerato alla fine
di un anno scolastico, l’anno
in cui poi mi sono separata, a
108 | Animazione Sociale marzo | 2015 bazar
Una cosa che
mi aiuta a
difendermi nei
»
momenti di «vuoto
è l’agenda.
i
Cerco di mettermo
nn
fa
i
m
e
ch
cose
sentire sicura.
settembre. Ero molto stanca
per la fine del lavoro a scuola,
ma soprattutto per un anno di
tensione in famiglia.
Per motivi compositi e complessi in quel momento rappresentavo l’anello debole di
una catena: i miei figli (uno
di 14 anni, l’altro di 16) non
hanno potuto scegliere di stare
con me, in qualche modo sono
stati ricattati e sono rimasti col
padre. Ho subìto il dramma
dell’abbandono della famiglia,
dei figli, della casa. Ancora
adesso non riesco a liberarmi
da quel ricordo.
Tutta la solitudine nella quale
ero piombata, pur vivendo in
famiglia, ho cominciato a vincerla proprio nel momento del
primo ricovero. Ho iniziato a
riflettere e a parlare dei miei
problemi. A ripensare al passato e a segnare mentalmente
tutte le cose che avrei voluto
fare in futuro per me, invece di
vivere solo per gli altri.
Il periodo in cui ho cominciato a essere curata al Centro di
salute mentale di Barcola (Ts)
ha rappresentato un momento
di ripresa. È stato un periodo
molto faticoso, con un’andatura da gambero, un po’ avanti e
un po’ indietro. Adesso ho l’im-
pressione che anche questi momenti di crisi siano dei passaggi
positivi, prima vissuti come una
regressione, una sconfitta, ma
dopo il recupero, alcuni giorni
dopo, mi sembra che tutto sia
comunque un andare avanti nel
percorso di guarigione.
Mi è stato d’aiuto soprattutto
il modo di parlare dei medici
e degli operatori, per cui sono
riuscita a capire il percorso della malattia, il senso dello stare
bene e dello stare male, dell’andare a fondo. Sono stata aiutata
prima di tutto a ricostruire un
progetto per la mia vita. Ho ritrovato interessi intorno a cose
già concretamente avviate e che
durante gli ultimi anni del matrimonio avevo abbandonato.
Al Csm, oltre a una certa scansione temporale dei colloqui,
più frequente rispetto a quelli
che possono essere sostenuti
con il medico privato, ho trovato tutto un insieme di agganci, di progetti, per esempio il
«gruppo donne di Barcola»,
che portiamo avanti da tre
anni. Il gruppo si è organizzato intorno a letture di testi che
proponevamo io e un’amica,
insegnante pure lei. Andavo
là dopo una giornata faticosa
di lavoro e mi chiedevo «ce la
faccio ad andare a Barcola con
l’autobus oggi pomeriggio?».
Ma ogni volta ritornavo a casa
molto più rilassata. Con alcune
persone di questo gruppo ho
costruito rapporti veri di amicizia, riuscendo a scoprire da
un lato problemi simili ai miei,
dall’altro possibilità diverse e
nuove di farvi fronte.
Una cosa che mi aiuta a
difendermi nei momenti di
«vuoto» è l’importanza dell’agenda. Programmo la mia vita.
Poi sono disposta anche a cambiare tutto: se c’è l’imprevisto
magari tutto quello che ho programmato va a monte, però, da
quando sono sola, ho raccolto
tutta la mia vita nelle agende.
Anno per anno sono sempre
più fitte di appuntamenti e di
cose da fare e che mi interessa
fare. Questo mi aiuta a coprire
certe assenze. Cerco di fare delle cose che mi piacciono, che mi
fanno sentire sicura.
Ultimamente ho vissuto un
piccolo episodio di sofferenza
psichica in coincidenza con
il capodanno. In questi casi,
prima di stare male veramente
cerco di rivolgermi a un medico, prendo delle medicine
che ho a casa. Ho imparato.
Quest’anno sono andata con il
taxi, di mia scelta, al Servizio
di diagnosi e cura, pensando
molto consapevolmente che
mi avrebbe aiutato. La mattina
dopo sono tornata a casa e ho
ripreso la vita normale. L’importante è riuscire a capire in
anticipo che si ha bisogno di
aiuto.
La timidezza mi condiziona
moltissimo quando sto male.
Fa parte di questo processo
di ricostruzione impegnarsi
per vincerla. Per esempio, arrossisco come una bambina
e nei rapporti sociali questo
inibisce anche l’interlocutore,
quindi dopo mi colpevolizzo e
dico: gli altri stanno male in mia
compagnia. Adesso mi ascolto,
mi analizzo, sono consapevole
che i momenti di tensione, di
imbarazzo accadono più frequentemente in concomitanza
con le crisi.
Animazione Sociale marzo | 2015 bazar | 109
Nei momenti in cui sono
socialmente più debole, ho
questo rossore, questo imbarazzo, magari mi viene la
paura di uscire di casa. Ma se
non esco il problema diventa
più assillante, lo collego con
la crisi e cerco di tenerlo sotto
controllo. Il rossore è come
un handicap, è come essere
balbuziente. Quando si scatena, è più forte di me e mi fa
sentire sconfitta. La mia autostima cade verticalmente. È un
circolo vizioso: io mi disistimo
e la paura del rossore diventa
più assillante. Ora mi sembra
un poco alla volta di saper
controllarmi di più. Guarire
per me è riuscire a vincere
questa timidezza.
Leggo questo mio percorso
come un cammino. Non ho
raggiunto nessun traguardo,
ma mi propongo, come un
imperativo, la volontà di continuare a lavorare su me stessa,
di migliorare. Mi piacerebbe
moltissimo costruire un rapporto migliore con i miei figli,
nel senso di far loro capire
quel poco che io ho capito
troppo tardi.
§§§
Pietro e
l’addomesticamento
della «cosa»
P
er me è stato come combattere con una cosa
che non si conosce. Non ti fa
mangiare, non ti fa dormire.
Stavo malissimo, non riuscivo
nemmeno più a uscire di casa.
Da oltre due anni avevo interrotto il lavoro, e nello stato
mentale in cui mi trovavo non
sentivo neppure il desiderio di
tornare a lavorare. Solo l’idea
di alzarmi, fare anche le più
piccole cose, era diventato un
ostacolo insormontabile. Per
me la vita «normale» era finita.
Il momento di rottura è stata
la malattia di mio padre, ma
forse anche prima c’era qualcosa che covava, un rapporto
conflittuale con i genitori, un
percorso non proprio imposto, ma mediato dalla loro volontà, per cui i figli vengono
«costruiti», sono sempre un
po’ manipolati, e così è difficile che poi prendano la loro
strada.
Il mio malessere, la mia depressione, e la malattia di mio
padre erano strettamente legate, come in un circolo vizioso, perché dovevo accudirlo
nelle sue esigenze primarie,
in quanto invalido totale, e
cercare di andare avanti con
l’aiuto di mia madre. A un certo punto ho dovuto distaccarmi un po’. Distacco non vuol
dire abbandono, è anche un
processo interno. Sentivo che
dovevo allontanarmi da mio
padre, dalla pesante situazione che si presentava ventiquattr’ore al giorno. Credo sia
stato questo il cambiamento
più importante che ho fatto, la
scelta che si è rivelata decisiva.
Ho dovuto trovare un equilibrio tra la mia salute e quella
di mio padre, in modo da non
ricadere nel malessere. Qualche volta bisogna imparare a
dire no, a guardarsi dentro. Se
ritengo che qualcosa non vada
bene per me, devo riuscire a
dire di no, a costo di litigare.
Darmi totalmente porterebbe
a una ricaduta: posso dare fino
a quando me la sento, poi devo
pensare anche a me stesso. Ciò
non significa non avere amore
per i propri genitori, ma imparare a patteggiare.
Ho affittato una casa – e anche
questo è stato uno sprone, un
impegno da prendere con me
stesso. Metterla a posto, farci
dei lavori ha costituito infatti
una responsabilità, un modo
per non rimanere sempre
bloccato con la testa al pensiero della malattia. Era uno
spostamento d’attenzione, che
mi ha fatto prendere un’altra
strada. Ma fondamentale è stato l’aver trovato una soluzione
sul lavoro.
In questo percorso il supporto del Centro di salute mentale si è rivelato determinante.
Parlando col medico, infatti,
abbiamo maturato insieme
l’ipotesi di adottare un orario
part-time, che mi avrebbe evitato una stanchezza eccessiva,
cambiando al contempo sede
di lavoro. Inizialmente c’era
un po’ di smarrimento da parte mia, ne parlavamo ma non
ci potevo ancora credere. Poi,
pian piano, sono cominciate ad
arrivare le conferme che tutto il
progetto era realizzabile.
Ho dovuto scontrarmi, però,
con le opinioni degli altri. Ridurre l’orario lavorativo viene
considerato un cedimento, una
perdita, non solo di una parte
dello stipendio. Tuttavia è un
lavoro che devi fare con te stesso: devi vedere che cosa è meglio per te, perché non sempre
ciò che va bene agli altri va bene
anche a te.
In questo processo è stato
di grande aiuto per me il sostegno del Centro di salute
110 | Animazione Sociale marzo | 2015 bazar
no,
Definirmi guarito to.
lia
credo sia sbag
Diciamo
che ho imparato e
ad addomesticar
«la cosa».
Non la scaccio,
ma l’accetto.
mentale. Soltanto la figura di
un professionista può aiutare.
I familiari non sanno cosa sia
questa «cosa», non sanno come
sostenerti. A volte possono addirittura creare una situazione
peggiore, perché spronare può
ottenere l’effetto opposto. Aiutare cercando di spronare l’altro ad andare avanti fa peggiorare, perché in quel momento
ti senti sull’orlo di un burrone
e uno che ti sprona è come se
ti spingesse giù. E poi ognuno
ha un proprio tempo per poter
uscire dal malessere, se non
completamente, almeno per
migliorare. Ognuno a un certo punto sente uno scatto, un
clic, come un interruttore che
si accende. Sentirsi dire: «Dai,
su che ce la fai...» non serve a
niente.
Prima di rivolgermi ai servizi,
per circa un anno sono andato
privatamente da un dottore e
anche da una psicologa. È stato
forse l’anno più brutto, perché
ancora non sapevo cosa fare,
a chi rivolgermi. Inizialmente
pensavo di avere un male fisico,
non pensavo alla testa, per cui
andavo a fare tutti gli esami a
livello organico per vedere se
c’era qualcosa che non andava:
l’elettroencefalogramma, l’elet-
trocardiogramma, l’analisi del
sangue, delle urine, tutti gli
esami possibili e immaginabili.
Ma risultava tutto regolare. Infine, dopo circa un anno, sono
approdato al Centro di salute
mentale, non ricordo bene per
quale strada.
La prima sensazione non è stata
negativa. Chi inizia ad affidarsi
al servizio pubblico lo associa
subito ai «matti», si pensa al
manicomio, perché la malattia
psichica è sempre vista con pregiudizio. Io ci sono andato con
l’idea di voler conoscere anche
quella dimensione, per vedere
che aiuto potevo ricevere.
A quel punto ho potuto fare un
confronto tra i colloqui con lo
psicologo del Centro di salute
mentale e quelli in privato. Si
parla sempre di quello che è
successo, ma nel privato ci sono
orari precisi e quando scade il
tempo ti devi alzare e andare
via, anche se sei sotto pressione
o se devi ancora concludere: e
questo sicuramente non è una
buona cosa. Uscendo ti dici:
cosa ho capito oggi? Eppure
devi pagare. Finisce l’ora e devi
pagare.
Sono rimasto stupito invece
con lo psicologo del Centro,
perché mi dava la sua disponibilità, aveva pazienza, non
guardava l’orologio, facevo
con lui una chiacchierata, senza
premura. Senti il lato umano, la
calma e la disponibilità dell’altro. Non ho avuto bisogno del
servizio per trovare casa, ma è
stato di grande aiuto – come
dicevo – per il rapporto con il
lavoro. Nella mia impossibilità
di gestire la situazione, i servizi
sono stati un tramite, hanno
fatto un po’ le mie veci per poter portare avanti determinate
istanze nell’ambito del lavoro:
contatti, certificati medici sul
mio stato di salute e poi l’avvio
della procedura di domanda di
part-time indicando un possibile lavoro alternativo.
Definirmi guarito no, credo
sia sbagliato. Non direi mai una
parola definitiva, è una cosa un
po’ così, di volta in volta, non
si può dare una definizione
esatta. Diciamo che va meglio
di prima. Inizi a conoscere un
po’ la «cosa», a lavorare sul
sintomo, sulle cose che prima
ti colpivano, ti aggredivano e da
cui non sapevi come difenderti.
Si ripresentano situazioni che
hai già conosciuto, però ora sai
addomesticarle.
I sintomi si presentano comunque, non riesci a cacciarli via del
tutto: l’ansia, come fattore psicosomatico, la paralisi, la perdita del tatto. I sintomi possono
venire ancora a farti visita, ma
li accogli, non li scacci; perché
se li scacci via possono tornare
con più forza, se invece li accetti dici: «Sei venuto a trovarmi?
Va bene, accomodati». È una
forma di maggiore controllo,
cerchi di capire un po’ meglio
come intervenire. È terribile
quando non conosci la «cosa».
Però se è «addomesticata» fa
male in maniera diversa, in un
altro modo, è un altro tipo di
sofferenza. La «cosa» ti abbatte, ti butta giù, ma impari
a dire: «No, sono più forte di
te, anche se ci sei io comunque
vado avanti».
Izabel Marin assistente sociale,
lavora nel servizio abilitazione
e residenze del Dipartimento di
salute mentale di Trieste: izabel.
[email protected]
Animazione Sociale marzo | 2015 bazar | 111
Il circolo No.à. nella Torino nascosta ai pellegrini
La piola social
dove il pasto è a 1 euro
Roberto Camarlinghi
Q
uando in bici cerco il 154 di
corso Regina Margherita,
percorro la via che i pellegrini
della Sindone non vedranno
mai. Perché questo tratto di
città, sulle mappe date ai turisti nei giorni di Ostensione (19
aprile-24 giugno), è segnato
con una riga rossa. Come dire:
«Di qui non passate».
A Porta Palazzo,
nel grande ventre
Siamo a Porta Palazzo, cuore multietnico della città, da
sempre il «grande ventre» che
a Torino accoglie la migrazione. Un tempo dal Sud, oggi
dal mondo. Qui hanno messo
radici le grandi istituzioni caritatevoli della città, perché dove
c’è migrazione c’è miseria. Il
Cottolengo, l’Opera Giulia di
Barolo, il Sermig poco distante.
E i grandi santuari di devozione cittadina: Maria Ausiliatrice,
dove Don Bosco iniziò le sue
attività a favore dei ragazzi,
la Consolata. Proprio di fronte, l’ex ospedale psichiatrico,
il «manicomio delle donne»
come si diceva fino agli anni
’60. Un quartiere denso insomma, di storia e umanità.
Anche il Circolo No.à. - Gioia
e Rivoluzione a suo modo prosegue una tradizione – su un
versante laico e civile – di attenzione agli ultimi della città.
Tentando la sfida di far convi-
ANDAR PER LOCANDE
vere, in questo interno cortile
dove sembra di entrare in una
cartolina anni ’20, le diverse
anime della città. Quella emarginata, quella artistica, quella
musicale. E quella che va matta
per gli spaghetti alici e broccoli
o per gli hamburger di fassone
piemontese qui proposti a prezzi imbattibili. La sfida insomma
di fare città, perché una città
respira se le sue tante anime si
parlano.
È la prima volta che entro in
questo capannone di 300 mq
che nei secoli è stato tante cose.
A inizio ’900 boita (in piemontese bottega artigiana), poi
proprietà del Torino Calcio e
dopo del Consolato di Birmania, quindi officina meccanica,
oggi circolo Arci con cucina.
Ci vengo perché ne ho sentito
parlar bene. Qui si fa buon cibo,
buona musica, buon teatro, e si
produce socialità diffusa.
Su facebook gira un post che
indica il No.à. tra le 10 migliori piole della città. Le piole, a
Torino, sono le osterie di una
volta, posti semplici, frequentati da ceti sociali molto diversi,
con il pergolato (tòpia) e l’uva
americana (uva fròla).
Una locanda che di giorno
è mensa popolare
Proprio nella tòpia del No.à. mi
siedo con Andrea Casa e Renato
Piccolo, due dei soci fondatori,
in una tiepida serata di primavera. E mi faccio raccontare anzitutto l’aspetto sociale del locale.
Perché qui, ogni giorno, dal 15
dicembre al 30 aprile, si è dato
da mangiare a 50 persone inserite nel programma Emergenza
freddo del Comune di Torino.
«Nel progetto ci siamo capitati
un po’ per caso. All’ultimo il
circolo Arci che doveva occuparsi dei pasti ha dato forfait.
Così siamo subentrati noi. È un
progetto impegnativo, ma che
davvero ha senso. Del resto la
nostra volontà è sempre stata
quella di non essere solo circolo
culturale e ludico-ricreativo, ma
di attivarci nel sociale».
Gli orari di accoglienza sono
legati agli orari dei dormitori:
«Noi diamo merenda e cena.
Merenda dalle 15 alle 17, cena
dalle 17 alle 19. Perché alle 19
le persone devono già rientrare
nei dormitori. Alle 20 apriamo il
locale a tutti». Per la verità non
tutte sono persone collegate ai
dormitori. «Il Comune di Torino inizialmente ci ha chiesto di
occuparci di 30 senza dimora,
poi di aggiungere 10 persone
del quartiere in difficoltà. Noi
abbiamo accettato e abbiamo
deciso di aprire ad altre 10, così
siamo arrivati a 50».
Ma l’emergenza non finisce
certo col freddo, è costante
in questa zona. «Questo è un
quartiere difficile, complesso.
112 | Animazione Sociale marzo | 2015 bazar
o
«Offrire il past
a
a un euro
nziani,
disoccupati, aficoltà.
persone in dif cchio
È un nostro ve osta
sogno, una risp
el
alla povertà d
».
re
ie
rt
qua
Per questo terremo aperto anche nel mese di luglio e agosto,
quando alcune mense comunali
e private chiudono. L’obiettivo
è dare da mangiare a 100 persone al giorno, stiamo attrezzando
la cucina».
La vera novità, tuttavia, è in vista
dopo l’estate. Offrire il pasto a
un euro per disoccupati, anziani
e persone in difficoltà economica. «È un nostro vecchio sogno.
Il modo migliore per sostenere
la popolazione qua intorno, che
spesso viene a chiederci aiuto.
Stiamo provando a realizzarlo
grazie al sostegno del Banco
alimentare, della Coop e di altri supermercati che ci danno i
prodotti e con il finanziamento
delle Fondazioni e del Comune.
Un’ora fa abbiamo saputo che
la Chiesa Valdese ha considerato questo progetto come destinatario dei fondi dell’8 x 1000».
Dialogo e fermezza
con gli spacciatori
Sui muri sono scritte le due
parole chiave del circolo. Gioia e rivoluzione. Chiediamo
che senso abbiano oggi. «Noi
siamo non violenti nel dna. Ci
rifacciamo ai valori del nuovo
umanesimo. Gioia è cercare di
avere lo spirito positivo nonostante le difficoltà. Rivoluzione
è trasmettere nel quotidiano
modelli diversi di comporta-
mento. Quando siamo arrivati
qua, avevamo gli spacciatori
di fronte. La popolazione ci
diceva “siete pazzi, non cambierete mai nulla, sono 20 anni
che proviamo a mandarli via”.
Dopo un anno sono venuti a
dirci “vi chiediamo scusa, siete
stati bravi”».
Cos’è cambiato? «La differenza l’ha fatta il nostro modo di
comunicare. Siamo sempre intervenuti cercando il dialogo,
pur mantenendo la fermezza
nei principi. Poi è chiaro, questi sono spacciatori, mettersi in
conflitto con noi non fa comodo a loro. Perché noi da subito
abbiamo chiamato i carabinieri, però non li chiamavamo
chiusi nel locale, siamo sempre
usciti a dirglielo in faccia: “Ragazzi, o la smettete o dobbiamo
chiamare le forze dell’ordine’’.
Loro a volte facevano gli spavaldi: “Ma figurati, dai fallo’’.
E noi per 2-3 volte l’abbiamo
fatto davanti a loro».
«Siamo in una zona molto difficile. Molti si lamentano, ma
questa è anche una zona piena
di odori, di colori, di cultura, è
bello star qua. Sei a Porta Palazzo, il mercato aperto più grande
d’Europa, un’esperienza unica
sul piano delle sensazioni e degli incontri. Sì ci sono aspetti
negativi, ma dove non li trovi?
Certo, per il circolo questa
cosa non paga, “Io in quella
zona non ci vengo perché è
pericoloso”, ci dicono alcuni.
Hai voglia a dire “Guarda che
io sono tre anni che esco alle 3
di notte in bicicletta, a volte con
l’incasso addosso, e non mi è
mai successo niente”. Mai. Tutti i giorni in tre anni. In bici poi,
neanche in macchina riparato
dall’abitacolo».
Una programmazione
aperta all’inatteso
Anche il No.à. si propone come
spazio di incontri, di mescolanze. «Dalle 20 in poi si può venire
a mangiare, a bere, ad ascoltare
musica. Alle 21.30 di solito inizia una serata a tema. Al lunedì e
mercoledì c’è la scuola di comicità. Facciamo tanti spettacoli
di teatro il venerdì e sabato. E
poi concerti, laboratori di danza, di yoga, di autodifesa. Il
martedì si è formato un gruppo di lettura. L’idea però è di
non predeterminare troppo gli
spazi, altrimenti fai un circolo
chiuso. Abbiamo sempre detto
“gli spazi teniamoceli un po’ liberi, così se arriva qualcuno e ci
dice di aver bisogno del circolo
per due ore per fare le prove,
glielo dai e ti conosci”. E dagli
incontri nascono le novità. Per
esempio adesso stiamo collaborando a un progetto di Contact
Improvisation, che è la danza
spontanea, libera, e nell’arco
di 2-3 mesi siamo arrivati a 3540 persone».
Si potrebbe definire il circolo
No.à. una sorta di «Casa del
quartiere», come a Torino ne
sono sorte tante (nove) in questi anni. Un presidio di socialità e un ventilatore di energie
fresche. Esco dal circolo che è
sera, mi guardo intorno. E questo tratto di via che i pellegrini
della Sindone non vedranno
mai mi appare un pezzo di Torino che merita raccontare.
Circolo Arci No.à. (nonviolenza
attiva) - Gioia e Rivoluzione - corso Regina Margherita 154 - Torino
- [email protected]
Roberto Camarlinghi è giornalista di Animazione Sociale: [email protected]