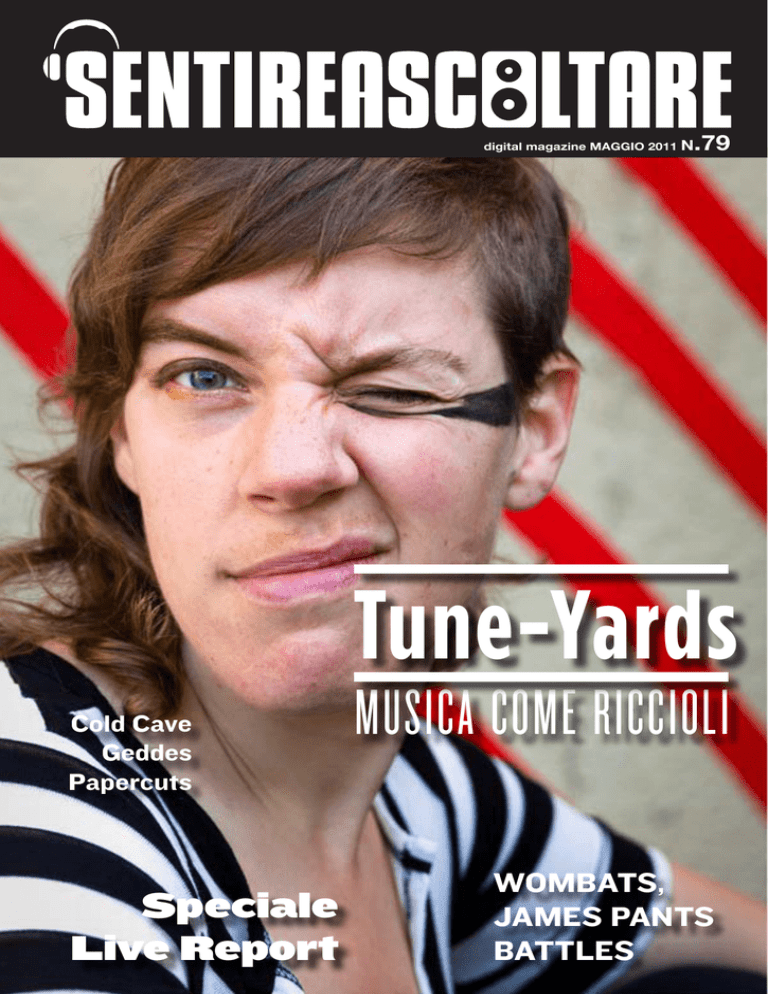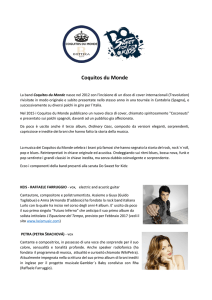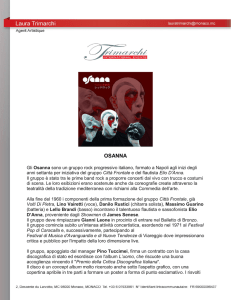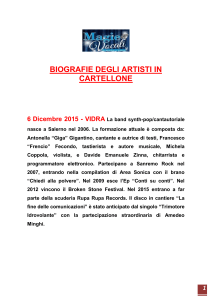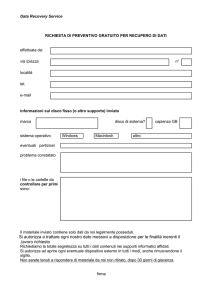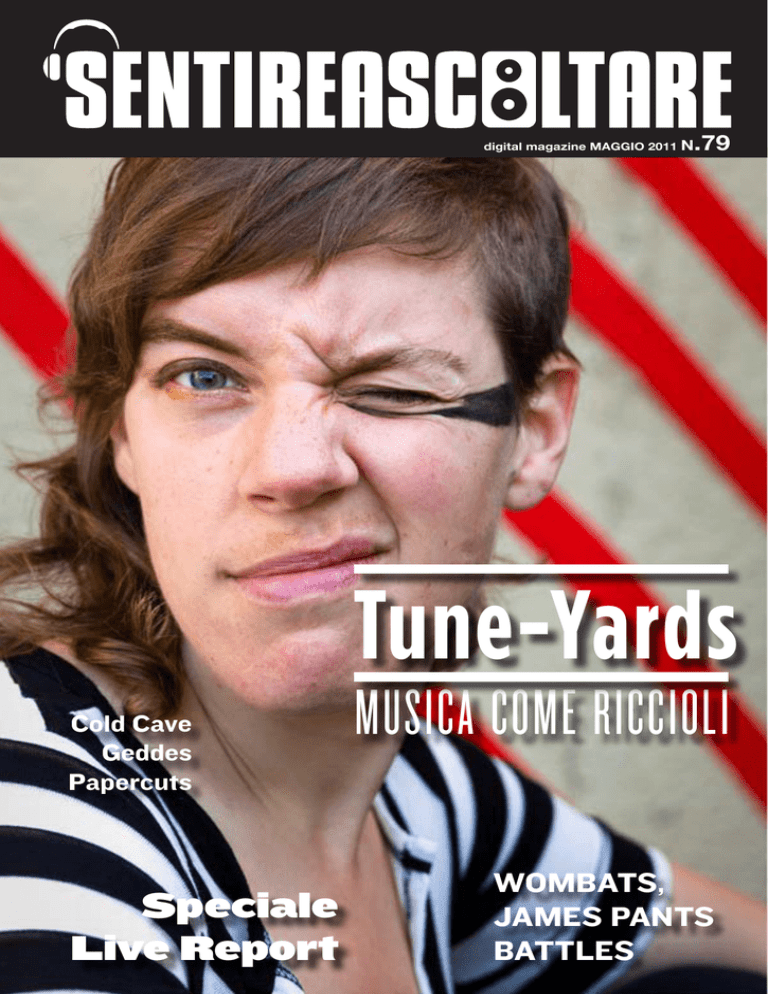
digital magazine maggio 2011
N.79
Tune-Yards
Cold Cave
Geddes
Papercuts
Speciale
Live Report
musica come riccioli
Wombats,
James Pants
Battles
p. 4
Turn On
Cold Cave, Geddes, Papercuts,
p. 10
Tune IN
Wombats, James Pants, Battles
sentireascoltare.com
p. 22
Drop Out
Tune-Yards
p. 30
Recensioni
p. 86
Speciale Live Report
.
Rubriche
p. 92
p. 94
p. 96
p. 100
p. 101
Gimme some inches
Reboot
China Files
Campi Magnetici
Classic Album
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda.
Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale,
in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,
è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Direttore: Edoardo Bridda
Direttore Responsabile: Antonello Comunale
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Coordinamento: Gaspare Caliri
Progetto Grafico e Impaginazione: Nicolas Campagnari
Redazione: Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco
Staff: Marco Boscolo, Edoardo Bridda, , Luca Barachetti, Marco Braggion, Gabriele Marino, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Luca
Barachetti, Andrea Napoli, Diego Ballani, Mauro Crocenzi, Fabrizio Zampighi, Giulia Cavaliere, Giancarlo Turra
Copertina: Aucan (foto di Giordano Garosio)
Guida spirituale: Adriano Trauber (1966-2004)
Turn On
Cold Cave
—Goth pop orchestra—
La cura del rigore ha dato i suoi
frutti e ora l’electro minimale può
lasciare spazio a grandiosi anthem
post punk. I nuovi Cold Cave
raccontati da Wesley Eisold
È
un Wesley Eisold diverso, più maturo (ma verrebbe da dire più sgamato), quello che abbiamo contattato
in occasione dell’uscita del nuovo album Cherish The Light Years. Solo un paio di anni fa, il trentaduenne
agitatore culturale della New York più underground, era un ex punk prestato all’elettronica DIY; con i Cold Cave si
ispirava ai primi, minimali esperimenti synth pop, mentre la sua misantropia andava di pari passo ad un suono
algido e alieno. Oggi i Cold Cave sembrano ben più di uno dei tanti progetti estemporanei. L’uscita dell’album ha
coinciso con una voglia di assaporare il responso di nuove platee e di lasciarsi andare ai riti del pop, senza tuttavia
tradire l’impronta artsy originaria.
Mi sembra evidente che siano cambiate parecchie cose rispetto a Love Comes Close, in cui bassa fedeltà
e minimalismo digitale rappresentavano i segni distintivi del vostro sound. Cos’è successo in questi due
anni?
Diciamo che gli aspetti che hai elencato per me erano importanti, ma il motivo era che non c’era altra scelta. Prima
di allora non avevo mai scritto e registrato musica. Naturalmente apprezzo il minimalismo e penso che il lo-fi si
adatti particolarmente a certe situazioni musicali. Le canzoni che ho scritto per quest’album, però, non avrebbero
funzionato con quel tipo di sonorità; quando le ho scritte le immaginavo anthemiche e grandiose. La differenza è
che il tempo è passato e non avevo intenzione di rimanere fermo al suono dell’album precedente.
Dunque si è trattato di una naturale maturazione musicale?
Beh, avendo preso confidenza con tutto il mio equipaggiamento, è stato naturale iniziare a scrivere canzoni più
strutturate. Quello che volevo fare era un disco pop che però suonasse ancora chiaramente Cold Cave. Sono molto
contento del risultato. Ci sono voluti due anni per realizzarlo e sicuramente viaggiare nei quartieri in cui sono nato
ha contribuito a darmi l’ispirazione giusta.
The Great Pan Is Dead , il singolo che ha anticipato l’album, ha un approccio rock molto potente. Mi pare
che nella tua musica ora ci sia più fisicità e più partecipazione emotiva rispetto a prima.
4
È vero, anche se tutto sommato quella canzone è
un’eccezione all’interno dell’album. Per come la vedo
io, c’è sempre stata emotività nella mia musica ma forse ora è venuta allo scoperto. Volevo che quella canzone fungesse da cerniera fra quello che ho fatto in
passato e quello che sta per accadere. Essendo poi il
primo estratto dall’album, volevo che fosse chiaro che
le cose sono cambiate rispetto al passato.
Il tuo modo di cantare, in alcuni brani del disco mi
ricorda quello di Phil Oakey degli Human League.
Quanto sono state importanti per te band le electro pop band degli anni 80, come gli stessi League
o i New Order?
Certamente quelle band per me sono importanti, ma
non più di altre. Da Gary Numan agli Absolute Body
Control, fino ai Sisters Of Mercy, sono cresciuto con
questa musica ed è quella che ascolto ancora oggi.
Tornando al discorso della voce, la musica elettronica,
soprattutto quella dalle sonorità più fredde, ha sempre avuto parti vocali impassibili. Bisogna però essere
molto naturali per suonare credibili.
Gli artisti che hai citato hanno portato una buona
dose di sperimentazione nella pop music dell’epoca. Pensi che sia una cosa che può essere fatta anche oggi?
In verità non sono interessato a qualcosa di simile.
Sono più interessato a fare musica in cui credo, mantenendo una certa onestà intellettuale. Non so se ci sia
spazio per questo. Personalmente sono attratto dagli
aspetti più sperimentali della musica popolare. In fondo mi piace il conforto della familiarità ma adoro godere degli errori umani.
Per essere un artista che fa un ampio utilizzo di tecnologia nuova e vintage, so che hai sempre avuto
opinioni piuttosto negative sul modo in cui questa
influenza l’uomo.
Quello che penso è che facciamo affidamento sulla
tecnologia per esprimere quello che non si può dire o
che non ci sentiamo sicuri di dire con quelle cose apparentemente insignificanti che sono il nostro cuore e
il nostro cervello. In musica, ad esempio, non potremo
mai fare a meno di sintetizzatori e chitarre.
I Cold Cave sono un frutto della scena DIY newyorkese. Hai mai sentito di avere qualcosa in comune
con quegli artisti?
A New York ci sono band interessanti ovunque, ma non
sono sicuro di avere qualcosa in comune con qualcuna di esse. In generale non mi sento ispirato da band
che hanno un suono simile al mio. Preferisco ispirarmi
alla gente in cui credo, indipendentemente da quale
sia il mezzo con cui scelgono di esprimersi.
Per cui non ci sono artisti che ammiri o con cui ti
piacerebbe collaborare?
Si, ma in questo momento sono più attento ad altre
forme di espressione artistica, come certo design d’avanguardia per l’abbigliamento. In particolare c’è un
designer italiano a cui sono molto legato, si chiama
Maurizio Amadei.
So che avete un programma serrato di date per
promuovere l’album, vi troverete anche di fronte
alle grandi platee dei festival estivi. E’ corretto dire
che le performance live stanno diventando importanti per voi?
Si, è così. Saremo in tour dalla fine di Marzo fino, almeno, a Settembre. È un ottimo momento, dopo molto
tempo mi sento pronto ad uscire da New York. Per me,
poi, non è mai stato un problema di piccole o grandi
platee. Ho avuto esperienze positive e negative in entrambe le situazioni.
Immagino che sul palco, questa volta, ci sarà una
vera e propria band. Alla luce di questo consideri
sempre I Cold Cave come un tuo progetto solista?
Continuo a scrivere e dirigere la band in prima persona. Poi, naturalmente, ci sono amici che suonano
insieme a me, ma in generale l’input esterno è molto ridotto. L’intenzione, dal vivo, è di sembrare di più
una band tradizionale. Fino all’anno scorso eravamo
io, Dominick Fernow, Jennifer Clavin e un batterista.
Ora abbiamo anche un chitarrista. L’aspetto visuale in
realtà è cambiato molte volte da quando la band ha
cominciato a suonare dal vivo.
So che non ti occupi solo di musica, ci sono altri
progetti in cui sei coinvolto al momento?
Sto lavorando su alcuni libri ma i Cold Cave occupano
la maggior parte del mio tempo. È la cosa che preferisco fare in questo momento.
Questo significa che stanno diventando una specie
di lavoro per te?
Li considero più una scelta estetica, non un progetto o
un lavoro. Meglio dire uno stile di vita.
Cosa dobbiamo aspettarci dai Cold Cave nell’imminente futuro?
Come dicevo saremo parecchio in tour nei prossimi
mesi. Sto anche scrivendo e registrando nuovo materiale, in generale sto cercando di migliorare quello che
ho fatto fino ad ora. Aspiro ad essere un esempio per
le persone a cui è stato detto che non sono in grado
di fare quello che desiderano. Il tempo che abbiamo è
troppo prezioso per essere sprecato.
Diego Ballani
5
Turn On
Geddes
—No Fit States—
Intervista a Stuart Geddes per
parlare di house londinese al di fuori
dei circuiti mainstream...
6
U
sciamo per un attimo dal continuum UK in compagnia di Stuart Geddes. L’uomo produce e
suona house a Londra, organizza i party Mulletover
nella migliore tradizione danzereccia della capitale.
Il mese scorso ci ha allietato con una compilation per
la sua etichetta murmur. L’abbiamo sentito per capire
dova va il suono londinese al di fuori delle atmosfere fumose del dubstep, sempre e comunque underground. La chiacchierata in esclusiva per noi. Ciao! Ti puoi presentare al pubblico italiano?
Ciao! Sono Geddes e vivo nell’East London, la parte
più cool della città, dove girano le ragazze più carine.
Sono il responsabile di due party underground (Mulletover e Nofitstate) che si svolgono in piccoli scantinati e in capannoni fuori dalla città. Ho iniziato sette
anni fa a suonare al Mulletover, perché era impossibile
entrare nel circuito dei club. Così ho proposto questa
nuova serata tutta mia, per suonare quello che mi piaceva di più.
Dopo anni di LP e tracce sparse, hai deciso di pubblicare una compilation. Cosa avevi in mente quando hai iniziato il progetto?
L’ho registrata perché non ne avevo mai fatta una. Anche se il mercato non tira molto, la nostra nofitstate
sta andando a ruba. Siamo molto contenti solo a livello di prevendite del disco. Prima registravo dei demo
mix che regalavo alla gente che veniva al Mulletover. I
ragazzi però non apprezzano molto i dischi gratuiti, e
soprattutto non credono che un prodotto possa essere di buona qualità se non lo pagano, quindi ho deciso
di passare al commerciale.
Perché hai scelto Tom Demac per il secondo disco?
Tom è l’artista che rispetto di più e in cui credo veramente. Ha molti pro e idee che sono diverse dalle mie.
Anche se il suo stile è più vario la nostra matrice è comune.
Nel CD hai usato tracce di Deniz Kurtel, Maceo Plex
e altri artisti che suonano ‘soft’ house. Ti piace suonare calmo, senza sparare il solito basso four-onthe-floor?
Dipende dalla serata. Qualche volta serve suonare
soft, qualche volta serve spingere. Quando suono nelle location più piccole posso essere un po’ più creativo
e raccontare una storia. Nel grandi club tutto ciò non
è permesso.
Negli ultimi mesi c’è stato un grosso hype intorno
ai nomi di Wolf + Lamb e Nicolas Jaar. Ti piacciono
pensi che stiano proponendo qualcosa di nuovo?
Conosco molto bene il loro lavoro [W+L]. Penso che
suonino freschi e nuovi. La stampa infatti si è buttata
subito su di loro, ma non so quanto possano durare.
Nicolas è diverso, suona con gente che non viene dai
club. La sua musica sta inglobando nel suono house
sonorità jazz e probabilmente potrebbe diventare la
contemporanea per il 21-mo secolo.
Pensi che questo cambiamento sposterà un po’ i
gusti della gente che frequenta i club?
La musica che propongono ha ancora un audience
piccolo in confronto a quello dei club house. La loro
proposta è molto interessante e funziona bene, ma
credimi, se vuoi raggiungere le folle non puoi suonare
a 120bpm...
Suoni spesso in Inghilterra ma anche negli States.
Pensi che si sia una differenza nei clubbers di questi due paesi?
Puoi dirlo forte. Gli europei sono più cosmopoliti e
sono aperti a sonorità e gusti nuovi. Gli States sono
un po’ retrò, guardano di più al passato, non hanno la
cultura musicale sufficiente per apprezzare le novità.
Suoni anche in Italia? Conosci artisti italiani?
Ho suonato solo una volta in Italia per la crew The Flame; mi ha invitato Luciano Esse. Penso che sia italiano,
no?
Ho visto che nella compilation hai usato una traccia di Marco Passarani. Lo conosci? Ti piace il suo
lavoro?
Conosco poco del lavoro di Marco. Le sue produzioni
su Running Back è strana forte però!
Quali sono i DJ che ti piacciono di più?
Ricardo Villalobos, Danny Tenaglia, Jay Hannan, Craig
Richards, Giles Smith. I tuoi prossimi progetti?
Ho qualche traccia che esce a breve e qualche remix
(Kruse & Nurenberg feat. Nathalie Claude ‘More and
More’)...
Cosa stai ascoltando ora?
Il podcast di Roman Flugel su Beats In Space.
Quali sono le prossime uscite su murmur?
Un sampler in vinile con tracce esclusive di James
What e un remix di Glimpse. Poi escono gli EP di Marc
Ashken con un remix di Annoym, l’EP di Hugo Barritt
feat Robert Owens and qualcosa Hamid che è resident
all’Half Baked.
Perché hai chiamato la compilation nofitstate?
Alla fine delle serate siamo sempre in un ‘no fit state’ e
poi il party si chiama proprio così. L’idea era di richiamare l’atmosfera notturna...
Marco Braggion
7
—Loveless Parade—
Sulla spiaggia del cosmic dream pop
prende posto Jason Quever: Van
Dyke Parks incontra il paradiso dei
My Bloody Valentine
8
Turn On
Papercuts
L
a scena è un po’ sempre la stessa: una spiaggia al tramonto e un setting sun che tutto dori e illumini di
barbagli arancioni, sfumature tardo-adolescenziali assolute ma pudiche, nostalgia per un attimo che fugace ci ha
riempito il cuore, l’anima e le orecchie, e poi se n’è andato
per sempre, tuffandosi nell’oceano, infilandosi tra le stelle che stanno apparendo sulla volta celeste mentre il sole
si accomiata. E’ un momento che sfiora più che toccare,
come una brezza che annuncia l’estate: effimera muove
appena i capelli impregnandoli di bittersweetness.
Sarebbero sentimenti da noi che abbiamo scoperto
Siddartha tra i banchi di scuola, di nascosto tra un Dante
o un Boccaccio, che ci pareva avessero un odore troppo
forte, e le equazioni di secondo grado o la trigonometria,
che – invece – di odore sembravano proprio non averne
alcuno. Ma sono invece alcuni dei colori che riempiono
da qualche anno le tele musicali di alcuni act che si sono
via via guadagnati rispetto e audience fuori dal ristretto
giro delle camerette. E’ il suono dei Morning Benders
dei vari Grizzly Bears e Beach House che hanno riempito le playlist delle ultime stagioni, e dove ritroviamo
anche il (mezzo) nostrano Jonathan Clancy, sponda His
Clancyness. Una scena, e una spiaggia, che sembrerebbe da tutto esaurito, e sulla quale, invece, trova posto
Jason Quever con il suo progetto Papercuts, che con il
quarto atto della sua discografia ufficiale, si iscrive definitivamente al club.
Nato in una comune della West Coast, Jason Quever
vive a San Francisco dove ha avuto l’occasione di sistemare un vecchio hangar per trasformarlo in uno studio
di registrazione e chissà che la struttura industriale non
abbia avuto un qualche ruolo nel fargli nascere un interesse per i riverberi e i delay. Da una parte all’altra della
baia collabora, tra gli altri, con Cass McCombs, Vetiver,
Casiotone for the Painfully Alone. Nei ritagli di tempi si
dedica a un folk-pop solare che diventa materia dei primi
due dischi, Mokingbird e Can’t Go Back.
Già dal penultimo You Can Have What You Want, invece, si registra un cambio di rotta, che fa guardare Jason a quella spiaggia con occhi diversi. Non più quelli del
folkster, ma quelli del drempopper. “Alcuni anni fa Spin
Magazine definì la mia musica”, ci racconta, “come la perfetta colonna sonora per un giro in macchina senza meta
lungo la Pacific Coast Highway. Sì, è vero, adoro guidare
lungo quella strada e perdermi nel paesaggio, ma questo
era il sound di Can’t Go Back, con un sacco di chitarre
acustiche. Oggi il nostro suono è diverso, anche se non
riesco a fare a meno di tornare – senza accorgermene –
al sound dei Sixites”. Il nostro suono, già. Perché non solo
Quever ha firmato per la Sub Pop, ma Papercuts è diventato un po’ più una band che ha suonato “per mettere giù
almeno la metà delle canzoni che sono finite sul disco.
Tutti insieme”.
Con la compartecipazione della live band o meno, Fading Parade è il risultato di una ricerca iniziata molti anni
fa e giunta a un primo passo importante e maturo. “Ogni
volta che fai un disco dovresti sentirti come se stessi crescendo e migliorando. Questo ti permette di dire quello
che vuoi in modo migliore. E’ una questione di esperienza
che si accumula”. Nonostante questi discorsi da bambino
grande, Jason Quever rimane un ragazzo che ha trovato
il modo per far uscire le proprie canzoni dalla cameretta
(letteralmente, visto che finora aveva fatto praticamente tutto da solo) e approdare a un’etichetta importante.
“Lavorare con i ragazzi della Sub Pop è fantastico, perché
hanno dimostrato un grande entusiasmo nei miei confronti e credo che questo si senta nel disco. Sono stati determinanti per permettere a me e alla band di poter fare
esattamente il disco che volevamo”. Aiuto che deve essere arrivato anche dalla co-intestazione della produzione,
che oltre al solito Quever, vede in console anche Thom
Monahan, già al lavoro per Vetiver e Devendra Banhart.
A proposito di produzione, già dalle note stampa, viene citato Phil Spector come uno dei fari a cui si è voluto
guardare. L’accostamento è più che mai azzeccato se si
presta attenzione agli strati di suono che sono stati depositati uno a uno sulle canzoni per dar loro un impatto
quasi fisico, ma senza snaturare la natura eterea e dream
delle composizioni. “Mi piacciono molto le produzioni di
Spector, ma non posso dire di ascoltarle molto ultimamente”. Il punto è che, produzione importante o meno,
è necessario che sia buona la materia di partenza. “Pensa alle Ronettes, una delle mie band preferite di sempre:
loro sono state eccezionali, sicuramente anche grazie
al lavoro di Spector, ma la qualità c’era già in partenza.
Quando penso al concetto di wall of sound, però, non
penso a Spector, ma ai My Bloody Valentine: una vera
pietra miliare per me”.
Ecco un altro illuminato sulla via di Loveless, del paradiso in terra e del sogno ad occhi aperti. Eppure, nonostante di noise qui ce ne sia poco, l’idea è sensata. E’
la band di Kevin Shields ad aver sparso sul pianeta una
polvere angelica che ha aperto le porte del sogno per
molti musicisti della generazione di Quever. La capacità
di quest’ultimo, il suo vero talento, è quello di far convivere questa materia con Van Dyke Parks, i Beach Boys e
gli Zombies in una macchina del tempo che li fa ritrovare
tutti sulla stessa spiaggia. Ma oramai è scesa la notte ed è
tempo di guardare le stelle mentre si accendono i falò e
ci mettiamo una coperta sulla spalle.
Marco Boscolo
9
Tune-In
Il perché e il per come Let’s Dance To Joy Division, tre
anni dopo, si è vestita di synth pop e non di grunge.
Ne abbiamo parlato con il bassista Tord ØverlandKnudsen...
Wombats
—Party da ritardatari—
S
Testo: Simone Madrau
10
ono insospettabilmente dimessi, gli Wombats.
Cortesi nei modi, sorridenti, parlano poco al di
fuori delle interviste, forse un po’ spaesati, forse un po’
stanchi tra apparizioni promozionali e concerti. Una
pacatezza che stride con il loro profilo di indie-band
giovanile attesissima in UK per This Modern Glitch, un
secondo album particolarmente difficile vista la rapidità con cui il mercato inglese di oggi mastica e rigetta
giovani band e hit radiofoniche.
E’ una frenesia in cui il gruppo sembra non sapersi inserire. Se il precedente A Guide To Love, Loss And
Desperation si abbeverava dai primi anni ‘80 dopo
che un intero filone di gruppi li aveva già abbondantemente riesumati, i nuovi brani subiscono le medesime
conseguenze rispetto al ritorno del synth pop che ha
dominato nella seconda metà degli ‘00. Revival per revival, un disco in odore di ‘90 come quello che il trio di
Liverpool prospettava avrebbe potuto rappresentare a
conti fatti una mossa più saggia.
Ecco quindi che i retroscena su questa seconda release, svelati a tu per tu con il bassista, il norvegese Tord
Øverland-Knudsen, finiscono con l’essere un trampolino per una serie di divagazioni in cui cerchiamo di capire come certi meccanismi musicali vengono percepiti da qualcuno che li vive sulla propria pelle.
Iniziamo parlando del nuovo album. Quando e
dove è stato registrato?
Per lo più lo abbiamo registrato a Los Angeles, per tre
mesi durante l’estate, facendo avanti e indietro da Liverpool. La prima session è stata prodotta da Jacknife
Lee, con cui abbiamo registrato tre canzoni. Poi qualche settimana dopo con Eric Valentine abbiamo registrato altre due canzoni, e ancora siamo tornati per
registrare il grosso dell’album con Rich Costey. E poi,
siccome lui era impegnato per finire le ultime canzoni
dell’album, siamo andati a Santa Monica per registrare
le ultime due canzoni con Butch Walker. Quindi quattro produttori diversi. Avremmo voluto registrate tutto
con Eric ma considerando che lui era molto impegnato
e che noi avevamo già lavorato con Rich per l’album
precedente, sapevamo di essere comunque in ottime
mani.
Non sorprende che Jacknife Lee sia tra i produttori.
Perfect Disease è prodotto da lui? Perchè mi ha ricordato molto il sound del secondo Bloc Party.
No, quella è prodotta da Rich Costey che comunque
aveva mixato quel disco. Quindi diciamo che ci sei andato vicino.
Il disco suona meno post-punk e più vicino al synth
pop o alle cose più ballabili degli anni 80. Voi per
primi lo dichiarate apertamente in Techno Fan dicendo ‘we are in the 1980s’. E’ una cosa voluta o è
il tocco dei produttori che ha portato le cose verso
questo risultato?
Il fatto è che dopo aver passato tre anni a suonare le
canzoni del nostro primo disco, eravamo talmente stufi che volevamo suonare in maniera ribelle, andando
letteralmente contro quanto avevamo prodotto fino a
quel momento. Pensa che il primo gruppo di canzoni
nuove che avevamo registrato era praticamente roba
grunge, molto heavy. Al punto che quando la nostra
etichetta le ha sentite la reazione è stata tipo ‘what the
fuck?!’. Andava bene cambiare, ma secondo loro quelli
non erano gli Wombats, erano proprio un altro progetto. Così abbiamo deciso di riprovare sul versante opposto, mettendoci a sperimentare con l’elettronica. L’utilizzo dei synth non è quindi un’idea della produzione,
siamo semplicemente noi che ci siamo messi a giocarci
perchè quel piglio post-punk scanzonato sul primo album ci era venuto a noia. Avevamo voglia di spingerci
il più lontano possibile da quello che avevamo fatto.
In verità ti ho chiesto questa cosa perchè sto notando che molte band inglesi tra quelle uscite negli ultimi anni stanno prendendo questa direzione,
meno basata sui riff di chitarra e più tesa a riscoprire certi suoni di matrice 80’s.
In effetti hai ragione, per quanto percepisca ugualmente molte sfumature tra questi gruppi. Gli anni 80
11
sono un buon denominatore comune probabilmente,
ma sarebbe semplicistico ridurre tutto a questo. Credo
che ciò che descrivi tu dipenda da due fattori differenti:
da una parte le possibilità che offre la tecnologia oggi
rendono molto più facile evolvere e farsi influenzare da
altre cose - forse anche troppe, devo dire - modificando il proprio suono nell’arco di poco tempo. Dall’altro
lato le tendenze musicali di oggi cambiano in maniera
molto più rapida, e così anche le esigenze di consumo
e i gusti di chi consuma musica. La gente ascolta molta
più musica, escono almeno quattro gruppi nuovi ogni
giorno.
Parlando di testi, vecchi e nuovi, penso che la parola ‘ironia’ sia la parola chiave dietro i vostri testi.
La cosa era già esemplare ai tempi di Let’s Dance To
Joy Division, dove dichiaravate che ballavate i Joy
Division per celebrare l’ironia del fatto che tutto
andava storto ma voi eravate felici. Una sindrome
generazionale, si direbbe.
Indubbiamente, e indubbiamente in questo disco
siamo sempre noi da quel punto di vista. Ma come ti
dicevo prima non abbiamo molto in simpatia quanto
abbiamo prodotto in precedenza, compreso quel singolo. Considera che Tokyo (Vampires And Wolves) parla
proprio di Let’s Dance To Joy Division. E ne parla come
se fosse un qualcosa da abbattere. E’ una canzone sui
meccanismi dell’industria musicale, su come sia facile
finirne intrappolati con una sola canzone e sulla necessità di fuggire prima che sia troppo tardi.
Bè, effettivamente Let’s Dance To Joy Division è stato un vero e proprio club anthem qualche anno fa.
Ti confesso tuttavia che personalmente preferisco
questa nuova Jump In The Fog: molto più matura in
termini di composizione, magari meno melodica
ma per molti versi sintomatica di una certa evoluzione.
Penso in effetti che sia il brano che anche a livello di
liriche suona come il più distante dal disco precedente.
Poi certo ci sono cose che suonano più vicine ai Wombats che la gente conosce. Ma pure aperture folk ed
esplosioni grunge.
In passato avete già presentato alcuni brani di questo nuovo disco dal vivo. Come ha reagito la gente?
Dipende. Nel caso di Tokyo hanno per lo più continuato
a ballare, nonostante serpeggiasse una certa curiosità.
Ma mentre eseguivamo Jump In The Fog, prima dello
scorso Natale, ho visto la gente fermarsi e mettersi ad
ascoltare con attenzione. Non è che non apprezzassero, anzi: sembravano sinceramente curiosi di capire
cosa stessimo facendo, piuttosto che intenti a ballare come scalmanati. Smettono di saltare e ballare e si
12
mettono ad ascoltare: sarà banale dirlo, ma è un modo
di reagire che mi piace davvero molto.
Cosa succede nell’underground di Liverpool in questo momento? Tu vieni dalla Norvegia ma vivete
tutti e tre lì, giusto?
Il paradosso è che pur essendo io l’unico membro della band non originario di Liverpool, sono anche l’unico a vivere a Liverpool al momento. Matt vive a Londra e Dan si è trasferito a Parigi. Quanto alla scena di
Liverpool, per essere onesti non la sto frequentando
molto perchè tra il tour, le registrazioni del disco che
come ti dicevo sono state piuttosto impegnative e la
promozione, ho passato davvero poco tempo a casa.
Quando ci sono, tendo ad andare a vedere i miei amici
che suonano. Posso dirti che in questo momento c’è
una discreta attività in ambito hardcore, soprattutto di
stampo At The Drive In e Blood Brothers. Quel genere di cose.
Non proprio la prima cosa che ci si aspetta quando
si pensa a Liverpool. Già voi siete molto lontani da
quell’immaginario, ma l’hardcore è praticamente
opposto.
Bè, se ti riferisci ai Beatles che io sappia gli unici nomi
in città con un’attitudine simile sono i Coral e Miles
Kane (ex The Rascals, metà dei Last Shadow Puppets
e di prossima uscita con un album solista tra i cui ospiti
figura Noel Gallagher, NdR). Ma sono cose abbastanza
sorpassate, almeno per ora.
Siamo a cavallo tra un decennio e l’altro. Qual è la
tua band preferita degli anni 00?
Bè, una sola è davvero difficile. Posso scegliere un disco
in particolare?
Certo, come meglio credi
Allora ti dico Kid A dei Radiohead. Mi ha cambiato un
sacco. Mi piacevano anche prima di allora ma quel disco è stato così di ispirazione: è musica elettronica ma è
pieno di chitarre al tempo stesso. E’ stupefacente come
sia riuscito ad aprirmi la mente. Dopo di loro ho iniziato
ad ascoltare gli Air, per esempio, e altri gruppi simili
che non avevo mai considerato.
Guardando ai vostri esordi pensavo aveste un’estrazione post-punk
Personalmente più che dal post-punk provengo dall’indie-rock degli anni 90. Conosci un gruppo genovese
chiamato Motorpsycho?
Certo...
Ecco, quello è il gruppo che mi ha fatto desiderare di
avere un gruppo. Avevo 13 o 14 anni.
E gli altri due? Hanno gusti più giovanili?
Non direi, anzi, anche loro vengono da ascolti come
Smashing Pumpkins, Weezer, tutto il periodo post-
grunge americano. E più recentemente si sono messi
ad ascoltare folk.
C’è qualcuno tra voi che ascolta davvero i Joy Division?
Certo che sì, semplicemente non sono stati un ascolto
così formativo come la gente immagina.
Cosa ti aspetti invece degli anni ‘10, a livello di suoni
e di musiche? Dieci anni fa la ruota è girata sensibilmente con gruppi come gli Strokes che hanno un
po’ cambiato attitudini e profili visti fino a quel momento, una sensibilità che ha dominato poi su tutto
il decennio.
In realtà credo che queste siano percezioni amplificate
da media tipo NME, che appunto portano alla ribalta un
certo stile creando un mercato intorno. Per certo, però,
qualcosa avverrà. Gli Strokes rappresentavano una
sorta di ritorno agli anni 70, ora come abbiamo detto
siamo dentro agli anni 80. E’ lecito quindi pensare a un
ritorno degli anni 90. Non solo in ambito rock, ma anche in ambito di dance music. E poi, certo, una rinascita
del grunge!
Tornando agli Wombats cosa c’è invece nel vostro,
di futuro?
Abbiamo iniziato il tour lo scorso mese e lo porteremo
avanti per tutto il prossimo anno, forse anche un anno
e mezzo. Dipende da come saremo accolti in America.
Non abbiamo speso molto tempo lì in occasione del
primo album ma al contrario questo, come ti dicevo,
ha comportato un sacco di lavoro da quelle parti. Siamo interessati a tornarci per registrare nuove cose con
i produttori americani e chissà quindi che non ci scappi
anche un tour di supporto per altre band.
13
Tune-In
Chiacchierata d’obbligo con questo ragazzone schivo
e strampalato che è un vero misconosciuto talento.
Chiuso nel proprio guscio...
James
Pants
J
—I Live Inside an Egg—
Testo: Gabriele Marino
14
ames Singleton, classe 1982, è un ragazzone dallo
sguardo un po’ svagato e dai modi timidi, avvolto
come da un alone di eccentricità naïf. James è James
Pants, uno dei talenti meno noti del roster non-specificamente-hip hop di casa Stones Throw. Un artista che
è prima di tutto un appassionato e che trova le ragioni
di una umiltà, di una disponibilità e una simpatia davvero rare nell’aver cominciato come stagista negli uffici della casa discografica che lo ha poi pubblicato. Un
musicista e un producer tuttofare a cui piace lavorare
in solitudine e con tutta la calma del mondo, chiuso nel
proprio studio e in quello stesso splendido paradossale guscio che è la tranquilla vita da provincia americana
che ha partorito le stranezze, l’assurdo e il surreale di
un David Lynch. E se sicuramente - lo sappiamo per
certo - Pants conosce e ama Twin Peaks, allora è anche
cresciuto a pane, burro d’arachidi e Residents e si dà la
buona notte con i Pussy Galore di Jon Spencer e così
via, riferimenti scontati e perfettamente assimilati dalla
e nella sua musica. Pensiamo noi. Ma James dei primi
conosce molto poco (“li devo approfondire”) e del secondo addirittura nulla. Mentre dichiara tutto il proprio
sconfinato amore per il “più grande genio musicale della
nostra epoca”: Gary Wilson. Ovviamente qualcosa non
quadra e quindi quadra perfettamente tutto.
Eccolo James, ennesimo splendido esponente di una
weirdness tutta americana - ad un tempo casuale, artigianale, seriale, metodica, casinista; borghesissima
e quindi davvero rivoluzionaria - che si nutre (oltre
che delle fondamentali crostate di ciliegia messe a
raffreddare sul davanzale) delle canzoni di Frankie
Avalon, del soul della Motown e delle song di Tin
Pan Alley, e che restituisce poi giocattolini deformi
e grotteschi in forma di incubi pop. Sempre in bilico tra umorismo e umori sinistri, dopo la new-wave
psichedelica, malata e maltrattata di Seven Seals,
il terzo omonimo album di James - che è però il suo
quinto long playing - sembra segnare una più decisa apertura al pop e al rock’n’roll. Declinati, ovviamente, sempre alla sua maniera. La nostra intervista.
James, puoi raccontarci ancora – ma per il pubblico
italiano sarà forse la prima volta – la tua incredibile
storia, che fa tanto “Sogno Americano”? Mi sembra
la migliore delle autopresentazioni possibili…
Certo! Era il 1998-1999 e io ero un grande fan delle
produzioni Stones Throw. I dischi che pubblicavano
in quel periodo erano soprattutto di rap underground
ed erano tra le cose migliori che si potessero trovare in
giro. Cose come Homeliss Derelix, Peanut Butter Wolf,
Lootpack [il gruppo rap di Madlib; ndr], Rasco. Venni
a sapere che Peanut Butter Wolf aveva programmato
un dj set a Austin, Texas (dove all’epoca vivevo). Volevo
andarci a tutti i costi, ma era la sera del ballo del liceo e
inoltre avevo un appuntamento con una ragazza (Cindy Huckabay). Così, da nulla, presi e mandai una mail a
PBW in cui gli chiedevo se gli andava di andare a comprare dischi assieme a me. Ovviamente io non conoscevo l’indirizzo: ho provato a indovinare quello giusto
(credo di avere provato un milione di combinazioni).
Assurdamente, PBW mi rispose e soprattutto mi rispose che gli andava bene. Ero tesissimo, eccitato come
un bambino. Così, dopo il ballo, portai la ragazza allo
show di Peanut, che era già finito da un pezzo. Lo riconobbi, lo fermai, ci scambiammo i numeri di telefono
e qualche giorno dopo andammo davvero per negozi
di dischi. Era un sogno che diventava realtà. Abbiamo
continuato a sentirci e io sono andato a trovarlo ad altri show nel corso degli anni. Una volta finita l’università, gli chiesi se potevo essere preso alla Stones Throw
come stagista e, di nuovo, assurdamente, mi disse di sì.
Così per un certo periodo mi sono trasferito a Los Angeles e ho lavorato negli uffici della ST. Non ricordo assolutamente quello che facevo, perché per me non era
reale, era un sogno. Inoltre, non gli ho mai fatto sentire
le mie cose. Credo che sia stato uno dei grafici con cui
avevo fatto amicizia, e a cui avevo passato qualcosa, a
parlargli delle mie registrazioni. Sta di fatto che circa un
anno dopo la mia assunzione come stagista, mi propose di fare un disco. Fu il giorno più bello della mia vita.
Il tuo immaginario è fatto di elementi pop grotteschi. La provincia americana, l’American lifestyle,
la musica anni Cinquanta e la musica anni Ottanta
(c’è qualcosa di Lynch-iano in questo miscuglio…),
kitscherie, giocattoli, ecc. Unisci una sensibilità pop
15
a un gusto e a una ispirazione weird. Quali sono i
tuoi interessi, le tue passioni extra-musicali?
Grazie! Mi hai proprio inquadrato per bene (ride)! Allora… interessi al di là della musica… Vediamo… Mi
piace molto andare in bici. Mi piace andare per negozi
e comprare dischi. Mi piace molto cucinare (pensa che
c’è stato un momento in cui ho pensato di mollare la
musica e diventare cuoco). Sono un grande fan dei libri e dei film horror e thriller degli anni Sessanta. Che
altro… Mi piace stare con mia moglie e con la mia
bambina di 2 anni: le piace un sacco ballare, non importa se si tratta di un boogie anni Ottanta o di una
filastrocca. Alla fine, principalmente, mi piace stare
in giro senza fare niente di particolare. E bere caffè.
Hai davvero letto l’Apocalisse di S. Giovanni per realizzare a Seven Seals?
Assolutamente no! Ma tutta quella roba mi affascina molto. Mio padre è un ministro presbiteriano. Sia
chiaro, non è assolutamente il tipo fissato con l’Apocalisse, il fuoco eterno, lo snake handiling [un rito
praticato da alcune chiese pentecostali americane ultraconservatrici che prevede di maneggiare un vero
serpente velenoso; ndr] e il mandare-i-tuoi-soldi-aGesù-Cristo. Anzi, è abbastanza fico. Ma ovviamente il
lato “deviato” del Cristianesimo (e dell’Inferno) è decisamente molto più eccitante per l’immaginazione (e
per i telegiornali) della semplice realtà di tutti i giorni.
Puoi descriverci la tua formazione musicale, come
musicista (e polistrumentista) e come ascoltatore
di dischi? Quando e come hai cominciato; che roba
ascoltavi; hai studiato musica?
Sono sempre stato malato per la musica. Pensa che
mio padre mi comprò un set di batteria, di quelli supercheap, tipo di cartone, quando avevo tre anni. Me ne
stavo tutto il giorno a pestare sopra i dischi di Whitney
Houston. Per un paio d’anni ho suonato la viola, ma poi
sono ritornato alla batteria. Ho suonato la batteria in
contesti jazz e in contesti orchestrali per tutto il periodo
delle scuole. Ho anche fatto parte di una marching band.
Allo stesso tempo, suonavo anche in gruppetti garage.
Poi una volta, al liceo, ho visto suonare Dj QBert e ho subito deciso che sarei diventato un super-dj da battaglia
[nel senso del turntablista virtuoso; ndr], come lui. Così
ho messo per un po’ da parte la batteria. Ma non ero
portato per essere un bravo battle dj. Poi ho scoperto
il sampling e il beat making e questo mi ha portato a
scoprire tutta la musica più pazza che si può trovare in
giro. Alla fine il cerchio si è chiuso, perché sono tornato
ai miei primi amori, il buon vecchio garage rock, il pop
16
e tutte quelle cose lì: molti dei dischi che mi facevano
schifo quando ero un b-boy e un crate-digger [il producer che cerca vecchi vinili per cavarne fuori loop e
beat; ndr] sono quelli che adesso mi piacciono di più.
Dicci di più su questo cosiddetto “fresh beat”. Sembra una coloratissima miscela lo-fi di vecchi beat hip
hop, dance anni Ottanta, influenze caraibiche, newwave malata…
Io non faccio “fresh beat”. Mi sa che è stato qualche espertone di marketing a tirarlo fuori (ride). Io faccio semplicemente quello che mi va di fare in quel preciso momento,
non mi importa se è new age, rap, jazz, soul, pop o altro.
Facciamo un gioco. Io ti dico il nome di un artista o
di un gruppo e tu mi dici quello che ti viene in testa,
quello che pensi, quello che vuoi.
Residents: Gli uomini talpa! Adoro The Making Of A
Soul da Not Available. Il sax mi fa pensare a una qualche
band exotica da incubo. E’ quello il sound che voglio.
Suicide: Facile. L’esempio perfetto di come le canzone
più semplici e più stupide sono le migliori. E’ come se
Frankie Avalon uscisse fuori dagli anni Cinquanta e cantasse sopra una drum machine scassata e una bassline
fatte di due note. Il mio pezzo preferito è I Surrender.
Jon Spencer: Non l’ho mai ascoltato.
Devo: Mi piacciono solo le loro primissime cose tipo
Booji Boy e Are We Not Men…
Half Japanese: Mai ascoltati.
Animal Collective: Sopravvalutati. Quando uscì Sung
Tongs mi piacque molto. Non c’era niente del genere
in giro. Ma andando avanti, devo dire che hanno finito
con l’annoiarmi. Sono comunque stati importantissimi,
perché è stato davvero incoraggiante vedere che anche
una band che suona una musica come la loro può vendere dischi. Sono ancora fichi, sicuro. Il disco di Panda
Bear era fico [probabilmente si riferisce a Person Pitch;
ndr].
Ween: Mi ricordo solo la loro Push The Little Daisies. Ho
anche un sacco di amici che sono fan dei Ween… forse
è arrivato il momento di approfondire la faccenda (ride).
They Might Be Giants: Mai ascoltati.
Frank Zappa: Per me è un po’… a come capita. Mi
piacciono un sacco le sue prime cose tipo The Duke of
Prunes e Help, I’m a Rock, ma alcune sue cose successive sono troppo “proggy” per me. Del resto, devo dire
che mi piacciono anche alcune cose del suo repertorio
prog, come Florentine Pogen. Insomma: la giuria deve
ancora deliberare (ride).
Gary Wilson: La più grande mente musicale della nostra epoca.
Baron Zen: Il prof. di scienze delle medie più fico che
conosco.
Peanut Butter Wolf: La seconda più grande mente musicale della nostra epoca. Deve solo riuscire a fare un
altro disco adesso (ride)!
Dam-Funk: Un professionista al 100%. Gli ho visto
fare una canzone dall’inizio alla fine – in cui suonava tutti gli strumenti in sequenza – in tipo 10 minuti: ed era bella! Inoltre, è una delle persone più carine che si possano incontrare nello showbusiness.
Approfondiamo il discorso sui Residents. Secondo me nei tuo dischi si sente molto l’influenza dei
loro suoni, delle loro voci deformate e, soprattutto,
dell’atmosfera generale della loro musica. Soprattutto del loro capolavoro pop-grottesco Commercial Album (vedi anche formato e intenti del tuo All
The Hits: brevi canzoni-schizzo simili a jingle pubblicitari). E’ vero? Cosa mi dici?
Mah.. forse è vero. Anche se io possiedo due, forse tre dischi dei Residents. Sicuramente è una band
che devo approfondire. Mi piace moltissimo il modo
che hanno di trattare la materia musicale. Mentre
non sempre mi piace il modo in cui effettano le voci.
Dai l’impressione di essere un solitario, un autarchico, uno che suona, registra e produce tutto da solo.
La voce femminile sul nuovo album è campionata
oppure si tratta di un feat vero e proprio? E, soprattutto, hai una band con cui portare in giro dal vivo
la tua musica?
Esatto. Lavoro molto meglio da solo. Mi viene difficile
collaborare con gli altri. Non so perché. Forse semplicemente perché con gli altri mi stresso e divento nervoso,
mentre quando sono solo non ho nessuno stress e non
sono in tensione. Sul nuovo disco c’è Lucrecia Dalt – che
ho conosciuto alla Redbull Music Academy – che canta su un paio di canzoni. Tutte le voci femminili in sottofondo invece sono di mia moglie. Quanto alla band,
ne ho una con cui suono regolarmente quando sono a
Spokane, Washington. Sono eccezionali, tutti miei vecchi amici, e mi diverto un mondo con loro. In ogni caso,
adesso io sono in tour in Germania, e ho trovato solo ragazzini di 13 anni da far suonare nella mia band (ride)...
Ci sono artisti contemporanei che ti piacciono particolarmente? Non so, gente come Flying Lotus, Toro
Y Moi, Tune-Yards?
Certo! Mi piacciono molto Flying Lotus e Toro y Moi,
e poi Sunn 0))), Mark Pritchard, Memoryhouse, Ariel
Pink, Daedelus, Teen Inc, Broadcast, Bubonic Plague,
le cose della Ghost Box [la fucina dell’hauntology Duemila; ndr], Ghostface, Build an Ark, Nissenenmondai,
Anika, Beak, Lil B, Felix Kubin, Oneohtrix Point Never,
Weedeater, Addison Groove, Kaval, Freddie Gibbs e mille altri. Hey, sto solo scorrendo il mio iTunes (ride)!
17
Tune-In
A colloquio con Ian Williams, chitarrista della band di
New York, nuovamente sulle scene con Gloss Drop: uno
degli album più attesi del 2011.
Battles
U
—Back to the battle field—
Testo: Simone Madrau
18
n’isterica fusione di math-rock ed elettronica
glaciale, l’indie-rock passato al vaglio dell’IDM
e quindi traslato nel futuro: era questa la formula alla
base di Mirrored, fulminante biglietto da visita con cui
quattro anni or sono Warp Records presentò quello
che sarebbe poi divenuto uno degli acts più brillanti
degli anni 00. Dietro ai misteriosi Battles si celava un
supergruppo formato da math-rockers vecchio stampo diretti e coadiuvati da una mente tanto fresca quanto schizofrenica come quella di Tyondai Braxton. Poi,
qualche mese fa, la separazione a sorpresa di quest’ultimo dal resto del gruppo; e poco dopo ecco i membri
superstiti sul sito della Warp, a promettere un ritorno in
una nuova veste. Un vero e proprio terremoto avvenuto nell’arco di pochissimi giorni, che minava in partenza le aspettative future di quanti, conquistati da Mirrored e dal successivo tour, credevano di aver trovato nei
Battles una nuova band di riferimento.
Alla prova del secondo disco, l’oggi trio di New York
sembra effettivamente cambiato. Il nuovo Gloss Drop
si muove in un colorato amalgama di math elettronico
e variopinte influenze esterne: colonne sonore, dub, e
molto altro. Gli esiti a nostro giudizio non sembrano
all’altezza della prova precedente, ma siamo in ogni
caso di fronte a un’uscita importante, che farà discutere e che non potevamo evitare di approfondire.
Da parte sua Ian Williams, raggiunto al telefono, non
vede l’ora di aprire il libro. Il tono di voce è quello di una
persona alla mano, giunta al termine di un lavoro dichiaratamente realizzato con maggiore sicurezza, ma
che pure non deve essere stato facile portare a compimento; e nondimeno, una fatica per cui l’ex Don Caballero vuole sentirsi ripagato, e di cui ci parla quindi
con grande spontaneità. L’unico tasto dolente sembra
proprio quello che riguarda Tyondai: per quanto Ian e
compagni abbiano già girato pagina, trapela un po’ di
amarezza nel guardarsi indietro. L’intervista.
Quando Tyondai se ne è andato, avete dichiarato che i Battles sarebbero stati una band diversa.
Ascoltando Gloss Drop direi che è proprio così
Sapevamo che qualcosa sarebbe cambiato, un po’ perchè era inevitabile e un po’ perchè noi per primi desideravamo evolverci in qualche misura. Quindi abbia-
mo fatto quella dichiarazione, ma non era niente più di
una dichiarazione di intenti. Al punto in cui eravamo in
quel momento non credo che nessuno avrebbe potuto
prevedere cosa esattamente sarebbe cambiato. Senza
contare che la registrazione di ogni brano di questo disco ci ha condotto a risultati spesso molto diversi: difficile quindi parlare di un cambiamento ben definito. Il
nostro modo di comporre consiste semplicemente nel
registrare i ritmi, le melodie, le dinamiche, e metterli
insieme. Mi piace molto, in particolare, ritrovarmi ad
ascoltare due tracce che suonano quasi in opposizione
l’una con l’altra, inserirle nello stesso brano e ascoltarne l’effetto. La visione completa di ciò che hai creato, in
ogni caso, arriva sempre per ultima: il sound di un determinato brano è qualcosa che crei inconsciamente,
non qualcosa che puoi pianificare. O almeno, noi non
ci riusciamo.
Una linea comune tra i brani comunque la si ritrova:
sembrate più positivi in questi nuovi brani, meno
Warp nel senso elettronico-futuristico e molto più
solari e divertiti
Penso che questa sensazione di maggior positività in
Gloss Drop sia dovuta al fatto che rispetto a Mirrored
abbiamo preso ulteriormente confidenza con questo
progetto, e non parlo solo di strumenti ma anche di
interazione tra i membri del gruppo. Con questo disco
ci siamo resi conto che non avevamo più paura di fare
queste cose e di farle in questo modo. A parte questo
abbiamo sempre avuto un certo senso dell’umorismo.
Ho il sospetto che la gente in generale ci prenda troppo sul serio rispetto alle persone che siamo oltre la musica.
Probabilmente questo è anche dovuto al tipo di
immagine che avete reso con l’album precedente.
Se ripensi al video di Atlas, devi ammettere che era
davvero claustrofobico con questa specie di cubo
trasparente immerso nel nulla. Tutt’altra cosa rispetto a un singolo come Ice Cream
E’ vero, Ice Cream è una canzone molto stupida. Ma ha
uno sfondo di serietà. Quando l’abbiamo registrata
eravamo in studio a Providence, Rhodes Island, e c’erano questi video di Bollywood alla televisione: football,
gente che ballava, ecc. Abbiamo pensato che quelle
19
sarebbero state le immagini giuste per Ice Cream: uno
strano ascolto legato a un’atmosfera allegra, come se
qualcuno ti dicesse che dietro quella felicità apparente tutto stava andando nel senso sbagliato: e abbiamo
giocato su questo aspetto. L’apporto di Matias Aguayo
nel brano è in equilibrio perfetto su tutto questo, concentrato sul modo in cui questa trappola omicida americana ti uccide mentre ci stai seduto davanti. Ha portato lo spirito giusto nel pezzo.
Parlando in senso strettamente musicale, invece, ritieni che ci sia anche un po’ di influenza glo-psichedelica a rendere Ice Cream così ‘solare’ e ‘diversa’?
Non saprei. Penso che in generale ciò che ci piace fare
sia sovvertire determinati meccanismi, e non essere
prevedibili nè tra un brano e un altro, nè all’interno dello stesso brano: penso ad esempio a White Electric, che
procede ‘seria’ per poi esplodere in quel divertente finale con la tastiera. Credo che questo punto sia per certi
versi la sintesi di ciò che vogliono essere i Battles: portare l’ascoltatore a credere che la nostra musica segua
un determinato schema per poi di colpo stravolgere
contesti e aspettative. Nel caso di Ice Cream l’intervento di un artista personale come Matias ha certamente
giocato un ruolo decisivo nell’economia del brano. Dubito che la gente si aspettasse un singolo del genere dai
Battles, e questa cosa ci conferma che il ragionamento
di cui sopra ha senso.
Ci sono brani come Africastle che hanno un’atmosfera cinematografica, in particolare nella seconda
parte sembra di ascoltare la colonna sonora di qualche pulp-movie
E’ vero, ci siamo fatti un po’ prendere la mano. Il fatto è
che adoriamo le colonne sonore in generale, soprattutto quelle dei vecchi film. E’ una sorta di nostalgia verso un tempo antico che sembra impossibile riprodurre
oggi: da un lato soffriamo questo aspetto, ma al tempo
stesso questa impossibilità rende tutto molto romantico.
Ci sono dischi, magari anche recenti, che vi hanno
influenzato nella creazione di alcuni brani, anche
solo sul piano degli arrangiamenti o di certe scelte
di suono?
Non saprei. Ascoltiamo musica di ogni genere ma non
sapremmo dire cosa precisamente ci influenzi. Ci sono
tanti gruppi che ci piacciono, a cominciare da quelli
che abbiamo coinvolto nel nostro disco ma, per quanto
possano piacerci, loro hanno il loro percorso e noi il nostro e non credo, al di là della reciproca stima, che ci influenzino più di quanto noi possiamo influenzare loro.
A parte questo ci capita spesso di ritrovarci ad ascoltare
cose molto distanti da noi, essenzialmente quelle che
20
passano per radio, come reggaeton e cose così: di base
non ci dispiacerebbero, ma sono in larga parte di qualità scadente. Così quando ci ritroviamo in studio prendiamo in considerazione solo noi stessi, con la massima
serietà, e cerchiamo di costruire da soli il nostro sfondo
lasciando tutte le altre influenze contemporanee a ruotare intorno a noi, ispirandoci magari sul piano dei contenuti ma non su quello prettamente tecnico.
Hai accennato agli ospiti del disco. Di Matias Aguayo abbiamo già parlato. Raccontaci qualcosa sugli altri, a partire da quella leggenda vivente che è
Gary Numan
Gary aveva una data del suo tour a Boston lo scorso autunno, e casualmente in quel momento noi eravamo
a Providence a registrare il disco. Siccome siamo tutti
suoi fans e siccome Boston dista solo 45 minuti da Providence, siamo andati a vederlo dal vivo. Siamo rimasti
impressionati dal suo live e gli abbiamo chiesto di partecipare al disco. Lui ha accettato con grande entusiasmo. E’ venuto in studio e ha registrato il suo intervento
in My Machines tra una data e l’altra, quindi un po’ di
fretta, ma il risultato ci ha comunque convinto. Quando
hai a che fare con un artista del genere non hai bisogno
di tempi particolarmente lunghi per produrre qualcosa
che ti soddisfi.
Kazu Makino
La sfida in questo caso era metterci alla prova con una
voce femminile. Quella di Kazu è molto particolare, così
pensavamo sarebbe stato ancora più difficile nel caso
specifico. In realtà, invece, tutto è stato molto più facile
del previsto perchè a dispetto della sua timbrica Kazu
ha uno stile molto naturale, e suonare intorno alla sua
voce è venuto spontaneo anche a noi.
E per finire, Yamantaka Eye
Non lo conoscevamo personalmente ma conoscevamo
gente che lo conosce e che ci ha messo in contatto con
lui. E’ una sorta di leggenda vivente, ci piacciono molto
i Boredoms e ci piaceva ancora di più l’idea di avere una
voce giapponese sul disco: un po’ perchè siamo stati in
tour in Giappone e abbiamo ricevuto forse la miglior
accoglienza di sempre in termini di pubblico, e un po’
perchè ci piaceva l’idea di avere un album ‘poliglotta’,
con gli ospiti che cantano ciascuno nel proprio idioma.
Non ci siamo propriamente riusciti, a dire il vero, ma ci
abbiamo provato.
Avete mai considerato la possibilità di trovare un
sostituto per Tyondai, ovvero un nuovo cantante
fisso?
Sì, ci abbiamo pensato lì per lì ma poi abbiamo rinunciato. Tyondai era parte del gruppo fin dall’inizio e, a
parte il fatto che non è facile sostituire un elemento
così caratteristico, trovare un nuovo membro fisso per
un progetto già avviato non era una cosa che ci allettava. Inoltre come ho detto prima era prioritario per noi
guardarci in faccia e capire come potevamo portare le
cose avanti rispetto al disco precedente. Ed era qualcosa che sentivamo di dover risolvere tra di noi.
Cosa ti manca di più di Tyondai?
(lungo silenzio, NdR) E’ un ottimo musicista.
21
Tune-Yards
Drop Out
—Musica come riccioli—
Il DIY di saper cogliere tutte le
opportunità dai propri mezzi.
L’intervista a Merrill Garbus aka
Tune-Yards
Testo: Gaspare Caliri
M
usica come riccioli. Riassumiamo così un’indole: in essi c’è la
natura – e la sua potenza – e l’elettricità – e la sua energia.
Il talento è la caratteristica che più descrive le peculiarità di
Tune-Yards, al secolo Merrill Garbus. Eppure il talento è nullo se
non si trova di fronte all’occasione che trasforma.
Trasformazione. Parola chiave imprescindibile. Merrill è un movimento continuo, sotto una molteplicità di punti di vista. Una
giovane mamma che diventa musicista. La stanzetta che diventa
studio. La voglia di esprimersi che diventa produzione sofisticata.
La competenza, acquisita con il fare, dell’arte del layering che crea
le condizioni di possibilità per applicarsi sulla musica di qualcun
altro. E, quindi, l’esperienza della co-produzione in Thao & Mirah,
con la folkster di K Recs e Thao Nguyen della Kill Rock Stars. E
ancora, una esperienza “professionale” che non può che fare da
22
23
Oltre alla capacità e alla presenza scenica unica della voce, calda e soul
ma anche venata di altri continenti, la prima evidenza che saltava agli occhi
era il lo-fi, ma non quello perseguito come fine che si emancipa dallo status
di mezzo. Altrettanto semplicemente, la “bassa fedeltà” dei cervelli-uccello
era, come un ritorno alle origini, la conseguenza dell’economia dei mezzi.
Momentanea eppure già stato dell’arte. Rimasero a bocca aperta anche gli
scout della 4AD, che decisero all’istante di mettere il proprio marchio sul
disco appena uscito e ripubblicarlo. Il mondo scoprì Merrill Garbus e tutti
cercarono di andarla a vedere dal vivo. Quel sound di riciclaggio worldtuned si rivelò molto più sofisticato del previsto, fatto com’era – com’è – di
sovrapposizioni di ragionamenti, toni, elementi di una composizione che
trascende il mero effetto pop, pur non perdendolo di vista come outcome.
O ccasioni
anticamera per un rapporto amicale.
Il tutto esemplificato, tangibilmente, dallo spostamento fisico e di contesto che è scelta di movimento completo. La provincia canadese, il New
England, che diventa metropoli (Montreal) e poi California. Il tema del viaggio e della ricerca di mondi è un bagaglio che le iarde di toni condividono
con tante altre esperienze. C’è tutta un’infanzia e un percorso formativo,
nella Garbus, che parla di tradizione locale, di rotonde radici anglosassoni.
Dato il presupposto, la voglia di sperimentare è risultante di una continua
scoperta, che si ripercuote nell’ascoltatore. Le canzoni di Tune-Yards sono
chiaramente il massimo indizio dei mondi toccati dall’autrice. Come si dice
a volte, la filogenesi dei brani prospetta a volte l’ontogenesi della persona,
delle note che dal cervello finiscono con l’essere incise.
Per questo e altro, Merrill Garbus è personaggio che portiamo a esempio sempre più spesso, e sempre come best practice dei quartieri musicali che frequentiamo. Ci siamo entusiasmati quando nel 2009 uscì BirdBrains, inizialmente per la portlandina (guarda caso) Marriage Records. Lo
chiamammo pop globale, ma inteso in un modo diverso rispetto alle manifestazioni di intenti e istanze di M.I.A., così come da universi di collage
etnomusicologico. Ci sentimmo, semplicemente, il mondo chiuso in una
stanza, e la quintessenza degli ’00. Un riassunto perfetto del glocal di fine
millennio, scollegato da riverberi politico-economici.
24
mai mancate
Certo la storia di Tune-Yards non nasce nel 2009, e oggi che la freschezza è più matura vi riconosciamo una collezione di esigenze che diventano
scelte brillanti, altro modo per esprimere la formula “necessità che diventa
virtù” saturata di creatività. Il primo passo della vicenda è piuttosto il trasloco dal nativo New England alla raggiante Montreal, dove la Garbus, figlia
d’arte, entra nei Sister Suvi dell’amico Patrick Gregoire. Nascono occasioni
di scambio ma anche piccole frustrazioni originate dalla disparità di investimento nel progetto. Merrill non ha ancora trovato quello che cerca. E non
le serve molto tempo, a dire il vero, per accorgersi che il percorso migliore
è quello personale: la rielaborazione di un cervello che contiene tradizioni vicine e lontane, insegnamenti famigliari e i frutti delle proprie indagini
musicali. I primi passi sono “open mics” nei locali di Montreal, ma anche
performance di strada. “La regola era, come sempre, cogli l’attenzione della
gente, o muori. Fallo entro i primi cinque minuti, o meglio ancora entro i primi
trenta secondi, oppure non avrai più orecchie che ti stanno a sentire”. “Sentiti
parte del contesto, oppure vattene”, si diceva in quelle circostanze.
Non è un caso. Già dietro a Bird-Brains c’erano tanto studio e tanta dedizione - verso le tecniche teatrali, ma soprattutto nei confronti della Madre Africa come origine della musica nera che sboccia in ogni angolo del
mondo, leggi anche alla voce Giamaica. Merill conosce per frequentazione
il Kenya, ma non solo. “Ho ascoltato molto la musica di Nairobi degli anni Settanta e Ottanta – quella roba che facevano con le chitarre ha influenzato moltissimo il modo in cui suono l’ukulele. Lì ci trovo tutto il mio lo-fi”, dichiarava un
paio di anni fa. “Quando ascolti registrazioni di posti come quelli, dove non vai
molto spesso, ti viene da pensare ‘Oh my God, thi is real music’. C’è qualcosa di
profondo, che scava. Una performance di gruppo a cui mi sento estremamente
vicina”. Imitando l’Africa Merrill, da autodidatta, impara a far deflagare la
voce, e a credere nel flusso. La sua investigazione trova la massima sazietà
quando scopre la musica di una tribù della Tanzania chiamata Wagogo. È
come un fulmine sulla strada di Damasco. In quella tribù Tune-Yards si scopre come tale, capisce una volta per tutte la propria sensibilità musicale.
Il travaso non è facile, quando le idee e le melodie non hanno una controparte tecnica che garantisca la corretta esternalizzazione. Uno dei tratti
che più ci convince in Bird-Brains è la genialità estremamente talentuosa
del tramutare una mancanza in motivo di progettazione musicale. Valgano
da esempio quelle sofisticazioni che ovviarono alla mancanza di un basso
con layer di percussioni da bedroom e pedale. Il DIY di Tune-Yards non è
25
scelta estetica ma nasce come messa a sistema di quello che si ha. “Non
avevo un basso”, dichiara sorridendo Merrill, “letteralmente non ne possedevo uno, per l’appunto, e le percussioni dovevano essere poderose ed evidenti,
per nasconderne l’assenza”. Un tratto distintivo come questo, un elemento
così esplicito da poter diventare subito elemento caratteriale, cui aggrapparsi per garantire riconoscibilità a lungo termine, è stato superato quando
si è ovviata alla mancanza. Quando si guarda oltre, con l’innocenza e la determinazione della curiosità, la penna supera le forme statiche. Il live, come
si accennava, non è motivo di replica ma di “improvement”. Non appena
giunti gli apprezzamenti per lo splendido esordio, Garbus inizia a girare il
Nord America per mostrare i tunes effervescenti di cui è capace.
Approda persino alla Music Hall di Williamsburg, come opener per i
Dirty Projectors. Ad accompagnarla, un nuovo compagno di avventure, il
bassista Nate Brenner, oggi di fatto altra colonna di Tune-Yards (forse una
band, ormai?). La musica non può che assorbire gli effetti del nuovo ingresso in formazione, e così il secondo album, tagliato non a caso con riff
post-punk in bella vista, frullati nel pentolone di loop ma pur sempre determinanti nel far cogliere un’evoluzione. Terza parola chiave. Variante del
movimento e della capacità di quello stesso talento di proseguire la strada
intrapresa con la giusta passione verso il nuovo.
L ayer
colorati
Di questo e altro abbiamo parlato direttamente con Merrill Garbus, in una
sequenza di domanda risposta che non ha deluso le nostre aspettative,
così come il sophomore non ha fatto che accrescere la curiosità con cui
rivolgeremo l’attenzione al prossimo album di Tune-Yards. Abbiamo trovato una persona inevitabilmente colorata, ma anche capace di mettere a
26
fuoco la direzione che sta percorrendo. Il focus delle energie che ha mette
a disposizione si è dimostrato tutto teso a non perdere di vista la ricchezza
della sovrapposizione di layer, meta-strumento che si perde per origine nei
decenni passati, pur essendo materia da scommesse sicure anche per il futuro. Ancora una volta, Merrill si distingue per essere figura rappresentativa
di un tempo specifico (il nostro) e produttrice di una qualità musicale che
resisterà probabilmente al corso degli anni.
Passando dal tempo (orizzontale) alla dinamica verticale, non si può
non parlare, a proposito della Garbus, dell’efficienza trasversale di quello
che propone. Basta cercare Tune-Yards sui motori di ricerca per rendersi
conto della sfaccettatura di mondi che la citano, la guardano, la ascoltano. Non è il solo Pitchfork ad averla lanciata. O meglio, le riviste di settore
hanno fatto il loro corso e hanno prodotto inviti come quello al Primavera
Sound di quest’anno, arena di proclamazione ideale per l’autrice di Whokill. Eppure c’è tutto un altro sistema di mondi di diversa estrazione – in
materia di cultura musicale – che si affezionano a Tune-Yards e a canzoni
come Bizness o Hatari.
Non sarà l’unico motivo, ma di certo la quotidianità ha contribuito alla
fidelizzazione dell’ascoltatore “medio”, inteso come media di una sommatoria di target molto diversi tra loro. È Merrill che introduce sé stessa al principio di Whokill. È la sua bimba a intervenire per la madre nel primo brano
di Bird-Brains. Testimonianze del privato che si confonde col pubblico. Altro
elemento di ancoraggio trasversale è la comunicazione. 4AD è una grossa
etichetta e conosce i tempi e i modi giusti per promuovere un prodotto. I
videoclip dei brani di Bird-Brains funzionano, ma forse ancor più ha funzionato la finta tattica (in realtà componente di una strategia di promozione)
di mostrare la Garbus al lavoro nel suo nuovo studio di registrazione californiano. Il volto dell’ex-lo-fi-er che si mette in gioco con un’apparecchiatura professionale. In questo caso, a cascarci sono tutti i fan e i curiosi del
settore, che intravedono il segnale – ponderatissimo – di una svolta, senza
tener presente la gradualità con cui Tune-Yards affronta la trasformazione,
giorno per giorno. Tutti appigli intelligenti per tener lì attaccato il cervello, in attesa che sia l’orecchio il protagonista vero dell’esperienza. Anche
questo è talento. Del resto, come Merrill stessa ci confessa, il mestiere della
musica vuol dire saper fare un raccolto mirato in ettari di melodie che sarebbero a disposizione di tutti, se solo le sapessero riconoscere e cogliere.
Se Tune-Yards le raccoglie e confeziona così bene, viene da dire, è meglio
continuare a osservare e aspettare il risultato.
Com’è nata la trasformazione da Merrill a Tune-Yards?
È stato molto semplice. Ho iniziato suonando l’ukulele nella mia stanza da
letto. Subito dopo ho sentito l’esigenza di avere del ritmo e mi sono fatta
prestare da un amico un pedale per loop e ho iniziato a battere sull’ukulele
per ottenere dei beat. Il tutto è stato testato grazie a open mics e performance nei caffè di Montreal. Bird-Brains è frutto del lavoro nella mia camera
e del suo effetto in piccoli live.
Se non sbaglio, sei figlia d’arte e hai avuto una formazione musicale…
In effetti entrambi i miei genitori erano musicisti. Entrambi dediti al folk.
Mia madre mi ha insegnato a suonare il pianoforte quanto avevo tredici
anni. Mio padre suonava il banjo e il violino in molte band diverse, e mi insegnò a trattare con le melodie tipiche del fiddle (violino usato nella musica country, ndt.). Non ho mai avuto formalmente un’educazione musicale,
27
non almeno quella standard dei conservatori, ma la musica è sempre stata
dentro e attorno a casa mia.
Mi incuriosisce molto la tua maniera di comporre. Usi un metodo standard nel fare musica?
In realtà no, o meglio, non succede mai nello stesso modo; in genere le canzoni nascono con frammenti di melodie o idee ritmiche. Il passo successivo
è l’improvvisazione di looping pedal che rielabora quei primi elementi. È
momento essenziale del mio approccio. Lì vengono fuori tante cose: giocare con loop e sovrapposizioni mi aiuta molto. Ora che ci penso è una
pratica abbastanza assodata nel mio modo di fare musica: inizio con un
beat improvvisato e poi vedo come funziona con sopra una linea di ukulele
o una melodia vocale.
In generale: la musica è una pratica o una mera espressione di sentimenti e delle proprie sensazioni?
Decisamente una pratica. Le sensazioni vengono sempre fuori, ma è la pratica che dà loro una forma e una cittadinanza.
Quando penso al nome Tune-Yards penso a una cascata di melodie
soul che si sovrappongono. Come i “mattoni” delle composizioni minimaliste. Ti ci ritrovi? È più centrale una melodia o il layer di cui essa fa
parte, nella tua musica?
È una questione interessante. Ogni melodia è un frammento con la sua importanza. O meglio, è frammento ma in quanto melodia porta con sé una
storia, la racconta, per così dire. Ma il mio obiettivo, ciò su cui mi concentro
di più, è l’effetto complessivo del layering. È questo che mi appassiona, il
risultato finale della sovrapposizione.
Le “tune-yards”, per me, sono lande dove si possono trovare canzoni. È un
pensiero che mi rilassa molto: quelle melodie, quelle canzoni, esistono già,
basta trovarle, e il ruolo del musicista è propriamente il loro disvelamento,
come una mietitura, un raccolto.
Per realizzare Whokill hai avuto a disposizione uno studio vero. Cos’è
cambiato? Ti ci sei sentita a tuo agio?
Abbiamo avuto una piccola sala prove, più che uno studio, dove ho scritto
la musica di Whokill, e poi uno studio di registrazione dove tutto ciò ha
preso vita. La sala prove è come il mio ufficio. Funziona come un posto di
lavoro normale. Ci sto tutto il giorno e mi causa pure stress, perché so che
quando ci entro mi aspetta un sacco di lavoro!
Lo studio è un po’ un’estensione della bedroom? Oppure un non-luogo
che si anima a intermittenza?
Per la mia esperienza, è difficile che uno studio di registrazione possa essere personale come un luogo privato. Eppure, i benefici che ti dà sono molti.
Non solo: consente di passare ore gioiose, specie se lo condividi con persone con cui si lavora bene. Nel mio caso, questo è successo con Eli Crews, il
nostro ingegnere del suono, che mi ha dato un grosso aiuto con Whokill…
con lui abbiamo lavorato sodo, suonato moltissimo, ci siamo sentiti “creativi” e realizzati. In qualche modo quei momenti sono irripetibili, e credo che
questo dà un’anima a un luogo.
La più grossa sfida cui ho fatto fronte nello studio è stata liberarsi del “sound
da studio”. Il rischio è sempre tangibile, quando si viene da contesti più informali e si ha a che fare con un posto così professionale. Ma io avevo l’obiettivo
chiaro in mente: essere certa che le mie canzoni non finissero col suonare
asciutte o statiche, ma sempre vitali, e capaci di rimbalzare sui muri.
28
Domanda secca: le differenze principali tra Bird-Brains e Whokill?
Le due maggiori differenze a mio parere sono state, come detto, registrare in uno studio con un ingegnere di talento come Eli e aver suonato per
un anno, subito prima, con un bassista vero, cioè Nate Brenner. Nate ha
aggiunto elementi cruciali nella maggior parte delle canzoni, e la nostra
esperienza di suonare di fronte a migliaia di persone ha avuto un impatto
decisivo sul nostro modo di suonare, e ci ha fatto sentire una band.
Oggi lavori anche come produttrice, alludo all’esperienza con il selftitled di Thao&Mirah.
È stato meraviglioso approcciarsi a un progetto dall’esterno. Dal momento che non mi sentivo così emotivamente coinvolta dalle canzoni, le ho
potute vedere e affrontare da un punto di vista squisitamente musicale. Il
risultato? L’amicizia con Thao e Mirah, e tanto divertimento.
Per tirare le somme: è evidente che ti piace lavorare con altre persone…
Assolutamente sì. Whokill non ci sarebbe senza la collaborazione di Nate
ed Eli. Tune-Yards non è mai stato un progetto che ho voluto tenere per
me, ma la mia insicurezza ha sempre evitato che lo condividessi con altre
persone, per paura che non capissero le mie esigenze. Con Nate ed Eli è
andato tutto a meraviglia, e, al contrario, mi hanno aiutato a esprimermi.
C’è chi dice che la relazione tra live e studio in Whokill sia più stretta.
Abbiamo registrato molti live e poi li abbiamo riascoltati e trattati in studio.
È inevitabile che un po’ di effetto dal vivo finisse nel nuovo disco. Ma il live
show e un album sono due bestie differenti.
Che musica ascolti? O cosa ti piace di più in questo periodo?
La maggior parte delle cose che ascolto sono band di amici e parenti, come
quella di mia sorella, Ruth Garbus. Oppure Chris e Kurt Weisman. Mi piacciono molto i Dirty Projectors, per esempio. Potrei fare mille nomi, ma forse
la risposta più sensata è che apprezzo il silenzio, nei rari momenti in cui non
sto creando musica.
Cambiare città cos’ha comportato? Hai trovato una scena musicale accogliente?
Mi sono trasferita a Oakland l’anno scorso, e questo ha avuto sicuramente
una grande influenza sulla mia musica. Amo questa città. mi dà una fortissima energia creativa. C’è confronto, fibrillazione. E credo che questa energia
si senta nelle nuove canzoni.
Credi nell’arte?
Certo che sì! Dopo tutto, le ho dedicato la mia vita!
Cosa ci dobbiamo aspettare da Tune-Yards?
Attualmente sto provando a lungo per i tour che sta per iniziare. Dal vivo
saremo io, Nate al basso, Matt Nelson e Kasey Knudsen ai sassofoni. Suona
già meravigliosamente, ma vi prometto che suonerà sempre meglio!
29
Recensioni
2562 - Fever (When In Doubt, Marzo 2011)
Genere: Steps, Funk
Cinque anni di carriera e una strada tutta in salita per
Dave Huismans, music maker dal doppio alias, 2562
(Tectonic, 3024) e A Made Up Sound (Delsin, Clone),
che si era avvicinato progressivamente al 4/4 e a una
visione sempre più autarchica in sede di produzione.
Lo scorso anno ben cinque delle sue produzioni risultavano self released: è quindi naturale oggi vederlo pubblicare per una label personale, la When In Doubt (per
quest'ultima l’olandese ha già pubblicato alcuni 12’’ tra
cui il buon Aquatic Family Affair). Ora è la volta dell’album lungo che risponde, almeno nelle intenzioni, a un
concept. Tutti i sample infatti, dovrebbero provenire
dalla disco music tra i Settanta e gli Ottanta con particolare attenzione al 1979, sua data di nascita. Condizionale più che mai d'obbligo perché nell’album non
vi è traccia del tipico immaginario 70s se non in senso
molto (ma molto) aleatorio.
Huismans è sempre stato dominato dal tipico rigore 'arischio-freddezza' di tanti producer continental-step e
Fever non fa eccezione se non per un decisivo arricchimento e bilanciamento della formula. Se disco dev'essere, Dave l'aggiorna intelligentemente con spezie UK
Funk, rompendo gli schemi bidimensionali techno /
dubstep (alle volte in triangolazione house) e aprendosi al (2 step) garage. Gli smalti dubstep (Flavour Park
Jam), trance e techno (i già accarezzati ricordi belga di
Brasil Deadwalker) ne risultano rinvigoriti e se anche
quest'album si avvale del citazionismo primi 90s tipico di questi anni, Huismans è sicuramente il producer
meno infatuato del retrò. Ed è soltanto un bene.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
31Knots - Trump Harm (Polyvinyl Records,
Maggio 2011)
Genere: art-pop
È una carriera lunga e purtroppo sottovalutata quella
dei 31Knots. Giunti al settimo album, senza contare
mini ed ep, i tre da Portland sembrano tutto tranne che
appagati dal fare musica. Sia in termini generali (di successo e/o riconoscimento, oltre la nicchia, se ne è visto
30
— cd&lp
poco) che personali, vista la verve con la quale affrontano ogni esperienza discografica. Cosa quest’ultima
che li spinge avanti incoscienti e menefreghisti al punto da metter su l’ennesimo album strambo, spigoloso,
coraggioso e, diciamolo, completamente “fuori moda”,
se la definizione ha un senso.
Cosa quest’ultima da considerarsi un grandissimo
complimento poichè evita la standardizzazione della
proposta e sta a significare che il chitarrista Joe Haege (sfaccettato leader visto ultimamente coi fantastici
Tu Fawning, coi Menomena, autore di soundtrack e
anche attore in film indipendenti), il bassista Jay Winebrenner e il batterista Jay Pellicci hanno un progetto
ben chiaro in mente e sono pronti a seguirlo fino in
fondo e a qualsiasi costo.
Su pentagramma, ciò si traduce nei 10 brani di Trump
Harm, dall’appeal avanguardisticamente pop per
come sono sospesi tra sperimentazione “rock” e accondiscendenza popular. Roba in grado di solleticare
i palati degli indie-kids meno dozzinali e attenti alle
evoluzioni sperimentali del trittico rock chitarra-basso-batteria: che siano i cambi di tempo scavezzacollo
dell’iniziale Onanist’s Vacation o l’indie-rock umorale
di Middle Ages, le aperture teatrali post-wave di Egg
On My Face o lo stranito e weird horror-show di Love
In The Mean Of Heat, i 31Knots vanno costruendo un
suono che è suggestione e originalità. Alla faccia del
fuori moda.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
highlight
Arrington De Dionyso - Suara Naga (K Records, Aprile 2011)
Genere: eartherngarage
Capita a volte che un album diventi tanto importante nella carriera di un musicista da diventare il moniker di un nuovo progetto. Non sempre i risultati pagano - vedi le alterne vicende del moniker Mount
Eerie di Phil Elvrum. Proprio a proposito di Old Time Relijun, l’ex collega, la mistica e sanguigna voce
che risponde al nome Arrington De Dionyso, sceglie una strada simile. Dopo Malaikat Dan Singa,
album dove Arrington celebrava un felicissimo sposalizio tra l’indonesiano e il garage occidentale, oggi Suara Naga (“la voce del dragone”) esce a
nome Arrington De Dionyso’s Malaikat Dan Singa (ovvero “gli angeli e
i leoni di ADD”).
Arrington è un virtuoso di quelli che vorremmo calcassero più strade possibili. Le virtù, per lui, sono sempre funzionali a un valore musicale, a una
ricerca. Non accade mai viceversa. Da etnomusicologo, per analizzare la
voce e l’anima ha inciso a fondo l’essenza delle proprie corde vocali, le ha
portate alle estreme conseguenze; allo stesso modo, ha appreso l’indonesiano, da autodidatta, e ha iniettato il turbamento e l’assalto strumentale occidentale nella lingua di
quell’estremo Oriente, rendendolo apocalittico, mischiando quell’incrocio di vitalità e esotismo erotico
con le bruciature che vengono dal centro della terra (Iblis Atas Ibis).
In realtà, non ha fatto altro che sviluppare un canovaccio, come nelle musiche popolari. Un modello
di composizione, strumentazione ibrida, campanelli e riff, fiati paraindiani e gutturalismi. Questo non
vuol dire che manchi accuratezza. Quel canovaccio è Arrigton stesso. Non rappresenta una cultura ma il
sostrato del repertorio di De Dionyso portato in superficie, così com’è, e ripetuto in Malaikat Dan Singa
quanto in Suara Niga. La voce, il modo di comporre, il mondo sanguigno e pronto a zoppicare come un
appestato: c’è tutto Arrington, tanto nel boogie surreale di Madu Mahadahsyat quanto nel rock steady
di Biangala. Il giudizio va all’uomo, al percorso di ricerca, più che alla veste effettiva dell’album. È vuole
essere un incoraggiamento ad andare avanti così, senza fermarsi, complicando il canovaccio (verso
l’Africa in Susu Naga) anziché asciugarlo al sole.
(7.3/10)
Gaspare Caliri
AA. VV. - Let The Children Techno (Ed
Banger Records, Febbraio 2011)
Genere: french touch
Monsieur Pedro Winter chiama a raccolta i purosangue della propria scuderia per una compilation che
vuol far divertire più che scatenare, come l'artwork del
disco lascia intendere. Tra i nominati, personaggi importanti di oggi e di ieri, come Mr. Oizo, Discodeine,
Cassius, Siriusmo, persino Skream e Flying Lotus, ad
offrire un affresco ad ampio raggio delle possibilità
techno dell’etichetta francese più nota del pubblico
mainstream (insieme solo a Kitsuné e alla barbarie de-
gli innumerevoli Buddha Bar). A spiccare non è una tendenza in particolare, ma una
generale sregolatezza che va dalle mosse più hardcore
di Brodinski e Bobmo a quelle più french style di Breakbot. Tra gli additivi funk di Duke Dumont, la fidget
dello stesso boss Busy P (Procrastinator), tech-step di
lusso (Boat Party), glam-disco (Shades Of Black) e aperture pop/electro (Infinity Riser) la proposta si fa apprezzare tenendo lontana la noia. Per gli estimatori sarà solo
una nuova conferma, ma chi non conoscesse l'offerta
di casa Ed Banger è un'occasione d'oro per recuperare.
Don't lose your time.
(6.5/10)
Carlo Affatigato
31
Adam Haworth Stephens - We Live On
Cliffs (Saddle Creek, Aprile 2011)
Genere: indie folk
Metà dei Two Gallants, dopo che dal 2002 ad oggi il duo
si è guadagnato la propria visibilità gettando litri di sudore sui palchi di mezzo mondo (e un pugno di buoni dischi,
va detto), Adam Haworth Stephens fa il suo debutto solista con lo sguardo fisso sull'orizzonte del genere Americana, coniugandolo con un'aspirazione all'airplay.
Non ci sarebbe nulla di male nel cercare di bucare anche nel mainstream se si tenta, per farlo, la strada della
personalità, dell'originalità e della creatività declinandola in sussulti pop. Qui, invece, tutto suona un po' già
sentito, come una versione minore della band maggiore, come un ripercorrere stereotipi country/folk/rock
che vanno bene, quando sono ben riusciti, per fare
da sottofondo a un viaggio in auto, quando va male ti
spingono a cercare il tasto "skip".
Succede così per Heights of Diamond che ti ricorda
qualcosa di già sentito, e precisamente quella Second
Mind ascoltata due tracce prima e che segnala un'ispirazione non proprio al suo massimo. Elderwoods è AOR
indeciso tra l'uptempo e la ballad, Sounthern Lights un
compitino folk senz'anima e il tentativo di premere il
piede sull'acceleratore country-rock con Praises in Your
Name non colpisce del tutto nel segno, soffocato com'è
da troppi spigoli per poter scorrere fluidamente.
(5.5/10)
Marco Boscolo
Africa Hitech - 93 Million Miles (Warp
Records, Maggio 2011)
Genere: ambient minimaltech
Mark raffredda i bollori street, urban, tribal - in definitiva, ragga - che lo avevano spinto a dare vita al progetto, frena le pulsioni che avevano animato le sue cose
migliori realizzate sotto questo moniker (a partire dal
singolone d'assalto Out In The Streets), fa emergere il
suo lato più cerebrale, calcolatore, scacchistico, freddo,
ambient (e perde la partita a distanza con Kode9). Spacek relegato in un angolino, si impongono per quantità
le produzioni dei brani strumentali, una vera goduria
per i tecnicisti e gli specialisti, vero cuore senza cuore
di un disco lavoratissimo ma tutto tranne che potente,
laboratoriale ma non sperimentale, una sequenza di
cesellatissimi esercizi ritmici e timbrici.
Le diverse componenti di cui Pritch speravamo potesse
fare sintesi vengono invece esposte in separata sede: ci
sono i pezzi urban (pochissime cose, Out In The Streets,
appunto, e il vocoder liquido ma denso come mercurio
di Do U Wanna Fight) e c'è la sfaccettata anima ambient
32
del produttore, fatta di rigorosi giochetti minimaltechvideogame (Our Luv è un lunghissimo showcase di soluzioni mutuate dagli arcade di metà anni Ottanta) e di
acquerelli che declinano l'africanismo della ragione sociale secondo modi e toni praticamente latin (non lontanissimi da certa ambient-house Cobblestone Jazz,
solo che Mark parte dalla minimal e non dalla deep;
Cyclic Sun è una superbo lounge-jazz suonato dal taglio cameristico e dal respiro epico).
93 Million Miles doveva viaggiare avanti anni luce,
come prometteva sulla carta la formula del progetto
e come promettevano all'ascolto le produzioni dell'EP
2010. Ma la componente afrofuturista è stata quasi del
tutto diluita, messa tra parentesi anzi, a favore di un
elegante esibizionismo produttivo di certo invidiabile
ma che non riesce a scavalcare la supermaniera.
(7/10)
Gabriele Marino
Aidan Moffat/Bill Wells - Everything's
Getting Older (Chemikal Underground
Records, Maggio 2011)
Genere: Jazz-Pop Poetry
Ok, Aidan lo conosciamo già, e pure bene: non ne perdiamo una mossa, dacché lui e Malcolm hanno imboccato strade separate, spezzando non pochi cuori
svezzati a pane e Philophobia. Su Bill Wells, compagno
della nuova tappa di un errabondo percorso solitario
che finora ha portato il barbuto di Falkirk alla poesia
porno (I Can Hear Your Heart) e al cantautorato folk-pop
(How To Get To Heaven From Scotland, coi Best Ofs), val
decisamente la pena di spendere due parole. Stiamo
parlando di un signore che da diversi annetti è protagonista assoluto del sottobosco scozzese, che produce
ma soprattutto suona (basso, chitarra, piano), che mastica jazz e avanguardia (con il suo Bill Wells Trio) ma
non disdegna collaborazioni e contaminazioni varie e
assortite (Isobel Campbell, Pastels, Telstar Ponies, BMX
Bandits, Future Pilot A.K.A., Maher Shalal Hash Baz), che
va da Gil Evans a Burt Bacharach passando per Mingus
con una sensibilità che non è proprio da tutti.
“A change is just a new routine” canta Moffat in Cages, ed
è proprio questa l’idea su cui si regge Everything's Getting
Older, appena venticinque minuti in cui la formula Arab
Strap rivive di nuova linfa, diversa eppur ancora uguale, con quei versi sbilenchi in bilico tra canto e spoken
word rovesciati (a mo’ di pinta sul bancone, ovviamente) su tappeti sonori mai prevedibili e scontati, pur nella
loro matrice classica e jazzy. Ci sono voluti la bellezza di
otto anni per completare queste poche tracce (l’avvicinamento tra i due è avvenuto all’epoca di Monday At The
Hug And Pint, sui cui solchi Wells fece tintinnare il piano),
ma davanti a piccole gemme di melodia come A Short
Song To The Moon e il cinematico singolo (If You) Keep
Me In Your Heart, il rap sordido a su base acid di Glasgow
Jubilee o una Ballad Of The Bastard che echeggia addirittura Neil Young (quello coi tasti d’ebano e d’avorio,
non con la sei corde), sembrerebbe sia trascorso proprio
il tempo giusto, non un secondo in meno. Un disco di
quelli in cui non ti imbatti tanto spesso, no.
(7.1/10)
Antonio Puglia
Alain Johannes - Spark (Domino, Maggio
2011)
Genere: post-grunge
C'erano una volta gli Eleven, band di Los Angeles in
cui militavano Alain Johannes, la di lui moglie Natasha
Shneider ed il batterista Jack Irons, già apprezzato nei
Red Hot Chili Peppers e in procinto di raggiungere i
Pearl Jam. Non eclatante il successo, ma neanche trascurabile. Quanto al resto, se la passavano bene scambiandosi prestazioni sonore e amicizia con simpaticoni
quali Queens Of The Stone Age, Mark Lanegan, No
Doubt, Pearl Jam e Chris Cornell. Poi, la tragedia: il
cancro si porta via la Shneider nel 2008, lasciando il
marito comprensibilmente distrutto. Lo ricordiamo
fiero e commosso al concerto-tributo organizzato da
Homme, ospiti i QOTSA al completo più altri calibri
come Jack Black (l'attore) e PJ Harvey. Una bella persona, Alain. Non si è arreso. Ha continuato a lavorare
come ingegnere del suono per Gutter Twins e Arctic
Monkeys, ad esempio, poi nell'ottobre dello scorso
anno ha sfornato questo Sparks, commercializzato
solo oggi dalle nostre parti.
Tema dell'album, indovinate un po', l'adorata Natasha,
ovvero anche un'occasione per riflettere sulla persistenza della memoria, sulla morte, sull'amore, sulla
persistenza dell'amore malgrado la morte attraverso
la memoria. Bene. Anzi, non troppo bene. Ok, male.
Piuttosto male. Perché - fermo restando il rispetto per
i sentimenti che hanno mosso l'operazione - questo
disco è quasi inascoltabile. Pervaso del lirismo aulico e
pettoruto del Cornell solista, saturo di misticismo muffoso Jimmy Page (Make God Jealous è praticamente
un plagio di Black Mountain Side), costruisce un tabernacolo più tronfio che affranto, così ottusamente postgrunge, così impegnato a definire eterei barocchismi e
tormentose profondità da sembrarne - ohibò - compiaciuto. In poche parole, è un ascolto imbarazzante.
(4.8/10)
Stefano Solventi
Alexander - Alexander (Rough Trade,
Marzo 2011)
Genere: lo-fi folk
In libera uscita dai due act più noti in cui è coinvolto
(Edward Sharpe & the Magnetic Zeros e Ima Robot),
Alexander Ebert si concentra su un cantautorato di matrice lo-fi che affonda le proprie radici nel folk.
Per questo esordio tutto sommato relativo, e comunque per un'etichetta dal peso specifico non piccolo,
Alexander abbandona il cognome e come in tutti i dischi eponimi ci si aspetta una specie di album-manifesto. Sul talento di comporre melodie degne di nota
c'è poco da discutere, basti l'efficace folk-stomp col fischietto di Truth o il saliscendi in salsa country di In The
Twilight. Il problema, semmai, è una certa in-finitezza.
Nel senso proprio classico del termine di qualcosa di
non finito. Che non riguarda l'estetica lo-fi complessiva, ma l'impressione generale che se Ebert avesse voluto avrebbe potuto levigare ulteriormente le sua composizioni e fare un esordio davvero coi fiocchi.
Questo discorso vale per il mezzo sberleffo dylaniano
di Let Make a Deal to Not Make a Deal che poteva essere
asciugato nell'arrangiamento, per i cori eccessivi di Bad
Bad Love e in generale per le indecisioni su cosa davvero si voglia dire. Ecco, tra un'allusione ai Fleet Foxes,
una al Neil Young da corsa all'oro, forse Alexander non
ha ancora del tutto chiaro cosa vuol fare da grande.
Di certo sa cosa gli piace, ma una poetica personale è
qualcosa di più del buon gusto.
(6.4/10)
Marco Boscolo
Anne-James Chaton - Événements 09
(Raster Noton DE, Aprile 2011)
Genere: poesia trance
Associare techno e poesia non è da tutti. Chaton riesce nell'intento in modo apocalittico e diaristico, combinando in un patchwork folle e pesantissimo parole
che apparentemente sono un frullato dada di scontrini, biglietti, numeri, titoli di giornali e altre diavolerie
ipnotiche con gli avvenimenti che hanno colpito il suo
personalissimo diario nel 2009: l'investitura di Barack
Obama, la morte di Michael Jackson ('The king of pop
is dead'), la morte della coreografa Pina Bausch e altre
notizie più o meno popolari.
L'intento ricorda in eco l'esperimento del nostro Lindo
Ferretti (nell'album Co.Dex) con Eraldo Bernocchi, ma
qui i tagli non ammiccano a nulla di ideologico o di storico, qui si esce direttamente dalla storia e con il solo
ausilio della voce e di pochi editing e sovrapposizioni
si crea un mostro sonico che per la sta bene in casa Ra33
ster Noton (dove aveva già collaborato con Alva Noto
nel 2008 in Unitxt), ma che fluisce degnamente anche
nella mente di qualsiasi post-raver in un trip apocalittico e straniante.
Il 'poeta sonoro' di Besançon non pensa al successo,
pensa a non dire nulla, quasi un ricordo del Godot di
Beckett. La promessa di 'non dire' e di trasformare le
tracce in un flusso technoide a bassa fedeltà che non
spieghi nulla della storia, rivelano però molto di più di
quello che un cantautorato di protesta o di testimonianza del presente potrebbe tentare di spiegare. La
voce dell'uomo (quest'anno sentita anche in due belle
collaborazioni con Andy Moor su Unsounds) è magnetica, e la serie di questi événements potrebbe essere ripetuta più spesso (il primo disco è del 99), per regalarci
altri attimi di estasi sonico-ritmica indimenticabili. (7.5/10)
Marco Braggion
Atomic Bitchwax - The Local Fuzz (Tee Pee,
Aprile 2011)
Genere: stoner-psych
Se siete orfani dei grandi riff che hanno caratterizzato
la storia del rock, avete trovato di che placare la vostra
sindrome d'abbandono. Si, perché l'unica traccia di
questo The Local Fuzz altro non è che un'incessante
serie di riff macinati a tutta velocità, uno dopo l'altro,
per 40 minuti ininterrotti.
A risaltare sopra a tutto è la bravura degli Atomic
Bitchwax: un'abilità tecnica indiscutibile e una capacità di mutare a proprio piacimento melodie e tempi
senza perdere mai le coordinate. I tre musicisti sono
in grado di creare un turbinio di hard rock, stoner, psichedelia, heavy metal, blues e passare con disinvoltura
disarmante dall'uno all'altro. Ciò che però in definitiva
ribolle in questo calderone è più un divertissement che
una pozione incendiaria. Un disco che fila via liscio e
godibile, cosa che nonostante la natura del lavoro, non
è così scontata, senza però risultare nulla di più che un
divertente esercizio di stile.
(6.3/10)
Francesco Asti
Babies (The) - The Babies (Shrimper, Aprile
2011)
Genere: garage lo-fi
Ne parlavamo in occasione di Share The Joy e ne abbiamo la conferma ora: le Vivian Girls, attuali e passate
che siano, hanno più progetti paralleli che full length.
Dopo Frankie Rose And The Outs dell’ex batterista
Frankie Rose e i La Sera della bassista Katy Goodman,
34
è ora la volta dei The Babies, terzetto che vede Cassie
Ramone affiancarsi a Kevin Morby (basso per i Woods)
e Justin Sullivan (alle pelli per i Bossy, progetto minore
condiviso proprio con la chitarrista).
The Babies, uscito col celebre marchio lo-fi americano
Shrimper e in concomitanza col nuovo lavoro della
casa madre, è il vero e proprio debutto dopo un paio
di cassette live e una manciata di 7” per etichette carbonare e non si discosta molto dalle lande usualmente
toccate dalla Viviana. Undici pezzi in mezzora scarsa
che in Voice Like Thunder, Meet Me In The City, Wild 2 e
Personality si muovono tra indie-rock dei primordi vigoroso, power-pop zuccheroso, psichedelia docile e
garage-rock in bassa fedeltà acceso e riottoso.
Godibilissimo e catchy ma in definitiva roba che, pur
evidenziando l’anima più aggressiva e rock del terzetto
newyorchese (la chitarra della Ramone) e le capacità
da frontman e compositore di Morby (non più solo un
comprimario), non dice nulla più del già noto.
(6.3/10)
Stefano Pifferi
Bass Drum Of Death - GB City (Fat Possum,
Aprile 2011)
Genere: Fuzz & noise
I Bass Drum Of Death sono due tangheri del Mississipi, proprio i due buzzurri che vedete ritratti in copertina avvolti da una nube di fumo. Non fanno stoner, ma
non di meno amano tormentare i propri strumenti (che
sono, appunto, chitarra e batteria) senza preoccuparsi
troppo: A) del volume a cui lo fanno B) della perizia tecnica che impiegano nel farlo.
Mai come in questo caso quello che conta è cacare
fuori dagli ampli il più selvaggio e purulento garage
punk. Chiamatela urgenza o fregola distruttiva, quel
che è certo è che nel loro caso si accompagna al gusto
di sminuzzare blues e mersey beat gettandoli nel tritatutto elettrico, in ponte immaginario fra le due sponde
dell'oceano che poi rappresenta la loro peculiare cifra
stilistica.
Mente (diciamo così) del progetto è John Barrett, quello spiritato sulla sinistra, ex impiegato alla Fat Possum,
che ha registrato l'album contando solo su un microfono USB. GB City è un disco che esprime tre o quattro
concetti in modo rozzo ma con una chiarezza che non
ha rivali, proprio quello che ci si potrebbe aspettare da
questi Jay e Silent Bob prestati alla musica.
Ecco allora che Nerve Jammin parte con un riff saturo
e arrembante che ricorda quello di New Rose dei Damned, prima di aprirsi in uno sgangherato coretto surf; la
titletrack invece è puro 60s beat incrociato con grezzo
highlight
Art Department - The Drawing Board (Crosstown Rebels, Aprile 2011)
Genere: deep house
I canadesi Kenny Glasgow e Jonny White (patron della label No. 19) all’esordio in combo dopo il singolo
bomba dello scorso anno Without You (qui incluso), tonnellate di progetti in solitaria e negli ultimi mesi
una batteria di serate in accoppiata vincente dietro la consolle.
Nel full length è inevitabile sentire tutta quell’influenza che Detroit ha portato e porta alle generazioni
di cool’ house che viaggiano sulla sottile e spesso tagliente lama del successo. Basslines gonfiate al
punto giusto, la voce imbronciata di Kenny che sa di club Novanta soul paradossalmente mescolata
con echi à la Ian Curtis, qualche appunto con bonghi e tribal che a qualcuno potrebbero anche far venire in mente il nostro beneamato Daniele Baldelli.
Pronti per partire con una lista della spesa da far gola ai più scafati producers: la lunghissima apertura
epic-detroit di Much Too Much, il già citato singolo con degli echi che ricordano le cupe vampe di Chelonis R. Jones tagliato con dei synth primordiali 70; i featuring da panico
di Osunlade e Soul Clap in We Call Love, e di Seth Troxler in Living The
Life e Vampire Nightclub (stupendo crescendo mistico e sensuale per Seth)
ci fanno capire che qualità di amicizie abbiano i due DJ di Toronto. Per
finire poi delle chicche che spiegano come sia difficile raggiungere una
coolness così misurata e al contempo piena di feeling: il ricordo Ottanta
depechemodiano in Roberts Cry e la chiusa I C U che guarda alle baleari
con tastierine solari.
Deep al massimo grado che smuove l’anima, il corpo e che conferisce un
senso al tracciato segnato dalla cricca del Marcy Hotel brooklyniano, aprendo a sonorità meno sperimentali, più squadrate ma non per questo meno profonde. Il soul di due personaggi che hanno aspettato troppo a mandare segnali di fumo al panorama house mondiale.
(7.4/10)
Marco Braggion
e sferragliante rock'n'roll. Di certo non fanno difetto nel
trovare la melodia azzeccata e ad avvolgerla costantemente in una fitta nube di fuzz, proprio come nei Kinks
scartavertrati di Young Pros, nella filastrocca '77 di High
School Roaches. Nelle lente e allucinate trame di Spare
Room e Leaves, emerge poi la loro anima detroitiana e
l'effetto delle droghe inizia sentirsi pesantemente.
E' con dischi come questo che la Fat Possum, dopo
excursus nel pop con gente come Smith Westerns e
Yuck, ritorna a giocare sul terreno che le è più congeniale: garage rock, blues e pattume assortito e che Dio
l'abbia in gloria per questo.
(7/10)
Diego Ballani
Battles (The) - Gloss Drop (Warp Records,
Maggio 2011)
Genere: Electro Math-Rock
Avevamo lasciato i Battles in un momento delicato: appena finito di raccogliere i frutti di Mirrored, ad oggi
una delle uscite più importanti degli anni 00, era arrivato come una doccia fredda l'annuncio della dipartita di quella che era considerata la mente del progetto,
Tyondai Braxton. Il tutto alle porte delle registrazioni
di Gloss Drop, che esce ora anticipato dal singolo Ice Cream con il feat. Matias Aguayo: mano sedata sul fronte
febbrile (Atlas, Tonto) e passo indietro verso strutture
tipicamente math.
Il valore aggiunto è l'approccio giocoso e divertito: pur
nel maggior rigore, tanto il suddetto singolo quanti altri
momenti nel disco manifestano un colore e una vitalità
che mancavano nel grigiore metropolitan-warpiano di
Mirrored, concedendosi a tratti svisate soundtrack (Africastle), dub (la Sundome con Yamantaka Eye dei Boredoms) e sul finale anche prog (White Electric); si prova,
in pratica, a mischiare le carte seguendo strutture più
rigide e cercando comunque di non perdere la propulsione tipicamente battlesiana (volgarmente rock).
Perso Tyondai, e quindi il lato melodicamente più schizzato del prisma, i Battles si trovano a riflettere nuova35
mente sul math e sulle traiettorie art-pop che proprio il
wiz kid aveva cercato d'introdurre nell'ultima fase della
line up originaria. Con i featuring la compensazione riesce soltanto a metà: aumentano le possibilità ma alla
base il gruppo si scopre monolitico e non altrettanto
capace di raggiungere una nuova e convincente cifra
stilistica.
L'effetto per certi versi è quello di un disco dei Chemical Brothers in salsa matematica. E Gloss Drop, passato
un primo deludente impatto, si rivela essere un buon
album di transizione.
(6.8/10)
Simone Madrau
Beastie Boys (The) - Hot Sauce Committee
Part Two (Capitol, Aprile 2011)
Genere: hip-hop
Tornano i ragazzi bestia con un degno seguito del precedente strumentale The Mix-Up (vincitore nel 2008 di
un Grammy come Best Pop Instrumental Album). Dopo
che Adam 'MCA' Yauch ha annunciato lo scorso luglio
di soffrire di un cancro, i fan del gruppo non aspettavano un'uscita così ravvicinata di questa fantomatica
'seconda parte', dato che la prima non è ancora stata
pubblicata (e forse non lo sarà mai). Invece eccoci qua
ad ascoltare l'ottava fatica del trio newyorchese.
In tre quarti d'ora e in sedici tracce viene delineato un
ritorno alle origini, a quegli anni '80 da cui il verbo del
white rap è germinato poi in tutto il mondo, a quel mix
di mainstream blaxploitation (Make Some Noise, Multilateral Nuclear Disarmament) che ha fatto la fortuna
della loro proposta musicale: una sensazione che avevamo già subodorato nel già citato disco strumentale,
in qualche canzone più introspettiva di To The 5 Boroughs e se proprio vogliamo anche in Paul's Boutique,
old-school anche quando non poteva -per definizione
- esserlo.
Anticipato sul loro canale youtube con un singolare
streaming integrale al Madison Square Garden (stadio
dei Knicks, squadra simbolo per molti rappers della
grande mela) e con un cortometraggio di mezz'ora
(Fight For Your Right Revisited), l'album amplifica, recupera e scherza parodisticamente sul sentimento di
nostalgia di quegli anni che ovviamente non ci sono
più, ma che per il trio americano col passare del tempo
diventano sempre più importanti. Pochi i featuring con
qualche leggera deviazione dal suono 'basic-Beastie' (il
rockettino Run-DMC di Too Many Rappers con Nas, già
nella Hot 100 di Billboard nel luglio 2009 e il bel reggae
con Santigold in Don't Play No Game That I Can't Win),
qualche effetto d'epoca (le voci robotiche in OK, gli
36
effetti lo-fi in Nonstop Disco Powerpack, gli slap robotici di Funky Donkey) e la solita eccellenza nel rhyming
confermano come i (non più) ragazzi siano ancora in
forma, anche se c'è un grosso ma.
L'operazione di looking back per le star mainstream
sembra attraversare infatti un periodo apicale: vedi ad
esempio i ritorni alle vecchie abitudini di R.E.M. e di
Foo Fighters (questi ultimi nel video di White Limo).
Un'estetica passatista che non sconvolge, non propone singoli memorabili, ma che conferma. All'orizzonte
non si vedono segnali di svolta, ma la calma piatta in
cui questo ed altri dischi prodotti da vecchi lupi possono farci crogiolare in momenti di apprezzabile e professionale divertimento. Per le rivoluzioni c'è (?) tempo.
(6.9/10)
Marco Braggion
Bon Homme - Bon Homme (Motor
Entertainment GmbH, Ottobre 2010)
Genere: electro pop
Tomas Høffding, cantante e bassista dei Who Made
Who, si presenta in veste solista sotto lo pseudonimo
Bon Homme, con una voglia matta di esprimere la propria individualità, ora finalmente libera dai compromessi della vita da band. Fiero narcisista, ama parlare
di sé e mostra una certa coscienza intellettuale nel fare
musica, collocandosi stilisticamente in un'ipotetica
squadra con Hot Chip e Kraftwerk. E soprattutto, tira
fuori una nettissima componente electro, il vero oggetto di repressione nel suo percorso di carriera.
Furbo, Bon Homme, concentra le mosse migliori alla
partenza: se tutto l'album seguisse la scia della coppia
d'apertura Ray Ban / The Battery Inside Your Arm, abili a
coniugare classic electronica d'essai e modernità vicine
a Junior Boys ed Alex Gopher, ci sarebbe da esaltarsi.
Nemmeno la successiva Mother delude, approcciando
il dance-pop con l'intenzione di sabotarlo. Non tutto
però ha quei livelli di personalità: a prevalere è perlopiù una nu-disco ad alto tasso glam, tra infatuazioni
vintage (gli Human League di Dare! in Heaviest Flower
Of Europe) e orientamenti pop non troppo messi a fuoco (Cards Of Love, Needle e quel caratteristico falsetto in
odore Scissor Sisters).
Il tentativo di volersi distinguere è chiaro, ma riesce
solo in parte. Il finale con Could Be Your Daughter, scartata dai Who Made Who durante le sessioni di registrazione di The Plot, rivela il fuoco di paglia. Attenti a non
illudervi.
(6.2/10)
Carlo Affatigato
highlight
Burial - Street Halo (Hyperdub Records, Aprile 2011)
Genere: tech-step
Più che andare da qualche parte, il suono Burial sembra forgiato per rimanere e impregnare le teste di
chi lo ascolta; come se “l’esiguità produttiva” del nostro volesse ricordarci l’effetto di una lenta somministrazione narcotica. Ogni release dopo Untrue è stata infatti dosata con il contagocce: una manciata
di singoli e remix uniti a preziose collaborazioni (Four Tet) che hanno alterato il modo stesso di percepire le evoluzioni del suono dell'uomo più oscuro del dubstep dal 2005 ad
oggi.
Street Halo mostra innanzitutto la lenta virata Techno di William Bevan; con
un andamento fin da subito meccanico e privo di fronzoli ritmici, la traccia
scivola su territori Basic Channel e pulsa d'ossessioni industrial tipicamente sheffieldiane (Cabaret Voltaire). NYC, al contrario, mostra il Burial più
classico, fatto di cazzeggio ritmico 2-step e morbidi pad suonati dentro
una grotta. Qui e là, gli immancabili pitch vocal dal sapor mediorientale
ribadiscono un continuum estetico tutto inglese fatto di esotismi e allucinogeni (Future Sound Of London e Banco De Gaia). Stolen Dog è il pezzo ibrido: cassa dritta di panna
e piccole sincopi, il tutto affogato in un tenue arpeggio di scuola Aphex Twin.
Non delude Burial e nell’attesa di un ipotetico seguito di Untrue possiamo di nuovo fermare il tempo
dentro questi nuovi abissi di suono.
(7.3/10)
Dario Moroldo
Box Codax - Hellabuster (Gomma, Maggio
2011)
Genere: Indie
Torna a far parlare di sé il progetto Box Codax, composto da Nick McCarthy, chitarrista dei Franz Ferdinand, la moglie Manuela Gernedel e il poeta tedesco
Alex Ragnew. Hellabuster arriva a 5 anni di distanza dal
primo Only An Orchard Away, un esordio controverso
che risaltava per le forti sperimentazioni tra electro e
lo-fi e nulla aveva a che vedere col sound della band
di Glasgow.
Il nuovo album sposta la faccenda su un piano diverso,
proponendosi come concept sulle vicende private di
un adolescente, tra patimenti d'amore, introspezioni e
strani incontri. Da un lato dunque i contenuti aumentano di spessore, mentre in parallelo si riduce l'audacia
del profilo compositivo. Le musiche diventano accompagnamenti ai temi esposti, con brani di sola voce e
chitarra country per i momenti più malinconici, alternati ad un art rock vivace per le fasi più movimentate.
Tanta carne al fuoco unita da un filo conduttore solo
concettuale, ma un risultato di ascolto a maglie troppo
larghe, che unisce sotto lo stesso tetto svago indie rock
(Hellabuster, I Won't Come Back), morbido cantautora-
to (Charade, Inanimate Inamorato) e teatralità à la Tom
Waits (My Room). Tutto di buona fattura, sia chiaro, ma
difficile da apprezzare come insieme: Hellabuster è la
colonna sonora di un film che non c'è, e l'assenza del
collante dà una netta sensazione di irrisolto. Bravo regista cercasi.
(5.9/10)
Carlo Affatigato
Boy George - Ordinary Alien (Decode,
Gennaio 2011)
Genere: house
Il 30 aprile del 2012 Boy George ha promesso di riunire
i Culture Club, nel trentennale dall'esordio del gruppo
con il singolo White Boy. Prima di rispolverare la memoria di quel mito pop Ottanta, il mutaforme vede bene
di tornare su disco, proponendo una raccolta di tracce
risalenti allo scorso decennio che erano stato abbozzate e mai finite, oggi mixate e prodotte dall'amico e
collaboratore Kinky Roland - come è ben riportato dal
sottotitolo: The Kinky Roland Files.
Il lavoro attraversa un sentire pseudobalearico, con altalenante positività negli arrangiamenti e nella voce
dello stesso George. Tra le tracce che spiccano c'è
37
l'omaggio a Barack Obama (Yes We Can è un singolo
dance pop che va via leggero nella miglior tradizione
pop UK), la mid-trance Novanta di Amazing Grace e il
ricordo Ottanta in Time Machine. Nostalgie a parte, il
disco scivola in seguito su una facile commerciabilità
che distanzia il potenziale dell'ex Karma Chameleon
dal buon risultato, sicuramente ottenibile.
Un ritorno che non stupisce, confermando la presenza
di un drago del suono pop di sempre declinato in centinaia di compilation, feste, remix, sballi, storie d'amore
e lacrime. Attendiamo che trovi un manager in grado
di fare emergere ancora una volta il suo stile, intriso
di soul e coolness (Mark Ronson,ce la puoi fare). Alla
prossima, George.
(6/10)
Marco Braggion
Britney Spears - Femme Fatale (Sony BMG
Music Entertainment, Marzo 2011)
Genere: vocoder pop
Settima pallottola della Spears. La reginetta (?) del pop
torna in pista con una cosa che farà gola ai remixatori
più smaliziati (le tracce sicuramente andranno in mano
a gente che comanda gli stadi, sia per quella che una
volta chiamavamo 'commerciale' oggi capitanata dalla Swedish House Mafia, sia per gli amici no problemo
Crookers).
Il disco ci va di autotune, vocoder, bassi ultrafidgettati
e la solita vocina che ormai potrebbe anche venir fuori direttamente dallo speaker del portatile in quanto a
inventiva e complessità. La Spears punta ovviamente
al suo avatar, la femme fatale che non è (e probabilmente non sarà mai, cioè Madonna). Britney è ancorata ovviamente ai produttori, che in fondo qui non
fanno nemmeno una brutta figura. Max Martin e Dr.
Luke (Backstreet Boys, *NSYNC, Robyn, Katy Perry e altri) manovrano a loro piacimento il manichino, che ha
già sbancato in America. Supersuccesso mondiale e sicuramente per mesi in classifica.
L'ennesima dimostrazione del superpotere dei produttori. Le tracce si fanno ballare, ma Britney non è più il
personaggio di qualche tempo fa. Oggi lo stile-al-passo-coi-tempi pop è tutto per Lady Gaga. Una bomba
solo per i fan. Per gli altri è già musica-da-autoscontri.
(5/10)
Marco Braggion
Carpacho! - La futura classe dirigente
(Pippolamusic, Aprile 2011)
Genere: indie, italiana
Se siete amanti del pop, nella sua accezione più equi38
librata e colorata, di certo nel 2007 vi eravate un po'
innamorati del lavoro di questi ragazzi romani, i Carpacho!, che esplodevano nel piccolo mondo indie italiano con La fuga dei cervelli. Si trattava di un disco
autoprodotto eppure curatissimo, nei testi come nel
sound: ironia, gusto, melodie scattanti e irresistibili,
parole taglienti e acute. Da allora i Carpacho! sono un
po' spariti dalla circolazione fatta eccezione per un EP,
L'oracolo e il fardello (2009) che contiene quella che
probabilmente è la loro canzone più riuscita: Il reale
mi dà l'asma, mix dei Baustelle di una volta e intuizioni
d'armonie lunari eccellenti.
Esce oggi, per Pippola music - sempre capace di scegliersi artisti che le donano - La futura classe dirigente.
Fughe dei cervelli e future classi dirigenti, formule descrittive comunemente usate e abusate stanno qua a
designare il tentativo d'analisi sociopop costante nel
lavoro della band. A questo giro però, occorre dirlo, siamo un po' sottotono e dopo svariati ascolti non è più
possibile nascondersi dietro la scusa delle aspettative
che erano certamente piuttosto alte.
Un lavoro che non svetta mai, un sound tendente alla
reiterazione della stessa formula melodica, quella in
cui i Carpacho! sono in effetti fortissimi. Non basta, e
si sente: brani che si rincorrono gli uni con gli altri in
una costante ripetizione piuttosto stancante e senza
particolari guizzi, nulla di più di quanto avevamo già
ascoltato, con anzi un po' di problemi nei testi.
Una cosa però va sottolineata: i Carpacho! stanno tra
quella band italiane che scontano paradossalmente in
termini di popolarità una capacità di costruire brani impeccabili dal punto di vista della forma canzone, della
forma canzone pop. Insieme ai Numero 6 vanno annoverati tra quegli artisti per niente maudit con la volontà, anzi, di portare discorsi sociali e intimi quotidiani
senza scontatezze in canzoni dove la melodia impera
su tutto, seduce. Spiccano qua, in questi termini, brani
come Niente che non va, Assassino seriale sensibile e La
classe diligente, con consueti inserti elettronici, coretti,
Baustelle imperanti nelle ritmiche. Senza infamia e senza lode, insomma, consci del fatto che qua di capacità
ce ne sarebbero molte.
(6.7/10)
Giulia Cavaliere
Christian Prommer/Alexander Barck Alex And The Grizzly (Derwin Recordings,
Aprile 2011)
Genere: nu-jazz, techno
Che dall'incontro in studio di Christian Prommer e
Alexander Barck potesse nascere qualcosa di impor-
tante non v'erano dubbi. Il primo è l'autore delle acclamate Drumlessons, nonché protagonista lungo i due
decenni passati dei progetti Fauna Flash, Trüby Trio,
Voom:Voom e, più in generale, uno dei produttori più
influenti del panorama elettronico odierno. Il secondo
è fondatore del collettivo Jazzanova, nome imprescindibile del nu-jazz di oggi.
I due guardano con affetto a quella glacialità scandinava anni '90 che, filtrando la chill-out di Orb e KLF con le
lezioni Warp IDM, fece da culla per la successiva generazione Röyksopp. Una nostalgia che si rivela in brani
come Picture Of The Sea, che poteva benissimo stare in
Melody A.M., o Soweto Symphony in odore di Björk, ma
anche in Submarine Bells, attraverso i ritmi da 'liquid
music' dell'ultimo Caribou. Nello stesso tempo, però, è
messa in gioco una netta attenzione verso forme dancey d'annata: se Journey riprende la house classica con
inserti ambient e jazz, le Roland di The Barking Grizzle
provengono invece dalla classic techno europea ed
Everything, col suo incedere vellutato, nasconde comunque una natalità eurodance.
Chill-ambient svagata e dance liberatoria, due dimensioni che si incrociano con grande naturalezza, tra
i versi dei gabbiani e il calore da spiaggia balearica: i
due la chiamano "earthboogie dance", come a voler
sottolineare la voglia di ripristinare un legame con la
natura, reso per certi versi anche dai diffusi inserimenti
tribal (la danza propiziatoria di Dr. Jekyll And Mr. Hyde).
Alex And The Grizzly è un disco costruito sapientemente intorno all'ascoltatore moderno, che risponde alle
sue esigenze di evasione e riconciliazione col mondo.
Tenere da parte per i propositi di fuga dal mondo occidentale.
(7.1/10)
Carlo Affatigato
Circle - Infektio (Conspiracy Records,
Aprile 2011)
Genere: psych-jazz-metal
Sin troppo facile perdersi nella sterminata discografia
del collettivo finlandese Circle. Infektio - pur considerando soltanto album originali e live - dovrebbe essere
grossomodo il full length numero 30 o giù di lì e mostra
i finnici sempre più in palla, persi nel proprio mondo
sonoro.
Rispetto alle svisate hard&heavy di cui vanno fieri a tal
punto da autodefinirsi “kings of the NWOFHM” (New
Wave Of Finnish Heavy Metal, no?) e con cui si fecero
notare agli albori della propria carriera, da molti album a questa parte i Circle prediligono forme ibride
e percorsi magari meno rumorosi ma sicuramente più
sconnessi ed interessanti. Ecco così che Infektio si prefigura come un disco corposo e sfaccettato, ma in cui
il potenziale del sestetto si offre in versione più free,
con contaminazioni jazzy, prog, addirittura afro-beat,
che unite all’incedere psych-rock liberano i finnici da
schemi e recinti.
La musica acquisisce pertanto un respiro più ampio e
libero, permettendo ai Circle di spaziare in un sentire
musicale se non originale, per lo meno personale, fatto di rielaborazioni e commistioni altamente suggestive. Pisara, dall’incedere ipnotico e orientaleggiante, la
psichedelia jazzy di Saarnaaja, il mega-trip Salvos - 15
minuti di bassi pulsanti e iridescenze post-kosmische dicono di una band persa completamente nel suo trip
ma sempre totalmente godibile e allucinatoria.
(7/10)
Stefano Pifferi
Cornershop - Cornershop & The Double
O’ Groove Of (Ample Play, Aprile 2011)
Genere: interracial pop
E’ sempre difficile ricreare la magia. Il problema è che
certi dischi riescono a cogliere il significato e lo spirito
di un’epoca perché se ne fanno attraversare, poi li plasmano in un duplice atto di comunicazione. Al settimo
album in carriera, Tjinder Singh e Ben Ayres provano
a invertire la rotta guardando ai fulgidi Woman’s Gotta Have It e When I Was Born For The 7th Time, però in
modo che sia l’India a permearsi di sonorità occidentali
e non viceversa. Ce n’era bisogno? Fossero riusciti a dar
corpo a una bella idea di cortocircuito culturale senza
incappare in lungaggini e in una scrittura spesso senza
guizzi, senz’altro sì.
Va infatti benissimo consegnare il microfono alla cantante Bubbly Kaur e rifarsi alla storia della black per gli
arrangiamenti, ma - poiché è un piano “pop” quello in
cui ci si muove - occorrono canzoni che rimangano.
Magari non delle novelle Brimful Of Asha, ma certo è
che la trainante United Provinces Of India, l’ipnotica dolcezza di Topknot e il frizzante errebì tra Style Council e
Pizzicato Five The Biro Pen un po’ si perdono tra troppa dignitosa monotonia e qualche scivolone kitsch (il
fondo lo tocca il terrificante clavicembalo barocco di
Double Decker Eyelashes). Più dell’occasione mancata,
ne deriva un impantanarsi a metà strada che, date le
premesse, comunque dispiace.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
39
Current 93 - HoneySuckle AEons (Coptic
Cat, Marzo 2011)
Genere: gothic folk
Aver a che fare con i Current 93, anche solo per lo spazio di una recensione, non è mai facile. Troppo il carisma di un personaggio come David Tibet per non lasciarsi sempre e comunque ammaliare, troppa l'attesa
del nutrito nugolo di adepti al culto della sua personalissima chiesa, troppo - va sempre sottolineato - anche
il talento per riuscire agilmente a imbrigliarlo in poche
righe. Rispetto a episodi recenti che hanno fatto rialzare le sue quotazioni, come quando nel 2006 riuniva
una pletora di amici e collaboratori per l'ottimo Black
Ships Ate The Sky, qui il cantante e compositore inglese ha lavorato per sintesi, riducendo a poco più di
mezz'ora la durata del disco e concentrando nell'aspetto gotico la vena creativa che pervade le sue ballate.
Non hanno perso un grammo di forza la sua dizione
ieratica e il canto evocativo, e l'atmosfera è cupa, cupissima, come già la copertina fa capire, con quelle idee di
croce in campo nero. Il legame con il folk qui è sottolineato dalla presenza di Lisa Pizzighella alla marimba e
da Eliot Bates all'oud e al bendir, mentre il theremin affidato Armen Ra non fa che moltiplicare i fantasmi che
popolano il mondo sonoro che Mr. Tibet ha generato
per questo disco. Oramai il sound dei Current 93, come
quello di un progetto per certi versi parallelo come
i Death In June, è oramai simile solamente a se stesso, quasi che Tibet, da buon compratore e venditore di
anime morte, stia sardonicamente facendo mercimonio del suo brand.
Questo non toglie assolutamente nulla a HoneySuckle AEons, che nonostante sia da inserire tra le opere
minori è pur sempre un disco che mostra la stoffa di chi
lo ha composto. Si potrebbe dire 'solo per completisti',
salvo poi accorgersi che all'ennesimo ascolto la schiena viene ancora trapassata da un brivido. (6.8/10)
Marco Boscolo
Da Hand In The Middle - Shiver Animals
Sensations (Autoprodotto, Aprile 2011)
Genere: blues rock
Un fantasma si aggira nelle dimenticate campagne del
Belpaese, tra fragranze ed olezzi, nel dimenticato incontro tra il compiersi del ciclo naturale ed il lavoro (la
vita) degli uomini. E' un fantasma turbolento e vivace,
un burlone col ghigno storto e lo sguardo acidulo. Che
ama impossessarsi ad esempio dei Da Hand In The
Middle, sei mattacchioni da Montecchio (provincia di
Terni) con l'aria da performer che amano mimetizzare
40
il talento dietro l'estro buffonesco. Forse perché hanno
capito che la scena è lo spazio della creazione, e perciò
se l'apparecchiano allestendo teatrini balzani e facinorosi come dei Moby Grape tarantolati (Sweet Oven),
inventandosi un immaginario da giullari elettrificati,
spiriti agresti che sferzano l'indole fricchettona che alberga in ognuno (di loro, di noi).
Provate ad immaginarvi un Jon Spencer colto da raptus rurale (Bake Him A Cake), paludato di vampe di ottoni e gracidii d'organo, una convulsione blues per ogni
raglio d'asino, visioni lancinanti e afrore di granaio,
capace altresì di misurarsi con rumbe sardoniche (Joe
Flies To El Limon) armato di campanacci e vecchi trattori.
La mascherata è waitsiana e dylaniana finché i demoni
sono quelli colti al crocicchio blues (Where's My Fuckin'
Mule?), però altrove diventa mistero indolente Howe
Gelb mischiato di fiabesca ebbrezza Panda Bear (The
Redeemer), anche se dell'attuale freak folk giocano più
che altro a sembrare i garruli antenati, mirando semmai a cogliere il fiore della sagace follia Country Joe
And The Fish (Take Another Poor Gun) battuta ove occorre da garrule brezze swing (Sandy Room).
Hanno abbastanza padronanza della materia da suonare come minimo divertenti. Se vorranno e sapranno
affondare il coltello nella piaga, capacissimi di fare il
botto.
(7.2/10)
highlight
Cyclo - ID (Raster Noton DE, Marzo 2011)
Genere: glitch
Germania e Giappone. Motorico e precisione, macchina e origami. Presenza e assenza. Ryoji Ikeda e
Carsten Nicolai nuovamente in combinata doppia per il bis del progetto Cyclo.: con l'omonima uscita
del 2001 sdoganarono la glitch music al nuovo secolo, alleggerendone l’estetica con linguaggi più accessibili, che sbirciavano per qualche lungo istante alla techno.
ID è un progetto visuale che - come il precedente - converte in suono gli
input video dei due guru della sperimentazione cerebral-noise: cose che
avevamo già visto fare nei live dei Pan Sonic e che oggi ritornano con una
forza proiettata in futuri da costruire, magari per dire qualcosa che vada
oltre la diaspora -step.
Nell'attesa dell’imminente uscita visual (annunciata dalla Raster Noton),
l'album parte dal suono e da lì esplode in una potenza che divora i confini
del noise con i bassi di Ikeda (id#00) in dialogo con i rimasugli apocalitticodigitali (id#01) di Alva Noto. Oltre ai trip sperimentali (id#02), il disco scivola verso inquadrature di più
facile messa a fuoco, che permettono di fruire il lavoro anche da un pubblico (osiamo!) clubbistico,
tanto che proprio in questi giorni viene discusso su forum di sopravvissuti alle tonnellate di MDMA
degli anni Novanta (fate un giro ad esempio su We are the music makers per sondare la temperatura
della faccenda). Chi ama gli Autechre e le visioni più acide di Aphex Twin, potrà trovare qui un degno
compagno di viaggio verso il prossimo rave (id#03, id#06 addirittura in sentore progressivo).
La spocchia della cosiddetta ricerca si applica sul campo e il risultato fa intravedere una nuova via che
amplifica la fruibilità del mix di suoni ad un primo ascolto ostici o per lo meno alieni da qualsiasi tipo di
ripetitività, abilmente sottaciuta dal duo, ma in ultima analisi presente e oltremodo fondante. Un testo
di looppismo spinto su cui meditare a lungo.
(7.6/10)
Marco Braggion
Stefano Solventi
Daniele Silvestri - S.C.O.T.C.H. (Sony BMG
Music Entertainment, Marzo 2011)
Genere: italiana, pop
Daniele Silvestri ci aveva lasciato nel 2007 con Il latitante, album decisamente fuori forma, lavoro eterogeneo nel peggior senso del termine: incompiuto e, un
po' come da titolo, latitante di contenuti. Il ritorno del
cantautore romano era atteso da molti, curiosi soprattutto di capire se quel disco così poco riuscito fosse
l'inizio della fine di una brillante carriera o solo un episodio morto e da dimenticare.
S.C.O.T.C.H., uscito per Sony il 29 marzo scorso, non
lascia dubbi: Silvestri è tornato in grande forma e ci regala uno dei momenti più brillanti della suo percorso
artistico. Un album nato in poco tempo, da un'evidente
esigenza di scrittura che lo rende ispirato e in grado di
riallacciarsi ad alcuni canoni propri del suo autore pur
slanciandosi, al tempo stesso, verso orizzonti fortemente contemporanei.
Una storia d'amore finita non per tuo volere e un Paese sull'orlo del precipizio che sembra impossibile far
tornare a splendere, queste le due facce del tema por-
tante dell'LP, a riconferma di una passione per la narrazione parallela dell'intimo e del sociale che da sempre
ha accompagnato Silvestri nella stesura dei suoi testi:
Io e il Paese ma anche Io e te, Io e tutti gli altri Io. Emblematico e stupendo, in questo senso, il brano composto
e realizzato a quattro mani - e due voci - con Niccolò
Fabi, Sornione, nel quale si evidenziano le impossibilità
d'affermazione della verità, quasi che questa venga rifiutata in ogni sua forma, dal legame tra amici o amanti
a quello tra Stato e cittadino. L'impossibilità del dolore, la falsità dilagante a partire da tutti i "come stai?"
pronunciati nelle nostre giornate e tutte quelle altre
domande che implicitamente non aspettano risposte
oneste e chiarificatrici, domande come quelle che avvolgono il caso Borsellino e che Silvestri mette superbamente in ska ne L'appello, citando non a caso Una
storia disonesta di Stefano Rosso.
Se pezzi come Precario il mondo, Questo paese, Monito(r)
sono esplicite sottolineature della nostra condizione
politica e sociale, di contro Le navi, la caposseliana In
un'ora soltanto e una bellissima ghost track, sono spazi personali, struggenti di intimità che vuole tornare
anch'essa a respirare bene e per farlo cerca ostinatamente un'ultima possibilità di cambiamento. Il cambiamento è infatti, in tutto e per tutto, l'altro tema intorno al quale l'album ruota, l'acqua che stagna/l'acqua
che scorre e un singolo, Ma che discorsi, che si incentra
tutto sul gusto di svoltare l'angolo per gustarsi, chissà,
un'imprevista sorpresa.
S.C.O.T.C.H. è un lavoro spiccatamente annodato ai
riferimenti sonori che Silvestri ha sempre riproposto,
dalla ballata a quel sound mediterraneo e radicalmente sudamericano che sta nel suo immaginario artistico
fin dagli inizi. Ospiti d'eccezione Andrea Camilleri e
Gino Paoli, il primo in una lettura il secondo in una rilettura de La gatta che per l'occasione diventa La chatta, prestandosi ai consueti giochi di parola e di senso
che già Silvestri ci propose in passato - si veda 1000
euro al mese in Unò-duè.
Menzione speciale va a una cover assolutamente riu41
scita di Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber. Verrebbe da consigliare di dimenticarsi de Il latitante, di
saltarlo a piè pari per ritrovarlo qua, in forma compiuta,
risultato maturo di un cantautore italiano dallo spessore ancora sottovalutato da troppi.
(7.3/10)
Giulia Cavaliere
Dark Dark Dark - Wild Go (Melodic UK,
Marzo 2011)
Genere: chamber folk
Come già testimoniavano l'esordio del 2008, The Snow
Magic, e il valido EP Bright Bright Bright (qui aggiungo come secondo dischetto per chi se lo fosse perso),
il sound degli americani Dark Dark Dark assomiglia
a una costellazione di molti astri, ma dei quali il centro è un vuoto, come se il focus della ricerca musicale
dei due membri fondatori Nona Marie Invie e Marshall
LaCount non fosse nelle singole parti, ma nei sottili
rapporti che tra essi si vengono a creare. Tra le stelle
di questo Wild Go, allora, ritroviamo tanto le musiche
dell'est Europa, il jazz di New Orleans, il folk da camera
e il minimalismo. Non v'è dubbio che sia spesso l'intensa e profonda voce della Invie, vicina per certi versi a
quella di Fiona Apple, a creare da sola l'atmosfera rarefatta delle composizioni.
Ecco allora l'organetto di Celebrate a creare un cortocircuito tra le praterie americane e la steppa ucraina, e
che si fa ballabile marcetta punteggiata dai fiati; il pianoforte estremamente europeo di Nobody Knows che si
declina in un intreccio vocale che fa tanto Fleet Foxes.
Le cose vanno un po' meno bene quando il microfono
principale passa a LaCount, sebbene Right Path abbia
un'atmosfera haunting che sembra la colonna sonora
di Lemony Snicket. Il ragazzo, di sicuro, funziona come
paroliere, soprattutto quando nella titletrack mette in
bocca alla sodale un'utopico ritorno ai nativi dell'isola
di Manhattan, comperata dai colonizzatori olandesi a
prezzo della libertà di una nazione. A chi sostiene che le canzoni di Wild Go tendano a sfumare l'una nell'altra, senza quasi soluzione di continuità, forse bisognerebbe far notare che potrebbe essere
una scelta deliberata, di una soundtrack che cambia di
sfumature, ma che sempre la stessa vita è chiamata a
commentare. Certo, ci sono alti momenti di pop, come
il singolo Daydreamer, e altri invece che non convincono. Ma anche le vite hanno i loro periodi no?
(7/10)
Marco Boscolo
42
Davila 666 - Tan Bajo (In The Red Records,
Aprile 2011)
Genere: garage-rock ispanico
Brujerìa e spesse catene al collo, camicie sgargianti e
dollari insanguinati, droghe e cattivo gusto a go-go.
C’è tutto l’immaginario ispanico più trito e guasto nel
garage-pop del sestetto portoricano, sia a livello estetico che di immagine. Per quel che riguarda i gusti musicali invece, i finti fratelli Davila si muovono sulla falsariga dell’esordio omonimo di un paio di anni fa.
Con una mezcla di Stones meno bolliti e Jesus And
Mary Chain più corposi e feedback oriented (il riff iniziale di Si Me Vez è preso pari pari dall’esordio dei fratelli Reid), garage-rock d’ovvia matrice In The Red meets
Nuggets e vocalità sixties come ormai sembra essere
d’ordinanza per certi suoni, i sei dimostrano di saper
masticare referenti e riferimenti ad uso e consumo delle nuove generazioni di lo-fi addicted. Rispetto al citato Davila 666, però, la carica strumentale sembra più
pacata, le atmosfere leggermente più oscure (ma forse
è solo una questione di produzione) e i suoni più adagiati sul trend psych-sixties rock tanto di moda ultimamente. Cosa che sinceramente fa un po’ rimpiangere
l’esordio, più genuino e raw rispetto a questo pur buon
esempio di garage/lo-fi for dummies.
(6.4/10)
Stefano Pifferi
Delicate Steve - Wondervisions (Luaka
Bop, Aprile 2011)
Genere: modern freak
Quando dici famolo strano, è a gente come Steve Marion che pensi. Nel senso che il ventitreenne chitarrista
del New Jersey vanta l’amicizia dei Dirty Projectors e
l’aver supportato gli Yeasayer dal vivo, ma soprattutto
simpatia e visionarietà in dosi non comuni. Dovrebbe
tuttavia sforzarsi di capire cosa vuole per davvero: se
tediare con pippe cosmiche e inutili siparietti rumoristi; oppure approfondire compositivamente una “follia
con metodo” che, in un contesto privo di cantato, offre
l’interessante The Ballad Of Speck And Pebble (qualcuno dirà Vampire Weekend: in realtà è - ma guarda che
caso
- il Paul Simon di Graceland a spasso con gli Xtc
più bucolici), una Sugar Splash di simile e più contorta
vena e apprezzabili bozzetti d’elettronica agreste - tra
Brian Eno e Cluster - come Z Expression e Flyin’ High.
Altrove Steve pasticcia fondendo low-fi e math rock e
traccheggia con l’acustica: conseguenza ne è il rifugiarsi dentro una title-track sardonica e riassuntiva. Dal
quale riemerge con la slanciata ironia di Don’t Get Stuck,
così che i conti non tornano. Forse è solo questione di
maturazione, e magari due chiacchiere col padrone di
casa David Byrne potrebbero essergli d’aiuto.
(6.2/10)
Giancarlo Turra
Donkeys (The) - Born With Stripes (Dead
Oceans, Aprile 2011)
Genere: SoCal pop
Le strisce del titolo non sono - ovviamente - quelle
della bandiera americana, ma quelle che decorano la
pelle della psichedelica rana ritratta in copertina. Cover
e provenienza geografica (San Diego) e sappiamo già
che tipo di sound incontreremo infilato il cd nel lettore:
southern California sound e reminiscenze Sixties dal
vago profumo psych.
Rispetto al precedente Living On The Other Side del
2008, qui ci sono meno Byrds e Grateful Dead, meno
chitarre twang. Chissà che l'accoglienza così e così di
quel disco non sia stata la molla che ha fatto scattare nei Donkeys la voglia di costruire una via che porti
all'estetica slacker. I Pavement, i titolari assoluti dell'etichetta slacker, sono un riferimento ma qui c'è meno
rock in senso stretto e si strizza di più l'occhiolino a ritornelli facil-pop che ricordano il college rock più pigro piuttosto che il melting pot musicale di Beck, al
quale i Donkeys vorrebbero aspirare.
Si prenda il midtempo I Like The Way You Walk. Il giro di
chitarra è You Get What You Give dei New Radicals suonato al 40% della velocità e il cantato pop-rock da classifica tardi Novanta. Nelle atmosfere Seventies di Ceiling Tan si nota il sound di Living On The Other Side, e il
compitino calligrafico si sgama per quello che è, con
il missaggio del Pernice Brothers Tom Monahan a
non convincere appieno, per non parlare del tentativo
di contaminazione percussioni etno e synth Eighties
di Oxblood che è semplicemente pacchiano.
Malkmus e soci possono dormire sonni tranquilli: il loro
primato slacker non è in discussione (e pure il Beck
di Mutations può lasciare tranquillamente riposare il
proprio spettro a Tijuana).
(5.5/10)
Marco Boscolo
Elisa Luu - IPO // 24 (Ipologica, Gennaio
2011)
Genere: ambient electronica
Elisa Luu torna sullo stesso luogo dopo un anno esatto
dalla svolta electro. Un altro EP su Ipologica per ribadire la sua presenza nell'arena electro-ambient italiana.
Tre pezzi che confermano il suo savoir faire in ambito
sintetico: Rode 3 è un crescendo che accumula echi del
miglior Four Tet tagliati con ecumenismi pop-nordici
degli anni zero, Docile Ostinatezza ripassa il bbreaking
di scuola Ninja tagliando tutto con una chitarra in assolo svisato e straniante, mescolando opzioni già usate in
casa Broadcast, 15-4 ricalca l'epopea trip-hop puntando su modulazioni avant che arricchiscono la palette
e la voglia di sentire un lavoro più lungo. Elisa, ora ci
vuole il full-length.
(6.8/10)
Marco Braggion
Encode - Core (Ghost Records, Aprile 2011)
Genere: post wave
Tempi lunghi per i varesini Encode, che non solo fanno
passare otto anni per dare un seguito a Singing Trough The Telescope (senza contare l'ep My Shadow Is
Taller Than Me del 2006), ma sembrano meditare la
loro proposta in una dimensione rallentata, indifferente al frenetico avvicendarsi degli stili che rende obsoleta oggi l'eccitazione di ieri. Dal post-rock con venature
dark e psych dell'esordio non si registrano clamorosi
spostamenti, ma un aggiustare il registro dell'inquietudine su frequenze vagamente etichettabili "emo", lemma di per sé abbastanza insulso per non dire equivoco,
soprattutto se ci si prende la libertà di accoppiarlo ad
un titolo allusivo come Core. Nulla o poco a che fare
infatti con le scorribande modello Fugazi o Hüsker
Dü, semmai nel ventaglio di fragranze esalate da queste nove tracce capita di avvertire molecole brumose
For Carnation, inquietudini narcotizzate Red House
Painters, afflizioni wave-industrial Depeche Mode e
nevrosi sintetiche dEUS.
Però non prendetele come coordinate attendibili, perché a dire il vero mancano appigli forti, è più un aggirarsi senza navigatore dove porta l'estro di una scrittura
priva di particolari colpi di genio ma sufficientemente
densa e intensa. Ne risulta un disco più che dignitoso, il
classico sophomore che "conferma la bravura", lasciandoti però con la sensazione che un po' di coraggio sia
rimasto in canna. Un lavoro più composto che appassionato, più di consolidamento che d'assalto, in ultima
analisi piacevolmente interlocutorio: non proprio quel
che ci si attende da una rock band che molto ancora
deve dimostrare. Ok, nessun problema, però che peccato: l'irrequietezza androide di Ausfhart, le invenzioni
soniche di Reset e il morbido turbamento di My Season
Will Still Suck dimostrano che le potenzialità ci sono.
Buone basi da cui spiccare, ci auguriamo, un balzo più
deciso.
(6.2/10)
Stefano Solventi
43
highlight
EMA - Past Life Martyred Saints (Souterrain Transmissions, Maggio 2011)
Genere: spectral-folk
Past Life Martyred Saints comincia col consueto countdown rock ma, sottoposto com’è ad un trattamento al ralenti quasi fosse sotto metadone, da la misura dell’universo dispiegato da Erika M. Anderson per questo suo esordio ufficiale. Un universo sfatto, umorale, struggente e a tratti dolorosamente
disperato, esattamente come quello inscenato in una purtroppo breve parentesi dai Gowns, di cui la
Anderson era mezzo cuore pulsante e dal quale, volenti o nolenti, essendo
stato quello una concomitanza di amore e musica, prende le mosse questo suo ritorno.
Quello a nome EMA è un disco meno arty e più intimista, personale e sofferto (si ascoltino attentamente i testi al proposito) rispetto alla breve e
acclamata epopea di coppia, ma fa brillare l’astro della sua autrice nel firmamento delle migliori chanteuse underground di sempre. Disillusione e
disperazione, aggressività e furore, distorsioni e chitarra acustica, strutture
rock che spaziano dal grunge alle efferatezze da riot grrls passando per
struggenti a-cappella (Coda) e ballate voce e chitarra da pelle d’oca (Breakfast), unite ad un senso di
malinconia e un mood darkish che veleggiano sul tutto, fanno di Past Life Martyred Saints uno degli
esordi dell’anno. La biondina del South Dakota ha bene in mente cosa fare e come farlo, riattivando il
filo rosso che da Nico arriva a Cat Power, passando per Liz Phair e Elizabeth Frazer, lambendo l’aggressività di Carla Bozulich e le melodrammatiche aperture della nostra Nada in un unico pezzo (Red Star).
Sì, perché EMA ha anche il grosso pregio di sapersi diversificare, cambiando pelle come un camaleonte
da pezzo a pezzo; essendo al tempo stesso cantautrice folkish e rocker di prim’ordine, ragazzina riottosa e dark-lady emozionale, sperimentatrice dissonante e melodica ammaliatrice, spesso e volentieri
in un unico pezzo. Si prenda ad esempio l’opener The Grey Ship: metà soffice nenia acoustic-rock, metà
disperata e ossessiva marcia per animi infranti. Non poco per una che a malapena arriva ai 24 anni e che
solo un anno fa era sul punto di abbandonare la musica e tornare a casa dei genitori.
(7.7/10)
Stefano Pifferi
Explosions in the Sky - Take Care, Take
Care, Take Care, (Bella Union, Aprile 2011)
Genere: post-rock
Per descrivere questo Take Care, Take Care, Take Care si
potrebbero tranquillamente prendere le parole spese
da Solventi per Hardcore Will Never Die, But You Will dei
Mogwai tanto è palese il percorso parallelo del quartetto texano con gli ormai bolliti scozzesi. Oppure riproporsi i dubbi e le perplessità usate ormai quattro anni
fa per All Of A Sudden, I Miss Everyone, visto che nulla
sembra essere cambiato. Di nuovo in pieno post-rock
chitarristico, di quello epico, con pezzi incredibilmente
lunghi (6 pezzi per 50 minuti) e reiterati in dicotomica
prospettiva pieno/vuoto, atmosfere drammatizzate al
servizio degli indie-kids più sensibili, qualche accensione ritmica che mantiene ogni tot minuti desta l’attenzione e dozzinale romanticismo melodrammatico
come se piovesse.
44
A differenza dei Mogwai però qui non c’è nessun tentativo di uscire dall’impasse di un genere che, codificato a tal punto qual è ora, non rischia più nemmeno di
sembrare reazionario. Lo è, punto e basta. Agli Explosions In The Sky però sembra interessare poco la diatribe critica sul senso del post-rock. Vanno ormai per la
loro strada e i fan sembrano dar loro ragione. Noi decisamente meno.
(4.5/10)
Stefano Pifferi
Fabio Orsi - Stand Before Me, Oh My Soul
(Preservation, Aprile 2011)
Genere: avant-rock/drone
Fabio Orsi ha saputo crearsi un territorio dai contorni
ben definiti ma dall'orografia tutt'altro che uniforme. Il
suo habitat sonoro ha permesso di intravedere all'orizzonte alcune piste meno battute a cui, vista la vitalità
con ha girovagato e con cui continua a girovagare, sarebbe prima o poi giunto.
Stand Before Me, Oh My Soul abbandona le atmosfere
elettroacustiche che hanno caratterizzato la produzione solista del tarantino per deviare verso un approccio più rock. A dare il tono dell'album sono, infatti, la
chitarra - che Orsi questa volta mette in primo piano
rispetto ai field recordings e alle tastiere - e il supporto
della batteria di Rich Baker.
Ne esce un lavoro in grado di muoversi su più piani:
passando per il rock in stasi di Naked Trance e la psichedelia spacey di Papa, Show Me Your Blues LPs, attraverso il trip krauto My Awesome Drugs Propaganda e
l'ambient al rumor bianco di Please Could You Hide That
Ghost, per far ritorno, infine, ai territori più conosciuti
di Soon, I'll Be At Home. Un lavoro che riconferma il dinamismo di Fabio Orsi e la sua volontà di rimanere in
movimento, contro qualunque staticità. Confermando,
insomma, la bontà della sua produzione.
(7/10)
Francesco Asti
Feelies (The) - Here Before (Bar None,
Aprile 2011)
Genere: pop rock
Altra carrozza da aggiungere al treno delle reunion:
tornano i The Feelies, a più di vent'anni dal loro ultimo disco e a più di trenta dall'imprescindibile Crazy
Rhythms, pilastro della new wave in salsa pop. Ora,
nonostante una buona dose di curiosità, le aspettative che questo genere di operazioni portano con sè
sono già più o meno calibrate, e si riducono nell'auspicio di un buon ascolto, con brani in grado di reggere
il confronto dei vecchi fasti, e poco altro. Il che è esattamente quello che troverete in questo Here Before,
un disco pop-rock fedele al marchio Feelies, e che anzi
ne rappresenta una piccola antologia. C'è la sezione ritmica uptempo, i brani giocati su pochi riff e brevi assoli
di chitarra, i coretti melodici in background come nel
caso della title track.
Nel complesso si accentua la passione per il pop, con la
chitarra acustica che trova più spazio e strappa applausi nella pregevole Blue Skies, che pare venir fuori direttamente dalla penna degli Yo La Tengo, o in Morning
Comes, ballata dal gusto 90ties sul sentiero dei migliori
Gomez. Il resto dell'album (dal gusto più ottantottino)
serve a ribadire l'ottima capacità di scrittura dell'accoppiata Mercer-Million, che riesce a rinverdire lo spirito
punk-wave degli esordi (Time Is Right), a interpretare
con successo i binari power pop (Again Today), e a concedersi anche alla passione per i Velvet (On And On). Un
disco che si insinua a tinte chiare e carico di un' aura
positiva, rappresentando un più che gradito ritorno;
certo è un po' monocorde e non riserva sorprese, ma
d'altronde non è qui che bisogna cercare la luna.
(6.8/10)
Stefano Gaz
Feeling Of Love (The) - Dissolve Me (Born
Bad, Aprile 2011)
Genere: Psych Garage
Terzo album per i weird-punks più amati di Francia,
secondi per fama solo ai parigini Cheveu. Se Ok Judge
Revival aveva imposto una nuova sonorità a forte tinte
Velvet Underground, Dissolve Me continua sulle medesime coordinate, ammorbidendo forse la tensione
dei brani della precedente raccolta.
Massici dosaggi di garage-rock imbevuto di psichedelia
sixties e ciclicità kraut, in cui alle pesanti influenze del
già citato gruppo di Reed/Cale (Cellophane Face, I Am
The Road) si aggiungono spunti à la Neu!/Spacemen
3 (le conclusive Numboy e White Smoke Rising), senza
che venga meno quella freneticità stramboide che è
poi il vero marchio di fabbrica del trio di Metz (la titletrack, Funk Police e I Am Right You Are Wrong). E tra una
cavalcata elettrificata dal fuzz e una ballata sbilenca c’è
anche tempo per una bella cover di Serge Gainsbourg (Là-bas C'est Naturel), da sempre nume tutelare della
band, in cui i Feeling Of Love sembrano giocare con
gli umori hypna-tropicali tanto in voga di questi tempi.
E proprio questo sembra essere il messaggio di Dissolve Me: mentre il sotto-mondo out va dietro alle sempre più cangianti sensazioni del momento, i ragazzi di
Francia tirano dritto per la loro strada confezionando
un disco in perfetto equilibrio tra tributo alle glorie
passate e ricerca di un sound che sia al contempo classico e personale.
(7.2/10)
Andrea Napoli
Filo Q - Il bordo del Buio (Micropop, Aprile
2011)
Genere: italiana, acustica
Filo Q è Filippo Quaglia, genovese, da sempre diviso
tra acustico, elettronico, brani da remixare e progetti
massonici londinesi. Una figura eclettica con alle spalle
collaborazioni con Numero 6, Casino Royale, Almamegretta, Meganoidi, Perturbazione, Ex-Otago e
oggi i nuovi Magellano. Il terzo album, Il bordo del buio pubblicato con Micropop dopo Le proprietà elastiche del vetro (registrato e mixato da Paolo Benvegnù nel 2007), è un
45
highlight
Foo Fighters - Wasting Light (RCA, Aprile
2011)
Genere: Heavy Rock
Gablé - Cute Horse Cut (LoAF, Aprile 2011)
Genere: Art-Pop
Con Cute Horse Cut i francesi Gablè si giocano la carta dell'espansione oltre i propri confini e la bella
notizia è che hanno i numeri per farcela, seppure all'interno della loro nicchia. Per chiarire di cosa si
tratta bisognerebbe tirare in ballo etichette come art-pop o avant-pop, ma è un peccato circoscrivere
quando si ha a che fare un gruppo dall'approccio così estremamente libero, informale e divertito. Per giunta il presente lavoro, già il terzo, condensa
in una quarantina di minuti la bellezza di venti brani: un minutaggio da
disco punk per un'attitudine tutto sommato similare, evidenziata anche da
testi come: 'I know a trick, all you need is a brick and a window: throw the
brick through the open window and let it land on my hand', cui seguono
dei soddisfatti: 'I love broken fingers, let's do it again'. La canzone si chiama Brick Trick ed è il biglietto da visita collocato a tre minuti dall'avvio del
disco, tanto per mettere in chiaro come eclettismo e pazzia vadano di pari
passo in questo progetto.
Suona facile il paragone con i campioni del momento, The Chap, o anche con i classici Stereolab nei
momenti di relativo intimismo, ma qui tutto è portato a livelli di schizofrenia più elevati e lo spettro di
influenze contemplato si direbbe, se possibile, ancora più ampio: sospensioni elettroniche e microbeats di eredità Morr Music (Cyanure e Bunch), gospel ridicoli (Haunted), finti tropicalismi che sfociano
in irruenti crescendo di chitarra elettrica (Ouac); e ancora: folktronica esangue (Ghost Host, quasi un
singolo), incisi vocali al limite del naif (in Day il titolo del brano viene declamato insistentemente tra i
denti a simulare un riff di chitarra), campionamenti di posate che sfregano (Eezy Peezy), tutta una serie
di trovate tecnicamente ridicole ma del tutto efficaci.
L'album gira così veloce e concentra così tante cose diverse all'interno di ogni traccia da rendere quasi
impercettibili le distinzioni tra queste ultime: è difficile trovare quindi melodie incisive, ma pure sarebbe sciocco cercarne; piuttosto è apprezzabile il modo in cui tutto questo frenetico ed esuberante
sfoggio di capacità riesca a suonare coerente. L'impressione è che il gruppo sia riuscito nell'impresa, se
non di fare un vero passo avanti nell'ambito di questo non-genere, quantomeno di fornirne un'interpretazione suggestiva e unica, al punto da imporsi come possibile nome di riferimento. Va da sè che chi
intende il pop come canzoni strofa-ritornello farà bene a tenersi alla larga, ma per tutti gli altri qui c'è
una delle cose più fresche e bizzarre successe alla musica di inizio decennio.
(7.5/10)
Simone Madrau
lavoro ricco di sonorità, quasi tutte acustiche seppur
filtrate, talvolta, dall'uso del campionatore. Un disco
musicalmente piuttosto maturo, saldamente aggrappato alla tradizione cantautorale italiana, con qualche
momento altamente contemporaneo in uno dei brani
migliori del disco, La memoria, dove si sente piuttosto
marcata l'influenza di Vasco Brondi a far da contraltare
alla delicatezza vocale vicina a quella del primo Francesco De Gregori, presente in tutto l'album.
Un album dalla struttura classica che però pecca nei
testi, decisamente non al livello dei suoni. Lo scarto tra
le due componenti è netto ma Filo Q fa del buon cantautorato pop, vicino per certi aspetti a quello di due
46
amici che militano in veste di chitarristi nel disco: Roberto Angelini e Giuliano Dottori. Menzione speciale
per Rendermi presentale che svetta, in chiusura, sull'omogeneità dell'album con l'inconsuetudine di una melodia perfetta, malinconica e davvero ben riuscita. C'è
un po' del Niccolò Fabi che fu in questo lavoro che ci
auguriamo essere il principio di una maturazione ancora più completa.
(6.5/10)
Giulia Cavaliere
E' sempre increscioso recensire l'album di una band
che reputi estremamente sopravvalutata. Soprattutto
se si tratta di un lavoro che tutti, tranne te, sembrano
attendere con impazienza.
Magari è colpa del sottoscritto, che non si è mai lasciato blandire da quel post grunge annacquato, tagliato
su misura per Mtv, con cui Dave Grohl ha dissipato il
credito accumulato in anni di militanza con Scream e
Nirvana. Ma tant'è, le strade artistiche di Mr. Grohl, se
non infinite si sono certamente disperse in molteplici
rivoli.
A tre anni e mezzo dall'ultimo Echoes, Silence, Patience & Grace, il nuovo Wasting Light, registrato
interamente in analogico nel garage del buon Dave,
promette un rilancio in grande stile per la band, grazie
a connubi artistici nuovi (Bob Mould) e ad altri antichi
e rodatissimi (Butch Vig, Pat Smear e Krist Novoselic).
Pertanto non mi resta che pormi diligentemente all'ascolto.
Si parte con una Bridge Burning tesa e affilata come
una pugnalata al petto. Appartiene a quel rock totale,
squadrato e finemente prodotto, perfezionato Queens
Of The Stone Age, esperienza che non ha mancato di
lasciare il segno sul patrimonio artistico del baffuto
leader. Stessa cosa può dirsi della seconda e già nota
Rope, la quale può vantare un groove deciso e qualche
boccaccia metal in più.
Dal progetto Probot all'apparizione in Tenacious D And
The Pick Of Destiny, sono anni che Grohl non manca di
ricordarci la sua antica infatuazione per il metal degli
80s. Ecco allora che traccia dopo traccia, la chiave di
lettura dell'album diventa sempre più chiara. Wasting
Light è la logica conseguenza dei Probot.
Raggiunti gli "anta", forte di un successo che il giovane
batterista degli Scream non avrebbe mai neanche potuto auspicare, Grohl si abbandona alle passioni di una
vita, dimostrando finalmente di infischiarsene di vendite e passaggi televisivi (che comunque arriveranno).
Spaziando attraverso tutte le fogge del rock più duro
ed anthemco a cavallo fra 70-80, l'album suona vario,
compatto e per nulla scontato, soprattutto se paragonato alle produzioni odierne. Così White Limo ha la foga
trita ossa dei thrash della Bay Area. Dear Rosemary ha la
melodia e la potenza un pò sguaiata delle migliori hair
metal band. Ma soprattutto, in brani come Miss The Misery e Arlandria, c'è la vena innodica e quella produzione luminosa del class rock firmato Desmond Child.
Curiosamente tutte cose che i Nirvana, con i quattro
minuti e mezzo di Smells Like Teen Spirits, avevano reso
di colpo obsolete. Vent'anni dopo, un Grohl finalmente
pacificato, sembra dirci che forse abbiamo sbagliato a
buttare il bambino con l'acqua sporca.
(6.7/10)
Diego Ballani
Forty Winks - Bow wow (Unhip Records,
Marzo 2011)
Genere: Power pop
A sei anni dal precedente e omonimo album, ecco il
lavoro che porta a compimento la maturazione della
band emiliana, tanto che in Bow Wow non c'è quasi
più traccia del pop punk degli esordi. I Forty Winks del
2011 prendono il meglio del moderno rock a stelle e
strisce e lo fanno flirtare con coloratissime melodie di
stampo britannico.
Bow Wow è un disco squisitamente power pop: termine logoro che nel loro caso si usa senza temere alcuna
improprietà di linguaggio. Come definire altrimenti curiosi ed avvincenti ibridi di rock stralunato come Mannequins (i Foo Fighters finiti come per incanto nella
Swinging London) e Beneth Her Feet (i Supergrass andati a lezione da Josh Homme)?
Se Way Out ha un tiro prepotente, nel più canonico stile Queens Of The Stone Age (ma con un inserti elettronici dai colori vivaci e cangianti), Meet You At The
Bar ha come termine di paragone il brit pop riletto dai
'mmeregani' di un gruppo come gli OkGo.
Difficile scegliere il brano migliore di album così ricco,
tuttavia vale la pena segnalare la bella I Feel Dead, un
patchwork sixties dai cori irresistibili, tiro garage e una
coda che ricorda i Beatles psichedelici di I Want You
(She's So Heavy).
One Last Round, infine, tira fuori i fiati ed un incedere
Northern Soul che la dice lunga su come alla band le
definizioni vadano ormai strette. I Forty Winks sono ormai un gruppo pop tout court e vista la concretezza e
la freschezza di questo nuovo lavoro, non c'è che da
rallegrarsene.
(7/10)
Diego Ballani
Friendly Fires - Pala (XL, Maggio 2011)
Genere: post-nu-rave
Secondo album per il trio formato da Edward Gibson,
Edward Macfarlane e Jack Savidge. Dopo l'omonimo
debutto del 2008, la band ha continuato a crescere e a
partecipare a progetti che hanno contribuito a portare
avanti il verbo nu-rave anche dopo lo scioglimento degli LCD Soundsystem e la decadenza di Rapture & Co.
47
Registrato fra uno studio della campagna francese (ma
quanto va di moda oggi?), la cintura urbana londinese
e New York, il disco è co-prodotto da Paul Epworth, il
produttore inglese che ha lavorato fra gli altri con Adele, Florence And The Machine, Bloc Party, Primal
Scream e, guardacaso, Rapture. Anche se influenzate
dalla mano del pluripremiato smanettone di consolle, le tracce cercano di smarcarsi dagli stereotipi delle
band con l'articolo 'The' davanti al nome e si ritagliano una cantabilità pop che fa l'occhiolino ai Cut Copy
(Running Away), riprende riff dei Daft Punk (l'incipit
di Blue Cassette è la riscrittura velocizzata di One More
Time, i filtri di Hurting sono old-school french touch
anche se c'è di mezzo l'Harlem Gospel Choir), e inevitabilmente ricalca la lezione dei maestri newyorchesi
aggiungedo echi '80 (Running Away e True Love con il
featuring di Alex Frankel degli Holy Ghost!).
Il risultato non è però così scontato e banale, dato che
si aggiunge varietà smarcandosi su territori tropicalsincopati à la Paul Simon (Pull Me Back To Earth), soul
sdolcinati-loungey (nella titletrack), funkettini sciccosi
(Helpless) e in generale su una coesione che si toglie
di dosso l'aura malinconica del rock dela grande mela
post-9/11, per tuffarsi in una coloratissima e a tratti
spensierata passeggiata pop. L'invocazione del romanzo utopico di Aldous Huxley del 1962 (Pala è il nome
dell'isola di Island, appunto) ci fa sperare in una maturità in arrivo. Per ora ci sono ancora troppi elementi di
plagio e di nostalgia dei primi anni zero che rendono il
disco nient'altro che un buon passatempo.
(6.6/10)
Marco Braggion
Frivolous - Meteorology (Cadenza
Records, Febbraio 2011)
Genere: deep, tech-house
Tornano ad evolversi le invenzioni visionarie di Daniel
Gardner, in arte Frivolous, il produttore canadese ormai da anni residente a Berlino. Rispetto al precedente
Midnight Black Indulgence l'orizzonte si allarga ulteriormente, ciò è frutto delle circostanze nelle quali nasce
il nuovo album: un periodo di isolamento sia artistico
che personale, durato alcuni mesi, in un'isoletta nell'oceano Pacifico.
L'eclettismo per cui Gardner è noto non tradisce nemmeno stavolta. Meteorology riflette a tratti le atmosfere
tropicali da cui proviene, e la cosa non si evidenzia solo
nella scelta di certe sonorità tribali in brani come One
Final Solstice, ma soprattutto in una generale ricchezza melodica solitamente estranea alla tech-house, con
pezzi come Serenade Des Excentriques e Wasting Time a
48
rendere l'ascolto più caldo e arioso. Il temporaneo allontanamento dalla scena berlinese si traduce in una
migliore messa a fuoco del background musicale che gli
appartiene: l'album ha uno spiccato carattere dancey,
sul quale si sviluppano iniziative ambient prossime a
John Roberts (Allen Town Jail), vivacità funky che strizzano l'occhio al fermento UK (Red Tide), corde dal sapore
orientale (Back Into The Deep) e addirittura passi di valzer
trasformati in groove da club (Cinemascopique).
Nelle architetture di Frivolous protagoniste son sempre le sfumature, e Meteorology non fa eccezione: le
partenze lente sapientemente studiate per creare attesa, i bassi avvolgenti che danno il tempo, gli abili incastri con la cassa in quattro, son tutte espressioni del suo
personalissimo stile, che dà vita a creature sempre più
indefinite. Originale lo è sempre stato, stavolta è anche
lunatico e inquieto. Ma non azzardatevi a fermarlo.
(7.3/10)
Carlo Affatigato
Gang Gang Dance - Eye Contact (4AD,
Maggio 2011)
Genere: tribal dance
Davvero poco da dire sul percorso artistico dei Gang
Gang Dance. Gente che si è reinventata ad ogni disco
con una verve creativa che sa di sperimentazione molto più di qualunque nerd ripiegato sugli effetti. Considerato il fondamentale turning point del precedente
Saint Dymphna i newyorkesi erano attesi al varco del
quinto disco per testimoniarne lo status di culto. Il passaggio a 4AD aiuta non tanto in quella direzione, quanto sotto il lato distributivo e del marketing, perché di
fatto vendere questi GGD qui diventa una questione
sostanzialmente diversa da quella che si poteva dare
anche solo con l’ultimo lavoro (i precedenti sono davvero tutta un’altra faccenda
).
Il cambio di pelle cominciato con l’ep RAWWAR e proseguito con Saint Dymphna si completa definitivamente con Eye Contact che si incarica di inquadrare la
band newyorkese sotto una lente che piega le venature psych e dub degli esordi sotto una spessa nervatura
fatta di umori etno, venature world, con il piglio dance
mai così pronunciato, finendo col diventare una sorta
di strana fusione kitch tra M.I.A. e le vecchie suggestioni etno di gente come Loop Guru e Transglobal
Underground. Effetto finale? Un maelstrom stordente
e ridondante, eccessivo e ricolmo di cattivo gusto anni
’80 che a sentire il primo singolo Mindkilla, i Crystal Castels in confronto sembrano i profeti della nuova era.
Il martorio costante a base di synth e ritmica sostenuta
impasta tutto il disco in una sorta di continuum da cui
diventa difficile estrapolare singoli momenti cardine.
Saint Dymphna ragionava maggiormente sui brani, qui
tutto tende alla contemplazione dell’affresco nella sua
interezza. I momenti migliori sono quelli dove ancora dimostrano di saper disegnare jam psichedeliche potenti
e visionarie: Glass Jar e Adult Goth. Ma non tutto sul disco
viaggia su questi livelli. Su Chinese High ascoltiamo Lizzi
Bougatsos che si trasforma in una sorta di strano ibrido
tra Natacha Atlas e Shakira e forse è meglio stendere
un velo pietoso sui goffi tentativi soul di Romance Layers.
Suggestive le ipotesi di etnica garbage e postmoderna
di Thru And Thru con il refrain new wave ad innestarsi
sulla base mediorientale, come se i Depeche Mode di
Violator fossero cresciuti a Damasco o in qualche sperduto villaggio siriano. Certo, con i GGD non ci si annoia
mai, ma stavolta l’impressione è che abbiano esagerato
e il risultato è un disco molto più caotico e meno a fuoco
del precedente che già faceva della sua non risolutezza
la sua ragion d’essere.
(6.5/10)
Antonello Comunale
Gangpol & Mit - The 1000 Softcore Tourist
People Club (Ipecac Recordings, Marzo
2011)
Genere: 8bit pop
Gangpol & Mit sono Sylvain Quément e Guillaume Castagnè, duo musicale/grafico nato a Bordeaux a metà
degli anni zero che approda ora su Ipecac con questo
The 1000 Softcore Tourist People Club, vale a dire 14 tracce
8bit-pop un po' weird, un po' naif impregnate in un'estetica da cartone animato nello stile di un Amiga o un
Atari. Nella sostanza i nostri cercano di trovare una via a
metà strada tra le pazzie di Mike Patton (The 1000 People Band (Part 1)), il barocchismo di Momus (The Enemy I
Never Met), e l'austerità degli Yello (The Softcore Tourist). Come dire, il problema qui non è tanto la sintesi degli elementi, perché il lavoro ha tutto sommato una fisionomia omogenea, quanto più semplicemente che
il disco è scialbo. Il giocattolino pop made in Japan di
Otsuki Sama non graffia, From Your House To The Universe è una siglettina cartoon che senza controparte
visuale risulta un nonsense, ed anche le schegge sonore di trenta secondi come The Burial e Skillful Fingers
sembrano più riempitivi che espressione di stile. Qualche buono spunto, la dance di The Softcore People Club
e l'orientaleggiante downtempo di Browse At Night, rimane troppo annacquato per giustificare qualcosa che
vada oltre il semplice ascolto.
(5.5/10)
Stefano Gaz
Gavin Friday - Catholic (Rubyworks,
Maggio 2011)
Genere: wave pop
Sedici anni ci ha messo Gavin Friday per dare un seguito all'opera terza da solista Shag Tobacco. Non che
l'ex-leader dei Virgin Prunes sia stato nel frattempo
con le mani in mano: ha infatti architettato spettacoli
teatrali e composto colonne sonore (per Jim Sheridan
e Neil Jordan tra gli altri), prestandosi ogni tanto anche
alla recitazione. Quindi, bontà sua, ha sentito il bisogno
di tornare all'antico amore propinandoci un album tutto intero, il qui presente Catholic. Ovvero una dimostrazione del proverbio che la classe non è acqua, ok,
però si può annacquare eccome.
Prodotte da Ken Thomas (già al lavoro con Cocteau
Twins e Sigur Ros), le undici tracce in programma
costituiscono cinquanta minuti abbondanti di pelosa
melensaggine decadente. Tema portante il crepuscolo
della vita e una riflessione spirituale sul "dopo", argomento che accettiamo ben volentieri se ad affrontarlo è uno dei fautori del cosiddetto goth-rock. Peccato
però che venga ricondotto a forme appiccicosette da
nostalgico dei Roxy Music (con risultati accettabili in
Able, discreti nella vagamente lennoniana It’s All Ahead Of You, pessimi in quella The Only One che semmai
rimanda a certe ignominie Cock Robin), bazzicando
al bisogno kitsch vaporoso (come nella sfacciatamente sigurossiana Lord I'm Coming o in A Song That Hurts,
ove sfoggia un falsetto à la Bono tra evanescenze sintetiche come bignami Ultravox-Brian Eno) e croonerismo torbido (i Lambchop narcotizzati Cousteau nel
folk jazzy di Blame, la caricatura Depeche Mode-Scott
Walker di Where’d Ya Go? Gone).
Melodicamente insulso, interpretato con vellutata rigidità, sorretto da un'idea sonora da ex wave-rockers
convertito alla pantofola, è un disco da brividi. Ma perlopiù di raccapriccio.
(4.7/10)
Stefano Solventi
Gentlemen's Agreement (The) - Carcarà
(Materia Principale, Marzo 2011)
Genere: tropical fusion
Se è vero che la premessa di ogni buon disco è un luogo
emotivo in cui accadere, lo spazio definito da Carcarà
- secondo lavoro lungo per i The Gentlemen's Agreement - fa anche di più: apparecchia una dimensione
in cui perdersi, esotismo magico che polverizza le coordinate terrene, cuce i balcani coi tropici, scompiglia
e mescola resine mediterranee, brume jazzy e aromi
tex-mex. Già amato oltralpe, il quintetto partenopeo
49
allarga quindi considerevolmente lo spettro sonoro
rispetto all'esordio Let Me Be A Child conducendo l'ascoltatore in un viaggio fiabesco attraverso le peripezie
d'un ragazzo vittima di pene amorose, alla cui consolazione provvedono i pesci del mare, impetositi dai suoi
lamenti. Il mare diventa così un vasto, accogliente, immaginifico ventre nel quale immergersi per assorbirne
la mutevole fluidità e rinascere rinnovati nello sguardo
e nel cuore.
Mille le fragranze come i timbri dei molti strumenti, armamentario acustico ubriacante per orditi multicefali
come potrebbero tramarli dei mariachi cresciuti tra le
ombre ed il sole del Vesuvio, dei gitani alle prese con
miraggi morriconiani (Mama Oceano), dei sambeiri
scissi tra estro Bacharach (The Path Of Life) e fregole
swing. Colto il fiore del tropicalismo, spesa la doverosa devozione a Caetano Veloso (e alla di lui sorella
Maria Bethania), il quid poetico di questa band si distingue per l'entusiastico sincretismo, il festoso frugale
caleidoscopio di segni, sogni e culture. Alla cui riuscita
contribuiscono il senso teatrale (non a caso il tour diverrà uno spettacolo vero e proprio) e la voce solista
(di Raffaele Giglio) lirica e acidula come un Devendra
Banhart meno fricchettone che solare.
(7.4/10)
Stefano Solventi
HatchbacK - Zeus & Apollo (Lo Recordings,
Marzo 2011)
Genere: new age / cosmica
Sam Grawe è affezionatissimo al suono cosmico che
guarda alla new age. Non essendone un agiografo,
però, non fa troppa distinzione tra le eccellenze (Popol
Vuh ricorsi ma classicamente mai raggiunti in Orinoco
Waltz) e gli ascolti evitabili.
Dimenticata la fase deep house e pure quella spacedisco, il progetto Hatchback, di cui è titolare, alla seconda uscita per Lo, sceglie di fare una lunga dedica
all’ambient acquatico che evita picchi emotivi e in definitiva anche la qualità creativa. La differenza tra l’esserci e il farci, specie per il sound delle lande dei mondi
e dello spirito, non è da poco. C’è chi non ama la new
age, ma nessuno può evitare di accettare il percorso
che il genere ha proposto, le strade che ha aperto. Una
strada ha però una carreggiata e un limite, per quanto
possa essere disegnato o sfaccettato.
Gli ambienti rilassati di Zeus & Apollo soffrono come
un libro che non si fa leggere dopo l’exergo. Detto in
altro modo, il problema sopraggiunge nelle intersezioni che musica come quella prodotta da Hatchback
incrocia. L’easy-listening è sempre dietro l’angolo (già
50
nella title-track), la muzak sotto, e anche attorno, a creare una bolla d’aria che abbassa la capacità del nostro
orecchio di concentrarsi ed effettuare uno spostamento cognitivo. E l’iperuranio si allontana.
(5.5/10)
Gaspare Caliri
Holly Golightly - No Help Coming
(Transdreamer, Aprile 2011)
Genere: americana
Difficile che la dolce Holly possa avvicinarsi ai livelli di
Billy Childish dal punto di vista quantitativo. Nel senso
che questa londinese trapiantata in Georgia, è giunta
alla trentina di uscite in un paio di decenni: bazzecole,
se prendiamo come metro l’iperattivo Billy col quale
ha più di un punto di contatto. Non è dei dischi usciti
in coppia che parliamo, né della militanza della stessa nelle Headcoatees. La questione ha a che vedere
con affinità elettive, con la pervicace riscrittura di canoni di rock n’ roll e folk, di country e blues con piglio
vigoroso e mano sicura, ma con meno garage e low-fi
per il progetto Brokeoffs in combutta con l’americano
Lawyer Dave a chitarra, batteria e voce.
La “solita” ricetta, insomma, devota a un approccio
asciutto alle radici e ispirata a Wanda Jackson e Johnny Cash, nondimeno sapendo bene che nel frattempo
sono passati Violent Femmes (che la title-track immagina alle prese con una novella Folsom Prison Blues e
Burn Oh Junk Pile, Burn associa a Tom Waits) e White
Stripes (più che altrove nel tormentato soul-blues The
Rest Of Your Life). Gusti ruvidi, genuini e duraturi se chi
li propone ha i mezzi per consegnarne un’idea credibile, alternando una frase sguaiata (Get Out My House)
con una riflessione (la splendida River Of Tears, una traslucidaThe Whole Day Long) e mettendoci sempre tutta
l’anima e il cuore, la classe e il feeling possibili. Oltre
ai brani succitati, li certificano belle riletture di uno ieri
oscuro - l’attitudine, mutatis mutandis, ricorda i Cramps - come un’accorata Lord Knows We’re Drinking, l’errebì anni ’50 Here Lies My Love e il country n’ roll L.S.D.
Made A Wreck Of Me. Americana, che per la quarta volta
di fila, associa tradizione e personalità in un vigoroso
paradosso.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Horrible Present - Endless Summer /
Winter Shows Up (Autoprodotto, Marzo
2011)
Genere: electro-shoegaze
highlight
Grouper - A | A - Alien Observer / Dream Loss (yellowelectric, Aprile 2011)
Genere: dream drone
Liz Harris, Grouper, è già da tempo oggetto di culto per le aste di ebay dove i suoi dischi in vinile finiscono sempre per essere battuti a cifre irragionevoli e si può stare certi che lo stesso avverrà con le poche
copie esistenti del doppio vinile A | A. Due dischi singoli, Alien Observer e Dream Loss, riuniti sotto
un’unica etichetta tanto metaforica quanto sostanziale.
Si era già visto con l’ultimo split con Roy Montgomery quanto la scrittura
della musicista di Portland si fosse raffinata con il tempo. A | A per compiutezza e disegno generale è destinato a fare da capo d’opera per la sua
autrice, dribblando abilmente la pericolosa risacca del post - Dragging A
Dead Deer Up A Hill, il disco che nel 2003 le diede più visibilità forte di un
songwriting più pulito e una distribuzione firmata Type.
Oggi, tutto torna in autonomia. Produzione autarchica e distribuzione fai
da te (con l’aiuto di Mississippi Records che vale come minimo a garanzia
di qualità
) sono gli architravi per un doppio sogno sonoro che sulle prime
annichilisce per l’integralismo e la coloritura monocromatica, e ai passaggi successivi tende ad accogliere sempre di più in un caldo intimo abbraccio. A | A salta di netto il profilo pop folk di Dragging A
Dead Deer Up A Hill, facendo da trait d’union tra le ultime composizioni apparse sull’ultimo ep Vessel
e dischi precedenti come Wide e Cover The Windows And The Walls, probabilmente i suoi lavori più
enigmatici e fascinosi.
Dei due, Alien Observer contiene le tracce più recenti. La title track è tra le cose più vicine a David Lynch
apparse di recente, ma è lo stile stesso di Grouper ad andare verso quella direzione: nebbia brumosa
di feedback, canto lunare e ultraterreno, malinconia oltre il livello di guardia. In heaven everything is
fine. L’ostinato profilo lo-fi che pure fa storcere qualche integralista del microfono buono non fa altro
che aggiungere fascino ad una musica che se prima era soprattutto scenografia e (r)umore, ore è anche
architettura e forma. L’iniziale Moon is Sharp potrebbe essere tranquillamente un brano dei Cocteau
Twins di mezzo, se non fosse per la polvere nebulosa della chitarra effettata e per gli eco riverberati
fino all’eccesso. Che il taglio generale dell’operazione sia quello dell’ultima figlia dello shoegaze è quasi
ovvio. Se l’idea dei My Bloody Valentine, di abbozzare delle canzoni e ricrearle nel missaggio sfasato
delle tracce ha dato vita ad una folla di scialbi imitatori, Liz Harris dimostra di aver appreso la lezione
con una maestria tutta sua. Arrivano da qui brani come Vapor Trails e She Loves Me That Way, sempre sul
punto di sfaldarsi in un non meglio definito noise di sottofondo. Come dire che lo status di bozza può
diventare un regno di possibilità espressive.
Dream Loss contiene le tracce più datate. L’atmosfera del primo disco, già sospesa e rarefatta, subisce
qui un ulteriore regressione verso l’onirismo e l’oblio. Dragging the streets, nella sua diafana psichedelia
liturgica è a due passi dai This Mortal Coil di It’ll Ends In Tears e c’è qualcosa di profondamente piacevole nel modo in cui il brano si stempera nella distorsione di I Saw A Ray e ci troviamo di colpo in territori drogati alla Flying Saucers Attack. Per non dire delle successive e impenetrabili No Other e Wind
Return, degradate nella forma dal missaggio e irrefrenabili nella loro malinconia folk che sembra di
ascoltare un nastro di Sibille Bayer sopravvissuto all’ultima delle catastrofi. E infine il canto della Harris, costantemente ottenebrato da qualche intervento tecnico, sia esso un riverbero, una doppia voce,
una distorsione, eppure immediatamente riconoscibile nella sua eco triste. Un trademark non da poco.
Grouper, in fase di press release, ha tenuto a dire che sottili e sotterranee correnti tramano da un disco
all’altro, finendo di fatto per identificarli come unità, sebbene siano godibili anche presi singolarmente.
Di sicuro un doppio del genere farà la gioia degli estimatori dell’epoca dream pop / shoegaze o dei
“nostalgici” della prima Kranky e dell’altra Bristol, anche se forte com’è di un songwriting di altissimo
livello è destinato a raccogliere consensi un po’ ovunque.
(7.7/10)
Antonello Comunale
L'impressione è che Horrible Present sia un po' la zona
51
franca del The Calorifer Is Very Hot - ora solo Calorifero, come da nuova ragione sociale - Nicola Donà.
Un playground in cui ampliare le fascinazioni lo-fi che
da sempre animano il progetto condiviso con Nazareno Realdini e Samuele Palazzi verso scenari meno
battuti e forse anche più avventurosi. Come dimostra
l'elettro-wave della title track o lo shoegaze in sbornia
Spacemen 3 di Floating Mess, primi passi di un trip
volenteroso ma per ora ancora controllato (Later On e
Those Days Those places non sono poi così distanti dalla
produzione del Calorifero) che ha soprattutto lo scopo
di ragionare sui suoni, provandone di nuovi. Senza la
responsabilità di una band sulle spalle a frenare le irrequietezze creative e col timone ben puntato verso un
mood più scuro ma nient'affatto radicale.
Cambi di atmosfera, intuizioni solitarie, convivenze
possibili ma non definitive: quelle che una Everything's
Already Done analizza appiccicandosi a un pop psichedelico che flirta con l'elettronica o una Primordial Noise
avvicina a certe cadenze dei Deerhunter. Un bighellonare consapevole e basato sull’istinto che porta il padrone di casa a mescolare coolness e vecchie abitudini
in un disco intrigante e in download gratuito all'indirizzo http://soundcloud.com/horrible-present.
(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Ibrido_XN - Non ingerire (Black Fading /
Action Directe, Dicembre 2010)
Genere: dark-wave
Considerare ibrido o meltin' pot (come da note stampa) un disco che si rifà semplicemente alla new wave e
al dark aggiungendo qualche solida base elettronica, ci
sembra una forzatura: sono almeno quindici anni che
escono produzioni sul genere e questa non ci pare più
borderline o sperimentale di altre. E infatti a curare il
suono degli Ibrido_XN non viene chiamata una figura trasversale, ma un guru del settore come Cristiano
Santini (ex Disciplinatha).
Detto questo, proprio il suono è la parte migliore del
disco. Patinato, ma alla fine capace di blindare la musica della band laziale in uno streaming evocativo e
credibile fatto di chitarre elettriche vicine al metal e
tastiere. Con qualche colpo di genio (gli archi di L'odio),
ruvidezze particolarmente riuscite (All'apice) e in generale una taratura degli equilibri tra rumore e melodia
quasi perfetta. Il problema di Non ingerire, semmai,
sono i brani: passino le analogie con i Subsonica che si
respirano un po' ovunque nel cantato, restano testi per
lo meno discutibili per un combo che si fa portatore di
una «canzone d'autore moderna e graffiante». Niente di
52
tutto questo. Al massimo un tentativo apprezzabile (La
giostra) ma al tempo stesso confusionario di innovare
un linguaggio dai codici ben noti.
(5/10)
Fabrizio Zampighi
Instra mental - Resolution 653 (NonPlus,
Aprile 2011)
Genere: IDM, Techno
Cresciuti a Rave Culture e Warp Records all’inizio dei
Novanta, folgorati dal discorso contaminato e intelligent operato da Photek alla drum’n’bass, i londinesi
Alex Green & Damon Kirkham ovvero Instra:mental
avevano esordito nell’anno peggiore per la cassa rullante. La scena aveva chiuso i ranghi e pure le produzioni più sperimentali, tipo il tech-step, erano arrivate
a un punto morto. Tra 2000 e 2001, i due facevano una
comparsata su Demonic con tracce d’n’b scure a bpm
rallentati (130 circa) tra cui l’anthem ragga Boomer, le
cinematiche noir di Channel Zero e una splendida Pimp
star (blim caraibico di chitarrina campionata e retrogusto jazz al basso, percussioni tribali) che dava da internere più di quanto, evidentemente, non si potesse fare.
Poi cinque anni di hiatus e il ritorno in consapevolezza
con mosse calibrate e una produzione ancora più lenta
e dark. Per Darkestral escono tre 12’’ a mettere in chiaro lo scarto dal d’n’b mentre le lezioni electro e techno
(Autechre) si fanno sentire e così pure l’interesse per i
film di Carpenter e il Blade Runner di Vangelis, le claustrofobie di Detroit, certe freddure Pan Sonic intersecate con casse che assomigliano sempre di più ai codici
Morse (ancora Autechre e il lato hip hop della faccenda).
Nel 2009, i conti con il passato vengono definitivamente saldati: Watching You - un gioiello di fusioni 2 step,
idm e house - dice la parola fine alla cassa rullante, anzi,
la relega a uno degli stili in oggetto del revisionismo a
nome Club Automaton, moniker per il quale, assieme
a Darren White / Dbridge, escono una serie di podcast
gratuiti che presto rappresentano download di culto e
infine anche un’omonima label gestita da quest’ultimo.
Contemporaneamente il singolone esce per un’etichetta personale, la Nonsplus. Gli Instra:mental, cresciuti in
termini di amicizie e contatti, suonano all’impazzata
tra Berlino, Londra e il mondo, pubblicano singoli di
Actress e della star dubstep Skream la cui specialità è
naturalmente parte del menù del FabricLive, che a sua
volta è una sorta di best dei Podcast. A completamento abbiamo l’album lungo, ovvero la nuova pelle del
dopo Photek.
La lezione Rave e Warp, cyber Autechre e tunnel vision
AFX ritorna ancora ma questa volta la dichiarazione
d’appartenenza all’UK Bass proviene da una camera
iperbarica tutta electro e rigore. Resolution653 è uno
di quei lavori zen sul continuum che sottopone l’autismo dei mancuniami a visioni detroitiane Gerald
Donald / Drexciya (Arc, la kraftwerchiana Plok), dove
il Plastikman ai tempi della Plus8 (8) si mescola alla
braindance e all’acid più involuta della Rephlex (Aggro
Acid, Love Arp), dove la toponomastica dubstep in scifi Planet Mu (Rift Zone), trova l’ambient house (Talkin’
Mono) tra sincopi, circuiti e letteratura cyber. Un disco
di luce nera al confine tra cuffia e dancefloor. Nessuna
bomba vera ma una produzione che raggiunge picchi
incalcolabili.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Jaki Liebezeit/Burnt Friedman - Secret
Rhythms 4 (Nonplace, Aprile 2011)
Genere: Tribal funk
In tanti se non tutti conoscono la storia di Secret
Rhythms. Burnt Friedman e Jaki Liebezeit decidono
di trattare in studio un loro concerto alla Triennale di
Colonia del 2000. E il tutto, anziché rimanere un episodio isolato, diventa l’inizio di un percorso, o meglio, di
un processo di analisi oggi arrivato alla puntata numero quattro.
Ovunque ci sia lo zampino di Jaki, la lavorazione del ritmo non può essere elementare. È lui stesso ad aborrire
i tempi che il rock tradizionalmente si è scelto. L’impero dei quattro quarti, per il leggendario batterista dei
Can, è quanto di più noioso si possa concepire, specie
per uno che ha colto da giovanissimo le potenzialità
di spostamento di immaginario della “musica leggera”,
pur provenendo da studi ben più altolocati. Si sentono
le delizie ritmiche di Future Days, in Secret Rhythms
Vol. 4, che dal retrobottega emergono sempre o quasi in primissimo piano (182-11; ma è responsabilità del
missaggio di Burnt), comunque le maggiori responsabili del mood creato dall’album. Certo, il ritmo non è
solo fatto di percussioni, ma di sponde di sample create da Friedman (131-7, forse il migliore intarsio che risulta della formula), e contrappunti e ritagli di chitarra
(grazie a Joseph Suchy), fiati (Hayden Chisholm), basso (Daniel Schroeter).
La complessità del ritmo, come chi è appassionato di
Africa saprà già, non significa però affaticamento per
l’orecchio occidentale. Al contrario, è un invito a entrare nel flusso, a non limitarsi a battere il piede ma
seguire le decine di input a battuta con tutto il corpo.
Secondo questa logica, i brani sono infiniti o brevi,
senza che la sostanza cambi; e in questo senso il Vol. 4
si inserisce nella sequenza iniziata dal primo capitolo
senza una vera soluzione di continuità. Basta cogliere
la complessità interna a ogni passaggio, per capire la
natura dell’intera operazione, e non aspettarsi niente
di più che una serie di esempi di alto livello dello stesso
metodo.
(6.7/10)
Gaspare Caliri
James Ferraro - Night Dolls With
Hairspray (Olde English Spelling Bee,
Aprile 2011)
Genere: hypnagogic pop
Chi avrebbe mai pensato che James Ferraro avrebbe
fatto un disco pop. Uno che ha tirato fuori le più nefande e nauseabonde cose ascoltate negli anni '00 in
compagnia di Spencer Clark con gli Skaters, i padrini
del drone noise più lercio e ignobile. Uno che ha perseguito imperterrito nella sua opera solista (in cui gli
pseudonimi non si contano) l'inquinamento delle nostre orecchie suonando la psichedelia ambientale di
una discarica. Uno così come può fare un disco “commerciale”? Ascoltando Night Dolls With Hairspray si comprende
immediatamente che a cambiare non sono certo i lemmi fondanti del linguaggio ferrariano (che rimangono
sozzura, bassa fedeltà e approccio luddista), ma il frame di riferimento che diventa quello del bubblegum
pop, in pratica un popular ottenuto dal rigurgito del
pubblico, rimasticato e riconfezionato secondo i suoi
stessi standard, un prodotto di massa guastato e infettato fino al midollo e reso così spazzatura della spazzatura.
Ferraro lavora anche con il video ed è proprio dallo
pseudo film in Vhs Rapture Adrenaline (un cut up dei
peggior horror movie e telefilm degli anni '80/'90, collage di video di Mtv e traposizioni cinematografiche di
videogame tipo Mortal Kombat, purulento mix di cultura trash degno della mente di un produttore di Videodrome) che è cominciato il rinnovamento che questo
Night Dolls With Hairspray porta a compimento e completamento, anzi, a saturazione.
L'ex Skaters infetta telefilm adolescenziali stile Saved by
the Bell (Bayside School in Italia) con splatter d'ambientazione scolastica a là Jolly Killer (Leater High School),
inscena demenziali filastrocche da sigla di Beverly Hills
90210 (Buffy Honkerburg's Answering Machine, Roses
And Mystery) fino a intonare power pop mongoloidi
(Runaway, Dollhouse Frotteur) e pastiche di frequenze
Am (Radio Cherubs).
53
highlight
Implodes - Black Earth (Kranky, Maggio 2011)
Genere: Heavy drone buzz
Esordio potente e visionario per le nuove stelline di Kranky Records. Gli Implodes arrivano da Chicago, con una classica lineup a quattro costruita intorno ai chitarristi Matt Jencik e Ken Camden, con
quest’ultimo già fattosi notare l’anno scorso proprio su Kranky, con il disco solista intitolato Lethargy & Repercussions. Le coordinate su cui si
muoveva Camden in proprio, ovvero krautrock classico e dronemusic tra
le più estatiche trova soltanto parzialmente una sua eco tra le spire spesse
e metalliche degli Implodes che al contrario piegano ogni cosa sotto uno
spesso umore di tenebra.
Black Earth è un disco dotato di un fascino scuro ed arcano che poggia
le sue fondamenta su un mix molto abile e furbo. Da un lato, più che fare
bieco citazionismo, prende in prestito in toto la lezione black metal con il
taglio metallico e acido delle chitarre e le voci ridotte al rango di rantoli riverberati. I brani rimangono
sempre sufficientemente melodici per non superare mai davvero la linea di confine, ma tutto questo
aggiunto al piglio tribaloide delle ritmiche e alle incursioni insistenti su una drone music apocalittica e
nerissima traghettano la musica in un terrirorio che sembra stato battutto già milioni di volte eppure
mai con questa efficacia. Qui dentro c’è del post rock mischiato Current 93/Death In June (i mormorii sinistri e tenebrosi su
Screech Owl, Song for Fucking Damon II, Hands on the Rail); acid folk da apocalisse (l’iniziale Open The
Door, Oxblood, Experiential Report); metal-grunge (la micidiale Marker o la malinconica Meadowslands);
dark ambient virata kraut (White Window, Wendy, Down Time). Tutto concorre alla descrizione meticolosa di questa terrifica terra di mezzo del nero. Non sarà un viaggio indolore, ma finalmente i teenagers
del 2011 che non si arrendono all’emo hanno trovato una colonna sonora adeguata ai loro tempi.
(7.5/10)
Antonello Comunale
Un collage impetuoso, capace di sferrare la sua fatality
e con una sua forza scatologica. Del genio vi abita senza dubbio, ma attenzione alla scadenza e al compiacimento. Il Pit Fall è vicino...
(7.4/10)
Francesco Asti
Jamie Woon - Mirrorwriting (Polydor,
Aprile 2011)
Genere: nu-soul popstep
Uno degli album più attesi dalla cricca di gente che
viaggia con la playlist su coordinate nu-soul e dubstep:
per intenderci, quelli che hanno esaurito dopo pochi
istanti i posti per il concerto di James Blake o che si
sono esaltati ascoltando il disco dei Darkstar. L’esordio
di Jamie Woon, già anticipato dal singolo Night Air coprodotto da Burial, si riporta su binari popstep influenzati dal blues e dal soul, come va di moda oggi.
Il ragazzo ventottenne non è però un novellino. Ami54
co di Ramadanman (che ha chiamato in suo onore
una delle sue tracce The Woon), in tour come spalla di
Amy Winehouse, vari remix per lui da parte anche di
Hudson Mohawke e Royce Wood (Lady Luck), un featuring in compagnia di Om’Mas Keith per il singolo Solidify di Subeena su Planet Mu, coinquilino del Portico
Quartet nell’East End londinese, segnalato come New
Band Of The Day dal Guardian, al quarto posto nell’influentissimo sondaggio BBC Sounds of 2011 (dietro a
Jessie J, James Blake e The Vaccines): insomma, uno
che si dà da fare.
Tre anni per concludere il disco, registrato tra Londra
e un cottage della Cornovaglia, dove il gossip dice che
abbia registrato i suoni dell’argenteria e delle pietre del
torrente per trasformarli in percussioni da aggiungere
all’album. Un’attesa che gli ha portato fama, riconoscimenti e probabilmente esperienza. Il ragazzo londinese - dalla voce che somiglia tanto a quella dell’omonimo Jamie Lidell - parte con un full denso di riferimenti
agli Ottanta e ai Novanta (ad esempio al pop raffinato
degli Everything But The Girl), al soul e alle derive
post-step che oggi si incanalano nei binari del pop.
Street è una cosetta da niente che ti prende subito, un
ritmino eighties che non ti togli di dosso, il singolo con
Burial (Night Air) riprende la fase electro dei Depeche
Mode e gli aggiunge la voce cristallina che va su e che ti
cuoce l’anima, Lady Luck si fa contaminare dal soul pacchiano da classifica (ma ha un suo mood che esula dal
peggior Timberlake, per intenderci) e che sicuramente
sarà amata da migliaia di ragazze, Shoulda è il richiamo
alle canzoni da studio 80 (dice bene il NME quando cita
In The Air Tonight di Phil Collins), Echoes ci va di falsetto
retrò con qualche puntatina step, e poi la seconda metà
del disco si rilassa in qualcosa che potrebbe essere benissimo usato in qualche compilation chill-ambient di
classe (Spiral, Secondbreath) e che fa scendere le vibrazioni dei picchi raggiunti in precedenza.
Il dubstep è diventato ancora una volta pop. Woon lo
testimonia con un album che potenzialmente può essere ascoltato da chiunque (sì, dalla casalinga che ha
l’autografo di Julio Iglesias incorniciato alla parete alla
ragazza che ama i Dari), a prescindere che si conoscano
o meno i trascorsi oscuri del genere. Il rischio però (da
metà tracklist in poi le tracce lo testimoniano) è quello
di perdersi in una patina che rasenta il trash di molte
delle più infauste boy band anni Novanta. Il ragazzo
ha una bella voce, sdogana il soul nella pasta popstep,
ma deve stare attento a non infognarsi nel tunnel di
una commercialità che non ha nulla a che vedere con
le ricerche proficue di Blake & Co. Marketing e tattiche
commerciali intaccano l'underground londinese, come
già presentivamo nella bufala Magnetic Man.
(6.9/10)
Marco Braggion
Jason Forrest - The Everything (Staatsakt,
Aprile 2011)
Genere: plunder-mash-up
Ci ha messo sei anni Forrest a dare un seguito al precedente Shamelessly Exciting. Il producer e artista (noto
anche con il moniker di Donna Summer) non è stato
però con le mani in mano in questo lasco temporale.
Ha curato ben due etichette (la Cock Rock Disco per
la musica sperimentale e la Nightshifters per i suoni
clubbistici), ha fondato il festival Wasted con DJ Pure
ed il club Transmediale di Berlino per dare visibilità alla
scena breakcore (genere di cui è uno dei personaggi
di spicco) e all'inizio di quest'anno ha lanciato pure il
canale TV/sito/magazine Network Awesome.
L'album riprende le idee dei suoi lavori mid-noughties
proponendo una lista di tracce massimaliste che assemblano a puntino sample per costruire stanze funk
(New Religion), visioni filmiche loungey tagliate con
breaking e krauterie varie (Italian Lessons), reminiscenze break-acid-core à la Kid 606 (la traccia che dà
il nome alla raccolta), americana bluesy proto-Beck
(Raunchy), organetti per Luke Vibert (The Exquisite
Organs), truzzismi in ghetto lo-fi (Roger Dean Landscape), porno lounge Settanta (Keys To The Door starebbe
bene in un live di Frank Zappa) e per chiudere pure la
notevole meditazione slo-mo pianistica (Isolation, Too).
Jason è un uomo che non sta mai fermo, e che con le
sue migliaia di idee in pochi attimi fa attraversare mondi lontanissimi. Per chi segue l'elettronica da qualche
anno, la proposta si situa su un solco tracciato dallo
stesso Forrest in compagnia del già citato Kid 606, di
Duran Duran Duran, DJ Rupture e Spooky fra gli altri.
Nulla di nuovo insomma, ma il prodotto ha una coesione e una capacità di arrangiare i materiali notevoli.
Per questo, dopo anni dall'esordio, Forrest sta sempre
sopra la media. Keep it going, Jas.
(7/10)
Marco Braggion
Jolaurlo - Meccanica e natura (Irma
Group, Marzo 2011)
Genere: synth wave rock
L’eredità dei Novanta dei gruppi italiani si disperde
oggi in centinaia di proposte, che alle volte sottolineano come quel laboratorio - che fra gli altri ha visto
lavorare gli Üstmamò, i Disciplinatha, i Subsonica, la
Bisca e (sì, pure loro) i CSI - avesse idee e propositi ben
al di sopra dello zeitgeist, confinato spesso in fanatismi
spiccioli ed effimeri. Gli Jolaurlo di Marzia Stano (frontgirl e vocalist del combo pugliese) partono sull’ultima
canzone di questo terzo album da una connessione
con il famoso Consorzio: Annarella (registrata dal vivo)
è il cordone ombelicale che ricollega l’ultima fase delle
molteplici creature di Ferretti all’oggi post-tutto.
Questo link azzardato, ma non troppo peregrino, ci permette di accostare il gruppo per affinità strumental-vocali
alle derive electro del gruppo della Redeghieri (amica di
Giovanni Lindo) in un sentiero che è anche - ovviamente
- influenzato dal presente. Il lag temporale che intercorre dall’ultimo lavoro della band dell’appennino reggiano
viene rimpolpato con riferimenti ai Prozac+ (Polistirolo),
ai Subsonica più dancey (Il Buio) e in certi episodi anche
agli Ottanta più sintetici di OMD, Soft Cell e Ultravox, oggi
in sommo rispolvero (Chiaroscuro, Banale).
Prodotto dall’impareggiabile Casasonica di Torino (Ale
Bavo il mastermind dietro le quinte) il disco suona ot55
timamente, ha una buona carica e si configura come
un prodotto dal sicuro potenziale radio-pop. Se questi
fossero stati gli obiettivi di Marzia e dei suoi colleghi, il
bersaglio è stato centrato in pieno. Beninteso: lo iato
con i padri nobili è tutt’altro che colmato e se il combo volesse alzare il tiro contro l'erosione temporale, è
proprio sui testi e sulla poetica che dovrebbero lavorare. C’è ancora molta strada, ma l’impegno e le 'good
vibrations' di Meccanica e natura meritano il dovuto riconoscimento.
(7/10)
Marco Braggion
Jookabox - The Eyes Of The Fly (Asthmatic
Kitty Records, Aprile 2011)
Genere: lo-fi hip-hop
Che il quattro venga da sé lo dice uno dei proverbi più
affidabili sulla piazza. Il cinque invece è notoriamente
più precario. Quello scellerato mattacchione di Moose
Adamson deve pensarla più o meno così, dal momento che ha accompagnato l'annuncio del quarto album
dei suoi Jookabox con la notizia del loro scioglimento.
Canto del cigno inatteso dunque, ma assolutamente
degno dei predecessori, tanto spasmodico e vitale da
compensare il rammarico con qualche fondata speranza nel nuovo progetto solista di Adamson dietro moniker DMA.
Dieci tracce per una mezz'ora tra le più schizoidi sulla piazza, questo The Eyes Of The Fly. Titolo attinente, non tanto per le ossessioni kafkiane che riverbera
quanto per il senso di frammentazione visiva, di sguardo che scassa, fracassa, disarticola e ricompone con
l'ingegno gioioso e selvatico d'un bimbo che si crede
un freak (e viceversa). Regressione sonora consapevole,
più beffarda che dissacrante, liberatoria perché reclama libertà espressiva - appunto - a partire dalle radici
folk e blues su cui poggia, per poi scodinzolare spedita
tra imponderabili ipotesi hip-hop, psuedo-tribali e lofi. Obiettivo? Sparigliare le tessere del puzzle per comporre un'immagine paranoica del sensibile quotidiano,
alla ricerca genialoide e un po' disperata della combinazione inaudita, quella cioè capace di perturbare le
certezze, scuotere i sedimenti, oppure solo di operare
una chirurgica distrazione dal consueto (dal reale).
Viene sì da pensare alle farse alienate di David Thomas, alle stravaganze acute del primo Beck, all'estrosità goliardica dei Camper Van Beethoven, al dadaismo insidioso dei Residents, così come al post-black
eterogeneo dei Tv On The Radio e all'estrosità burrascosa di Jon Spencer: in ogni caso, qui tutto accade
entro un'aura da b-movie fumettistico e cazzone, con
56
l'obiettivo d'un divertimento sì delirante e fors'anche
malsano, ma tutto sommato abbastanza piacionesco,
tipo dei Gorillaz meno fighetti e più facinorosi. La filastrocca ipnotica di Cold Solution ed il piglio febbrile di
FF rappresentano un po' gli estremi stilistici del discorso, il cui apice coincide col formidabile pasticcio della
title track, visionaria stratificazione di surf, countryfolk, hip-hop e psych in un brodo di trafelata frenesia.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Katy B - On a Mission (Rinse, Aprile 2011)
Genere: Uk dance pop
Sulla virata mainstream di alcuni culti dubstep vi abbiamo già detto: prima è arrivato Roska, poi il super trio
Magnetic Man formato da Benga, Artwork e Skream,
dunque la prova solista di quest’ultimo e infine naturalmente, James Blake, il primo astro di una bolla speculativa nu soul a base dubstep che ora esplode con
Jamie Woon (il nuovo Craig David?).
Kathleen Brien, classe ’89, protetta Rinse.fm, allieva
della BRIT School (la fucina di personaggi nuovi che ha
dato alle stampe i lavori di Adele, lo stesso Woon, Amy
Winehouse e altre star nascenti UK), già all’attivo con
un paio di hit in proprio (Katy On A Mission e la grimey
Lights On con Ms Dynamite) e la famosa Perfect Stranger dei Magnetic Man (qui ri-compresa), arriva all'album su Columbia prodotto prorpio dall'afro warrior
dubstep Benga.
Dubstep, drum’n’bass, 80s, remember ’92, e house.
Tutto addomesticato al pop r'n'b da classifica come si
era già notato in Katy On A Mission, quinto posto negli
UK lo scorso luglio, ottimo riff hard step del producer
e una parte melodica piatta come poche. Oggi si replica male con tentativi wave pseudo-La Roux (Witches
Brew) e fastidiosi euro-disco (Broken Record), ma l’album, indubbiamente, si regge discretamente su terreni nu soul à la Janelle Monáe e affini. A segno, anche
se non proprio originali, i colpi house, disco o breakbeat nelle rispettive Why You Always Here, Movement e
Disappear e quasi sempre ottime le soluzioni confezionate da Benga (una base su tutte Go Away, una postdrum’n’bass liofilizzata).
In definitiva, un disco spesso scontato e non sempre
all’altezza in termini di personalità. Qui non è certo
questione di songwriting, ma di non essere il clone
del clone di qualcuno, tanto più che Katy partiva con
il culo straparato, da amici e controamici. Perché non
osare giusto un po' di più?
(6/10)
Edoardo Bridda
King Creosote/Jon Hopkins - Diamond Mine
(Domino, Marzo 2011)
Genere: Folk
E' un'accoppiata delle più improbabili quella che sigla
questo Diamond Mine. Uno è King Creosote, folkster
scozzese, profilo coerentemente indie e una serie di
album mai decisivi ma di buon valore. L'altro è Jon
Hopkins, la cui ambient, a dispetto di molte illustri collaborazioni (da 'papà' Brian Eno fino a Massive Attack
e Coldplay) non si è finora distinta particolarmente
nell'opera a suo nome. La somma delle parti comunque non compromette nè l'una nè l'altra, anzi, si direbbe che le migliori entrambe. Hopkins si sbarazza delle
superflue sbavature dubstep che rendevano prescindibile il suo ultimo disco per tornare alla materia che
padroneggia meglio; mentre King Creosote prende un
po' le distanze dai suoi modelli più classici (Paul McCartney in primis) per aggiornare il proprio registro e
sfogare quella voglia di 'modernità' che già trapelava
qua e là nei suoi album.
Nonostante l'intro strumentale sono le canzoni a fare la
parte del leone, ma l'apparato elettronico, per quanto
contenuto, si rivela comunque cruciale nell'economia
dei brani, particolarmente decisivo nell'avvicinare delicatamente ciò che sarebbe un buon disco folk a nomi
più imponenti. Sia Bats In The Attic che Your Own Spell,
ad esempio, percorrono le vie bucolico-siderali dei Sigur Ròs; se Your Young Voice riecheggia distintamente
Tim Buckley, Running On Fumes aggiorna la lezione di
quest'ultimo a quella dei Radiohead più epici e dilatati; mentre l'altra faccia della band di Thom Yorke, quella elettronica, è la base della commovente Bubble che,
complice l'inserimento del banjo, fa l'occhiolino anche
ai Notwist di Neon Golden.
La mancanza di una forte personalità era un difetto che
già condizionava le rispettive opere in solitaria del duo,
e qui non si può che rimarcarlo con maggiore severità,
considerato l'alto numero di paragoni possibili e, viceversa, la quantità di opzioni che due mondi musicali
così distanti metterebbero a disposizione. Ma a quanto
sembra la prospettiva di osare non interessava i nostri,
che più verosimilmente hanno solo pensato a dare la
forma migliore a una serie di brani in cui credevano:
con ragione, perchè l'ispirazione che governa questi
ultimi è tale da rendere l'esperimento riuscito.
(7.2/10)
Simone Madrau
cora caratterizzata da quel misto di post-rock ed elettroniche che lì caratterizzò nei Novanta, ai tempi della 'neue deutsche welle' del kraut rock assieme a To
Rococo Rot, Tarwater e Mapstation. E quanto scritto
recentemente per 2014 vale sostanzialmente anche
per Tank con l'importante eccezione che questo è probabilmente il miglior album della ditta.
I Kreidler trovano finalmente la quadratura in un lavoro
solido, vario e affascinante, che non deve nulla a nessuno, fa la propria cosa e la fa con il solito misto di freddezza, gusto per le timbriche e pennate d’elettronica
sempre misuratissima. Confezionano una breve manciata di tracce dove il rock dialoga con una techno primordiale a braccetto con Vangelis, dove una costante
dark, che rimanda a tutta una classica cinematografia
(Blade Runner, Essi Vivono ecc.) scambia fluidi con il
lato più umbratile del post-punk che va dai Savage
Republic ai Piano Magic. E ancora il con kraut a base
di motorik Neu!, lo sci-fi ereditato dai Kraftwerk. Le
triangolazioni di terra, metafisica e cielo.
Anche se il mondo guarda altrove e queste sonorità, si
dirà, hanno fatto il loro tempo, non commettete l'errore di farvi scappare un album come questo.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
La metralli - Del mondo che vi lascio (A
Buzz Supreme, Aprile 2011)
Genere: jazz / cantautorato
I La metralli sono il tipico progetto “alto” che parte
dal jazz e sfocia in una canzone d'autore caposseliana
(Sull'ultima vertebra) mista ad atmofere folk popolari. Tanto che il risultato alla fine è una musica contestualizzata, finanche prevedibile nello svolgimento,
ma nonostante tutto ben fatta. Chitarra, fisarmonica,
contrabbasso, kazoo, qualche batteria sparsa e la voce
di Meike Clarelli a immalinconire tra valzer e blues
sfilacciati (Un niente di felicità), jazz e qualche altrove
imprevedibile (il Tim Buckley di Anchora). Con un parco strumenti virtuoso e arrangiamenti che alla fine si
mantengono piuttosto minimali.
Del mondo che vi lascio è un bel disco, forse fin troppo
uniforme, nonostante qualche aroma balcanico diffuso
(Balkan Graffiti) e un approccio ai “classici” che diverte
senza snaturare la tradizione.
(6.5/10)
Fabrizio Zampighi
Kreidler - Tank (Bureau-b, Aprile 2011)
Genere: Kraut
Salvo un tocco appena più wave, la loro formula è an57
La Nevicata Dell'85 - La nevicata dell'85
(Fumaio, Marzo 2011)
Genere: post psych
Ogni nuovo epigono è un attestato di merito per chi
- come Massimo Volume e in parte CCCP/CSI - ha
dettato le coordinate del "read'n'rock" in italiano. Ai
cari Offlaga Disco Pax, agli ottimi Bachi Da Pietra e
dopo l'eccellente conferma dei Bancale, possiamo aggiungere al novero anche i bergamaschi La Nevicata
Dell'85, un trio che di specifico ci mette una meditazione sonica ad alto tasso scenografico, quasi a definire
in ogni canzone lo sfondo d'una pieces emotivamente
sostenuta, spinta vicino al limite eppure assolta da un
raziocinio che sa organizzare i tumulti in una narrazione stratificata, assieme complessa e focosa (vedi il
sapiente intreccio di veemenza hard, vampe gotiche e
aromi latini della stupenda Settembre).
Ne esce un apprezzabile equilibrio tra liriche, interpretazione e musica, quest'ultima impegnata a definirsi
come narrazione parallela, frutto d'estro espressionista
che sa dosare pennellate evocative (come gli aciduli
miraggi psych di Io sono Jean-Baptiste) o impetuose
(vedi il clangore industrial-motoristico nella furibonda
Delenda). Altri segnali di libertà, o se preferite di mancanza di preclusioni stilistiche, sono le fiabesche escandescenze desert-noise di Il disguido di Gringo e quella
Polvere cantata con facinoroso languore che riverbera
lirismi incrociati post-rock, stoner e progressive. Un debutto notevole.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Ladytron - Best Of 00-10 (Nettwerk Music
Group, Aprile 2011)
Genere: Synth Pop, Electro
Un equilibrio instabile tra forma e sostanza, tra indietrend ed effettive capacità, revivalismo e presente
effettivo; e nondimeno, un nome di cui tenere conto
nell'interpretazione di dove vanno (andavano?) i gusti
di un certo pubblico. Non si direbbe in apparenza ma
i Ladytron negli anni si sono evoluti, in una maniera
che magari ha allontanato le simpatie di chi viene da
gruppi come i Broadcast ma che in compenso ha avvicinato quelli che con certi anni 80 (Depeche Mode in
testa) ci sono cresciuti.
La presente raccolta mette in fila i 17 brani che hanno segnato il successo del gruppo, evitando l'ordine
cronologico e studiando invece una tracklist più strategica, che cala subito l'asso Destroy Everything You
Touch, ad oggi probabilmente singolo più popolare, e
poi procede alternando atmosfere tenui e beat danza58
bili, mescolando l'elettronica suadente e carillonesca
dei primi lavori (Playgirl) con le imponenti architetture
synth-pop degli ultimi lavori (Ghosts).
L'ascolto nel complesso è godibile, complice l'assenza
quasi totale di quei momenti morti che hanno sempre
inficiato la bontà complessiva degli album veri e propri. Per chi già ha questi ultimi, la mancanza di brani
inediti dovrebbe togliere la tentazione di un eventuale acquisto. Per gli altri, questa è una cartina al tornasole di uno degli electro-pop acts più rappresentativi
dell'ultimo decennio.
(6.9/10)
Simone Madrau
Lake - Giving & Receiving (K Records,
Aprile 2011)
Genere: psych-pop
Un album dei Lake presenta ingredienti sicuri: canzoni
“corrette”, delicate, lievemente psichedeliche, condotte
con naturalezza. Il collettivo non rinuncia, neanche nel
terzo album per la K Recs, ai retaggi Sixties e al tocco
che ha sempre distinto band di Eriksson, Moore e compagnia.
Si sentono molto i Dub Narcotic Studios, dove il combo ha registrato durante i mesi caldi del 2010, e dove
ha messo a punto un’infilata di brani con inventiva ma
senza picchi - dove l’eccesso è bandito, ma, qui sta la
bravura, non è sostituito con la banalità. Si sente anche
Karl Blau filtrato Paul Simon (Within/Without), deus ex
machina e mentore stilistico di chi passa da Olympia
- così come Calvin Johnson. Entrambi mettono la propria firma sull’uscita, chi - Karl - al mixing e all’ingegnerizzazione, chi - Calvin - solo a quest’ultima fase.
Ciò che piace è che le canzoni dei Lake ci attraversano
senza sembrare mai davvero nuove, quasi fossero un
easylistening automatizzato. Eppure, cosa quanto mai
rara date le premesse, le creature dei Lake non perdono
mai in personalità (tra i picchi c’è Mother Nature’s Promise, piena della tipica flemma del gruppo, ma anche
di verve e di trovate strumentali). Avrà influito il lavoro
di Ben Hargett, che ha trattato il tutto con il suo laptop
(esatto, proprio un computer), oppure meglio, e più in
generale, sarà che naturalezza qui non vuol dire approssimazione, ma costruzione leggiadra e minuziosa
che al lato pratico - leggi l’ascolto - scompare, lasciando il piacere delle melodie e degli arrangiamenti. E un
gusto di lavoro collettivo, di macchina molto umana e
molto oleata. Non ci aspettavamo e non ci aspetteremo altro. Né ci stuferemo di ascoltarli.
(7.1/10)
Gaspare Caliri
highlight
James Pants - James Pants (Stones Throw, Maggio 2011)
Genere: weird pop
Sensibilità pop maturata in anni di ascolti onnivori e disordinati iniettata nel corpo di un nerd della
musica con un innato istinto weird. Ecco la formula semplice semplice che spiega il talento di James
Pants. Un piccolo maverick della suburbia americana che con un paio di
mosse giuste a livello di immagine e di comunicazione (magari con la spinta di un hype-setter come Pitchfork) potrebbe benissimo fare sfracelli nel
mondo indie/alt/lo-fi eccetera.
Innamorato tanto della Motown e del doo-wop quanto della dance solarizzata anni Ottanta e della new-wave più malata, James produce beat,
compone, suona e canta praticamente in solitaria; ogni suo disco è una
generosa girandola di idee, di invenzioni, di riferimenti, di sovrapposizioni
e parallelismi (per cui, per dire, diresti che la notte dorma abbracciato al
bulbo di uno degli zii Residents, ma non è mica vero). Questo suo omonimo disco, il terzo propriamente concepito come album, è probabilmente il suo lavoro più compiuto finora, sicuramente il cosiddetto
disco della maturità.
James prende il power pop e lo infila stropicciato nella buca delle lettere dei Pussy Galore (Beta); si
mette a giocare serissimo col soul e trasfigura Sometimes I Don't Know What To Feel (Every Night I Dream); sembra fare il verso agli acusticismi delicati dei Kings Of Convenience (mettendoci sopra la voce
glo-izzata di Lucrecia Dalt; Clouds Over Pacific); prende Gates of Steel dei Devo, la rallenta e la ricopre di
melma, poi la mette in trasparenza con una baracconata alla Gary Wilson, poi ancora - netta cesura mette in primo piano basso, batteria e uno sfarfallare di synth in un rockettino anni Cinquanta virato
lo-fi (A Little Bit Closer). E via così, con la magia pop a base di umide tastiere Ottanta e carezze grottesche
alla Residents di Kathleen (è il nome della moglie), con lo strano western di Body On Elevator, i mesh appunto - Cinquanta/Ottanta di Darlin' e Alone e il synth sognante, il basso pulsante e scuro e la voce
femminile bianca come la luna (sempre la moglie) dello squacio romantico Dreamboat. Nel vostro scaffale 2011, da mettere tra Driver&Driver e Tune-Yards.
(7.5/10)
Gabriele Marino
Le Rose - Le Rose (Pippolamusic, Settembre
2010)
Genere: synthpop, italiana
Fiori colorati, lievi, morbidi e pungenti: ecco quel che
abbiamo davanti. Le Rose sono il progetto a due voci
di Flavio Scutti e Andrea Noce, due che probabilmente,
dopo essersi incontrati come da Annales, ai piedi del
Colosseo, hanno cominciato a parlare di Gianni Togni
e di Diana Est decidendo poi di mettersi a suonarli
contemporaneamente.
Nei '90 band come La sintesi, Bluvertigo, Subsonica
e, su tutti, Soerba, erano riuscite a riportare in vita un
sound sepolto dalla flanella dimostrandoci come tutto
in termini di pop dovesse, sensatamente, ripartire soprattutto da lì, oggi i due romani ne proseguono più
che degnamente il discorso sorvolando sulle passate
indagini colte dell'elettronica (testi post dogmatici,
volontà mistico-intellettuale) e calcando su un pop
puro, semplice e nella più complessa delle accezioni
(se la già citata Diana, in Tenax, cantava versi di Seneca
a tutto spiano, parlare di Schumann non sarà certo un
problema).
Nove brani uno più singolo dell'altro che vanno dal
candore cinematografico di Meteo al romanticismo
epicoerotico di Hotel Como e Mi dice sì, fino all'electro
sfrontato di Monica Vitti (un contraltare perfetto al più
scivoloso Pop porno nazionale). Il risultato? Matia Bazar da disco omonimo e Aristocratica con tanto, tanto
Garbo e Italodisco, tutto suonato impeccabilmente.
Un altro coupe non da poco della nostra Pippola music.
(7/10)
Giulia Cavaliere
59
Left Lane Cruiser - Junkyard Speed Ball
(Alive Naturalsound Records, Marzo
2011)
Genere: garage-blues
Tirate fuori dal cesto delle cose sporche la vostra camicia più stracciata, lasciate crescere i peli sulla vostra
faccia, coricatevi per terra e rotolate nella polvere. In
Junkyard Speed Ball di pulizia, e di quella che un tempo
si definiva vita borghese, non ne troverete traccia.
Se vi eravate fermati tra il radicalismo chic dei White
Stripes o tra le venature soul dei Black Keys (anche
loro della scuderia Alive Natural Sound), il terzo album
del duo dell'Indiana arriverà fastidioso come l'umidità
del Mississipi a ricordarvi di cosa è fatto il blues: sporcizia e sangue, passione, emozioni e istinto, pochi fronzoli e tanta sostanza. Rozzi come solo dei redneck sanno esserlo, i Left Lane Cruiser si lanciano con impeto
sui loro strumenti dando sfogo a tutte le energie in un
passaggio diretto tra viscere, braccia e voce. Le abilità
tecniche e le sperimentazione, infatti, meglio lasciarle
ad altri: le qualità che conquistano dal primo ascolto
sono l'immediatezza e l'impatto sonoro. Basta passare
per l'apertura di Lost My Mind o la ballata Giving Tree
per accorgersi di come i motivi entrino con facilità sorprendente nelle orecchie.
Pieni di urgenza espressiva e carichi di una sana e sacrosanta ignoranza, il duo barbuto si candida a rinverdire i fasti del rock sudista e, perchè no, anche ad entrare nel cuore dei fan di mr. Jon Spencer e la sua Blues
Explosion.
(7/10)
Francesco Asti
Lento - Icon (Denovali, Aprile 2011)
Genere: heavy-doom
Supera in parte i cliché del genere l’atteso comeback
dei romani Lento. Se già Earthen - e prima ancora il lavoro collaborativo Supernaturals Record One condiviso
con gli Ufomammut - aveva messo in luce le possibilità elusive del quintetto, ora Icon disperde ancor di più
referenti e riferimenti.
L’accordatura ribassata delle tre chitarre, classica quando si traffica con pesantezze del genere, induce alla
cupezza strumentale ma non influisce sul potenziale
evolutivo della band. Passaggi quasi sinfonici e disarmonie post-prog, stacchi in levare e parentesi statiche
diluiscono il solito rifferama monolitico d’estrazione
post-metal e decostruiscono l’assetto delle composizioni dei Lento. Perché è questo il grosso pregio del
comeback: fondere e destrutturare l’approccio monodimensionale del genere di riferimento in un pulvisco60
lo di suoni, sensazioni e suggestioni che esulano dal
solito e iper-abusato contesto vuoto/pieno. L’horror
vacui di Icon, le parentesi simil-prog-metal disseminate
nel maelstrom di Hymn, le stasi sinfonico-celestiali che
aprono e chiudono circolarmente l’album (Then e Admission), il rumorismo ambientale che inaugura Limb
non sono che esempi di un procedere che allunga le
radici sino ad Earthen e promette sviluppi notevoli se i
romani avranno ancor più voglia di sperimentare sulle
fondamenta del proprio suono. Per ora accontentiamoci di Icon, un album che getta sicuramente nuova
linfa in un ambito a volte troppo chiuso nel suo recinto.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Little Scream - The Golden Record
(Secretly Canadian, Aprile 2011)
Genere: folk psych
Laurel Sprengelmeyer, opportunamente ribattezzatasi
Little Scream, esordisce per Secretly Canadian con un
parterre di tutto rispetto, ovvero coadiuvata da membri di The National (Aaron Dessner), Silver Mt. Zion
(Becky Foon) e Arcade Fire (Sarah Neufield e Richard
Reed Parry, quest'ultimo anche produttore). La polistrumentista dell'Iowa gioca una partita versicolore,
estrosa e misterica, mischia le carte e cala mani stordenti lasciando trapelare una evidente strategia sensazionalistica.
Con quella voce tra velcro e velluto guarda al folk revival asperso di misticismo psych, ammicca certe trepidazioni allibite ai margini del post, rincula verso un
rock acido scomodando vaghi fantasmi Jefferson
Airplane e Patti Smith, bazzica stravisioni bucoliche
contemporanee (gli Animal Collective via Polyphonic Spree) e via discorrendo in un ampio progetto da
"famolo strano" purché arty. Muggiti elettrici, vapori
cameristici e rugiade acustiche sono i colori base di
quadretti suggestivi perché bramosi d'esserlo, e che
proprio in cotanta tensione superficiale esauriscono il
principale motivo d'interesse, lasciandoci molti e fondati dubbi riguardo la sostanza.
Si lasciano sì apprezzare episodi quali The Heron And
The Fox (Nick Drake sognato da Laura Marling), i barocchismi catchy di Cannons, l'impeto rurale PJ Harvey
di Red Hunting Jacket, quella People Is Place che ricalca
certe trepidazioni diafane Sigur Ros, ma non c'è continuità né profondità melodica. Disco ben confezionato, certo, ma più espedienti che cuore. Come potrebbe
una freak col cuore da nerd.
(6/10)
Stefano Solventi
Lone - Echolocations EP (R & S Records,
Aprile 2011)
Genere: techno idm
Ritorna sulla media distanza Matt Cutler. Dopo 4 album e una manciata di singoli e rmx (su tutti, quello
per All The Flowers di Bibio), Lone riappare in grande
stile con Echolocations, EP firmato per la mitologica R&S
records. La label belga legata indissolubilmente alla
storia della techno europea, sta operando negli ultimi
tempi un ricambio generazionale e stilistico del proprio
roster. Questo svecchiamento (basti pensare alle release di James Blake) ricorda per certi versi quello che
è successo alla Warp una decina d'anni fa, anche se in
questo caso persiste una consolidata dimensione di
culto underground.
Tornando a noi, finora Lone ci aveva abituato ad un
percorso sonoro fatto di morbide atmosfere glo-fi e digressioni cinematiche che da un lato richiamavano ingombrantemente l'immaginario warpiano dei Boards
Of Canada e dall'altro una specie di fake-negritudine
wonderiana perfetta per sonorizzazioni porno vintage.
Per impacchettare il tutto nella contemporaneità Cutler
si è poi adoperato nel trattamento della propria materia sonora secondo gli standard produttivi sfocati e impressionistici della chillwave.
Rispetto a tutto ciò, la novità più consistente di Echolocations è l'avventurarsi nei territori della Detroit Techno
e dell'house Chicagoana. Per essere precisi, oltre a misurarsi con il materiale originale, in questi 6 pezzi c'è
anche il tentatvo ulteriore di filtrare il tutto con la lente
dell'acid house inglese dei primi Novanta, quel suono
che proprio sull'asse Chicago-Detroit ha plasmato tutta
la rave culture inglese. Explorers è una sequenza di sinuisoidi alla Orbital, Coreshine Vodoo e Blossom Quarter il
ripescaggio del Mark Bell degli esordi con gli L.F.O.; il
resto è un vero e proprio tributo all'estetica House di
Chicago con l'estasi techno stabbistica di Rapid Racer
o la gigioneria-Larry Heard di Approaching Rainbow e
Dolphin. Dietro le quinte, immancabile e forse ancor di
più che in passato, c'è sempre e comunque lo spettro
dei BOC, quasi un accorato appello a ritornare sulla scena da parte di un fan.
Al di là della palpabile aria di revival che ci regala un
immaginario amarcord '90, l'EP, dopo ripetuti ascolti lascia un pò l'amaro in boccca: non tanto per l'evidente
citazionismo, ma piuttosto per la dicotomia tra la bassa
fedeltà del linguaggio chillwave e la complessa stimolazione sensoriale a cui ci ha abituato la techno più 'intelligente'. Uno dei punti di forza del linguaggio IDM è appunto l'impulso a cercare una stratificazione del suono
sempre più avanguardistica e sofisticata. L'idea di com-
primere tutta la varietà timbrica di questi mondi sonori
in un patchwork di natura squisitamente estetica non
rende giustizia alla scrittura e alla composizione delle
tracce. Ci piacerebbe sentire Echolocations in chiave hifi. Chissà se sarebbe un passo avanti o un passo indietro? Per la musica tutta o solo per Matt Cutler?
(6.8/10)
Dario Moroldo
Love Inks - E.S.P. (Hell Yes!, Maggio 2011)
Genere: Indie
Freschi di esordio sull'italiana Hell, Yes!, i texani Love
Inks propongono una ricetta in cui l'indie-pop degli
anni 00 si mescola con le ultime seduzioni glo. In quasi
ogni traccia il gioco di paragoni si spreca. La Sera in alta
fedeltà (Blackeye)? Dum Dum Girls un po' meno sporche e ridotte all'osso (Too Wild, Rock On)? Beach House
sottovoce (Leather Glove)? Xx con l'acceleratore (Skeleton Key)? L'accostamento con questi ultimi potrebbe
sembrare il più azzardato in termini di contesto e profilo, siccome i Love Inks non hanno certamente niente a
che fare con certe atmosfere notturno-metropolitane;
eppure la somiglianza è forte in termini attitudinali, considerando l'approccio estremamente misurato,
nonchè il fatto di utilizzare poche note dritte al punto.
Laddove però la premiata coppia Jamie & Romy farciva
il proprio esordio di melodie già importanti, qui quel
tipo di impatto sembra tenuto a freno: è vero che tutto
sembra messo al servizio della canzone, quasi a cercare estensioni verso platee numerose, ma se è davvero
questo l'obiettivo ci sono delle carte che potevano essere giocate meglio. Un crescendo come quello su cui
culmina la bella Can't Be Wrong, ad esempio, avrebbe
dovuto sfociare in qualcosa, non spegnersi sul più bello. E anche altrove si riscontra quella sensazione un po'
fastidiosa di qualcuno che prova, vorrebbe e avrebbe
anche i numeri, eppure non colpisce quando è il momento.
Per l'ascoltatore disinteressato a certe dinamiche, E.S.P.
rimane comunque un buon disco: non un lavoro decisivo ma già promettente, reso ancora migliore dalle intriganti pieghe vocali della brava Sherry LeBlanc, timbro
tutt'altro che caratteristico ma competenza rara nell'utilizzarlo. Forse ancora troppo 'di genere', e per giunta
di un genere inflazionato: ma, in quel genere, un'uscita
di discreto valore.
(6.9/10)
Simone Madrau
61
Mark McGuire - A Young Person’s Guide
(Editions Mego, Aprile 2011)
Genere: chitarrismo emeralds
A Young Person’s Guide, ovvero il Mark McGuire pensiero spiegato ai poveri di spirito. In realtà, sarebbe più
giusto dire “ai distratti”, visto che questo doppio album
compila tracce sparse dal chitarrista degli Emeralds
nella sua elefantiaca produzione in solo. Per lo più cd-r
e cassette in tirature limitatissime e edizioni casalinghe
affidate alla propria Wagon, alla Pizza Night o ad altre
micro-label sparse per il mondo in cui McGuire ha affinato quell’arte chitarristica che ha visto, nel recente
Living With Yourself su Mego, il suo picco più alto.
Collezionate qui trovate insomma le tracce sparpagliate (e sparigliate) della weltanschauung del giovane
chitarrista: l’ala più elettrica e quella acustica (l’estatica reiterazione di Radio Flyer o la malinconica Icy Windows), il versante più droning oriented (Dream Team) e
quello intimista e personale. Non sarà dunque difficile
rintracciare lo spirito kosmische, certe tendenze alla
stratificazione o quella sottile vena di malinconia tipiche della discografia della casa madre. Ma soprattutto
si avrà modo di osservare da vicino il chitarrismo - magari non così originale, ma indubbiamente riconoscibile al primo ascolto - del prolifico McGuire, spesso intento a giocare di sponda con loops e layering. A Young
Person’s Guide finisce dunque con l’essere non solo una
introduzione per i neofiti, quanto un condensato - ottimamente selezionato da mr. Mego Peter Rehberg - capace di intrigare i fan della prima ora.
(7/10)
Stefano Pifferi
Massimiliano Pagliara - Focus For
Infinity (Live At Robert Johnson, Maggio
2011)
Genere: cosmic disco 80
Torna di prepotenza la cosmic italo nell’esordio di Pagliara, ragazzo pugliese con un passato da coreografo a Milano, emigrato ormai da molti anni a Berlino. Qui ha iniziato
a fare il DJ nei localini per poi passare ai club più blasonati.
Ha poi stretto una connessione con cricca Discodromo,
l’act formato da Giacomo Garavelloni e Giovanni Turco,
che promuove il suono progressivo al Berghain al party
Cocktail d’Amore e viaggia da poco sulla label di Prins
Thomas (altro nume prog contemporaneo).
Dopo l’esordio sulla Balihu Records dell’amico Daniel
Wang (Transmissions Florales è del 2008), qualche altro
singolo su Rush Hour, Needwant e Meakusma - con
Alessandro Tartari e Jules Etienne, nel gruppo synth-pop
[sic!] -, Massimiliano remixa pezzi di Hard Ton, Mock &
62
Toof e altri personaggi. Nel 2009 il nostro approda finalmente con il mini Toxic Love su Live At Robert Johnson.
Tripudio di ricordi Ottanta, romanticismo, tastierine vintage e slow-motion. Questi gli ingredienti che rimangono anche su questo nuovo Focus For Infinity.
Se del ritorno del progressive si era già detto molto con
la bomba del 2008 di Lindstrøm Where You Go I Go To,
oggi con personaggi come Bjørn Torske assistiamo ad
un ripescaggio ulteriore del passato remoto di Daniele
Baldelli, nume tutelare di generazioni di DJ e dancers,
che nei Settanta ha fondato la sua estetica sempre e comunque attualizzabile. Nel full di Pagliara ci si riattacca a questa tradizione e si ripescano i suoni chic pure
disco’ (Feel So Real), bassi in stomp moroderiani (After),
slo-mo loungey nordica tagliata con vocioni pseudoblack (I’ll Never Be), tensioni che richiamano la località
di provenienza (senti Berlino e il motorico nell’intro
squadrata di As The Night Breathes) e che virano verso
lidi donnasumeriani per chiudere in punte techno-glo
in ricordo nerdy 8-bit (In Order Of more Depth).
Un disco d’esordio importante per un ragazzo che
vuole (e riesce) a far sentire la sua voce da una delle
etichette più interessanti degli ultimi mesi. Più di un’ora che si assesta su un sound storicizzato, ma non per
questo privo di vita. Da qui Pagliara può decollare con
una navicella verso pianeti lontani. Speriamo che non
bruci subito tutto il carburante.
(7.1/10)
Marco Braggion
Michele Bombatomica - The Crooked Debut
Of... (Tannen , Maggio 2011)
Genere: folk blues
Ad ascoltarlo mi viene in mente un'immagine truculenta, tipo un frontale tra due furgoni guidati da Pogues
e Vinicio Capossela. Tra le vittime ahinoi anche molti
passeggeri, più o meno tumefatti e riconoscibili quali
Gun Club, Black Heart Procession, Calexico, Goran
Bregovic, Noir Desìr, Micah P. Hinson, più altra fauna di frontiera in corso d'identificazione. Nella realtà,
il responsabile del misfatto è tale Michele Darrel Bertoldi, altrimenti noto come Michele Bombatomica,
autore di scorribande smaniose a capo della Cheap
Orchestra, ovvero quattro facinorosi che lo spalleggiano brandendo tromba e fisarmonica, chitarre aspre e
contrabbasso, lap steel e flauto, organo e basso tuba.
La miscela è impetuosa e ubriacante com un vin brulé
corretto al cherosene, prima un bailamme trafelato
nella gola poi nel corpo un languore febbrile. La scaletta si compie tra carrellate da road movie col morto
(Shot You Down), palpitazioni lisergiche (Flower Song
highlight
Kuniyuki Takahashi - Dancing In The Naked City (Mule Musiq, Aprile 2011)
Genere: Deep, jazz
Sound designer e producer di stanza a Sapporo, in Giappone, Kuniyuki Takahashi professa i verbi deep
e future jazz da più di dieci anni. Attivo discograficamente su Mule Musiq dal 2002, dove ha pubblicato
anche il qui presente Dancing In The Naked City, si è fatto apprezzare per
una jazz-latin house morbida e avvolgente che trova nei fasti del Paradise
Garage le sue radici ideali. Larry Heard, Ian Obrien, Dj Cosmo, Dego dei 4
Hero ma soprattutto guru della grande mela come Joe Claussell e idoli
internazionali come François Kevorkian lo hanno tenuto d'occhio fin dai
primi Duemila e, assieme a loro, anche nuove leve deep hanno dimostrato interesse nelle sue svariate produzioni a nome Koss. Tra loro troviamo
Henrik Schwarz, vocal guest dal precedente Walking In The Naked City trasformato oggi cambiando l’incipit in Dancing e consegnando al pubblico un remake che valorizza i
punti di forza del precedente.
Takahashi non stravolge la jazz House organica delle tracce originali, ma ne approfondisce gli aspetti
deep e dub senza dimenticare il feeling live. I flauti andini à la Future Sound Of London perfettamente
innestati nei bassi di Night Forest, la latin house jam Come With Us ma soprattutto l'altro grande discorso
dub che è Set Me Free potrebbero già bastare come testimonianze del percorso finora svolto dal produer; in aggiunta c'è il lato propriamente black con le lezioni di Herbie Hancock (il lato piano bar newyorchese tributato nel mix di piano, chitarra, e singing di Schwarz in Once Again) e soprattutto Miles
Davis (le percussioni live afro e la calda tromba di Flying Music) a innestarsi perfettamente in un'idea di
viaggio ritmico composto ma non per questo incapace di immergere e coinvolgere, anzi.
Dancing In The Naked City è più di un remix album: è il miglior biglietto da visita di un producer generoso, capace inoltre di suonarti una seducente song in remember 90s con vocal molto Everything But
the Girl (Kristiina Tuomi in Deliverance), angolarti IDM-jazz e spalmarti Knuckles (Storm) con l'ambient,
la deep con i Liquid Liquid visti da dentro un acquario (Bamboo City).
Un grande producer che merita tutta l'attenzione del mondo, specie in questo periodo di rallentamenti
e sguardi latini (Nicolas Jaar).
(7.3/10)
Edoardo Bridda
For Barefoot Dancers), marcette nevrasteniche (Nonsense Song To Sing Along), trepidazione da mariachi in acido (Never Return), cha cha cha da guitti letterari (Liar) e
valzer da bettola triste (Bar). Nulla di nuovo sotto questo sole tendente al grigio, nessun lampo inaudito che
spezzi la monotonia dell'orizzonte, ma una commedia
dark recitata fino all'ultima stilla di sudore, aggrappandosi alla linea di confine tra stereotipo e vita, dove la
finzione (musica, cinema, letteratura, di nuovo musica)
è innanzitutto una verità mascherata.
Nel caso in questione, tra crederci e non crederci val
bene concedere il beneficio del dubbio. Te ne viene in
cambio un ascolto appagante.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Minio Indelebile - Minio Indelebile
(Autoprodotto, Aprile 2011)
Genere: crossover 90s
“Suono e attitudine a torso nudo”, dicono in sede di
presentazione. Ma anche, aggiungiamo noi, un passatismo che colpisce emotivamente chi quegli anni li
ha vissuti in prima persona. Quali anni? Beh, quelli del
boom della musica alternativa e del crossover di stili: i
primi anni ’90, insomma. Proprio quelli in cui i Minio Indelebile mossero i primi passi e di cui portano le stimmate sanguinanti a tutt’oggi.
Tra suoni hard, commistioni tra generi, cantato enfatico
e sopra le righe, crossover energico e impatto frontale
tra il socio-politico e l’esistenzialismo, Minio Indelebile
porta con sé tutti i cliché dell’epoca e tutta la polvere
63
che nel frattempo vi si è posata sopra, senza riuscire
a smarcarsi da una forma mentis troppo retrò. Certo,
il fatto che alcune delle composizioni risalgano al periodo dello scioglimento (1995, un’era geologica fa in
fatto di musica) aiuta a comprendere di più le musiche
del quartetto (Max "Delpo" Del Pozzo, Beppe Facchetti, Luca Vanenti e Roberto Fenaroli), ma non ad alzare
l’asticella.
(5/10)
Stefano Pifferi
Moon Duo - Mazes (Souterrain
Transmissions, Marzo 2011)
Genere: Kraut Pop
Secondo full-length per il duo composto da Ripley
Johnson dei Wooden Shjips e Sanae Yamada, questa
volta per Souterrain Transmissions in Europa e Sacred
Bones negli States. Chi si aspettava una mera replica
del debutto Escape (uscito su Woodsist esattamente
un anno fa) avrà qui di che ricredersi e rimanere stranito.
Se l’opener Seer sembra vergata dal Kurt Vile più lisergico, il giro surf della title-track chiarisce subito come
Mazes intenda indagare una nuova declinazione
dell’astrattismo sonoro della coppia di San Francisco.
Impressione che viene confermata dai riff grattugiati
in stile Monks/Trio di Run Around, In The Sun e Goners
che sembrano sottratti alla più minimalista delle garage band dei ’60 o - meglio ancora - degli ’80 e su cui i
nostri applicano nuovamente il tappeto di divagazioni
psych/kraut di scuola Neu!/Spacemen 3 che li ha caratterizzati fin dai primi EP.
Un album più solare dunque, più diretto e in ultima
analisi più pop/rock, in cui il Duo tenta, con successo, di
svecchiare le influenze più sperimentali in favore di un
garage-surf psichedelico. Scelta che, se lascerà basiti i
fan più integralisti del cosmic sound, farà breccia nella
voglia di estate del pubblico indie che non mancherà
di presenziare alle imminenti date del tour europeo.
(7/10)
Andrea Napoli
Nada - Vamp (Edel, Marzo 2011)
Genere: italiana, pop
Se hai esordito a Sanremo, nel 1969, quindicenne, e a
distanza di esattamente quarantadue anni te ne esci
con un nuovo disco, i casi sono due: o sei molto libera,
o non la sei affatto. Nada Malanima, per noi tutti semplicemente Nada, risponde al primo caso. Se c'è una
cosa che la splendida cantautrice livornese non ha mai
fatto è presentarsi al pubblico con qualcosa di costret64
to, non del tutto desiderato, amato.
Vamp, uscito il 28 marzo a distanza di quattro anni dal
precedente Luna in piena, porta con sé tutte le novità
e le esigenze del caso. Interamente scritto da Nada, il
disco è stato mixato negli storici studi di Abbey road
a Londra avvalendosi del prezioso aiuto, in fase produttiva, di Manu "Max Stiner" Fusaroli, famoso per aver
messo mano agli album di esordio de Il teatro degli
orrori e Le luci della centrale elettrica. Il risultato è
un lavoro curioso, vario, ricco di stratificazione sonora,
dal pop all'elettronica, e capace di guardare ad esempi
più nuovi che datati. Lele Battista risuona tra le note
di Raccogliti e in generale questo disco pare essere l'evoluzione del ramo cantautorale di alcune produzioni
elettropoprock 90s, vedi i Bluvertigo e, ancor di più,
il Battiato di Gommalacca (Chiodi). Al disco partecipano Appino e Karim Qqro degli Zen Circus, ai quali
Nada aveva prestato la voce per Vuoti a perdere in Andate tutti affanculo, anch'esso prodotto da Manu Fusaroli. Non mancanco altre collaborazioni, come quella
riuscitissima con Fabiano Marcucci, Ludovica Valori e
Marco Gasbarro degli eccezionali Ardecore.
Vamp è un album di qualità eccellente dovuta non solo
a una produzione impeccabile ma alla scrittura di un'autrice ancora ricca di guizzi, idee, intuizioni mai banalizzanti. La varietà del suono è sorprendente, la riuscita dei
brani, se non totale, è sicuramente molto ampia. Pezzi
come Il comandante perfetto, assai politicizzato, o la
splendida Sarebbe una serenata, sono vere perle e Nada
non smette di ricordarci che sobrietà e attenzione alla
sostanza portano sempre a ottimi risultati.
(7/10)
Giulia Cavaliere
Okkervil River - I Am Very Far
(Jagjaguwar, Maggio 2011)
Genere: Indie-Rock
Ci sono gruppi che con i cambiamenti e le svolte costruiscono carriere, altri invece che sarebbe meglio non
cambiassero mai, tanta è genuina e vincente la loro
proposta. Gli Okkervil River fanno parte di quest'ultima schiera: e se mai ci fossero stati dubbi, questo I Am
Very Far chiarisce in maniera inequivocabile. Ma lo fa
nella maniera peggiore, ovvero provando inutilmente
ad arricchire quello scarno amalgama di indie-rock e
folk urlato che aveva procurato al gruppo molte attenzioni nella prima metà dei 00s.
Non si tratta di uno snaturamento radicale e, del resto,
già nel precedente The Stand Ins, si avvertiva questa
voglia di riempire i vuoti della loro musica; qui però
siamo oltre, quasi che tutta la pienezza di suoni e ar-
rangiamenti espressa equivalesse a una sorta di consacrazione, una sorta di proclama "mondo, consideraci!".
Ci sono già degli Wilco in giro, e un disco (quello sì)
di svolta come Yankee Hotel Foxtrot gli Okkervil non lo
possono bissare e nemmeno raggiungere.
In I Am Very Far non mancano alcune buone canzoni
(Show Yourself, l'apertura corale e promettente di The
Valley), ma è indubbio che l'arricchimento si trasforma
troppo spesso in episodi tronfi e pomposi (Wake And
Be Fine) o in brani (Mermaid) che funzionano davvero
soltanto in detonazione.
Avrebbero dovuto incidere un disco semplice come sapevano fare, con la voce in primo piano, la chitarra, e
l'ukulele, come facevano - e bene - ai tempi di Don't Fall
In Love With Everyone You See. Un autentico passo falso.
(5.7/10)
Simone Madrau
Old Calf - Borrowed A Horse (No Quarter,
Aprile 2011)
Genere: americana
Bel problema avere dei fratelli “titolati”, ma non ditelo
a Dave Davies né a Ned Oldham. Col cognome che si
ritrova e il fatto di aver accompagnato il più bravo Will,
costui può dirsi comunque soddisfatto della propria
carriera. Sinora alle prese con i discreti Anomoanon,
si imbarca in una nuova formazione col fisarmonicista
Marty Metcalfe per offrire - da un garage della Virginia, aiutato da tali Michael Clem (basso, mandolino) e
Brian Caputo (percussioni) - una trama di folk e bluegrass antica ma non troppo.
Già sentito, eh? Eppure fareste bene a mettere da parte
scetticismo e supponenza, poiché questo artigianato
fiero e ricco di feeling funziona eccome. Preso atto che
il timbro vocale è simile a quello del Principino Billy e
nulla vi si può fare, apprezzi che i versi siano tratti da
fonti popolari e siano un guardare nel passato per
cavarne il sostegno all’oggi. Più che eloquenti Bonny
Cuckoo (versione britannica del semiomonimo, noto
traditional) e la Henry Was A Worthy King che guardano - rispettivamente, tramite le sorelle Dolly e Shirley Collins e i Fairport Covention - alle radici del folk
albionico e il commovente valzer d’Irlanda Follow My
Bangalorey Man.
Laddove a distillare americana pura ci pensano il caracollare country di Stool-ball e il Neil Young di A Gift, A
Ghost/Monday Alone, la traslucida When I Was Taken e
l’afflato alla John Wesley Harding di I Saw A Peacock With
A Fiery Tale. Autentici lampi di genio, infine, le venature
psichedeliche delle splendide Far From Home - non a
caso, l’assolo è dell’ospite Dave Heumann, ovvero Ar-
bouretum - e What Did I Dream, così come i cambi di
passo in There Are Men In The Village Of Erith. Ci ripensi e
tutto quadra, siccome buon sangue non mente.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Oracles (The) - Have A Nice Trip (Nexus,
Aprile 2011)
Genere: rock'n'roll
Una mezzora giù a rotta di collo tra garage-rock e
brit-sound, grunge e rock’n’roll dei primordi: questo il
mega-trip affidato dagli Oracles al proprio album di debutto. Ampli al rosso, voce ruvida ed eclettica il giusto,
passaggi strumentali in grado di oscillare in tutta tranquillità dall’accessibilità dei primi Oasis alle ruvidezze
pre-grunge alla Mudhoney, oscillando indietro nel
tempo fino a Yardbirds da una parte e Kinks e compagnia danzante dall’altra, così come riattualizzando il
sound Sub Pop - misto melodia vocale e rumore chitarristico sporco ma non troppo - senza scadere nel revival puro e duro.
The Lior Kneazir alla voce, Federico Mengoz e Antonio Uras alle chitarre, Marco Sacilotto al basso e Paolo
Calderan dietro le pelli mostrano passione e capacità di coinvolgimento oltre che una innegabile abilità
tecnica e una voglia di rock che trasuda da ogni nota.
Ne esce un percorso, il trip del titolo, nella tradizione
rock-rumorosa cui si sono formati i cinque friulani, ma
che non riesce ad eludere i vari cliché di genere e a far
scivolare nel dejà-vu sonoro. Un pizzico di personalità
in più avrebbe aiutato.
(6/10)
Stefano Pifferi
Orange (ITA) - Rock Your Moccasins (Gpees
Productions, Marzo 2011)
Genere: rock
Personalmente non ho mai apprezzato le comparsate
del “nongio” Francesco Mandelli su MTV né l'immaginario da loser à la page che da sempre propaganda.
Una professionalità giocata tutta su una comicità triviale e ammiccante, fantozziana ma in fondo immanicata, evidentemente tagliata su certe fasce di pubblico
giovanili ben ricettive. A sua parziale discolpa, il fatto
che il popolare network musicale per cui lavora certe
scelte di immagine le ha spesso accondiscese, se non
auspicate. Oltre alla probabile consapevolezza di non
poter/voler aspirare a un “concettualismo” sul modello
di un Massimo Coppola.
Detto questo è anche vero che nel caso di Francesco
Mandelli televisione e musica suonata sembrano esse65
highlight
Leisure Society (The) - Into the Murky Water (Full Time Hobby, Maggio 2011)
Genere: Folk pop orchestrale
Che roba, quei Mumford & Sons. Ragazzotti più inglesi che mai che riescono a conquistare critica e
pubblico di mezzo mondo imbastendo quella che sostanzialmente è una mascherata, ovvero camuffandosi - benissimo - da folkster yankee. Segno dei tempi, certo, ma
c’è un’altra via. C’è un modo in cui
in UK oggi si può suonare folk genuinamente - ovvero mantenendo le proprie radici, inserendosi peraltro in una più che nobile discendenza pop che parte dalle vignette dei Kinks e arriva dritta alle meraviglie orchestrali targate Divine Comedy. Chi
ha sentito il debutto targato The Leisure Society, The Sleeper (“un piccolo
miracolo di equilibrio e intensità”, nelle parole del nostro Stefano Solventi),
sa di cosa stiamo parlando; non a caso è stato oggetto di un culto crescente in patria, con il patrocinio di fan d’eccezione come Elbow e Brian Eno
e le nomination all’Ivor Novello Award per il songwriter Nick Hemming. A
sentirne il seguito, Into The Murky Water, verrebbe da dire che il sestetto di
Brighton è riuscito persino a superarsi: il tiro di arrangiamenti e di scrittura
si alza vistosamente, ma tutto suona tanto naturale e immediato che quasi non ci si accorge di quanta
ambizione ci sia in questo lavoro. È d’altronde questa la classe autentica, no?
Provate pure a farvi un giro dalle parti delle evoluzioni melodiche e emotive di The Hungry Years, degli inserti classici di I Shall Forever Remain An Amateur, o della giga festosa This Phantom Life, o ancora
dell’ariosità della title track - ma invero ogni traccia fa storia a sé - e capirete di cosa stiamo parlando:
un’architettura sonora complessa eppur lievissima, al servizio di una penna (e di una voce) felice almeno tanto quanto quella della recente rivelazione Villagers, in una varietà di stili e di toni in grado di
soddisfare un po’ tutti i palati. Se la vivacità, l’ironia e la profondità rimandano inevitabilmente ai citati
Ray Davies e Neil Hannon, per versatilità, gusto ed efficienza vengono in mente macchine perfette
come Belle And Sebastian, New Pornographers e Delgados; ma il combo di Hemmings e Christian
Hardy ha tutte le carte in regola per scrivere nuove, eccellenti pagine di quel bel libro iniziato tanti,
tanti anni fa. Senza necessità di buttar l’occhio sui quaderni dei compagni d’oltreoceano. Vi pare poco?
(7.3/10)
Antonio Puglia
re due dimensioni separate e ingiusto sarebbe deprecare l'una soltanto per i (plausibili) torti dell'altra. Anche perché dal secondo disco degli Orange, progetto
che il chitarrista/cantante condivide con il batterista
Enrico Buttafuoco, emerge quantomeno un passato
di ascolti attenti e da onesti cultori. Sintetizzato da una
musica che ben rielabora - anche se in maniera fin troppo fedele - la lezione di Kills, White Stripes, Strokes,
Libertines, Stooges, replicando più o meno il rock spigoloso che caratterizzava già l'esordio Certosa.
Coolness di riflesso e immaginario sopra a tutto, insomma, ma anche un pugno di brani meno scontati di quel
che si sarebbe potuto pensare. Volutamente lontani da
quel brand televisivo discutibile ma potenzialmente
fruttuoso e inseriti in un progetto autarchico che ha
tutto l'aspetto di un sentito omaggio ai pronipoti e ai
66
padri del rock.
Di più non è lecito attendersi.
(6/10)
Fabrizio Zampighi
Orange Lem - David Is A Narcoleptic Man
(Bulbartworks, Febbraio 2011)
Genere: wave pop
I testi degli Orange Lem pullulano di riferimenti a registi (Fellini, David Lynch), attori (Mastroianni), scrittori
(Jonathan Coe), artisti come Andy Warhol e fenomeni
sospesi tra costume e Storia come Jackie Kennedy. Pesi
massimi insomma dell'immaginario collettivo trattati
con la leggerezza delle fantasie da cameretta, come
modelli di ipotetiche prospettive tramate nella cerchia
degli amici più fidati. Un metodo preso in prestito -
diciamo così - ai primi Belle And Sebastian, simile il
senso di dimensione precaria però illuminata, come se
nell'epoca delle comunicazione pervadente la periferia rappresentasse un punto di vista sempre più raro e
quindi prezioso.
Questo è a spanne lo sfondo poetico sul quale opera il
linguaggio del quartetto pesarese, indie-wave piuttosto nostalgica e sbilanciata british, polpa frugale ravvisabile attraverso le evidenti propensioni sintetiche
che li portano ad omaggiare i Visage (di cui rileggono
con sagace morbidezza Fade To Grey) e più in filigrana
Giorgio Moroder (nella conclusiva Cinematronics). La
loro non è una proposta eclatante, del resto neanche
sembrano interessati a stupirci con dispositivi sonici
inauditi. Tuttavia, con quella pronuncia un po' scolastica, con le congetture abbastanza prevedibili degli arrangiamenti, con quell'applicarsi puntuale alla luce di
un disarmante contro-virtuosismo, si dimostrano capaci di snocciolare canzoni ben scritte, piantate su solide
fondamenta e ravvivate da intuizioni non trascendentali ma sempre opportune. Vedi su tutte il pop-wave
screziato psych di The House Of Sleep (ugge The Sound
e intrighi Stranglers), le palpitazioni di Toast To A Butterfly (da qualche parte tra Chameleons e Notwist) o
ancora i Wire allampanati Xtc di Geometric Woman.
Come esordio è davvero niente male. Quanto ai colpi
di genio, restiamo sintonizzati.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Paolo Spaccamonti - Buone Notizie (Bosco
Rec, Aprile 2011)
Genere: cinematic
Ancor più intimista e criptico, Paolo Spaccamonti, sin
dall’artwork. Buone Notizie riprende il discorso ben avviato da Undici Pezzi Facili due anni fa e gioca di sponde
ironiche tra titolo e copertina all black per addensare
ancor più nero sulle atmosfere cinematiche oscure ed
evocative che il chitarrista torinese dimostra di gestire con sapiente abilità. Lo stuolo di preziosi guest la
dice lunga sulla credibilità di Spaccamonti - l’uomo dal
cognome più “dronico” del mondo, secondo il Twitter
della Temporary Residence - così come dell’ampio
spettro di sfaccettature in cui l’animo dell’autore riesce
a riverberarsi nello spazio di un solo disco: Julia Kent
e Fabrizio Modonese Palumbo (Larsen, Blind Cave
Salamander) come testimonianza del retroterra sperimentale e darkish; Daniele Brusaschetto a sottolineare la forza della ricerca in solo e di un cantautorato off
che qui addirittura fa a meno delle parole; Ezra (Casino Royale, No.Mad) e Davide Compagnoni (Stearica,
Namb) come legame con una città, Torino, musicalmente unica sul panorama italiano.
Questi sono soltanto alcuni tra i tanti artisti e amici che
aggiungono qualcosa alle composizioni originali di
Spaccamonti. Perché, sia chiaro, questo è totalmente
un disco del torinese, la cui creatività smuove montagne a colpi di decadente solipsismo post-romanticismo (Buone Notizie, L’Ultimo Vestito Non Ha Tasche) o
avant-blues dal beat possente e ipnotico (Guitar Heroin), post-rock jazzato (Tartarughe, Niente Per Bocca),
accese lande desert-jazz-rock (Claude) o soundtrack
music evocativa e algida (Ossamiche) o trasognata e
soffice (Specchi).
Non è il particolare, comunque, a fare la differenza. A
restare impressa, ancor più che in Undici Pezzi Facili, è
la netta e contrastante creatività di Spaccamonti, compositore insieme umorale e visionario, melanconico e
anticonvenzionale, narrativo e strumentale.
(7.3/10)
Stefano Pifferi
Paul Simon - So Beautiful Or So What
(Concord, Aprile 2011)
Genere: folk pop
Tra i reduci dei sixties ancora in attività, il quasi settantenne Paul Simon è forse quello invecchiato meglio.
Lascia quasi increduli infatti la freschezza di questo
So Beautiful Or So Wath, dodicesimo album del piccolo grande cantautore del New Jersey, ad un lustro
dal buon Surprise e in attesa che le corde vocali del
sempiterno compagno di palcoscenico Art Garfunkel
tornino in forma per riavviare l'Old Friends Tour. Dieci pezzi per poco meno di quaranta minuti nei quali il
consueto mix di perizia, dinamismo e sensibilità sboccia con rinnovata immediatezza. Non è difficile prestar
fede a quanto dichiarato dallo stesso Simon, d'aver
cioè ripreso gusto a comporre sulla chitarra, mettendoci più cuore e meno raziocinio.
Non per questo viene meno quel senso di dominio assoluto sulla materia, evidente tanto nei risoluti struggimenti (la pensosa Questions For The Angels, la delicatezza indolenzita di Love And Hard Times, in entrambe
vaghi retrogusti Paul McCartney) quanto nei vividi
sussulti (le vibrazioni errebì della title track e della tirata Love Is Eternal Sacred Light). Il bello anzi il cuore
della cosa sta però nella levigata ricchezza degli arrangiamenti, concepiti con la complicità dell'antico collaboratore Phil Ramone e sapientemente aspersi d'elettronica grazie alla supervisione di Chris Bear (batterista
dei Grizzly Bear). Ogni traccia è come un bassorilievo
da indagare attraverso "sguardi" successivi, manufatti
67
che diresti tanto artigianali quanto sintetici ottenuti
stratificando particelle bluegrass, doo wop, folk, gospel e world.
Se spesso si finisce col pensare al capolavoro Graceland (si prendano le fragranti pulsazioni di The Afterlife
e le aromatiche nuances di Dazzing Blue), è vero però
che gli africanismi non oltrepassano la soglia di una
suggestione - per così dire - organica, come l'impronta
di un dialetto metabolizzato che ormai fa parte dell'intercalare e che caratterizza l'invenzione sonora anche
quando sembra guardare altrove (l'oriente flamencato
di Rewrite, le amniotiche freakerie appalachi di Love
And Blessings, il folk-rock radiante dell'iniziale Getting
Ready For Christmas Day). Davvero una bella raccolta,
assieme malinconica e suadente, lirica e festosa. Ad
avercene di dischi senili di tal fatta.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Peluqueria Hernandez - Amaresque
(Audiar, Marzo 2011)
Genere: jazz-blues-mex
Sembra di vederli quelli della Peluqueria, sganasciarsi
dalle risate mentre noi poveri scribacchini ci si inventa un termine per descrivere la loro musica. E di fantasia ce ne vuole, visto che da che mondo è mondo i
Nostri mescolano stili e maniere con una semplicità
disarmante. Prendete ad esempio una Katunga in cui
il Duke Ellington più afro si fa adottare da Quentin
Tarantino o una Cuoraccione di Melone rubata alle balere caposseliane, una O' Mariaccio Nnammurato tra
Messico e Ry Cooder o una Procopio che abbraccia il
post-rock. Immaginari malinconici che si intersecano,
sagre paesane e cover sudamericane (una La Martiniana di Andrès Henestrosa solcata da un sax da liscio e a
cui partecipa Umberto Palazzo) che convivono, valzer
e frontiera che vanno amabilmente a braccetto. In un
suono naturale, immediato, quasi istintivo.
Il secondo disco del gruppo veronese ha indirettamente lo stesso spessore che poteva avere l'opera prima
degli Ardecore. Quel dividersi tra dimensione popolare
- qui ribadita anche dal dialetto della Valnure declamato da Lilith in X o Dos / Struggente Dream, oltre che dai
vari riferimenti musicali - e trame raffinatissime che finisce per mostrare la pregnanza semantica ed emotiva
del blues.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
68
Pierre LX - Out 1 (Initial Cuts, Aprile 2011)
Genere: deep, UK bass
La nuova realtà emergente da quel ribollire perpetuo
della scena londinese è Pierre LX, un 25enne francese cresciuto in Brasile e stabilitosi nel Regno Unito nel
2003. Un'impegnata gavetta dietro i piatti, un paio di
release con l'etichetta francese Initial Cuts, e poi un
seguito sempre più corposo fino ad arrivare al Fabric,
dove oggi è resident dj. E da dove oggi si propone nei
panni di artista a tutto tondo, nella consueta prova cruciale del primo album in studio.
Out1 apre non a caso con la techno-ambient di Winter
Light, apertamente ispirata al primo Matias Aguayo,
che Pierre indica come una tappa decisiva del suo percorso artistico. Ma è solo una parentesi: l'eleganza del
disco sta nell'inserirsi nel continuum UK bass senza
sprofondarci del tutto, rivisitandolo con uno spirito costruttivo di matrice detroitiana che tende ad arricchire il
risultato con ritmiche multistrato e inserti classic electro.
L'aria che si respira non è tenebrosa o cupa (effetto che
da tempo si tende ad allontanare) ma golosamente
deep. Se da un lato brani come Gerry o L.A. Dreams si
tengono con una certa aristocrazia lontani dalle piste
e fedeli ad un rigore dub, dall'altro non mancano momenti dall'appeal tipicamente house, ora più raffinato
(Quadrivium farà fischiare le orecchie a John Roberts,
anche per le affinità nel percorso personale), ora più
decisamente dance (Olympia accede alla hall via Sei
A). Il quadro offerto da Pierre LX svaria con destrezza
lungo l'intero spettro di stili britannico, sfoggiando sicurezza e completezza artistica. Doveroso lasciarli crescere in libertà, sia il disco che l'autore.
(6.9/10)
Carlo Affatigato
Planningtorock - W (DFA, Maggio 2011)
Genere: elettro opera
Janine Roston, già collaboratrice dei The Knife e artefice in proprio di uno strambo quanto complicato mix
tra opera multimediale e artrock sperimentale produce
per DFA il secondo disco come Planningtorock aggiornando opportunamente la formula coniata all’altezza
del debutto per Chicks On Speeds con il disco del 2006,
Have It All. Il senso di operazioni come questa lascia
sempre leggermente interdetti se posti esclusivamente di fronte alle tracce musicali. E’ fin troppo ovvio e si
avverte ovunque in un lavoro come W che il supporto
dello spettacolo multimediale non è un corredo cosmetico, ma gran parte della sostanza.
La proposta della Roston costruita su forme macchiettistiche, bizzarre e contorte, a suon di acquerelli pop
highlight
Meat Puppets - Lollipop (Megaforce, Marzo 2011)
Genere: new-roots
Sono persone come i fratelli Kirkwood a rendere ancora degno scrivere di musica, e ancor prima ascoltarla come si deve e cioè dedicandole tempo, devozione e impegno. Tra gli evanescenti trend che durano una settimana, il ritorno dall’al di là di chi aveva consegnato dischi splendidi suscita un piacere che
travalica la circostanza. Di tutto e per niente bello, infatti, quanto accaduto a
Curt e Chris sino a prima del 2007: un contratto major stracciato e una sequela
di storiacce di droga e cronaca nera finalmente alle spalle.
Del resto, sono uomini come chiunque. Anzi, no: perché chi è stato capace di
capolavori come Huveos, Mirage e II fondendo hardcore punk e psichedelia, blues e folk, nella categoria
della gente comune sta stretto. Argomenti sonori che tornano nel terzo atto della rinascita - cui partecipa alla batteria Shandon Sahm, figlio del leggendario Doug: buon sangue non mente - assecondando
una vena “roots” poco più accentuata mentre penna ed esecuzione rimangono prossime all’epoca d’oro. La visionarietà anche, come spiegano il tono vocale indolente e le chitarre che scintillano lussureggianti, azzeccate stramberie come i Love indecisi tra Arabia e hard di The Way That It Are, la country-skadelica (!) Shave It, o come l’Elvis Costello oppiaceo - accompagnato da una mista Los Lobos e Grateful
Dead - di Incomplete e Baby Don’t.
Materia da applausi, come del resto quanto guarda al glorioso passato senza soccombervi e poggiando
sulla saggezza acquisita ritornando dall’inferno. Da una scaletta compatta e a lento rilascio, peschiamo
inoltre l’oriente gagliardo di Hour Of The Idiot e gli arpeggi desertici (hola! Calexico
) di Lantern, il folkrock celtico traslocato nel Mojave Town e la policroma filastrocca Amazing. Quanto basta e avanza a
rendere Lollipop pieno di idee e vita, vibrante e commovente.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
elettro s'aggiorna sul supporto di un uso più pronunciato del violino e di un elettronica più ammicante. Se per
metà disco viene in mente Laurie Anderson (Doorway,
The One, Going Wrong, The Breaks), per l’altra metà accantona le pretese artsy e si concede alla pista di ballo
con le cadenze più sostenute di ballate disco dall’umore
retrò (Manifesto, I Am Your Man, Living It Out). Il risultato
preso di per sé suona troppo freddo e intellettuale per
suscitare un interesse reale che vada oltre la forma.
Eppure basta il supporto delle immagini del video di
Doorway, dove la Roston, dismessi gli abiti elisabettiani
dell’esordio, si traveste in un novello mostro androgino
(evocato per gran parte del disco dalle metodiche interferenze sulle timbriche vocali, si vedano Milky Blu e
Jam) per dare una nuova sostanza all’insieme. Un disco
del genere andrebbe distribuito su supporto dvd con
corredo di apparato visuale, mentre Planningtorock si
conferma un’esperienza da vivere soprattutto dal vivo,
piuttosto che su disco.
(7/10)
Antonello Comunale
Polar For The Masses - Silence (Black
Nutria, Marzo 2011)
Genere: wave
Siamo già al terzo lavoro per i Polar For The Masses, e
già i precedenti Let Be Me Here e Blended (licenziati
quattro e due anni fa) ci avevano fatto valutare positivamente il peso specifico di questo trio vicentino. Che
nel qui presente Silence dà fondo e forma all'attitudine chitarristica in bilico tra piglio wave e fregola post
punk, tipo un'irrequietezza robotica Wire a sparagliare impeto P.I.L. (Dismembered), lasciandosi margine di
manovra per copule punk-funk variamente devolute
(Ignorance, The Last Man), struggimenti grunge-noise
(una Sailing Away che sta nel guado tra Mark Lanegan
e i R.E.M. di Monster) e rigurgiti d'emotività accesa
non distante dai primi Radiohead (Guilty sembra un
po' la nipotina facinorosa di Ripcord).
Ma la caratteristica comune alle otto tracce è l'accattivante semplicità della scrittura, quasi a voler perseguire un'idea pop sì mutante ma pur sempre empatica,
come una radio che irradia vibrazioni carezzevoli per
69
lenire il delizioso disastro quotidiano, forse per questo
finendo un po' col rammentare il teatrino sardonico degli U2 tra Zooropa e Pop (Consequences). Disco conciso (poco più di mezz'ora) ma tenace, che compensa un
eccesso di devozione per i modelli di riferimento con
la disinvoltura di chi ha ben metabolizzato la lezione.
Non a caso pare che dal vivo ci sappiano fare parecchio
(il circuito Keep On li ha indicati tra i dieci migliori live
act dello scorso marzo). Ergo: tenerli d'occhio.
(7/10)
Stefano Solventi
Pollyester - Earthly Powers (Permanent
Vacation, Maggio 2011)
Genere: Nu-disco, krautrock
Il primo album in studio è l'occasione per farsi un'idea
più chiara di quale direzione stia puntando la "strana
coppia" Pollyester. Negli EP prodotti prima di Earthly
Powers, i coniugi Polly e Yossarian hanno toccato new
wave, krautrock ed electro con un carattere d'avanguardia che gli era valso l'accostamento ai Can e alla
no-wave newyorkese. Un quadro ribelle e fuori da ogni
schema, che lasciava intendere una naturale evoluzione verso soluzioni possibilmente più semplici.
Eppure, invece che rilassarsi, i due rendono le cose ancora più complicate. Lo stile è se possibile ancora più
sghembo di prima, e a quanto già detto aggiunge anche accenni di neo-psichedelia di recente ispirazione
Not Not Fun (Voices, Predetermined Breaking Point), movenze tipicamente disco (Pikant) e colate di synth con
Düsseldorf sempre vicina (Oyster's Casino, El Silbo Gomero). La stravaganza fa da testa d'ariete stimolando il
primo l'interesse, ma col tempo emerge un certo equilibrio di base, che non vuole forzare troppo la mano:
non è nerdismo autocompiaciuto e difficile da accogliere, ma estro ingegnoso che sa far presa, soprattutto grazie a certe simpatie funk (Conciérge d'Amour) ed
electro-pop (Round Clocks).
Al prossimo appuntamento dovranno per forza far un
passo indietro, o finiranno per strafare. Ma nel frattempo, il merito è quello di aver eretto una solida colonna
con del materiale instabile. Beata incoscienza.
(6.9/10)
Carlo Affatigato
Poly Styrene - Generation Indigo (Future
Noise, Marzo 2011)
Genere: Power Mesh Pop
Tra il seminale Germ Free Adolescents delle sue X-Ray
Spex e l'odierno Generation Indigo c'è di mezzo un'intera generazione. Anche se deve convivere con un
70
tumore da poco diagnosticato, Poly Styrene sembra
comunque intenzionata a riprendersi un po’ di vita sui
palchi dopo la reunion della sua storica band. Ripulitasi
dalla sporcizia punk già dall'album solista Translucence
del 1980, l'icona si presenta oggi con 53 primavere alle
spalle e Martin Youth’ Glover in cabina di regia.
Il personaggione - per gli smemorati - ha collaborato
praticamente con tutto il gotha della musica elettronica e rock: Killing Joke (dove suonava il basso), Paul
McCartney, Verve (ha co-prodotto Urban Hymns),
remix per Primal Scream e per una lunga batteria di
band anni 80, che qui prepotentemente tornano remiscelate al punk: Yazoo, Duran Duran, Bananarama, Art
Of Noise, Depeche Mode e molti altri. Non da ultimo,
l’uomo è una parte importante degli Orb.
L’estetica di Generation Indigo va a ripescare dei suonini
di tanto tempo fa, scontrandosi con la moda del giro
mesh di M.I.A. (No Rockefeller) e del power now-pop di
La Roux, Beth Ditto e delle altre ragazze che oggi riportano in auge le incazzature del punk conciate però con
creste e cravattine da figlie di papà. Che il disco non
sia un capolavoro è un dato di fatto. Suona comunque
decente in alcuni pezzi dal tiro rock (White Gold), power
(L.U.V.), blues acustico (Electric Blue Monsoon) e reggae
(la mano del dub di Youth ci sta tutta in Code Pink Dub).
Niente di esplosivo, ma qualche ascolto se lo merita,
consegnando singoli che potrebbero suonare molto
bene in radio. Un antidoto che speriamo dia la carica
a Poly per uscire dalla malattia e per tornare a farci sognare.
(6/10)
Marco Braggion, Carlo Affatigato
Prefuse 73 - The Only She Chapters (Warp
Records, Aprile 2011)
Genere: chamber esoterica
Pioniere dell'hip hop strumentale e del cut-up estremo
come arte, quando si parlava di glitch-hop e non ancora di wonky, Guillermo/Prefuse ci presenta un album
che vuole essere uno spartiacque all'interno della sua
produzione. Influenzato dalle collaborazioni con Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), Neon Indian e
la polacca Ausko Orchestra (che ne ha reinterpretato
alcuni materiali in chiave suonata e classico-contemporanea), Guillermo mette da parte il beat, costruito o
decostruito che sia, e si immerge in una dimensione a
metà tra ambient, elettroacustica, concreta e avantgarde alla John Zorn, una dimensione fluttuante fatta di
canzoni diluite in una nebulosa electro organica, con
mille particelle in sospensione. Il concept è nebuloso
tanto quanto i suoni, quel che è certo è che si tratta
highlight
Pat Jordache - Future Songs (Constellation Records, Marzo 2011)
Genere: art noise
Già bagnato da una pioggia di consenso alternativo militando nei Sister Suvi, il canadese Pat Jordache ha esordito lo scorso anno come solista nel formato minimal-retrò dell'audiocassetta, oggi ristampata sul più massificato e massificante (ancorché obsolescente) cd dalla benemerita Constellation.
S'intitola Future Songs e ci costringe a spendere due pensieri circa un domani musicale all'insegna di
cotanto do it yourself, un lo-fi fisiologico se vogliamo, stante l'ipotetica - e tutto sommato non improbabile - estinzione dell'industria con relativa polverizzazione del circuito produttivo e promozionale.
I più bravi sapranno fare di necessità virtù. I previdenti già lo fanno, chioserebbe Pat. Il quale, tanto per
tranquillizzare chi teme la scomparsa dell'invenzione sonora assieme al dileguarsi dei capitali, ha confezionato otto tracce sature d'insondabile mistero a bassa fedeltà. Ovvero,
di noise wave popadelica e radiante, sfrangiata e vaporosa, cupa e frugale,
bucolica e androide. Congetture allucinate e febbrili come i Joy division disegnati male di Salt On The Fields, tese e indolenti come lo Scott Walker strattonato Julian Cope di The 2-Step, insidiose e suadenti come la trepidazione
Can di Phantom Limb. Echi da un'altra dimensione, dove il croonerismo è un
miraggio lattiginoso e febbrile, dove il tempo e lo spazio sono il miraggio
accartocciato d'un formidabile cazzone, come i Beach Boys sognati da Syd
Barrett (con l'amorevole assistenza d'un Wayne Coyne prima maniera) di Song 4 Arthur, o i TV On The
Radio prima intrisi di resina dub in Radio Generation e poi caramellati Mercury Rev nella conclusiva
ukUUU.
Pietruzza preziosa perché scabra, salda nel suo malfermo, scostante, sbandato splendore. (7.4/10)
Stefano Solventi
di un omaggio pagano e neo-primitivista all'eterno
femmineo (e anche qui torna il parallelo con i modi
zorniani), incarnato dalle voci - tra le altre - delle muse
Zola Jesus, Shara Worden dei My Brightest Diamond
e della compianta Trish Keenan dei Broadcast.
Le cesure tra un pezzo e l'altro ci sono, ma l'effetto stream of consciousness è inevitabile e comunque ricercato, nel bene e nel male. Inutile quindi stare a dire dovesuccede-cosa: in una atmosfera ritualistica ed esoterica,
ma tutt'altro che minacciosa (a tratti anzi proprio solare, carica di energie positive), troviamo fiati elegiaci
che avvicinano addirittura il romanticismo agrodolce
di Sakamoto, flussi - perché influssi - oneohtrixiani, un
harpsichord lontano e sfocato, sporcature industrial/
noize e arpeggini acustici. Il tutto equamente distribuito tra belle canzoni alla Zola (che stingono le mollagini
glo in una nebbia dark; oltre a quelle con le artiste già
citate, quella con Niki Randa), quadretti di sognante
psichedelia folk (Nico Turner, Adron), toppe ambient/
avant con quel po' di fuffa che è distintiva del genere/
dell'approccio e un paio di intermezzi glitch/wonk sul
finale (come a dire: se ci avessi messo il beat sarebbe
venuto fuori così). Giusto prima di presentare un condensato/frullato super-caotico di tutto il disco in un'unica soluzione (The Only Repeat; come a dire: per me
sperimentare è innanzitutto giocare).
Non è la solita pappetta pseudo-avant, forse perché
avant Guillermo lo è stato davvero e in un ambito in cui
non si può rinunciare facilmente alla concretezza della soddisfazione dell'ascolto. A tratti ripetitivo, questo
sì, quindi leggermente noioso; ma a tratti molto molto
fascinoso.
(7.2/10)
Gabriele Marino
Psychedelic Horseshit - Laced (Fat Cat,
Maggio 2011)
Genere: hypnanoisepop
La cronaca underground li conosce per aver coniato il
termine shitgaze. Discutibile anziché no, certamente
non esente da un certo grado di efficienza. La svolta
oggi è l’approdo a una label come Fat Cat, e quindi, in
qualche modo, l’emancipazione dal circuito Siltbreeze,
Woodsist, ecc. degli Psychedelic Horseshit. Non che
71
l’uscita dal giro sia evento in sé positivo, né probabilmente gli psichedelici ne avevano bisogno, a un lustro
abbondante dalle prime produzioni; ma di certo è un
fatto interessante, che apre a interrogativi e interpretazioni.
Una chiave di lettura è allora l’adattamento della formula a un pubblico più consistente, e a un mondo che
non mangia pane e feedback stercorari. L’elemento
“pop” e vetero-rock si trasforma da ossimoro - o contrappasso - a caratteristica in primo piano, in Laced.
Una freschezza quasi spendbile, una stratificazione
anche piuttosto elaborata (echeggia la scuola Black
Dice, quelli più giocosi) e un piglio che non è poi così
lontano da quei Flaming Lips che sempre più spesso ci
troviamo a citare. Ironia uber alles, specie se si ha a che
fare con una parodia di Highway 61 Revisited (Another Side).
Non glielo diremo mai abbastanza, che è meglio che
si scrollino di dosso la nomenclatura di genere che
non accennano ad abbandonare. Ma forse è compito
nostro fargliela dimenticare, producendo confronti,
allargando gli orizzonti della musica di Psychedelic
Horseshit anzitutto nei risultati che produce. Un esempio: I Hate The Beach è uno scherzo che procrastina un
riddim raggamuffin fino a raggiungere strutture di cui
maestri conclamati sono i Ruby Suns - come tramite i
soliti Animal Collective. Un bel tuffo nell’ipnagogico
che di certo non stupisce, ma, ancora una volta, semmai denota un percorrere i tempi, al di là di militanze e
scelte oltranziste. La conferma arriva con la velvettiana
Dead On Arrival (con ospitata di Beth Murphy di Times
New Viking). Rimane un gusto per la sporcizia - passata nel travaglio New Tribal America - traghettato verso
nuovi lidi, metà americani, metà inglesi. La buena onda
(Revolution Wavers) è pronta a essere cavalcata.
(7/10)
Gaspare Caliri
Raveonettes (The) - Raven In The Grave
(Vice Records, Aprile 2011)
Genere: Pop wave
Tagliano il traguardo del quinto album i due Danesi, da
anni impegnati in una personale esplorazione di tutte
le varianti del rumore applicato al pop. Partiti come una versione noir dei Jesus And Mary
Chain, sono andati via via acquistando maggiore sicurezza dei propri mezzi e, va da sè, una maggiore personalità. Ora sono dalle parti di un pop diafano e minimale, sorta di incrocio fra le trame eteree dei Cocteau
Twins e l'asciutto esistenzialismo dei primi Cure.
Quanto mai essenziale negli arrangiamenti, fatti quasi
72
sempre di semplici linee chitarristiche e generosi tappeti di synth su cui le voci di Sune e Sharin possono
dispiegarsi fragili e ammalianti, Raven In The Grave
testimonia la maturazione di una peculiare concezione
del pop: austera ed immediata, sempre in bilico fra leggerezza e malinconia.
Alla prima vanno ascritti i temi spectoriani in chiave
80s di Forget That You're Young e la lullaby narcolettica
di Summer Moon; War In Heaven e Apparitions, al contrario, sono melodie umbratili e limpide come specchi
d'acqua di montagna, appena increspati da gentili tocchi di chitarra.
La ritmica, del tutto assente nella maggior parte dei
brani, prende invece il sopravvento nella batteria dritta
del surf wave Ignite e nella melodia circolare e negli accordi graffianti di Recharge & Revolt, lungo ed accorato
mantra pop senza ritornello, che ad orecchie smaliziate
ha subito assunto la statura del classico.
Il fatto che i Raveonettes lo abbiano scelto come primo singolo la dice lunga sulla libertà espressiva conquistata in dieci anni di onorata carriera e di come, lasciata da parte la coperta di Linus fatta di feedback, si
sentano liberi di svelarsi in tutta la loro grazia.
(7/10)
Diego Ballani
highlight
Retina.it - Randomicon (Flatmate, Aprile 2011)
Genere: electronica
Torna il duo napoletano formato da Lino Monaco e Nicola Buono. La loro carriera - che spazia dalla
wave, al dub e all'elettronica d'avanguardia - li ha portati a collaborare con i nostrani 99 Posse e Marco
Messina e negli ultimi tempi con personaggi dell'elettronica mondiale nelle maglie della chicagoana
Hefty (che ha pubblicato tra gli altri Telefon Tel Aviv, L'altra e Savath & Savalas).
In questo nuovo lavoro esplorano le sonorità dei sytnh modulari costruiti
dallo stesso Nicola Buono. Un modo di approcciarsi alla materia elettronica
'dal basso', senza mediazioni di software o di preset standardizzanti. Il suono
ovviamente risente di questa ricerca, proponendo soluzioni che si possono
accostare al sentire squadrato della Raster Noton, con pulizie e tenaglie al
laser che ricordano la minimal di Richie Hawtin (Spherically Symmetric) sezionata con le visioni di fino dei Dopplereffekt (Equation For U) per approdare
infine alla lezione robotica dei primi Autechre (Gamma Repeater). Non solo:
in questi 50 minuti si scorge anche qualche ammiccamento al bbreaking (These Attractors (Toten)) e
all'ambience gloomy (Gravitational Collapse) con rifiniture di field recordings che ricordano pure l'industrial (A Model For Nonspherical Collapse).
Un disco stampato in sole 500 copie che manifesta la maturata consapevolezza compositiva di Lino
e Nicola, ormai sdoganati a livello internazionale (vedi ad esempio la loro partecipazione al Sonar nel
2006). Un isolamento proficuo il loro, che dovrebbe essere riconosciuto e promosso anche in patria,
data la loro capacità di spaziare tra mondi e stili diversi. Non solo per nerd.
(7.3/10)
Marco Braggion
Robert Miles - Th1rth3en (S:alt Records,
Febbraio 2011)
Genere: prog ambient aor
Sì proprio il Miles di Children. Il suo ritorno dopo un
po' di anni di silenzio discografico, passati a scrivere
colonne sonore a L.A., sorprende l'ascoltatore che non
ha seguito il percorso artistico dell'uomo. Già da molto collabora infatti con numerosi artisti che non hanno
molto a che vedere con i suoi trascorsi 'dream house'
(memorabile è ad esempio il duo con il guru della tabla
Trilok Gurtu del 2004).
Fra i collaboratori di questo nuovo full sono presenti Robert Fripp, Mike Patton e John Thorne (Lamb),
quindi la tracklist risulta influenzata dal rock progressivo del chitarrista dei King Krimson, da qualche break e da eterogeneità miscelate a dovere. Inaspettato il
sincretismo che il produttore internazionale riesce ad
operare con voci così divergenti, tanto che a tratti ricorda pure la deriva ambient di Aphex Twin (i pianoforti
di The Wolf affini ad alcuni momenti dei Selected Ambient Works) e le atmosfere choir-ambient di Morricone
(Voices From A Submerged Sea).
Il disco - che resta a cavallo tra molti generi, ma che potrebbe essere bollato con la vecchia etichetta di 'adult
oriented rock' - ci riporta a quella tranquillità mentale e
compositiva che avevamo sentito nel Tom Middleton
di Lifetracks, citando a dovere pure Vangelis (Orchid
Miracle) e i Pink Floyd (Afterglow). Una visione tagliata
con l'esperienza del successo mondiale, che rimescola
le carte di un uomo e di una mente ancora propositiva.
Carriera ancora in salita per Robert. Bentornato!
(7/10)
Marco Braggion
Ryan Driver - Who's Breathing (Fire
Records, Giugno 2011)
Genere: Alt.country/jazz
Il canadese (dell'Ontario) Ryan Driver giunge al secondo album solista, seguito di Feeler Of Pure Joy del 2009,
senza tralasciare mai la sua attività intensissima con il
suo jazz-quartet The Ryan Driver Quartet, con la root
band The Silt (sempre in casa Fire Records) e chissà
quante altre collaborazioni. Vista gli interessi bifronti,
non stupisce che Who's Breathing sia un progetto diviso a metà tra il Constellation sound della prima parte e
la canzone jazz della seconda.
Fino alla splendida Blues Skies Don't Care, Ryan Driver
centra la sua scrittura sulla chitarra e i tipici stilemi del
nuovo country di Uncle Tupelo/Wilco. Ma con It's Tulip
Season, la sesta traccia, a prendere il centro della scena è il pianoforte. La forza della prima parte, con quel
modo tutto particolare di ficcare più parole di quante
si pensi sia lecito in un verso, sta tutta nella serenità
agrodolce che la voce e le armonizzazioni infondono
alle composizioni. Nei panni del jazz-singer, Driver si
abbandona, invece, alle atmosfere notturne da ballata
sofferta ma elegante.
Il problema di Who's Breathing sta forse tutto in questa indecisione di essere l'una o l'altra cosa: un album
country o una collezione di canzoni classiche? Perché
nulla, ad eccezion forse di una leggera monotonia della
seconda parte, è fuori fuoco: tutto suona meravigliosamente. Ed è evidente che Driver si sente a proprio agio
in entrambe le incarnazioni. La sensazione, però, è che
non si accontenti nessuno dei due potenziali pubblici.
(6.5/10)
Marco Boscolo
73
highlight
Susana Baca - Afrodiaspora (Luaka Bop, Aprile 2011)
Genere: etnica
Ne ha fatta di strada dal suo Peru, Susana Baca. Senza fretta ma con costanza, si è imposta a fianco di
Cesaria Evora e Omara Portuondo nell’alveo delle “dive” di quella che per comodità noi occidentali
seguitiamo a chiamare world music. Dimenticando che, in fondo, è una questione di prospettiva, di processi storici che non ci fa onore ricordare ma che si devono tenere ben presenti, più che mai in questi
anni di massicce migrazioni “moderne”.
Un tassello di pregio e passione lo sistema nel dibattito Afrodiaspora, per il
quale la Baca si è immersa nelle diverse tradizioni del suo continente sconfinando fino a Cuba, allo scopo di tracciare una mappa sonora che le ricongiungesse alla comune origine. Al forzato abbandono dal continente africano
esplicitato nel titolo e nel rifarsi alla musica sparsa per il continente americano dagli schiavi; che, trapiantata altrove, ha assunto nel tempo forme diverse
ma simili.
Che siano la sensuale cumbia Detras De La Puerta o una Que Bonito Tu Vestido
con tanto di gustosa citazione de La Bamba, l’omaggio a Celia Cruz Baho Kende/Palo Mayimbe o la tesa
però lieve Reina de Africa, il significato ultimo è nel senso di malinconico riscatto “a posteriori” che affiora in un’ora scarsa, i cui estremi stanno nelle corde tristi di Bendìceme e nel piroettare di Plena Y Bomba e
il culmine nella ripresa di Hey Pocky Way. Prelevata dalle leggende funk Meters e gemma di quella New
Orleans che resta tuttora un esempio di melting pot. Sofferto e sofferente da suggerire che, a un certo
punto, non sia più questione di musica, ma di vita.
(7.4/10)
del Mr. Oizo di Moustache (Half A Scissor), rintracciabile qui nei momenti più eccentrici e destrutturati
come Feed My Meatmachine, Red Knob e la stessa titletrack. La ricca scaletta - 17 tracce - raccoglie diverse
frontiere di sperimentazione affrontate dal producer
berlinese, svariando tra il serio e il faceto: nella prima metà si alternano sferragliate acieed (Sirimande),
intrecci folli tra hip-hop e breakbeat (Bad Idea) e spigolosità taglienti ereditate dai compagni di merende
Modeselektor (123, Feromonikon); dopo il giro di boa
emerge invece il lato più giocoso del disco, tra svaghi
à la Justice (Einmal In Der Woche Schreien) e riconoscibili affinità french-house che richiamano tanto il pioniere Etienne De Crécy (Nights Off) quanto gli ultimi
arrivati Bot'Ox (Idiologie).
Nonostante suoni tanto inventivo da essere inclassificabile, dietro al mosaico di Siriusmo non c'è nessun
proposito intellettuale, nessuna specifica volontà di
inventare qualcosa. Ci sono però entusiasmo, euforia
ed un'irriverenza sempre volta a rompere lo schema.
Techno-divertissement per la cyborg generation: all'evoluzione della specie penseranno altri.
(7.1/10)
Carlo Affatigato
Giancarlo Turra
Santo Barbaro - Lorna (Ribéss Records,
Dicembre 2010)
Genere: canzone d'autore
Arriviamo colpevolmente in ritardo con i Santo Barbaro e ce ne scusiamo. Del resto tralasciare un disco come
Lorna non sarebbe stato possibile, dal momento che il
secondo episodio della formazione romagnola è opera
intensa, eterea, poetica, come se ne ascoltano di rado.
Il centro di gravità del gruppo rimane la parola di Pieralberto Valli, tagliata e rimodellata su una narrazione
che poco ha a che vedere con la forma canzone e molto con un fluire evocativo e personale. E in cui la musica
di Franco Naddei, Diego Sapignoli e dello stesso Valli
si innesta deformandosi a richiesta per seguire il ritmo
del testo e sottolinearne i passaggi più evocativi.
Sembra di ascoltare Adriano Modica, ma dove il musicista calabrese spinge sul pedale della psichedelia, i
Santo Barbaro preferiscono le mezze luci, le morbidezze soffuse, lo streaming emotivo senza facili punti di riferimento. Magari su uno xilofono e una batteria (Nudi
Dorsi) o in un crescendo elettrico vicino al post-rock
(Naufragio), avvinghiati a un'elettronica che sarebbe
piaciuta a Daniele Brusaschetto (Il vuoto) o colti a ci74
Sloan - The Double Cross (Yep Roc, Maggio
2011)
Genere: pop-rock
tare l'ultimo Giancarlo Onorato (Scia di polvere).
Eleganza, estrema varietà nei colori (da applausi il dub
etnico di Finisterre), qualche parentesi rugginosa (la
title-track): Lorna è disco di spazi e nuvole, inquietudini
e rese. Ennesimo esempio di una canzone d'autore che
non si stanca di auto-rigenerarsi riafferrando con stile
il presente.
(7.2/10)
Fabrizio Zampighi
Siriusmo - Mosaik (Monkeytown Records,
Marzo 2011)
Genere: Avant-techno
Oltre dieci anni passati a sfornare singoli, EP e remix
per nomi blasonati (Simian Mobile Disco, Chromeo,
Digitalism, Gossip per citarne solo alcuni) sono un
biglietto da visita che non tutti possono permettersi.
Circondato da alte aspettative sul suo primo vero album in studio, Moritz Friedrich aka Siriusmo risponde
con un lavoro complesso che, alternando brani inediti
a materiale già noto, copre efficacemente lo spettro
electro-techy che lo caratterizza.
Il punto di partenza di Mosaik rimane l'old-school
Non molto noti da questa parte dell'oceano Atlantico, i
canadesi Sloan continuano da vent'anni a predicare la
loro formula di pop rock a base di classici e riferimenti
Ninenties nel continente nordamericano, con apici notevoli (Between The Bridges del 1999) e qualche caduta
di tono (le trenta tracce di Never Heard The End Of It del
2006), ma senza mai scendere sotto un livello medio
tutt'altro che basso. The Double Cross è il decimo della lista ed esce il giorno del ventesimo anniversario del
primo show.
Il dato che si consolida con queste dodici tracce è la
notevole classe del combo canadese, composto da
quattro polistrumentisti che si avvicendano alla scrittura e alla voce principale senza perdere la coesione.
Dal loro incrocio di rock Seventies, pop e armonie vocali Sixties non ci si aspetta sicuramente nulla di innovativo, ma l'intrattenimento che delle vecchie volpi
dell'indie sono in grado di regalare. E ascoltando The
Double Cross stupisce il tasso di divertimento che i
quattro sembrano ancora trovare nello scrivere e suonare insieme. Si veda, da questo punto di vista il gioco
delle citazioni interne, di cui vi segnaliamo la reprise
del tema della quarta traccia, Shadow of Love, nella de-
cima, Beverly Terrace, mentre vi lasciamo il piacere di
scoprire autonomamente le altre.
Il programma si svolge tra maschio rock Seventies
come Bobbie Gilliespie pagherebbe per riuscire a scrivere (Follow The Leader e Unkind), turbamenti power
pop con sfumature surf (You're Daddy Will Do), schegge
Stooges (It's Plain to See), ballad da FM (Loving So Low)
e il pianoforte suonato con il polso bloccato di (The
Answer Was You). In piena forma, si meritano l'etichetta
di 'classici'.
(7/10)
Marco Boscolo
Sonny And The Sunsets - Hit After Hit (Fat
Possum, Aprile 2011)
Genere: Lo-fi pop
L'unico modo in cui questi pezzi potrebbero diventare delle hit, sarebbe che Sonny Smith e suoi Sunsets si
imbarcassero su una Delorean diretta verso il 1955 e
andassero ad eseguire le loro canzoni al ballo Incanto
Sotto il Mare.
O forse no, troppo debosciato e minimale il loro garage rock, troppo indolente e sfigato per un posto e un
luogo (l'america dei 50s) in cui l'ottimismo e il perfezionismo la facevano da padrone.
Eppure il songwriting di Sonny si nutre proprio di questo: sunshine pop, frat rock, surf e doo wop, ma nella loro versione più negletta. E' l'alba dei teen sound
passata attraverso le slackness e il punk dei 90s. Solo
che qui di punk non c'è neppure l'ombra. Di slackness
invece si, eccome!
L'opener, She Plays YoYo With My Mind, per dire, è un jug
blues narcolettico, appena smosso da un tamburello e
lievi twang chitarristici, su cui la voce nasale di Smith
accenna a grottesche vicende amorose. I Wanna Do It è
un pop da girl group che procede per inerzia. Qualche
flebile slancio urlato a mezza voce si ha nel ritornello
dello psycho garage Teen Age Thugs, ma per il resto
il sound si mantiene fra lo scheletrico, il posticcio e il
dannatamente accattivante.
Perché naturalmente, in tutta la sua indolenza Sonny
è uno che sforna pop song con la facilità con cui gli altri si grattano il naso. Basti pensare che i brani di Hit
After Hit nascono dalle sessioni del suo progetto più
ambizioso: quello di realizzare 100 singoli (con relative
b-side, per un totale dunque di 200 canzoni) per 100
band immaginarie.
Un'ispirazione pantagruelica seconda solo al Robert
Pollard dei tempi d'oro. Se a quanto detto aggiungiamo che i Sunsets sono costituiti da membri di The Oh
Sees e Fresh & Onlys, capirete bene che ci troviamo
75
di fronte all'ennesimo curioso organico della scena lo-fi
pop californiana. Un pozzo di cui ancora non si vede il
fondo.
(6.8/10)
Diego Ballani
Susanne Sundfør - The Brothel (Gronland
Records, Aprile 2011)
Genere: elettro-pop
Dura un paio di ascolti la sbornia per questa norvegese
dalla voce austera e cristallina. Poi si affievolisce, trasformandosi in un hangover piacevole ma con qualche
punto interrogativo. Si fa per dire, ché di cose buone
in The Brothel ce ne sono molte. Eppure, nonostante
uno stile vocale virtuoso in bilico tra Bjork, Anna Calvi, Joan Baez e un lavoro di produzione sopraffino che
mescola classica, ambient ed elettronica (nel disco c'è
lo zampino del Jaga Jazzist Lars Horntveth), qualcosa
non torna.
I dubbi in realtà nascono dall'impressione che le aspirazioni della Sundfør vadano nella direzione di un pop
quanto più possibile ad ampio spettro, più che esplorare coraggiosamente quel terreno di confine che il crossover di suoni alla base dei dieci episodi vorrebbe suggerire. Un tentativo di raccogliere consensi riuscendo
a mantenere una certa integrità di fondo, per un disco
da interpretare ma nello stesso tempo non troppo selettivo.
Sembra di ascoltare una Enya rivisitata e decisamente
indie, a cui si affiancano scenari nordici evocativi (la title-track) e drum'n'bass eterea (Lilith), ambient sognante (Black Widow) e catarsi ai limiti della musica sacra
(Father Father), batterie marziali (O Master) e partiture
complesse in bilico tra sintetico e archi (Turkish Delight).
In un misto di arte, virtù e lungimiranza che ha portato
il disco ai piani alti delle classifiche di vendita norvegesi.
(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
Thao Nguyen/Mirah - Thao & Mirah (Kill
Rock Stars, Maggio 2011)
Genere: indie pop
L’una (la portlandina Mirah) puledro folk di scuderia
K Recs, l’altra (Thao Nguyen) astro assodato della Kill
Rock Stars. In mezzo, o forse sopra le parti, la compartecipazione nella stanza dei controlli dell’esuberante
Merrill Garbus (aka Tune-Yards). C’è una sommatoria
degna di nota, nell’uscita self-titled di Thao&Mirah.
L’output è leggero ma sofisticato. Sono certosini i tocchi che danno forma e sostanza ai tanti piccoli scrigni
indie-pop (Folks), sono tradizionali - e forse meno im76
prescindibili - i richiami alla tradizione del cantautorato
indie femminile, da Cat Power a PJ Harvey (Space Out
Orbit). Si sentono anche gli ultimi due lustri di elettropop alla The Blow (Eleven, How dare You). Ciò su cui le
due eccellono è la variazione/variabilità espressa nelle
potenzialità esecutive, specie su temi percussivi. Una
molteplicità che convince quando l’arrangiamento attraversa i generi fino a diventare mutante, in pieno stile
NYC, in Rubies And Rocks.
A uno sguardo d’insieme, l’approccio è abbastanza
chiaro: si parte con una linea melodica e un arpeggio,
che poi è scomposta, aggiungendo movimento e anima collettiva 00, sempre e comunque all’interno di un
universo pop (Little Cup). Non c’è - o non si vede - un
discorso sulla coesione, una mission, per così dire, ossia ciò che generalmente sta dietro alla nascita di una
band. Thao & Mirah è oggi niente più che un “progetto” - fra l’altro, commercialmente parlando, giustificato
da una motivazione di raccolta fondi a sostegno di Air
Traffic Control, organizzazione a supporto di musicisti
indie.
Così accogliamo Thao & Mirah tra i nostri dischi. Senza
eccessivo entusiasmo ma neanche con noia indotta. Di
certo c’è intesa, complementarietà (anche corale: niente male l’operazione di sottrazione, ripetizione e cacofonia di Likeable Man) senza accenno di un conflitto tra
comprimarie. E quindi la porta al sophomore rimane
aperta.
(6.8/10)
Gaspare Caliri
The Cruels - Infesto Ep (Clinical Archives,
Aprile 2011)
Genere: Industrial punk
Se il buon giorno si vede dal mattino, quello che si prospetta per i Cruels sarà davvero radioso. Il trio lucchese, attivo dal 2008 e costituito da giovani di appena
vent'anni, è autore di una avvincente miscela di rock dal
tiro punk e dalla pesantezza industriale.
I due brani centrali di questo breve ed intenso ep d'esordio (sei brani per un totale di appena quindici minuti), fondono una furente vena hardcore con il sound
post apocalittico dei Killing Joke. Un'idea, in un certo
senso vicina a quella che i Therapy? inaugurarono all'epoca dei loro primi lavori. Si sente infatti l'influenza di
certo alternative meno velleitario, soprattutto nell'incedere lento e disturbante di I'm A Big Machine.
Negli ultimi due brani in programma (Nola e Infesto), la
virulenza delle chitarre si trasfigura in una psichedelia
urbana, una sorta di shoegaze metropolitano di un grigiore metallico.
Peccato per una produzione che non sempre valorizza
la lucentezza del loro sound. Una volta messo a punto
questo aspetto potremmo trovarci di fronte a qualcosa
di veremente importante e originale.
(6.7/10)
rossa degli Archer in jazz, un portale che potrebbe anticipare nuove prolifiche dimensioni e innesti inattesi.
Per ora accontentiamoci di questo bel lavoro.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Diego Ballani
Tied & Tickled Trio - La Place Demon (Morr
Music, Aprile 2011)
Genere: Jazz
Si sa che The Notwist, 13 & God e Tied & Tickled Trio
sono le facce principali dell'Archer pensiero in musica, tre lati di una magmatica sonora fatta di parentesi, mosse di lato e piroette all'indietro, tre progetti che
coabitano senza scadenze temporali precise e s'attivano al manifestarsi delle giuste occasioni. Quest'anno la
compagine ha già sfornato Own your ghost, la solita
operazione di indie-hop made in Anticon a nome 13
& God, e oggi approda a questo affascinante La Place
Demon. Dopo il lavoro di elettronica minimale di due
anni orsono(quell'Aelita commissionato dal festival di
Hausmusik a Monaco ispirato ai sogni dei fantascenziati del Novecento), ritroviamo il combo in piena fregola
jazz con il solito quartetto base (con Casper Brandner
e Andreas Gerth), un contorno di 11 musicisti (tra cui
Johannes Enders e Carl Oesterhelt) e un batterista d'eccezione, Billy Hart.
Hart, settanta primavere appena compiute, più di seicento album incisi (e collaborazioni di lungo corso con
Herbie Hancock e Stan Getz), è ça va sans dire lo starter della nuova esperienza: cofirmatario delle tracce e
dell'album, il lavoro è stato disegnato attorno all'uomo,
la scusa ideale per unire svariate generazioni attorno a
un prisma jazz senza barriere di stili e contaminazioni.
Il batterista è pure la ragione del ritorno al paradigma
dell'esperimento dentro l'esperimento di Observing
Systems, album dei TTT del 2004 il cui approccio ritorna con i suoi riferimenti (Gil Evans, Sam Rivers, John Coltrane, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Miles Davis,
Ronald Kirk e Sun Ra), periodi storici prediletti (l'incrocio 60s e 70s) e strategie d'inserto elettronico (in particolare per gli strumenti a fiato).
Eccessiva calligrafia e devozione sono i classici difetti di
operazioni del genere ed il progetto non ne è mai stato immune, eppure quando in Le Place Demon il drumming scuro di Hart si dilegua nella cosmo-delia firmata
Sun Ra (The End Is The Same As The Beginning), il combo
è potente e visionario come deve e il viatico tra sci-fi e
vecchie maniere, magari diviso tra l'amore per la Ballroom music ante guerra mescolata con un poco di Coltrane (The Three Doors (Part 1)), è senz'altro la sottile linea
Timber Timbre - Creep On Creepin' On (Full
Time Hobby, Aprile 2011)
Genere: Retrò Pop
Con l’omonimo album di due anni fa, il combo canadese Timber Timbre aveva coniato un personale cantautorato che scavava nella tradizione folk blues americana
da un’angolazione estetizzante e cinematica. La voce
nasale di Taylor Kirk, in convergenza parallela sia con
quella di un Stuart Staples (Tindersticks) ma anche
con quella di Mark Sandman (Morphine), e gli arrangiamenti, un misto di soundtrack music avvicendata su un
impianto tipicamente folk-pop, erano stati in grado di
creare un immaginario d’eleganza lunare, un portale
sonico verso una realtà parallela dove i neri diventavano bianchi e viceversa, dove un senso di classicità pop
da coscienza collettiva era costantemente strattonato
da un bisogno di catarsi timbrico narrativa.
Spooky e creepy - gli aggettivi più utilizzati dalla stampa brit - la musica dei Timber Timbre prendeva la lezione dei The Good, the Bad & the Queen per portarla
nel terreno degli Elvis Presley e dei James Brown dei
50s. Non a caso una strategia è quella di inscenare infinite varianti al classico Men’s Men’s Men’s World il cui
picchiettio di piano (e contorno di significanti e significati) diventa un’autentica fissazione in questo nuovo
lavoro fin dall’iniziale Bad Ritual e finisce poi per trasformarsi nel tema portante dell'album e dalla traccia che
nome all’album, Creep On Creepin’ On, titolo emblematico che traduciamo, a questo punto in una resa definitiva allo “strisciare sinuosi nella classicità in crooning
black’n’white”, al guardare con gli occhi di un rockabilly
in retroguardia o di un honky tonk venuto da marte.
Consapevolmente prigioniero di sé stesso, decadentemente specchiato nel mondo che ha così abilmente
evocato e ricreato, il trio esercita ancor’ora un enorme
fascino, soltanto che, rispetto al self titled del 2009 vincitore del Polaris Music Prize, la sensazione è di un colpo non completamente a segno.
Si tratta di separare l’ottimo dal molto buono però:
ascoltate l’intelligenza dei siparietti thriller come
Swamp Music (tra legni e archi in pura soundtrack music), l’efficacia dei fiati gangster in Woman, gli ottimi tagli country folk-rock di Too Old To Die Young, gli smalti
quasi lynciani del lavoro sulla classica ballad Lonesome
Hunter, oppure la bellissima fanfara con tocchi cosmic
77
psych e jazz che è Do I Have Power.
Pettine e camicia aperta davanti allo specchio. Tutto
nero baby.
(7.2/10)
Edoardo Bridda
Tommy Guerrero - Lifeboats And Follies
(Galaxia, Marzo 2011)
Genere: jazz latin rock
Personaggio sui generis, questo Tommy Guerrero.
Californiano di San Francisco classe '66, un passato da
skateboarder professionista, saltuariamente attore e infine musicista attorno alla cui produzione - un pugno di
uscite dall'inizio del nuovo millennio - è germogliato un
piccolo culto. Lifeboats And Follies è il quinto album
a suo nome, come i precedenti deve il suo fascino alla
capacità di crearsi una dimensione sonora particolare,
una specie di bozzolo cinematico, esotico, onirico ma
irriducibilmente concreto. Congetture jazz, ebbrezza
latin rock, blues strascicato, funk soul letargico, aura
stropicciata house, sottigliezze psych: la mistura è rilassata, suadente, a tratti pure festosa, eppure attraversata
da vibrazioni irrequiete, come se tutto accadesse in una
zona franca in mezzo all'inferno della quotidianità.
Ipotesi meditabonde (The Same Confusion And Hope),
percussività agile e impressionista (Nomadic Static),
crossover estatico (The Last Maverick), exotica acidula e
stropicciata (Cut The Reins) e spersi miraggi di frontiera
(On The West) punteggiano un programma godibilissimo e inquietante.(7.1/10)
Stefano Solventi
Tronco - Primo Annuale E Mezzo Resoconto
(Sincope, Aprile 2011)
Genere: noise-core
Noise a scartamento ridotto, musica tronca come binari
di treni interrotti o come parole mozzate e urlate senza
remore. Questo il senso ultimo dell’ennesimo progetto
uscito dalla Sincope: non paga di aver co-firmato uno
dei lavori meglio riusciti d’inizio anno - il Fragranze Silenzio di Daniele Brusaschetto e aver prodotto del
buon noise-harsh (Fecalove su tutti) - la label diy laziale
replica col primo resoconto annuale (e mezzo) del duo
Tronco. Truculentboy - deus-ex-machina della label e
metà Compoundead - alla chitarra/voce e Francesco
a batteria/voce mettono fuori un dischetto di improvvisazioni rielaborate che, pur ispirato almeno nel titolo
dalle crudezze industrial di matrice Throbbing Gristle,
ripiega più su un noise-(core)-rock scartavetrato e scheletrico pronto a schiantarsi su minimali lande wave/
post-punk chitarristiche.
78
L’uso dell’italiano avvicina il progetto a territori da acre
stil post, per usare il titolo di un nostro articolo in cui indagavamo l’uso della lingua di Dante in Massimo Volume e Bachi da Pietra, Starfuckers, Altro e CCCP. Proprio
questi ultimi due sembrano essere i punti di riferimento più prossimi per i Tronco, abili a mostrarsi in sintonia
coi cut-up degli Altro e con le pastoie linguistiche di un
Lindo Ferretti ancora non anestetizzato. A dimostrare
il legame e la contiguità prendono a prestito la lenta
Noia e la riducono ad un colabrodo noise-punk-core
non disprezzabile. Coesione e forza d’urto unite a una
idea di base piuttosto chiara ci fanno ben sperare per
un album compiuto.
(6.9/10)
Stefano Pifferi
TV Ghost - Mass Dream (In The Red Records,
Aprile 2011)
Genere: Post Punk
Che dire di questo secondo album (se non si considera anche il primo 12 pollici su dieStasi) dei TV Ghost?
I ragazzi del mid-west sperduto si sono accasati già dal
precedente Cold Fish presso la leggendaria In The Red
e oggi rilanciano una nuova portata fedele alla ricetta
originale.
Chi ha già avuto modo di esperire le frenesie elettriche del quartetto di Lafayette sa bene cosa aspettarsi. Riff crudi e urticanti di chitarre in odore di Gang Of
Four usate come fendenti acuminati, ritmiche tribali,
sconnesse e scomposte a creare un senso di panico
basato sull’alternarsi di vuoto e pieno, urla belluine e
lamentosi gorghi vocali, synth dirottati e pronti a deragliare contro un muro di allucinazioni. Unica, piccola novità sembrano essere le tonalità particolarmente
scure della voce, vagamente più goth del solito, ma il
limite del gruppo sta nel puntare troppo sull’isterismo
ipnotico in cui sono maestri e troppo poco sulla struttura e l’individualità dei pezzi, alla lunga un po’ troppo
simili a se stessi.
La carica esecutiva e la consapevolezza dei propri punti
forti di certo non mancano, ma dire se Mass Dream sia
migliore o peggiore delle altre pubblicazioni del Fantasma Televisivo è compito che lasciamo volentieri a
qualcun altro.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Tv On The Radio - Nine Types Of Light
(Interscope Records, Aprile 2011)
Genere: pop wave soul
Impattare la primavera col nuovo album - il quarto - dei
highlight
Vinicio Capossela - Marinai, profeti e balene (Warner Music Group, Aprile
2011)
Genere: cantautorato
Vinicio Capossela è tornato dopo aver bevuto il mare. Dopo il manierismo ostentato - e soprattutto
sfocato - di Da Solo, il cantautore indeciso di allora diventa oggi, ora, paesaggio liquido, dipinto a
strati, acquoso negli arrangiamenti. Il nuovo Marinai, profeti e balene ritrova un Capossela complesso,
circolare, denso, messa da parte la pomposità della forma canzone, ci si affida alla corporeità del suono,
alla sua manipolabilità, uno sguardo ridimensionato eppure esploso dai ricordi sonori. Lo scanzonare
di Pryntil, puro stile sirenese, una nenia disneyana mescolata al contorto e così tanto deflorato Louis
Ferdinand Cèline, un Capossela raramente così ispirato nel suo strabordare storie onnivore lanciate in
mezzo ai mari. Oppure Billy Budd, così tesa nei ricami avant western del fido e
claudicante Marc Ribot, così terrea nelle parole, quasi un reading cadenzato
di Non si muore tutte le mattine, piccole suggestioni rassegnate, come impossessate di Tom Waits.
Una Polpo d’amor svestita rispetto alla versione con i Calexico, un dondolarsi
liquido tra lettere in profondità e danze tra gli abissi, piccola storia di perdite, un ritrovarsi tra echi di John Surman e scenografie alla Crialese - vedi
il lasciarsi alle spalle il mondo di Respiro - che ritorno alle ostilità delle vite
nostre. Il destino malinconico de Le Sirene, un leggero capitombolo tra le trovate mancate dell’ultimo
caposseliano, il mai tanto deludente Da Solo, alla lunga annoiata e ripetitiva, questa Le Sirene, ovvietà
e mancanza d’ispirazione rimbombano sottovoce. Più riuscita La Madonna delle Conchiglie, innocua
ninna nanna sputata dal mare. Un sussulto avvolge l’ascoltatore colpito dalle trovate ariose di Lord Jim,
divertissement curato fino allo spasmo, una circolarità da brividi, un manifesto della sconfitta, “credevi
di esser saldo, ora sai chi sei, ora che sta a te, ora hai mancato il colpo”.
Fuochi Fatui è discesa agli inferi, fuoco che sopravvive al mare, delirio geniale che comprende il mondo
tra urli insensati e aperture melodiche da post tempesta, da post Sanremo, l’apocalisse tanto annunciata si riduce alla normalità del vivere quotidiano: parafrasando lo stesso Vinicio, il cantautore vomita
su di noi l’ultimo respiro. La Lancia del Pelide dismessa la maschera di marcia funeraria, grazie a un passaggio della linea invisibile e sinuoso, si reinventa come sospiro affaticato, un’apoteosi colma di tutti gli
elementi visibili del mondo, qualcosa che riconduce alla vita, alle origini delle sensazioni.
Capossela ci restituisce la conoscenza e la coscienza dell’essere sommersi: una vita sorge in mezzo al
mare dove i momenti ridicoli quasi spariscono al cospetto della terra. Marinai, profeti e balene ci
riconduce all’amore per l’indistinto, per l’inafferrabile, e inevitabilmente, per il cantore di tali docili storielle. Qualcosa di simile a correre sommersi dal mare.
(7.4/10)
Federico Pevere
TV On The Radio è una gran bella storia. Se già il precedente Dear Science, ammiccava un piacionismo in
cui s'andava deliziosamente ad impantanare la spinta
esploratrice, oggi quel residuo movimento è diventato
una languida stasi. Sedata la fregola dell'ibridazione,
esaudita la smania di cercarsi, i cinque si sono accoccolati nel proprio sound come piselli nel baccello. Condizione ideale per comporre, e infatti hanno sfornato
squisitezze d'alto bordo. Una melodia via l'altra - carezzevoli, concitate, polpose, sgargianti - su dieci tracce
una buona metà sono hit potenziali. Ad esempio quando fanno i cugini setosi dei Gnarls Barkley (Forgotten, Second Song), la Beta Band morsa dalla tarantola
Talking Heads (No Future Shock), i Wire ipnotizzati Gorillaz (Repetition) o ancora il Peter Gabriel più etereo
circonfuso d'organi amniotici Traffic (Killer Crane).
Predomina un senso di relax turgido nel quale la negritudine va a stemperarsi perfettamente tra le congetture wave-pop, producendo sentimento espanso tra
vibrazioni spacey e afrori black, intrighi elettrici e sin79
copi androidi sotto lo sciroppo della superficie. Il quid
sonico ne esce tanto duttile quanto robusto, capace
d'imbastire con disinvoltura funky fuzzante (la nervosa
New Cannonball Blues) e soul cinematico (una Will Do
sul punto di ridondare trip-hop), di chiamare in causa
con disarmante naturalezza vampe Beastie Boys (Caffeinated Consciousness) oppure l'epica evanescente U2Eno altezza Zooropa (Keep Your Heart).
Nine Types Of Light è un lavoro pungente, radioso, per
nulla banale. Nella sua affabilità cela un'affascinante
ipotesi di sincretismo sonoro per il presente. Quanto al
futuro, per il momento può attendere.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Uv Race - Homo (In The Red Records, Aprile
2011)
Genere: garage/post-punk
Tornano gli australiani UV Race dopo l’esordio omonimo di un paio di anni addietro e una costante presenza
nel mondo dei pezzi piccoli in vinile e delle cassettine.
Ora Homo, pur non tagliando i ponti con l’underground
più oltranzista (esce anche in versione tape su Aarght!),
si fregia del marchio In The Red a testimoniare una doppia crescita per questi proto-punk from down under. Di
interesse innanzitutto, ma anche nello sviluppo di una
cifra musicale più messa a fuoco rispetto anche al citato
debutto. Il sestetto misto mette in scena un universo
proto-punk in cui le evidenti influenze aussie - Scientists e Saints su tutti, ma si parla dell’ovvio - sconfinano
verso gli states rovinati della Detroit stoogesiana o verso la Manchester di Mr. Fall Mark E. Smith.
Non fossilizzatevi però sui nomi, perché gli UV Race si
muovono in indipendenza attraverso post-punk scartavetrato (il sax che deturpa la falliana Burn That Cat) e
melodie diafane da B-52s a testa in giù (Lost My Way), visioni velvet-garagiste (Girl In My Head) e paranoie semiacustiche (la freakeria autistica di Always Late), divertissment rock’n’roll (la cantilena al femminile di Low) e
stranite aperture psicotiche. Una buona conferma per il
gruppo che tira le fila di un intero universo seminascosto - da Super Wild Horses a Total Control, passando
per Eddy Current Suppression Ring, Witch Hats, Slug
Guts, Circle Pit e molti altri - pronto ad essere scoperto.
(7/10)
Stefano Pifferi
80
Vasco Rossi - Vivere o niente (EMI, Marzo
2011)
Genere: pop rock
Fanno quasi trent'anni che, adolescente, m'invaghii
di Vasco Rossi. Non era difficile volergli bene, anzi:
quell'adulto fuggito alla maturità, sorta di Peter Pan
tanto arguto quanto balordo, lucido e sensibilissimo
sotto la buccia dello scazzo perenne, diventò il contrappeso ideale alla sempre più pressante adultificazione. In qualche modo, mi sembrava un cuginastro
più grande e scellerato che ha capito la lezione di
Lucignolo cavandosela tutto sommato alla grande.
Più avanti, quell'immaginario di marachelle tossiche,
frustrazioni esistenzial/sentimentali, balbettii allusivi
e filosofia spicciola avrebbe rivelato tutti i suoi limiti,
la sua velleitaria baldanza - appunto - adolescenziale.
Ben presto il rock mise in chiaro di poter dare molto
altro e di più, d'essere una faccenda - in ultima analisi
- adulta. Ultimi scampoli di simpatia per Liberi liberi,
anno 1989, poi tanti saluti al Blasco e alle sue vicissitudini di sedicente perseguitato, almeno per quanto
mi riguarda.
Eppure, come sappiamo, con quella strategia da outsider beffardo ma innocuo, con quella tenerezza stropicciata da alcolista mai pentito e lo sguardo da ragazzino
in un corpo sempre più bolso, s'è costruito una mitologia nazional-popolare che perdura, riaffermata periodicamente dal rito ciclopico nelle grandi chiese-stadio.
Oggi, alla soglia dei sessant'anni, Vasco ed il vaschismo
sembrano approdare ad un livello di consapevolezza
nuovo, che permette al signor Rossi di gettare la maschera - dopo gli atroci look da supergiovane - sulla
mezza età terminale. Questo Vivere o niente, sedicesimo album in repertorio, è infatti una specie di concept
sulla "maturità matura", sulla persistenza tra le cose vive,
sull'esserci ancora nonostante tutto in compagnia dei
soliti vizi e vezzi. Biascicando cioè i ben noti turbamenti
esistenziali, balbettando le stesse beffarde allusioni, dipingendosi come un sempre più improbabile outsider,
ma con una differenza sostanziale: d'un tratto Vasco è
diventato un anziano signore.
Non a caso nel video di Eh... già lui, il Komandante, colui
che dicono essere l'unica rock star italiana, sembra il gemello di Vitellozzo, un vecio sul punto di andare al bar
per la partitina a carte e un bicchiere di vino. Uno che
può quindi permettersi di confessar burlando la crisi
spirituale (Manifesto futurista della nuova umanità) e lo
scetticismo riguardo al progresso tecnologico (L'aquilone), per poi prodigare consigli paterni disseminandoli
di strisciante pessimismo (Prendi la strada). Su questa
falsariga c'erano le premesse per sfornare un disco al-
meno dignitoso, nobilitato per così dire dalla sopravvenuta devastante disillusione che finalmente consentiva
all'uomo di prevalere sul personaggio. E invece, macché: c'era da riempire la scaletta, blandire il target, tenere in piedi l'avatar.
Allora avanti coi rockacci tragicomici in overdose da
viagra (Sei pazza di me, Non sei quella che eri), con le
scialberie sentimentali (la quanto mai uggiosa Stammi
vicino), con l'innodia impettita (quella sorta di prequel
883 di Dici che) e con la vacua inquietudine masticata
dalla title track. Il tutto confezionato con la consueta
mega produzione bidimensionale (circa venticinque i
musicisti coinvolti, diretti dal sodale Guido Elmi) perseguendo un'idea sonica disarmante, cristallizzata più o
meno a fine anni Ottanta e senza neanche uno straccio
d'alibi po-mo (che poi forse è anche meglio). Non è il
caso tuttavia di eccedere col biasimo: in tempi di diffusa
regressione adolescenziale, coi gadget (e spesso l'imitazione di essi) elevati al rango di valori, un linguaggio
del genere può ben dirsi emblematico. E passi se ha
l'impudenza di spacciarsi rock.
(4.5/10)
Stefano Solventi
Vivian Girls - Share The Joy (Polyvinyl
Records, Aprile 2011)
Genere: sixties-pop
Traslocate dalla garage-oriented In The Red ad una stilisticamente più varia Polyvinyl, persa per strada anche la
batterista Ali Koehler (dopo la fondatrice Frankie Rose
migrata verso Frankie Rose And The Outs) e disseminati progetti laterali a destra e a manca (The Babies e
La Sera gli ultimi in ordine di tempo), “Kickball” Katy
Goodman e Cassie “Ramone” Grzymkowski reclutano
Fiona Campbell dietro le pelli e se ne escono con l’ennesimo disco di godibile garage-pop virato psych-sixties.
Novità e sorprese però sembrano purtroppo finire qui,
relegate nel limbo del gossip rock’n’roll, nonostante
Share The Joy cerchi di dare una sferzata al sound del terzetto, impostandolo su varianti e differenze strutturali.
L’acceso dinamismo della new entry, soprattutto, fa da
asse portante a pezzi come Lake House, un punk’n’roll
vertiginoso, Vanishing Of Time o la tribaloide Trying To
Pretend. Nello stesso tempo sembra aver reso più grintoso il sound delle Vivians, come testimonia l’atmosfera
da riot-grrrl ingentilite meets americana di Sixteen Ways
o la lunga, conclusiva Light In Your Eyes, in cui si respirano umori vagamente velvettiani.
Resta però un senso di amaro in bocca per come le tre
si siano assestate su una formula rodata e che, pur non
mostrando la corda, le relega ad una aurea mediocri-
tas. Chiaro che ipotizzare una qualsivoglia via di fuga è
alquanto arduo (diluire il respiro? spingere sulla psichedelia? darsi al twee-pop tout-court?) ma forse sembra
l’unico modo per sfuggire al rapido oblio. Insomma,
quello che si supponeva (o sperava) potesse essere il
disco della definitiva consacrazione, è invece quello
dell’assestamento e della standardizzazione in un limbo da istantanea noise-pop.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Volkwerk Folletto - Volkwerk Folletto (I
Dischi del Folletto, Maggio 2011)
Genere: kraut
Prima pagina: dedica di apprezzamento di Hans Joachim Roedelius. Già dice molto, se la si incontra appena si apre il sofisticato libretto interno di Volkwerk Folletto. Sembrerà retorico sottolinearlo, ma raramente il
packaging è stato così determinante nel giudicare un
disco. Non per scelta del recensore, ma per strategia di
visibilità neanche troppo celata. Il CD di Volkwerk Folletto è incernierato su un sacchetto da aspirapolvere.
Il progetto di Andrea Renzini e Gian Luca Patini è una
sorta di détorunement, un lavoro dialettico. Ce lo ricorda, dopo la frase di Roedelius, un breve saggio di Toni
Negri, personaggio quanto mai inserito in una militanza che lega la propria comprensibilità al passato. Per la
proprietà transitiva, Volkwerk Folletto è un incrocio
di immaginari, di culture. Un aspirapolvere italiano che
sottrae linfa residuale da un quartiere operaio tedesco.
La metafora si arricchisce, se consideriamo la duplice meccanicità operosa che ha permesso il krautrock
di raggiungere picchi così alti. Da un lato, il sound. Il
motorik come espressione musicale di una catena di
montaggio. Dall’altro, la collettività al lavoro. La coincidenza di tante teste eccellenti tutte dedicate a costruire una pratica estetica. E chi la ama ne seguirà i
paesaggi nel lavoro di Renzini. È un disco per chi si
scioglie sempre quando ascolta un motorik filologicamente ragionato - quindi non squisitamente compilativo, ma esplicitamente derivato, con passaggi logici
abbastanza evidenti. Cal Neva Lodge è da manuale
Neu! virata in down tempo; Gilera è da manuale Neu! e
basta. Lyndon Grinch è invece un thriller sottocutaneo.
Un modo di esprimere l’inquietudine Klaus Schulzeiana, synth-etica e “analogetica”, ovvero basata sulla
pratica dell’analogico come scelta quasi deontologica. Un lavoro di ricerca, potremmo dire, prima che di
espressione.
L’obiettivo è concentrare in un sacco di carta tutta la
polvere cosmica di cui si è capaci (anche la meno cru81
highlight
Yuck - Yuck (Fat Possum, Febbraio 2011)
Genere: 90s indie
Dopo il revival Eighties che ha contraddistinto l'ultimo periodo, era ora che un pugno di poco più che
ventenni spostasse l'asse del tempo alla decade successiva, andando a spolverare il catalogo di Dinosaur Jr., Sonic Youth e compagnia. Daniel Blumberg (chitarra e voce), Max Bloom (chitarra e voce), Mariko Doi (basso) e Johnny Rogoff (batteria) sviluppano una nostalgia per quel
sound senza aver vissuto in diretta il periodo a cui fa riferimento. Il loro è un
mondo costruito nelle camerette, spulciando last.fm, discogs e compagnia
web 2.0. Questa costruzione di un immaginario e di un mondo così preciso,
trova corrispondenza nella sospensione dei confini, nei trattati di Schengen
della musica via Internet per cui puoi suonare americanissimo anche se vieni
dal nord di Londra.
Aprendo con Get Away che sembra cantata da J Mascis, proseguendo per
Shook Down che sembra un'outtake di Grand Prix dei Teenage Fanclub,
passando per Operation che sembra venire fuori da Teenage Riot dei sonici newyorkesi, una Georgia
che brilla di meravigliose sfumature twee, toccando financo la slaker-attitude nella sua coda di chitarre
"grasse" di Rubber, l'atto compositivo dei quattro rimane lontano dal semplice esercizio calligrafico.
Perché il grande pregio di Yuck è di farti pensare costantemente "Ehi dove ho già sentito questo arrangiamento? E questo suono di chitarra? E questo modo di cantare?", ma incastonandolo in dodici piccole
perle di pop declinato lo-fi e shoegaze che non è facile trovare in giro. Per ora queste gemme luccicano
di luce riflessa, ma non è detto che non prendano presto a rifulgere autonomamente.
Alla voce "yuck" il Cambridge Dictionary recita "esclamazione che sta per espressione di disgusto". Aggiungete una nuova definizione, grazie.
(7.2/10)
Marco Boscolo
da, in falò). Volkwerk Folletto dimostra di non voler
seguire il consiglio di Toni Negri: “svuotate la poubelle
dell’aspirapolvere”. E noi consigliamo a tutto il progetto
di scrollarsi di dosso le giustificazioni intellettuali. Come
quando si usa un elettrodomestico.
(7/10)
Gaspare Caliri
Waines - STO (3Waines.Org, Aprile 2011)
Genere: blues
Arrivati al secondo album STO i palermitani Waines si
confermano una delle novità più fresche e apprezzabili
provenienti dall’estremo sud italiano. Avevamo qui già
plaudito a suo tempo l’adrenalinico esordio tra blues e
pop, STU, di un paio di anni fa; ora, forte di un missaggio oltreoceano (ad opera di Mario J. McNulty che ha
lavorato per David Bowie, NIN, Laurie Anderson tra
gli altri) il trio ritorna con un album compatto che fa del
blues il suo credo assoluto.
Due chitarre e una batteria per un suono potente, ve82
loce e adrenalinico che non conosce battute di arresto;
siamo dalle parti di Led Zeppelin, Allman Brothers, AC/
DC, White Stripes, il Beck più sporco, ma anche il glamrock di T-Rex e le melodicità dei Beatles, oltre al blues
del Delta di riferimento. Il tutto rivisitato alla maniera
Waines, con tocchi pop e non solo, si vedano le pennellate glam, la onnipresente melodia sempre marchio
di fabbrica del gruppo siciliano e i tocchi psych che rendono STO album godibilissimo e dal respiro europeo;
la band ha avuto infatti un buon seguito oltralpe con il
precedente lavoro.
Una gradita riconferma per un gruppo ormai adulto.
(7.3/10)
Teresa Greco
Who Made Who - Knee Deep (Kompakt,
Aprile 2011)
Genere: electro pop
Lo senti che c’è un qualcosa di strano nell’ultimo disco dei tre danesi. Come una patina di sconforto, di
darkness che quasi quasi la associ (molto lontanamente) a certi echi Doors (Every Minute Alone e la citazione
testuale in Nothing Has Changed di People Are Strange).
Il motivo è presto detto: scazzi con le major (passano da
Gomma a Kompakt), problemi matrimoniali e pure case
incendiate per qualche membro del gruppo.
Visto però che gli LCD Soundsystem non li possiamo
più ascoltare (se non altro per overdose), questo midlength è un promettente sostituto: una cosa che tira
in ballo l’eredità di Murphy, coniugandola con Bowie
(All That I Am), Hercules And Love Affair (Nothing Has
Changed ispiratissima) e la New York del nightclubbing;
come aveva qualche tempo fa anticipato il cantante
Bon Homme in un suo progetto solista, qui si guarda
molto a se stessi e il narcisismo alle volte può risultare fruttuoso. Rinchiusi in un hotel di Copenhagen, i tre
hanno passato l’inverno 2010 a scrivere canzoni. Il set
più riflessivo ce l’abbiamo sottomano, l’altra selezione
- di cui non è stato pubblicizzato alcunché e che probabilmente verrà considerata il vero e proprio album uscirà entro la fine di quest’anno.
I riferimenti alle poetiche di Talking Heads, Jimmy Somerville e Depeche Mode (tre pilastri su cui si basa da
sempre il suono del gruppo) non scompaiono, ma vengono usati in maniera cosciente, selezionando citazioni
sporadiche, puntando su una consapevolezza e maturità sonora che al terzo lavoro finalmente esce fuori e soprattutto sta in piedi. Connessioni dichiarate alla stampa con 'le produzioni psichedeliche dei 60' (We’re Alive, It’s
A Miracle), progressività pop (555), il bel remix di Michael Mayer per Every Minute Alone e un sentire più pop
(There’s An Answer con le vocals in quoting di Anthony) che smussa la direzione smascellata dell’etichetta
di Cologna, sono tutti ingredienti che contribuiscono a
rendere Knee Deep un lavoro pregevole. Da ascoltare in
loop prima del full.
(7/10)
Marco Braggion
Wild Beasts - Smother (Domino, Maggio
2011)
Genere: art pop
Chi pensava - non senza qualche buon motivo - che i
Wild Beasts fossero l'ennesima effimera stellina nel
firmamento del pop-rock d'Albione, deve ricredersi,
almeno per il momento. Col terzo album Smother i
quattro ragazzi di Kendal consolidano la posizione di
prestigio guadagnata col buon sophomore Two Dancers. Ci riescono confezionando un programma che al
solito intrattiene stemperando languore, dinamismo,
melodramma, astrazione e giusto quel pizzico d'inquie-
tudine ad insaporire. C'è molto soul ma come dire omeopatico, reso avatar di se stesso da un processo di ibridazione post-wave, di decantazione tra struggimenti
art-pop e intellighenzia danzereccia, di trasfigurazione
sulla spuma di ben meditate fantasmagorie androidi.
Non è eccellente la scrittura, non sorprendono gli arrangiamenti, ma convincono le situazioni ed il loro susseguirsi piano, con morbide svolte stilistiche e d'umore,
come un mantra lenitivo. L'alternarsi delle voci (quella
tenorile - pomposa e soave - di Hayden Thorpe, quella
baritonale di Tom Fleming) è il dualismo più evidente di
un disco che gioca a far coesistere calligrafie così lontane così vicine, un carosello d'incontri utopici per combinazioni poco probabili eppure fruttuosi tipo Antony
e Brian Eno, Tindersticks e Morrissey, David Byrne
e Horace Andy, Mark Hollis ed Hercules And Love
Affair. Tutto ciò accade con una levità sciropposa che
finisce col suonare convincente traccia dopo traccia:
l'ipnotica Loop The Loop, la svenevole Albatross, la palpitante Reach A Bit Further e la post-tribale Bed Of Nails
su tutte.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Wolfram - Wolfram (Permanent Vacation,
Marzo 2011)
Genere: eurodance revival
Che Wolfram Eckert fosse un pieno estimatore della
dance anni '90 era già noto a tutti, a partire dalle prime uscite a nome Diskokaine e marfloW. Stupisce lo
stesso constatare che il suo primo album metta in scena
una plateale operazione di revival eurodance, con tanto
di protagonisti del passato (tra le collaborazioni troviamo il Paul Parker di Right On Target e l'Haddaway (!) di
What Is Love).
Se il rispolvero di un'estetica ormai storicizzata può facilmente condurre a risultati poco apprezzabili, l'esperienza ci insegna che nel farlo si può altresì destare nuovo interesse: lo dimostrano in questi stessi giorni gente
come Mirrors o Holy Ghost! in territori affini. Qui però
è la fittissima girandola di collaborazioni a buttare troppo fumo negli occhi (quasi ogni traccia è un featuring).
A nebbia diradata ciò che emerge è una sostanziale
aderenza al classico tale-e-quale, con un piglio tanto
fedele che alla fine si accartoccia su se stesso.
A distinguersi rimangono i soliti Hercules And Love Affair in Fireworks (una bomba nu-disco degna di Blind),
e Patrick Pulsinger, con l'electro house di Teamgeist in
stile Shit Robot. C'è anche spazio per un paio di riuscite
atmosfere ambient-electro (Roshi e So Fine All The Time
con il krautismo vocoderato del buon Legowelt), ma il
83
resto è frutto di un innamoramento cieco verso sonorità che hanno più di qualche dito di polvere. E di cui, ci
scuseranno i qui presenti Sally Shapiro, Sebastian Muravchik e lo stesso Wolfram, oggi si può fare volentieri
a meno.
(5.5/10)
Carlo Affatigato
Wombats (The) - This Modern Glitch (14th
Floor, Aprile 2011)
Genere: Indie-Pop
Quando A Guide To Love, Loss And Desperation uscì, a fine
2007, gli Wombats parvero i fanalini di coda di un'ondata wave ridotta a puro biz per indie-kids da club londinese. Let's Dance To Joy Division ne fu una più o meno
consapevole autoparodia e soprattutto un grande successo in un panorama pop inglese che, di fatto, aveva
già lo sguardo altrove.
This Modern Glitch ripete lo stesso canvaccio in fuori
synch: episodi gradevoli - Jump Into The Fog e Tokyo
(Vampires & Wolves) - altri trascurabili (Techno Fan), altri
ancora evitabili (Walking Disasters) ma niente che sfondi o colpisca le radio. E così i difetti risaltano e il ritardo
con i quale i ragazzi si presentano all'appuntamento
con le synth wave è ancora più evidente. Ciliegina: il ricorso a certi 90s di Anti-D - archi scopiazzati da Verve o
Oasis - che sembra la nuova Wonderwall senza avere i
crismi nè i numeri per esserlo.
Il prossimo disco degli Wombats sarà sicuramente un
disco grunge. E arriverà in ritardo...
(5.5/10)
Zwischenwelt - Paranormale Aktivitat
(Rephlex, Marzo 2011)
Genere: dark electro
Annunciato già da un anno, vede finalmente la luce il
progetto di Heinrich Mueller, ovvero il moniker deutsch
di Gerald Donald, già noto alla Rephlex per le produzioni a nome Arpanet e ovviamente Drexciya. L’album
ispirato alle immagini e alle idee di una dimensione parallela nasce dalla collaborazione tra il detroitiano e
un trittico di gelide donne electro, la DJ newyorchese
Susana Correia, la producer spagnola Penelope Lopez
e la vocalist tedesca Beta Evers. I quattro esplorano
quella tabula rasa elettrificata che dalla centrale elettrica di Kraftwerk-iana memoria porta alle morbosità
pre-Techno dei Throbbing Gristle di 20 Jazzfunk Greats (Enigmata), il tutto dominato dalle classiche fisse di
Donald: atmosfere da dopobomba carpenteriano, coolness da deserto urbano, cold wave con allusioni fetish
e para nazi.
Lo scavo nel pre-techno 80s della Rephlex continua
dunque con un lavoro affascinante, senza compromessi
e destinato agli ultra puristi. Una sola traccia (Telemetric)
in cassa quattro, il resto però evidenzia anche la mancanza di una presenza vocale di carattere e esperienza. (6.5/10)
Edoardo Bridda
Simone Madrau
84
85
Speciale
no col ritmo, con la tranquillità di chi pare non stia facendo la minima fatica ad alternarsi tra chitarra, tastiere
e parco giochi d’effetti portatosi da casa.
Dave Konopka è forse il componente del gruppo che
fa un vero salto di qualità dopo il divorzio da Tyondai.
Dimostra di saper straziare le corde del suo basso come
mai prima d’ora potendosi permettere soli ed assoli e
reclamando spazio per loop e distorsioni capaci di durare minuti e minuti.
Infine John Stainer, già da definirsi mostruoso, ora va oltre. Batteria che conclude il trasloco al centro del palco,
acquistando più spazio e ancor più importanza nell’economia del live. Sinceramente non ho contato quante
camicie abbia sudato e cambiato o quante bottigliette
d’acqua abbia scolato, ciò che fa semplicemente impressione è quanto pesti duro e con quanta precisione
riesca comunque ad “assestare” ogni colpo.
La dipartita di Tyondai Braxton, però, non solo ha lasciato i colleghi senza il quarto per il poker, ma li ha pure
privati della voce. E perso il vocalist cosa accade? Chi
non avesse ancora ascoltato i singoli reperibili in rete
avrà 3 sorprese, come successo al pubblico del Parenti quando, alle spalle di Jon Stainer, due pannelli fino
a quel momento semplici elementi della scenografia,
s’illuminano e sulle note di Sweetie & shag mostrano il
faccino di Kazu Makino (voce dei Blonde Redhead) diffondendone la voce.
Live Report
Ice creamche gode della partecipazione di Matias
Aguayo e My machines con ospite Gary Numan seguono il medesimo colpo di scena. Trovata che lascia un po’
straniti: chi si era abituato a Tyondai, si ricorderà e reclamerà sempre la sua singolarità, la sua voce posseduta,
sostituirlo con playback in 2d non convince del tutto,
nonostante l’effetto sorpresa.
Anche Gloss drop sembra muoversi su binari diversi dal
precedente e ormai consumato (dopo 4 anni di ribalta)
Mirrored. I brani presentati, non fosse per la devastante
batteria, lasciano da parte la metodica distruzione che
era marchio di fabbrica Battles, per guadagnare melodie e ritmi da electro-pop.
Ma allora vuoi vedere che chi s’è presentato alla cassa
semplicemente per ballare, non aveva sbagliato luogo
ne gruppo.
Marco Canepari
Architecture in Helsinki
26 Aprile / Magnolia / Milano
Mi ci ero appassionato a loro, vittima del tanto carino
quanto, in fin dei conti, inoffensivo passato. Mi ci ero
appassionato al punto di non credere a quanti mi descrivevano la loro deriva disco pop anni ‘80. Che il pop
degli Architecture in Helsinki era una cosa, il pop plasticone di trent’anni fa un’altra. Purtroppo era invece tutto
vero. Ascoltato il disco, visto il concerto che lo presen-
Architecture in Helsinki
Battles
Battles (The)
17 Aprile / Teatro F. Parenti / Milano
No, Atlas non l’hanno fatta.
Spiace deludere subito, così senza introduzioni ne mezze misure, ma dato che sembrava l’unica domanda le
bocche presenti al teatro Parenti pronunciassero, meglio mettere le cose in chiaro. Ed essendo Atlas l’unico
brano che (e non esagero) l’80% delle bocche al teatro
Parenti conoscessero, in un certo senso è stata una goduria. Anche se, confesso, un concerto dei Battles senza poter gustarsi il loro singolo di maggior successo,
lascia un po’ affamati. Con quella sensazione da “manca
qualcosa”... Basta saperlo per le prossime volte.
Il pericolo di chiamare gruppi così “estremi” per concerti così popolari (prezzo ottimo e teatro stracolmo di
conseguenza, senza il minimo spazio per ballare, muoversi, respirare) è sempre il solito: quasi la totalità del
pubblico non sa a cosa sta andando incontro. Se poi,
86
nella scheda di presentazione, oltre ad Atlas, si richiama
solo al singolo dato in pasto ai vampiri d’Eclipse, si può
immaginare chi si sia presentato all’ingresso del teatro.
Gente che pensava ad un nuovo fenomeno dark, altri
esaltati per poter finalmente ballare Atlas, altri ancora
che “i Battles ci piacciono, li hanno passati anche su radiodj!”
Il solito spreco in fin dei conti, perché la serata milanese è davvero particolare per il trio: presentazione
ufficiale del prossimo nascituro di casa Warp e una delle
ultime prove generali prima di portare in giro il carrozzone del tour. Qualche domanda sulla resa di un gruppo che poco più di 6 mesi prima ha perso il suo, se è
concesso scrivere, frontman è obbligatoria. Ma la risposta, se un minimo li conoscete, è anch’essa inevitabile: i
3 rimasti si fanno un culo doppio. Ian Williams sul palco
sembra tornare bambino, espressioni goduriose ogni
volta che libera un sample, mani lunghe che si muovo87
tava... deriva è anche termine simpatico: qui s’affonda
lentamente.
Hai voglia a presentare un regalo avvolto in carta
sbarluscichenta, mille pailettes e glitterato da testa a
piedi: lo specchio per allodole può funzionare la prima
mezz’ora, alla lunga però il trucco si squaglia, cola e mostra zampe di gallina, rughe e occhiaie.
Peccato perché il Magnolia s’era addobbato a festa:
strobo e led che sembrava il polline degli alberi del parco dell’Idroscalo avesse invaso anche il locale, pienone
(anche se ormai a Milano non sai più quando ci sia vero
pienone o quando le autorità abbiano intimato di non
far più entrare gente) e sfilata di costumi da parte del
pubblico, che Arlecchino veste sobrio a confronto.
Ma doveva essere il tripudio del “pensapositivo” e il
gruppo di Melbourne la sua voce, quindi niente in contrario. Il parere però cambia quando comprendi che dal
“pensapositivo” si sia passati a uno sconsolante “non
pensare che fai prima”. E ancora più sconsolante vedere
il pubblico seguire alla lettera l’indicazione.
Balli sincopati su basi da Ricchi e Poveri; maschere da fan della prima ora, poi però, appena partono le note di Do the whirlwind, tutti a chiedersi che
canzone fosse mai quella; sorrisi di ricambio a 32
denti quando Cameron Bird si mette a discorrere del più e del meno salvo poi impallidire al primo
sintetizzatore che comincia a fare il suo compito.
Dire che il gruppo non faccia il suo dovere sarebbe però
un crimine: gli Architecture in Helsinki suonano e suonano bene assieme. Cameron Bird e Kellie Sunderland
si distribuiscono sapientemente le parti vocali, dandosi
cambi che neanche perfetti staffettisti. Chitarre e tastiere (3 tastiere) van d’amore e d’accordo ricreando atmosfere da Duran Duran dei tempi migliori (se ce ne sono
mai stati). Resa dei brani dell’ultimo album curata nei
minimi dettagli e si nota. Sembra quasi un concerto in
playback tanto tutto è perfetto, troppo perfetto, quasi
di plastica.
E te ne accorgi quando vengono riproposte vecchie
conoscenze: la già nominata Do the whirlwind, Wishbone. Altro livello, l’imprevedibilità, la gioia di un arrangiamento un filo differente. Da parenti stretti degli Of
Montreal a brutte copie degli I’m from Barcelona.
Marco Canepari
Thousands
06 Aprile / Grand Social / Dublino
Il Grand Social è un locale affascinante sito nel centro
di Dublino, a metà strada tra il classico pub, caldo ed
accogliente, e una sala da ballo campagnola, con teli
colorati attaccati al soffitto illuminati a tratti da file di
88
lampadine. Questa è la location del debutto irlandese
dei Thousands. I Thousands, duo squisitamente folk di
Seattle, al secolo Kristian Garrard e Luke Bergman, sono
da poco usciti con il loro primo album, The Sound of
Everything, un lavoro basato su un solido finger picking
e intricate melodie vocali, semplice e diretto all’ascolto,
che è la perfetta premessa per un concerto tranquillo,
velato qua e là da un po’ di malinconia.
Dopo l’esibizione di un folksinger locale in apertura, Owensie, ecco i ragazzi salire sul palco: due chitarre
acustiche e due microfoni sono tutto quello che serve,
oltre a poche parole un po’ impacciate di ringraziamento. Poi un’ora e mezza di musica suadente e affascinante, un’incantata parentesi atemporale, lontana anni
luce dal caos di Temple Bar e dei suoi pub affollati di turisti. I pezzi di The Sound of Everything scivolano via uno
dopo l’altro, senza incertezze né intoppi, nonostante la
complessità di alcuni passaggi. Sembra di essere a un
house concert vista l’intimità della serata e l’ambiente
relativamente ristretto. Il pubblico tiene il fiato sospeso
per non fare rumore, creando un silenzio ovattato in cui
è possibile distinguere ogni più piccola sfumatura della
musica. Pezzi come Sun Cuz, Love Won’t Come, Red Seagullis, On and On, Mtses III, già piacevoli nella versione
dell’album, sembrano addirittura più convincenti dal
vivo.
Garrard e Bergman, come due novelli Simon & Garfunkel, stregano gli ascoltatori con le loro note cristalline, aggiungendo alla scaletta anche un paio di inediti.
Certo, sulla presenza scenica c’è forse ancora un po’ da
lavorare, ma sull’impatto che le canzoni dei Thousands
hanno sul pubblico non c’è niente da ridire: o le ami per
la loro semplicità, o le odi per il medesimo motivo, e il
pubblico della Grand Social le ha sicuramente amate.
Francesca Ferrari
James Blake
21 Aprile / Magazzini Generali / Milano
Spostato all’ultimo minuto dall’oscura location a Lambrate ai rodatissimi Magazzini Generali (con un pubblico a occhio e croce raddoppiato rispetto alle selezioni
fatte via Facebook), il primo e - pare - unico concerto
italiano di James Blake per il 2011 è certamente un
evento. Ci sono i musicisti (senza troppo sporgere il
collo intravediamo tra la folla gli Aucan e - ci dicono
- i Crookers; becchiamo anche un paio di amici produttori wonkytaliani), ci sono gli addetti ai lavori, ci sono i
dubsteppiani di lungo corso, ma soprattutto i newbie
infatuati di questo dubstep arty tagliato con il bisturi
per piacere agli indie cresciuti con i Radiohead prima
e Burial poi.
chiassoso sui pezzi più slow e più soft). James insomma
alla fine non delude, anche perché, oltre i feticismi produttivi e timbrici, i pezzi sono quelli e sono belle canzoni, punto, basta una buona interpretazione, intensa,
sentita, per esaltarle. Resta però l’idea che per quello
che propone, soprattutto in questa vesta suonata (questo trio stripped down voce/tastiere, chitarra/effetti e
batteria/pad), James dovrebbe fare concerti alle tre di
notte in club per massimo cinquanta persone.
Piccola curiosità: vediamo James sfrecciare tra il
pubblico prima del concerto almeno un paio di volte,
altissimo, efebico, inglesissimo nella sua camicia di raso
bleu, ma nessuno pare riconoscerlo.
Gabriele Marino
Belle And Sebastian
14 Aprile / Alcatraz / Milano
james blake
Dopo un gruppo spalla non meglio identificato (un
duo abbastanza ectoplasmico che suona post-rock ambient), James parte - in strategico ritardo - con Unluck.
E parte abbastanza moscio. Gli ci vogliono un paio di
pezzi per scaldarsi ed entrare in serata. Si accende con il
mantra di I Never Learned To Share e con una Lindisfarne
che si scopre molto folkie con quell’arpeggino di chitarra. Il pubblico va un po’ a pilota automatico, applaude tutto con convinto entusiasmo, ma già da subito a
metà sala si parla come si fosse al pub, e per svegliarlo
dall’automatismo - e metterlo in riga - ci vuole un lungo
pezzo di dubstep burialiano da dancefloor, che finisce
con la cassa pestata in quattro. Ottima mossa. Il set è
breve come previsto, un’oretta scarsa, con la tracklist
dell’album passata quasi tutta in rassegna e il cuore di
tutto, ovviamente, in una Limit To Your Love che ormai è
cosa da accendini.
Amplificazione che tutto sommato regge, nonostante i superbassi ogni tanto ronzino, ma è proprio la
proposta di James ad essere messa alla prova, e ad uscire provata, dal passaggio sul palco, con tutti quei dettagli e quelle specificità che rendono speciale il disco
che finiscono fuori fuoco e stingono. Eravamo preparati
dai molti video visti sul Tubo (in location non sempre
azzeccate, tipo mega-festival all’aperto sotto il sole del
primo pomeriggio), con uno scenario non troppo diverso da quello dei Magazzini (ivi compreso il pubblico
“Quindi...t’è piaciuto?”
“Ma si dai, anche se rimpiango un po’ le atmosfere da
cameretta”
Al termine di un’ora e mezza di concerto, il succo è tutto in queste battute rubate all’uscita dell’Alcatraz. Un
gruppo che cresce e invecchia (bene). Che compie 15
anni di carriera, che dai Pastels passa alle matite colorate sino ai pennarelli di più largo consumo. E viene
accolto da un seconda generazione di fan, giovani giovani, che, come nota Stuart dal palco, “questa canzone
è del ‘97, forse molti di voi qui sotto son troppo giovani
per conoscerla”.
È un Alcatraz tutto esaurito che accoglie i Belle & Sebastian: biglietteria chiusa due ore prima del concerti,
tagliandi esauriti e bagarini, concetto incompatibile col
gruppo scozzese, a pasteggiare sulle finanze di chi cerca
d’entrare comunque. Ed essendo la loro unica data italiana, tutto previsto dato il successo di Write about love.
Il resto è pop. Ma un pop che comincia ad avere qualche difficoltà a definirsi ancora indie. Un pop che, come
anticipato, trasloca dalla cameretta e viene collocato in
salone, davanti a tutti, lucidato a puntino.
I Belle & Sebastian, dal vivo in particolare, tendono alla perfezione. Arrangiamenti che cambiano di
poco gli equilibri ma li puntualizzano, accompagnamenti d’archi che non vogliono innalzarsi a vette liriche ma semplicemente completare i vuoti e un impeto e un ardore che vanno sbiadendo concerto dopo
concerto. Inevitabile notarlo. Ma in fondo non è fiacchezza di motivazioni, è scoprirsi e riscoprirsi pacati.
Perché di questo si parla comprando un biglietto per vederli in carne, ossa chitarre e archi. Se ricerchi tranquillità, pace, sai che le troverai: marchio di fabbrica. L’atteggiamento della band non è mutato nel tempo, non
89
cercano di trascinarti sul palco (nonostante a due fortunate sia capitato nel corso della serata); t’accolgono,
ti abbracciano, scambiano parole e confidenze (per gli
amanti di gossip Stuart è sposato con una catanese), ma
ti lasciano in platea a bearti nei tuoi pensieri più morbidi.
Ciò per cui li benedici tutti, uno a uno, da Stuart Murdoch a Sarah Martin è l’offerta di spunti. Ogni volta che
la discografia s’arricchisce di un capitolo, sai che troverai
pane per i tuoi sentimenti. Le eccezioni son state rare.
E così via, un’ora e mezza di note per rivedersi lungo 15 anni. Si comincia da dove dovevano I don’t see it
coming (primo brano dell’ultimo album) e si conclude
con Me and the major (anno di grazia 1997). Nel mezzo passa di tutto: passano 7 album, 2 ep, predilezione
per Dear catastrophe waitress ma anche chicche con un
decennio abbondante sulle spalle come I’m waking up
on us, Legal man o una certa My wandering days are
over, tuffo al cuore da “c’eravamo tanto amati”. Passa e
viene metabolizzata senza rigetti l’opera ultima, con l’esecuzione di I’m not living in the real world con coro in
falsetto del pubblico tutto, “aizzato” da Stevie Jackson,
come uno dei momenti più alti della serata.
Sarà poi che solo 4 brani dei 22 suonati siano stati
presi da Write about love, sarà che la seconda generazione di fan, appiccicati alla transenna sotto il palco,
è comunque educata (musicalmente) bene, sarà che
Sleep the clock around l’hai ormai “consumata”... Però,
in fondo, non ti senti più in dovere di preservarli dalla
massa. La massa li ha ormai raggiunti: inevitabile, quindi, che in cameretta non sia rimasto più spazio.
Marco Canepari
Live Footage
13 Aprile / Jesce Sole / Viterbo
La resistenza passa anche per l’appropriazione di spazi
o la creazione di eventi dove l’asfittico panorama sembra essere appena stato attraversato da Attila. Questo
in definitiva ciò che i ragazzi di Allimprovviso – gente
del giro Winter Beach Disco e della netlabel SubTerra
– stanno facendo da un po’ di tempo a questa parte nella depressa e “pidiellizzata” Viterbo con concerti, letture,
spettacoli tra situazionismo di provincia e azione diretta in luoghi non canonici (negozi di thè, cantine, vicoli
del quartiere medievale) ma altamente affascinanti.
In questa serie di iniziative si colloca anche il live dei
Live Footage, cinematico duo newyorchese in questi
giorni in pieno tour europeo, già apprezzato col fulllength Willow Be qualche mese fa. La formula minimal(classical)-electro di Mike Theis e Topu Lyo da vivo acquisisce però sfumature ulteriori facendosi apprezzare
per coinvolgimento e grado di evocazione.
90
Elegantemente fasciati in sobri vestiti giacca & cravatta, l’uno (Theis) a batteria, tastiere e live-processing,
l’altro (Lyo) a violoncello, loops e effettistica varia, i
newyorchesi si calano perfettamente nel mood dello
scantinato medievale che li ospita e tirano giù un set di
un’ora e mezza in cui atmosfere lounge e sperimentazione strumentale, delicatezze dreaming e visionarietà
cinematografica, post-rock concreto e umorale jazz in
bassa battuta si mescolano in un flusso sonoro visionario ed evocativo. Musicisti altamente preparati e appassionati, capaci di conquistare un pubblico attento e
curioso anche con rendition “neo-classiche” e credibili
di pezzi pop (Janet Jackson e Rhianna). L’ennesima dimostrazione che la buona musica non passa per nomi
altisonanti o grossi investimenti, ma solo per passione e
creatività. Quella che i Live Footage e i ragazzi di Allimprovviso non hanno fatto mancare stasera.
Stefano Pifferi
Anna Calvi
10 A prile / B ronson / R avenna
Inizia alle 23 e dura solo quarantacinque minuti l’attesissimo concerto di Anna Calvi al Bronson di Ravenna.
E’ questa l’unica pecca di un live intenso come ci si sarebbe potuti aspettare e perfettamente rappresentativo di un omonimo esordio che spedisce di diritto la
cantante inglese nell’empireo dei potenziali “big”. Glaciale, irresistibile, raffinata come una ballerina di tango
con camicia rossa e capelli imbrillantinati, la Calvi sembra quasi un replicante. Un Roy Batty dai sorrisi tenui
e talvolta dovuti che non sai bene se stia li a recitare,
soffra di una timidezza cronica – ma è difficile pensarlo
sentendola cantare – o ci creda talmente da riuscire a
estraniarsi al pari di una Josephine Foster.
A dare una mano una chitarra supplementare, la
batteria di Daniel Maiden Wood ma soprattutto una
Mally Harpaz metronomica e fascinosa all’armonium e
alle percussioni. Pochi colori ma fondamentali nell’ottica di un suono che nonostante l’ampio ventaglio di riferimenti – per tutti i dubbi del caso c’è la recensione di
Stefano Solventi – si impone confini da rispettare legati
all’essenzialità del blues e del crooning più umorale.
Come dimostra una iniziale Rider To The Sea da deserto morriconiano in cui spiccano anche le doti tecniche
della Calvi alla chitarra o la cover della Surrender di Elvis
Presley impegnata a svelare insospettabili - ma plausibili - legami di parentela. Se Suzanne And I è Shirley
Bassey traviata dai Calexico, Desire si rivela il previsto
“riempipista” del gruppo, con quei crescendo à la Arcade Fire fin troppo esposti che il pubblico pressato di un
Bronson al limite del sold-out dimostra di apprezzare.
Già, il pubblico. La Calvi piace e a tutte le latitudini:
dall’indie-boy sul pezzo con la maglia a righe e il ciuffo
stiloso all’ascoltatore di RDS, dalla femminista alla femme fatale sofisticata, dal rocker attempato con l’ormone
nervoso al giornalista meno inserito. Per l’eleganza ricercata – e calcolata - misto di avvenenza e inquietudine, ma soprattutto per una voce impeccabile capace
di tracciare un trait d’union esemplare tra tradizione
americana, canzone europea e quella sensibilità legata
al “bel canto” che alla fine è soprattutto roba nostra. Alle
volte basta un cognome familiare su un profilo nordico
a farcela ricordare.
Fabrizio Zampighi
Massimo Volume
09 Aprile / Covo / Bologna
L’aura dei Massimo Volume necessitava di una doppia
serata celebrativa, un weekend tributo organizzato da
uno dei locali storici della loro Bologna, e dunque l’asfissiante Covo di un aprile già troppo sudato. E così è
stato. Il venerdì ha visto compiere quel tanto lieve incrociarsi tra i mai così lisergici Bachi da Pietra e i padri
fondatori Massimo Volume: un intrecciarsi mai così gradito, degna conclusione di un tour condiviso a dir poco
entusiasmante e di uno split delizioso tra scambi di cover e inediti che è già classico. Il sabato vede invecei fan
come illustri protagonisti, Mimì Clementi e compagnia
declamante a fare da jukebox: un modo per ripercorrere i “giochi d’ombra e gli altari di luce viva” dei Nostri.
La consueta passeggiata tra la folla cui sono – grazie
a Dio – costrette le band al Covo, introduce l’ipnotico
giro di basso di Atto Definitivo, storia di stenti e precarietà, la voce di Clementi trema sommersa dalla marzialità carveriana del cantato. Una partenza quasi delicata,
volutamente intimista, ben testimoniata dal racconto
di puttane e tradimenti di Senza un posto dove dormire;
uno scandire lento ed efficace come fosse una condanna a morte, una feroce litania che ben riassume la poetica dei Massimo Volume: l’ineluttabilità delle nostre
esistenze, la voce ancora incatenata di Clementi che
deve fare ancora i conti con cose di cui ha una conoscenza solo vaga, “la solitudine ad esempio”. Il rinnovato manifesto di questi anni Dieci, Le nostre ore contate,
restituisce i versi definitivi, “io non ti cerco non ti aspetto
ma non ti dimentico”, quasi a voler ristagnare nelle cattive abitudini cui ci hanno costretto: l’impossibilità delle
parole si sciolgono nel primo sorriso della band, finalmente pronti a farsi celebrare.
Egle Sommacal – sempre perfettamente assistito
dall’allievo Stefano Pilia – dà vita all’urlo scheletrico di
Meglio di uno specchio, nessuna pausa, pochi respiri e Il
primo dio sconvolge e si riflette nel grido sold out del
Covo, una frustata, quasi un obbligo a urlare nella pioggia. La recente – e già inno – Litio vede realmente Clementi declamare come fosse un De Niro allucinato (ma
molto più violento), Pilia si contorce sui ritmi di Vittoria
Burattini, la precisione fatta donna, Sommacal sostiene
il tutto travestendosi da rumorista. Coney Island è un
respiro iniziale nella sua aria così trasognata, deflagrante e incestuosa – vedi l’intreccio di chitarre – nella sua
coda improvvisa e infinita, il suono fatto circolarità, un
fantasma prende finalmente forma dai ricami chitarristici, Clementi regala sguardi come macigni alle prime
file. Dall’innocuo Club Privè viene scelta solo la sontuosa
e criptica Seychelles ’81, la distonia travolge ed è come
essere in una chiesa colorata eppure alcolica, le poche
luci intasano le menti.
Poi succede l’imprevisto, viene sbattuta in faccia al
pubblico una commovente Fuoco Fatuo, nelle prime
file un uomo - senza capelli solo basette - s’appoggia
al muro e piange, una ragazza lo consola, “è questo che
siamo?”. Mimì Clementi lo chiama presentandolo come,
“Leo, il protagonista delle mie storie”. Leo sale sul palco
e ringrazia tutti, dice che i Massimo Volume sono macchina vitale e necessaria, cita Karol Wojtyla parlando di
scopate, tutti ridono. Il protagonista di quasi tutte le
storie della serata ha un volto, manca solo Rigoni e il
suo inveire contro il mondo.
L’acustica Stagioni incanta così delicata e rasserenata laddove Ororo è purezza primordiale, perfetta conclusione, qualcosa di simile alla caduta degli Dei: c’è
chi salta, chi si commuove, chi si rannicchia, nessuno si
guarda indietro. I live dei Massimo Volume stanno diventando qualcosa di necessario, visti i tempi apatici,
qualcosa di irrinunciabile, perché a differenza di tutte le
altre band italiane restituisce solo poesia ed essenzialità, poche cose di cui tutti i presenti sembravano aver
bisogno.
Federico Pevere
91
Gimme Some
Inches #16
Questo mese a Gimmes 7 e 12 pollici direttamente da Buzz Aldrin e
Movie Star Junkies, Vulturum e EMA, Naked On The Vague e Fresh
& Onlys and many, many more. Che il giradischi sia con voi...
Torna alla grande la Hell Yes! di Marco Rapisarda dopo che quest’ultimo si è divertito con i Crocodiles
prima e con gli Smart Cops poi. E
se altrove leggete del primo vinile
lungo (E.S.P. dei Love Inks, a cui
faceva da intro il 7” Blackeye) la specialità della casa resta sempre il 7”,
spesso e volentieri in versione single-sided. Non sfuggono perciò alla
regola di casa HY gli ultimi due nati.
Cover The Sky, il 7” delle promesse
Reading Rainbow – Robbie Garcia
e Sarah Everton da Philadelphia – è
uno zuccherino psych-rock ruvido
e umorale quanto basta con la Everton a impreziosire il tutto con la sua
nenia da fata in cui rievoca slanci
emotivamente shoegaze (“Clouds
at night, they cover the sky. But I
still know the stars are behind”).
L’altro 7”, in uscita proprio in questi giorni, è invece appannaggio di
un nome molto caldo: EMA, il moniker dietro cui si cela l’ex Gowns
Erika Anderson. E per confermare
ciò che si dice della bionda chitar92
rista americana, e cioè che sia la più
dark tra le nuove chanteuse in solo,
ecco l’ennesima cover che nessuno
si aspetterebbe. Il lato A del singolo vede infatti EMA cimentarsi nella rilettura di un pezzo di Danzig,
Soul On Fire dal debutto omonimo
dell’ex Misfits. E la biondina non sfigura affatto al confronto: con la sua
voce oscillante tra profondità baritonali e slanci da rocker provetta e
una produzione cavernosa rende
al massimo quella che è un vero e
proprio omaggio, oltre che un gustoso anticipo dell’upcoming Past
Life Martyred Saints.
Passando a distanze più ampie
è la volta di una nuova puntata extra-confine per progetti collaterali
italiani. Stavolta sono i Buzz Aldrin
a gemmare un duo accasato presso
la londinese Robot Elephant: nome
in codice, Husband; personale ridotto al minimo (Gianlorenzo e
Chiara). Musica? Beh, qualcosa di
vagamente vicino alla casa madre
è rintracciabile: soprattutto l’acce-
so versante ritmico che impreziosisce i due pezzi che danno titolo al
12” Love Song/Slow Motion. Uscito in splendida edizione limitata
“marbled green” per il Record Store
Day e previsto per la metà di maggio il 12” (anche in versione digital
con 4 prescindibili remix tra italodisco, hypna-pop e altro, opera di
Soft Metals, Mascara, Sifaka Kong
e Wolther Goes Stranger) sciorina due pezzi mozzafiato. La nenia
post-tribal psych di Love Song e la
tempesta ritmica di Slow Motion in
cui sembrano dei Liars insieme invasati e indolenti, dicono di un progetto che non può non produrre un
full-length. È il mondo a richiederlo
a gran voce, ma nell’attesa ci si può
gustare il 7” split Buzz Aldrin/Movie Star Junkies appena rilasciato
dalla sarda Here I Stay. I primi in A
Monster Gun Into The Lover’s Mouth
triturano il r’n’r per come potevano
intenderlo gli Stooges alla maniera
dei Suicide se il duo Vega/Rev invece del blues avesse preso il punkrock come materia prima. Ossessivi,
ipnotici e luridi, con tanto di organo. Rispondono con Branches From
My Arms i torinesi alla loro maniera:
con un delirio post-caveiano urlato
e sgraziato, eppure fottutamente
intrigante.
Un altro 12” meritorio dell’attenzione generale è il ritorno dei
tre Vulturum (Alessio Leone, Luca
Battaglia e Nicola Ferloni). Vivi Di
Luce Riflessa, 12” gemello di Vineta e pubblicato da Sangue dischi
e Trips Und Traume, mostra il consueto psychedelic slow-core tra
spasmi atmosferici e nuove, affascinanti visioni. Se la lunga title track
è un trip malvagio tra post-core e
lentezze semi-doom, Voraussage è,
nelle loro parole, “una previsione,
una profezia, una versione alternativa di qualcosa di là da venire”
che si snoda tra chitarre acustiche,
sintetizzatori e oniriche visioni. Bel
passo avanti.
Voliamo ora verso il cuore
dell’underground statunitense, ovvero la Grande Mela da cui arrivano
un paio di EP pubblicati di fresco,
neanche a dirlo, dall’inesauribile
Sacred Bones. Il primo vede il ritorno su media lunghezza degli australiani Naked On The Vague che
continuano nella direzione presa con l’ultimo full-length Heaps
Of Nothing su Siltbreeze. Twelve
Dark Noons offre sei brani di postpunk a tinte scure, vagamente onirico e arabeggiante, in cui le voci di
Lucy Cliché e Matthew Hopkins si
alternano e si susseguono lungo i
sottili tappeti dei riff dell’elettrica e
i ritmi spezzati della batteria sullo
sfondo. Il secondo mini rilasciato
dalla label di Brooklyn è invece appannaggio di quei Fresh & Onlys
il cui Play It Strange tanto ci era
piaciuto. E proprio dall’album edito da In The Red lo scorso autunno
riparte Secret Walls, ma fin da subito la title-track ci svela una nuova
declinazione del sound della band:
arrangiamenti pop quasi barocchi,
melodiche cavalcate mid-tempo,
nessuna concessione alla frenesia
garage. Un interessante punto di
svolta per future evoluzioni, anche se doppiare il sopra-citato LP
non sarà facile. In patria invece ci
attende la cosmopolita Shit Music
For Shit People che rilascia Sliding
Deck, nuovo singolo dei Love Boat
in cui gli isolani più amati dello
Stivale snocciolano quattro pezzi
dal tipico tiro garage-folk solare e
spigliato che ha già avuto modo di
fare la felicità dei rockers di mezza
Europa grazie all’album pubblicato
su Alien Snatch! un paio di anni fa.
Ma anche la label romana raddoppia, questa volta con la tape di debutto di un nuovo progetto tutto
al femminile. Corpus Christi è infatti il frutto della nuovissima joint
venture tra Cristina dei Capputini ‘i
Lignu e Tina degli Intellectuals, al
debutto in speciale combutta con
l’americano Sam Crawford, qui
ospite al banjo. Sì perché le ragazze
di Roma rivisitano in versione casereccia (è il caso di dirlo) una bella
manciata di classici country, partendo dalla Carter Family e approdando a Johnny Cash, passando
ovviamente per Hank Williams. Per
chi ha nelle orecchie, e nel cuore,
l’immortale sound degli Appalacchi, Charity And Chastity è un ottimo modo per rispolverare vecchi
amori mai sopiti.
Stefano Pifferi, Andrea Napoli
93
Re-Boot
#15
Un mese di ascolti
emergenti italiani
Nostalgie wave, un pizzico di cantautorato destabilizzante e tanta voglia di psichedelia: la consueta immersione mensile nelle
acque pescose e irrequiete del rock emergente italico.
Siamo tra la Sicilia e Roma, con il
mondo immaginifico di El Senor
Pablo dalla provincia di Agrigento;
un EP omonimo (El Senor Pablo
1,autoprodotto, 6.9/10) di 5 pezzi
in cui cantautorato psichedelico
e ironico fa mostra di sé in modo
arguto. Echi Barrett-iani e Beatles
psych a volontà, tra elefanti rosa,
scarafaggi su strisce pedonali, scarabei, boschi di bambù e quant’altro, in un elenco snocciolato con
molto divertimento. Una buona
verve compositiva e una ispirazione fervida a livello di testi fanno di
questo EP un discreto biglietto da
visita. Bravo.
Ci spostiamo nel trevisano con
Lullabier, alias Andrea Vascellari, titolare della neonata netlabel,
specializzata in musica cantata in
italiano, che pubblica il suo album
Mai nulla di troppo (ViVeriVive,
6.9/10). Siamo in territori di psichedelia ’90 tanto cari a Galaxie
500, Low, Red House Painters e
94
compagnia slow folk. Atmosfere
sognanti e mantriche, con slowcore e shoegaze a farla da padrone;
il cantato si adatta perfettamente
alle melodie ipnotiche, e anche
dove talvolta prevale venendo fuori dalla musica con più decisione, il
risultato è godibile. Chi ha ragione
non ha bisogno di gridare, come recita la filosofia dietro al progetto
Lullabier.
l quintetto bresciano The Churchill Outfit è in pista da poco più
di un anno ma possiede già un
sound ben smerigliato, stringendo
le coordinate sul rock psichedelico
della cuspide Sessanta/Settanta
con un intreccio ben acido di chitarre e tastiere. Nell’ep di esordio
In Dark Times (Produzioni Dada,
6.8/10) l’attitudine per una visionarietà calda, più atmosferica che
trafelata, li porta a tratteggiare intensi bozzetti a metà strada tra Al
Stewart e Pink Floyd (The Circus
In Town), a riesumare certe sbri-
gliatezze Vanilla Fudge con tentazioni prog (Dark Times) per poi
dimostrarsi capaci di sciorinare
contemporaneità indie nella conclusiva Mr. Gavin, qualcosa tipo i
dEUS colti da languore Stephen
Malkmus. Se terranno a bada le
fregole nostalgiche potranno fare
buone cose.
Tornano a distanza di pochi
mesi i Poptones, stavolta con un
album tutto intero ancorché stringato, quasi un ep lungo a dire il
vero. Ma tant’è: questo The Major
Man (Miacameretta/Musica per organi Caldi, 7.1/10) ribadisce il piglio
indie dei tre frusinati aggiungendo
una più ficcante e disinvolta fregola wave/psych. Dietro il bailamme
acido e le manipolazioni sintetiche
s’intravede sempre un ghigno tra
il beffardo e l’insidioso, l’arguzia
facinorosa e un po’ invasata di chi
risale alla spinta primordiale del
garage conscio delle strategie destabilizzanti messe a punto da tipi
poco raccomandabili quali P.I.L.,
Stranglers, Clean, Jon Spencer
e Clinic. Una High Rise tanto rutilante quanto catchy ed il patema
surf trasfigurato di Baby sono forse
i momenti migliori d’una scaletta
tutta sinapsi e fulmicotone. Bravi.
Fin troppo radiofonico nei
suoni, ma col timone decisamente orientato verso l’America che
ci piace. Alla voce di questo Wild
Days (autoproduzione, 6.0/10)
sembra di sentire Eddie Vedder e
invece c’è Davide “Dave” Marella,
uno che sulla discografia dei Pearl Jam deve essersi fatto ben più
che le ossa. Anche se il disco, tra
il già citato gruppo di Seattle (The
Deepest Feeling), i R.e.m. (Let You
Go) e il Bruce Springsteen periodo E-street Band (Waiting For The
Wind To Come) si auto-parcheggia
su un classicismo stentoreo e poco
propenso ai salti nel vuoto. Entro i
limiti formali del caso, comunque,
tutto funziona a dovere, anche se
alla fine si tratta più di materia di
studio appassionato che di effettiva reinterpretazione dei canoni.
I Karate Lessons arrivano da
Cagliari e trovano il modo di mediare tra programming in odore di
glitch/dubstep, post rock e wave
britannica. Quattro i brani dell’EP
Will Improve My Self Confidence
(autoproduzione, 6.5/10), con una
Snake Rat strumentale che s’imparenta di diritto con la produzione dei Joy Division, una Gulliver
Weight circolare che richiama i Radiohead di un paio di ere fa, una
Old Grudge rubata alle chitarre di
Egle Sommacal dei Massimo Volume e vicina all’ambient. Si paga
pegno solo in chiusura, con una
cover di Decades meno efficacie
dell’originale ma coerente con le
aspirazioni del disco.
Copertina e art work sensazionali per i Yellow School Bus Factory, band valdostana che esce
con il primo Lp , Antistatic (autoprodotto, 7.1/10), mixato nientemeno che da Marco Fasolo dei
Jennifer Gentle. Si tratta di un
lavoro pieno di spunti, fra garage,
surf e psichedelia: dodici brani in
cui sembra di rivivere al meglio la
stagione del pop anni Sessanta, le
chitarre ritmiche, la voce riverberata, le code rumoristiche, ma mai
fuori luogo. Un disco nostalgico,
che riproduce bene l’atmosfera di
Who, Beatles e Byrds, ma sa be-
nissimo spaziare anche altrove, nel
revival surf-rock dei giorni d’oggi, ad esempio. Da non perdere. Un lungo sorso di tequila accompagna invece le nove delicatissime tracce di Berlino, New York,
Città del Messico (Controrecords,
7.1/10), nuovo lavoro del cantautore torinese Stefano Amen. Il suo
sound è soffice, ma al contempo
ironico e beffardo; è un soffio intimo, fatto di piccoli arpeggi e voci
sospirate sulla scia di quanto insegnato dal maestro Vinicio Capossela. Ma non solo: nelle liriche di
Amen c’è tutto un mondo, una visione politica del capitalismo perduto, dell’italietta del qualunquismo, dell’ignavia, il tutto all’ombra
di un mood da sedia a dondolo nel
bel mezzo del deserto americano,
fra un banjo e una armonica a bocca.
Stefano Solventi
95
L’ avvento
Yan Ruisheng
del
comunismo e il
controllo sulle arti
Ombre cinesi
China underground#6
Un’introduzione al cinema cinese dalle origini ai nostri giorni
C’erano una volta le ombre cinesi.
Intrecciavano storie per il pubblico
seduto al di là dello schermo, con
figure incise su pelle d’asino e riflesse da una potente fonte di luce. Un
proiettore, delle immagini riflesse
e uno schermo. Ecco perché quando il cinema arrivò in Cina, alla fine
dell’Ottocento, gli fu dato il nome di
“giochi d’ombra occidentali” (xīfāng
yĭngxì). Il cinema era allora un qualcosa di completamente sconosciuto, uno di quei prodigi tecnici che
l’arretrato dragone mirava con sospetto e stupore. In Cina nessuno
sapeva fare cinema. Le prime proiezioni furono solo di film stranieri
e la nascita dell’industria cinematografica cinese fu imprescindibile
dagli insegnamenti, dall’assistenza
di tecnici e dagli investimenti di avventurieri d’oltreoceano.
All’inizio del Ventesimo secolo, in
un periodo di crisi sistematica e fermenti riformisti-rivoluzionari, i cinematografi erano uno svago per tanti: gente in cerca di intrattenimento,
o incuriosita dalla fedeltà di imma96
gini in grado di riprodurre scene di
vita così simili alla realtà. O anche al
passo con le ultime mode, desiderosa di esotico, aperta all’Occidente e
al mondano. In pochi anni i cinema
spuntarono a centinaia, spesso con
vita breve, per mano di improvvisati impresari attratti dai margini
di guadagno e incuranti dei rischi.
Si racconta persino che la celebre
imperatrice vedova, Cixi, per il suo
settantesimo compleanno ricevette
in regalo dal Consolato inglese un
proiettore e delle tracce di film. Peccato che alla prima proiezione il generatore non resse e scoppiò, provocando un’ondata di panico e, in
virtù del cattivo presagio, un rigido
veto alla trasmissione di film dentro
il perimetro della Città proibita.
Il
primo film cinese
Yan Ruisheng, il primo lungometraggio cinese, uscì nel 1921. Girato da
Ren Pengnian, si trattava di una storia ispirata a un fatto di cronaca che
aveva fatto scalpore nella Shanghai
di primo Novecento, l’omicidio della
Zhang Yuan,
Jia Zhangke, Lou Ye
“regina di fiori” Wang Lianyang - tra
le più note concubine dei quartieri
di piacere - per mano di un uomo,
Yan Ruisheng. La sceneggiatura era
un riadattamento di un testo teatrale di Zheng Zhengqiu, uno dei
padri fondatori del cinema cinese,
nonché regista e critico teatrale. Yan
Ruisheng era un racconto dotato di
intenti realisti (la produzione chiese
ad un buon amico di Yan di recitare la parte dell’omicida e anche la
vittima fu interpretata da una exprostituta), faceva leva su una storia
avvincente, con al centro un omicidio e la fuga dell’assassino, mentre
la triste storia di Wang Lianyang
dava voce alla critica dell’ipocrisia
di una società viziosa e maschilista,
malcelata dietro le apparenze del
perbenismo.
In quegli anni Shanghai recitava
la parte della New York cinese. Una
società urbana sulla via della modernità e antitetica al mondo tradizionale, contadino e patriarcale.
La donna assurgeva a una sublimazione senza precedenti, ma anche
piena di rischi. Le attrici erano tra i
simboli di un immaginario di sedu-
zione, un oggetto di desiderio sessuale la cui immagine si confondeva
a tratti con quella delle concubine e
a tratti con quella delle femmes fatale che popolavano i quartieri di
piacere, incarnando le ambiguità
morali della vita cittadina. La società urbana cinese degli anni Venti e
Trenta era una realtà viva e in movimento, che culturalmente manifestava una forte volontà di rinnovamento, spesso radicale, iconoclasta.
Il cinema, nato come genere di intrattenimento, ne rimase in parte ai
margini, almeno fino agli anni Trenta, quando prese forma il cinema di
sinistra, che andava ad affiancarsi a
una serie di film maggiormente disimpegnati, impregnati di miti, leggende e storie di cappa e spada. Il
cinema di sinistra si fece strada con
il consolidamento di valori socialisti, contro la corruzione politica del
partito nazionalista, rappresentata
nelle ingiustizie sociali e nell’eleva-
zione di ideali riformisti.
In questo contesto le attrici erano costrette in un modello di virtù
senza appello, difensore di quei valori nobili e progressisti elevati nei
film. Le vite libertine delle star, vere
o presunte, ispiravano le prime forme di gossip; il loro comportamento
era esempio morale per la società,
al punto che la vita privata arrivava
ad influenzare un eventuale ingaggio. La donna si imponeva come un
nuovo modello, sincero e virtuoso
a cui non erano date alternative. Fu
in questa commistione di fervore,
idealismo, mondanità e ipocrisia
che emersero le prime eroine tragiche del cinema cinese. Come Ruan
Lingyu, una delle attrici più espressive nella storia del cinema cinese,
morta suicida nel 1935 nel clamore
pubblico, prigioniera di una condotta privata troppo esposta al giudizio
mediatico e ferita nella sua dignità.
Oggi il cinema cinese ha mantenuto la sua funzione artistico-sociale,
nonostante lo stravolgimento del
contesto ideologico in cui si trova
ad operare. L’occupazione giapponese (1931-1945), la salita al potere
dei comunisti (1949) e l’ascesa maoista (1949-1976) diedero vita a un
nuovo ordine, da cui il cinema cinese uscì con un’identità completamente rinnovata - se non stravolta
- e dettata dal potere centralizzato
del Partito comunista. Il rapporto
con gli ambienti cinematografici si
tinse dei colori foschi della critica,
della censura e dell’interdizione.
Tutto quello che rimane oggi di
quell’epoca, in una Cina mille miglia
lontana dalla povertà e dal fervore
di massa degli anni Sessanta, sono
dei poster dall’estetica socialista, o
le locandine ispirate agli “otto modelli di opera rivoluzionaria”, a cui
i film dovevano ispirarsi all’epoca
della Rivoluzione culturale (19661976). Si tratta di oggetti divenuti
il marchio di fabbrica di una forma
di pop art in salsa cinese, in cui le
immagini della propaganda sull’edificazione socialista delle masse,
sul patriottismo anti-imperialista o
sulla liberazione delle minoranze
etniche dalla povertà si impongono
come oggetti di un nuovo culto, icone appassite e svuotate delle loro
reali implicazioni storiche sulla vita
degli individui.
In realtà l’eredità del maoismo e
del radicalismo ideologico sul cinema cinese contemporaneo è stata
ben più pesante, lasciando in vita
gli spettri di una dicotomia tra arte
e regime. Ci sono poi da considerare gli effetti della trasformazione. In
Cina i passaggi dalla tolleranza liberale al controllo ideologico furono
rapidi ed estremi, al punto da creare
delle crisi di identità sociale che non
97
potevano non essere fotografate
dal cinema e dalle arti in generale.
I registi che emersero con il clima
liberale istaurato da Deng Xiaoping
dalla fine degli anni Settanta rappresentarono a tutti gli effetti una
svolta nella storia del cinema cinese, affiancando alla produzione ufficiale di propaganda e a una serie di
film più propriamente commerciali
(miti, leggende, combattimenti e
arti marziali firmati Hong Kong e Taiwan) una forma di cinema di qualità
e stilisticamente connotato, sensibile a problematiche socio-politiche e
dotata di orientamenti intellettuali
alternativi a quelli della dirigenza.
Wu Tianming (Old Well), Xie Fei (A
Girl from Hunan, Black Snow), Tian
Zhuangzhuang (Horse Thief, Blue
Kite), Chen Kaige (Yellow Earth,
Farewell My Concubine, Temptress
Moon), Zhang Yimou (Red Sorghum,
Raise the Red Lantern), Zhang Yuan
(Beijing Bastards, East Palace West
Palace) e Wang Xiaoshuai (Frozen,
Beijing Bycicle, Shanghai Dreams)
sono registi che con la loro produzione hanno introdotto uno spirito
critico verso la tradizione cinese e le
contraddizioni sociali emerse nelle
realtà urbane in seguito all’ingresso
della Cina nel mercato.
Il valore del nuovo cinema d’autore cinese non tardò ad avere
riscontri nelle sale occidentali, ottenendo riconoscimenti nei maggiori festival internazionali, a Cannes (Chen Kaige nel 1993), Venezia
(Zhang Yimou nel 1992) e Berlino
(Zhang Yimou nel 1988 e Xie Fei nel
1993). Contemporaneamente, però,
la consacrazione e il successo internazionale sembrano avere inaridito
il valore artistico di alcuni tra questi
registi. C’è chi è stato criticato per
essersi gradualmente avvicinato
alle esigenze di una platea intellettuale occidentale a prescindere dal
pubblico cinese. Altri registi sono
stati reintegrati nella macchina di
98
stato, ottenendo così grandi finanziamenti e attenzione mediatica
in Cina e portando in cambio ventate di nazionalismo. Emblema di
quest’ultima tendenza è l’epica maestosa del kolossal con caratteristiche cinesi Hero, giunto anche nelle
sale italiane nel 2002 e girato dal regista cinese probabilmente più popolare in Occidente, Zhang Yimou.
Il
cinema indipendente
di nuova generazione
In questo contesto, l’eredità del cinema d’autore è stata presa in carico
dalla cosiddetta sesta generazione
di registi cinesi, la prima del tragico post-Tiān’ān mén. I simboli manifesto di questo gruppo di registi
molto variegato al suo interno sono
Zhang Yuan e Wang Xiaoshuai.
I loro primi film colpiscono per il
coraggio nel denunciare problemi
sociali di diversa estrazione, l’emarginazione giovanile, l’alienazione
sociale degli artisti, l’omosessualità,
all’interno di quello stesso contesto
urbano che la retorica ufficiale sullo sviluppo e sulla liberalizzazione
economica dipingeva con tinte brillanti. Questo tipo di film ridiede vita
alla censura del Partito, che nel 1994
avrebbe interdetto per diversi anni
Zhang Yuan, Wang Xiaoshuai, Tian
Zhuangzhuang, la regista Ning Dai
(moglie di Zhang Yuan) e altre personalità di primo piano, come He
Jianjun (The Postman) e il documentarista Wu Wenguang (Bumming in
Beijing: the Last Dreamers). Alle loro
spalle muovevano però altri artisti,
capaci di aggirare - almeno in parte
- la mano della censura e di realizzare allo stesso tempo importanti
fotografie della società cinese presa
da angolazioni inconsuete.
È questa l’epoca d’oro del cinema
indipendente cinese, un tipo di cinema che trova nel valore di alcune
personalità, nell’onestà intellettuale
e nella carenza di mezzi e sponso-
rizzazioni i suoi tratti essenziali. Nel
1997 usciva Xiao Wu ad opera di Jia
Zhangke, in seguito insignito del
Leone d’Oro a Venezia con Still Life.
Influenzato dai maestri del neorealismo italiano e dal realismo socialista sovietico, Jia Zhangke ha saputo
dare forma a una estetica a metà
tra l’autobiografico, la creazione
artistica e il documentarismo vero
e proprio. Cornice dei suoi primi
film (Xiao Wu, Platform e Unknown
Pleasure) era la realtà urbana della
provincia cinese, che si affacciava sul libero mercato lasciando sul
campo una certa gioventù incapace
di approfittare realmente della liberalizzazione. Lo scenario dei suoi
film era la provincia dello Shanxi,
la stessa che aveva offerto i natali
al regista. I film erano girati in uno
stato di semi-clandestinità, con camere digitali e approfittando della
conoscenza dei luoghi e della realtà
dove venivano effettuate le riprese
per non dare troppo nell’occhio.
Altri registi che hanno ottenuto riconoscimenti all’estero sono
Wang Quan’an (The Tuya’s Marriage, Apart Together, Weawing Girl),
autore di film che spesso ritagliano
un ruolo centrale alla condizione
femminile in ambientazioni nella
Cina rurale e non, e Lou Ye (Suzhou
River, The Summer Palace, Spring
River), il cui lirismo introspettivo è
in grado di offrire angolazioni del
tutto fuori dal comune, tanto su
eventi storici dall’alto valore simbolico (i disordini di Piazza Tiān’ān
mén) quanto sui maggiori simboli
socio-economici della nuova Cina
(la città di Shanghai). Lou Ye è come
in costante esplorazione del vissuto
dei suoi personaggi, immersi in storie individuali e mai direttamente
coinvolti in una relazione attiva con
il contesto in cui agiscono. Ma nei
loro profili resta un riflesso naturale
e continuo dello scenario storicosociale esterno, a cui restano ine-
luttabilmente legati nel percorso di
trasformazione delle proprie storie
di vita.
Di Zhang Yang (Quitting, Shower) si segnala invece la sensibilità
nel sapere descrivere le sottigliezze
di relazioni familiari all’interno di un
contesto sociale che tiene come riferimento costante la Pechino degli
ultimi due decenni. In Quitting, presentato a Venezia nel 2001, Zhang
Yang è riuscito a mettere in scena
l’egocentrico senso di alienazione
generazionale di una certa gioventù pechinese degli anni Novanta,
attraverso il racconto della reale
storia di dipendenza dell’attore
Jia Hongsheng (morto suicida nel
2010), in un esperimento cinematografico che non è né documentario né finzione, bensì pura recitazione di un dramma familiare ad opera
dei suoi stessi protagonisti, che nel
film interpretano se stessi.
A conti fatti, al di là dei suoi
esponenti più rinomati, la cosiddetta sesta generazione di registi sembra avere raggiunto una maturità
stilistica in grado di dare al cinema
cinese un’identità insieme composita e dalla forte personalità, grazie
ad una ampia e variegata compagine di autori. Il decennio appena trascorso ha consacrato figure chiave
del cinema cinese, come Jiang Wen
(The Devils on the Doorstep, Let the
Bullets Fly), regista e attore autentica icona del cinema cinese, in grado di armonizzare critica, pubblico
colto e successo commerciale in un
unico coro di apprezzamenti. Ma
hanno visto la luce anche personalità di pari valore, malgrado il minore
successo all’estero e in Cina. Come
il regista Li Yang (Blind Shaft, Blind
Mountain), autore di fortissime denunce sociali che non trovano voce
nei media ufficiali, o il documentarista Wang Bing (He Fengming, The
Dish), promotore di vere e proprie
inchieste cinematografiche sui lati
oscuri della Cina comunista, nonché detentore di un record notevole, con le nove ore di documentario
racchiuse tutte in un’opera sola, l’acclamato West of the Tracks.
La lista sarebbe ancora più lunga
chiamando in causa registi ancora
più di nicchia o gli autori di ultimissima generazione - la cosiddetta
dGeneration - moltiplicatisi con l’avvento delle tecnologie digitale, ma
una ultima segnalazione va riconosciuta soprattutto al “Nuovo cinema
del reale”, un filone che riunisce una
serie di documentaristi e ha in Wu
Wenguang l’indiscusso capostipite. Il documentario cinese, anche
in questo caso in tutto e per tutto
indipendente dai percorsi ufficiali
di produzione, elegge a scenario
prediletto le ambientazioni me-
tropolitane post-moderne e postsocialiste, di cui coglie l’essenza
come reale in continuo movimento e trasformazione nell’asfissiante
processo di distruzione-costruzione
che affligge le città cinesi. Sospeso
tra la pura e semplice riproduzione
del vero - senza voci fuori campo
né spiegazioni - e l’intervento nella
realtà rappresentata - attraverso il
risveglio di un senso di responsabilità civile - il documentario cinese è
caratterizzato tanto da una estetica
artistica ben definita quanto da un
attivismo sociale di fondo, volto al
salvataggio o, quantomeno, alla documentazione della scomparsa della Cine tradizionale, nel bene e nel
male.
Mauro Crocenzi
99
CAMPI MAGNETICI #4
classic album rev
Mauro Pelosi
Suede
Mauro Pelosi (Polydor, Giugno 1977)
Suede (Nude Records, Maggio 1993)
Mauro Pelosi è uno di quei cantautori rimasti vittima
delle etichette del proprio tempo - si pensi similmente a Lolli o Sorrenti, due che difficilmente sono stati
valutati artisticamente al di fuori del loro preciso raggio di genere. Pelosi rimane, in chi ne ha memoria, un
cantautore prog, un autore romano degli anni ‘70 che
scriveva canzoni e che, essendo lontano dalla cerchia
del folk-studio e dell’impegno politico strettamente inteso, naturalmente non poteva che essere esponente
dell’altra faccia di quel decennio. Nulla di più sbagliato, perchè se è vero che Pelosi dagli anni ‘70 non è mai
uscito, vero è anche che i suoi quattro album, sapientemente distribuiti tra il 1972 (La stagione per morire)
e il 1979 (Il signore dei gatti) sono espressione di una
forma autorale più profonda, strutturalmente legata in
modo massiccio alla classicità del cantautorato italiano, più vicina al Venditti di L’orso bruno che al Banco
del mutuo soccorso di Darwin.
Nel ‘77 esce con Polydor il suo disco omonimo, il
terzo: destinato a diventare il più completo, intimo e
rappresentativo della discografia di Pelosi: musicalmente stratificato, orchestrato e pop mentre nei testi
più che mai urgente di quella scrittura psicoanalitica
rivolta ugualmente al personale e al sociale. Dopo un
disco d’esordio quasi concept sul suicidio, e un secondo lavoro di non distante respiro, un album omonimo
non può che consacrare le venature tristi di una scrittura che è drammatico emblema di forme di solitudine
differenti. Con una raffinatezza descrittiva e una perizia
evocativa rare vengono così a galla le storie di Claudio
& Francesco, una coppia di omosessuali alle prese con
il difficile quotidiano (“abbiamo portato Freud dallo sfasciacarrozze e ora viviamo insieme”) o quella dei bombaroli di Alle 4 di mattina, a presentare un tema che
nello stesso anno De André affronterà nel suo Storia
di un impiegato. Protagonista è, su tutto, Pelosi stesso, a sottolineare
con decisione l’omonimia tra autore e LP: al centro c’è
il simbolo, l’oggetto che nasconde il concetto, il feno100
meno che ha in sé il noumeno. La bottiglia ma soprattutto La lecca lecca d’oro, anche primo 7’’, che dietro alla
facciata pop completamente riuscita nasconde la rappresentazione dell’amore perfetto finalmente trovato
che non sopravvive però al dolore della perdita di un
legame imperfetto ma sincero. Pelosi è a tutti gli effetti
quello che l’inconografia culturale del ‘900 definirebbe
prima come Maudit e poi, a specchio dei tempi, come
Loser, a sottolinearlo sono i due pezzi attorno a cui il
disco pare ruotare: Una casa piena di stracci e Ho fatto
la cacca, accomunati da una coda di certa derivazione
prog non distante da alcuni brani degli Osanna. Due
pezzi di nichilismo disperato, meno velato nel primo e
sottolineato dal sarcasmo del secondo. Arrangiato in modo magistrale da Pinuccio Pierazzoli, l’album vede la partecipazione di Edoardo Bennato all’armonica a bocca in L’investimento e di Ricky
Belloni (New Trolls) alle chitarre. Un disco che naturalmente vendette ben poco, per un artista che oggi è su
cd solo per metà, in cofanetti che raccolgono classici
dell’italian prog. In epoca di rivalutazioni sarebbe bello
cercare di andare oltre, uscire dai generi e riscoprire il
valore di un autore dalla penna e dal sound tanto connotati quanto incisivi e dai caratteri compositivi non
difficili da ritrovare in alcuni progetti d’oggi (ManzOni,
Iosonouncane...).
(7.7/10)
Giulia Cavaliere
Che i Suede fossero destinati a guardare tutti dall’alto
fu chiaro da subito, se è vero che pure l’ex Smiths Mike
Joyce, si presentò ai provini per diventarne il batterista.
A decretarne la grandezza di fronte ad un pubblico alla
forsennata ricerca dei nuovi Morrissey & Marr, fu l’alchimia creatasi tra teatralità decadente di Anderson e
il chitarrismo fluente e straripante di Bernard Butler,
una sorta di erede spirituale di Mick Ronson, nonchè
un musicista che al riff ha sempre prediletto l’intarsio
elettrico, il cesello minuzioso e irregolare.
Il ‘92 fu il loro anno. Prima ancora che il singolo d’esordio toccasse gli scaffali, il Melody Maker dedicava
loro la copertina. The Drowners, che avrebbe visto la
luce a maggio, aveva un passo marziale e altero di una
diva della rivista. Bastò tanto perché l’Inghilterra tutta
si genuflettesse. Pochi mesi dopo Metal Mickey ne ripeteva il canovaccio con maggiore incisività, muovendosi
al ritmo sculettante del singer, con un Butler intento ad
assestare possenti sculacciate e un chorus che fungeva
da inno da stadio per giovani in crisi d’identità sessuale.
Nel frattempo si era fatto il ‘93 e mentre sulle riviste un Anderson atillatissimo chiudeva i conti con le
felpe sformate e pantaloni baggy della generazione
rave, Animal Nitrate anticipava l’album con un campionario di tentazioni che sfiorava pericolosamente temi
tabù. A rubare le scena, però, era ancora il riff stridulo
e psichedelico che durante il breve solo, stritolava la
melodia come un boa di struzzo. Fu a quel punto che
anche i più smaliziati caddero trafitti al cospetto dei
londinesi.
Personalmente giurai loro eterna fedeltà appena
dopo aver ascoltato l’arpeggio adamantino e il singhiozzo di Brett nell’intro di So Young, brano che apre
il loro primo e inestimabile album. Era come se il glam,
che fino a quel momento sembrava una cosa lontana e
polverosa, rialzasse la testa per mangiarsi in un boccone tutto l’understatement delle star dimesse d’oltreoceano. Fu un breve e travolgente momento di follia, in
cui Anderson poteva permettersi di recitare versi come
“Let’s chase the dragon”, senza rischiare di apparire ridicolo.
Suede è un album che ancor oggi, che le sue polveri purpuree si sono depositate e il suo odore acre si
è disperso nell’aria, mostra tutto lo spessore a livello
di composizione, esecuzione e fantasia degli arrangiamenti. Fieramente controverso a partire dalla cover,
con i due esseri asessuati intenti a scambiarsi effusioni,
è un viaggio al termine della notte delle virtù umane;
un rito iniziatico ai piaceri proibiti, con le sue impervie
accelerazioni, i suoi momenti catartici e le sue epifanie.
Su tutte quella di Pantomime Horse, ballad maestosa come una cattedrale barocca, cantata da una specie
di Marlene Dietrich in acido e resa classica da un riff
funereo di Butler che la suggella come una lapide. E’
il pinnacolo di un album che vive della dicotomia fra i
momenti soffusi di Sleeping Pills e She’s Not Dead, in cui
Anderson pare lisciarsi malinconicamente le piume, e
gli scatti da diva di Hollywood in astinenza da barbiturici di Moving e Animal Lovers. Un tour de force fra temi
rischiosi come tossicodipendenza e suicidio, su cui la
band seppe muoversi felpata, determinando il clima
al tempo stesso inebriante e gravido di decadenza che
pervade ogni singola traccia.
Se ne esce vagheggiando su una vita dopo l’ineluttabile fine. “See you in your next life” cantava Anderson,
nella prima di una serie di delicate closing song eseguite al pianoforte, pur sapendo che quello che sarebbe
venuto dopo, per forza di cose, non avrebbe mai potuto essere eccitante come quello a cui avevamo assistito
fin qui.
Diego Ballani
101
si con
e
m
i
i
t
t
u
azine
tal mag
il digi
in pdf
nto è t
e
m
a
t
n
L’appu
orni su
i
.com rofondimenti
g
i
e
i
r
t
t
a
u
t
l
et
o
sc
a
t, app
e
s
r
i
e
t
t
n
n
o
c
e
www.osncerti, recensioni,
News, c
tis
ra
tutto g
click
n
u
i
d
ata
e a port
anche su