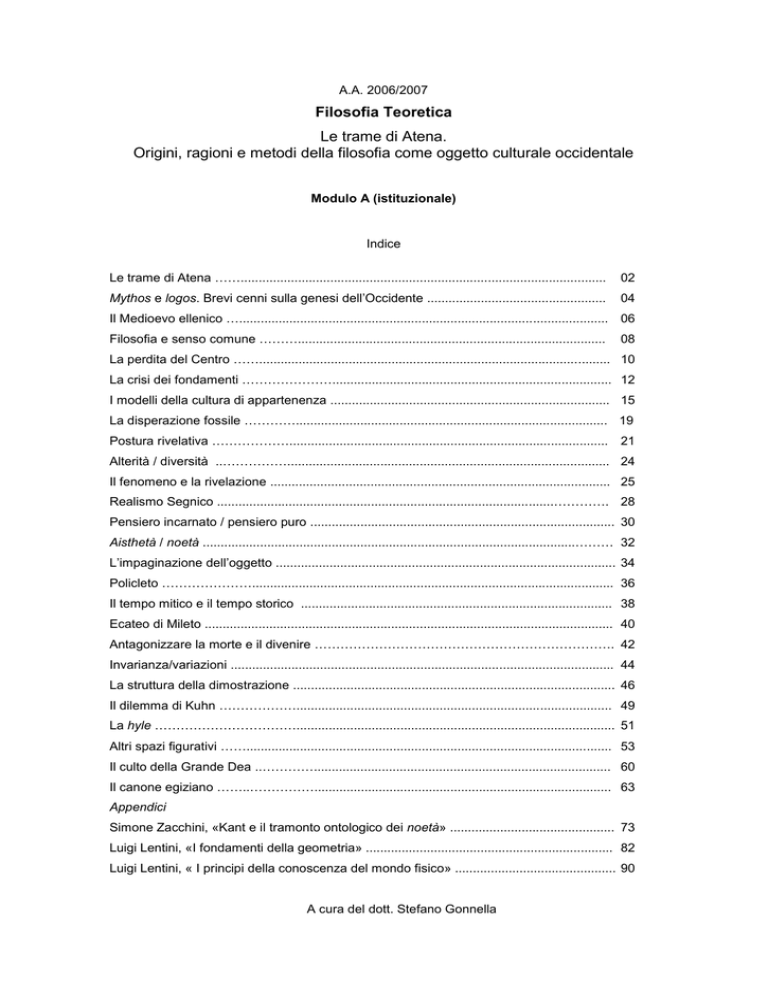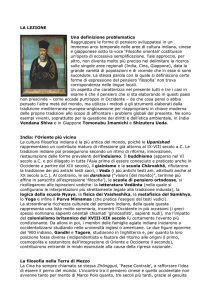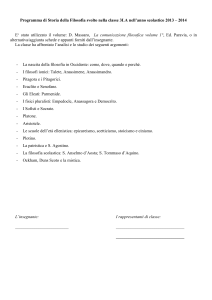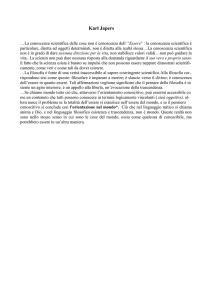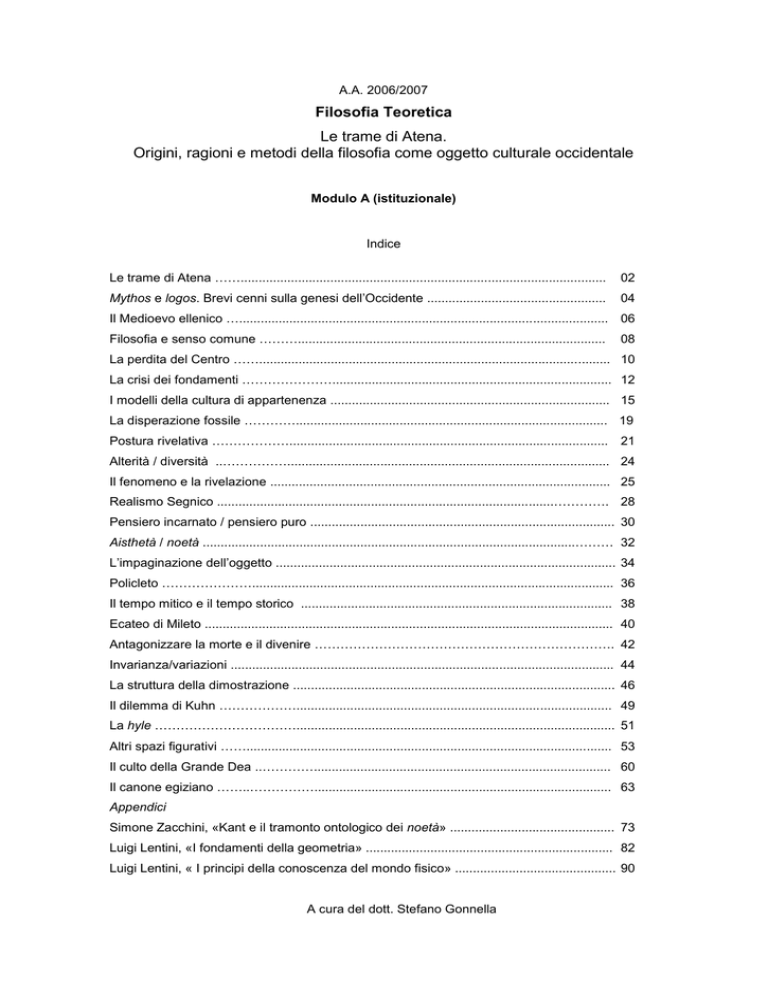
A.A. 2006/2007
Filosofia Teoretica
Le trame di Atena.
Origini, ragioni e metodi della filosofia come oggetto culturale occidentale
Modulo A (istituzionale)
Indice
Le trame di Atena ……......................................................................................................
02
Mythos e logos. Brevi cenni sulla genesi dell’Occidente ..................................................
04
Il Medioevo ellenico …....................................................................................................... 06
Filosofia e senso comune ………......................................................................................
08
La perdita del Centro …….................................................................................................. 10
La crisi dei fondamenti ………………….............................................................................. 12
I modelli della cultura di appartenenza .............................................................................. 15
La disperazione fossile …………....................................................................................... 19
Postura rivelativa ………………......................................................................................... 21
Alterità / diversità ..…………….......................................................................................... 24
Il fenomeno e la rivelazione ............................................................................................... 25
Realismo Segnico ..............................................................................................…………. 28
Pensiero incarnato / pensiero puro ..................................................................................... 30
Aisthetà / noetà ........................................................................................................……… 32
L’impaginazione dell’oggetto ............................................................................................... 34
Policleto …………………..................................................................................................... 36
Il tempo mitico e il tempo storico ....................................................................................... 38
Ecateo di Mileto .................................................................................................................. 40
Antagonizzare la morte e il divenire ……………………………………………………………. 42
Invarianza/variazioni ........................................................................................................... 44
La struttura della dimostrazione .......................................................................................... 46
Il dilemma di Kuhn ………………........................................................................................ 49
La hyle ……………………………......................................................................................... 51
Altri spazi figurativi ……...................................................................................................... 53
Il culto della Grande Dea ..…………................................................................................... 60
Il canone egiziano ……..……………................................................................................... 63
Appendici
Simone Zacchini, «Kant e il tramonto ontologico dei noetà» .............................................. 73
Luigi Lentini, «I fondamenti della geometria» ..................................................................... 82
Luigi Lentini, « I principi della conoscenza del mondo fisico» ............................................. 90
A cura del dott. Stefano Gonnella
Le trame di Atena
«La filosofia teoretica è una disciplina al tempo stesso particolare e generale. Essa è una partizione
interna di quell’intero che è il sapere filosofico e nel contempo è, o riassume in sé l’intera filosofia. (…)
penetrare in questo paradosso e comprenderlo significa comprendere la natura stessa del sapere filosofico,
in quanto evento che ha segnato il destino storico dell’Occidente e che ora si trova a fronteggiare il futuro
planetario dell’uomo, avviato a una immane trasformazione tecnologica dei suoi modi di esistenza.» (Carlo
Sini, Filosofia teoretica, Jaca Book, Milano 1992, p. 7).
Diogene Laerzio, Vitae philosophorum I, 12
Per primo Pitagora usò il termine filosofia e per primo si chiamò filosofo; nessuno è infatti
saggio, eccetto la divinità.
«L’espressione “filosofia teoretica” ha la sua radice nel linguaggio dei Greci e allude manifestamente a
un sapere (sophia) incentrato sul vedere o su un atto di visione (theorein).» (C. Sini, op. cit., p. 8) Questo
atto di visione ha una natura particolare: theōrêin significa essenzialmente “contemplare”, esercitare lo
sguardo contemplativo, e deriva dal verbo orao, “vedere”.
Cicerone, Tusculanae Disputationes V, 3, 8
Vi sono certe rare persone che trascurano completamente tutto il resto e studiano
attentamente la natura. Questi si chiamano amanti della sapienza, cioè filosofi, e come nel
mercato l’atteggiamento più nobile è fare da spettatore senza cercare vantaggio alcuno, così
nella vita lo studio e la conoscenza delle cose è di gran lunga superiore a tutte le attività.
Invero Pitagora non solo fu l’inventore del nome, ma diede sviluppo all’attività stessa.
«Già la sapienza dei misteri eleusini culminava in una visione o esperienza visionaria (epopteia). Così
pure la festa dionisiaca metteva capo alla contemplazione visivo-allucinatoria del Dio. Come riferisce Filone,
“i posseduti dalla frenesia bacchica e coribantica giungono nell’estasi sino a vedere l’oggetto bramato”.
L’oggetto bramato non è altri che il Dio, resosi manifesto all’arreton, alla visione indicibile. Queste forme
arcaiche della sapienza connesse al vedere si riallacciano a sapienze ancora più antiche, le cui radici
risalgono alla notte dei tempi e alle simbologie originarie dell’uomo dei primordi, ben oltre le culture del
neolitico, e cioè nell’oscura e misteriosa profondità del paleolitico. Il sapere filosofico ha alle spalle tutto ciò,
come un’eredità al tempo stesso conservata e rimossa, vale a dire reinterpretata e trasformata in una nuova
accezione della visione e del vedere che costituisce, col suo avvento, una grande cesura nella vicenda
spirituale dell’uomo.» (C. Sini, op. cit., pp. 8-9)
L’immagine delle “trame di Atena” che dà il titolo al corso, potendo risultare sconcertante ed enigmatica,
richiede qualche parola di spiegazione. Esiodo nella Teogonia (886) racconta che Zeus come prima sposa
aveva scelto Metis o Metide (Mẽtis), la più sapiente fra gli dei e gli umani. Figlia di Oceano e Teti, Metis
aveva la capacità di assumere varie forme quando Zeus tentava di possederla (Apollodorus Mythographus,
1, 3, 6). La nascita di Atena viene narrata da Esiodo appunto in relazione a Metis (Th. 887), in uno dei brani
2
più avvincenti della mitologia greca nel quale si vede Atena balzare fuori dalla dolorante testa di Zeus,
aperta dall’ascia di Efesto. Dopo la profezia di Urano (il Cielo) e Gea (la Terra), i quali lo avevano avvertito
che dalla sua sposa Metis sarebbe nato un figlio che lo avrebbe poi detronizzato (come lui stesso aveva
fatto con Crono), Zeus astutamente inganna la dea con discorsi lusinghieri e la inghiotte, introducendola nel
suo ventre già incinta di Atena. Compiuto il tempo della gravidanza, sarà appunto Efesto, con un preciso
fendente della sua doppia ascia, a consentire il parto di Zeus. Pallade Atena nasce già adulta dalla testa di
Zeus, armata di tutto punto, con indosso una splendente corazza d’oro, l'elmo, lo scudo e la lancia,
emettendo un potente grido di guerra, forte al punto di risuonare così lontano da far rabbrividire il Cielo e la
Madre Terra (Homeri Hymni, 28, 5). Tutti gli immortali erano rimasti stupiti e atterriti vedendola uscire dalla
testa di Zeus brandendo la lancia acuminata. «Un potente tremito percorse il grande Olimpo sotto il peso
della fanciulla dagli occhi di gufo. Ne risuonò la terra tutt’intorno e il mare si gonfiò furiosamente sollevando
onde purpuree.» (Károly Kerényi, Gli Dei e gli Eroi della Grecia, Garzanti, Milano 1963, p. 113s).
Atena è dunque figlia di Zeus e di Metis. Entrambe, Atena e Metis, sono divinità che impersonificano la
sapienza, ma mentre Metis incarna la sapienza rivelativa, la conoscenza mitico-rituale, Atena è l’emblema di
un pensiero formale, un pensiero di tipo relazionale non più basato su valori rivelativi assoluti e che
diventerà sempre più complesso e sofisticato. Dalla Mesopotamia e dall'Asia Minore si era diffusa nel
Mediterraneo una concezione oracolare della sapienza, risalente al Neolitico, una sapienza legata alla figura
della Grande Dea. Di questa concezione del sapere come sapere rivelativo sono depositarie in varia misura
le figure femminili della mitologia greca, che possono essere intese come altrettante incarnazioni, tarde
metamorfosi della Dea originaria, e tutte naturalmente dotate di mẽtis.
Nella mitologia greca Metis incarna la sapienza pratica e intuitiva. Il termine mẽtis non indica la
conoscenza contemplativa: piuttosto è la sagacia, l’astuzia, l’arte di tessere inganni. È un genere di sophia,
ma in grado di elaborare e trovare soluzioni pratiche. Ha bisogno di mẽtis il navigante, colui che naviga nel
póntos, il mare aperto (che non è il pélagos, dove la costa è a portata di sguardo). Nel póntos cielo e mare si
fondono, il mare aperto è "aporetico" (poros è il sentiero), non ha sentieri, vie tracciate da seguire. Chi perde
il kairós, l'attimo propizio, non potrà mai uscire dall'aporia, ma il kairós si può cogliere solo con la mẽtis.
[ Testo → M. Detienne - J.-P. Vernant, La astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia]
Metis e Atena sono due figure emblematiche. L’avvicendamento tra Metis e Atena rappresenta in
maniera estremamente sintetica la transizione verso un sapere di tipo non templare, non rivelativo: è la
nascita metaforica di quello che sarà poi il pensiero filosofico e scientifico. Le “trame di Atena”, quindi, altro
non sono che i molteplici intrecci e sviluppi che caratterizzeranno la vicenda del pensiero occidentale dagli
albori in terra greca fino ai nostri giorni.
La garanzia del tipo di ragione incarnato per così dire da Metis derivava dalla sacralità. In un universo in
cui sono le figure potenti ad elargire realtà e senso, la razionalità si fonda sul Sacro. Ma quando il Sacro non
garantisce più la verità, bisogna mettersi in cammino, occorre cercare la verità, che prima era direttamente
rivelata, una volta per tutte. Cominciamo allora a domandarci (con Talete) come sia fatto l'Essere,
quell'Essere che ama nascondersi (come ci dice Eraclito) e si impone la necessità di escogitare un metodo
per oltrepassare il póntos, dato che la mẽtis non aiuta più. Si incominciano a seguire i sémata, i segni, per
3
raggiungere l'Essere, la natura delle cose. E in questo percorso ci si garantisce solo con gli strumenti, con il
metodo: nessun dio ci dà più la sapienza o garantisce la nostra conoscenza.
Quando il sapere cessa di essere un sapere di tipo rivelativo, quando l'Essere comincia a nascondersi,
non manifestandosi più nelle cose, e il mondo sensibile si separa dal mondo intelligibile, sorgono due
problemi fondamentali: quello della natura dell'Essere e quello del metodo, degli strumenti in grado di farci
conoscere l'Essere. Da un lato, nella sfera dell’intelligibile, viene a depositarsi la verità dell’Essere, una verità
nascosta ed invisibile agli occhi del corpo; dall’altro, nel sensibile, si cercano i segni che possano indicarci la
via per raggiungere questa verità. Senza una “trama” appunto che riesca ad unificare e ricucire di nuovo
queste due sfere nessuna conoscenza potrà dirsi sicura. La tessitura di questa trama è proprio la ricerca
filosofica, la trama stessa, invece, è il logos, cioè una struttura che ci permette di raggiungere, attraverso i
segni sensibili, la verità immobile dell’intelligibile.
Mythos e logos. Brevi cenni sulla genesi dell’Occidente
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l'aria infinita, e quel profondo
Infinito seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (vv. 84-89)
“Perché c’è la morte?” “Dove andrò a finire dopo la morte?” “Perché c’è il male, il dolore, la sofferenza?”
“Perché c’è qualcosa piuttosto che il nulla?” “Che cos’è l’Essere?” “Che cos’è il nulla?” Queste sono alcune
domande che quasi mai formuliamo esplicitamente, perché fanno parte della nostra condizione esistenziale
elementare. A queste domande l’uomo ha cercato di rispondere in vari modi. Per millenni ha risposto
allestendo un sistema di sicurezza basato sul discorso mitico, o meglio, sull’apparato mitico-rituale. I modi
per rispondere a queste domande più vicini a noi, quelli che appartengono alla storia del pensiero
occidentale, sono essenzialmente due: la metafisica (per semplicità, la filosofia) e la scienza. Anche se
sostanzialmente diversi, entrambi gli approcci hanno la medesima radice nel logos greco.
La verità rivelata, la rivelazione espressa da una figura potente, può depositarsi in un testo (in un mito)
ed essere presentata con una azione (con un rito), ma non è fatta dall’uomo, non è mai intesa come creata
dall’uomo. Il sistema mitico-rituale, in estrema sintesi, è basato sulla rivelazione dei legòmena e dei
dròmena, fa tutt’uno con essi. Ossia, è rivelazione il mito (legòmenon) ed è rivelazione pragmatica il rito
(dròmenon): questi si autofondano, si fondano da sé, non è l’uomo che conferisce loro un senso. Non è
l’uomo a ritenersi autore o inventore dei miti e dei riti. L’uomo rileva il fatto di essere impotente e di non
essere autonomamente titolare della propria esistenza e del senso di essa: sono le figure potenti che
elargiscono rivelativamente l’una e l’altro all’uomo e al mondo, che ne sono essenzialmente privi. E questa
rivelazione si presenta attraverso un mito (narrazione del rito) e attraverso un rito (attivazione del mito).
4
La distinzione tra mythos e logos non compare prima di Platone, e solo con Aristotele diventerà una
contrapposizione determinante. In Platone nel Protagora (320c 3), ad esempio, c’è chiaramente la
distinzione tra mythos e logos. Socrate, dialogando dell’insegnabilità della virtù con Protagora, a un certo
punto domanda:
-
«Se, dunque sei in grado di far vedere più chiaramente che la virtù è insegnabile non rifiutarti
di farlo e dimostracelo».
-
«Ma Socrate - disse -, io non mi rifiuterò. Piuttosto, preferite che io, come anziano che parla ai
giovani, ve lo dimostri narrando un mito, oppure facendo un ragionamento?»
All’obiezione socratica secondo cui la virtù non sarebbe insegnabile, Protagora risponde con il celebre
mito sull’origine della civiltà, in cui si narra come Zeus abbia assegnato a ciascun uomo ”pudore” (aidos) e
“giustizia” (dike): è grazie a questi doni (e non solo in virtù delle sue abilità tecniche) che all’uomo è dato di
autoconservarsi. E dunque Protagora interpreta il mito alla luce della propria tesi relativa alla possibilità di
insegnare ed apprendere la virtù.
Logos e mythos si confondono ancora in Omero, si confondono nei Presocratici, e soltanto in Senofane
si presenta chiaramente una divaricazione drammatica tra mythos come “discorso falso” e logos come
“discorso vero”. La comparsa del logos nell’antica Grecia pone questioni di enorme complessità, tuttavia può
essere messa in relazione alla caduta delle spiegazioni che gli apparati mitico-rituali avevano dato fino ad
allora nelle comunità e fra le etnie che popolavano l’antico Mediterraneo. Ad un certo punto le credenze
mitico-rituali non rispondono più alle domande originarie. La crisi di questo paradigma culturale ha inizio
quando i miti non vengono ritenuti più certi e assoluti, e tramonta l'idea che conoscere ed agire significhi
ripetere, secondo precisi rituali, le azioni compiute in origine, nel tempo mitico, dalle divinità, dalle figure
sacrali. Questo è lo sfondo a partire dal quale si può tentare di comprendere perché i Greci abbiano
inventato la filosofia, ossia abbiano elaborato un sapere della totalità, un sapere dell'intero, un sapere che
mira ad essere certo ed assoluto.
Secondo questa lettura, il logos greco nasce come risposta ad una crisi epocale, come tentativo di
ricomporre un mondo ormai sfasciato. Da un punto di vista filosofico questa crisi può essere sintetizzata
come divaricazione della sfera sensibile da quella intelligibile. Tale distinzione, che si esplicherà in tutta la
sua forza con Parmenide e si assesterà mirabilmente nella teoria filosofica del mondo delle idee di Platone,
travolge definitivamente quella sorta di unità originaria di parole e cose, di segni ed enti, garantita per
millenni dalla struttura dell’apparato mitico-rituale, ormai entrato in crisi irreversibile. Questa distinzione, tra le
altre cose, mette a tacere anche i contenuti veritativi del mito, una volta per tutte, alienandoli nella sfera dell’
“incomprensibile”, del “mostruoso” o del “primitivo”. Il mito diviene oggetto di discussione critica nelle colonie
greche, proprio da parte di quei pensatori che la tradizione ci tramanda come primi filosofi.
Quando il sistema mitico-rituale comincia a vacillare, l’uomo si ritrova gettato in un mondo che richiede
senso e ordine: quel senso e quell’ordine che prima venivano garantiti, o meglio, elargiti dalle figure potenti.
Si iniziano a porre quelle domande sul senso della vita e sulla natura del mondo circostante che mai prima di
allora avevano sfiorato l’uomo, essendo appunto già risolte dal riferimento paradigmatico al mito. Nel gesto
del domandare, nel momento della domanda si può pertanto individuare una carenza cui il domandare
stesso allude. La domanda sul senso, in altre parole, scaturisce nel momento drammatico in cui ci si accorge
che il senso stesso non è più presente. Quando Talete asserisce che l’essere di tutte le cose è l’acqua, al di
5
là dell’interesse storiografico per una invenzione filosofica, quel che conta è comprendere la domanda che
ha provocato tale risposta: la domanda è quella circa il fondamento del reale e dell’esistente.
Il logos dunque non distrugge il mythos, non è responsabile dell’eclissi del mito, come gli Illuministi
ameranno pensare molti secoli più tardi. Il logos non nasce per combattere ed eliminare il mythos, ma
emerge per antagonizzare una crisi epocale legata al collasso dell’universo mitico-rituale.
Il Medioevo ellenico
Alle spalle di Talete, anche se non proprio immediatamente a ridosso, si profila l’ombra di un’imponente
ed imprevedibile catastrofe antropologica, avvenuta, per motivi complessi e in gran parte ancora oscuri,
proprio nell’area culturalmente nevralgica del bacino del Mediterraneo Antico-Orientale. Tra il XX e il XII
secolo a.C., il territorio dell'attuale Grecia viene invaso da Ioni, Eoli, Achei. Tra tutte queste popolazioni
indoeuropee originarie del bacino del Danubio si distinguono gli Achei, forti guerrieri e fondatori di cittàfortezze indipendenti (la principale è Micene, da cui deriva il nome di Micenei), che cominciano ad
espandersi nel Mediterraneo: invadono Creta, dominandola per due secoli (1400-1200 a.C.), poi
saccheggiano e annientano Troia.
La prima ondata migratoria verso il territorio greco si verifica tra il XX e il XV secolo a.C. Tra i primi ad
arrivare dal Nord, gli Ioni occupano l'Attica e alcuni territori dell'isola Eubea, espandendosi successivamente
nella maggior parte delle isole del Mar Egeo (tra cui le isole Cicladi) e quindi la stretta striscia di terra sulla
costa occidentale dell'Asia Minore poi nota come Ionia. Questi popoli, la cui civiltà si fonde con quella delle
popolazioni autoctone, sono portatori di una cultura diversa: conoscono la ruota da vasaio, allevano cavalli,
praticano le sepolture individuali.
Successivamente arrivano gli Eoli e si stabiliscono prima in Tessaglia, espandendosi poi a fondare
numerose colonie anche in altre regioni della Grecia. Nell’XI secolo a.C. molti di loro emigrano nell'isola di
Lesbo nel Mar Egeo. Fondano città anche sulla costa occidentale dell'Asia Minore tra i Dardanelli e il fiume
Ermo, nella regione che diverrà nota come Eolide. Il dialetto eolico è generalmente riconosciuto come una
delle più antiche forme della lingua greca.
Infine gli Achei, i quali si insediano nel Peloponneso, in particolare nelle regioni dell’Acaia e della Focide,
dove danno origine alla civiltà micenea. Anche gli Achei si spingono sulle coste dell’Asia Minore, dove
fondano città come Cnido e Alicarnasso. La distruzione di Troia, avvenuta secondo la tradizione nel 1184
a.C., segna il culmine della potenza micenea. Subito dopo infatti, tra il XIII e il XII secolo a.C., Micene e altre
città achee vengono espugnate e devastate dai Dori, i quali mettono fine alla civiltà degli Achei, rendendo
irreversibile il trapasso ad un nuovo modello culturale. Anche la popolazione dei Dori ha origini indoeuropee.
Gli invasori dell'Est attraversano i monti della Macedonia, si spingono verso il Peloponneso, riuscendo a
sconfiggere gli Achei che vi risiedevano. I Dori hanno una superiore tecnologia bellica: dotati di armi di ferro,
si impongono con facilità sul bronzo delle popolazioni locali.
I Dori occupano a loro volta tutto il Peloponneso (eccetto l'Arcadia e l'Attica), e successivamente
invadono anche le isole Cicladi, Creta, Rodi e la costa sud-occidentale dell'Asia Minore (le città di Cnido e
Alicarnasso e l’isola di Coo). I rapporti fra i nuovi invasori e le popolazioni indoeuropee già stanziatesi in
Grecia non sono facili, molti Achei trovano rifugio nel Peloponneso settentrionale, nella regione chiamata da
6
allora in poi Acaia; altri (soprattutto gli abitanti della Laconia e della Tessaglia) tentano di opporre resistenza
e, dopo essere stati sconfitti, vengono fatti schiavi. Tra le popolazioni che dal Peloponneso si trasferiscono in
Attica e nell'isola Eubea, alcune migrano insieme agli Eoli verso le coste dell'Asia Minore dando così avvio
alla prima colonizzazione greca.
Per dare solo un’idea della complessità degli eventi che in questo periodo interessano il Mediterraneo
orientale, è solo il caso di nominare anche quelle popolazioni egeo-anatoliche stabilitesi nel corridoio siropalestinese nell'Età del Bronzo finale e tradizionalmente conosciute come «Popoli del Mare». Tali popoli non
sono stati ancora identificati con certezza, ma si trovano genericamente indicati come «Popoli del Mare, del
Nord e delle Isole» nelle iscrizioni in geroglifico del tempio egiziano di Medinhet Habu (12° secolo a.C.),
dove sono raffigurati alcuni eserciti invasori stranieri, con al loro seguito donne, bambini e masserizie, che
vengono sconfitti in battaglia dai Faraoni. Quanto meno, l’arrivo dei cosiddetti «Popoli del Mare» causa
notevoli problemi al traffico navale del Mediterraneo, alle rotte mercantili più importanti per l’epoca, sulle
quali poggiavano le economie dei signori micenei che trafficavano con lo stagno ed il rame per produrre il
bronzo. Ma più che un’invasione repentina o di una guerra totale, si tratta a ben vedere di una lunga crisi, di
uno stillicidio di popoli che entrano, si scontrano, si mescolano, si fanno guerra, si coniugano, in un’area –
quella del Mediterraneo Antico-Orientale – caratterizzata da un vuoto di potere centrale.
Con l'invasione dorica comincia il cosiddetto Medioevo ellenico (XII-VIII sec. a.C.), un periodo di cui non
abbiamo molte notizie, che vede appunto la dissoluzione del regno miceneo nel Mediterraneo e dell’impero
Ittita nell’Anatolia (l’attuale Turchia). La Grecia continentale in questo periodo non subisce ulteriori invasioni
esterne, ma vive una profonda crisi economica e sociale, che interessa anche le coste dell’Asia Minore
(l’attuale Palestina, la zona della cosiddetta “mezzaluna fertile”), e dilaga poi nelle Isole Egee. Si registra un
notevole regresso culturale e materiale rispetto alla precedente cultura micenea. Decadono i commerci e si
ritorna ad un’economia basata su agricoltura e pastorizia. Scompare l'architettura monumentale: i grandi
palazzi vengono distrutti da incendi a Micene, a Tirinto, a Pylos e a Tebe. Le grandi tombe collettive
vengono sostituite da tombe individuali, molto più modeste, o dal rito dell'incinerazione. Scompare la
lavorazione del bronzo, per le già citate difficoltà degli scambi commerciali necessari per l'importazione del
rame e dello stagno. Come traccia materiale della cultura dell'epoca resta solo la ceramica, mentre si perde
anche la scrittura, elemento fondamentale nelle amministrazioni delle cancellerie micenee e mediorientali.
L'avvento di queste nuove popolazioni, con altre credenze e altre divinità, dunque, innesca un tracollo
culturale, una crisi antropologica che ha mutato il nostro pianeta e da cui, tra le altre cose, è stato generato il
logos greco. Quando questo periodo finisce, troviamo in prima istanza le testimonianze dell’Iliade e
dell’Odissea, che mostrano già un distacco nei confronti della religiosità tradizionale. Alle origini della cultura
occidentale, nei testi di Omero, troviamo già una certa laicizzazione del pensiero, rafforzata dal fatto che i
Greci non avranno mai un sapere dei templi, una classe sacerdotale, una organizzazione sacrale: avranno
piuttosto delle polis (da cui deriva il termine “politica”) e delle istituzioni cittadine.
Questa crisi è epocale nel senso che qualcosa di inaudito accade durante l’Età del Ferro, dopo l’Età del
Bronzo, lungo un arco di tempo esteso per almeno tre secoli e mezzo: uscendo dal Medioevo ellenico, il
pensiero umano cambia completamente rotta, e fin dai primi vagiti dell’Occidente, compaiono oggetti e
strutture culturali che riconosciamo ancora come nostri e che ci caratterizzano ancora in maniera eminente.
In un’area molto circoscritta, in un territorio ad altissima ibridazione di popoli e culture, nascono la tragedia,
7
l’epopea, la filosofia, la struttura della dimostrazione. Si assiste, così, ad una profonda mutazione del
rapporto uomo-mondo. E questa trasformazione si consolida nelle terre dell'area ellenica mediterranea verso
il IV secolo a.C., quando vengono fissati criteri e principi che resteranno sostanzialmente invariati fino a noi e
comincia a svilupparsi un modo di pensare che è il nostro, che tuttora ci appartiene e in cui ci riconosciamo.
Filosofia e senso comune
È il caso a questo punto di segnalare alcuni aspetti fondamentali del pensiero filosofico delle origini:
innanzitutto si tratta di un genere letterario. La filosofia si scrive, non si trasmette oralmente. Ed è un genere
letterario urbano, fa parte della cultura delle poleis, delle città greche, degli agglomerati urbani. Inoltre, la
filosofia nasce nelle colonie greche, non nella madrepatria. Esplode addirittura nel Mediterraneo, con la
scuola di Elea – l’attuale Velia, in Campania, colonia focese della Magna Grecia, fondata tra il 540 e il 530
a.C.: Parmenide è la vera matrice dell’Occidente, il primo a pensare con modalità senza le quali non ci
sarebbero stati né Einstein, né Heisenberg, né la scienza contemporanea.
Genere letterario, dunque, cittadino e coloniale, la filosofia nasce con un senso molto preciso: come
critica e come espressione della sostanziale perdita di fiducia nella “enciclopedia tribale”. Questo significa
perdita di fiducia nella rivelazione, nella verità della rivelazione, quindi perdita di fiducia in blocco nella
tradizione culturale consolidata. I Greci non hanno testi sacri. Non si sono mai sognati di trasformare l’Iliade
e l’Odissea in una Bibbia. Questo ha condotto ad un pensiero “altro”: un pensiero critico, di sospetto, che
oltrepassa queste credenze.
Di fronte alla perdita di senso nella tradizione mitico-rituale che per centinaia di migliaia di anni aveva
accompagnato la vita dell’uomo sulla terra, il logos risponde con un pensiero che noi, con un termine
impiegato dai Pitagorici, chiameremo poi “filosofico”. Un pensiero che concepisce tutto ciò che non è
propriamente filosofico e rigorosamente critico quale “senso comune”. È la filosofia a inventare, si può dire, il
senso comune. E ancora oggi noi distinguiamo il senso scientifico, il senso filosofico, dal senso comune,
quello partecipato e condiviso da tutti coloro i quali la pensano allo stesso modo, giudicano allo stesso
modo, credono alle stesse cose, e subiscono, assorbono acriticamente quanto viene trasmesso loro dalla
cultura. Tutto questo costituisce il bagaglio del senso comune: la cosiddetta enciclopedia tribale.
Sono i filosofi a ritenere esplicitamente che il senso comune, le credenze comuni, i comportamenti
comuni debbano essere criticati, messi in discussione. Dunque quando nasce la filosofia, con essa nasce il
senso comune. Anzi, la filosofia in prima istanza non è altro che critica del senso comune. Tutte le credenze
corrive, tradizionali, consuetudinarie della comunità sono sottoposte ad una critica perfino feroce e
sprezzante da parte di uno sparuto gruppo di intellettuali, che si contrappongono aristocraticamente agli altri
– ai pollòi, la “maggior parte”, i più – coloro i quali non sono in grado di elevarsi alle altezze speculative dei
filosofi. Si tratta di un’élite, senza dubbio di una classe ridotta, una sparutissima minoranza, però costoro
cambiano la cultura del mondo. La critica istituzionalizzata del senso comune porterà alla scienza e alla
metafisica.
Quante volte ci è stato detto che la filosofia nasce dalla meraviglia, dallo stupore?
8
TEETETO: Per gli dèi, Socrate! Sono straordinariamente meravigliato dalla natura di tutto ciò, tanto che a
volte, esaminandolo a fondo, mi vengono le vertigini.
SOCRATE: Pare, amico mio, che Teodoro non abbia espresso un giudizio sbagliato sulla tua indole: ciò che
provi - la meraviglia - è un sentimento assolutamente tipico del filosofo. La filosofia non ha altra origine che
questa e, a quanto pare, chi ha definito Iride figlia di Taumante, non ha tracciato una cattiva genealogia.
Platone, Teeteto, 155d
Qui troviamo un gioco di parole fra thaumázein, che vuol dire «meravigliarsi», e Taumante, il padre di
Iride, la messaggera degli dèi. Iride, in quanto messaggera, rappresenta in senso metaforico il sapere, la
conoscenza, e quindi la filosofia. Anche secondo Aristotele l’origine della meraviglia spinge l’uomo alla
filosofia:
«[…] gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da
principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco,
giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli
del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di
dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere (…) Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi
dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche
utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressoché tutto ciò
che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si cominciò a ricercare questa forma
di conoscenza. È evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad
essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad
altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.»
Aristotele, Metafisica A 2, 982b 12-27
La ricostruzione di Aristotele, che vuole la filosofia nata dal thaumázein, dalla meraviglia – dal
meravigliarsi del mondo, per poi scoprirsi nel mondo – è forse più bella e accattivante, ma non persuasiva.
La filosofia è nata dalla tragedia di un’etnia che vive improvvisamente, senza volerlo, la crisi di un sistema
millenario. Quando i Greci cercarono di affrontare la crisi, lo fecero inventando questo logos.
Il pensiero del sospetto, il pensiero critico, non ha distrutto il mito, ma è nato quando ormai non si crede
più alle attestazioni mitico-rituali e ai valori rivelativi. Il residuo di questa enciclopedia tribale, che da sempre
veniva trasmessa ne varietur, per così dire, alle nuove generazioni, fu allora ridotto e interpretato come
senso comune e rimase accanto alla filosofia, di contro alla filosofia, come ciò che pensano i più. Ma ciò che
pensano i più – indottrinati semplicemente da una trasmissione di tipo tradizionale – non è detto che sia
vero. Il senso comune non basta più perché ormai ha perso la sua antica base rivelativa.
Così l’universo del mito in Grecia viene progressivamente considerato come un centone di cianfrusaglie,
un collage di dati che saranno tutt’al più utili per la commedia, per l’arte, per le favole, per la retorica e per la
politica: Platone userà dei miti, preferendoli all’argomentazione, come nel passo citato del Protagora. Ma i
Greci fin dall’inizio della loro storia hanno ormai perso il senso autentico del mito. Il mythos è ora un
racconto, un racconto che può essere suadente, persuasivo, utile, ma non è più il mito delle culture
rivelative.
9
La perdita del Centro
Sebbene possegga un evidente connotato spaziale, il Centro del mondo non è in alcun modo il punto in
cui, ad es., si incontrano gli assi di simmetria dei poligoni e dei poliedri regolari o il punto interno equidistante
da tutti i punti che giacciono sulla circonferenza, secondo le usuali convenzioni della geometria piana
euclidea. Non è neppure un centro inteso quale luogo fisso, immobile, perché nei popoli nomadi è il palo
sacro o il palo della tenda, che viene spostato e piantato di volta in volta, sia pure per una notte soltanto, ad
essere ritenuto il Centro del mondo. Così essi, pur percorrendo anche spazi molto estesi, si mantengono
sempre accanto al Centro. Un Centro molto singolare, quindi, che può essere uno e molteplice nello spazio
e nel tempo (per iterazione).
Il Centro del mondo è, in realtà, quel luogo privilegiato ove, sulla base di un preciso dettato mitico, è
possibile incontrare la figura potente, cioè il Sacro. Questo incontro, sempre invocato e temuto, è comunque
attuabile, perché i racconti mitici affermano l'esistenza in tale sito di una sorta di apertura, un corridoio che
consentirebbe la comunicazione diretta tra i diversi livelli del cosmo: il livello terrestre, quello celeste e quello
infero. Il nome dei santuari (ad es., le celebri ziqqurat mesopotamiche, vere e proprie "montagne cosmiche")
di Nippur, Larsa e Sippar era Dur-an-ki, cioè "legame tra il cielo e la terra". Babilonia, come Bab-ilani, cioè
"Porta degli Dei", era detta "Casa della base del cielo e della terra", "Legame tra cielo e terra". Centri del
Mondo e accessi celesti ed inferi erano, inoltre, le capitali dei sovrani cinesi e tutti i siti che ripetono Alberi,
Montagne, Colonne cosmiche, come il monte Meru della tradizione indiana, Haraberezaiti degli Iraniani,
Himingbjor degli antichi Germani, il Monte dei Paesi mesopotamico, i monti Tabor, Gerizim e Golgota in
Palestina.
In effetti, l'imperioso e irresistibile vissuto – individuale e collettivo – dello stare vicino al Centro del
Mondo, ha avuto sempre, presso le comunità umane, un indiscusso valore esistenziale. Il potente vissuto
territoriale di abitare una terra che sta intorno al Centro del mondo è il connotato eminente ed ecumenico –
e, quindi, del tutto fisiologico – dell'etnocentrismo insito in ogni postura indigena e in ogni comunità umana.
Questa complessa condizione esistenziale, che coinvolge singoli ed etnie, non si esaurisce nel determinare
la distinzione tra terre e uomini avvertiti come familiari e terre e uomini che non sono riconosciuti come tali.
Essa induce, irresistibilmente, a complessi processi di marginalizzazione e di periferizzazione antropologiche
– non di rado drammatici e violenti – di paesi e di intere comunità che vengono rifiutati come affini e,
addirittura, come umani. In quanto luogo abitato o frequentato in terra dal Sacro, il Centro del mondo
esibisce la massima concentrazione pensabile di realtà e di senso, però, a mano a mano che ci si allontana
da esso, la sua potenza protettiva e salvifica progressivamente declina, indebolendosi, così, fino a spegnersi
definitivamente al di là delle estreme frontiere del territorio abitato dall'etnia, riconosciuto come proprio e
come unico mondo possibile. Sono, questi, luoghi selvaggi, incolti e poco accessibili all'uomo, come i deserti,
le distese acquee, le foreste impenetrabili, le cime elevate, ritenuti non cosmizzati e, quindi, preda
dell'irrealtà e dell'insensatezza, segnati dal terrore e dalla pena, luoghi ove sogliono risiedere gli spiriti dei
morti, i demoni, le potenze del Caos, del Nulla e, comunque, tutto ciò che è "altro" rispetto a qualunque
usuale riconoscibilità umana.
[ Testo → D.A. Conci, “Lontano dal centro del mondo”]
10
L’uomo senza cultura muore: identità e securizzazione sono garantite esclusivamente dalla cultura di
appartenenza. Ogni indigeno – noi compresi – ha bisogno della propria cultura per poter sopravvivere, e la
cultura a sua volta ha bisogno di essere conservata, difesa, circondata da divieti, da tabù, trasmessa ne
varietur, senza mutamenti. Al punto di giustificare – negli universi mitico-rituali – la credenza che le origini
della cultura stiano nella voce degli dei: gesti, comportamenti, attività, relazioni, ecc. derivano da paradigmi
rivelati illo tempore da una divinità. Le culture mitico-rituali sono nutrite da una radice di senso di matrice
rivelativa, mentre i Greci non hanno una cultura rivelata. La filosofia non è fatta di testi sacri, non si presenta
come un sapere rivelato, anche se in certi casi prova ad avvolgersi di sacralità per legittimarsi.
La storia del nostro pianeta è anche una storia di estinzioni culturali. Oltre che per la violenza degli
aggressori esterni, le culture si estinguono soprattutto per mancanza di trofismo interno, per una sorta di
implosione, di collasso. Quando una cultura entra in crisi perde il proprio centro: allora scompare, oppure
sopravvive a se stessa, si trascina come cultura ormai implosa. Quando si perde il centro si verifica uno
spaesamento, si subisce una dislocazione: non si crede più che le proprie credenze e convinzioni siano
assolute ed esclusive.
L'Europa è in crisi ormai da più di un secolo: è dalla fine dell'Ottocento, passando per l'intero Novecento
per arrivare a tutt’oggi, che l'Occidente si trascina in una condizione esistenziale di sofferenza che possiamo
sintetizzare, usando la nota espressione di Nietzsche, come "perdita del centro". Nonostante la cultura
occidentale si sia espansa ovunque, conquistando le Americhe nella doppia valenza culturale anglosassone
e latina, protendendosi in Asia e nell'Oceano Pacifico, il presente è segnato da questa grande crisi
dell'Occidente, che può essere letta anche come crisi delle radici culturali: come se le fonti originarie della
nostra cultura, che stanno in Europa e in particolare nella Grecia antica, avessero finito per inaridire il loro
senso. Va segnalato tuttavia che il decentramento dell’Occidente è in realtà un processo graduale, che
accompagna ormai da secoli il nostro percorso culturale. Un processo scandito da alcune tappe significative,
sintetizzate efficacemente da Sigmund Freud, il quale, in un articolo del 1916 "scattava un’istantanea" di
quell’immagine del mondo che si era creata con la nascita della scienza moderna, sottolineando le
"umiliazioni" inferte da questa al narcisismo eurocentrico:
«Vorrei mostrare come al narcisismo universale, all’amor proprio dell’umanità, siano state fino
ad ora inferte tre gravi umiliazioni da parte dell’indagine scientifica.
a) Dapprima, all’inizio delle sue indagini, l’uomo riteneva che la sua sede, la terra, se ne stesse
immobile al centro dell’universo, mentre il sole, la luna e i pianeti si muovevano attorno ad essa
con traiettorie circolari. [...] La posizione centrale della terra era comunque una garanzia per il
ruolo dominante che egli esercitava nell’universo, e gli appariva ben concordare con la sua
propensione a sentirsi il signore del mondo. La distruzione di questa illusione narcisistica si
collega per noi al nome e all’opera di Niccolò Copernico nel sedicesimo secolo. [...] Quando
tuttavia essa fu universalmente riconosciuta, l’amor proprio umano subì la sua prima
umiliazione, quella cosmologica.
b) L’uomo, nel corso della sua evoluzione civile, si eresse a signore delle altre creature del
mondo animale. Non contento di tale predominio, cominciò a porre un abisso fra il loro e il
proprio essere. Disconobbe ad esse la ragione e si attribuì un’anima immortale, appellandosi a
11
un’alta origine divina che gli consentiva di spezzare i suoi legami col mondo animale. [...]
Sappiamo che le ricerche di Charles Darwin e dei suoi collaboratori e predecessori hanno posto
fine, poco più di mezzo secolo fa, a questa presunzione dell’uomo. L’uomo nulla più è, e nulla di
meglio, dell’animale; proviene egli stesso dalla serie animale ed è imparentato a qualche specie
animale di più e a qualche altra di meno. Le sue successive acquisizioni non consentono di
cancellare le testimonianze di una parità che è data tanto nella sua struttura corporea, quanto
nella sua disposizione psichica. E questa è la seconda umiliazione inferta al narcisismo umano,
quella biologica.
c) La terza umiliazione, di natura psicologica, colpisce probabilmente nel punto più sensibile.
L’uomo, anche se degradato al di fuori, si sente sovrano nella propria psiche. [...] Tu ti comporti
come un sovrano assoluto che si accontenta delle informazioni del suo primo ministro senza
scendere fra il popolo per ascoltarne la voce. Rientra in te, nel tuo profondo, se prima impari a
conoscerti, capirai perché ti accade di doverti ammalare; e forse riuscirai a evitare di ammalarti.
Così la psicoanalisi voleva istruire l’Io. Ma le due spiegazioni - che la vita pulsionale della
sessualità non si può domare completamente in noi, e che i processi psichici sono per sé stessi
inconsci e soltanto attraverso una percezione incompleta e inattendibile divengono accessibili
all’Io e gli si sottomettono - equivalgono all’asserzione che l’Io non è padrone in casa propria.
Esse costituiscono insieme la terza umiliazione inferta all’amor proprio umano, quella che
chiamerei psicologica".
(S. Freud, «Una difficoltà della psicoanalisi», in Idem, Opere, vol. VIII, Torino 1989, pp. 660663.)
C’è un aspetto di questa crisi che ci interessa particolarmente, in relazione al tema di cui ci occupiamo.
La "perdita del centro" che ha travolto la tradizionale compagine dei fondamenti della cultura europea, ha
finito per rimettere in questione anche l’indole del rapporto conoscitivo tra l’uomo e il mondo, che noi
abbiamo ereditato dal pensiero greco. Il nostro rapporto conoscitivo, cioè, non può più essere inteso come il
gesto di chi assegna dei significati a qualcosa di neutro, a qualcosa che è già davanti a noi, e che se ne sta
lì aspettando che il nostro atto conoscitivo compia il gesto del significare, etichettando, per così dire, il
mondo. Come Adamo che dà i nomi alle cose… Questa idea è tipicamente ontologica, l’idea che ciò che se
ne sta davanti a noi sia privo di senso e che noi si sia naturalmente destinati ad attribuirgli un significato, a
dargli un nome. Per cui le cose non significano nulla, stanno lì e aspettano di essere significate.
La crisi dei fondamenti
Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, gli sviluppi delle scienze matematiche e fisiche
mettono in crisi i principi e le categorie fondamentali su cui si era basata fino allora la scienza moderna.
Ancora ai tempi di Kant geometria euclidea e meccanica newtoniana potevano apparire come modelli di
rigore scientifico e fondamento certo di tutto il sapere: le loro strutture sembravano rispecchiare l’architettura
stessa della ragione umana. Ora, cambiamenti rivoluzionari nelle scienze portano alla nascita di geometrie
non-euclidee e meccaniche non-newtoniane. Questo periodo di dibattiti radicali nella filosofia e nella scienza,
che coinvolgono categorie della conoscenza come quelle di numero, spazio, tempo, causalità, ecc. e
12
portano a ripensare lo stesso rapporto cognitivo soggetto/oggetto, nella storiografia filosofica viene indicato
con il nome di “crisi dei fondamenti”.
Max Planck scopre ai primi del Novecento che l'energia delle radiazioni può essere emessa o assorbita
in quanti discreti: è la nascita della meccanica quantistica, che fa crollare il principio di continuità enunciato
dalla fisica classica. Successivamente, Werner Heisenberg formula il "principio di indeterminazione", il quale
esprime il grado con cui lo scienziato, attraverso il processo di misurazione, influisce sulle proprietà degli
oggetti osservati. I fenomeni atomici studiati dalla fisica non sono pertanto indipendenti dall'osservatore
umano, ma anzi interagiscono con esso; la loro connessione causale non è univoca e non può essere
stabilita in assoluto, cosicché le leggi scientifiche elaborate dalla nuova fisica non rispecchiano in modo
"obiettivo" il mondo (così come esso è stato pensato da Dio, avrebbe detto Galileo), ma rivestono soltanto
carattere statistico e probabilistico.
Nel 1905 Albert Einstein enuncia la cosiddetta formulazione "ristretta" della teoria della relatività, la quale
abolisce il principio classico dell'indipendenza reciproca di spazio e tempo, non più considerati come realtà
oggettive e assolute. I fenomeni osservati, in riferimento a velocità elevatissime, prossime alla velocità-limite
della luce (invariante rispetto ai sistemi di riferimento), non sono indipendenti dalla posizione e dallo stato di
moto dell'osservatore, ma anzi sono relativi a essi. Pertanto, sia nel microcosmo atomico, che nel
macrocosmo dei corpi celesti, la scienza novecentesca apre una via estremamente feconda di scoperte,
risultati e innovazioni, ma anche estremamente problematica relativamente al fondamento e al senso dei
suoi concetti, ossia al significato razionale e teoretico delle sue teorie.
Una rivoluzione di analoga importanza si verifica nelle matematiche, che già nell'Ottocento avevano
abbandonato, con Bernhard Riemann, l'univocità dell'antico modello geometrico euclideo. La ricerca della
scuola di Karl Weierstrass, viene proseguita da Richard Dedekind e Georg Cantor, i quali, chiedendosi se
fosse possibile ricondurre tutti i concetti matematici (divenuti col tempo estremamente complessi) ai numeri
naturali, pongono il problema dei fondamenti ultimi della matematica. Da tale ricerca e dalle aporie che ne
scaturirono avrà origine il tentativo di fondare e riformulare l'intera matematica, e in particolare l'aritmetica,
sulle basi della logica. Da tale grandioso programma, avviato da Gottlob Frege, si svilupperà il fecondo e, al
contempo, problematico cammino della logica matematica, o logica formale, nel nostro secolo, con Peano,
Russell, Whitehead e molti altri.
In particolare, la nascita delle geometrie non-euclidee tronca alla radice una delle idee filosofiche più
influenti e radicate della tradizione del pensiero occidentale: l’idea che gli assiomi della geometria euclidea
fossero delle verità evidenti e incontrovertibili. Le geometrie non-euclidee mostrano che quelli che erano
considerati “principi” non sono altro che “cominciamenti”, e che alcune proposizioni ritenute universalmente
valide ed eterne, sono mere convenzioni.
[ Lettura → Luigi Lentini, «I fondamenti della geometria»: Appendice, p. 82 ]
La ricerca filosofica e scientifica nel Novecento subisce una vera e propria “svolta analitica”, che può
essere qualificata propriamente sotto il titolo di "relativismo metodologico". La condizione di "relativismo
metodologico" significa semplicemente che non è possibile, per chiunque proceda in una indagine filosofica
o scientifica con autentica consapevolezza, presumere che i propri risultati valgano in sé e per sé, come se
fossero del tutto indipendenti dalla teoria e dal metodo che li hanno conseguiti. Il legato più grosso, quello
13
più costruttivo, del pensiero contemporaneo riguarda proprio questa valenza analitica degli enunciati: la
natura metodologica e non speculativa degli enunciati di una teoria.
Il fatto che i risultati dell'analisi abbiano un valore esclusivamente analitico, sancisce il carattere
contestuale dei risultati delle teorie scientifiche e delle teorie filosofiche. Non è possibile una
decontestualizzazione, una estrapolazione di tali risultati. Non è possibile concepire una struttura ab-soluta,
sciolta dal contesto dell'analisi. La perimetrazione di un contesto analitico coincide dunque con l'impossibilità
intrinseca di formulare asserzioni metaculturali. Pertanto è impossibile formulare asserti che possano valere
in modo assoluto ed esclusivo, cioè in ogni spazio e in ogni tempo. Se non siamo capaci di un accesso
diretto, transcategoriale all’Essere, svanisce di conseguenza ogni pretesa di accedere ad un ontos on, ossia
la pretesa di venire in sicuro possesso di una verità stabile, ultima e definitiva. L'intera cultura occidentale,
sebbene raggiunga risultati teorici e pratici rilevanti e utili, procede così sul vuoto, in radicale assenza di
fondamento.
Ogni enunciato quindi è sempre un enunciato il cui valore di verità è relativo al contesto nel quale viene
avanzato. Ma questo nuovo principio è di natura patologica: è una limitazione interna dell'analitica che ha
origine appunto dalla perdita del centro. La perdita del centro è in sostanza la perdita del fondamento
assoluto, dello «sguardo da nessun luogo» (questo è il centro) e si configura inequivocabilmente come una
forma di patologia culturale. Questa contestualità analitica è propria della scienza contemporanea ed
assume modalità diverse: nella fisica, ad esempio, convivono più fisiche. E così il principio di
indeterminazione di Heisenberg, l'individuazione di particelle dotate di massa negativa, la rivoluzione nel
concetto di spazio-tempo, lo sviluppo di logiche eterodosse, ecc., sono mutamenti che possono essere letti
come altrettante perdite del centro.
[ Lettura → Luigi Lentini, «I principi della conoscenza del mondo fisico»: Appendice, p. 90 ]
Le conseguenze della crisi non riguardano esclusivamente l’ambito scientifico, e si estendono – o
meglio, si inseriscono – nel generale mutamento del clima culturale dell’Occidente europeo. I quadri di
riferimento consolidati si alterano e comincia un processo di “derealizzazione” del mondo che comporta
conseguenze negative anche nei confronti dell’esistenza comune, quotidiana, non soltanto nell’ambito
specialistico delle discipline scientifiche. L’aspetto teoreticamente saliente di questo processo è la
conclamata impossibilità di pervenire ad una conoscenza ultimativamente fondata, universalmente valida e
incontrovertibile. Il sogno epistemico della filosofia greca, l’idea che un pensiero scientifico non possa
qualificarsi come tale se non in quanto ultimativamente fondato, se non come episteme, tramonta
definitivamente.
La storia del pensiero epistemologico del Novecento è in estrema sintesi la vicenda dei vari tentativi di
salvare la razionalità scientifica, e quindi la validità dell’impresa conoscitiva della scienza, nonostante la
caduta del paradigma del fondamento. Se la tendenza predominante sarà infine la proposta di forme di
razionalità limitata, nel corso del secolo si registrano anche alcuni tentativi di “rifondazione” epistemica. Il
neopositivismo e la fenomenologia di Edmund Husserl sono forse gli ultimi massicci tentativi fondazionali
nella storia del pensiero contemporaneo.
14
I modelli della cultura di appartenenza
Alle spalle del nostro pensiero, del nostro agire, del nostro sentire, c’è sempre una conoscenza di sfondo
(quella che Gadamer e Heidegger chiamano “precomprensione”) ed essa è dovuta all’inculturazione. Noi
abbiamo un cervello umano non soltanto perché siamo nati di donna, ma anche perché il cervello si è
sviluppato e complessificato grazie a processi inculturativi. Noi non abbiamo dei dispositivi biologici
impiantati nel nostro cervello che ci permettano di sopravvivere senza la cultura. Si può dire che noi ci
inculturiamo dalla nascita alla morte: l’inculturazione è continua, è quotidiana e permanente.
Che cosa significa “inculturazione”? Significa che noi riceviamo dagli adulti, appena nati (ma sembra che
persino nel ventre della madre vengano inviati dei segnali di inculturazione) ciò di cui siamo biologicamente
privi: modelli percettivi, modelli affettivi, modelli valutativi, modelli operativi. L’uomo non sa come
comportarsi, come muoversi: se fosse privo di questi modelli, di questi protocolli di comportamento non
saprebbe come agire. Questa modellizzazione del cervello fa sì che l’uomo abbia artificialmente ciò che gli
animali hanno naturalmente. Dunque l’inculturazione ci dà dei protocolli per percepire, per stare al mondo,
per valutare, per sentire. Senza questa modellizzazione, il cervello praticamente si spegnerebbe: non
sarebbe in grado di sopravvivere.
Questi modelli indotti e trasmessi dalla cultura, tuttavia, non sono semplicemente un elenco di voci
dell’enciclopedia tribale, un allestimento di contenuti sviluppato e implementato da una intelaiatura esterna.
La modellizzazione è qualcosa che sta sia fuori che dentro di noi, ma è soprattutto dentro di noi, è costitutiva
del nostro cervello. Il cervello pertanto non andrebbe inteso come un organo interno, ma come qualcosa che
si trova all’intersezione tra biologia e storia, qualcosa che vive, per così dire, tra l’interno e l’esterno del
nostro essere umani. È questa modellizzazione che complessifica e sviluppa il nostro cervello, preparandolo
appunto a vivere e a pensare in un certo modo piuttosto che in un altro: ecco da dove scaturisce la
differenza tra le varie culture. Ciò significa che il nostro modo di stare al mondo, e quindi di percepire, di
sentire, non è un rapporto che si instaura nel deserto dei condizionamenti culturali ed ambientali, bensì si
sviluppa all’interno di condizionamenti forti, talmente potenti che se non ci fossero noi non potremmo
nemmeno sopravvivere.
Dunque i nostri modelli condizionano pesantemente i pensieri, i sentimenti e le azioni che si svolgeranno
all’interno del nostro habitat culturale, per cui noi in fondo potremmo dire di essere dei cloni culturali: siamo
cloni della nostra cultura. Solo in condizioni eccezionali, di una genialità assoluta, l’individuo può esprimere
qualcosa di assolutamente creativo e libero. Solitamente il volume della creatività è minimale rispetto
all’habitat culturale, che funge come uno massiccio sfondo di precomprensione, che ci guida altamente e
capillarmente, ma senza essere visto e riconosciuto come tale.
Pertanto ogni nostro atto conoscitivo non è mai originario, non avviene mai per la prima volta, ma è
sempre un atto di ri-conoscere, perché sono i nostri modelli percettivi che ci hanno preparato a stare al
mondo ed assicurano la plausibilità di ciò che faremo, che diremo, ecc. Se nasciamo ad Arezzo ma poi
cresciamo in Cina, saremo cinesi, anche senza avere gli occhi a mandorla, che sono marcatori esterni. Tutto
questo ci dice che i nostri comportamenti poggiano su un fondamento, su una base di tipo culturale, non
semplicemente biologica. Una base culturale forte che di norma è invisibile perché noi ci stiamo seduti
sopra: non la vediamo, non siamo in grado di coglierla. Questo è importante, perché senza questi modelli
15
percettivi, noi non saremmo in grado di controllare il caos delle sensazioni che aggrediscono il nostro corpo
fin da quando apriamo gli occhi.
Noi ci comportiamo da esseri umani come se il nostro comportamento fosse un istinto, quando invece è
stato indotto dall’inculturazione. In fondo è questa la cosiddetta «personalità di base». Il mondo in cui
viviamo viene costituito dalla cultura: risulta istintivo comportarsi secondo certi moduli, secondo certi
protocolli, che variano a seconda del tipo di inculturazione ricevuto. Ma l’uomo viene inculturato in maniera
tale che ogni prodotto dell’inculturazione viene assunto come già dato: come se fosse un in sé. Questo
perché l’inculturazione è un processo che si svolge al di fuori della volontà del soggetto.
Di norma per cultura si intende una sfera in cui domina la libertà, dove abitano in sostanza la
spontaneità, l’originalità, la creatività. Una sfera autonoma al cui interno si muove una coscienza intesa
come consapevolezza continua. In realtà le cose non sono così semplici, perché all’interno della cultura
esiste un’area che appare del tutto fuori controllo da parte degli indigeni, di coloro cioè che appartengono
alla cultura in questione, ma che – pur essendo fuori controllo – è ciò a partire da cui tutto il resto può essere
pensato, sentito, agito e valutato. È un’area di norma geneticamente invisibile e che quindi facilmente può
essere assunta come la sfera dell’incondizionato, proprio perché essendo invisibile, ed essendo giustamente
non ritenuta prodotta dal soggetto (che l’ha subita attraverso l’inculturazione), può essere facilmente
interpretata e assunta come qualcosa di incondizionato, così come è incondizionato il nostro essere
fisiologico e biologico. Vale a dire, così come noi non abbiamo certo scelto di avere gli occhi che abbiamo, la
forma del naso, determinati polmoni, fegato, cuore, insomma il nostro particolare fisico e tutti i suoi organi
interni, così non possiamo a piacimento scegliere determinati fondamenti culturali piuttosto che altri.
Questa invisibilità conduce ad assumere come seconda natura, come incondizionato, qualcosa che in
realtà non è né naturale né incondizionato, perché è frutto di scelte, di giochi culturali che popoli appartenuti
anche ad etnie diverse dalla nostra hanno praticato collettivamente nel corso del tempo. Così noi subiamo
condizionamenti culturali anche di origine lontanissima. Ad esempio, quelli delle etnie greche che hanno
impiantato i rudimenti concettuali della filosofia, del pensiero scientifico dell’Occidente. Assunta come
incondizionata, questa sfera di presupposti finisce per essere interpretata se non proprio come naturale,
certamente – in altre culture e in altre epoche – come soprannaturale, come voluta da figure potenti, dalla
sacralità.
Quand’è che queste strutture di base appaiono, allora? Appaiono quando una cultura entra in crisi. Di
norma, in condizioni fisiologiche, esse sono invisibili. Ma quando la cultura entra in uno stato patologico,
cominciamo ad avvertirle, né più né meno come succede quando un nostro organo si ammala, e noi
avvertiamo la sua presenza dal dolore che esso ci invia proprio perché non funziona più come si deve. Ed è
appunto questa crisi che distrugge l’incondizionatezza e getta nell’ansia, arrivando in certi casi a provocare
reazioni violente. Distruggendo l’incondizionatezza e rendendo visibile ciò che era invisibile, ovvero ciò che
costituiva il fondamento della cultura, ci si accorge che la propria cultura non poggiava su una solida roccia,
non era sicura ma precaria, dunque non garantita. Tutto ciò genera angoscia e terrore, e a questi si può
associare la violenza. Il sistema di sicurezza che l’incondizionatezza stessa aveva disteso su una comunità
umana si disperde. E questo cosa significa? Da un punto di vista filosofico e antropologico, significa che ogni
qualvolta ci troviamo a parlare di concetti, di categorie, di termini, dobbiamo sempre intenderli, interpretarli
16
ed usarli riconducendoli al sistema culturale all’interno del quale essi sono nati. E se il sistema culturale è in
crisi, non è possibile che questi termini vengano usati come se fossero assoluti e incondizionati.
Quando si crede che i propri principi e criteri siano certi, assoluti ed esclusivi, allora li si proietta
dappertutto. Ed è ovvio che li si proietti dappertutto: non abbiamo altro. L’unico modo in cui possiamo
comprendere il mondo intorno a noi è adoperare gli strumenti del nostro sistema culturale. E facciamo
questo senza cautela alcuna, perché tali strumenti sono da noi necessariamente intesi come assoluti ed
esclusivi. Non si può uscire dalla propria cultura. «Il giaguaro non può uscire dalla propria pelle», è il detto
Masai che esemplifica tale condizione.
Solitamente distinguiamo i segni naturali da quelli culturali in quanto questi ultimi hanno un loro senso,
sono portatori di un senso che poi è il senso degli altri, il senso in cui l’intelligenza e la volontà di altri si sono
materializzate, sono precipitate nel segno, e così le possiamo osservare, studiare, interpretare. Quando
proiettiamo modelli matematici e logici su dati di esperienza che non sono in sé portatori di senso, o che
perlomeno non riteniamo siano tali, effettivamente non possiamo fare altro: i dati d’esperienza sono caotici e
sconnessi, per interpretarli e spiegarli abbiamo bisogno di un modello che li metta in relazione, che dia loro
un ordine, consentendoci di comprenderli. Ma quando proiettiamo il nostro senso su segni culturali che sono
già loro portatori autonomi di senso, si presenta un problema ulteriore: alla fine dei conti quello che
riusciamo a cogliere è il senso nostro o è il senso degli altri? È difficile rispondere a questa domanda.
Solitamente si usa il senso proprio per interpretare il senso degli altri. Di norma un antropologo, così come lo
psicanalista, lo psicologo, il sociologo, impiegano il proprio senso per cercare di spiegare il comportamento
della psiche, oppure quello della comunità, o della società che stanno studiando. E in questo modo gli altri
vengono impastati con le nostre credenze: tutto ciò è fatale.
Ma una volta perso il fondamento, venuto a mancare il fondamento assoluto ed esclusivo, non è più
possibile ritenere i propri criteri e i propri principi come assoluti ed esclusivi. Per questo motivo, nella
generale negatività della perdita del centro c'è anche un aspetto positivo: quando io perdo il centro non
posso più proiettare i miei criteri, i miei principi, i miei valori, poiché essi si sono drasticamente indeboliti. Noi
occidentali viviamo appunto in uno stato di debolezza culturale. E questa condizione di perdita del centro è
una condizione patologica, non è frutto di una scelta. Una cultura che ha perso del tutto il centro si trova
sempre in condizioni patologiche. Ma dobbiamo tener presente che, in quanto indigeno di questa cultura, io
continuo sempre ad utilizzare i miei strumenti, ad applicare i miei criteri, a seguire quei principi che mi sono
stati dati dall'inculturazione, trasmessi dai miei genitori, insegnati dai miei maestri, dai miei professori, ecc.
Sono sempre quelli, però si sono indeboliti, non sono più assoluti ed esclusivi, e allora non li posso più
proiettare: li posso mettere solamente accanto a quelli degli altri.
Ecco da dove scaturisce l'analisi contrastiva: riesco a capire me attraverso gli altri e gli altri attraverso
me, ma solamente per contrasto. Pertanto occuparsi del pensiero dei "selvaggi" non è un vacuo indulgere
nell'esotismo, interessarsi agli egizi o ai popoli mesopotamici non vuol dire coltivare una passione per
l'antiquariato: significa cercare di parlare di noi stessi, sforzandosi di capire la nostra condizione che poi è la
condizione di debolezza e di sofferenza tipica della nostra epoca, dell’età contemporanea.
In una condizione patologica, di sofferenza, di perdita del centro, non abbiamo altra possibilità che quella
di cominciare a dialogare con gli altri. Posso stare accanto agli altri e gli altri possono stare accanto a me,
senza pretendere di insegnare a tutti – come ha fatto da sempre l'Europa – chi è l'uomo, come si deve
17
comportare, quali valori deve avere, etc. Cercare di comprendere gli altri come altri, senza ridurli a noi, ci
consente di capire un po’ meglio noi stessi. Finalmente ci scopriamo come altri fra gli altri, e non come coloro
che stanno al centro mentre tutti gli altri stanno in periferia.
Il vissuto del Centro e quello della periferia sono in effetti vissuti in reciproca tensione e vicendevolmente
correlati. Chiaramente chi crede di stare al centro del mondo ritiene con altrettanta forza che gli altri stiano in
periferia: questo è l'etnocentrismo; l'idea che gli altri tanto più distanti sono dal centro, tanto più sono
inferiori. La deformazione sfigurante dell’etnicamente altro in “diverso” è del tutto fisiologica presso gli
indigeni di tutte le culture, perché esse si sono sempre comportate così, cognitivamente ed
esistenzialmente.
La maggior parte delle etnie ritiene fisiologicamente di essere composta da “uomini” in sé e per sé, dagli
uomini per eccellenza, ed esclude automaticamente dall’umanità i gruppi diversi dal proprio: gli altri sono
“non-uomini”. Per fare solo qualche esempio, con il nome Inuit “uomini cacciatori” gli Eschimesi designano
se stessi, mentre il termine “eschimese”, a noi più familiare, deriva da eskimatsik, parola che nella lingua
degli indiani Wabanaki del Canada, loro confinanti, significa “mangiatori di carne cruda”, ovvero “selvaggi”.
Gli Zingari o Bohemiéns, Gypsi, Sinti, Manush, Atzigani, Kalè, ecc. fra loro si chiamano Rom, “uomo”. In
America gli indiani Lakota (Sioux) si definivano “popolo degli uomini”, i Cheyenne chiamavano se stessi
“uomini”, mentre i Lakota erano da loro chiamati “volpi”. I Bantu sono “uomini”, Masai vuol dire “uomini
guerrieri”, gli indios Yanomami sono “gli uomini”.
Qui non si tratta affatto della cosiddetta “boria delle Nazioni”, secondo una nota e sviante espressione di
G.B. Vico, bensì di un istinto irrefrenabile a fini identitari e securizzanti, che induce gli appartenenti ad una
qualsiasi cultura a considerare se stessi come uomini tout-court e come abitanti del Centro del mondo, in
quanto detentori di principi culturali assoluti ed esclusivi, confinando, in tal modo, tutti gli altri in periferia o in
lontane regioni. Questi ultimi, allora, vengono compresi e trattati sempre relazionandoli alla propria cultura,
elevata a modello paradigmatico di perfezione, e vengono ridotti, in tal modo, a meri esiti di scarti, di
deviazioni, di deficienze. Questo è l’etnocentrismo. Per questa ragione hanno inevitabilmente prevalso, in
certe analitiche demo-etno-antropologiche, la logica e l’economia delle spiegazioni patologiche, portando ad
intendere gli altri come i prodotti della miseria morale, dell’ignoranza, dell’ingenua credulità, dell’irrazionalità,
del sottosviluppo economico-sociale, etc.
L'etnocentrismo dunque è fisiologico, non c'è cultura che non abbia pensato se stessa come vicina al
Centro. Ma quando l'uomo perde il centro, entra in una situazione di sofferenza, di disorientamento: perde il
senso. L'uomo non può vivere insensatamente. In Occidente la filosofia ha avuto sempre questa funzione,
quella di indagare sul senso, cercare il senso. Si può dire che fin dalle origini dell'Occidente la ricerca del
senso è un connotato fondamentale della nostra storia, che prima di tutto è greca. La Grecia ha dato i
fondamenti alla cultura occidentale, i canoni dell'arte e del pensiero, la scienza, la matematica, la struttura
della dimostrazione: tutta una serie di oggetti culturali senza i quali noi non riusciremmo a riconoscerci come
Occidentali. E naturalmente anche l'Europa, come tutte le altre culture, ha immaginato che la propria cultura
fosse esclusiva ed assoluta, avesse un fondamento assoluto, vale a dire, avesse un valore meta-culturale,
assoluto (nel senso di ab-solutum, prosciolto dai condizionamenti culturali, psicologici, storici, geografici)
cioè che fosse qualcosa che deve valere in sé e per sé.
18
La disperazione fossile
Circa otto milioni di anni fa, imponenti fenomeni eruttivi portarono in Africa all'apertura dell'immensa
fossa tettonica longitudinale chiamata Great Rift Valley che procede da nord a sud dal Mar Rosso al Tropico
del Capricorno. Tale datazione è il frutto di un "compromesso cronologico" tra i quindici milioni di anni
proposti dai paleontologi e i tre milioni di anni avanzati dai biologi molecolari.
[ Lettura → Y. COPPENS, "L'origine dell'uomo nella Rift Valley", Le Scienze ]
Questo dissesto geologico diede origine ad un abbassamento del fondo della Rift Valley e ad un
innalzamento di elevati vulcani (Kilimangiaro, Monte Kenya) e di alte falesie sul fronte occidentale che,
ostacolando il decorso dei venti umidi provenienti da ovest, trasformarono più tardi il clima della parte
orientale dell'Africa in quello tipicamente secco a regime monsonico della savana. Così, mentre i primati
antropomorfi occidentali continuarono a menare vita arboricola senza trauma alcuno nelle foreste umide
equatoriali e tropicali dove erano nati, conservando o specializzando addirittura tale adattamento, quelli
orientali, sotto un'inattesa ed elevata pressione ambientale prodottasi dal duplice evento tettonico e
climatico, non compensabile biologicamente, furono condannati brutalmente all'estinzione.
Tale drammatico esito che è, per altro, la regola e non l'eccezione sul nostro pianeta, dato che oltre il
90% delle specie viventi si è frattanto estinto, fu, per così dire, evitato o, meglio, rinviato, almeno fino ad
oggi, per merito di una australopitecina fortunosamente deviante che con l'assunzione della locomozione
bipede e l'avvento della cultura diede avvio al processo lento, precoce e discontinuo, del tutto imprevisto e
avventuroso, della ominidizzazione culminante nell'Homo sapiens sapiens attualmente in vita. Dunque
questo duplice evento tettonico e climatico sarebbe all'origine del processo di ominidizzazione.
In senso generale si può dire che un organismo vivente è destinato all'estinzione se perde la solidarietà
vitale con il mondo ambiente con cui deve interagire per vivere. E la solidarietà vitale svanisce quando una
qualsivoglia pressione ambientale inattesa o imponente si esercita su un organismo che non è in grado di
rispondere ad uno stimolo che eccede del tutto la portata del programma biologico di cui esso è dotato per
sopravvivere. Con la locuzione sindrome del ragno si allude a quel particolare status in cui, come ritengono
gli entomologi, il ragno sembra non distingua tra il proprio corpo, la tela che ha tessuto e la mosca che vi si è
impigliata. Si intende quindi l'immanenza assoluta della condizione animale in cui l'essere vive, interagendo
con il mondo ambiente che ecologicamente gli appartiene, in presa diretta, immediata e fusionale con esso.
Tale solidarietà vitale primaria può essere conservata e garantita solo mediante un programma biologico
adeguato che assicuri una soddisfacente omeostasi tra l'organismo e il suo habitat.
Ora, se «ogni animale è nel mondo come acqua dentro l'acqua» (G. Bataille, Teoria della religione,
Bologna 1978, p. 48), la perdita della solidarietà vitale comporta la crisi dello stato di immanenza assoluta
propria della condizione animale, cioè l'insorgere di una frattura che si apre là dove dominava il continuum
fusionale delle interazioni automatiche tra l'organismo vivente ed il suo ambiente, interazioni garantite ed
assistite dal suo specifico programma biologico. L'implosione, quindi, dell'immanenza animale significa
l'insorgere di una frattura e, con l'allontanarsi di ciò che occorre per sopravvivere, l'irruzione di una
trascendenza che uccide. Ma un allontanamento che divincola il mondo ambiente dall'abbraccio della
indistinta partecipazione animale e, distanziandolo, lo rende visibile, collocandolo del tutto fuori portata da
19
ogni possibile fruizione su base puramente biologica, è il segnale inequivocabile che annunzia a qualunque
animale condannato la sua imminente estinzione.
Se ora questa lontananza mortale non fosse stata abitata lentamente e precocemente da un senso di
complessità crescente che, surrogando i perduti legami della solidarietà animale con le relazioni artificiali
delle protesi culturali, ha fornito nuovi strumenti per garantire la sopravvivenza, questo primate si sarebbe
estinto in un breve volgere di tempo. L'avvento della cultura ha dunque salvato l'australopitecina inducendo il
processo di ominidizzazione di progenitori scimmieschi lungo percorsi di mutazioni bioculturali del tutto
inauditi.
Filosofi, letterati, teologi, hanno affrontato da sempre il tema della cosiddetta angoscia esistenziale che
accompagnerebbe come un'ombra l'avventura terrestre dell'uomo, elaborando motivazioni e adducendo
ragioni che sono sovente più oscure dell'enigma che dovrebbero svelare. Individuare nel vissuto
fondamentale di una remota antropomorfa, votata all'estinzione, la cosiddetta “disperazione fossile” potrebbe
illuminare a giorno le ragioni di quel cieco sentire umano, qualificato come “angoscia esistenziale”,
motivandolo mediante una lezione diversa da quella usuale.
La disperazione fossile è, anzitutto, il vissuto primario indotto da una condizione esistenziale di
irrelazione mortale, non da un terrore nato da un incontro specifico con un oggetto terrificante che, in quanto
tale, sarebbe sempre in qualche modo affrontabile. Proprio per queste ragioni, si tratta del vissuto identitario
di un essere disperato in sé e per sé, disperato per il suo semplice sentire di esistere, perché in quel primate
coscienza di esistere e coscienza di estinzione fanno tutt'uno. Sorda, cieca, immotivata ed inestinguibile,
essa giace alle radici del fortunoso processo di ominidizzazione e funge nascostamente come una generale
cassa di risonanza, alonando di un'eco abnorme le crisi piccole e grandi della nostra quotidiana esistenza,
dall'australopitecina sopravvisuta per caso all'Homo sapiens sapiens dei tempi attuali. Un primate, dunque,
che era stato votato all'estinzione e che tuttavia – caso unico in tutto il pianeta – riuscì a differire la propria
morte.
Il vissuto della disperazione fossile, quindi, come vissuto della perdita della immanenza animale e
dell'insorgere di una condizione mortale d'irrelazione, appare strutturalmente irreversibile perché
consustanziale all'esistenza stessa di Homo, sebbene da sempre Homo l'abbia culturalmente contrastato in
molteplici modi. Si tratta di un singolare vissuto collettivo, cioè di un vissuto proprio di una specie di primati
che doveva estinguersi e che, almeno finora, non si è estinta:
-
in quanto vissuto della sofferenza primordiale per la perdita della solidarietà animale, esso è
certamente fossile,
-
in quanto tale condizione di immanenza assoluta è andata irreversibilmente perduta, tale vissuto è
un vissuto permanente e inalienabile del nostro essere umani.
Una nota lezione retorica di tradizione umanistica, profondamente consolidata particolarmente in
Occidente, ha sempre interpretato l'avvento della cultura umana sul pianeta come il frutto della trionfale
liberazione dell'uomo dalle catene del cieco istinto biologico, mediante l'irrompere della luce dell'intelligenza
che avrebbe spazzato le tenebre della originaria condizione animale. Tuttavia, anche prescindendo da certe
difficoltà che tale tesi inevitabilmente comporta (cioè la necessità di spiegare, anzitutto, perché un essere
totalmente immerso nell'immanenza fusionale animale abbia ad un certo punto voluto liberarsi da tale felice
20
condizione ed uscirne progressivamente del tutto e come, poi, abbia potuto farlo senza usare le note
tecniche di sollevamento del celebre barone di Münchhausen), appare evidente che Homo è il risultato di un
complicato processo – al tempo stesso, filogenetico e storico-culturale – sviluppatosi a partire da un primate
sventurato che ne ha dato l'avvio non già sollevandosi dalla cieca immanenza animale, ma sfuggendo
fortunosamente alla estinzione annunziatagli dalla perdita della solidarietà vitale dovuta ad una aggressione
ambientale non compensabile da alcun preordinato programma biologico adeguato.
Homo, allora, non sarebbe emerso dopo una faticosa avventura a lieto fine iniziata da un progenitore
sportosi audacemente al di sopra della propria condizione animale (ove un organismo vivente, se fornito di
adeguato programma biologico, vive innervato nel proprio habitat con salda immediatezza senza problemi di
sorta) ma, al contrario, sembra essere emerso da un progenitore animale costretto con inaudita violenza a
sottrarsi funambolicamente alla condizione animale, semplicemente perché lo starci avrebbe comportato per
lui una morte sicura. In altre parole, il vissuto della disperazione fossile ci attesta che il nostro remoto
progenitore non si è sollevato dal fango paludoso dell'animalità per diventare Homo, ma è stato, piuttosto,
espulso dall’animalità suo malgrado e a viva forza, pena una morte annunziata priva di alternative.
Da questo punto di vista, sia la cultura mitico-rituale che quella scientifico-tecnologica sono da intendere,
in via generalissima, come sistemi di teorie e di tecniche di riscatto dalla quotidiana condizione di atona
consumazione dell'esistenza, segnata e scandita in profondità da quella disperazione fossile, in balia della
quale l'uomo non potrebbe certo essere lasciato inerme e indifeso, senza finire per estinguersi come specie.
Tuttavia, a prescindere dalla loro concreta efficacia antagonistica che non può, comunque, essere valutata
oggettivamente perché d'indole altamente contestuale, esse non sono tra di loro commensurabili.
Schematizzando, i vissuti sacrali sono vissuti potenti in maniera eminente e sono talmente reali e in assoluto
significanti da essere assunti come unica fonte di vita e di realtà e come matrice esclusiva di modelli e di
paradigmi per tutte le necessità insorgenti nell'esistenza umana. I vissuti profani, come vissuti segnati dalla
irrelazione della trascendenza e dalla disperazione fossile, sono, invece, vissuti quotidiani che, se
abbandonati a loro stessi senza sostegno alcuno, sono destinati all'impotenza radicale e, quindi, all'irrealtà,
all'insignificanza e alla morte senza ritorno.
In tal senso, particolarmente nelle società cosiddette tradizionali, la linea di demarcazione tra il sacro e il
profano è indubbiamente visibile, anche in maniera netta, là dove preghiere, invocazioni, riti e liturgie
segnalano il perimetro di spazi e tempi in preda alla sofferenza. Ma tale frontiera appare, di necessità, fluida
e mobile, data l'indole totalitaria ed accentratrice della sfera sacrale, necessaria, del resto, per attuare l'opera
fondamentale di sostegno e di soccorso cui il suo ruolo e la sua funzione la destinano nei confronti della
sfera profana, che può salvarsi solo coniugandosi con gli spazi ed i tempi forti abitati dalle figure potenti.
Postura rivelativa
Per universo mitico-rituale si intende un universo culturale che è fondamentalmente basato sul mito e sul
rito. Solitamente parliamo di questi universi alla luce di quello che i pensatori greci hanno pensato del mito e
del rito, proiettando così nostri presupposti e categorie. Provando invece ad accostarlo con cautela
metodologica, un universo culturale a base mitico-rituale si caratterizza in prima istanza per essere privo di
21
un oggetto culturale ben definito: la “secolarizzazione”. Questo termine, com’è noto, ha un’accezione storica
precisa: “secolarizzati” venivano detti quei beni – edifici o palazzi papalini – che dopo il 1870 erano passati
dal patrimonio della Chiesa a quello dello Stato italiano. “Secolarizzato” indica dunque “passato ad una
condizione laicale” e si riferisce alla gran parte degli edifici e dei conventi italiani, soprattutto laziali e romani
(palazzi come Montecitorio, il Quirinale, etc.), che per ovvie ragioni storiche sono passati dalla giurisdizione
papale a quella statale.
Seguendo un taglio filosofico, questo termine viene usato per indicare una condizione umana ed
esistenziale secondo la quale si ritiene di poter vivere lontano dal Sacro una vita degna di essere vissuta. Da
questo punto di vista, la secolarizzazione contrassegna in una certa misura, anche se in una forma larvale,
tutta la storia dell’Occidente, ed in modo particolare l’età moderna, a partire dal Rinascimento e
dall’Umanesimo, per poi maturare progressivamente nel ‘600 e diffondersi con la Rivoluzione Francese.
Nelle culture occidentali e in quelle influenzate dall’Occidente, ad esempio, l’universo profano si
identifica con la condizione di un’umanità che ritiene di poter condurre una vita autonoma e indipendente
dall’universo sacrale. Ma se noi assolutizziamo queste particolari concezioni del Sacro e del profano
maturate in Occidente e poi andiamo a proiettarle come paradigmi ermeneutici per la comprensione delle
concezioni sacre o profane di culture non occidentali o non occidentalizzate, il senso dei dati sotto
osservazione risulterà necessariamente occultato, se non, addirittura, stravolto. In tutti i sistemi culturali ad
esclusivo fondamento mitico-rituale, infatti, questo vissuto della secolarizzazione non è in alcun modo
rinvenibile e, pertanto, il profano non può essere assunto in essi come sinonimo di “secolare”.
L’antropologia fenomenologica tende a definire, addirittura, l’universo mitico-rituale come quel sistema
culturale che ignora la secolarizzazione. La condizione profana cosmica ed umana si rivela qui come uno
stile di vita segnato da una radicale impotenza esistenziale e cognitiva, a cui l’uomo e il mondo possono
sottrarsi solo coniugandosi ritualmente con quel Sacro che i miti, riconosciuti come tali dalle comunità, hanno
rivelato (ierofania) quale indiscutibile potenza salvifica (cratofania). Qui è il Sacro il titolare e gestore
esclusivo di quella esistenza (vita) e di quel senso (razionalità) di cui l’universo profano è costituzionalmente
privo e di cui ha estremo bisogno per sopravvivere. L’idea di una vita dotata di senso lontano dal Sacro è
dunque assolutamente aberrante in culture a fondamento mitico-rituale. In queste culture – ecco il contrasto
– non esiste secolarizzazione. Nelle culture a fondamento mitico-rituale si trovano condizioni esistenziali e
umane, singole e comunitarie, in cui si ritiene che l’uomo sia totalmente impotente, cioè che non sia in grado
di sopravvivere se non viene soccorso quotidianamente dal Sacro. Ma non si tratta di interventi miracolosi:
anche il miracolo è un’invenzione nostra. L’uomo ha bisogno del soccorso quotidiano, costante, del Sacro,
altrimenti non riuscirebbe a sopravvivere.
Solo il Sacro benigno o maligno può dunque elargire o sottrarre all’uomo esistenza e senso. Il vissuto di
impotenza, che contrassegna puntualmente il profano in tutte le culture a fondamento mitico-rituale, rinvia,
allora, ad una concezione del Sacro quale ierofania (manifestazione sacrale) il cui nocciolo è costituito
proprio dalla potenza assoluta e totale (cratofania) e implica da parte umana una particolare disposizione
esistenziale e cognitiva: quella “postura rivelativa” di una coscienza priva di un ego che l’Occidente sembra
aver del tutto smarrito.
Con l'espressione fenomenologica "postura rivelativa" si intende quel generale atteggiarsi esistenziale e
cognitivo della coscienza umana, specificamente impersonale, rilevabile presso alcune culture –
22
essenzialmente in tutte quelle a fondamento mitico-rituale – secondo il quale il conoscere, il sentire, il volere,
l'agire umani e i loro relativi contenuti e/o referenti, pur riconosciuti e assunti come pertinenti alla sfera della
coscienza e come suoi reali o possibili possessi, non sono assunti come originati dalla coscienza stessa,
quali atti relativamente liberi e autonomi di essa, ma sono sempre elargiti o consentiti da volontà e da
intelligenze "altre".
Nella cultura scientifica occidentale questo stato di coscienza è classificato senz'altro fra le
psicopatologie, in particolare tra quelle più gravi, costituite dall'indebolimento e dalla frantumazione dell'io. La
cultura occidentale egemone si fonda, eminentemente, sulla postura proiettiva di una coscienza personale,
centrata in se stessa, ritenendo necessario ed ovvio che, per conoscere il mondo e per agire su di esso,
l'uomo debba proiettare sui dati d'esperienza "vuote" strutture di senso (logiche e matematiche), escogitate
dalla sua mente come modelli relazionali e come possibili progetti ingegneristici, trasformando così i dati in
oggettività cognitive e operative.
Nella “postura rivelativa”, invece, i pensieri, le volizioni, i sentimenti e le azioni umane non sono ritenuti
eventi che nascono spontaneamente da un soggetto come suoi atti, cioè da una coscienza relativamente
autonoma e indipendente, ma sono sentiti come elargiti spontaneamente o ritualmente da realtà “non
proprie”. Dunque pensieri, volizioni, sentimenti dell’uomo si determinano, in maniera per noi paradossale e
incomprensibile, mediante rivelazioni che possono essere anche sacrali, quando sono potenti, e a volte
persino concretamente intrusive dei corpi e delle menti (sono questi i casi delle possessioni o infestazioni
degli uomini e dell’ambiente).
La coscienza impersonale non è che una modalità peculiare di avere coscienza. Una modalità che, a
differenza della coscienza personale, diretta e riflettente per autoreferenzialità – impostasi saldamente in
Occidente a partire soprattutto dalla modernità – si costituisce e si fonda solo per via indiretta e mediata,
come "di rimbalzo", cioè tramite l'acquisizione dei molteplici e vari modi intenzionali (cognizioni, sentimenti,
volizioni, valutazioni, etc.) che si mostrano sempre indissolubilmente sedimentati, come si è visto, nelle
realtà che rivelativamente si danno. Queste, insomma, con il loro manifestarsi, elargiscono alla coscienza
impersonale non solo il senso del mondo, ma anche il senso di se medesima, da qui l’impersonalità della
coscienza. In effetti, forse uno dei pregiudizi più ostinati della cultura occidentale è la convinzione che
«coscienza» e «io» siano sinonimi e che, di conseguenza, la negazione dell'io comporti eo ipso la negazione
della coscienza.
La postura rivelativa umana risulta comunque necessaria ma non sufficiente per l'accadere di una
rivelazione sacrale. Non tutto ciò che si rivela è Sacro, è, cioè, "parola del Signore". La postura rivelativa è
solo il prerequisito, cioè la condizione necessaria perché il Sacro – se, quando e come vuole – possa
manifestarsi ad una coscienza impersonale in postura rivelativa, ma non è anche condizione sufficiente. Le
analisi delle culture del nostro pianeta a fondamento mitico-rituale hanno ecumenicamente attestato che solo
le manifestazioni potenti (cratofanie) sono sacrali (ierofanie) e quindi che la cratofania è l'essenza stessa
della ierofania. Abbandonando, allora, le usuali attribuzioni distintive che identificano il Sacro con il
soprannaturale e il profano con il naturale, emerge fenomenologicamente il fatto che la sfera profana
coincide, diversamente da quella sacra, con l'ambito della rivelazione impotente, con la coscienza, cioè, di
quella intrinseca, insuperabile, debolezza che è propria della condizione dell'uomo e del cosmo, se questi
sono abbandonati a loro stessi. È tale vissuto elementare della condizione umana che è stato individuato
23
nella cosiddetta “disperazione fossile”, la disperazione di un essere privo di un dispositivo biologico di
sopravvivenza e totalmente incapace di sopravvivere senza protesi culturali.
Questi generalissimi rilievi di antropologia religiosa, indipendentemente dalla loro intrinseca validità, non
sarebbero, comunque, possibili senza un’analisi fenomenologica condotta da un antropologo che, invece di
assolutizzare i principi e le categorie della propria cultura – per proiettarle, poi, sui dati da analizzare,
sovrapponendoli ad essi come un estraneo vestito di idee – li impieghi, invece, accostandoli semplicemente
ai principi e alle categorie dell’altrui cultura, confrontandoli, in prima istanza, contrastivamente con i propri, in
nome della categoria dell’alterità e non di quella della diversità, la quale implica, sempre, un’uguaglianza di
principio non provata tra noi e gli altri.
Alterità/diversità
“Altro” (állos) e “diverso” (éteros) non sono necessariamente sinonimi, come comunemente si ritiene.
Enti e stati di cose sono, di norma, “diversi” quando sono tra loro relati, avendo un denominatore comune,
mentre sono reciprocamente “altri” quando, essendo privi di un tale denominatore, risultano, di fatto, irrelati
tra loro. L’irrelazione, implicando la loro reciproca incommensurabilità, esige, di necessità, l’approccio
contrastivo in sede d'analisi. Nel caso della diversità, invece, la relazione dà per scontata l’esistenza di una
comune identità di fondo che legittima e impone un tipo di analisi che proietta codici e categorie
d’appartenenza sui dati culturali altrui. Questi dati in tal modo vengono interpretati e compresi sempre come
“diversi da”, “mancanti di” (anche in senso positivo), etc., venendo così di fatto sfigurati, se essi sono, poi,
veramente “altri”, cioè irrelati. In altre parole, mentre “altro” segnala l’assenza di una relazione tra enti o stati
di cose, “diverso” implica logicamente ed ontologicamente una relazione, un legame che connette
indissolubilmente e necessariamente tale “diverso” a un “identico”.
L’analitica fenomenologica, applicata all’indagine antropologica, ha isolato un vissuto complesso e
sconvolgente: quello che sorge e si impone puntualmente in occasione di ogni incontro realmente
interetnico. Il vissuto, appunto, dell’alterità culturale in quanto tale. Tale vissuto dell’alterità appare costituito,
in prima istanza, dal profondo malessere provocato da un inatteso decentramento esistenziale e cognitivo.
Decentramento che sembra generarsi sempre in occasione del semplice imbattersi in una stravaganza
culturale.
È stato detto che «l’antropologia sarebbe tanto un sapere di frontiera quanto un sapere nato su una
frontiera” (U. FABIETTI, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Laterza, Roma-Bari, 2003,
p. 3). Tuttavia la frontiera antropologica non la si raggiunge effettivamente quando si cominciano a indagare
gli altri, ma solo quando l’antropologo, nell’esercizio del suo lavoro, si disloca cognitivamente, allontanandosi
effettivamente dal centro della propria cultura. Solo così l’antropologo può affrontare le “ragioni degli altri”
senza proiettare più su di loro, per giudicarle, i principi, le categorie, le credenze e i costumi di casa propria,
come fatalmente suole accadere quando si ritiene che questi siano “centrali”, cioè assoluti ed esclusivi.
Tuttavia un simile comportamento cognitivo ed esistenziale, molto complesso e decisamente anomalo,
poiché contrasta con gli elementari vissuti fisiologici d’identità e di securizzazione che solo la radicata
convinzione di stare intorno al centro del mondo può generare e legittimare, non è in alcun modo opzionale,
24
non nasce da una libera scelta, ma può essere indotto solo da un’involontaria crisi radicale che, rovinando i
fondamenti di una cultura, annichilisce alla radice ogni pretesa metafisica o metaculturale di essa.
Ora, avendo un simile collasso aggredito, a partire dagli inizi del secolo scorso, le basi della cultura
europea, la conseguente perdita del centro ha costretto, di fatto, gli indigeni d’Occidente o, comunque, quelli
più avvertiti e coscienti, a non proiettare più i propri principi e le proprie convinzioni sui dati delle culture
proprie e altrui, per coglierne ermeneuticamente lo specifico senso. Ma, nel momento stesso in cui si
dispiegava la concreta possibilità cognitiva ed esistenziale di comprendere finalmente le ragioni di casa
propria come altre tra altre, senza assolutizzarle, e quelle di casa altrui come altre, senza, cioè, più sfigurarle
in diverse, come sempre accade quando si fa riferimento ad un centro da cui misurare e valutare ogni altra
cultura assunta come periferica, la crescente omologazione culturale, dovuta alla crescita quasi biologica
delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione e all’egemonico imporsi delle ragioni
capitalistiche della produzione e del consumo, ha lentamente sbiadito, se non cancellato del tutto, ogni
alterità etnica.
Ora, risulta estremamente arduo, se non, addirittura, irrealizzabile, cogliere il senso di se stessi e della
propria cultura senza alcun termine di confronto possibile. Pertanto, il prediligere, in sede d’analisi
contrastiva, dati e testimonianze provenienti prevalentemente da culture mediterranee da tempo defunte,
non significa soddisfare appetiti archeologici o antiquari di sorta, né appagare l’umana passione per il
meraviglioso e l’esotico, bensì cercare di attingere dal mondo culturale dei morti, onde confrontarli
contrastivamente con i nostri, i codici e le categorie dell’alterità che nell’universo culturale dei vivi sembrano
rinvenibili, ormai, solo in una misura molto ridotta e sfigurata, se non quasi nulla.
Il fenomeno e la rivelazione
L'analisi fenomenologica qui praticata e intesa come una indagine non metaculturale di tipo contrastivo
tra le nostre e le altrui culture, è solo un caso tra i molti di analitiche novecentesche che hanno fatto proprio,
precipitandolo metodologicamente in un presupposto tecnico di indagine, il non voluto vissuto della perdita
del centro. In tal modo è stato possibile sviluppare una inaudita e articolata radicalità critica senza scivolare
precipitosamente nel nichilismo. Tale analitica sembra particolarmente feconda per una ricognizione rigorosa
del senso vissuto dei segni culturali, individuali e collettivi, di tutte le etnie, siano esse familiari o altre.
Questo particolare metodo consente, ad esempio, di isolare, mantenendole integre nell'alterità di senso e di
funzione che le caratterizza, strutture aliene di tempo e di spazio che non sono in alcun modo sovrapponibili
a quelle attive in aree culturali egemoni del nostro Occidente. Conseguentemente vengono escluse
procedure metodologiche che sogliono proiettare inevitabilmente sui segni altrui paradigmi e criteri che sono
propri della cultura di appartenenza. Anche quando non si arrogano, implicitamente o esplicitamente, il
privilegio di un accesso esclusivo ed incondizionato alle strutture di senso della vita e del pensiero umani in
generale, quasi gestissero una delega, in realtà mai loro elargita, a parlare a nome di tutte le etnie del
pianeta, queste posture analitiche ben "centrate" sfigurano, comunque, inevitabilmente i dati, perché questi
non potranno che restituire per riflessione il volto alterato dell'analista stesso.
Uno degli esiti più significativi e fecondi dell’applicazione di tale metodologica contrastiva, è la
25
distinzione tra fenomeno e rivelazione. Sebbene appartengano entrambi a pieno titolo all'indefinito e vago
mondo delle manifestazioni – visive, sonore, olfattive, gustative e tattili – i dati rivelativi non sono assimilabili
in alcun modo ai dati d'esperienza – di quella qualificata come "naturale" o "comune" – e, pertanto, essi non
devono e non possono essere trattati dal pensiero razionale filosofico e scientifico d'Occidente come esso,
per la loro comprensione, tratta, di norma, i dati d'esperienza.
Questa loro reciproca estraneità non è attribuibile in alcun modo alla nota differenza tra l'indole naturale
del dato d'esperienza e quella soprannaturale del dato rivelativo – come ritengono per consenso pacifico gli
studiosi di religione – perché la dicotomia "naturale/soprannaturale", di norma impiegata ampiamente sul
terreno rivelativo come ovvia, ha origine nella filosofia greca, il cui logos è geneticamente e strutturalmente
privo di fondamento rivelativo alcuno ed è, pertanto, estraneo per essenza costitutiva ed operativa a
qualunque contenuto rivelativo autentico. Ciò che li distingue, insomma, va individuato analizzando le
intrinseche strutture di senso delle manifestazioni, assumendole così come si danno, e non proiettando su di
esse categorie e dicotomie a loro "esterne", cioè mutuate da contesti e da atteggiamenti culturali alieni.
L’universo della manifestazione può essere distinto in due parti: un ambito fenomenico ed un ambito
rivelativo.
FENOMENO
RIVELAZIONE
Universo delle manifestazioni
La manifestazione fenomenica non c’è prima della comparsa del logos greco. L’esperienza è a priori
fenomenica e tale condizione essenziale la consegna ad uno status permanente di inadeguatezza cognitiva
e di precarietà esistenziale, che appare incolmabile da qualunque integrazione intuitiva, perché nel
fenomeno l'apparire non coincide - se non casualmente - con l'essere, cioè con la realtà stessa.
Questa devastante frattura di origine culturale è stata affrontata in Occidente, fin dagli inizi della stessa
filosofia, impiegando come protesi per la sua ricomposizione artificiale un logos vuoto, cioè puramente
relazionale. Con l'espressione "pensiero vuoto" si intende un tipo di logos che per funzionare non ha bisogno
di essere riempito di contenuto alcuno. Se, del resto, dovesse dipendere da materiali intuitivi specifici, esso
sarebbe privo di quella eminente facoltà relazionale pura che gli permette di costituirsi come protesi
integrativa di ogni carenza attestativa propria dei fenomeni. Così, dispiegando, mediante la sua attività
relazionale, una indiscussa potenza cognitiva ed operativa, il nostro logos culmina nell'impresa scientifica e
tecnologica, o meglio, costituisce la struttura essenziale della conoscenza qualificata come "oggettiva".
Ma l'indole malsicura e instabile della manifestazione fenomenica genera un'altra cruciale dicotomia che
è esclusiva della cultura occidentale. Se nella manifestazione fenomenica l'apparire non coincide con
l'essere e la manifestazione non è più e sempre testimone fedele della natura della realtà, sorge un
26
complesso quesito, cui la conoscenza comune, filosofica e scientifica hanno cercato da sempre, sia pure
con mezzi diversi, di rispondere. Di fronte all'intrinseca ambiguità di un dato fenomenico qualsiasi, cioè del
dato d'esperienza propriamente detto, quale aspetto di esso pertiene alla realtà vera e propria e quale,
invece, non le pertiene? E l'aspetto che non si riferisce alla realtà, e che pure contestualmente si manifesta,
a cosa mai può rinviare?
La risposta a tali domande, strettamente interconnesse, ha condotto all'individuazione e all'articolazione
filosofica e scientifica di due universi separati e tuttavia relati tra di loro, quello "esterno" e "trascendente"
della natura (l’al di là) e quello "interno" ed "immanente" della coscienza (l’al di qua), cui, evidentemente, si è
ritenuto appartenga ciò che non è attinente all'altro. Così, da questa ambiguità fondamentale della
manifestazione fenomenica, che la cultura occidentale non ha assunto come il prodotto di remote e inattese
mutazioni culturali, bensì come la condizione esistenziale e cognitiva propria dell'uomo in quanto tale nei
suoi rapporti con il mondo, sorgono e si impongono, oltre a quelle già prima elencate, altre importanti e
significative dicotomie concettuali. Fondamentali distinzioni quali quelle tra i segni – tra cui, soprattutto, il
linguaggio propriamente detto – e la realtà cui i segni alludono, tra il soggetto e l'oggetto, tra lo spirito e la
materia, tra la mente e il corpo, tra l'idea e la cosa, tra il senso (essenza) ed i fatti, tra le immagini fantastiche
ed oniriche e quelle forniteci dall'esperienza nello stato di veglia, etc.
La manifestazione rivelativa, invece, è a priori non fenomenica, perché essa ignora del tutto la
divaricazione occidentale tra apparire ed essere. Escludendo gli stati devianti, quelli indotti dall'errore o dal
disturbo patologico – ragioni del tutto contingenti –
è implicita nell'essenza stessa e nell'economia
dell'evento rivelativo la necessità che esso debba testimoniare direttamente ed immediatamente il reale, così
come esso è. L'Essere stesso qui emerge, per così dire, in superficie, disegnato a rilievo dal mobile
dispiegarsi delle apparizioni stesse. In tal senso, essendo la manifestazione rivelativa stabile, adeguata e
realissima come nessun'altra, la ricerca della realtà dell'Essere al di là della manifestazione, che
contrassegna da sempre l'impresa filosofica e scientifica occidentale, non è rinvenibile in alcuna delle culture
fondate sulla postura rivelativa. Sarebbe, in caso contrario, un totale non senso. Del resto, in quanto
manifestazione adeguata, cioè priva a priori di "rimandi" o di "scorci" verso orizzonti di ulteriorità, è la
manifestazione rivelativa stessa ad esibire il proprio contenuto di senso e di verità, quel contenuto che essa,
rivelandosi, porta in sé.
Invece in Occidente, ove i dati manifestativi sono insaturi nel loro intimo statuto di senso, si impongono
dei "rimandi" ad orizzonti di ulteriorità, al fine di attuare le necessarie integrazioni cognitive ed esistenziali.
Queste integrazioni avvengono mediante specifiche protesi logiche, che proiettano “ipotesi” (congetture,
teorie) al di là del piano fenomenico. L'inadeguatezza e la problematicità intrinseche della manifestazione
fenomenica, infatti, impongono l’ineludibile distinzione tra ciò che è reale e ciò che non lo è. E a questa
domanda è possibile rispondere solo sulla base di ipotesi e di prove di controllo altamente complesse.
Le teorie scientifiche "corroborate" dal felice superamento delle prove di controllo ritengono di poter
formulare asserti di esistenza in cui quest’ultima, essendo stata emendata, in una certa misura, dalle
ambiguità fenomeniche di partenza, è alla fine qualificabile come "oggettiva". Si può, così, affermare che in
Occidente è l'oggettività scientifica e non la manifestazione, in quanto tale, a certificare l'esistenza.
L'esistenza, beninteso, deve essere sempre "data" alla coscienza, o mediante una rivelazione o mediante
l'esperienza, ma, a differenza della esistenza rivelata, quella esperita o fenomenica è, sempre, ambigua e
malsicura. Nella cultura scientifica occidentale sono le teorie e le tecniche ipotetico-sperimentali della
27
"oggettivazione della esperienza" a dare cognitivamente il connotato della realtà a ciò che appare, mentre
nelle culture a base mitico-rituale la realtà e le sue strutture di senso sono attestate solo dalla rivelazione.
Poiché negli universi mitico-rituali non esistono quelle note determinazioni "della interiorità", come
"spirito", "mente", "idea", "anima", "psiche", "cultura", riferite ad entità autonome, separate e opposte alla
sfera "materiale", "corporea", "naturale", tutto ciò che si rivela – sia esso sacrale o no – è sempre "animato",
cioè dotato di senso, di intelligenza, di sentimento e di volontà propri. La coscienza "immanente", quella
egocentrata e chiusa in se stessa come una monade nei confronti del cosiddetto "mondo esterno", non
esiste e non può esistere nella postura rivelativa.
Realismo Segnico
La caratteristica centrale del sistema mitico-rituale è quella di essere basato sul Realismo Segnico:
questo è il nocciolo duro della rivelazione. Con l'espressione "realismo segnico" si indica sinteticamente la
credenza che l’apparire coincida con l’essere, la convinzione della identità generale di apparire e di essere.
È appunto tale convinzione a caratterizzare eminentemente tutti gli universi culturali a fondamento rivelativo
integrale. Alla luce di questa credenza il linguaggio e gli enti di riferimento (realismo nominale), la percezione
e la cosa percepita (realismo empirico), il sogno e il contenuto del sogno (realismo onirico), il concetto e il
contenuto del concetto (realismo concettuale) vengono senz'altro identificati, azzerando, per così dire, gli uni
negli altri. È pertanto sconsigliabile, nell'analisi di queste culture, interpretare come metafore e come
simbolismi tutte "le stravaganze culturali" dovute alla credenza nel realismo segnico.
Abbiamo ricordato che gli antichi Greci non si orientavano più con i miti, e quando ebbero smarrito tale
fiducia, apparve al loro sguardo una modalità manifestativa del tutto inaudita, quella meramente fenomenica,
costitutiva della sfera tipicamente occidentale della "esperienza". Per ragioni d'essenza poco affidabile, la
manifestazione d'esperienza va sostenuta, integrata e corroborata con strumenti adeguati, rivelatisi di
crescente complessità teorica ed operativa, forniti inizialmente proprio dal logos greco. Tutto questo perché
nel fenomeno non c’è rivelazione: nella manifestazione fenomenica non abbiamo un apparire che coincide
con l’essere.
Questo mutamento critico ha fatto sì che fin dalle origini del pensiero occidentale, già da Talete,
protofilosofo, si affermasse lo strano principio che l’essere ama nascondersi. Questo è un autentico enigma:
perché mai l’essere amerebbe nascondersi? Ed è un enigma ben più radicale dell’idea pitagorica secondo
cui per conoscere il mondo bisogna impiegare lo strumento matematico. Queste sono due “stravaganze”
culturali dell’Occidente, strettamente connesse, che scaturiscono entrambe dalla crisi dell’universo rivelativo
e si basano entrambe sul fatto che col tracollo del Realismo Segnico è comparsa la manifestazione
fenomenica, è comparsa la credenza che l’apparire e l’essere non coincidono necessariamente.
In termini tecnici, si ha una divaricazione tra la noesis e la hyle (pronuncia= "iùle") un termine che
significa "materia". La radice è quella stessa di sylva, significa "legno", che è la materia prima con cui gli
strumenti anticamente erano fatti. Schematizzando, nel pensiero greco la coscienza, la mente, l’intelletto
(nóesis) e la materia (hyle) si separano, si contrappongono. Questa divaricazione non la troviamo nelle
culture non greche, dove c’è piuttosto una indistinzione originaria tra il momento del pensiero,
dell’intelligenza, e il momento della hyle.
28
In altri termini, il pensiero del Realismo Segnico è possibile solo in quanto questa divaricazione – che è
nostra e che manca prima di Parmenide – non c’è, in quanto ogni pensiero è sempre materializzato, ed ogni
materia è sempre animata, è sempre intelligente. Non c’è una materia senza anima ed un’anima senza
materia. Quando compare questa distinzione tra una materia da una parte ed una intelligenza dall’altra,
crolla il Realismo Segnico. Questa frattura sarà epocale: ancora oggi noi siamo pervasi da questa dicotomia:
pensiamo, come esempio tra i molti, al dualismo anima/corpo. Ma noi non siamo in un corpo: noi siamo un
corpo.
L'identità che si instaura tra l'universo dei segni e quello degli enti è dunque di indole “iletica” (da hyle),
cioè si basa sul principio logico di assumere senz'altro come vero e proprio identico: l'analogo (la
somiglianza di relazioni, di proprietà o di funzioni); l'omologo (la somiglianza di forme); il contiguo nello
spazio o nel tempo.
Nella logica iletizzata è dunque possibile che due cose siano ritenute identiche semplicemente:
-
essendo analoghe, ovvero avendo qualità o contenuti simili;
-
essendo omologhe, ovvero avendo forme simili;
-
essendo contigue nello spazio e nel tempo, ossia essendo eventi che avvengono nello stesso
tempo, oppure essendo cose dislocate nello stesso spazio.
Per noi queste non sono identità, tutt’altro. Non è possibile nel medesimo contesto e sotto il medesimo
riguardo che si abbia A e non A: o abbiamo A oppure non A. A non può mai essere uguale a non A. Si tratta,
insomma, di una apparentemente assurda e contraddittoria identità eteroreferenziale, non autoreferenziale,
come invece è l’identità noetica (A = A), di matrice parmenidea, che non è possibile e comprensibile senza il
distacco preventivo della nóesis dalla hyle. È, questo, l'evento antropologico fondamentale che giace al
fondo delle origini stesse dell'Occidente, quello della rottura dell'unità intenzionale dell'originario vissuto
mitico-rituale (realistico) e della successiva "disincarnazione del pensiero" che, per la fenomenologia,
significa contestualmente la de-iletizzazione della nóesis, la sua autonomia nei confronti della hyle – ridotta a
"materia" – e, quindi, l'avvento di una inaudita coscienza autoreferenziale, centrata progressivamente in un
soggetto (l'ego).
Con l'espressione "realismo segnico", pertanto, la fenomenologia non intende in alcun modo affermare
che la realtà autentica si trova attestata solo negli universi culturali fondati sul realismo segnico, bensì
rilevare, soprattutto, che l'idea e la struttura del reale nell'universo mitico-rituale appaiono del tutto altre
rispetto a quelle nate e consolidatesi all'interno della cultura occidentale e occidentalizzata. Ma va
soprattutto precisato che il termine "reale", qui impiegato proprio in riferimento a tutte le manifestazioni
rivelative, va assunto in una accezione semantica del tutto particolare. La realtà intrinseca della
manifestazione rivelativa non è in alcun modo sinonimo di materialità, di corporeità, di fisicità e tanto meno di
quella "oggettività" costruita, relazionando i dati d'esperienza, dal pensiero filosofico e scientifico occidentale.
29
Pensiero incarnato / pensiero puro
Nelle culture non greche e pre-greche non è possibile un pensiero disincarnato. Ma proprio tale pensiero
è alle origini del formalismo matematico e logico: l’idea di un pensiero puramente formale, matematico,
logico, libero, disincarnato, viene dai Greci. È da lì che nasce il pensiero scientifico: dall’idea che sia
possibile liberarsi dal corpo. Ma liberarsi dal corpo perché? Perché questo aspetto negativo della materia?
Qualche brano scritto da Emanuele Severino per introdurre la propria versione dell’Orestea di Eschilo,
può aiutarci a mettere a fuoco tale ragione.
«Eschilo parla di noi, del modo in cui noi sentiamo la morte e il dolore. Noi, uomini
dell’Occidente. Ma Eschilo parla così, stando vicino al centro del vortice gigantesco che ci
avvolge e ci trascina (...) Il centro del vortice è un’evocazione. Evoca una morte e un dolore
nuovi, mai prima uditi, mai prima chiamati. Voi credete che per gli uomini la morte sia sempre
stata la stessa cosa? Qualche secolo prima di Cristo, in Grecia gli uomini incominciano a morire
− e nascere e a vivere − in un modo nuovo, inaudito. Si leva il turbine; il centro del vortice si
apre. Calmo come l’occhio del ciclone, il centro del vortice è quell’evento che viene chiamato
“nascita della filosofia”. (…) La filosofia più antica è l’evocazione del senso inaudito della morte.
Non è una semplice “meditazione sulla morte”: la filosofia ha inventato la nostra morte − ha
inventato il modo in cui ormai muoiono tutte le cose della terra. Con rigore crescente, la civiltà
occidentale − il cristianesimo, la scienza moderna, la civiltà della tecnica − trae tutte le
conseguenze dell’invenzione greca della morte.» (Emanuele Severino, Interpretazione e
traduzione dell’Orestea di Eschilo, Rizzoli, Milano 1985, p. 9)
«Per la prima volta, lungo il cammino dell’uomo, la filosofia, nascendo, parla così a ogni cosa
del mondo: “Tu, in passato sei stata niente. Ora, per un poco, esisti. Ma poi tornerai ad essere
niente”. “Niente”! Certo, la filosofia trova questa parola nella lingua greca; ma le assegna un
significato estremo, un significato al quale le parole di ogni lingua non si erano mai rivolte! Il
niente è diverso da tutto ciò che è − irriducibilmente, infinitamente, assolutamente diverso. Più
buio di ogni tenebra, più esangue di ogni pallore, più diafano di ogni trasparenza, più indigente
di ogni povertà. (…) La filosofia ha inventato la nostra morte − nostra e di tutte le nostre cose −,
perché ha inteso la morte come il cadere nel niente. E ha inteso la nascita come l’uscire dal
nostro niente. E ha inteso la vita come lo stare provvisoriamente al di fuori del niente.» (Ivi, p.
10s).
Dunque è la filosofia che inventa la nostra morte, la nostra concezione della morte, perché intende per la
prima volta la morte come il cadere nel niente, l’ingresso nel Nulla. In effetti, l’idea di rinascita, la garanzia di
una vita dopo la morte, era fondamentalmente appannaggio della Grande Dea mediterranea. Con il crollo
degli universi mitico-rituali, il mito e il rito non ci sono più, non funzionano più, non garantiscono più il ritorno
dell’uomo dalla morte. Allora l’uomo diviene preda del divenire: viene precipitato in una condizione
30
esistenziale in cui ogni cosa – compreso lui stesso – sembra provenire dal Nulla e andare verso il Nulla. Ma
qualcosa che viene dal Nulla e va verso il Nulla, è nulla: e questo è orribile. Intollerabile.
«Guardando il senso estremo del niente e l’ondeggiare delle cose tra l’essere e il niente, la
filosofia porta alla luce la forma estrema del dolore e del terrore. E, a partire da Eschilo, la
tragedia greca testimonia innanzitutto il culmine che il dolore e il terrore hanno raggiunto.» (Ivi,
p. 11).
C’è, alla base della condizione umana, un aspetto assolutamente gratuito e terrifico che suole alimentare
da sempre la riflessione generale dell’uomo sull’indole reale del proprio essere e del proprio destino,
l’aspetto, invero elementare, dell’apparire e dello scomparire delle cose e dei loro stati. Esso non suscita
tanto nelle nostre coscienze il contemplativo thaumàzein aristotelico, cioè l’astratta meraviglia di fronte ad
eventi che, in realtà, non sembrano fruibili come un semplice spettacolo, quanto piuttosto il terrore
esistenziale al cospetto della generale impermanenza del mondo. Impermanenza che implica angoscia.
L’angoscia della scomparsa, prima o poi, di tutti quegli stati positivi dell’esistenza di cui l’uomo,
comprensibilmente, invoca la permanenza sine die.
L’esistente, se fosse abbandonato a se stesso, si ridurrebbe ad un continuum minuto e quotidiano di
apparizioni e di scomparse caleidoscopiche, apparire e scomparire degli enti e dei loro stati. Il transito delle
stagioni, le migrazioni e il letargo di certi animali, il sorgere e il tramontare degli astri, il passaggio da una
classe di età ad un’altra, dal celibato al matrimonio, dallo stato profano all’affiliazione in una società
iniziatica, etc. sono intese e vissute, ad esempio, nelle culture a fondamento mitico-rituale, alla luce letterale
del paradigma dicotomico “nascita-morte”.
Di fronte, ora, a questo terrifico vissuto originario, stranamente sottovalutato da molti studiosi, l’uomo ha
reagito e reagisce ancora inventando realtà invarianti e orizzonti di permanenze, onde stabilizzare il positivo
dell’esistenza e del senso nella vita e nella morte, elaborando imponenti apparati culturali – privo com’è, a
differenza degli animali, di un dispositivo biologico di sopravvivenza. In tal modo, viene antagonizzata
l’impermanenza originaria del positivo.
«Ma l’estremo terrore spinge alla ricerca della salvezza, del rimedio, del farmaco. Nella storia
dell’Occidente, ogni salvezza tenterà sempre di essere il rimedio a quel terrore, a quella
minaccia − che sono questi, in cui noi stessi ci troviamo. Ma i più antichi pensatori greci − e
quindi anche Eschilo − rimangono coloro che se per primi hanno evocato il culmine della
minaccia, del terrore e del dolore, per primi hanno anche preparato il sommo riparo.» (Ivi, p.
12).
Da un punto di vista generale, miti e riti, filosofie e attività fabbrili, scienze e tecnologie, programmati e
sognati dalle rispettive culture come validi per sempre, sono tutti finalizzati a contrastare, in blocco,
l’impermanenza generale del reale. Nel vano e, tuttavia, lucido tentativo di stabilizzare il positivo affinché non
muti e scompaia con l’irruzione del negativo nell’esistenza degli uomini e delle loro cose.
In Occidente, l’unica cosa possibile di fronte alla morte senza ritorno è la fuga, il distacco,
l’allontanamento dal mondo di quaggiù, dal mondo delle nascite e delle corruzioni, verso un al di là eterno,
31
sottratto al divenire, sottratto alla storia, a quel tempo, cioè, che è il tempo della consumazione e della morte.
Quel tempo in cui il passato non torna, quel tempo in cui tutto ciò che accade è destinato a svanire nel breve
volgere di un mattino. Accanto alla concezione occidentale della morte, «culmine della minaccia, del terrore
e del dolore», nasce dunque l’idea della fuga dal divenire, l’allontanamento dal mondo di quaggiù, dal mondo
della storia: il mondo della storia è il mondo della génesis (pron.= ghènesis) e della phthorà (pron.=ftorà),
della nascita e della corruzione, della morte irreversibile. L’unico modo per risolvere questo ossessivo
pensiero è quello di abbandonare il mondo del divenire, allontanarsi dal mondo di quaggiù dirigendosi verso
un al di là vagamente inteso, che – nel razionalismo classico greco – è il mondo dei noetà, il mondo
dell’intelligibile.
Questo mondo del noûs per i Greci delle origini è il divino. Il mondo dei noetà, dell’intelligibile, è il divino,
perché è eterno, immortale. Sarà poi il mondo delle idee di Platone. Sono le strutture pitagoriche dei corpi
della statuaria greca che vediamo ancora nei musei: quelle sculture sono esseri “divini” essenzialmente per
la loro morphé, per la forma che hanno. Ma nessun uomo è fatto come il Doriforo di Policleto.
«Il sommo riparo è il pensiero non smentibile, il pensiero vero, che rivolgendosi al Tutto ne
scorge il Fondo eterno, eternamente salvo dal niente, dalla nascita e dalla morte, alle quali sono
sottoposte le cose del mondo. Questo Fondo del Tutto, che (dice Aristotele) è “sempre salvo”,
“il divino”, “Zeus”.» (Ivi, p. 12).
Per i Greci il divino è il Theion, ma il divino è dato dalla forma, non è dato dal contenuto. Questo significa
che i Greci si stanno già allontanando dalle credenze tradizionali. Per così dire, non hanno sostantivi, hanno
aggettivi: il divino. Non hanno un “essere divino”: hanno il “divino” solamente. Stanno perdendo la realtà
sacrale, per delle astrazioni che non sono certamente degne di culto. L’essere di Parmenide, così come
l’Atto puro di Aristotele, non sono che astrazioni, sono vuoti, nel senso forte del termine.
Ricapitolando, l’idea di un pensiero puramente formale, libero, disincarnato, è sostanzialmente un modo
per sfuggire alla morte. Si afferma in Grecia l’idea che sia possibile esercitare un pensiero puro, un’idea che
poi trionferà nella matematica e nella logica. E in contrapposizione a questo pensiero puro si delinea l’idea di
“materia”, una materia priva di senso, fondamentalmente assurda, che può anche avere un ordine, ma non
ha intelligenza, che può anche avere movimento, ma non ha volontà. Inanimata, oscura, atona, informe: una
materia che ha bisogno della luce del noûs per essere compresa. Il mondo del noûs è appunto in grado di
formare l’informe. È un mondo che può essere anche inteso come sfera della morphé intenzionale,
contrapposto alla hyle, alla materia priva di intenzionalità che ha bisogno di esser formata per diventare le
varie cose che si vedono, che si toccano, che si odono. Cose che hanno appunto delle configurazioni, hanno
delle forme.
Aisthetà / noetà
Per la tradizione del razionalismo metafisico non esiste solo il sensibile: non esistono soltanto gli
aisthetà, le cose che si percepiscono con i sensi, ma esistono anche i noetà, gli enti intelligibili. Secondo i
32
Greci, nell’uomo c’è il pensiero in quanto esistono cose sensibili e cose intelligibili, mentre per noi il pensiero
è piuttosto una faccenda mentale, formale, concettuale. Al punto che utilizziamo l’universo della matematica
come rete di relazioni astratte, vuote, da applicare sui dati dell’esperienza per cercare di compattarli e
ordinarli, rendendoli comprensibili.
Dunque, a prescindere dal fatto di credere o meno che il mondo sia essenzialmente matematico, noi
impieghiamo la matematica per conoscere il mondo, proiettando modelli relazionali, delle strutture relazionali
vuote: vuote nel senso che funzionano indipendentemente dai contenuti ai quali possono essere applicate.
Un pensiero di tipo relazionale, meramente funzionale, è appunto un pensiero che per operare non ha
bisogno di identificarsi con dei contenuti specifici, funziona a vuoto: proprio per questo è formidabile. Solo
così è possibile che queste strutture vuote possano essere riempite di contenuti qualsivoglia: molto
approssimativamente è così che funziona la scienza.
Il mondo delle forme, è un mondo che noi, grossomodo da Kant in poi, riteniamo sia possibile proiettare
sulla materia, per vedere se così è possibile descrivere la realtà. Perché descrivere è collegare: i dati che ci
vengono dall’esperienza, dalle sensazioni, sono sempre caotici, non sono formati di per sé, devono essere
organizzati. Per organizzarli e poterli descrivere, e quindi poter prevedere il comportamento della natura, noi
abbiamo bisogno di modelli, di modelli di natura concettuale. Questi modelli li prendiamo in prestito dalla
matematica, perché la matematica non è scienza delle quantità, è scienza delle relazioni. Newton, ad
esempio, utilizzava i modelli della geometria di Euclide per spiegare il comportamento dei pianeti intorno al
sole. Einstein userà un altro modello, la geometria di Riemann, una geometria curva, e così facendo, con la
teoria della relatività, spiegherà certi fenomeni che la teoria di Newton non riusciva a chiarire.
In sintesi, noi occidentali ci comportiamo così: riteniamo sostanzialmente che il mondo della noesis
fornisca dei modelli astratti che possono essere proiettati sui dati caotici per poterli relazionare, calando delle
forme, delle morphai su qualcosa che originariamente è informe. Quando abbiamo fatto questo, e dopo aver
controllato se le cose si comportano così come noi diciamo, riteniamo di conoscere il mondo. Anche se
discendiamo da loro, per i Greci le cose non stanno esattamente così. La loro idea del conoscere è una
concezione ontologica, metafisica, secondo la quale la realtà del mondo, l’essere del mondo nella sua
consistenza strutturale, ben nascosta dietro ai fenomeni, è costituito da noetà e si può cogliere attraverso i
noetà. L’essenza del mondo per i Greci è fatta di noetà. Apparentemente si dà come aisthetà, cioè come
fenomeni, cose sensibili, ma dietro agli aisthetà ci sono i noetà, che stanno al di là del sensibile: ecco il
termine “metafisica”, con cui si è voluto un po’ giocare: ta metá ta physiká, sono appunto le cose che stanno
al di là della fisica. Nella realtà, dunque, ci sono i noetà, che sono delle esistenze ontologiche, ovvero hanno
a che fare con l’essere così come è in sé, non così come appare, riguardano l’essere così come è al di là
delle apparizioni, al di là degli aisthetà.
[ Testo → Simone Zacchini, «Kant e il tramonto ontologico dei noetà»: Appendice, p.73 ]
Per muovere alla ricerca dell’Essere occorre allora trovare dei punti saldi di riferimento nel flusso
caotico, magmatico dei fenomeni: ma è possibile trovarli sul piano fenomenico? Parmenide risponderà di no:
per cogliere qualcosa di solido, un invariante, bisogna andare al di là dei sémata, al di là dei segni
fenomenici. Illuminante a questo proposito è il termine greco φύσις (phýsis). Phýsis è tutto ciò che si
manifesta, ciò che esce dal buio e viene alla luce. Intorno al IV secolo a.C., si consolida la credenza che ciò
33
che appare ed emerge alla luce, ciò che si manifesta ai nostri sensi, sia segnato dalla continua
trasformazione e da un continuo movimento che avviene in un tempo irreversibile. Il tempo viene visto come
irreversibilità degli eventi. Il tempo irreversibile fa scivolare gli eventi fuori dal campo di presenza. Ma così
facendo, il velo del tempo nasconde la parte reale della phýsis. E se si resta irretiti dal movimento, sfugge la
parte invariante, quella che non muta, che permane immobile.
Quindi si ha una divaricazione: da un lato una parte mutevole, il manifestarsi della phýsis nel continuo
divenire, nel nascere e nel morire; e dall’altro una parte invariante, nascosta, soggiacente alla mutevolezza.
Il reale per i Greci è ciò che non muta, ciò che permane, più reale di ciò che muta, che diviene.
L’Essere non si manifesta più, tuttavia, come dice Eraclito, «il dio che siede a Delfi non si rivela, ma non
si nasconde nemmeno: accenna». Il dio dunque lascia delle tracce, dei segni. Questa è la base su cui si
muove la scienza: il movimento, il variare, il mutare con cui le cose ci si presentano non è completamente
scisso, distinto, separato dall’Essere soggiacente.
L’Essere in quanto phýsis ama nascondersi. Per coglierlo occorre costruire una rete di relazioni, capace
di collegare il piano delle manifestazioni fenomeniche, il piano dell’immanenza, al piano dell’Essere. Il piano
dell’immanenza non è altro che il piano dei sémata, dei segni ambigui non solo perché insaturi ma perché
simultaneamente rimandano a un al di là (un oggetto) e a un al di qua (un soggetto). Tuttavia sia l’al di qua
che l’al di là fanno parte del mondo della phýsis. Tutto è phýsis. Per cui all’interno della phýsis si svolge il
dramma del conoscere: il tentativo di cogliere la vera natura delle cose, la realtà dell’uomo e del mondo.
[Testo → D. A. Conci, «Tra apparire ed essere. Fenomenologia della natura come segno culturale
occidentale» ]
L’impaginazione dell’oggetto
In che modo la cultura occidentale si rappresenta nello spazio e nel tempo un oggetto d’uso quotidiano,
qualcosa come una sedia, un tavolo, una scrivania? Si tratta di oggetti comuni e familiare, che occupano lo
spazio in profondità. Tutti gli esseri dotati di visione binoculare frontale (noi come le scimmie) hanno il senso
della profondità. Del resto, se non avesse il senso della profondità, un gibbone, o un babbuino, non potrebbe
certo prendere le misure e saltare da un ramo all'altro di un albero: lo sforzo che deve fare è commisurato
alla distanza e quindi deve senz’altro avere il senso dello spazio da colmare. Così come davanti ad un
oggetto, io so benissimo cosa fare per afferrarlo, la tensione che devo operare per toccarlo, etc. Ma c’è un
"come" della rappresentazione della profondità che viene dato dalla cultura.
La prospettiva è il modo in cui rappresentiamo la profondità in area occidentale. La prospettiva non è la
riproduzione, la mimesis della profondità: piuttosto è il modo con cui l'Occidente ha rappresentato e
concepito la profondità. In maniera senz’altro convincente per noi, mentre altri popoli hanno rappresentato la
profondità in modo totalmente differente. La prospettiva non corrisponde a qualcosa di reale, se non in una
certa misura. Prendendo come esempio una scrivania, possiamo notare che un oggetto del genere occupa
una certa profondità, si sviluppa in profondità. È un oggetto intorno al quale, data la sua pesantezza e
34
l'ingombro, mi posso muovere e che posso vedere secondo delle leggi che io ritengo ovvie, leggi “vissute”
più che volute o pensate. Quali sono queste leggi?
Innanzitutto l'oggetto non lo posso vedere simultaneamente da tutti i lati, ma posso cogliere solo alcuni
di essi nel medesimo tempo. Per esempio, mentre colgo un lato frontalmente, l'altro mi può apparire solo di
scorcio, si adombra mentre io giro intorno alla scrivania. Qui emerge una legge che per noi è ovvia e banale,
ma che ovvia non è proprio per niente. L'idea, cioè, che per vedere l’altro lato, quello nascosto, il lato che mi
è attualmente presente debba scomparire dal campo di presenza.
Per noi occidentali è reale solo ciò che è attualmente visto, è reale, ad esempio, il lato frontale della
scrivania, mentre l’altro lato, quello che poc'anzi vedevo ed ora non è più visibile, può essere trattenuto
soltanto nel ricordo, grazie alla memoria. Però la memoria me lo rende presente solo idealmente, non
realmente, non in carne ed ossa: in carne ed ossa adesso sto vedendo solo questo lato frontale, poi anche
questo scompare se io mi muovo. Quindi c'è un soggetto, che è il testimone oculare della scena, colui che
sta guardando, che si muove nello spazio e che osserva sempre da un preciso angolo visuale, mai da tutti i
lati simultaneamente.
Io posso vedere un oggetto soltanto guardandolo da un certo angolo visuale, da un angolo prospettico.
Progressivamente questo si defila, poc'anzi era presente ora non lo è più. Intanto muovendomi mi appare il
lato più corto della scrivania, prima celato, e diventa reale solo perché il primo è scomparso, è svanito. Il lato
non più presente lo posso magari trattenere ancora nel ricordo, però la sua è un'esistenza ideale. E ancora,
io non solo posso trattenere idealmente il lato che ora è scomparso dal campo di presenza, ma posso anche
anticiparne un altro. Tra non molto arriverà un altro lato e questa anticipazione è ideale pure essa, perché il
lato futuro non è presente in carne ed ossa: lo diventa solo quando io l'ho presente di fronte a me,
nell'attualità della mia percezione.
Quanto abbiamo fin qui delineato è uno spazio di tipo prospettico. La prospettiva si costruisce a partire
dall'occhio dell'osservatore, non c'è prospettiva se non c'è un osservatore. Lo spazio prospettico rimanda
necessariamente ad un testimonio oculare, quindi a un soggetto. E allo spazio prospettico si coniuga il
tempo storico, cioè un tempo irreversibile, in cui i lati dell’oggetto si succedono uno dopo l'altro, uno diverso
dall'altro, ma senza ritorno, perché il tempo storico, irreversibile, è il tempo della consumazione e della
morte, il tempo del non ritorno. L’irreversibilità caratterizza la freccia del tempo. Io posso tornare indietro, nel
senso che posso rivedere le cose già viste, però questo comporta un altro tempo, non è lo stesso tempo che
ritorna: è il lato, è la cosa, è l'aspetto che ritorna, non è il tempo. Quindi allo spazio prospettico va coniugato
un tempo storico, irreversibile.
C’è un altro aspetto fondamentale che resta da segnalare. Malgrado la molteplicità delle apparizioni
nello spazio e nel tempo, c'è una legge, un principio secondo il quale è sempre lo stesso identico oggetto ad
apparire al di sotto della molteplicità, nel flusso delle sue diverse apparizioni. L'oggetto è pensato non solo
nello spazio prospettico e nel tempo storico irreversibile del prima e del dopo, ma è pensato anche secondo
una struttura logica grazie alla quale le molteplici apparizioni dell'oggetto risultano tutte unificate e rette da
un polo invariante.
Questo polo invariante, che poi sarebbe l'eidos dell'oggetto, emerge come la regola della composizione
dell'oggetto, nel senso che tutte queste molteplici apparizioni non si squadernano caoticamente,
disperdendosi nello spazio e nel tempo, bensì si unificano in quanto congruenti con questo polo ideale che
35
fa sì che esse siano sempre apparizioni della medesima cosa. È sempre la medesima cosa che si mantiene
identica a se stessa. Malgrado i suoi lati possano mutare, in realtà l’oggetto-scrivania non si trasformerà mai
in una casa, in un cavallo o in una chimera: è sempre lo stesso oggetto che si mantiene identico a se stesso
al di sotto della molteplicità delle apparizioni, nello spazio e nel tempo, davanti ad un soggetto che lo
osserva. Quindi noi qui abbiamo un soggetto, abbiamo un oggetto, abbiamo una struttura spaziale,
temporale e logica che costruisce l'oggetto occidentale nello spazio: questo è il modello percettivo
trasmessoci con l'inculturazione. È la presenza di questo modello a far sì che nella nostra cultura di
appartenenza, quella occidentale, attraverso una storia lunga ormai 2500 anni, gli oggetti vengano concepiti
in questo modo.
A questo punto si tratta di vedere se anche le altre culture abbiano inteso l’oggetto così. Ma già
sappiamo che non lo hanno concepito nello stesso modo, dato che l’oggetto appare strutturato in maniera
diversa. E di norma questa differenza è stata interpretata come dovuta ad una mancanza, a un difetto,
all’ignoranza, a forme di infantilismo, attraverso giudizi e valutazioni – il fatto di essere selvaggi oppure
primitivi attardati lungo la scala evolutiva – che non aiutano molto nella comprensione della razionalità delle
altre culture.
Policleto
Una delle prime manifestazioni del logos greco si ha negli splendidi corpi scolpiti dallo scultore greco
Policleto. Ciò che abbiamo davanti agli occhi, quando ammiriamo i capolavori di Policleto, è sostanzialmente
una costruzione di matrice pitagorica. Si tratta di figure straordinarie, di corpi che noi riteniamo naturali, ma
che naturali non sono, perché frutto di una complessa struttura culturale, che è quella nostra, mentre, ad
esempio, le figure egiziane sono il risultato di un modello di rappresentazione che è un altro. Il corpo
egiziano non è innaturale: da un certo punto di vista lo è per noi, mentre per loro potremmo dire che è
“innaturale” il Doriforo di Policleto.
Nel suo trattato intitolato Kanón ("Canone"), scritto verso la metà del V secolo a.C., Policleto esponeva
le leggi del proporzionamento ideale del corpo umano, fondandole su precisi rapporti numerici mutuati dalla
dottrina pitagorica. Il trattato purtroppo è andato perduto, assieme alle sue opere scultoree, ma le sue
elaborazioni teoriche e le realizzazioni artistiche ci sono note attraverso le copie romane delle sue statue,
che testimoniano anche della fama e della fortuna che ebbero presso gli antichi. Stando alla tradizione
successiva, ad esempio Galeno (129-200 ca. d.C.), Policleto realizzò come modello concreto della sua
teoria proprio il Doriforo, definendolo "Canone". Secondo l'erudito Plinio il Vecchio (23/24-79 d.C.) furono,
invece, gli artisti dell'età imperiale romana che, considerando la statua un'opera esemplare, la definirono con
tale nome. Il Dorýphoros, "portatore di lancia", doveva rappresentare probabilmente Achille. Di quest’opera
non ci è pervenuto l’originale. La statua del Museo Archeologico di Napoli è la copia più completa del
celebre originale policleteo.
36
Policleto, Doriforo (ca 450 a.C.) copia romana di marmo dell’originale di bronzo (h.= mt. 2,12. Museo Archeologico di Napoli)
Nelle sculture di Policleto, pertanto, troviamo la matematica ed un calcolo delle proporzioni. È la
matematica che impagina un corpo che noi riteniamo normale e naturale, ma che naturale non è. Tuttavia
questa sua non-naturalità può essere riconosciuta solo quando il modello entra in crisi. E a un certo punto è
effettivamente questo ciò che accade: se tale modello fosse naturale, se fosse il portato di una struttura
biologica, psico-fisiologica, non entrerebbe mai in crisi. Invece entra ripetutamente in crisi nel corso della
nostra storia: alla fine dell’Impero Romano, poi nel Medioevo e in maniera definitiva alla fine dell’Ottocento,
con la fine dell’arte come imitazione, quando ci si rende conto che la natura non era così come credevamo
che fosse.
A partire dall’Impressionismo, con la crisi dei fondamenti della rappresentazione figurativa, non soltanto
alcuni celebri artisti come Picasso e Braque cominciano ad imitare la cosiddetta arte "negra", “primitiva”, ma
ci si rende conto che la rappresentazione prospettica dello spazio, nata in Grecia, ripresa poi nella Toscana
del Quattrocento e diventata poi paradigma europeo e rinascimentale, era semplicemente una
rappresentazione della natura elaborata dalla cultura occidentale, un certo modo di rappresentare lo spazio
37
e la realtà, non il modo assoluto per rappresentare lo spazio così come è in sé. Niente di più falso di questa
pretesa, perché ogni cultura si costruisce un'idea di realtà e poi rappresenta questa realtà così come l'ha
pensata. E la cosa funziona sempre, perché prima si costruisce la realtà e poi ci si fa un'immagine di essa
utilizzando gli stessi strumenti impiegati per costruire l’idea di realtà. Chiaramente si crea una specie di corto
circuito, in cui la rappresentazione non può che coincidere con la realtà, se l'una e l'altra sono in buona
sostanza costruite secondo gli stessi principi.
Noi abbiamo uno spazio continuo (non discontinuo), uno spazio quantitativo e misurabile (non
qualitativo), uno spazio neutro che si cala sulla realtà dell’esperienza, sul vissuto percettivo del corpo
umano, per costituire una unità organica che noi poi riconosciamo come il corpo di un uomo. E non
pensiamo che il corpo umano possa essere diverso da come appare in questi moduli paradigmatici. Moduli
che ci appartengono, che sentiamo come ovvii, semplicemente perché siamo stati inculturati con essi.
Al contempo, nei dipinti della nostra tradizione figurativa, il focus imaginarius della prospettiva posto
sulla linea dell'orizzonte, quello in cui vanno a confluire le linee di fuga tracciate nel dipinto, è strutturalmente
il punto in cui la perpendicolare che muove dall'occhio dell'osservatore tocca la superficie pittorica. La
prospettiva, dunque, presuppone, rimanda al testimonio oculare, alla coscienza di un soggetto egocentrato.
Per tornare alle nostre analisi contrastiva, per quanto possa suonare assurdo, il dato rivelativo non
implica né può implicare l'esistenza di alcun testimonio oculare, perché, a differenza del dato fenomenico,
esso è privo di quell'ambiguità manifestativa dovuta alla scissione dicotomica tra un al di là (una
trascendenza, un’esteriorità: il mondo esterno) e un al di qua (una immanenza, un’interiorità: l’io). L'al di qua
è il segno di una presenza coscienziale egocentrata. È il segno di un io, di un ego. Tale rinvio è del tutto
assente, e non si trova nemmeno in forma aurorale, nelle manifestazioni rivelative. Lo spazio prospettico,
quello ambiguamente qualificato in Occidente come "tridimensionale", e il tempo cosiddetto storico, quello in
cui gli eventi scorrono uno dopo l'altro irreversibilmente, uno diverso dall'altro, sono modelli spaziali e
temporali del tutto estranei a contenuti non fenomenici e, quindi, non dovrebbero essere applicati ai
contenuti dei vissuti rivelativi.
Il tempo mitico e il tempo storico
Gli eventi si collocano nel tempo, le cose nello spazio. Nella nostra cultura, lo spazio è il criterio di ordine
e di misura della simultaneità, della coesistenza (thèsis) del molteplice. Il tempo è il criterio di ordine e di
misura della successione (tàxis) del molteplice.
Nella sfera mitico-rituale c’è una ripetizione, una reversibilità del tempo. Ad esempio, l’Ultima Cena si
ripete – ora come allora – tutte le volte in cui si svolge intorno all’altare il sacrificio della messa. Il passato
diventa presente, ma ciò comporta anche un’ubiquità dello spazio: noi diventiamo coevi del tempo del Cristo,
e il Cristo è contemporaneamente in Palestina e accanto a noi, e in tutte le chiese in cui si sta svolgendo il
medesimo rituale.
Va precisato innanzitutto che il modello di tempo mitico-rituale, il tempo della ripetizione in cui gli eventi
passati possono ritornare, non ha niente a che vedere con il noto e abusato principio dell’eterno ritorno
dell’identico. Il tempo della ripetizione non è il tempo ciclico, come per influsso di Nietzsche si continua
ancora a dire. Quella del tempo ciclico in realtà è un’idea greca, è un’idea con un fondamento matematico
38
che rimanda all’automatismo della coincidenza dell’inizio con la fine. Coincidenza che è propria del cerchio,
del ciclo, il quale non è altro che un’immagine mobile dell’identità, dove tutto alla fine torna su se stesso,
come A=A, ossia: ogni cosa è uguale a se stessa. Dire che il tempo ciclico non è altro che un’immagine
mobile dell’identità, significa segnalare che in esso c’è un automatismo, addirittura fatale. Invece la
reversibilità mitico-rituale, con i suoi onerosi e impegnativi riti per indurre il ritorno di eventi considerati
positivi dalle varie etnie, non può implicare automatismi di sorta che diano per scontate, in quanto
astrattamente necessitate, simili ripetizioni e rendano del tutto inutili le cerimonie di propiziazione e di
sostegno. Il tempo ciclico è dunque un tempo greco.
Il tempo mitico-rituale non è il tempo ciclico essenzialmente perché è un tempo fratto. Nel tempo mitico
si presentano fratture cosmiche che devono essere superate, ricomposte, attraversate. Per i transiti occorre
costruire un ponte, e il ponte è dato dai riti: sono i riti che consentono di transitare al di là della frattura. Ogni
crisi è una frattura (il termine viene dal greco kríno: “separare”, “disgiungere”, “distinguere”, “frangere”;
κρίσις, krísis: “separazione”, “discordia”, “contesa”), però per oltrepassare la frattura occorre sempre allestire
un rito. Uno dei momenti critici per eccellenza nelle culture tradizionali è il capodanno. Quando finisce l’anno,
affinché il nuovo anno cominci occorre tutto un apparato mitico-rituale, non c’è l’automatismo della
ripetizione. Se nel tempo mitico-rituale ci fosse tale automatismo, allora tutto l’apparato sarebbe una follia. In
realtà, presso queste culture non è garantito il ritorno della stagione secca, o di quella umida, il riapparire
delle mandrie degli animali selvatici, etc. Ogni evento deve essere favorito, propiziato, sostenuto dai rituali
prestabiliti.
Il tempo della ripetizione ha un valore non solo cosmico, ma anche esistenziale potentissimo: ad
esempio, prima dei Greci, nelle culture del Mediterraneo Antico, i nuovi nati non erano che i morti risorti.
Questo tempo della ripetizione, l’idea che il passato potesse ripetersi, rappresentava un grosso sostegno
esistenziale per l’uomo, in quanto garantiva nientemeno che la rinascita, la resurrezione: l’uomo rinasceva
dopo la morte, poteva tornare dalla morte. Con il crollo dell’universo mitico, il nuovo logos porta un tempo
irreversibile, l’idea che gli eventi del passato non ritornano: possono essere ricordati, restare vivi nella
memoria dei superstiti, ma non tornano. Tutto ciò è orribile, e sta alle origini del pensiero filosofico. Come
abbiamo visto, il pensiero filosofico nasce fondamentalmente per antagonizzare questi due aspetti: una
morte senza ritorno e l’assurdità di un mondo in cui l’essere ama nascondersi, non si rivela, non si manifesta
sulla superficie delle apparizioni. Sono questi i due temi che ci servono per capire la filosofia come oggetto
culturale occidentale.
Il tempo storico compare con il culto degli eroi, nasce con l’epopea. A differenza dei santi e delle figure
potenti, gli eroi morti non ritornano. I nostri paesi, le nostre città pullulano di monumenti funebri, dedicati agli
eroi, che poi sono i cittadini caduti, morti in guerra. L’eroe vive in sostanza nella memoria dei superstiti, si
ricorda con la stele, con il canto: l’Iliade in fondo non è che un canto in ricordo degli eroi. Per cui l’immortalità
non è reale, ma è ideale. L’eroe, cioè, appartiene a un passato che non ritorna, ad un tempo non più
reversibile. La memoria si trasmette, si mantiene con la stele, il canto, i giochi funebri, le Olimpiadi – che poi
non erano altro che giochi funebri, forme sacrificali, nelle quali in onore e in ricordo degli eroi si sacrificavano
la propria forza, l’abilità, il vigore. Però gli eroi non tornano più.
Il culto degli eroi inaugura appunto il tempo storico, il tempo del non ritorno. L’idea vivrà nella memoria,
nel canto, nei giochi, nella stele, ma questo vivere nel ricordo dei superstiti è una esistenza ideale, che è
tipica del passato. Un passato che non è più reale, non rivive, non si può riattivare più, come accade invece
39
al passato mitico. La differenza tra un passato storico e un passato mitico è proprio questa: il passato storico
lo si può ricordare, lo si può conservare nei testi, nel racconto, nei canti; il passato mitico invece ritorna, in
carne ed ossa, si riattiva, ora come allora, tutte le volte che occorre. Il passato ritorna e si riattiva nel mito. Il
mito fondamentalmente non è altro che questo.
Nel rito gli eventi potenti, che sono necessariamente già stati prima dell’uomo, prima che l’uomo vivesse,
vengono riattivati secondo una sequenza cerimoniale ben precisa. La figura potente compie nuovamente il
gesto che ha dato inizio ad un evento importante e significativo: per esempio, nel rito della fine dell’anno, nel
capodanno babilonese si riattiva la battaglia degli dei, evento cosmogonico, nel quale i sacerdoti
combattono, ma non come attori, bensì incarnando per possessione le figure potenti stesse, le quali
ricombattono ogni volta, perché se non facessero ciò, il nuovo anno non arriverebbe, non si potrebbe
inaugurare alcun segmento cosmico-esistenziale successivo.
Questo per sottolineare che tempo storico e spazio prospettico sono strettamente coniugati, sono
strutture che compaiono insieme quando i Greci, con la crisi della manifestazione rivelativa, scoprono per la
prima volta che il mondo è fatto di fenomeni, non è fatto di rivelazioni. Ed è significativo, come già detto, che
alle origini della nostra cultura non ci sia un libro sacro. Il pensiero greco non ha un testo sacro al suo
fondamento, non ha una classe sacerdotale, gerarchicamente riconosciuta, non educa i propri figli nei
templi, come facevano gli Egiziani e i Babilonesi, ma li educa in istituzioni cittadine. Ancorché non ci fossero
scuole, c’erano dei pensatori, degli uomini chiamati filosofi, i quali a seconda del proprio valore e della
capacità di attrarre a sé, educavano i loro allievi. I filosofi hanno educato un’umanità che noi riconosciamo
come occidentale. La paideia che educava e formava l’humanitas greca è la culla dell’Occidente, ha
caratterizzato l’intera storia dell’Europa e di quelle parti del mondo che poi saranno influenzate dal logos, dal
pensiero greco.
Ecateo di Mileto
Abbiamo detto che con l’epopea emerge un’altra concezione dell’uomo, che si consoliderà con la nascita
della storia. Compare il tempo come tempo irreversibile, il tempo del non ritorno, che trova nell’Iliade e
nell’Odissea la sua testimonianza aurorale. L’eroe muore giovane, nel fiore degli anni, sottratto alle ingiurie
della vecchiaia. L’eroe non torna più, e viene ricordato dalla stele, che parla di lui, soprattutto al viandante.
Con Ecateo di Mileto geografo e storico greco (ca 550 - 476 a.C.) per la prima volta compare la
divaricazione tra passato e presente. Ecateo realizza delle genealogie che vanno dal remoto passato fino ai
suoi giorni, mentre Omero non va al di là del passato eroico. Nel tempo mitico il passato era privilegiato
rispetto al presente: la vita veniva da lì. Ora tutto si ribalta: con Ecateo è il soggetto vivente nel presente,
centrato nel presente, a misurare la distanza.
«Scrivo queste cose, così come a me sembrano vere. Infatti i racconti (mythoi) dei Greci, a quel
che mi appare, sono molti e ridicoli» (Genealogie. Proemio, 1 F 1a).
Ecateo, ingiustamente trascurato, non rientra tra i grandi pensatori degli inizi della filosofia. Mileto, com’è
noto, era una colonia greca sulle coste dell’Asia Minore, l’attuale Turchia. La filosofia, come già detto, nasce
come genere letterario, cittadino e coloniale, e c’è una ragione. La filosofia è segnata fin dall’inizio dal
40
distacco dalle tradizioni: le colonie non sono la madrepatria e il fatto che sia nata là non è un caso. La
filosofia nasce in città coloniali, lontane dalla madrepatria e in contrasto evidente con gli indigeni. Pensiamo
rapidamente a cosa potevano essere gli indigeni persiani dell’Asia Minore, provenienti dalla grande
tradizione orientale che aveva dominato il Mediterraneo fino all’età greca.
Dunque, c’è una differenza fondamentale tra il modo di trattare il passato da parte di Omero ed il modo
di trattare il passato da parte di Ecateo. Accanto ad Erodoto e a Tucidide, con Ecateo nasce la storia.
Ovvero nasce la ricognizione scientifica del passato, che si può realizzare soltanto se noi riusciamo a
ricostruire il filo della trasmissione dal passato al presente. La storia è costituita dalla freccia del tempo, dal
continuum temporale, che dal passato arriva fino a noi: noi siamo il punto centrale del riferimento. Non
diversamente dalla prospettiva spaziale, la quale presuppone l’occhio del testimonio oculare, altrimenti non
può essere costruita, così la storia si costruisce solo a partire dal presente.
Passato e futuro sono estasi differenti. Il tempo come storia irreversibile è centrato nel presente attuale e
imperniato sul soggetto. È il presente che accompagna il flusso degli eventi (sono gli eventi che trascorrono,
fluiscono nel tempo: il tempo non scorre) ed io, come soggetto vivente, finché vivrò mi sporgerò verso il
futuro. A partire dal presente, dunque, si ricostruisce il logos del passato, la trasmissione di una tradizione
dal passato al presente. L’epopea omerica, il canto degli eroi morti, non è storia. A differenza di come le
penserà poi Ecateo, le genealogie venivano sovente inventate semplicemente per legittimare il potere delle
classi aristocratiche nelle poleis. Il fatto di discendere da un eroe greco, il fatto di mantenere presso gli
aristocratici il culto delle tombe degli eroi, il fatto che i capi delle città discendessero da esseri divini o da
semidei, significava semplicemente compiere un’azione di legittimazione, svolgere un’azione di carattere
politico.
Per Omero il passato resta comunque sganciato dal presente. Benché ci sia già l’idea che il passato non
torna più, in Omero il passato è isolato – in quanto passato mitico – in un limbo di gloria, al fine di legittimare
le varie aristocrazie. Ecateo non fa niente di tutto ciò. La sua genealogia è completamente diversa: Ecateo
cerca di ricostruire l’intera storia del passato a partire dal presente. E il presente è diventato ormai il fulcro
della ricerca storica: ιστορία (istoría) in greco significa “ricerca”, e si svilupperà al punto di poter essere
confusa con la ricerca fisica.
In Ecateo possiamo dire che compare l’interesse scientifico per la temporalità. L’interesse per la
ricostruzione del passato, che si distingue ormai dal presente, che è altro, e che si distinguerà poi dal futuro.
Una concezione del tempo che è la nostra. Quella concezione del tempo che fa perno sul presente, non più
sul passato: perché è dal presente che nasce il senso, per la ricostruzione del passato e per progettare il
futuro. Nelle culture mitico-rituali invece è il passato fonte di senso, di esistenza e di salvezza. Solo col
ripetersi dell’evento mitico l’uomo ritiene di poter cogliere il senso della propria esistenza e crede di poter
sopravvivere: tutto questo i Greci, progressivamente, lo perdono. E così noi entriamo in una dimensione che
ci è familiare: quella del tempo storico, il tempo, cioè, dell’avvicendarsi degli eventi, l’uno dopo l’altro, uno
diverso dall’altro, in cui è il presente ad essere privilegiato, perché solo il presente è reale. Il passato invece
è ideale: io lo posso ricordare, lo posso “presentificare”, ma solo idealmente, non realmente. E il futuro lo
posso anticipare, ma sempre e solo idealmente.
Nel tempo storico, il presente è talmente labile, che io lo devo pensare sempre con una specie di coda
ritenzionale. Il presente è il continuo di qualcosa che poc’anzi è stato e che non è più e che nello stesso
tempo aggetta verso un futuro che non è ancora presente ma tuttavia si presenterà.
41
Antagonizzare la morte e il divenire
Ricapitolando quanto detto fin qui, ci sono due espedienti culturali fondamentali per affrontare e risolvere
il difficile problema costituito dall’impermanenza delle cose e conseguire così la salvezza. Si tratta di due
modelli di tempo, escogitati ad hoc nell’ambito di universi culturali diversificati tra loro per mettere ordine nel
caos delle percezioni e per rasserenare le coscienze. Due modelli che cercano di elargire un senso cognitivo
ed esistenziale alla successione meramente caleidoscopica, di per sé insensata e angosciosa delle
manifestazioni. Un avvicendarsi incessante che espone fatalmente quanto di positivo c’è nell’esistenza alla
contingenza assoluta.
Questi modelli di tempo possono essere raggruppati, malgrado significative modulazioni indotte dalla
varietà delle culture, in due differenti insiemi:
1) un tempo in cui gli eventi trascorsi possono ripetersi ora come allora e gli eventi futuri possono
anticiparsi ora come saranno (mantica, oracoli, profezie, etc.);
2) un tempo in cui gli eventi si svolgono nella storia rispetto ad un piano di invarianza di senso e di
esistenza costituito dalla polarità dell’Eterno, inteso come al di là dello spazio e del tempo.
Il primo insieme corrisponde, a grandi linee, alla concezione culturale pregreca o non greca, quella della
possibile e concreta reversibilità in avanti ed indietro degli eventi. Si tratta di un modello di tempo concepito
come pluridromo e non come monodromo. Il secondo, invece, corrisponde alla concezione occidentale e
occidentalizzata, sia pure con le articolazioni dovute a noti ibridismi culturali (come l’inserzione del semitismo
all’interno dell’ellenismo greco-romano dell’Occidente e dell’Oriente cristiano), in cui gli eventi sono intesi
avvicendarsi irreversibilmente lungo la cosiddetta freccia del tempo, svolgendosi l’uno dopo l’altro e l’uno
diverso dall’altro (monodromicamente), nella logica e nell’economia della consumazione e della morte.
Questo tragico scenario sarebbe senza riscatto alcuno se tali accadimenti non fossero, poi, sussunti
nell’esistenza e nel senso elargiti dall’assoluta alterità atemporale e aspaziale di un Eterno concepito, di
norma, come un’esistenza invariante puramente noetica. Invece, nel modello di tempo in cui gli eventi
possono ripetersi, spontaneamente oppure indotti cerimonialmente, i nuovi nati sono intesi tendenzialmente
come dei morti risorti, sotto qualunque spoglia, poi, umana o non umana, tale rinascita concretamente si
attui.
Per fare qualche esempio, a Celebes (Sulawesi), una delle maggiori isole dell’Indonesia, trascorso un
certo tempo stabilito dal cerimoniale funebre, l’anima del defunto si reincarna in un fungo o in un frutto
cresciuto in prossimità del villaggio e, se una donna ne mangia, si trova incinta di un essere umano. Se
invece l’anima si incarna in un bufalo, in una scimmia, in un cervo, essi daranno dei cuccioli e, se questi
verranno poi mangiati da esseri umani, si reincarneranno in uomini. Si tratta dunque di un ciclo complesso,
scandito da molte morti e da molte rinascite.
Mancando del tutto dell’idea occidentale di storia, che intende e qualifica gli eventi umani e non umani
sempre come trascorrenti irreversibilmente lungo la freccia del tempo, le culture mitico-rituali intendono la
morte, letteralmente e non metaforicamente, come uno dei tanti transiti che l’uomo e il mondo, senza
dileguarsi nel nulla, per loro strutturalmente irrappresentabile, sono costretti a compiere in spazi e in tempi
42
debiti, guidati da miti e assistiti da riti dotati di cerimoniali sovente complessi, senza i quali le nascite e le
morti non potrebbero essere sancite e legittimate.
L’idea del “non essere” in effetti può nascere solo all’interno di una specifica modalità di pensiero, quella
tipica della cultura occidentale che, a partire da Parmenide di Elea, ha liberato la noesis dalla hyle,
distinguendo, quindi, nettamente il noetòn dall’aisthetòn, cioè l’intelligibile dal sensibile. A differenza delle
culture mitico-rituali, che sono inguaribilmente realistiche perché ignorano una simile divaricazione, solo un
pensiero svuotato della hyle e divenuto come disincarnato, può pensare dei noetà fin dagli albori stessi della
sua storia.
Se leggiamo i frammenti di Parmenide, vediamo che l’essere si profila lentamente attraverso le
negazioni dei suoi contrari. La caratteristica di questo modo di definire l’essere è il ricorrere dell’alfa privativa
(α-), che nega tutte le varie determinazioni che riguardano i mortali.
L’Essere è:
-
αγένητον (a-ghéneton) = senza nascita, ingenerato;
-
ανώλεθρόν (a-nóletron) = senza distruzione, indistruttibile;
-
ατρεμές (a-tremés) = che non trema, immobile;
-
ατέλεστον (a-téleston) = senza fine nel tempo, eterno.
Questi termini, composti con l'alfa privativa che struttura la negazione, hanno la funzione generale di
negare lo spazio e il tempo. Le determinazioni negative dell’essere significano che l’essere sta fuori dallo
spazio e dal tempo. L’essere è la negazione stessa dello spazio e del tempo, è la negazione della hyle.
Vuoto di hyle, non è che un essere noetico.
Da un punto di vista fenomenologico, il connotato dell’esistenza è la hyle. I Greci, o meglio, questi
pensatori del filone razionalistico-dogmatico, ritengono di poter conquistare un’esistenza pur abbandonando
l’universo della hyle, degli aisthetá, il mondo dell’esperienza quotidiana, che si comincia qui a definire come
doxa, opinioni di mortali che non hanno il privilegio di sapere come stanno le cose, in sé.
L’orrore per la morte senza ritorno, per l’assurda condanna ad una esistenza ritmata dal divenire, dalla
génesis e dalla phthorá, nel fluire delle nascite e delle corruzioni, viene così antagonizzato con una fuga
nell’al di là, in cui ci si garantisce un’esistenza eterna, più reale, perfetta perché esente dal divenire.
Parmenide di fatto si sta liberando da ogni connotato iletico, perché la hyle appartiene allo spazio ed al
tempo. La hyle, la materia, non appartiene all’universo dell’eterno, che è puro noetón. L’essere, puro
intelligibile, è un’esistenza altra rispetto all’esistenza iletica: quella della doxa. Qui Parmenide ci sta dicendo
che accanto all’esistenza dossica c’è un’esistenza noetica. E tuttavia il mondo di quaggiù si può capire nella
sua giusta portata solo a partire dall’alto, non dal basso. Dalle doxai, dalle opinioni dei mortali, non si può
arrivare al mondo dell’eón, il mondo reale, perché questo è trascendente la sfera del sensibile.
Nelle culture mitico-rituali, invece, la morte, in totale assenza di leggi naturali che ne spieghino le cause,
è ritenuta prodotta sempre dall’aggressione di sacralità maligne che sogliono, per altro, sostare
pericolosamente presso la casa del defunto e presso i superstiti, il cui lutto è da intendere come necessaria
emarginazione contro la contaminazione in atto che rischia di estendersi a macchia d’olio, contagiando
l’intera comunità. L’interdizione melanesiana, ad esempio, si comunica contagiosamente non solo ai parenti
43
stretti che, comunque, restano i più esposti al male, ma anche al luogo, alla barca, ai beni, al cane, agli
attrezzi del defunto. Solo gli adeguati riti di sepoltura, in particolare quelli della doppia onoranza funebre,
quelli della duplice sepoltura, là dove essi vigono, possono, ad esempio, allontanare definitivamente ogni
pericolo, liberando lo spirito vagante del morto, che non ha ancora compiuto il suo transito, da quella
pericolosa condizione di stallo e di liminalità in cui esso, presso i vivi, è un ospite indesiderato e presso i
morti ancora un intruso. Così, grazie alle operazioni rituali, all’infezione della morte che rischia di rigenerare
lo stato caotico degli inizi cosmogonici, subentra il riordino del cosmo, momentaneamente scompaginatosi.
Con il compiersi cerimonialmente assistito del transito funebre, in cui il defunto abbandona per sempre ogni
indebito interesse mondano, l’esecuzione del rito fissa, distingue e relaziona nello stesso tempo,
reciprocamente, il mondo dei viventi e quello dei morti. Le nascite e le morti, in definitiva, obbediscono, in tali
culture, a dettami mitico-rituali e non, di certo, come accade in Occidente, a leggi fisiche.
Al contrario, nel modello di tempo in cui gli eventi si succedono irreversibilmente uno dopo l’altro e uno
diverso dall’altro, la permanenza del senso e dell’esistenza è demandata al piano assolutamente altro
dell’eterno, ove, al di là dello spazio e del tempo, l’esistenza e il senso sono costituiti da indelebili noetà puri,
fatti della medesima sostanza immortale delle anime che abitano, in vita, il corpo dei mortali. Tale
concezione che, in luogo della rinascita dei corpi, postula per i defunti l’immortalità delle loro anime, è
d’antica matrice greca perché è strettamente relata al culto degli Eroi, al culto reso alle loro tombe. Questi,
certamente, non ritorneranno più in carne ed ossa sulla terra e, tuttavia, potranno vivere definitivamente,
transitando dopo la morte in uno stato noetico – cioè, godendo di un’esistenza reale non materiale – nella
memoria dei superstiti, nella stele funebre e nel canto dell’aedo.
La possibilità di riscattarsi dalla sinistra impermanenza del mondo di quaggiù, nei termini di tale modello
di tempo, è stata integralmente affidata nella cultura occidentale (sebbene questa si sia potentemente
ibridata con il semitismo), alla originaria credenza nell’esistenza reale e non puramente mentale e
concettuale dei noetà, all’idea, cioè, metafisica che oltre agli enti materiali e sensibili esistano realmente
anche entità immateriali e intelligibili e che una simile esistenza sia esente da tutte le pecche e da tutte le
limitazioni dell’esistenza terrena. È questa la medesima sostanza delle anime, eterne e immortali.
In tutte le culture e in tutte le epoche, la nascita e la morte sono state sancite dalla cultura e non dalla
natura – come un certo pensiero occidentale ha ritenuto e ancora ritiene, giustamente, ma ignorando che
l’idea di natura è solo uno degli oggetti culturali tra gli altri dell’universo culturale occidentale. E noi
sappiamo, a questo punto, quanto ciò sia, di norma, fisiologicamente invisibile allo sguardo dell’indigeno,
sempre ciecamente convinto della genesi incondizionata e della struttura non costruttiva delle proprie
credenze fondamentali, di quelle cioè su cui poggia la propria cultura d’appartenenza.
Invarianza / variazioni
La struttura invarianza / variazioni è costituita da due poli: un polo invariante ed un polo costituito da un
piano, da una sequenza di variazioni. Questa struttura la troviamo dappertutto. Pensiamo ad esempio alla
nostra percezione visiva di un oggetto nello spazio. Tornando all’esempio della scrivania: la penso in uno
spazio prospettico e in un tempo storico, ma la struttura logica di fondo qual è? La scrivania si configura
44
come tale perché io la penso come un invariante di cui i vari aspetti, i lati che mi si presentano, ad esempio,
mentre le giro attorno sono le variazioni. Queste variazioni non alterano l’invariante: l’invariante-scrivania
resta sempre quello che è, malgrado il flusso incessante di variazioni, di aspetti, di qualità. Tutte le possibili
trasformazioni dell’apparire della cosa dunque le concepisco come un numero indefinito di variazioni di un
invariante: il polo di permanenza rimane, e mi garantisce l’identità dell’oggetto.
Questa struttura funziona ovunque: la troviamo nell’idea di sostanza e relativi accidenti. È in funzione
quando pensiamo a noi stessi: l’io è un polo invariante, le cui variazioni sono tutti i suoi atti: pensieri,
sentimenti, desideri, ecc. Un polo invariante che resta sempre identico a se stesso.
invariante
(eidos, universale)
triangolo
variazioni
Le variazioni non sono altro che momenti di trasformazione dell’invariante: ad esempio, l’idea di triangolo
è un eidos, un invariante, un universale. Universale ed individuale sono entità logiche. Sovente si legge che
il mondo dell’esperienza è il mondo dell’individuale, mentre il mondo della mente è il mondo dell’universale:
questo non è corretto. La distinzione universale/individuale è una distinzione di natura eminentemente
logica, ha a che fare con la struttura invariante/variazioni. L’idea di triangolo è un universale, è un eidos. Tutti
i triangoli che posso pensare, che posso disegnare, sono momenti individuali, variazioni individuali costruite
secondo una regola imposta dall’eidos stesso. Ogni singolo triangolo è un’individualità: può essere isoscele,
scaleno, rettangolo, ecc. Ma per quanto esteso e indefinito, il numero dei singoli triangoli non è altro che il
polo delle variazioni. L’individuo non è altro che una variazione di un universale, mentre l’universale non è
altro che l’invariante, ciò che fa sì che una serie di individui si possa collegare, possa stare insieme dentro
una collezione. Tutti i triangoli stanno insieme perché sono le variazioni, i singoli individui di un eidos che li
abbraccia tutti. Abbiamo, per così dire, il cesto dei triangoli, il cesto dei quadrati, il cesto delle mucche, e non
abbiamo il cesto di mucche e triangoli insieme. Questa idea non è meramente classificatoria, come può
superficialmente sembrare. C’è qualcos’altro, e occorre comprendere le regole in base alle quali dall’eidos,
dall’universale, si generano gli individui.
Questo è quanto cercavano di fare i Presocratici quando cominciarono a pensare che l’universale fosse
fatto di acqua e poi dovevano spiegare come dall’acqua vengono fuori tutte le cose. In una teoria astratta, io
devo individuare gli assiomi a partire dai quali, con delle regole di trasformazione, si genera tutta la cascata
dei teoremi. Ma i teoremi che cosa sono? Non sono altro che variazioni degli assiomi. Così come il mondo
45
che circostante, secondo Talete, non era altro che la variazione dell’acqua. C’è una struttura logica
soggiacente, fondamentale, che si esplicita con chiarezza soltanto lungo l’intero percorso della nostra storia.
Quando invariante e variazioni, il polo di permanenza e la sequenza di variazioni, si sovrappongono,
entriamo nella metamorfosi. La metamorfosi coniuga l’identico con il diverso e il divenire, comunque inteso,
sarà da interpretare metamorficamente se non è pensato alla luce di questa struttura noetica in cui l’identità
e la diversità, l’universale e l’individuale sono distinti e tuttavia collegati, secondo leggi radicalmente altre
rispetto alle nostre.
[ Testo → D.A. Conci, " Fenomenologia della metamorfosi "]
La struttura della dimostrazione
Come più volte ripetuto, dalla cultura greca abbiamo ereditato il vissuto della divaricazione
apparire/essere, non certo quello dell’identità dei due domini. Da un punto di vista cognitivo, occorre trovare
una strada che conduca al di là dei fenomeni, dal mondo dell’apparire al mondo dell’essere. E una volta
raggiunto questo essere – che ama nascondersi – da lì derivare tutti i fenomeni, ripercorrendo la strada a
ritroso, attingendo così una conoscenza fondata.
Il salto che si compie dal mondo dei fenomeni a quello dell’essere è di natura congetturale, è un’ipotesi
che parte sempre dal mondo dei fenomeni per allontanarsene. Lo strumento tecnicamente più sofisticato
elaborato dal logos occidentale per poter compiere e realizzare un nesso tra l’essere e l’apparire è la
struttura della dimostrazione. Questa struttura consente, con una serie di passaggi, di gettare un ponte, una
passerella tra intelligibile e sensibile, consente di oltrepassare le mere testimonianze dei sensi ed aprire il
pensiero all’idealità. La dimostrazione offre quindi una strada sicura e certa, estremamente rigida e regolata,
per calarsi dall’alto dell’Essere giù ai fenomeni, trasportando con sé la verità.
Per afferrare pienamente il senso di tale struttura, è il caso di ricordare che la dimostrazione è un tipo di
pensiero che va collegato strettamente con la perdita del possesso della verità, perché si dimostra ciò che
non si può affermare dal punto di vista rivelativo (ricordiamo che la rivelazione è data una volta per tutte), si
dimostra quando il mostrare non è sufficiente, quando il mostrare non è più un'attestazione di verità. L'idea
che la verità non è manifesta coincide sin dagli inizi con la storia stessa dell'Occidente. La verità non c'è
proprio perché la cultura greca delle origini non crede più al sapere templare, alla verità sacrale – manifesta
in quanto rivelata – e perciò elabora degli strumenti per cercarla.
La dimostrazione è una tecnica per affermare la verità di cose che di per sé non sono evidenti, dato che
se lo fossero basterebbe guardarle per convincersi che sono proprio in quel modo. Ma quando il mondo non
dà più l'evidenza, allora supplisce la tecnica inventata dai Greci, la tecnica della dimostrazione. Questa è
ancora oggi il cuore della teoria scientifica, con la quale in un numero finito di passi si riescono a dedurre
conseguenze vere da premesse vere. Ma è chiaro che la deduzione è una tecnica che sarebbe del tutto
inutile, superflua se si possedesse la verità.
La teoria scientifica nasce con la struttura della dimostrazione. Altri popoli avevano conoscenze
matematiche molto più ricche di quelle dei Greci. Alle origini, i Mesopotamici erano astronomi formidabili, gli
Egiziani avevano nozioni geometriche rigorose, però nessuno di costoro aveva la dimostrazione. Dimostrare
46
per il pensiero greco è un mostrare indirettamente. Non è cioè una ostentazione, come nelle indicazioni sui
triangoli nei papiri egiziani, dove il geometra indica la figura, mostrandola così come si manifesta.
La dimostrazione ci consente dunque di mostrare cose che non sono direttamente visibili. Tutto questo è
dovuto al carattere insaturo del fenomeno, all’ambiguità della manifestazione fenomenica. La manifestazione
fenomenica, come abbiamo detto, è intrinsecamente ambigua, perché contiene qualcosa che rimanda ad un
orizzonte ulteriore di realtà, qualcosa che si adombra, che si manifesta dietro i fenomeni, senza coincidere
compiutamente con essi: un al di là. Il fenomeno è dunque un segno che annuncia un reale che non si dà
mai “in carne ed ossa”, direttamente, ma si adombra, è quindi un segno che allude, accenna, indica
qualcosa che sta al di là del piano manifestativo, mescolato a qualcos’altro che sta al di qua del piano
manifestativo e che diventerà poi la sfera del soggetto.
Una figura di tipo dimostrativo appare in Occidente per la prima volta nel Poema di Parmenide.
“Dimostrare” è un “mostrare a partire da” (apò + déiknumi), a partire da proposizioni ritenute assolutamente
certe ed evidenti di per sé. I principi dai quali muove la dimostrazione sono conoscenze salde o epistemiche
(tecnicamente: “assiomi”) dalle quali posso dedurre la verità. Se infatti gli assiomi sono veri e se deduco
correttamente, i teoremi che via via ricavo a fil di logica saranno veri. La verità degli assiomi è
immediatamente evidente. Ed è appunto l’evidenza il cardine concettuale della struttura dimostrativa. La
verità dei teoremi non è evidente come quella degli assiomi, bensì mediata e derivata (dimostrata), ma
tuttavia ugualmente garantita.
La caratteristica essenziale della struttura della dimostrazione è quella di funzionare in base a regole di
deduzione del tutto formali, svincolate cioè dal riferimento a qualsiasi contenuto. Una volta ammesse come
vere delle proposizioni di partenza – gli assiomi – la struttura dimostrativa consente di derivare una serie di
altre proposizioni – i teoremi. La verità presente negli assiomi viene così trasmessa, in virtù dei nessi logici,
alle proposizioni derivate da essi, i teoremi.
P1
Tutte le volte che c’è fumo c’è fuoco
P2
Sull’Amiata c’è fumo
________________________________
C
Sull’Amiata c’è fuoco
Questo è un esempio di sillogismo, una struttura relazionale di tipo dimostrativo. Date due premesse, P1
e P2, ne deriva una conseguenza C. La struttura dimostrativa poggia su relazioni tra proposizioni, relazioni
di natura logica, e proprio per questo è indipendente da ciò di cui parlano le proposizioni: è una struttura
vuota. Mettendo a fuoco questa sua natura relazionale, notiamo che i contenuti di volta in volta relazionati
sono ininfluenti ai fini della comprensione della dimostrazione.
Dimostrare qualcosa non significa provare che questo qualcosa è vero. La validità di un ragionamento
deduttivo è distinta dalla sua verità o falsità. Correttezza di un ragionamento e verità della sua conclusione
non sono requisiti equivalenti. La dimostrazione di una proposizione sta nel nesso dei singoli anelli della
catena attraverso cui la si vuole dimostrare. Compito della logica è studiare tali nessi, identificando quelli
legittimi e fornendo regole in base alle quali stabilire se una dimostrazione è corretta o meno.
L’indipendenza delle leggi logiche dal valore di verità delle proposizioni è un aspetto che non è stato
riconosciuto agli inizi del pensiero occidentale. L’esempio della dimostrazione ci pone davanti qualcosa che
47
segna la peculiarità e la grandezza del pensiero occidentale: l’elaborazione di un modello di pensiero vuoto,
uno scheletro in grado di reggersi da sé e che può essere riempito di qualsivoglia contenuto.
La dimostrazione può essere categorico-deduttiva o ipotetico-deduttiva, a seconda della valenza
riconosciuta agli assiomi, alle proposizioni di partenza. La struttura categorico-deduttiva è tipica del pensiero
metafisico, e assume la forma di una “derivazione reale”, in cui, partendo da assiomi certi e indubitabili, veri
in quanto evidenti di per sé, si ritiene possibile procedere deducendo l’esistente, a fil di logica. In altre parole,
l’evidenza si coniuga con la verità all’interno di proposizioni universali (gli assiomi), partendo dai quali –
procedendo secondo le regole di deduzione – dovremmo sgranare tutta una serie di teoremi veri (perché
vere sono le premesse assiomatiche) e realmente esistenti (perché l’esistenza è contenuta negli assiomi dai
quali si parte).
α, β, γ, ...
_____________________
-a
Assiomi
-b
-c
-d
Teoremi
-e
-f
-g
- ...
La struttura ipotetico-deduttiva, invece, è caratteristica del pensiero scientifico, e gli assiomi da cui
muove non sono intesi come veri ed evidenti, bensì hanno uno statuto solamente ipotetico. L’esistenza non
è contenuta implicitamente negli assiomi, nelle premesse da cui si parte. Qui è l’esperienza ad aggiungere
l’esistenza, attraverso “protocolli d’osservazione”, ovvero con le condizioni iniziali poste subito dopo gli
assiomi, nella fascia pre-deduttiva. Le condizioni iniziali, dunque, vengono poste dall’esperienza e
dall’osservazione, non sono proposizioni universali, bensì proposizioni empiriche.
H1, H2, H3, ...
_____________________
Ipotesi (proposizioni universali)
C1, C2, C3, ...
_____________________
-a
Condizioni iniziali di riferimento
-b
-c
-d
Teoremi
-e
-f
-g
- h --------------→ h1
48
I teoremi, derivati dagli assiomi, ad un certo punto devono toccare il piano dell’osservazione. La struttura
ipotetico-deduttiva deve essere corroborata dall’esperienza, ovvero da un asserto “h1”, ricavato
dall’osservazione, il quale dice le stesse cose dell’asserto “h”. Se “h1” corrisponde ad “h”, se l’asserto
d’osservazione corrisponde all’asserto dedotto (astratto), allora la teoria si ritiene corroborata. Ciò vuol dire
che i fatti, indirettamente, concordano con le ipotesi.
Nel semplice esempio fatto, «Tutte le volte che c’è fumo c’è fuoco» è l’ipotesi “H” universale posta in
cima al modello. L’universalità non ha niente a che vedere con l’esistenza: da “H” non possiamo ricavare
«Sull’Amiata c’è fuoco», che è un asserto d’esistenza. Il fuoco esiste. Da un punto di vista cognitivo,
possiamo qualificare come evento o come ente individuale effettivamente esistente, soltanto ciò che è
definibile in base alle categorie di spazio e di tempo. Per formulare un asserto di esistenza dobbiamo
coniugare i parametri dello spazio e del tempo. Nel nostro caso, specificare quando e dove c’è fuoco.
In altri termini, agli asserti universali, in questo caso, all’ipotesi “H”, vanno connessi parametri spaziotemporali: non possiamo ricavare il teorema «Sull’Amiata c’è fuoco» senza passare dalle condizioni iniziali
espresse dalla proposizione «Sull’Amiata c’è fumo». Solo le condizioni iniziali danno valenza empirica ad
una struttura di derivazione che altrimenti parlerebbe solo in astratto.
Ma «Sull’Amiata c’è fuoco», a rigore, è un’ipotesi essa stessa, derivata a fil di logica, ancorché si
presenti come enunciato singolare d’esistenza. Si tratta, in poche parole, di un teorema vero e proprio,
ricavato dalle due premesse iniziali (maggiore e minore), che dev’essere controllato. C’è dunque una
differenza tra l’asserto “h” e l’asserto “h1”, che è frutto di un’osservazione. Gli asserti di osservazione non
possono essere derivati dagli asserti universali. Che il discorso corrisponda alla realtà implica un controllo di
tipo sperimentale, il quale si attua con l’acquisizione di informazioni, nel nostro caso, sulle condizioni del
Monte Amiata. L’esistenza non può essere dedotta, non siamo più in un ambito metafisico, categoricodeduttivo, e il controllo è una questione di ordine metodologico.
Il dilemma di Kuhn
Agli inizi degli anni Sessanta, Thomas S. Kuhn scoprì una cosa abbastanza singolare. Il libro in cui
presenta questa scoperta è La struttura delle rivoluzioni scientifiche, nel quale, a dispetto del titolo, si occupa
non tanto della struttura della scienza straordinaria, la scienza nelle sue fasi rivoluzionarie (pensiamo ad
Einstein, a Planck, a questi grandi fisici che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso hanno
rivoluzionato i fondamenti del pensiero scientifico), bensì di qualcosa che, benché palese, non era stato
ancora sufficientemente notato (come sempre le cose che non vengono viste sono proprio quelle più ovvie,
quelle di cui non ci si accorge perché stanno quotidianamente sotto i nostri occhi). Quanto Thomas Kuhn
mostra nel suo libro è il fatto che di norma l'attività scientifica si svolge all'ombra di paradigmi, cioè si muove
all'interno di una cornice di credenze ritenute salde, ovvie, le quali vengono trasmesse alle nuove
generazioni. In buona sostanza, nelle Accademie e nelle Università, attraverso i manuali e la didattica
vengono trasmesse delle credenze, delle convinzioni alle quali si dovranno ispirare tutti coloro che si
preparano ad essere degli scienziati, e che saranno scienziati fin quando obbediranno a queste credenze
fondamentali.
49
In effetti, se proviamo a leggere un qualunque manuale scientifico, nel testo troviamo tutta una serie di
convinzioni presentate come se fossero ovvie, ma che in realtà ovvie non sono, non tanto perché siano
criticabili, o debbano per forza essere messe in questione, ma per il semplice fatto che vengono
necessariamente trasmesse agli allievi senza essere presentate per quel che sono: ovvero il frutto di
processi culturali, di fattori sociali, di condizionamenti storico-antropologici ben precisi. La scienza pensa e si
muove all'interno di questa cornice di ovvietà e di credenze fondamentali. In altre parole, secondo Kuhn, la
scienza normale pensa burocraticamente, ossia seguendo ciecamente quelli che sono i dettami di fondo, le
credenze, le convinzioni fondamentali della cultura. Questa è l’attività predominante nella scienza.
Nelle prime pagine di questo libro, Kuhn si pone un quesito, una domanda che a prima vista può
sembrare stravagante, ma è significativa per proseguire il nostro discorso: quando Aristotele e Galileo
guardavano una pietra legata ad una corda o appesa al soffitto di una stanza e la vedevano oscillare,
vedevano la stessa cosa e la interpretavano in maniera diversa oppure vedevano cose diverse? Per capire
un po' qual sia il dilemma in questione ricordiamo che secondo Aristotele una pietra che oscilla legata ad
una corda non è un pendolo, è semplicemente un grave che per la teoria dei luoghi naturali aspira a cadere.
Per Aristotele un misterioso appetito abitava nei corpi, alcuni agognavano ad andare in alto, come l'aria e il
fuoco, e non c'era verso di trattenerli quando la loro forza vinceva la resistenza, mentre altri corpi avevano
l'appetito di andare verso il basso: l'acqua, la terra, gli elementi solidi. Ora, secondo Aristotele una pietra che
oscilla legata ad una corda è un grave che vuole andare in basso, ma è trattenuto dalla corda, per cui cerca
di scendere quanto più è possibile, ma la corda lo tira indietro. Galileo invece, come è noto, in una pietra che
oscilla legata ad una corda vede un pendolo. Un pendolo è anzitutto qualcosa retto da leggi rigorose, ad
esempio quelle dell'isocronismo, per cui l'ampiezza delle oscillazioni non influenza in sostanza il tempo di
percorrenza della traiettoria (l'isocronia del pendolo è infatti un elemento di misurazione del tempo).
Alla domanda se Aristotele e Galileo guardando una pietra legata oscillare vedessero la stessa cosa
interpretandola in maniera diversa oppure vedessero cose diverse. Kuhn risponde dicendo che in realtà
vedevano cose diverse: una pietra che cade in modo vincolato o un pendolo che oscilla isocronicamente,
sono effettivamente due cose del tutto diverse. Quindi non è vero che vedono le stesse cose e le
interpretano in maniera diversa: vedono cose diverse.
In realtà questa è una domanda indecidibile: noi non possiamo decidere né in un senso, né nell'altro, né
nel senso di Thomas Kuhn, né nel senso di Karl Popper. Popper è convinto che il mondo esista,
oggettivamente, e che la comprensione di questo mondo possa essere raggiunta dalla scienza, anche se
non in maniera definitiva, mentre per Thomas Kuhn, in sostanza, la natura è frutto di costruzioni. Perché non
si può decidere? Perché la nostra conoscenza, la nostra storia, il modo in cui stiamo nel mondo, sono tutte
condizioni tali da non consentirci di dire come stanno effettivamente le cose, e quindi non possiamo decidere
se effettivamente ciò che conosciamo è il frutto esclusivo di una nostra costruzione intellettuale oppure è la
corretta registrazione delle informazioni che ci vengono dal mondo esterno. In altri termini, noi non possiamo
conoscere come è fatto il mondo in sé, fin quando viviamo in strettissima correlazione con il mondo
circostante.
Noi stiamo nel mondo, siamo all'interno del mondo, siamo all'interno della cultura. Ciò che conosciamo è
sempre frutto della relazione tra noi e il mondo. Noi non conosciamo il mondo così come esso è, a
prescindere dal nostro rapporto con esso, quindi non possiamo sapere in che misura il mondo sia fatto in sé
e per sé, e se quel mondo fatto in sé e per sé sia un mondo che possiamo acquisire indipendentemente dal
50
suo essere guardato, essere osservato, essere misurato. A parte il fatto che l’esigenza dell’ “in sé” è di
carattere metafisico, noi interagiamo con il mondo e l'idea di conoscere i fenomeni che si svolgono nello
spazio e nel tempo indipendentemente dal fatto che siano osservati o meno, è un sogno a lungo nutrito
dall'uomo.
Come più volte ribadito, oggi non è più possibile universalizzare o naturalizzare, cioè considerare come
leggi del pensiero o caratteristiche innate dell’essere umano, i nostri principi, le nostre convinzioni,
dicotomie, categorie. Perché tutto è relativo alle culture. Ogni principio, valore, modello, ecc. ha un senso,
soprattutto, all’interno della cultura che l’ha generato. Questa è un’affermazione che proviene dal relativismo
metodologico e caratterizza in senso analitico l’antropologia fenomenologica. Occorre tener presente la
distinzione tra relativismo metodologico e relativismo speculativo: relativismo metodologico vuol dire
essenzialmente che gli esiti di una analisi non possono essere sospinti verso l’incondizionato, trasformando
in un in sé ciò che ha validità relativa all’analisi.
Come le cose siano “in sé” è impossibile saperlo: come faremmo a dirlo? Per cui ciascuno si ritaglia non
tanto un “in sé”, ma una verità relativa al metodo adottato, quindi sempre legata alle ipotesi di lavoro e al
metodo impiegato. Questo vuol dire, per inciso, che nemmeno la verità di questa affermazione è una verità
assoluta. Si tratta di una tesi relativa al metodo fenomenologico e potrebbe essere contestata da un altro
punto di vista analitico, magari da un altro fenomenologo che dica “no, le cose non stanno così”. Ma tutto
questo non significa accedere a un “in sé” dal quale giudicare, uscendo dal proprio relativismo metodologico.
La hyle
Il progetto di cogliere prima o poi le cose come sono in sé potrebbe realizzarsi soltanto se potessimo
metterci tra parentesi, oppure sollevarci, uscendo fuori dal mondo. In realtà noi non possiamo osservare il
mondo nascosti, come guardandolo dal buco della serratura. Ciò che conosciamo è sempre frutto di una
interrelazione strettissima tra i nostri costrutti teorici, le nostre idee, le nostre convinzioni, le nostre credenze
– che sono intenzionali – e qualcosa che intenzionale non è. Chiamiamolo "materia", "cosa", "mondo",
oppure "mondo esterno", giusto per usare una terminologia ambigua ma tuttavia abbastanza fortunata
perché è quella che di norma è presente nel linguaggio comune, quando si riferisce al mondo cosiddetto
"esterno".
Sia in un caso che nell'altro noi non possiamo affermare nulla, non possiamo dire che esistano solo fatti,
né possiamo dire che esistano solo interpretazioni. Possiamo solo dire che c'è l'una e l'altra cosa: sono
strettamente connesse. E la demarcazione, la linea di confine tra l'una e l'altra, non è facile a trovarsi, ad
individuarsi. Allora, tanto per cominciare possiamo senz'altro dire che le culture ci offrono dei modelli di
percezione. Noi siamo stati educati in un certo modo, e nel complesso delle informazioni che ci vengono
date dal processo di inculturazione che trasforma i nostri cervelli in cervelli umani, ci vengono trasmessi
anche dei modelli di percezione. In altre parole, ci viene insegnato come guardare il mondo e cosa vedere in
esso. Riceviamo delle istruzioni precise: se non fossimo istruiti non potremmo riconoscere neanche una
sedia, un ombrello o una pentola per cucinare. In qualche modo noi non conosciamo mai per la prima volta:
riconosciamo sempre. Le nostre conoscenze in realtà sono riconoscimenti.
51
Questi modelli che ci dicono come dobbiamo vedere, cosa dobbiamo vedere e anche persino che cosa
dobbiamo concludere quando siamo, per esempio, di fronte ad una pentola che bolle, come ci dobbiamo
comportare (se accostarci o meno, se toccarla o meno), tutto questo – è banale dirlo – ci viene trasmesso
dalla cultura, dal processo di inculturazione. Tuttavia non siamo soli. Sappiamo benissimo che il mondo
sarebbe molto diverso se potessimo costruirlo a nostra immagine e somiglianza. Ma nel mondo c'è qualcosa
di non intenzionale. I Greci chiamavano questa non-intenzionalità hyle, che comunemente traduciamo come
“materia”.
La materia è ciò che resiste, ciò che dice di no ai nostri tentativi di sfruttarla, di dominarla. Tuttavia
questa hyle viene dal fatto che siamo un corpo. Noi siamo un corpo, i nostri pensieri, i nostri sentimenti sono
i pensieri di un corpo, i sentimenti di un corpo: essere incarnato è la condizione originaria ed elementare
dell'uomo. Nonostante molte culture e molti pensatori abbiano vissuto il corpo come qualcosa di negativo
(pensiamo a Platone, a Plotino, che aveva addirittura vergogna di essere un corpo), il nostro è un pensiero
incarnato. La dicotomia anima/corpo è un'invenzione greca che si è trasferita anche nel cristianesimo e ha
influenzato potentemente lo stesso pensiero cristiano, che non era platonico alle origini, dato che Cristo
parlava della resurrezione dei corpi, il che confligge evidentemente con l'idea di una separazione tra anima e
corpo. L'immortalità dell'anima è greca, la resurrezione dei morti è cristiana: basta questo accenno per
rendersi conto che ci sono dei problemi formidabili, che qui non toccheremo.
Per il nostro discorso è sufficiente notare che noi non siamo soli: c'è un aspetto non intenzionale – la
hyle – che si coniuga fin dall’inizio con i costrutti e con le intenzioni – che
invece appartengono alla
coscienza. La nostra conoscenza, la nostra vita sentimentale, affettiva, valutativa, ecc. risentono di questo
fitto intreccio tra elementi intenzionali, che dipendono appunto dall'attività della coscienza, e la condizione in
cui questa coscienza vive e pensa, che è quella di essere incarnata, di essere un corpo. Non dovremmo mai
dire: "sono in un corpo", o "abito un corpo", bensì "sono un corpo".
Importante è rendersi conto che il volume dell'attività intenzionale è comunque imponente rispetto alla
componente iletica, non intenzionale. Questo perché abbiamo bisogno in funzione protettiva di elaborare, di
costruire, di pensare un mondo sempre più vicino ai nostri bisogni, ai nostri sentimenti, ai nostri desideri. Noi,
esseri condannati all'estinzione, grazie a questa attività costruttiva ed elaborativa della cultura siamo riusciti
a sopravvivere. O per lo meno, a differire finora la nostra estinzione, perché senza cultura non possiamo
vivere.
Quindi va da sé che l'aspetto costruttivo cresca a dismisura nella storia dell'uomo sulla terra, tendendo,
come dire, a ridurre, a frantumare, a masticare, a digerire l'aspetto propriamente non intenzionale, che è
l'aspetto che ci avvicina di più agli animali. Gli animali sembra che abbiano un'imponente attività iletica, e
un'attività noetica o intenzionale minimale. Questo perché l'animale può sopravvivere senza cultura, l'uomo
no, quindi ha bisogno di sviluppare fin dove è possibile – complessificando enormemente l'esistenza – il
volume dell'attività intenzionale a scapito dell'attività non intenzionale, che è quella propria dell'essere un
corpo.
Hyle in buona sostanza è l'insieme di tutte le informazioni che acquisiamo dal nostro corpo, ad esempio
dagli organi esterni, gli esterocettori, cioè i cinque sensi, che hanno dei precipitati iletici e dagli enterocettori,
che veicolano le sensazioni degli organi interni (quelle che sentiamo di più quando ci ammaliamo). Ci sono
quindi i propriocettori (sempre parlando in termini fisiologici, non filosofici), che ci portano le sensazioni
provenienti dal movimento delle articolazioni, dai muscoli e dai tendini, e dagli organi che servono
52
all’orientamento, praticamente l'orecchio interno, il quale mi dà il senso della direzione e dell'equilibrio.
Abbiamo poi la cenestesi, che corrisponde ai sentimenti elementari della propria esistenza interna, il senso
di malessere o di benessere generale degli organi del corpo proprio. E infine, ultima ma non ultima, c'è la
cinestesi, il senso del movimento.
Il movimento è fondamentale: perfino fissare un oggetto o una persona senza muovere gli occhi in realtà
è qualcosa che non accade mai, perché anche gli occhi seguono un loro percorso nel visualizzare un
immagine. Ad esempio, H. Rheingold, nel suo testo La realtà virtuale, presenta una mappa delle aree dei
movimenti oculari, e spiega che «le persone muovono gli occhi in maniera differente a seconda che
osservino l’immagine di un volto, di un paesaggio, di un corpo nudo. Nessuno, in realtà, fa scorrere il proprio
sguardo lungo ogni centimetro quadrato della fotografia di un volto, per esempio. Noi “costruiamo” un volto
con una serie di occhiate veloci tra un occhio e l’altro, tra gli occhi, il naso e le labbra con un passaggio
veloce tra le labbra e il mento, per poi tornare nuovamente agli occhi. Benché ci sembri di vedere l’intera
immagine, quello che facciamo si avvicina ad un processo di selezione di caratteristiche fondamentali,
consultazione di modelli mentali e simulazione dell’immagine." (pp. 182s.)
La costruzione è affare sempre dell’intenzionalità, non della sensazione (in questo caso, visiva). La
cinestesi è dunque la base di ogni attività percettiva e tutti questi organi interni danno come precipitato
quello che i greci chiamano la hyle. In sostanza, questi organi ci trasmettono informazioni sullo stato del
mondo esterno e interno, che sono strettamente connessi. Quindi il corpo, per così dire, fa da mediatore tra
il mondo interno e il mondo esterno. Queste informazioni non sono volute da noi, decise da noi, se non in
una misura estremamente limitata. Queste sensazioni sono dei dati che ci vengono offerti tramite il corpo e
noi in sostanza elaboriamo questa informazione e costruiamo una conoscenza che sarà più o meno
complessa a seconda del volume delle attività costruttive che poi siamo in grado di allestire sulla base di
queste informazioni.
Altri spazi figurativi
La presentazione e l’analisi fenomenologica di opere e manufatti di altre culture e civiltà lontane
dall’Occidente serve a mostrare in che misura i segni e le immagini possano testimoniare differenti modi di
concepire il mondo e la realtà. Si tratta, tanto per cominciare, di familiarizzarsi con l’idea che un’immagine
costruita dall’uomo, più che essere intesa come una testimonianza della capacità creativa di un soggetto
libero e indipendente, possa essere letta come una rappresentazione della realtà così come lui la
concepisce, la vive, la pensa.
Il più delle volte queste immagini sono semplicemente delle tracce lasciate da culture defunte, lontane
da noi nello spazio e nel tempo. Noi ci rivolgiamo a questi segni per cercare appunto di sorprendere l'idea di
realtà, e quindi le credenze che questi popoli hanno elaborato sul cosiddetto mondo esterno, attraverso una
analisi fenomenologica di tipo contrastivo, cercando di cogliere tali credenze in rapporto alle nostre, nel
senso già più volte ricordato che le nostre convinzioni e i nostri presupposti non vengono qui impiegati,
come normalmente si fa, quali paradigmi per l'interpretazione delle credenze altrui.
53