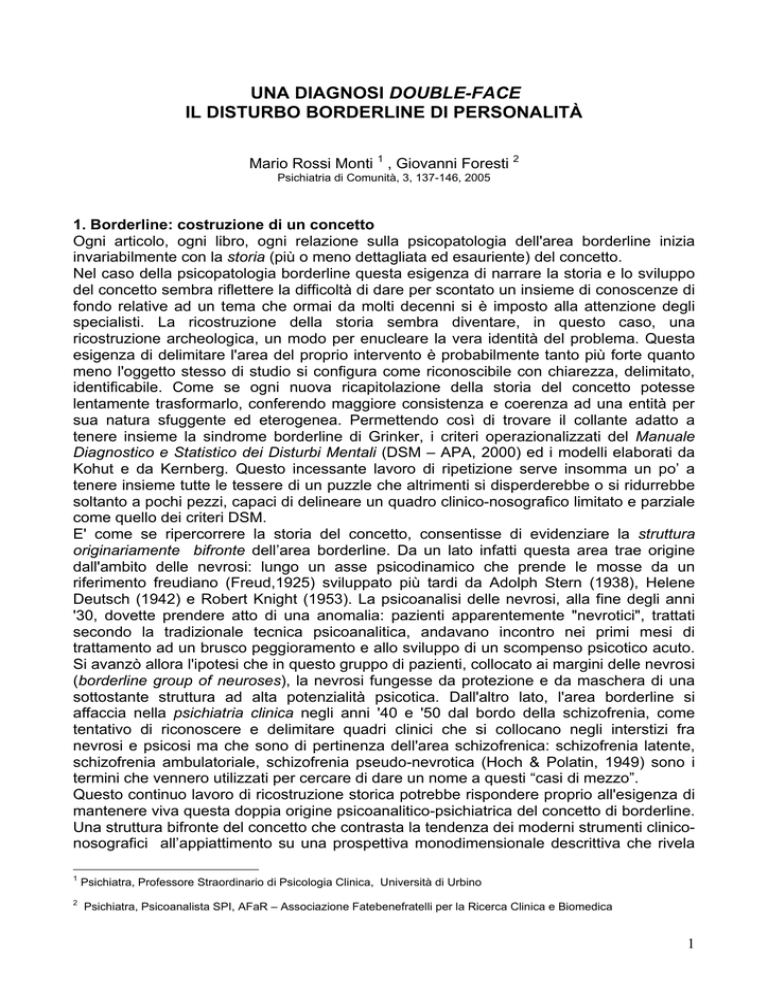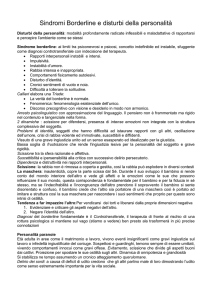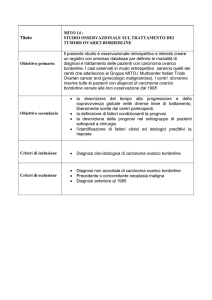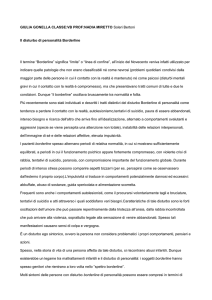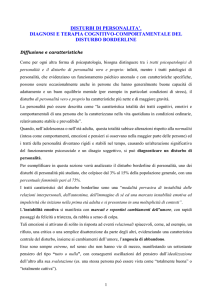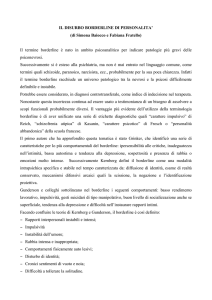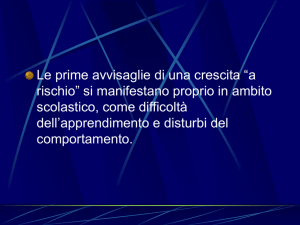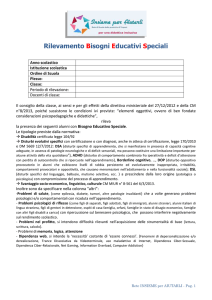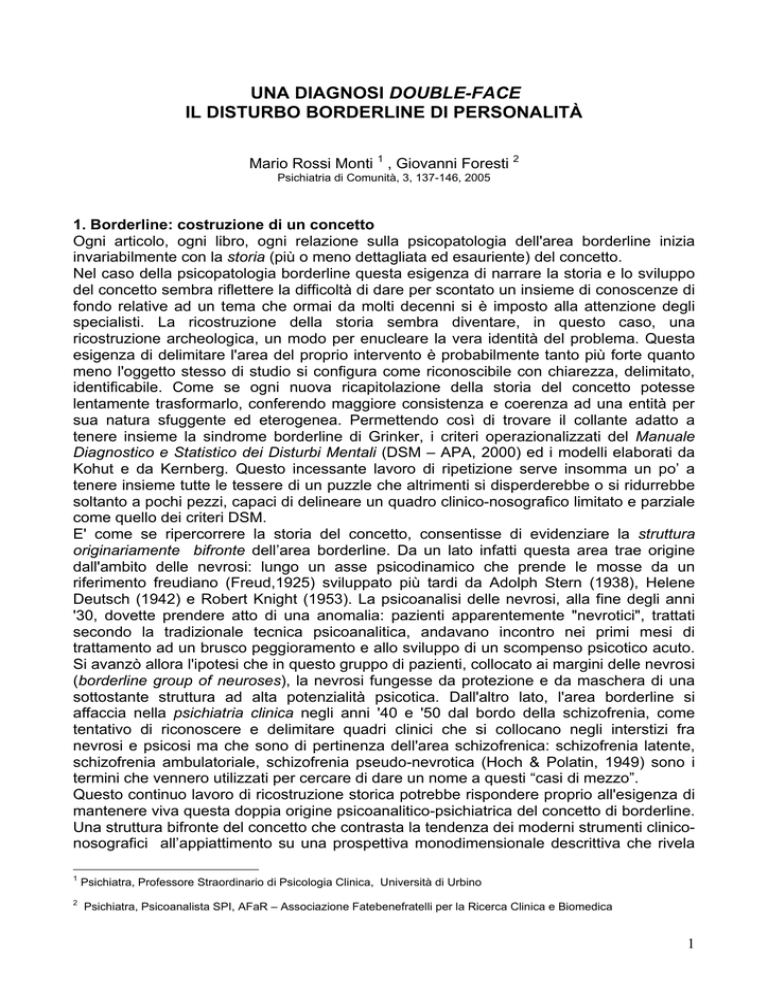
UNA DIAGNOSI DOUBLE-FACE
IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Mario Rossi Monti 1 , Giovanni Foresti 2
Psichiatria di Comunità, 3, 137-146, 2005
1. Borderline: costruzione di un concetto
Ogni articolo, ogni libro, ogni relazione sulla psicopatologia dell'area borderline inizia
invariabilmente con la storia (più o meno dettagliata ed esauriente) del concetto.
Nel caso della psicopatologia borderline questa esigenza di narrare la storia e lo sviluppo
del concetto sembra riflettere la difficoltà di dare per scontato un insieme di conoscenze di
fondo relative ad un tema che ormai da molti decenni si è imposto alla attenzione degli
specialisti. La ricostruzione della storia sembra diventare, in questo caso, una
ricostruzione archeologica, un modo per enucleare la vera identità del problema. Questa
esigenza di delimitare l'area del proprio intervento è probabilmente tanto più forte quanto
meno l'oggetto stesso di studio si configura come riconoscibile con chiarezza, delimitato,
identificabile. Come se ogni nuova ricapitolazione della storia del concetto potesse
lentamente trasformarlo, conferendo maggiore consistenza e coerenza ad una entità per
sua natura sfuggente ed eterogenea. Permettendo così di trovare il collante adatto a
tenere insieme la sindrome borderline di Grinker, i criteri operazionalizzati del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM – APA, 2000) ed i modelli elaborati da
Kohut e da Kernberg. Questo incessante lavoro di ripetizione serve insomma un po’ a
tenere insieme tutte le tessere di un puzzle che altrimenti si disperderebbe o si ridurrebbe
soltanto a pochi pezzi, capaci di delineare un quadro clinico-nosografico limitato e parziale
come quello dei criteri DSM.
E' come se ripercorrere la storia del concetto, consentisse di evidenziare la struttura
originariamente bifronte dell’area borderline. Da un lato infatti questa area trae origine
dall'ambito delle nevrosi: lungo un asse psicodinamico che prende le mosse da un
riferimento freudiano (Freud,1925) sviluppato più tardi da Adolph Stern (1938), Helene
Deutsch (1942) e Robert Knight (1953). La psicoanalisi delle nevrosi, alla fine degli anni
'30, dovette prendere atto di una anomalia: pazienti apparentemente "nevrotici", trattati
secondo la tradizionale tecnica psicoanalitica, andavano incontro nei primi mesi di
trattamento ad un brusco peggioramento e allo sviluppo di un scompenso psicotico acuto.
Si avanzò allora l'ipotesi che in questo gruppo di pazienti, collocato ai margini delle nevrosi
(borderline group of neuroses), la nevrosi fungesse da protezione e da maschera di una
sottostante struttura ad alta potenzialità psicotica. Dall'altro lato, l'area borderline si
affaccia nella psichiatria clinica negli anni '40 e '50 dal bordo della schizofrenia, come
tentativo di riconoscere e delimitare quadri clinici che si collocano negli interstizi fra
nevrosi e psicosi ma che sono di pertinenza dell'area schizofrenica: schizofrenia latente,
schizofrenia ambulatoriale, schizofrenia pseudo-nevrotica (Hoch & Polatin, 1949) sono i
termini che vennero utilizzati per cercare di dare un nome a questi “casi di mezzo”.
Questo continuo lavoro di ricostruzione storica potrebbe rispondere proprio all'esigenza di
mantenere viva questa doppia origine psicoanalitico-psichiatrica del concetto di borderline.
Una struttura bifronte del concetto che contrasta la tendenza dei moderni strumenti cliniconosografici all’appiattimento su una prospettiva monodimensionale descrittiva che rivela
1
2
Psichiatra, Professore Straordinario di Psicologia Clinica, Università di Urbino
Psichiatra, Psicoanalista SPI, AFaR – Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca Clinica e Biomedica
1
inevitabilmente la propria insufficienza nel passaggio alla operatività clinica.
Evidentemente, nella presa in carico a lungo termine di un paziente borderline, il problema
non è soltanto quello della diagnosi descrittivo-nosografica, quanto piuttosto potersi
orientare, all'interno di quella problematica clinica (definita anche dal punto di vista
nosografico) in una serie di problemi e questioni alle quali la nosografia del DSM non dà
(nè intende dare) risposta.
E' esattamente a questo punto che ogni formazione professionale che abbia fatto del DSM
il suo prevalente punto di riferimento mostra drammaticamente la corda. Il DSM ci pianta
in asso. Un po' come accadeva alla psichiatria classica nei confronti del delirio. Di fronte
ad una donna che si convince in maniera irragionevole della infedeltà del marito e che si fa
prendere la mano da questa idea, gli psichiatri - scriveva Freud (1915-1917) - hanno
convenuto di parlare di idee deliranti e vedono nella diagnosi di delirio la caratteristica
essenziale del caso clinico. Il fatto però che questa idea non receda nel confronto con la
realtà deve far pensare che questa idea abbia poco a che fare con la realtà ed anzi non
tragga origine da essa. Forse non si modifica di fronte ad un esame di realtà poiché più
che con la realtà ha a che fare con il mondo interno di quella persona. Da dove proviene
allora? E perché ha preso come contenuto la gelosia? Arrivati alla diagnosi di delirio scrive Freud (1910) - è qui che vorremmo sapere qualcosa di più dallo psichiatra, «ma
proprio qui egli ci pianta in asso»: al massimo si metterà a discorrere di ereditarietà, di
predisposizione, di vulnerabilità, di eventi scatenanti o di qualche altra ipotesi che ci
allontana dai fatti clinici osservati.
Allo stesso modo, una volta arrivati alla diagnosi di disturbo borderline di personalità, il
DSM ci pianta in asso perché non fornisce (nè del resto intende fornire) strumenti idonei a
guidare la presa in carico, le scelte terapeutiche. Le domande che si aprono, da questo
punto in poi, sono: disturbo borderline di personalità sì, ma di quale borderline stiamo
parlando? Con quale borderline abbiamo a che fare? Con un bordeline in cui prevale
l’impulsività, le oscillazioni della affettività o ancora la incoerenza della indentità? E
ancora, in fasi più avanzate del percorso terapeutico: quanto borderline? Borderline di
fascia alta o borderline di fascia bassa? Quanto prossimo alla frammentazione psicotica,
quanto capace di fronteggiare i microlutti della relazione terapeutica, quanto capace di
venire a patti con la quota di frustrazione che il contatto con la realtà impone? E così via.
Tutte domande alle quali il DSM non fornisce risposta.
E' evidente a questo livello la drammatica insufficienza degli strumenti descrittivodiagnostici. Clarkin e Lenzenweger (1996) hanno sostenuto da tempo la necessità di
passare da un approccio ateoretico ai disturbi di personalità ad un approccio guidato
invece dalla teoria. Questo passaggio è tanto più indispensabile quando, come nel caso
del disturbo borderline, sia necessario impostare un trattamento di carattere
psicoterapeutico. Evidentemente non può esservi psicoterapia in assenza di una teoria del
funzionamento mentale normale e patologico, ancorché parziale e contraddittoria, ma
comunque necessaria per l'orientamento della terapia. I criteri del DSM, utili ai fini
dell'inquadramento nosografico, sono in grado di orientare la modalità della presa in carico
di un paziente borderline? Varrebbe la pensa sottoporli al test descritto da Westen (1998)
per valutare la rilevanza della diagnosi ai fini della terapia. Si tratta del test "e allora…?",
grazie al quale ci si può chiedere, di fronte a ciascun criterio: e allora? E cioè: che cosa
questo criterio diagnostico ci permette di inferire circa le modalità dell'approccio
terapeutico? In altri termini: i soggetti borderline hanno una modalità di relazione instabile
intensa: e allora? I soggetti borderline "manifestano ricorrenti comportamenti, gesti o
minacce suicidari, o comportamento automutilante". E allora? Come possiamo utilizzare
queste conoscenze all’interno di un progetto terapeutico? Tutto questo ci avverte
semplicemente di ciò a cui il paziente (e noi come curanti) andremo incontro? Oppure ci
fornisce delle indicazioni su come orientare il progetto terapeutico? No, un approccio
2
ateoretico qui sconta proprio la mancanza di una teoria di riferimento: di un modello
patogenetico che colleghi, in forma magari sotterranea e ipotetica, molti degli item
sintomatologici di riferimento all'interno di un unico disegno, di una medesima struttura
nella quale ciascuno di essi possa trovare un senso, in modo tale da orientare anche
l'atteggiamento del terapeuta.
2. Il pendolo della ambiguità
La natura dei criteri diagnostici del DSM e la loro drammatica insufficienza nelle
applicazioni clinico-terapeutiche ha a che vedere con una aporia costitutiva della
psichiatria. La psichiatria è una scienza ambigua. E la sua ambiguità consiste nel suo
continuo oscillare tra l'essere-con-qualcuno e l'avere-qualcosa-di-fronte (Cargnello, 1980).
Ambigua in che senso? Nel senso che la psichiatria si connota proprio per una sostanziale
indecidibilità, un continuo oscillare intorno a due modalità di mettersi in rapporto con l'altro,
ognuna delle quali (insieme con l'altra) è costitutiva della psichiatria stessa. Come dire che
non c'è psichiatria se non esiste la possibilità di occuparsi dell'altro come qualcosa che
abbiamo di fronte (una malattia, un disturbo, un modo di essere?); ma non esiste
psichiatria nemmeno se non c’è la possibilità di essere-con-qualcuno, di porsi in relazione
con il mondo e la soggettività dell'altro.
Ogni punto di equilibrio è continuamente a rischio di andare perduto. La tentazione di
eliminare uno dei termini della ambiguità è fortissima. Si realizzano in questo modo
psichiatrie mutilate, monodimensionali che da un lato dimenticano il cervello, dall'altro
dimenticano la mente.
Nella oscillazione ambigua tra 'avere-qualcosa-di-fronte e 'essere-con-qualcuno si tiene
invece aperta la possibilità di: (i) pensare in qualche momento alla malattia-disturbo come
a qualche cosa di in-sensato, privo di senso personale, non intessuto con la storia di vita,
con le vicende interiori di una persona; qualcosa che interrompe e sbarra il corso del
flusso vitale, dividendo la vita dell'individuo in un prima-libero-dalla-malattia e in un dopo
siglato da una malattia che ha alterato profondamente la modalità di esistenza; (ii) in
qualche altro momento sentire invece di essere-con-qualcuno, immersi in una relazione
nella quale gli stessi sintomi divengono portatori di un significato personale. Essere-con
qualcuno quindi che non è solo anonimo “portatore” di un disturbo, ma parte di quello
stesso disturbo. In qualche misura autore e portatore al tempo stesso del disturbo. Dal
momento che quella “malattia” o meglio quella sofferenza si configura subito come avente
un senso, inserita in un percorso di senso che fa perno su vicende di vita che appaiono
significative e naturalmente connesse con quella sofferenza. Una sofferenza che si
inscrive nella storia della vita interiore e che appare inestricabilmente legata ad un
particolare momento dell’esistenza di quella particolare persona. Avere di fronte una
“malattia impersonale” – partecipare di una sofferenza personale: l’oscillazione tra questi
due poli può toccare tutte le posizioni intermedie. Alcune situazioni con le quali la clinica ci
confronta spostano sistematicamente il pendolo da una parte o dall’altra. Quando
sentiamo sulle nostre spalle il peso di una drammatica impotenza terapeutica il pendolo
tira inevitabilmente dalla parte dell'avere-qualcosa-di-fronte Come ci sentiamo di fronte ad
un paziente schizofrenico cronico con sintomi negativi (Rossi Monti & Foresti, 2002)? Più
vicini all’avere qualcosa-di-fronte oppure all'essere-con-qualcuno? Nel contatto con questi
pazienti “vi sembrerà che non soltanto le vostre parole, ma il vostro pensiero e infine tutta
la vostra persona siano privi di senso, non solo, addirittura svuotati di significanza. Di voi
non resta che un guscio riempito di vuoto” (Racamier, 1980). In questo caso, in cui il
senso sembra azzerato e la mente spenta, il pendolo si sposta sistematicamente verso
l’avere-qualcosa-di-fronte: verso l’idea di una malattia che attacca la mente poichè ha
attaccato e "appiattito" prima di tutto il cervello. Ma proprio quando il pendolo tira in una
direzione è vitale potere recuperare l'esperienza dell'essere-con-qualcuno. Proprio di
3
fronte a sintomi che appaiono soltanto come gusci comportamentali vuoti (Rossi Monti,
1990) vale la pena ricordare che il vuoto non coincide necessariamente con una assenza
perenne: “di uno sguardo, di un'orbita si dice che sono vuoti in quanto hanno contenuto la
visione e l'hanno perduta” (Starobinski, 1995). In questo senso i sintomi negativi
potrebbero essere non tanto lo “specchio” di una lesione ma il concreto prodotto di una
attività auto-demolitiva, grazie alla quale - pur di liberarsi del fardello della auto-percezione
– un’esperienza disturbante è stata trasformata in un comportamento inerte e stereotipo.
Un vuoto che sarebbe quindi anche “fare il vuoto”, frutto di una qualche presa di posizione
di fronte al mondo e alla psicosi.
Quando un paziente vive periodicamente crisi di panico nella classica forma di attacchi
immotivati, come altrettanti fulmini a ciel sereno, tende spesso a mettere il clinico nella
condizione dell'avere-qualcosa-di-fronte. Il messaggio, più o meno esplicito, è di questo
tipo: "soffro di attacchi di panico e voglio essere liberato da questo qualcosa che nulla ha a
che fare con me". Se aderiamo in maniera acritica a questa prima modalità di superficie
con la quale il paziente si presenta (ed alla rappresentazione che di questa patologia offre
il DSM, con il suo ben pettinato schema nosografico) finiamo per credere di avere
effettivamente qualcosa di fronte. Una entità naturale di malattia che ha lo stesso statuto di
ogni altro ente di natura: il disturbo da attacchi di panico esisterebbe allo stesso modo di
come esiste un gatto o un tavolo. Ma quando percepiamo che forse quell’attacco di panico
che il soggetto vive come estraneo ed immotivato ha in realtà qualcosa a che vedere con il
suo assetto personologico, con il modo di essere di quell’individuo in quel periodo della
sua esistenza, allora la sensazione di essere di fronte a qualcosa, slitta gradualmente
verso quella di essere-con-qualcuno. In questa oscillazione tra l'avere-di-fronte un attacco
di panico che assomiglia a una tradizionale malattia medica e l'essere-con una persona
che riesce a dare espressione ad una serie di difficoltà solo distanziandole in questa
scarica di angoscia prevalentemente somatica, diventa possibile costruire un percorso
terapeutico che tenti di riunire entrambe i corni del dilemma.
Viceversa è più agevole sentire di essere-con-qualcuno – per fare ancora due esempi –
nel contatto con una psicosi reattiva breve, un disturbo post-traumatico da stress o un
episodio depressivo maggiore che magari si sia verificato in prossimità di una vicenda
critica di vita. Tutte evenienze nelle quali avvertiamo la presenza di "qualcuno", di una
soggettività e della sua storia più che di un "qualcosa" che abbiamo di fronte. Un arresto
melanconico tira invece ancora il pendolo dalla parte dell'avere-qualcosa-di-fronte: per la
caratteristica invarianza, atemporalità e astoricità delle forme melanconiche che sembrano
svincolarsi dalla storia di vita e dalle caratteristiche dell’individuo per riproporsi sempre
uguali a se stesse.
Si potrebbe continuare, elencando condizioni cliniche che tirano il pendolo più da un lato
che dall'altro. Ma in tutti questi i casi, soprattutto quando il pendolo tira da una parte,
diventa particolarmente importante conservare il senso della oscillazione proposta da
Cargnello in modo da tenere aperto un varco nel quale articolare un progetto terapeutico.
3. Insufficienza dei moderni strumenti statistico-diagnostici
Il DSM è stato costruito per classificare i disturbi. Assume quindi inevitabilmente l’ottica
dell’avere-di-fronte-qualcosa. Se questo assetto può avere una sua utilità nella
classificazione dei disturbi a scopo di ricerca rivela la sua drammatica insufficienza
quando si tratta di provare ad essere-con-qualcuno. I disturbi di personalità del cluster B
sono quelli nei quali il fenomeno, comunque presente, diventa clamorosamente evidente.
Diventa evidente perché molti disturbi di personalità sono – per loro stessa natura disturbi a forte impatto relazionale. Dove non si ha a che fare con pazienti regrediti,
sintomi deficitari o negativi, con persone con scarse competenze relazionali, schive,
sfuggenti o addirittura autistiche. Non si tratta in questo caso di supplire ad un esame di
4
realtà fortemente compromesso ma di essere-con persone che tendono a sviluppare nel
rapporto con gli altri circuiti di carattere ripetitivo e fallimentare. Limitati ma anche allo
stesso tempo altamente sofisticati dal punto di vista relazionale. Si tratta in sostanza di
fronteggiare brusche e continue oscillazioni nei livelli di funzionamento, con passaggi
anche brutali dalla autonomia alla dipendenza, con risonanze emozionali molto ricche ed
inaspettate: insomma, tutto il contrario dell'appiattimento affettivo descritto nella
schizofrenia cosiddetta negativa.
La patologia borderline di personalità fa letteralmente ribollire la relazione. Assai più di
quanto siamo abituati a vedere accadere nelle forme cliniche di cui si è tradizionalmente
occupata la psichiatria: le psicosi maggiori. La psichiatria per lungo tempo si è occupata di
mondi chiusi, monopersonali: forme di esistenza patologica incentrate sul singolo
individuo. Nonostante siano state prese in considerazione anche le ripercussioni di
carattere familiare, gruppale e sociale di questo tipo di assetto, resta il fatto che il mondo
dello schizofrenico, il mondo autistico, il mondo melanconico sono mondi chiusi, che
tendono ad una autosufficienza per la quale Racamier (1980) ha usato i termini di
"onnipotenza inanitaria". Se il nevrotico vive il conflitto nella propria interiorità e lo psicotico
realizza un tentativo allo-plastico di modifica della realtà circostante sovrapponendovi una
fantasia delirante, il soggetto borderline vive invece nella realtà e nella relazione quelle
vicende che non riesce a vivere sul piano psichico dentro di sé. La realtà e la relazione
sono quindi il terreno sul quale costantemente si muove, qualcosa che è necessario alla
estrinsecazione della sua psicopatologia come l'acqua è necessaria al pesce che vi nuota.
Vale anche la pena ricordare che mentre la psichiatria nell'affrontare la psicopatologia
psicotica ha largamente utilizzato un filtro istituzionale (dal manicomio alle odierne
strutture riabilititative) dotato di una funzione difensiva nei confronti degli operatori, il
lavoro con il disturbo borderline si svolge, per così dire, in campo aperto.
Il disturbo borderline di personalità è in questo senso un disturbo disturbante per essenza.
Nel contatto con questa patologia il clinico viene investito da questo aspetto disturbante
del disturbo. Dato che non esiste nel paziente la possibilità di contenere nella mente una
sofferenza che si esprime invece nella turbolenza e imprevedibilità delle azioni, il clinico si
trova a dovere lavorare in primo luogo sugli elementi di realtà e a vivere in presa diretta
tutto questo aspetto disturbante. In questo senso l’aspetto disturbante del disturbo di cui il
clinico si fa carico costituisce uno dei primi nuclei di sofferenza che emerge nella
relazione. Ma la sopportazione da sola non basta: il terapeuta deve mettersi nella
condizione di poter vivere questo “disturbo” - faticoso e a volte quasi insopportabile - come
primo passo di un possibile percorso trasformativo.
Alla luce del concetto di personalità psicopatiche di Schneider (1950), il disturbo borderline
di personalità, in virtù del suo essere altamente disturbante, può essere considerato il
paradigma dei disturbi di personalità. Il borderline cerca la relazione: ti coinvolge, ti afferra
e poi ti butta via. Il problema quindi non è tanto che il borderline è privo di competenze
relazionali. Al contrario, il problema è che ne ha troppe e che queste competenze sono
troppo specializzate. Tanto da tendere sistematicamente alla riproduzione di un unico
pattern di relazione, che segue una sequenza predeterminata. Ne derivano storie tipiche,
connotate da vicende relazionali burrascose e fortemente discontinue, sul piano affettivo e
lavorativo: relazioni brevi ma intense, con un elevato coinvolgimento ed investimento
iniziale a cui segue una brusca e qualche volta rovinosa interruzione, accompagnata da
vissuti di disprezzo, frustrazione, scontentezza, svalutazione.
E tu – come clinico e come operatore - che cosa fai? Anche se hai letto e conosci tutto ciò
che il DSM di turno dice sulla psicopatologia borderline, vieni facilmente catturato nella
rete, avviato in questo perverso giro relazionale in cui le cose si ripetono sempre uguali.
Che cosa fai? Ti fai coinvolgere e poi buttare via? Oppure in questa burrasca relazionale
puoi provare a inventare qualcosa di meglio? Magari trovando un modo, tra mille difficoltà,
5
di "tenere la relazione", per vedere se, al di là di questo burrascoso percorso, non esista
qualche altra possibilità di approdo.
4. La questione borderline
Il contatto con la psicopatologia borderline solleva una ampia serie di questioni: alcune di
carattere epistemologico e teoretico, altre invece di carattere clinico e pragmatico
(Pazzagli & Rossi Monti, 1999). Per quanto riguarda questo secondo ambito, vale la pena
elencare una serie di problemi che si pongono in maniera ineludibile nel trattamento del
paziente borderline:
la questione della relazione e la questione del drop-out
la questione della impulsivita’
la questione del suicidio-suicidosi
la questione della evoluzione del disturbo nel tempo
la questione della cura in condizioni caratterizzate da marcata discontinuità
Non è possibile, in questa sede, dare conto di ciascuna questione. Ognuna di esse
meriterebbe uno spazio a se stante. E' sufficiente tuttavia fermare la attenzione su due
requisiti di fondo indispensabili per avventurarsi sul terreno della terapia a lungo termine di
pazienti borderline.
a. la funzione mitigatrice della teoria
Marsha Linehan (1993), che ha maturato una vasta esperienza nel trattamento di pazienti
borderline caratterizzati da marcata impulsività e tendenze auto-lesionistico e suicidarie,
ha messo nero su bianco quanto ciascuno di noi si è trovato a sperimentare in simili
circostanze:
suggerire al terapeuta di essere accogliente va benissimo quando il paziente
non mette in dubbio in ogni interazione le sue competenze, la sua credibilità e
la sua sincerità, non lo tempesta di telefonate indesiderate ad ogni ora del
giorno e non minaccia di uccidersi ogni volta che l'altro fa un passo falso o
quando è sovraccarico di altre preoccupazioni.
Va benissimo quando il paziente non minaccia ogni settimana di abbandonare
la terapia, non si lamenta del terapeuta..., non riformula rigidamente quello che
gli è appena stato detto operando distorsioni e amplificazioni ..., non risponde
con un silenzio protratto ogni volta che si fa un'osservazione poco partecipativa
... Ma che dire quando alcuni o tutti questi comportamenti, e magari anche altri
peggiori, fanno la loro comparsa?
In circostanze del genere non c'è solo la difficoltà di conservare un certo grado
di accoglienza ma c'è anche quella di evitare di compiere rappresaglie e di
attaccare il paziente. Non ho mai provato personalmente, nè osservato in altri
terapeuti, tanta rabbia verso i pazienti quanto se ne può trovare nelle terapie dei
borderline
Assumere un atteggiamento da San Sebastiano, farsi trafiggere da una miriade di frecce
non è di per se stesso sufficiente a indurre una trasformazione terapeutica. La presa in
carico a lungo termine di un paziente borderline implica senza dubbio una buona capacità
di sopportazione: la relazione terapeutica sarà inevitabilmente burrascosa, piena di
imprevisti, di situazioni dilemmatiche nelle quali il clinico si sentirà spinto con le spalle al
muro. Basti citare le drammatiche richieste di aiuto nel fine settimana o la minaccia-ricatto
suicidarla, da considerare sempre con grande attenzione visti i reali pericoli autolesivi
6
caratteristici di questa patologia. Ma assumere un atteggiamento di rassegnata
sopportazione porta poco lontano. Anzi, in nome di una malintesa neutralità si rischia di
perpetuare una modalità di relazione patologica: quanto più il terapeuta apparirà poco
toccato o turbato dai comportamenti del paziente borderline, tanto più quest'ultimo sarà
costretto, per così dire, ad "alzare la voce". Un po' come se il borderline fosse una persona
che è sempre stata circondata da individui sordi e che per farsi sentire dovesse
continuamente alzare la voce o addirittura urlare. Urlare equivale anche a mettere in atto
comportamenti che sono spesso sopra le righe e realizza quella condizione a cui Zanarini,
Gunderson e Frankenburg (1990) hanno dato il nome di atteggiamento iperbolico. Un
terapeuta che non scappa ma si rifugia in una rassegnata tolleranza, tenta in realtà di
tagliare via i toni alti della relazione costringendo il paziente ad alzare ancora di più la
posta, spingendo la relazione verso una sorta di momento della verità: punto critico nel
quale verificarne davvero la tenuta e consistenza. La sola "sopportazione" delle
vicissitudini del rapporto non conduce quindi da nessuna parte. Anzi conduce sempre allo
stesso esito: ad una ripetizione-replica che non è una ripetizione-ripresa. Per dirla
altrimenti: quando si è in ballo bisogna ballare, lasciarsi toccare e necessariamente anche
turbare dalla relazione con il borderline. Salvo però potere conservare la capacità di
assumere – su quanto sta accadendo – un punto di osservazione diverso. Dal quale
potere fare ricorso ad una bussola: una teoria, una conoscenza teorica, un modello della
psicopatologia borderline. Un modello (o anche, inevitabilmente, più modelli) grazie ai
quali dare un senso a ciò che accade nella relazione e anche nella propria esperienza di
terapeuta: un modello dello stile relazionale borderline che consenta di sentirsi sballottati
dai marosi pur potendo fare, di tanto in tanto, il punto della navigazione. Una funzione che
potremmo chiamare funzione mitigatrice della teoria, analoga a quella capacità alla quale
ciascuno di noi fa ricorso in misura maggiore o minore per ripristinare dentro di sè uno
stato di calma e di quiete in presenza di eventi perturbatori. Una capacità di cui il
borderline dispone in grado molto limitato e che lo rende terreno fertile per l’ invasione e la
persistenza nel tempo di emozioni che non possono essere elaborate.
b. competenza relazionale
Nancy Mc Williams (1994) ha dato un brillante resoconto di come l'addestramento degli
operatori alla valutazione del rischio suicidario possa non tenere in debito conto gli aspetti
relazionali della minaccia di suicidio e portare così ad un intervento controproducente sul
piano clinico, se non addirittura anti-terapeutico. L'addestramento a focalizzare la
attenzione sulla idoneità o meno del mezzo suicidario negli operatori che rispondono alle
chiamate dirette ad un servizio telefonico di pronto intervento impedisce, nel caso di molti
pazienti borderline, di valutare ed accogliere il bisogno di ascolto insito nella minaccia
autolesiva. Sottolineando gli aspetti realistici e concreti della situazione si amplifica il
rischio di passaggio all'atto. La impossibilità di trovare nell'ascolto dell'altro un argine alla
propria esperienza angosciosa conduce ad una escalation nella richiesta di aiuto che
assume toni sempre più drammatici. La necessità prevalente del paziente borderline è
spesso quella di trovare un ascolto mediante il quale mitigare il senso di solitudine: avere
la sensazione che c'è un altro che recepisce e coglie il suo messaggio, senza ridurlo
immediatamente ad altro. Come è possibile acquisire la competenza relazionale
necessaria a gestire situazioni di questo tipo? Inevitabilmente si pone il problema della
acquisizione di competenze di carattere psicoterapeutico davvero indispensabili nel
trattamento a lungo termine dei pazienti borderline. Qui meno che mai la relazione può
essere difensivamente evitata. Come invece da sempre molti psichiatri tentano di fare in
ambiti psicopatologici che offrono loro maggiori opportunità di defilarsi grazie alla passività
della posizione assunta dal paziente (schizofrenia cronica, sintomi negativi, autismo).
Avere a che fare con un paziente borderline è invece essere inevitabilmente catturati in
7
una relazione caratterizzata da emozioni intense: prima tra tutte la disforia (Pazzagli &
Rossi Monti, 2000; Rossi Monti, 2000). Non esiste insomma – hanno scritto
provocatoriamente Fonagy e Target (2000) riprendendo una famosa immagine di
Winnicott – una cosa come la persona borderline: esiste sempre e solo una coppia. Al
centro del progetto terapeutico è quindi la relazione e la coppia.
Non è certo sufficiente riempirsi la bocca con termini come alleanza terapeutica. Anche
perchè la alleanza terapeutica di cui tanto si parla, nel caso del borderline, è un mito. Non
nel senso che non esiste. Ma nel senso che è tutta da costruire e che deve magari per
lungo tempo transitare per forme di alleanza presunta nelle quali sono coinvolti aspetti del
paziente fortemente influenzati dal transfert in quel momento in atto nel rapporto con il
terapeuta (Searles, 1986). La alleanza terapeutica è comunque qualcosa di cui non si
dispone all’inizio del trattamento, se non in grado molto limitato, e - quando arriva - arriva
alla fine del lavoro. Si tratta casomai di impostare le condizioni nelle quali una alleanza
terapeutica si possa sviluppare, agevolando da un lato la comprensione cognitiva,
dall'altro l'esperienza del sostegno, della comprensione, della possibilità di ritrovare
qualcosa che assomigli ad uno stato di quiete motoria nella quale sia possibile cominciare
a pensare a ciò che spesso viene trasfuso direttamente in azione. Per questi motivi
Gunderson (2001) ha sentito il bisogno di distinguere forme diverse di alleanza
terapeutica, delineando gli elementi costitutivi di una alleanza che può svilupparsi nel
corso del processo terapeutico. Se è vero che un approccio troppo diretto e concreto,
centrato sulla apparente oggettività del problema posto dal paziente – come nel caso della
minaccia suicidarla discusso da McWilliams (1994) – impedisce di cogliere il bisogno
retrostante di ascolto e accoglimento incondizionato, è altrettanto vero che un
atteggiamento troppo recettivo-passivo, nel quale il terapeuta attenda che sia il paziente a
formulare una richiesta di aiuto più strutturata, astenendosi dal prendere iniziative, mostra
tutti suoi limiti di fronte all'incalzare di agiti che mettono a rischio non solo la relazione
terapeutica, ma spesso anche la stessa vita del paziente. Da questo punto di vista,
soprattutto nelle fasi molto iniziali della terapia, quando il quadro è dominato dagli agiti (in
specie condotte autolesive o di carattere para-suicidario) i terapeuti di orientamento
psicodinamico – sostiene giustamente Gunderson (2001) - hanno molto da imparare dai
terapeuti cognitivo-comportamentali che adottano un approccio direttivo, pratico, aderendo
sul piano dell'ascolto e della comprensione al problema che il paziente mette in primo
piano, senza avere interesse a svelarne per il momento altri possibili rimandi e
implicazioni, non prendendo troppo in considerazione il coinvolgimento nella relazione
transferale.
Lo sviluppo delle competenze necessarie al trattamento di un paziente borderline richiede
quindi, non soltanto delle conoscenze teoriche che facciano da sfondo alla relazione, ma
anche un assetto interno capace di reggere all'impatto anche violento della relazione ed in
grado di recuperare un punto di equilibrio anche quando la relazione viene portata in
prossimità del punto di ebollizione e di rottura. Senza la abitudine ad un lavoro di continua
metariflessione sulla propria esperienza che consenta di metabolizzarla, il trattamento a
lungo termine di un paziente borderline è arduo per non dire impossibile. Questa funzione
di carattere meta-riflessivo (che per l'appunto è uno degli aspetti carenti del funzionamento
mentale del borderline) può essere esercitata nell'ambito del gruppo curante, ma si giova
indubbiamente della possibilità che chi si impegna a fondo su questo piano abbia fatto una
esperienza di carattere psicoterapeutico o psicoanalitico dal lato del paziente. Un assetto
interno che si lasci turbare senza lasciarsi sconvolgere dalla burrasca relazionale
borderline costituisce il requisito minimo indispensabile a mantenere, perdere e poi
ritrovare nel tempo una condizione di relativa stabilità che sostenga il divenire della
relazione terapeutica. Del resto Searles (1986) venti anni fa sosteneva che proprio
l’impatto con gli affetti intensi e non integrati dei pazienti borderline induce un inevitabile
8
sentimento di incertezza nel terapeuta: incertezza rispetto alla tenuta della relazione, al
rischio che il paziente peggiori, abbandoni la terapia o si suicidi. Ma questa incertezza è
anche l’indicatore del fatto che il terapeuta – in queste forme di trattamento – non si può
aggrappare ad una identità professionale stereotipata, ma anzi ha bisogno di queste
continue fluttuazioni del suo senso di identità per utilizzarlo come vero e proprio organo di
percezione nella navigazione clinica.
5. Una diagnosi double-face
Nonostante si sia sempre più affermato come strumento di studio, conoscenza e
valutazione clinica in psichiatria, il DSM è stato progettato e costruito sulla base della
necessità di classificare i disturbi e non le persone. In questo senso adotta
necessariamente l'ottica dell' avere-di-fronte-qualcosa. Un'ottica che si sottrae alla aporia
costitutiva della psichiatria e che rivela inoltre tutta la sua insufficienza quando la relazione
viene, drammaticamente, in primo piano. Così accade quando il clinico si confronta con la
psicopatologia borderline: la dimensione di coppia è qui davvero ineludibile. L'alternativa è
secca: o si trova il modo di stare nella coppia o non si lavora in senso terapeutico. Il DSM,
a partire dai fini per i quali è stato progettato, non può fornire strumenti utili a questo
riguardo poichè trascura totalmente la dimensione della relazione e quindi dell'essere-conqualcuno. Tuttavia nonostante la aspirazione ateoretica, i criteri descrittivi adottati dal DSM
per il disturbo borderline di personalità lasciano intravedere la dimensione relazionale del
disturbo e non possono esimersi da riferimenti teorici: come ad esempio il riferimento alla
centralità delle esperienze di separazione o ancor più la alternanza tra idealizzazione e
svalutazione. Questo è tanto vero che cambiando il vertice dal quale guardare i criteri, è
possibile farne emergere le implicazioni relazionali e ripensarli in una dimensione di
coppia. Non assumendoli più come descrizione oggettiva, operazionalizzabile, ateoretica
di un fenomeno che si dispiega di fronte all'osservatore, ma ripensandoli in base allo
spirito che aleggia in ogni possessore di un soprabito double-face: soprabiti che da un lato
sono un normale cappotto ma, rivoltati, diventano dall'altro degli impermeabili, in modo da
potere essere indossati ora in un modo ora nell'altro. Ma anche quando lo si indossa in un
modo, come cappotto o come impermeabile, l'oggetto continua a mantenere per il suo
possessore anche un'altra identità, coesistente con quella manifesta: indossato come
cappotto, è possibile tuttavia considerarlo anche sotto il profilo di un altro aspetto della sua
identità, ancorché nascosta all’altrui osservazione.
Allo stesso modo, i criteri per la diagnosi di borderline possono essere considerati in
versione double-face, come un soprabito che può essere indossato in due versioni
differenti, ma complementari, dal paziente e dal suo terapeuta. Accanto ai criteri espliciti
ed oggettivi enumerati dal DSM crediamo che esista un'altra faccia dei criteri diagnostici,
nascosta alla osservazione esterna. Un versante problematico che chi si cimenta in un
progetto terapeutico vive in presa diretta ed in tutta la sua importanza. Se i criteri
diagnostici proposti dal DSM forniscono una versione descrittivo-oggettivante del disturbo,
gli stessi criteri, rivoltati come un guanto, danno conto della dimensione soggettivorelazionale del rapporto terapeutico. Ad ogni criterio diagnostico è possibile abbinare la
controfaccia corrispondente al vissuto soggettivo del clinico impegnato nella relazione
terapeutica. Ne deriva un effetto di "fermentazione" dei criteri diagnostici che da indicatori
relativi all'avere-di-fronte-qualcosa si trasformano in indicatori multi-dimensionali, capaci di
cogliere i modi di essere-con-qualcuno, coniugando gli aspetti descrittivi-oggettivi
indispensabili alla diagnosi nosografia con quelli vissuti-soggettivi, indispensabili per lo
sviluppo ed il mantenimento della relazione terapeutica.
I nove criteri diagnostici del DSM nella loro versione double-face possono essere così
riassunti:
9
Criterio 1: sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono.
A questo criterio corrisponde la sensazione di sentirsi afferrati, trascinati, coinvolti o anche
usati in una relazione. Questo coinvolgimento tende ad accentuarsi drammaticamente in
prossimità di ogni piccola o grande separazione nel corso del lavoro terapeutico. Il
sentimento del terapeuta è di difficoltà, disagio, colpa o anche vera e propria angoscia
Tutte le volte che il terapeuta non colloca il paziente al centro dei suoi pensieri, delle sue
attenzioni o preoccupazioni, tende a sentirsi messo in difficoltà, colpevolizzato, a disagio.
O anche in condizioni di vera e propria angoscia, di fronte, ad esempio, a ritorsioni di
carattere autolesivo-suicidario.
Criterio 2: un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate
dall'alternanza tra gli estremi di iper-idealizzazione e svalutazione.
Ci si sente sbatacchiati, un po' come fanno i bambini con i giocattoli nuovi quando li
sbattono per terra per vedere come sono fatti dentro. Tutto questo nel contesto di una
relazione molto intensa, caratterizzata da una elevata imprevedibilità e allo stesso tempo
iper-coinvolgente, nella quale cioè ci si sente tirati dentro, in una alternanza di momenti di
idealizzazione e viceversa di svalutazione
Criterio 3: alterazione dell'identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e
persistentemente instabili
La sensazione che si prova è quella di non sapere bene chi si ha di fronte, non riuscire a
farsene una idea, non riuscendo a svilupparne una rappresentazione che abbia un minimo
di coerenza. Totalmente assorbiti nel presente, dal dato contingente, da ciò che in quel
momento emerge come problema (spesso drammatico), si fa molta fatica ad istituire una
narrazione all'interno della quale quel dato possa essere inscritto, storicizzato e
relativizzato. Si finisce spesso per sentirsi messi in crisi circa la propria identità!
Criterio 4: impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il
soggetto, quali spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate
Invasi da agiti, comportamenti nei quali vengono direttamente travasati gli affetti, ci si
sente disturbati, bloccati, ingombrati da qualcosa che sollecita ad agire prima ancora di
avere potuto formulare un pensiero su quanto sta accadendo. Si avverte una spinta a
reagire a corto circuito, con un comportamento simmetrico a quello del paziente, spesso
all'interno di situazioni esasperate che vengono in un primo momento vissute come
dilemmi che non ammettono altre possibili soluzioni
Criterio 5: ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento
automutilante.
Messi al muro, nell'angolo, di nuovo immobilizzati in una situazione dilemmatica. Una
condizione qualche volta di vero e proprio ricatto, nella quale le alternative si riducono a
due possibilità estreme che esercitano un "effetto cattura" che obnubila la capacità di
pensare e di interrogarsi su quale sia la natura di quella situazione, come si sia
determinata, che bisogni esprima e su quali siano le possibili vie di uscita
Criterio 6: instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell'umore (per es., episodica
intensa disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore, e soltanto raramente più
di pochi giorni)
Si avverte una inquietudine affettiva, una condizione di instabilità nella quale ci si sente
preda di sentimenti di sconforto, impotenza, delusione, senso di fallimento, irritazione,
disforia o rabbia. Sentimenti che non di rado investono la totalità della persona del clinico
o comunque riguardano le sue capacità professionali progressivamente vissute come
deprezzate e svilite.
Criterio 7: sentimenti cronici di vuoto
Si vive un senso di desolazione e di vuoto nel quale fatica ad attecchire una idea, un
pensiero, un’emozione. Sembra che non vi sia nulla all'orizzonte di disponibile sul quale
10
far perno per sviluppare un’esperienza più stabile: tutto si sfarina e si perde, in un
crescente senso di avvilimento e frustrazione.
Criterio 8: rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (per es., frequenti
accessi di ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici)
Lampeggiano qua e là momenti di rabbia anche intensa: avere a che fare con un paziente
borderline è avere a che fare con un paziente arrabbiato e che fa arrabbiare, soprattutto
per la sensazione di essere in un modo o nell’altro “usati”.
Criterio 9: ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.
Si fanno strada anche nel terapeuta flash quasi-paranoidi del tipo: “ma non starà
registrando quello che dico?”. Oppure fantasie e vissuti di carattere persecutorio, stile
"Attrazione fatale".
6. Conclusioni
Cosa ci aspetta nella relazione terapeutica con un paziente borderline? Una diagnosi che
non sia solo descrittiva e focalizzata su ciò che è esterno e oggettivabile aiuta a formulare
un’ipotesi su quello che ci aspetta. Aiuta a fare previsioni e a dedicare a questi fenomeni
un’attenzione e una riflessione costante, mettendo a punto un vero e proprio monitoraggio
interiore del percorso terapeutico e della relazione. Questa attenzione costante non deve
necessariamente prendere la forma di una riflessione da praticare nel corso degli eventi,
quando ad esempio si è nel pieno di una bufera relazionale determinata magari da una di
quelle microfratture della empatia alle quali i borderline sono particolarmente sensibili.
Deve piuttosto accompagnare il corso degli eventi e magari svolgersi anche dopo che la
tempesta è passata: in modo da tessere in una filiera quegli avvenimenti “traumatici” che
altrimenti rischierebbero di cadere a lato della relazione e non potrebbero essere utilizzati
per la comprensione della stato e della genesi di un certo tipo di relazione.
Del resto è stato spesso notato che "il comportamento nell'ambiente terapeutico tende a
perturbare i rapporti interpersonali tra gli operatori dell'ospedale che inconsciamente
riproducono, intorno al paziente, il suo stesso mondo intrapsichico di relazioni oggettuali"
(Kernberg,1992). In questo senso la coppia terapeutica o il gruppo dei curanti si
troveranno a fronteggiare modi di essere-con-qualcuno che non possono essere ridotti
entro la logica dell'avere-di-fronte-qualcosa e che devono essere comunque governati
all'interno del gruppo degli operatori. Muoversi lungo tutto l'arco che separa (ed unisce)
questi due modi di intenzionare l'oggetto del lavoro clinico permette di percorrere tutto
l'ambito di oscillazione descritto da Cargnello e di ritrovare quella dimensione di ambiguità
costitutiva di ogni approccio psichiatrico che non si limiti a registrare la presenza di un
disturbo-malattia ma veda nello sviluppo di una relazione anche la possibilità di una
evoluzione del disturbo.
BIBLIOGRAFIA
American Psychiatric Association (2000). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi
mentali, DSM-IV-TR. Masson: Milano, 2001
Cargnello D. (1980). Ambiguità della psichiatria. In: Scienza, linguaggio e metafilosofia.
Scritti in memoria di Paolo Filiasi Carcano. Guida: Napoli
Clarkin J.F. & Lenzenweger M.F. (1996). I disturbi di personalità. Cortina: Milano, 1997.
Deutsch H. (1942). Forme di disturbi emotivi e loro rapporti con la schizofrenia. In:
Deutsch H. Psicoanalisi delle nevrosi. Newton Compton: Roma, 1978
Fonagy P. & Target M. (2000). Attaccamento e Funzione Riflessiva. Cortina: Milano
11
Freud S. (1910). Osservazioni psicoanalitiche su un caso di di paranoia (dementia
paranoides) descritto autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber). In
Opere, vol.6. Boringhieri: Torino: 1974.
Freud S. (1915-1917). Introduzione alla psicoanalisi. In Opere, vol. 8. Boringhieri. Torino,
1976
Freud S. (1925). Prefazione a “Gioventù traviata” di August Aichorn. In Opere, vol. 10.
Boringhieri: Torino, 1978
Gunderson J. (2001). La personalità borderline. Una guida clinica. Cortina: Milano, 2003
Hoch P. & Polatin P. (1949). Pseudoneurotic forms of schizophrenia. Psychoanalitic
Quarterly 23, 248-276.
Kernberg O.F.(1992). Aggressività, disturbi della personalità e perversioni. Cortina: Milano,
1993.
Knight R. (1953). Borderline states. Bulletin Menninger Clinic 17, 1-12
Linehan M (1993). Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline di
personalità.Cortina: Milano, 2001
Mc Williams N. (1994). La diagnosi psicoanalitica. Astrolabio: Roma, 1999.
Pazzagli A. & Rossi Monti M. (1999). L'area borderline come paradigma della psichiatria
psicodinamica. Psicoterapia e Scienze Umane 4, 77-88
Pazzagli A. & Rossi Monti M. (2000). Dysphoria and aloneness in borderline personality
disorder. Psychopathology 33,220-226.
Racamier PC (1980). Gli schizofrenici. Cortina: Milano, 1983.
Rossi Monti M. (1990). I sintomi negativi: metamorfosi dell' autismo. In: Salsa A.,
Schiamone M. (a cura di) Autismo schizofrenico. Patron: Bologna 181- 188.
Rossi Monti M. (2000). Disforia e condotte suicidarie nel borderline. Psichiatria e
Psicoterapia Analitica 2,156-162
Rossi Monti M. & Foresti G. (2002). I sintomi negativi sono davvero "negativi"? Psichiatria
di Comunità 3, 95-106
Schneider K.(1950). Psicopatologia Clinica. Fioriti: Roma, 2004
Searles H. F. (1986). Il paziente borderline. Bollati Boringhieri: Torino, 1988
Starobinski J. (1995). Vuoto e creazione. In: La coscienza e i suoi antagonisti.
Theoria:Roma-Napoli
Stern A. (1938), Psychoanalytic investigation of therapy in the borderline group of
neuroses. Psychoanalitic Quarterly 7, 467-489
12
Vaillant G.E. (1992). The beginning of wisdom is never calling a patient a borderline; or,
The clinical management of immature defenses in the treatment of individuals with
personality disorders. Journal of Psychotherapy practice and research1,2,117-134
Waldinger R.J. (1993). La diagnosi psicodinamica del disturbo borderline di personalità: un
tentativo di approfondimento. In Maffei C. (a cura di) Il disturbo borderline di personalità.
Bollati Boringhieri: Torino
Westen D. (1998). Diagnosi della personalità e formulazione del caso: due processi in
uno? In Westen D., Shedler J, Lingiardi. La valutazione della personalità con la SWAP200. Cortina: Milano, 2003
Zanarini M., Gunderson J., Frankenburg F. (1990). Cognitive features of borderline
personality disorder. American Journal of Psychiatry 147, 57-62
Indirizzo per corrispondenza:
Mario Rossi Monti Via G. Vico 13 – 50136 Firenze
e-mail: [email protected]
13