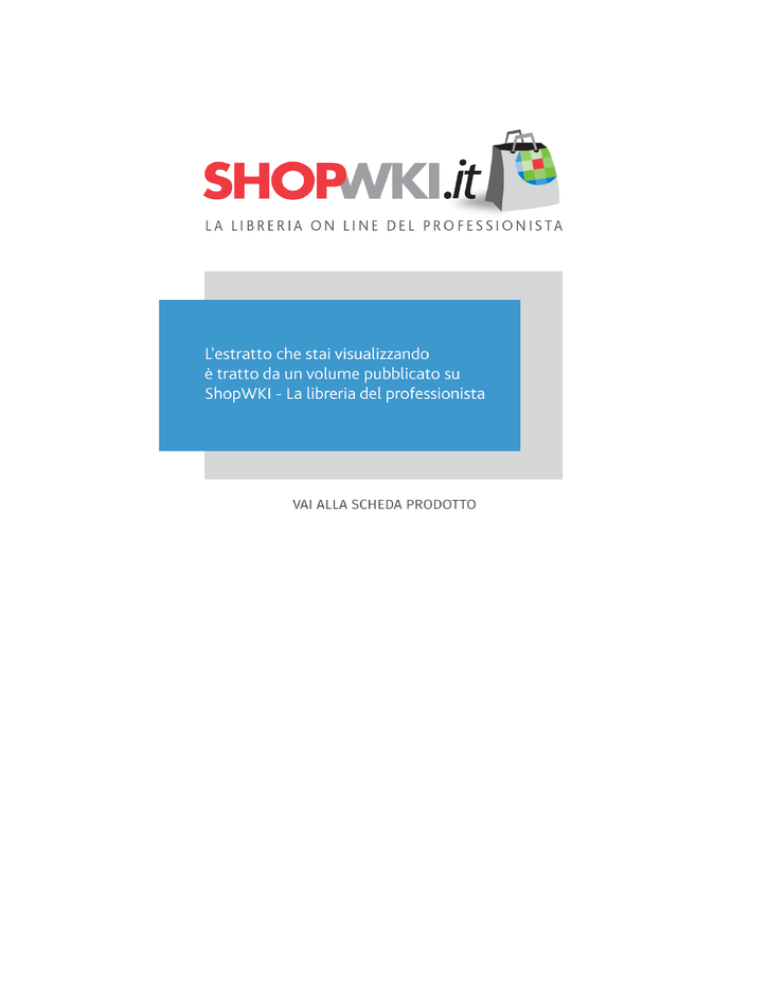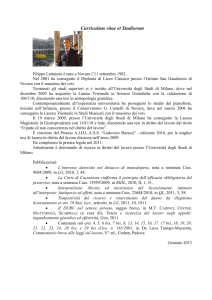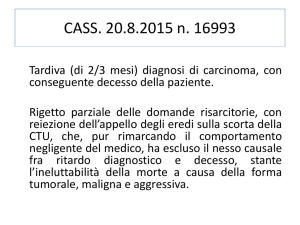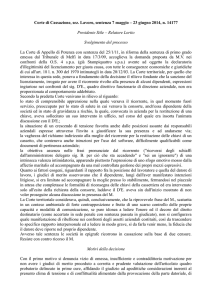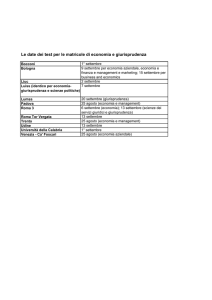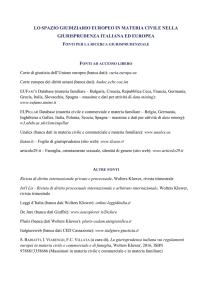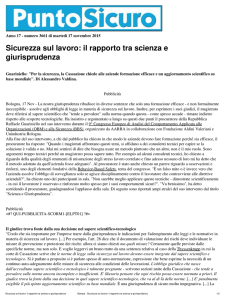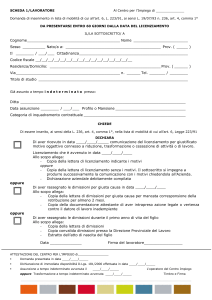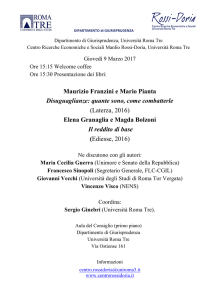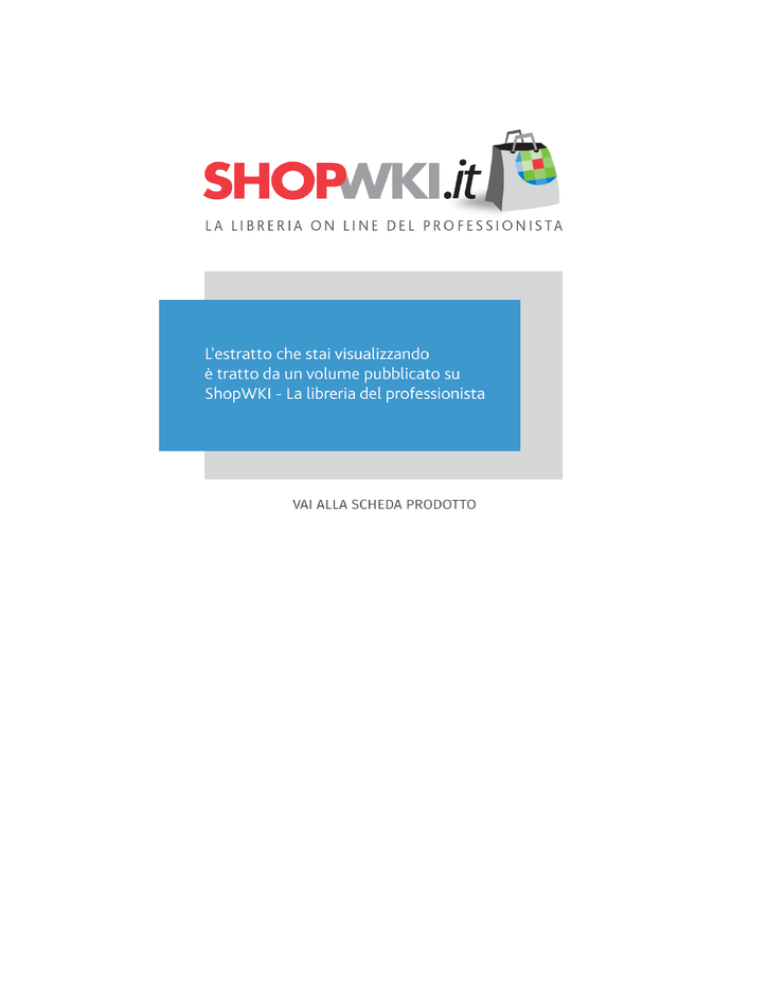
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
itinera
GUIDE GIURIDICHE IPSOA
APPALTI PRIVATI
E OUTSOURCING
Il volume, inserito nella sezione “Contratti d’impresa”, è suddiviso in
due parti principali: appalti privati e outsourcing.
La prima parte è dedicata all’istituto dell’appalto che viene affrontato
nella prassi applicativa e ne vengono analizzate le implicazioni
interdisciplinari, specie in materia giuslavoristica. Una particolare
attenzione è stata dedicata alla giurisprudenza, nella ricerca della
maggior completezza possibile.
La seconda parte della guida è dedicata alle figure di c.d. outsourcing,
rappresentate da rapporti negoziali mediante i quali le imprese
a cura di
P. POTOTSCHNIG,
G. CAPECCHI
Pagine: 480 - cod. 00186537
€ 70,00
affidano a soggetti esterni determinate attività o servizi necessari per
il loro ciclo produttivo.
Sono presenti clausole contrattuali e modelli di comunicazioni
o atti ricorrenti nelle fasi di esecuzione dell’appalto; casistiche
riguardanti l’applicazione giurisprudenziale in situazioni concrete di
norme e principi che governano l’istituto; descrizioni di casi pratici
gestiti dallo Studio Legance Avvocati Associati; approfondimenti
giurisprudenziali e dottrinali di particolari fattispecie e di questioni
Acquista
su www.shop.wki.it
Y65ES_CL.indd 1
Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città
Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie
Contattaci
02.82476.794
[email protected]
Y65ESCL
interpretative controverse.
16/02/16 10:21
ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/
00134998_2016_08-09_SOMMARIO.3d
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
il Lavoro nella giurisprudenza
Sommario
EDITORIALE
Precariato
nella scuola
LA FINE DEL PRECARIATO PUBBLICO MA NON SOLO PER LA SCUOLA
di Michele Miscione
745
DOTTRINA
Rapporto
di lavoro
IL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO SECONDO LA PIÙ VIRTUOSA GIURISPRUDENZA
NAZIONALE
di Daniela Izzi
748
DIMISSIONI, NUOVA FORMA SMATERIALIZZATA AD SUBSTANTIAM E DIRITTO
AL RIPENSAMENTO
di Marco Frediani
753
Spese di giustizia LE SPESE DI GIUSTIZIA NEL GIUSTO PROCESSO DEL LAVORO TRA LEGGE E PRASSI MINISTERIALE
di Vincenzo De Michele e Sergio Galleano
757
Età pensionabile PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE L’ETÀ PENSIONABILE: NODI IRRISOLTI
E SPUNTI DI RIFLESSIONE
di Giovanna Pistore
764
Dimissioni
GIURISPRUDENZA
Liberi
professionisti
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DIRITTI DEL PADRE AVVOCATO
Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016, n. 8594
Commento di Roberta Nunin
777
779
Società
cooperative
LA COMUNICAZIONE DELL’ESCLUSIONE DEL SOCIO-LAVORATORE NELLE COOPERATIVE
Cassazione Civile, Sez. lav, 1 aprile 2016, n. 6373
Commento di Luigi Angiello
784
789
Licenziamento
L’EPILOGO IN TEMA DI REPECHAGE E ONERE PROBATORIO
Cassazione Civile, Sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592
Commento di Carmelo Romeo
794
799
Straining
IL MOBBING ATTENUATO: LO STRAINING
Cassazione Civile, Sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291
Commento di Carmela Garofalo
803
808
RASSEGNA DELLA CASSAZIONE
a cura di Carlo Alberto Giovanardi, Guerino Guarnieri, Giuseppe Ludovico, Giorgio Treglia
817
RASSEGNA DEL MERITO
a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi
828
NORMATIVA
NOVITÀ LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE
a cura di Alessia Muratorio
833
INDICE
AUTORI
CRONOLOGICO
ANALITICO
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
837
743
ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/
00134998_2016_08-09_SOMMARIO.3d
Numero Demo
il Lavoro nella giurisprudenza
- Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sommario
COMITATO PER LA VALUTAZIONE
L. Angiello, A. Boscati, M. Brollo, C. Cester, G. Dondi, V. Filı̀, D. Garofalo, S. Mainardi, M.G. Mattarolo, L. Menghini, R. Nunin, A. Pizzoferrato, A. Topo, M. Tremolada, G. Zilio Grandi
La Rivista si cita Lav. Giur.
EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
INDIRIZZO INTERNET
www.edicolaprofessionale.com/lavgiur
DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi
REDAZIONE
Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Giuseppina Zanin
REALIZZAZIONE GRAFICA
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
FOTOCOMPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422
STAMPA
GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952
L’elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze
PUBBLICITÀ:
E-mail: [email protected]
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia
744
Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o
telefonare a:
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d’indirizzo, ecc., scrivere o
telefonare a:
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.024
e-mail: redazione.illavoronellagiurisprudenza.ipsoa
@wolterskluwer.com
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 – 20120 Milano
telefono (02) 824761 – telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 476
del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702
ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di
disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02-824761 - e-mail: servizioclienti.
[email protected]
Il prezzo dell’abbonamento carta
comprende la consultazione digitale
della rivista nelle versioni online
su edicolaprofessionale.com/lavgiur
tablet (iOS e Android) e smartphone (Android)
scaricando l’App Edicola professionale
ITALIA
Abbonamento annuale: E 235,00
ESTERO
Abbonamento annuale: E 470,00
MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
30% sull’acquisto dell’abbonamento annuale alla
rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsoa di
zona (www.ipsoa.it/agenzie) o inviando l’ordine via
posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6,
20090 Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o
rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n.
02-82476794.
Nell’ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante
l’appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere
iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6,
Milanofiori
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della
rivista e l’anno di abbonamento.
Prezzo copia: E 30,00
Arretrati: prezzo dell’anno in corso
all’atto della richiesta
DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento
Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.
Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede
legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima
tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i
dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n.
196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di
richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer
Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero:
02.82476.403.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Editoriale
Pubblico impiego
Precariato nella scuola
La fine del precariato pubblico
ma non solo per la scuola
di Michele Miscione - Professore ordinario di Diritto del lavoro
Con la sentenza n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte costituzionale ha affermato che la legge sulla
“buona scuola” (L. n. 107/2015) “cancella” l’illecito comunitario sui precari, in particolare per il
personale docente che ha avuto possibilità immediata di contratto stabile, ma per il personale
non-docente (ATA), che non ha fruito del piano straordinario di assunzioni, resta la via del risarcimento. La Corte costituzionale dovrebbe aver dato una svolta decisiva al problema del precariato non solo della scuola, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni, cui necessariamente
le stesse regole dovranno essere estese per il principio d’uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione.
Illecito comunitario “cancellato”
dalla legge sulla “buona scuola”
Sembrava che la storia del precariato nella scuola
dovesse non finire mai, con rinvii e promesse sempre deluse. Sembrava destino inesorabile che i professori rimanessero “precari a vita” ed i ragazzi dovessero avere sempre “supplenti”. Il precariato della scuola è il più ampio e combattivo, ma di precariato è piena tutta la pubblica amministrazione
(P.A.), a partire dall’università, dove ormai sono
più numerosi gli insegnamenti anche fondamentali
coperti con supplenze, che quelli con professori “di
ruolo”; ma ci sono anche insegnamenti inutili. Il
problema non è né è mai stato di costi, perché nel
complesso le “supplenze” costano non meno e forse
più delle assunzioni stabili, né solo organizzativo
per la “continuità didattica”: il problema è soprattutto di resistenze per motivi più vari, sempre negativi, e giustificazione solo apparente con il principio del concorso ex art. 97, comma 4, Cost.
(1) Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072, Giur. it., 2016,
5, 1169 con nota di P. Tosi, Lavoro pubblico - Contratto a tempo
determinato - Il danno nel rapporto a termine del dipendente
pubblico; cfr. anche M. Miscione, Nomofilachia, Sezioni unite,
“diritto vivente” (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della Cassazione), in questa Rivista, 2016, 4, 329.
(2) In prec., ma per caso speciale (dipendenti a termine con
fondazioni lirico-sinfoniche): Corte cost. 11 dicembre 2015, n.
260, in questa Rivista, 2016, 2, 148 con nota di V. De Michele,
Le ragioni oggettive “retroattive” del contratto a termine nella
sentenza n. 260/2015 della Corte costituzionale.
(3) Corte Cost. 20 luglio 2016. n. 187, in www.cortecostitu-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Dopo i tentativi della Corte di Cassazione a sezioni
unite (1), ora s’è arrivati alla fine, o almeno così si
spera, nel 2016 (2) con la Corte Costituzionale in
reciproca collaborazione con il legislatore nazionale e la Corte Europea.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del
2016 (3), ha dichiarato illegittime le norme del
1999 (4) che prevedevano senza limiti e con rinnovi potenzialmente illimitati l’utilizzo di supplenze
per copertura di posti “vacanti e disponibili”; l’illegittimità è stata dichiarata - attraverso l’art. 117,
comma 1, Cost. che impone e così costituzionalizza
i vincoli dell’ordinamento comunitario - per violazione della clausola 5, comma 1 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, all. alla Dir. n.
1999/70/CE, come affermato dalla Corte europea,
proprio per lo stesso giudizio, con la sentenza “Mascolo” del 2014 (5).
Nel frattempo era intervenuto il legislatore nazionale con la L. n. 107 del 2015 sulla “buona scuola” (6), che ha fissato per i supplenti un massimo
zionale.it. La sentenza sarà commentata approfonditamente
nel prossimo fascicolo di questa Rivista.
(4) Art. 4, commi 1 e 11, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(5) Corte di Giustizia UE, Sez. III, 26 novembre 2014, cause
riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13, C-418/13, in questa Rivista, 2015, n. 2, 135 con nota di R. Nunin, “Tanto tuonò che
piovve”: la sentenza Mascolo sull’abuso del lavoro a termine nel
pubblico impiego.
(6) L. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ripubbl. in G.U. del 30 luglio 2015.
745
Sinergie Grafiche srl
Editoriale
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pubblico impiego
di 36 mesi anche non continuativi ed ha previsto
l’obbligo dei concorsi nel triennio per tutti i posti
vacanti e disponibili, con piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 - ma solo
per il personale docente - nel rispetto del principio
del concorso (automatismi su graduatorie formate
già su concorsi, “selezioni blande” con concorsi riservati).
Con la cit. sent. n. 187 del 2016, la Corte costituzionale ha confermato (7) che la legge sulla “buona
scuola” ha “cancellato le conseguenze della violazione” delle norme comunitarie e dell’art. 117
Cost.: pertanto, chi ha fruito delle chances della
legge sulla “buona scuola” null’altro potrà pretendere. Tuttavia il personale non-docente della scuola (“ATA”), escluso dal piano straordinario di assunzioni, potrà avere la misura alternativa dell’ordinario risarcimento dei danni.
La Corte costituzionale ha confermato, seguendo
ancora la Corte europea, che contro l’“abuso” del
precariato pubblico sono ammesse misure alternative, per cui è sufficiente l’applicazione di una sola
di esse: è sufficiente una “disciplina che garantisca
serie chances di stabilizzazione del rapporto”, oppure il risarcimento del danno.
La tutela specifica, consistente in “procedure di assunzioni certe anche nel tempo”, è sufficiente e
“cancella” l’illecito comunitario per il personale
docente. Per il personale ATA resta il risarcimento
dei danni, con necessità del “carattere non solo
proporzionato, ma anche sufficientemente energico
e dissuasivo per garantire la piena efficacia”.
È anche confermato, in modo assoluto, il divieto
di trasformazione a tempo indeterminato senza
concorso (8).
Contenzioso finito per il personale
docente ma ancora parzialmente aperto
per il non-docente
Il contenzioso dovrebbe cessare, quindi, per il personale docente che ha fruito di “serie chances di
stabilizzazione del rapporto” con la legge sulla
“buona scuola” (L. 107/2015). L’illecito comunitario è “cancellato” dal diritto sopravvenuto (L. n.
107/2015 sulla “buona scuola”).
Il contenzioso resta aperto, si ripete, per il personale ATA, che, escluso dal piano straordinario di as(7) Come già nel par. 79 della cit. sentenza Mascolo della
Corte UE, Sez. III, 26 novembre 2014.
(8) Corte cost. n. 187/2016, cit., che richiama conforme anche l’ordinanza n. 207 del 18 luglio 2013, con cui la stessa
Corte cost. dispose il rinvio pregiudiziale alla Corte europea.
(9) Punto 18.2 del “considerato in diritto” della cit. Corte
746
sunzioni, potrà chiedere la “misura ordinaria del risarcimento del danno” (9).
Va chiarito che la prima misura che comporta la
“cancellazione dell’illecito”, in alternativa al risarcimento dei danni, consiste nella previsione di
chances effettive ed immediate d’assunzione con tre
requisiti (solo presupposti): a) una legge che fissi
con certezza i tempi per coprire i posti “vacanti e
disponibili”, b) un piano straordinario di assunzioni
nell’immediato e c) una legge che ponga un limite
soggettivo alle supplenze anche non continuative
(i 36 mesi). I tre requisiti sono previsti dalla legge
sulla “buona scuola” per il personale docente, mentre per il personale ATA mancano le norme per
l’immediato, con possibilità quindi della “misura
ordinaria del risarcimento del danno”.
È confermato per tutti, docenti e ATA, il tetto dei
36 mesi anche non continuativi (art. 1, comma
131, L. n. 107/2015), a decorrere dal 1° settembre
2016 senza contare i periodi precedenti; andranno
comprese solo le supplenze nelle scuole statali, per
la copertura di posti vacanti e disponibili. Si tratta
quindi di tetto soggettivo solo per il futuro, per cui
i singoli non potranno superare per sommatoria i
36 mesi. In connessione, la stessa legge sulla “buona scuola” prevede l’obbligo di “indire” i concorsi
nel triennio (art. 1, comma 113 L. 107/2015), in
modo che oggettivamente un “posto vacante e disponibile” non sia coperto con supplenze per oltre
il triennio, salvo i tempi per espletare il concorso.
Si ricorda anche, a conferma dell’effettività della
misura, che la legge sulla “buona scuola” prevede
un finanziamento per il risarcimento (art. 1, comma 132, L. n. 107/2015): in tal modo, conclude la
Corte cost., anche per questo aspetto la legge sulla
“buona scuola” è “in linea con la normativa comunitaria”. Nemmeno una parola però sulla misura
del risarcimento, ricordando solo, come già cennato, i caratteri essenziali della “dissuasività, proporzionalità, effettività”.
Il problema era stato affrontato e risolto invece
dalle Sezioni Unite (10), che avevano ritenuto applicabile il risarcimento forfetario e senza onere
della prova da 2,5 a 12 mensilità del Collegato Lavoro 2010 (11). La Corte Cost., nella sentenza n.
187/2016, nemmeno nomina le Sezioni Unite ed il
cost. n. 187/2016.
(10) Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072, cit.: le Sezioni
unite non hanno potuto considerare il diritto sopravvenuto per
il principio della domanda (i fatti risalivano agli anni ‘90).
(11) L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Editoriale
Pubblico impiego
silenzio potrebbe sembrare contrasto: al contrario,
si deve ritenere che sia rinvio implicito.
Si potrà sempre discutere se il risarcimento forfetario del Collegato Lavoro 2010 corrisponda ai requisiti comunitari, più volte richiamati, di “dissuasività, proporzionalità, effettività”. S’è detto talvolta
che il risarcimento dovrebbe essere “punitivo”, per
far pagare una somma che scoraggi veramente ulteriori inadempienze. Insomma, per un esempio essenziale, se il risarcimento fosse 100 il colpevole
dovrebbe pagare 200 per indurlo a non ripetere
l’errore. Il problema però è che, se il pagamento superiore al risarcimento può essere giusto, non altrettanto giusto può sembrare che ne profitti il
danneggiato.
Le norme e la giurisprudenza comunitaria affermano però che tra i requisiti del risarcimento debba
esserci quello della “proporzionalità”, escludendo
arricchimenti oltre il danno subito. Inoltre con recentissima ordinanza la Cassazione ha rimesso alle
Sezioni Unite la questione se i danni punitivi siano o no in contrasto con l’ordine pubblico (12). La
questione è delicata, e di grande importanza generale, senza possibilità di eccezioni per singoli casi.
Il danno presunto e forfetario della sent. n.
5072/2016 (13) supera ogni difficoltà, a partire da
quella se sussista un danno quantificabile per i supplenti che hanno ricevuto il trattamento di legge;
né sembra prospettabile, quanto meno per genericità, danno da perdita di chances per mancata indizione dei concorsi. Se dunque la funzione nomofilattica della Cassazione continuerà a funzionare,
anche il contenzioso del personale ATA dovrebbe
diminuire se non cessare. Nell’immediato, la Cas-
(12) Cass., Sez. I, ord. interloc., 16 maggio 2016, n. 9978,
in Corr. giur., 2016, n. 7, 909 con nota di C. Scognamiglio, I
danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile. Cfr. inoltre,
A. Guarisio, Risarcimento «comunitario» integrale, dissuasione e
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
sazione s’è già uniformata riconoscendo il risarcimento forfetario del Collegato Lavoro 2010 a precari di altra amministrazione (14).
Necessaria ed inevitabile estensione
a tutte le altre amministrazioni
A questo punto resta il problema forse meno noto,
o meno urlato, dei precari delle altre P.A., come
quello della sentenza da ultimo citata (15).
Sarà inevitabile, per il principio d’uguaglianza (art.
3 Cost.) e per evitare un contenzioso di nuovo senza fine, che a tutti i dipendenti delle P.A. siano garantiti effettivamente concorsi in tempi fissi e certi, in modo da coprire i posti vacanti e disponibili
con dipendenti “di ruolo”; dovrà essere affermato e
garantito una volta per tutte il principio, su cui si
esprime in modo chiaro e deciso la Corte costituzionale, per cui nella P.A. un posto di lavoro fisso
non può essere coperto con personale sempre precario.
Il problema sarà di capire il significato di posto
“vacante e disponibile”, che dev’essere veramente
necessario, come confermato dalla ripetizione della
copertura finanziaria: il concorso è dovuto se il posto è necessario e non si afferma che se ne possa fare a meno se manca la copertura finanziaria.
Inoltre, sempre per il principio d’uguaglianza, dovrà essere esteso a tutti i dipendenti della P.A. il limite dei 36 mesi di precariato, con contratti a termine o di altro tipo. Il risarcimento per superamento dei 36 mesi non cancella l’illecito ed anzi lo
aggrava, con responsabilità comunitaria ed erariale.
danni punitivi, in Riv. giur. lav., 2016, 2, II, 125.
(13) Cass., SS.UU., n. 5072/ 2016, cit.
(14) Cass., Sez. lav., 18 luglio 2016, n. 14633, inedita.
(15) Cass. n. 14633/2016, cit.
747
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
Licenziamento discriminatorio
Il licenziamento discriminatorio
secondo la più virtuosa
giurisprudenza nazionale
di Daniela Izzi - Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Torino (*)
La fisionomia molto concreta assunta ormai anche nel nostro Paese dal diritto antidiscriminatorio è testimoniata da alcune recenti pronunce giurisprudenziali, concernenti tutte licenziamenti e
dal contenuto non scontato, anche se pienamente in linea con le fonti dell’Unione europea e
con le indicazioni della Corte di Giustizia. L’autrice mette in evidenza le affermazioni più delicate
e impegnative rese dai giudici nazionali (di legittimità e di merito) in occasione di tre controversie nelle quali il recesso del datore di lavoro è stato ritenuto in contrasto con i divieti di discriminazioni in base al genere, all’età e alla disabilità.
Premessa: le potenzialità del diritto
antidiscriminatorio nell’era del diritto
del lavoro derogabile
Il diritto antidiscriminatorio, da apparato regolativo a lungo trascurato e condannato ad un’esistenza
più virtuale che reale, dimostra ormai di poter fornire un rilevante contributo per la concreta affermazione di quella libertà e di quella dignità della
persona che lavora a fronte delle quali, secondo
l’art. 41, comma 2, della nostra Costituzione, le ragioni dell’economia sono costrette ad arretrare.
Nel nuovo secolo, com’è noto, si è registrata per il
diritto antidiscriminatorio una sopravvenuta centralità, che trova origine in diverse cause: in parte
e perlopiù cause endogene, collegate al consistente
ampliamento del raggio d’incidenza dei divieti di
discriminazione (1) e al loro parallelo affinamento
tecnico, grazie al significativo apporto del diritto
dell’UE; in parte cause esogene, dato che le discriminazioni sono state preservate dalle operazioni di
alleggerimento delle tutele compiute in nome della
flessibilità. Penso evidentemente alla riscrittura
dell’art. 18 Stat. lav. effettuata dalla L. n. 92/2012
(secondo una linea già anticipata l’anno prima dall’art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011)
e al baluardo che ha finito per rappresentare il licenziamento discriminatorio, divenuto oggetto
d’interpretazioni - a mio parere di dubbio fondamento - sia di segno iper-estensivo (alludo alla tesi,
rimasta piuttosto isolata in dottrina, secondo cui
qualunque licenziamento ingiustificato sarebbe discriminatorio (2)) che di segno iper-riduttivo (mi
riferisco alla ricostruzione del licenziamento discriminatorio in senso soggettivistico, con la pretesa
ricorrenza dell’animus discriminandi come motivo
unico determinante dell’atto, su cui tornerò fra
breve).
Proprio sul licenziamento discriminatorio intendo
focalizzare l’attenzione, considerati i numerosi dubbi che si addensano attorno a questa figura giuridica e le interessanti prospettive che si aprono su
questo fronte, com’è testimoniato da alcune recen-
(*) Lo scritto rielabora l’intervento svolto al Convegno nazionale del Centro Studi Domenico Napoletano Il capitale umano - Il diritto del lavoro al tempo della precarietà, tenutosi a Torino il 27 e 28 maggio 2016.
(1) Tale ampliamento è dovuto alla molteplicità dei caratteri
soggettivi ormai considerati dai divieti di discriminazioni, alla
loro attitudine a superare le coordinate classiche del diritto del
lavoro includendo anche lavoratori non subordinati, inoccupati
e disoccupati, oltre che allo specifico ruolo assegnato al principio di non discriminazione nella tutela dei lavoratori non standard (in particolare lavoratori a termine, a tempo parziale e
somministrati).
(2) M.T. Carinci, Il licenziamento discriminatorio o “per motivo illecito determinante” alla luce dei principi civilistici: la causa
del licenziamento quale atto unilaterale fra vivi a contenuto patrimoniale, in Riv. giur. lav., 2012, I, 641 ss.
748
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
ti pronunce giurisprudenziali. Sarà l’esame della
giurisprudenza nazionale a fare da filo conduttore
al mio discorso, con la considerazione di tre casi
nei quali sono emerse domande teoriche di non
scarso conto, a dimostrazione della fisionomia molto concreta e pervasiva assunta oggi anche nel nostro Paese dal diritto antidiscriminatorio.
L’oggettività della discriminazione
nel licenziamento di una lavoratrice
alla ricerca della maternità
La sentenza da cui mi pare doveroso partire, data
l’autorevolezza dell’organo da cui proviene e l’importanza dei chiarimenti offerti, è quella resa dalla
Corte di Cassazione il 5 aprile scorso nell’ambito
di una controversia concernente l’ipotesi classica
di discriminazione basata sul genere, ove però viene in rilievo l’inusuale situazione di assenza dal lavoro dovuta non alla gravidanza della lavoratrice
ma alla sua sottoposizione a cicli d’inseminazione
artificiale: quindi una condizione di gravidanza solo potenziale, ma comunque, al pari della gravidanza, esclusivamente propria del genere femminile (3).
A seguito del licenziamento che colpisce la donna,
motivato con ragioni di carattere sia economicoorganizzativo che disciplinare, e dei ricorsi promossi dalle parti interessate, i giudici di legittimità si
trovano a dover sciogliere diversi nodi: stabilendo
se le giustificazioni oggettive e soggettive fornite
per il licenziamento possono escluderne la portata
discriminatoria; qual è il rapporto tra licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo; se è
possibile che il carattere oggettivo delle discriminazioni imposto dal diritto dell’Unione e codificato
nella legislazione interna conviva con la ricerca
dell’intento soggettivo di chi adotta il provvedimento sfavorevole; infine, che cosa deve provare il
lavoratore che denuncia la natura discriminatoria
del licenziamento subito, accompagnato dall’indicazione del giustificato motivo prescritto dalla legge.
A tutte queste domande la recente pronuncia di
Cassazione fornisce risposte, per nulla scontate, a
mio parere pienamente soddisfacenti perché sgombrano il campo da equivoci interpretativi che sono
andati sviluppandosi in giurisprudenza per la difficoltà di misurarsi con le specificità del diritto anti(3) Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, in banca dati Pluris. Per
un’approfondita analisi di questa pronuncia v. ora M.V. Ballestrero, Tra discriminazione e motivo illecito: il percorso acciden-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
discriminatorio e con i vincoli posti in materia dalle fonti europee.
Nella nostra giurisprudenza persiste infatti la tendenza ad assimilare al licenziamento discriminatorio, cioè determinato da uno dei fattori di rischio
posti a base dei vigenti divieti di discriminazione
(come il genere), il licenziamento ritorsivo o di
rappresaglia, cioè determinato da un’ingiusta ritorsione rispetto ad un comportamento legittimamente tenuto dal lavoratore, censurabile in quanto viziato dal motivo illecito unico e determinante previsto dall’art. 1345 c.c. In virtù di quest’assimilazione, il licenziamento discriminatorio viene spesso
ancor oggi ritenuto un atto intenzionale, la cui illiceità viene cioè a dipendere dalla prova fornita dal
lavoratore in ordine all’intento discriminatorio del
datore di lavoro, che deve potersi qualificare come
motivo unico e determinante del recesso.
È proprio questa l’impostazione respinta con nettezza dai giudici di legittimità con la sentenza n.
6575/2016, che coglie e sottolinea l’autonomia del
licenziamento discriminatorio rispetto a quello ritorsivo, la natura necessariamente oggettiva del
primo e il rapporto d’indipendenza stabilito dallo
stesso legislatore (nell’art. 3 della L. n. 108/1990 e
nel riscritto art. 18, comma 1, Stat. lav.) tra le motivazioni che accompagnano il licenziamento e la
ricorrenza di una discriminazione. Priva di fondamento viene quindi giudicata dalla Cassazione la
tesi secondo cui “la natura discriminatoria del licenziamento sarebbe esclusa dalla esistenza del motivo economico” dedotto nella comunicazione del
provvedimento.
Di conseguenza, non si può ritenere che il lavoratore che contesta la portata discriminatoria del licenziamento debba dimostrare l’insussistenza dei
fatti dedotti a giustificazione del recesso (perché
ciò significherebbe rovesciare la regola probatoria
fissata dalla L. n. 604/1966), e neppure il carattere
unico ed esclusivo delle ragioni discriminatorie;
suo onere, in forza del regime probatorio agevolato
previsto per le discriminazioni, e opportunamente
richiamato dalla Cassazione, è invece la semplice
allegazione di elementi capaci di convincere prima
facie il giudice del collegamento obiettivamente
esistente tra il licenziamento e uno dei fattori protetti dai divieti di discriminazione. Nulla di più.
Nella sentenza n. 6575/2016 si spiega che l’assimilazione tra licenziamento ritorsivo e licenziamento
tato della reintegrazione, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2016, 231
ss.
749
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
discriminatorio viene generalmente compiuta per
estendere al primo le tutele previste per il secondo,
per cui a monte del cattivo risultato della connotazione in senso soggettivo della discriminazione vi
sarebbe una buona intenzione. A questo proposito
occorre tuttavia distinguere: da un canto, infatti,
stanno le ipotesi in cui il motivo della ritorsione è
un fattore protetto dai divieti di discriminazione,
nelle quali non si realizza alcuna estensione perché
è già lo stesso diritto interno, sulla scorta di quello
europeo, a qualificare espressamente l’atto ritorsivo
come discriminatorio (si v. a conferma, con riferimento al genere, l’art. 26, comma 3, D.Lgs.
198/2006) (4); dall’altro, invece, stanno le ipotesi
in cui il motivo della ritorsione non è un fattore
protetto dai divieti di discriminazione, ove l’estensione può avvenire a prezzo di rinnegare la tesi della tassatività dei motivi posti a base dei divieti di
discriminazione, tesi al momento dominante e a
mio parere solidamente fondata, ma messa in discussione da una parte della dottrina (5) valorizzando il riferimento alle “condizioni sociali” contenuto nell’art. 3, comma 1, Cost. e l’espressione “in
particolare” che nell’art. 21.1 della Carta dei diritti
fondamentali precede l’indicazione dei possibili
motivi di discriminazione.
Le implicazioni del principio di non
discriminazione per età nel licenziamento
di un lavoratore intermittente
Il secondo caso giurisprudenziale concernente un
licenziamento discriminatorio su cui voglio soffermare l’attenzione, mentre si è in attesa della sua
conclusione definitiva, è quello che vede contrapposti la società italiana detentrice del noto marchio di abbigliamento statunitense Abercrombie e
un giovane magazziniere assunto con contratto di
lavoro intermittente a tempo indeterminato stipulato in ragione della sua età, ovvero collegato alla
condizione soggettiva di infraventicinquenne, secondo quanto previsto all’epoca dei fatti controversi dal D.Lgs. n. 276/2003 (all’art. 34, comma 2)
e oggi dal D.Lgs. n. 81/2015 (all’art. 13, comma 2).
La risoluzione del contratto effettuata dalla società
Abercrombie per l’avvenuto compimento dei 25 an(4) Sono queste le ipotesi di “falsa interpretazione estensiva
dei divieti di discriminazione”, emblematicamente rappresentate dalla figura (ben nota ai giudici) del licenziamento di rappresaglia per motivi sindacali: così M. Barbera, Il licenziamento
alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. it. dir. lav., 2013, I,
161 ss.
(5) In primis da A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro.
Nozione, interessi, tutele, Padova, 2010, 105 ss.; ma cfr. anche
750
ni da parte del lavoratore è stata contestata giudizialmente quale licenziamento discriminatorio in
base all’età, formulandosi la richiesta di reintegrazione e di risarcimento del danno ai sensi dell’art.
18, comma 1, St. lav. Tale richiesta ha trovato accoglimento (non in primo grado ma) dinanzi alla
Corte d’Appello di Milano con sentenza del 15
aprile 2014 (6), oggetto del ricorso per Cassazione
dal quale ha tratto origine l’ordinanza del 29 febbraio scorso di rimessione alla Corte di Giustizia
della questione pregiudiziale concernente la compatibilità della nostra disciplina sul job on call per
ragioni anagrafiche col principio uni-europeo di
non discriminazione in base all’età (7).
Diverse sono le domande sollevate da questa controversia. Si tratta infatti di capire, in primo luogo,
se la disparità di trattamento fondata sull’età del
lavoratore può essere giustificata dalla ricorrenza di
una finalità legittima, perseguita con mezzi adeguati e necessari, secondo i criteri stabiliti dall’art. 6
della Dir. n. 2000/78 e riproposti nell’art. 3, comma 4 bis, D.Lgs. n. 216/2003, oppure integra una
discriminazione. Nel caso in cui sia esclusa la giustificabilità del trattamento differenziato, occorre
poi verificare se può essere ritenuto responsabile
per licenziamento discriminatorio il datore di lavoro che, nella fase conclusiva del rapporto contrattuale come in quella genetica, si è scrupolosamente
attenuto alla disciplina italiana del lavoro intermittente, e al quale quindi non si può imputare la
volontà e probabilmente neppure la consapevolezza
di realizzare una discriminazione a danno dei giovani. Infine, risulta necessario comprendere se il
legittimo affidamento riposto dal datore di lavoro
nella validità della disciplina nazionale, ritenuta a
posteriori non conforme al diritto dell’Unione, può
essere sacrificato sull’altare dell’efficacia diretta del
divieto di discriminazioni per età, considerato che
tale divieto è stabilito da una fonte - la Dir. n.
2000/78 - per sua natura dotata di efficacia indiretta e abilitata tutt’al più a produrre effetti diretti
nei rapporti di tipo verticale (tra cittadino e Stato
membro) ma non anche di tipo orizzontale (tra
soggetti privati).
M. Barbera, op. cit., 148 s.
(6) App. Milano 15 aprile 2014, n. 406, in Riv. it. dir. lav.,
2015, II, 534 ss. Per una più ampia riflessione in proposito v.
D. Izzi, Il lavoro a chiamata per ragioni anagrafiche è messo fuori
gioco dal diritto dell’Unione europea?, in www.giustiziacivile.com, n. 6/2015.
(7) Cass. 29 febbraio 2016, n. 3982 (ord.), in Wikilabour.it.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
Il problema della compressione subita dal legittimo
affidamento del datore di lavoro, del resto, risulta
ridimensionato se si considera, come hanno fatto i
giudici milanesi, il carattere rigorosamente oggettivo dei divieti di discriminazione, che rende rilevante ai fini della realizzazione dell’illecito discriminatorio non la volontà né la consapevolezza di
penalizzare un giovane, ma semplicemente il trattamento pregiudizievole inflitto ad un giovane in
ragione della sua età.
Alla luce di quanto osservato mi pare quindi che il
contenuto di entrambe le decisioni attese per la
conclusione della vicenda Abercrombie - quella della Corte di Giustizia, prima, e della Corte di cassazione, poi - si possa ritenere in larga misura annunciato. Se le mie previsioni sulla tenuta della costruzione eretta dai giudici d’appello milanesi non sono
errate, ci si troverà perciò presto davanti ad un’altra nitida dimostrazione dei risultati molto consistenti ormai conseguibili mediante il diritto antidiscriminatorio.
La Corte d’Appello di Milano ha affrontato in termini pienamente condivisibili tutti questi profili,
rispettando i vincoli interpretativi risultanti dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Particolarmente scottante è la questione del sacrificio che la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento possono subire in nome dell’efficacia diretta del divieto di discriminazioni fondate
sull’età, nei termini molto forti in cui tale divieto
è stato ricostruito dalle sentenze Mangold e Kücükdeveci (8), generate da controversie coinvolgenti
lavoratori privati e quindi, proprio come nel caso
Abercrombie, rapporti di tipo orizzontale. In quelle
decisioni la Corte di giustizia ha superato il limite
dell’incapacità di una fonte secondaria di spiegare
efficacia diretta in senso orizzontale sostenendo
che il divieto di discriminazioni in base all’età, pur
essendo espresso dalla Dir. n. 2000/78, trova invero
la sua origine nel principio di non discriminazioni
per età sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti
fondamentali, cioè in una norma di diritto primario, ad effetto diretto in senso sia verticale che
orizzontale.
Fedele a quest’impostazione, la Corte d’Appello
milanese ha perciò ritenuto che il diritto a non essere penalizzati a causa del compimento di una determinata età deve essere garantito anche all’interno del rapporto orizzontale intercorrente tra il giovane magazziniere e la società Abercrombie, ritenendo quest’ultima responsabile di licenziamento
discriminatorio. La correttezza della scelta compiuta dai giudici di secondo grado pare trovare sicura
conferma con la recente sentenza resa dalla Corte
di Giustizia nel caso Dansk Industri v. Rasmussen (9). Qui infatti, proprio con riguardo ad una
controversia tra soggetti privati, la Corte ha chiarito che il giudice nazionale non può basarsi sul
principio della tutela del legittimo affidamento
“per continuare ad applicare una norma di diritto
nazionale contraria al principio generale della non
discriminazione in ragione dell’età”, perché così facendo finirebbe per negare proprio a chi ha intrapreso l’azione giudiziale il beneficio dell’interpretazione accolta dalla Corte (10).
L’ultimo caso sul quale mi pare utile riflettere è
quello affrontato dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 16 aprile 2015, che concerne la qualificazione giudiziale come licenziamento discriminatorio in base alla disabilità del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo intimato ad una lavoratrice divenuta fisicamente inidonea allo svolgimento delle mansioni cui era adibita (11). Si
tratta, a quanto mi consta, della prima occasione
nella quale le regole contro le discriminazioni basate sull’handicap stabilite dalla Dir. n. 2000/78
hanno ricevuto applicazione nel nostro Paese nei
termini intensamente protettivi indicati dalla
Corte di Giustizia nella sentenza HK Danmark (12), che costituisce in materia un’autentica
pietra miliare.
In questa pronuncia infatti, valorizzando due contenuti centrali della Convenzione delle Nazioni
(8) Corte di Giustizia UE 22 novembre 2005, causa C144/04, Mangold c. Helm; Corte di Giustizia UE 19 gennaio
2010, causa C-555/07, Kücükdeveci c. Swedex GmbH. Tra i numerosi contributi dedicati a valutare la portata di queste pronunce sia consentito rinviare a D. Izzi, La Corte di Giustizia e le
discriminazioni per età: scelte di metodo e di merito, in Riv. giur.
lav., 2012, I, 125 ss.
(9) Corte di Giustizia UE 19 aprile 2016, causa C-441/14,
DansK Industri c. Successione Rasmussen.
(10) Così ai punti 38 e 41 della motivazione di DansK Indu-
stri, cit.
(11) Trib. Pisa 16 aprile 2015 (ord.), in Arg. dir. lav., 2016, II,
164, con nota critica di V. Cangemi, Riflessioni sul licenziamento per inidoneità psico-fisica: tra ingiustificatezza e discriminatori
età, ivi, 169 ss. La controversia si è conclusa con una conciliazione in sede di opposizione alla cit. ordinanza e quindi senza
essere sottoposta al vaglio di altri giudici.
(12) Corte di Giustizia UE 11 aprile 2013, cause riunite C335/11 e C-337/11, HK Danmark per conto di Ring e Skoube
Werge.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Licenziamenti per inidoneità
sopravvenuta e divieti di discriminazione
in base alla disabilità: una frontiera che
inizia ad essere esplorata
751
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
Unite sui diritti delle persone con disabilità (13),
la Corte di Lussemburgo ha, da un lato, segnato
l’apertura ad una concezione dinamico-sociale, anziché medico-individuale, di disabilità (14); dall’altro, ha avallato una lettura estensiva e rigorosa dell’obbligo per il datore di lavoro di adottare le cosiddette soluzioni ragionevoli, cioè quegli accomodamenti che, senza comportare a suo carico un
onere finanziario sproporzionato, sono necessari
per consentire ai disabili di superare il loro specifico impedimento, e quindi di accedere ad un lavoro
o di conservarlo, e che comprendono non solo interventi di carattere tecnico-materiale, come il
riallestimento della postazione di lavoro e la sostituzione delle attrezzature, ma anche interventi di
carattere organizzativo, come la redistribuzione delle mansioni, la riduzione o rimodulazione dell’orario di lavoro, o il cambiamento dei turni.
Tenendo conto di queste importanti precisazioni il
Tribunale di Pisa, verificata la condizione di disabilità della lavoratrice e la possibilità per il datore
di lavoro di superare senza oneri eccessivi la sua limitazione fisica attraverso una redistribuzione di
compiti tra l’interessata e alcuni colleghi, ha censurato l’inadempimento dell’obbligo di provvedere
agli accomodamenti ragionevoli stabilito dall’art.
3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216/2003 e ha giudicato
discriminatorio il licenziamento collegato alla disabilità, condannando la società alla reintegrazione
della lavoratrice e al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale per la discriminazione subita. È stata così realizzata, in linea con le
fonti sovranazionali e quindi del tutto correttamente, una saldatura tra il mancato adempimento
datoriale dell’obbligo di adozione degli accomodamenti ragionevoli e la violazione del divieto di discriminazioni basate sulla disabilità.
A questa “chiusura del cerchio” non è giunto invece il Tribunale di Ivrea con l’ordinanza resa in
un’analoga controversia il 24 febbraio scorso, che
ha infatti sanzionato con il cd. regime di tutela
reale attenuata (ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 7)
il licenziamento di una lavoratrice la cui sopravvenuta inidoneità avrebbe potuto essere risolta con
una modifica, a costi contenuti, della sua postazione lavorativa (15). La recente pronuncia piemontese pare comunque molto lucida laddove evidenzia, in sintonia col precedente pisano, l’incisivo
condizionamento che l’obbligo delle soluzioni ragionevoli per i disabili è destinato a spiegare sul
potere di recesso del datore di lavoro, ponendo a
suo carico l’onere di dimostrare di non aver potuto
rimediare alla situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa neppure attraverso modifiche, a costo ridotto, della sua organizzazione aziendale.
Come è già stato puntualmente rilevato (16), la tutela apprestata a favore delle persone disabili dal
D.Lgs. n. 216/2003 finisce così per infrangere in
questo specifico ambito il dogma (rafforzato invece
sotto diversi profili dalle recenti riforme) dell’intangibilità e insindacabilità delle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro, mettendo in
discussione la consolidata giurisprudenza nazionale
in tema di licenziamenti per sopravvenuta inidoneità psico-fisica del lavoratore.
Insomma, profondi sono i cambiamenti che la progressiva assimilazione dei concetti chiave del diritto antidiscriminatorio europeo è in grado di provocare nella gestione dei rapporti di lavoro del nostro
Paese, nella fase della loro estinzione, come ho cercato di mostrare in questa sede, ma non soltanto.
C’è da augurarsi che quanti giocano un ruolo strategico nella produzione della cultura giuridica italiana riescano a cogliere al meglio quest’opportunità.
(13) Vale la pena ricordare che la Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità adottata dalle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006 è stata ratificata dall’Unione europea con la decisione n. 2010/48.
(14) La disabilità viene definita come una duratura “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali
o psichiche”, eventualmente provocata da una malattia, “che,
in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la
piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla
vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (così al punto 38 della motivazione di HK Danmark, cit.).
Sull’evoluzione intervenuta nei modelli medico-scientifici e giu-
ridici di disabilità v. M. Pastore, Disabilità e lavoro: prospettive
recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. dir.
sic. soc., 2016, 199 ss.
(15) Trib. Ivrea 24 febbraio 2016 (ord.), in RGLNews, n.
2/2016, 10 s.
(16) Da S. Giubboni, Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione dopo la legge Fornero e il Jobs Act, in
WPCSDLE “Massimo D’Antona.IT”, 261/2015, 8-14. In proposito cfr. anche R. Voza, Sopravvenuta inidoneità psicofisica e licenziamento del lavoratore nel puzzle normativo delle ultime riforme, in Arg. dir. lav., 2015, I, 781 ss.
752
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Lavoro subordinato
Dimissioni
Dimissioni, nuova forma
smaterializzata ad substantiam
e diritto al ripensamento
di Marco Frediani - Avvocato in Vasto
Il nuovo regime delle dimissioni, oltre a complicare immotivatamente le cose a lavoratore e datore di lavoro, rappresenta una svolta giuridica sul concetto di forma ad substatiam di un atto
giuridico e sull’irrevocabilità delle dichiarazioni unilaterali di volontà.
Forma telematica ad substantiam
Sino al 12 marzo 2016 la forma ad substantiam di
un atto giuridico riconosciuta nel nostro ordinamento era la forma scritta, intesa di solito come atto materiale firmato di pugno dal titolare del diritto.
A seguito del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 l’unica forma lecita e legittima ed efficace per rendere
le dimissioni è quella consegnata alle comunicazioni digitali o informatiche che dir si voglia sebbene
debitamente certificate: “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte,
a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità
telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (art.
26).
La smaterializzazione dell’atto giuridico cui affidare
la dichiarazione di volontà pertanto si affianca alle
tradizionali forme dell’atto pubblico e della scrittura privata sancite dall’art. 1350 c.c.
Nella sostanza la comunicazione informatica o digitale della volontà si pone nel mezzo tra le due
forma tradizionali: vale un po’ di più della scrittura
privata e, forse, un po’ di meno dell’atto pubblico.
La differenza, però attiene all’efficacia della nuova
forma. Ed infatti laddove il decreto prevede le nuove dimissioni informatiche come unica forma valida e ammessa dall’ordinamento (e quindi interviene sulla validità del negozio giuridico) in realtà dichiara implicitamente l’inefficacia della scrittura
(1) Art. 1, comma 2 “Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
privata pur con il medesimo contenuto anche laddove il lavoratore non abbia alcun interesse alla
prosecuzione degli effetti giuridici del rapporto.
Se è pur vero che il problema ha sempre riguardato
non tanto l’originalità della sottoscrizione quanto
la genuinità della datazione e del contenuto della
dichiarazione contenuta nelle dimissioni, la nuova
forma, nell’eliminare la necessità della sottoscrizione in originale (richiesta nella previgente disciplina con ratifica in calce alla trasmissione telematica
datoriale) la dà per accertata e certificata (e quindi
non più necessaria) con l’utilizzo dei pin personali
d’ingresso al portale INPS (ovvero attraverso l’utilizzo dei mediatori di turno), si concentra unicamente sul contenuto.
A parere dello scrivente le problematiche connesse
alla riferibilità al diretto interessato della dichiarazione di volontà trasmessa elettronicamente non
trovano comunque soluzione anche e soprattutto
laddove gestita da terzi.
Il perimetro di applicazione
Diversamente da quanto previsto dalla L. 17 ottobre 2007, n. 188, che disciplinava specifiche modalità per le dimissioni da rassegnare non solo da parte dei lavoratori subordinati in senso stretto ma anche da parte dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di rapporti di associazione in partecipazione e dei titolari di contratti
di lavoro di natura cooperativistica (1), il D.Lgs. n.
subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i con-
753
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
151/2015, al pari della L. n. 92/2012, fa unicamente riferimento alla fattispecie del lavoro subordinato. Tanto è stato confermato dal Ministero del Lavoro nella risposta alla FAQ n. 4 con riferimento
al punto 1.1 della circ. min. n. 12/2016.
Pertanto l’introdotta compressione del principio
della libertà di forma delle dichiarazioni di volontà
incide esclusivamente nell’alveo del lavoro subordinato.
La mancata formalizzazione telematica
L’obbligatorietà della forma telematica, che vince
sia sulla forma scritta che sul comportamento concludente del lavoratore, è stata ribadita dal Ministero del Lavoro con la FAQ 33 quale prima risposta ad una serie di quesiti formulati dai consulenti
del lavoro: “Q. Se il lavoratore rassegna le proprie
dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la
prevista procedura online, il datore di lavoro come
si deve comportare? A. Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal
DM 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di
lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.” (2).
Come però il datore di lavoro possa procedere senza alcuna insidia ad una valida risoluzione del rapporto non è dato sapere. Si dubita che la mancata
formalizzazione telematica di dimissioni rese per
iscritto possa di per sé stessa ricoprire valenza disciplinare, intercettando peraltro l’eventuale riconoscimento dell’indennità di preavviso. Difficilmente
ipotizzabile sarebbe pure la contestazione di un’assenza ingiustificata a fronte di una dichiarazione di
volontà risolutiva che, comunque, preclude l’esercizio del potere disciplinare sempreché non si voglia sposare la tesi estremista per cui qualsiasi comunicazione scritta del lavoratore tamquam non esset neanche a fini meramente giustificativi. È pur
vero, però, che tale soluzione sarebbe speculare a
quella ormai considerata adottabile nel caso in cui
il lavoratore rifiuti la revoca del licenziamento comunicata ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2015,
n. 23. In tali casi, infatti, il lavoratore che non riprende servizio all’esito della revoca, ed in quanto
“il rapporto di lavoro s’intende ripristinato senza
soluzione di continuità”, viene considerato assente
ingiustificato e pertanto perseguibile disciplinarmente.
tratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549
del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili
siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti
754
Ciò nonostante nei casi di forma richiesta ad substantiam la sua mancata osservanza determina la
radicale nullità del negozio concluso. Pertanto la
nullità delle dimissioni rese in “forma tradizionale”
determinerebbe la persistenza del rapporto di lavoro. Il Ministero nella FAQ 33 suggerisce ai datori
di lavoro, infatti, la rescissione e non la risoluzione
del rapporto di lavoro. Sebbene una rescissione di
carattere tecnico sia difficile da ipotizzare in questi
casi, nella sostanza il Ministero suggerisce la praticabilità di un licenziamento per giustificato motivo
oggettivo “per lesione”. Articolazione del recesso a
parte, v’è da considerare che la procedura obbligatoria introdotta dall’art. 7, L. n. 604/1966 riformato per i licenziamenti oggettivi dilaterebbe estremamente i tempi di un evento risolutivo che in
precedenza aveva natura istantanea. La forma diventa sostanza e prevale sulla volontà negoziale.
Diritto al ripensamento e potestà
di revoca dell’atto risolutorio
La nuova normativa, inoltre continua a prevedere (3) un assai strano diritto al ripensamento proprio in origine del solo codice del consumatore
(art. 26, comma 2). L’idea di fondo è la medesima:
i consumatori come il lavoratore sono parti deboli
del rapporto contrattuale e pertanto debbono essere meglio tutelati. In realtà introdurre un diritto al
ripensamento in un atto unilaterale recettizio scardina il concetto stesso di dichiarazione di volontà
e di diritto potestativo. A termine di codice civile
l’atto giuridico può essere revocato solo se è comunicato al datore di lavoro prima che quest’ultimo
abbia avuto notizia dell’atto di recesso (art. 1328
c.c.). Oggi per le dimissioni telematiche astrattamente “più sicure e genuine”, questo principio non
vale più. Ho facoltà dopo una settimana sabbatica
di revocare la mia dichiarazione e ripresentarmi legittimamente al lavoro.
Possiamo distillarne due conseguenze: a) la dichiarazione di volontà consegnata ai flussi telematici
non ha quella fermezza e definitività proprie della
scrittura privata tradizionale; b) l’esercizio di un diritto potestativo esercitato attraverso la forma telematica, a differenza di quella fisica, può essere revocato.
di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.”.
(2) Sul sito www.cliclavoro.gov.it del 7 aprile 2016.
(3) Il diritto al ripensamento era infatti stato già introdotto
dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 al comma 21 dell’art. 4 che permetteva di travolgere anche eventuali pattuizioni “aggiuntive”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Lavoro subordinato
A parte il fatto che tale nuovo panorama si scontra
con i consolidati giurisprudenziali maturati sul
punto (4), ci si domanda se scaduti i sette giorni
per il ripensamento si possano ancora esperire le
azioni di annullabilità per vizi del consenso (previste dall’art. 1324 c.c.) ovvero queste risultino precluse dall’esaurimento del termine “infrasettimanale” del comma 2 dell’art. 26.
In verità un parallelo diritto di ripensamento la L.
n. 92/2012 l’aveva introdotto in favore anche del
datore di lavoro consentendo la revoca unilaterale
del licenziamento senza necessità del consenso del
lavoratore (5) (art. 1, comma 42 oggi riprodotto
nell’art. 5 del D.Lgs. n. 23/2015). L’unico elemento da rispettare a tutt’oggi è di ordine temporale: la
revoca per essere efficace deve intervenire entro
15 giorni dall’impugnazione del licenziamento presentata dal lavoratore.
Nulla è previsto in ordine alla forma utile a rendere efficace e valida tale revoca ma è evidente che
questa debba rivestire semplicemente la stessa forma dell’atto risolutivo. In tale prospettiva è facile
avvedersi di un’asimmetria delle forme negoziali
previste per una stessa tipologia di atti unilaterali:
forma telematica per i prestatori e forma scritta per
i datori.
Tolleranza ed istituzionalizzazione
dei comportamenti contraddittori
Nella sostanza il nostro ordinamento ha introdotto
in materia di lavoro il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo. Tanto, come noto,
rappresenta un’eccezione ai principi di teoria generale del diritto. Ed infatti un’elementare bisogno di
buona fede e rispetto per gli affidamenti creati esige, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., che la dichiarazione risolutoria impegni il dichiarante. Sicché la disponibilità dell’effetto risolutivo non può
non ritenersi comunque contraria a buona fede
laddove il contegno di chi dapprima innesca il
meccanismo risolutorio, manifestando di voler liberare l’altro contraente, intenda nuovamente obbligarlo. Né è possibile in alcun modo presumere,
nei casi passati in rassegna nel paragrafo precedente, il consenso della controparte alla conservazione
del contratto o un interesse alla sua prosecuzione.
(4) Cass. 22 dicembre 2003, n. 19623, Varriale c. Poste Italiane S.p.a., in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, 415; Id., 29 agosto
2003, n. 12677, Giansante c. Soc. Poste italiane, in Gius, 2004,
n. 4, 542.
(5) Prima della Legge Fornero il datore di lavoro poteva pur
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
La ritrattazione della volontà risolutoria pone nel
nulla la risoluzione o meglio la dichiarazione unilaterale di volontà estintiva precedentemente espressa. Ed infatti incide sull’effetto risolutivo solo indirettamente in quanto revoca la revoca del consenso originariamente prestato. Ciò, in termini generali, consente di escludere che il comportamento
contraddittorio sia sempre censurabile non esistendo più il divieto assoluto di venire contra factum
proprium. Ma l’infranto principio potrebbe determinare conseguenze chiaramente paradossali in quanto la revoca può essere utilizzata all’infinito: revoca
della revoca della revoca e così via dicendo. È evidente che si tratta di una mera esasperazione retorica ma è pur vero che “qualsiasi arnese diventa
un’arma se lo si maneggia bene”.
Derive patologiche
A parte i problemi organizzativi aziendali che il diritto al ripensamento comporta, vi è anche un
aspetto legato ad un suo utilizzo contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale che deve far riflettere. Si fa riferimento al caso del dipendente che per beneficiare di una settimana di ferie
non concesse o difficili da ottenere ovvero per prolungarne la durata ovvero ancora per nascondere
una misura di restrizione provvisoria della libertà
disposta dall’Autorità Giudiziaria utilizzi le dimissioni revocabili come stratagemma per disporre
unilateralmente la sospensione temporanea del
rapporto.
La prova della mala fede, e quindi un licenziamento disciplinare, sarebbe impossibile anche perché il
ripensamento come le dimissioni sono atti acausali
e come tali insindacabili.
Non solo ma anche datori di lavoro non particolarmente corretti potrebbero indurre i propri fidi dipendenti (magari familiari) ad utilizzare le dimissioni a mo’ di fisarmonica per contenere l’esborso
in chiaro in busta paga e la conseguente contribuzione.
La preclusione delle dimissioni rese
in sede giudiziale
Inoltre la disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
151/2015 sembrerebbe escludere la possibilità di
rendere le dimissioni persino in sede giudiziale. Ed
sempre revocare il licenziamento comminato ma era indispensabile che il lavoratore comunque prestasse il proprio consenso alla ricostituzione del rapporto. La revoca infatti si configurava quale nuova proposta di lavoro che necessitava dell’accettazione.
755
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
infatti il comma 7 dell’art. 26 esclude l’applicabilità della procedura telematica (oltre che per i rapporti di lavoro domestico) solo “nel caso in cui le
dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di
certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003”. Pertanto, facendo l’art.
2113 riferimento solo agli artt. 185, 410, 411, 412
ter e 412 quater, ne rimangono esplicitamente ed
immotivatamente escluse le transazioni giudiziali ai
sensi dell’art. 420 c.p.c.
Tale problematica renderà sicuramente più complesse le conciliazioni di contenziosi che potevano
essere risolti immediatamente con la risoluzione
consensuale del rapporto o con la formalizzazione
delle dimissioni. Ed infatti il primo comma dell’art.
26 parla di dimissioni “fatte, a pena di inefficacia
esclusivamente con modalità telematiche”. Pertanto le dimissioni, al pari delle risoluzioni consensuali, affidate ad un verbale di conciliazione giudiziale
sarebbero affette da “inefficacia” (6).
Si potrebbe obiettare che nel verbale di conciliazione il problema sarebbe facilmente risolvibile
mediante previsione di apposita clausola che imponga alla parte o alle parti l’adempimento telematico. Ma in ogni caso sino a che non venisse assolta tale formalità le dimissioni indubbiamente risulterebbero, comunque, tamquam non esset con problemi in ordine alla loro decorrenza ed ai pagamenti collegati.
Per ovviare poi al pericolo non peregrino che, risolto il contenzioso ed abbandonata la causa, non
venga dato seguito alla comunicazione telematica
si potrebbe prevedere inoltre per il caso di inadempienza la risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro. Ciò nonostante tali soluzioni appaiono sovrastrutture eccessive laddove il lavoratore trovasi in
contesto protetto sia perché assistito da un tecnico
del diritto di fiducia sia perché confortato dalla
presenza di un giudice.
In conclusione la risoluzione del rapporto, sia essa
unilaterale o consensuale, non può più rappresentare, se non con le difficoltà pratiche sopra appena
accennate, merce di scambio per la conciliazione
del contenzioso.
(6) Tanto è stato ribadito dalla circolare n. 12 del 4 marzo
2016 del Ministero del Lavoro: “La nuova modalità di cui all’articolo 26 del decreto legislativo numero 151 del 2015 si applica tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di ri-
soluzione consensuale di cui all’articolo 1372, comma 1, del
codice civile, per i quali si introduce la medesima ‘forma tipica’
del modulo adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015.”.
756
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Controversie del lavoro
Spese di giustizia
Le spese di giustizia nel giusto
processo del lavoro tra legge
e prassi ministeriale
di Vincenzo De Michele e Sergio Galleano (*)
Nel 2011 il processo del lavoro, che prevedeva in base ad una norma del 1958 l’esonero da ogni
spesa e tassa anche per le imprese e i datori di lavoro che richiedevano l’accesso alla magistratura specializzata, diventa soggetto all’obbligo del contributo unificato, secondo le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia fissate dal d.P.R. n. 115/2002. Ma ciò
avviene solo in ragione del superamento di una determinata soglia di reddito personale, sufficientemente elevata in guisa tale da garantire che la regola, per la gran parte delle parti ricorrenti davanti al giudice del lavoro, anche in Cassazione, sia quella della gratuità del processo, così
come, iniquamente, il processo del lavoro è sempre gratuito per tutte le pubbliche amministrazioni. Gli Autori sostengono che la Circolare del 14 maggio 2012 del Ministero della Giustizia
stravolge le disposizioni introdotte per regolamentare l’accesso non gratuito al processo del lavoro sia per i lavoratori che per le imprese, trasformando, con un’interpretazione contra legem
in favore delle finanze erariali e della deflazione del contenzioso soprattutto in Cassazione, il processo speciale in giudizio iniquo e costoso nei confronti dei soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, vere responsabili del proliferare delle cause e del caos giudiziario in materia di
pubblico impiego e previdenza.
Il contributo unificato per le parti private
nel processo del lavoro secundum ius
Prendiamo lo spunto dall’editoriale del prof. Miscione (1) a commento dello stato della giustizia civile attraverso la lettura che ne fa il Primo Presidente della Cassazione nella sua Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario il 28 gennaio
2016, per affrontare un argomento che si lega, in
un rapporto di causa ed effetto, alla segnalata crisi
del processo del lavoro e alla difficoltà del sistema
giurisdizionale interno di dare effettività e rapidità
di risposte alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle imprese, soprattutto
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Cfr. M. Miscione, Nomofilachia, Sezioni Unite, “diritto vivente” (leggendo la Relazione 2016 del Primo Presidente della
Cassazione), in questa Rivista, 2016, 4, 329.
(2) L’articolo, prima modificato dalla L. n. 940/1959, è stato
sostituito nell’attuale formulazione dall’art. 10 della L. n.
533/1973, di cui però rimangono vigenti soltanto i commi 1, 2
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
nei confronti della pubblica amministrazione: le
spese della giustizia del lavoro.
La regola generale dell’esenzione da ogni spesa e
tassa per i giudici del lavoro è enunciata nell’art. 1
della L. n. 319/1958 (2). La norma era stata abrogata in quanto inserita nella disposizione n.
1639 (3) di cui alla Tabella A allegata al D.L. n.
112/2008 tra le leggi da abrogare, ai sensi dell’art.
24 dello stesso decreto legge, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2008, con decorrenza dal
centottantesimo giorno dal 22 agosto 2008. Immediatamente, però, l’art. 1, L. n. 319/1958 è stato
“ripristinato” dall’art. 3, D.L. 22 dicembre 2008, n.
200 e connesso Allegato 2 e, quindi, sostanzialmente è stato sempre in vigore nei commi 1, 2 e 5
e 5, mentre i commi 3 e 4 sono stati abrogati dall’art. 299,
d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R.
(3) V. sul punto M. Miscione, Gratuità fiscale o non del processo del lavoro, in questa Rivista, 2008, 12, 1191; D. Carpagnano, Come si cancella in punta di piedi il principio di gratuità
del processo del lavoro e previdenziale, su www.cgil.it.
757
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
per quasi 38 anni nella formulazione introdotta
dalla novella del 1973 di riforma del processo del
lavoro con la totale gratuità fiscale, senza cioè l’applicazione del T.U. sulle spese di giustizia, di cui al
d.P.R. n. 115/2002.
Nel 2011 l’art. 37, comma 8, D.L. n. 98/2011 modifica l’art. 1, comma 1, L. n. 319/1958 con decorrenza dal 6 luglio 2011, per cui l’esenzione fiscale
(dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura) continua
ad operare e quindi costituisce ancora la regola generale, senza limite di valore o di competenza, per
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli
uffici del lavoro e della massima occupazione (ora
Direzione territoriale del lavoro) o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle
cause per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, salvo la deroga introdotta dalla norma
d’urgenza, cioè “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Infatti, l’art. 37, comma 6, D.L. n. 98/2011 con il
n. 2 della lett. b) ha inserito l’art. 9, comma 1 bis,
d.P.R. n. 115/2002 che testualmente dispone: “Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le
parti che sono titolari di un reddito imponibile ai
fini dell’imposta personale sul reddito, risultante
dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione
a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma
1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo
è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma
1”.
In particolare, le tre ipotesi di assoggettamento al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, sono specificamente e distintamente indicate nell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, facendo
riferimento a specifiche e distinte norme contenute
nell’art. 13 dello stesso Testo unico delle spese di
giustizia:
- euro 43 per tutti i processi per controversie di
previdenza ed assistenza obbligatorie (compresi i
procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I
c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative
758
opposizioni, ricorsi cautelari), “salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis”, cioè salvo i processi
dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’art. 13, comma
1 [art. 13, comma 1, lett. a)], e, quindi, ad esempio, se si fa riferimento al caso più frequente delle
cause di valore indeterminabile o di valore superiore a euro 26.000 e fino ad euro 52.000, sarà pari ad
euro 518 per i soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto dall’art. 13, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 115/2002;
- per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (compresi i procedimenti sommari di cui al Libro IV titolo I
c.p.c., cioè ricorsi per decreto ingiuntivo e relative
opposizioni, ricorsi cautelari) il contributo è la metà di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, d.P.R.
n. 115/2002, “salvo quanto previsto dall’art. 9,
comma 1-bis”, cioè salvo per i processi dinanzi alla
Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto
nella misura di cui all’art. 13, comma 1 (art. 13,
comma 3), e, quindi, ad esempio, sempre facendo
riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, sarà pari ad euro 259 per i giudizi
sia di primo che di secondo grado e ad euro 518
per i soli processi dinanzi alla Corte di cassazione;
- per tutti i processi concernenti le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie dinanzi alla Corte di
cassazione, si verserà (soltanto) il contributo di euro 518 se ci manteniamo nello scaglione delle cause di valore indeterminabile (art. 13, comma 1, e
art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002).
Tutto sommato equa appare la soglia soggettiva
“economica” entro la quale “continuare” ad aver
diritto all’esenzione dalle spese di giustizia per tutte
le persone fisiche (e per quelle giuridiche) che
chiedano accesso alla giustizia del lavoro, come individuata dalla norma-eccezione dell’art. 9, comma
1 bis, d.P.R. n. 115/2002 rispetto alla regola della
gratuità fiscale prevista dall’art. 1, comma 1, L. n.
319/1958: la parte ricorrente deve essere titolare di
un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale
sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione,
non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art.
76, d.P.R. n. 115/2002 per poter accedere al gratuito patrocinio, che attualmente, in base al decreto
del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015, è
pari ad euro 11.528,41.
Quindi, soltanto superando il reddito “personale”
(e non del nucleo familiare) annuale di euro
34.585,23, quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, le persone fisiche e quelle giuridiche
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Controversie del lavoro
Meno equo il processo del lavoro appare nel caso
in cui parte processuale sia la pubblica amministrazione, perché l’art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R.
n. 115/2002 prevede che l’amministrazione pubblica è ammessa alla prenotazione a debito delle spese
del contributo unificato, se a carico della stessa
amministrazione.
Quindi, per il privato e per le imprese il contributo
unificato si versa per accedere alla giustizia del lavoro se si supera il reddito “personale” annuale di
euro 34.585,23, mentre per le pubbliche amministrazioni continua ad operare la regola della gratuità fiscale, come confermato dalle Sezioni unite della Cassazione, che, come già avvenuto nelle sentenze n. 4911-4912-4913-4914-4915-5072/2016 (4)
sul precariato pubblico, ritengono giustificato un
trattamento differenziato tra parte privata e pubblica amministrazione sul piano degli oneri e dei costi
processuali.
Afferma, infatti, la S.C. (5) sulla portata sostanziale dell’art. 158, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 come
regola generale di gratuità fiscale di tutti i processi
civili in cui la pubblica amministrazione sarebbe la
parte onerata del versamento del contributo unificato e degli altri oneri processuali: “È principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre
Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la
evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al
tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la
conseguenza che l’obbligazione non sorge. Si tratta,
quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale,
ma che vale esclusivamente nei confronti dell’amministrazione pubblica. Difatti nella ipotesi in cui
la controparte è soccombente relativamente alle
spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell’erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di
qualsiasi altra parte vittoriosa. L’istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta
la pubblica amministrazione dal pagamento degli
importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi
quelli afferenti il contributo unificato - che gravano sul processo assolve, altresì, alla funzione, sotto
il profilo amministrativo contabile, di evitare che
di detta esenzione possa giovarsi la controparte in
caso di soccombenza e di sua condanna alle spese.”.
Pare evidente che tale normativa di favore non solo deresponsabilizza le pubbliche amministrazioni
che sono parti processuali nei giudizi del lavoro (e
civili e tributari, in generale), perché consente di
impugnare sentenze di primo e secondo grado sfavorevoli senza oneri economici e, quindi, senza far
scattare i presupposti per una valutazione di responsabilità del dirigente che abbia autorizzato la
prosecuzione del giudizio, nonostante la possibile
temerarietà del gravame e il rischio di una successiva e più onerosa soccombenza, ma costituisce il
presupposto culturale e giuridico per alimentare lo
stesso contenzioso del lavoro, particolarmente in
Cassazione, dove invece le parti private devono
sopportare significativi oneri fiscali che, lo vedremo, sono stati surrettiziamente estesi dal Ministero
della Giustizia anche a quei soggetti nei cui confronti avrebbe dovuto operare la regola della gratuità fiscale.
Sicuramente questa situazione di favore processuale
nei confronti delle pubbliche amministrazioni appare in violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (6), perché altera vistosamente il principio
della parità delle armi nel giusto processo, discrimi-
(4) Cass., SS.UU., Pres. Rovelli - Est. Amoroso, 14 marzo
2016, nn. 4911 (Comune di Massa c. Lutri ed altri), 4912 (Comune di Massa c. Salvaggio ed altri), 4913 (Comune Massa c.
Martelli ed altri), 4914 (Comune di Massa c. Bertini) e 4915
(Milanta c. Comune di Montignoso); 15 marzo 2016, n. 5072
(Azienda ospedaliera universitaria S. Martino di Genova c.
Marrosu e Sardino). Il prof. Miscione nell’editoriale di aprile
2016 (cit.) fa riferimento alla più nota delle sentenze, la “Marrosu-Sardino” del 15 aprile 2016, n. 5072, l’unica che contiene
la motivazione del principio di diritto enunciato anche in altre
quattro decisioni depositate il giorno prima (nn. 4911-49124913-4914/2016), ma con motivazione che rimanda per relationem a quella che verrà depositata il giorno dopo, la n.
5072/2016! Evidentemente la funzione “copia-incolla” nel
computer dell’Estensore aveva subito un attacco di virus informatico da ingiusto processo. Fortunatamente, la Corte costituzionale con la sentenza del 20 luglio 2016, n. 187 (Pres. Grossi,
Est. Coraggio) sui precari della scuola sembra aver cassato
l’incredibile pseudo-principio di diritto, inventato dalla Suprema Corte, del “danno comunitario” che esclude la conversione
dei contratti a termine nel pubblico impiego in caso di abusivo
utilizzo.
(5) Cass., SS.UU., sent. 8 maggio 2014, n. 9938.
(6) Su un’applicazione dell’art. 47 della Carta di Nizza a fattispecie di eccessivo onere fiscale per l’accesso alla giustizia in
caso di azione di risarcimento dei danni per violazione del dirit-
hanno l’obbligo di versare il contributo unificato, a
seconda del valore della controversia (salvo per
quelle previdenziali ed assistenziali) nella stessa misura ridotta alla metà per le fasi di merito [art. 13,
comma 1, lett. a), e comma 3, d.P.R. n. 115/2002],
nella misura piena per il solo giudizio in Cassazione
(art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).
L’iniqua gratuità fiscale del processo
del lavoro per le PP.AA.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
759
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
nando l’accesso alla giustizia pubblica a sfavore della parte privata.
Il contributo unificato applicato alle parti
private nel processo del lavoro contra ius
Nessun rilievo ai fini della modifica del contributo
unificato per i processi del lavoro, come innanzi ricostruito nelle sue “originarie” e attuali condizioni
soggettive e oggettive di applicazione, avrebbe dovuto avere l’introduzione, con l’art. 28, comma 1,
L. n. 183/2011, con decorrenza dal 1° gennaio
2012, dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002,
in base al quale il contributo di cui all’art. 13,
comma 1, T.U. sulle spese di giustizia è aumentato
della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
Infatti, nonostante la legge di stabilità n. 183/2011
intervenga pochi mesi dopo il D.L. n. 98/2011, che
ha introdotto l’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n.
115/2002, questa regola speciale per i processi del
lavoro contenente le eccezioni alla generale gratuità fiscale di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 319/1958
continua ad operare senza modifiche, regolamentando così tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio,
compreso l’appello (il cui contributo unificato è lo
stesso di quello da versare per il primo grado, senza
nessuna maggiorazione) e il giudizio per cassazione
(il cui contributo unificato è quello da versare ai
sensi dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002,
senza il raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1
bis, dello stesso decreto, che opera soltanto per i
processi civili non di lavoro).
Il dato è testuale e logico: se il legislatore della L.
n. 183/2011 avesse voluto elevare il costo dei processi del lavoro in secondo grado e in Cassazione
nella misura prevista dall’art. 13, comma 1 bis,
d.P.R. n. 115/2002 contestualmente introdotto,
avrebbe dovuto modificare l’art. 9, comma 1 bis,
d.P.R. e sostituire per il giudizio di appello il richiamo dell’art. 13, comma 1, lett. a) (per i giudizi
previdenziali) e dell’art. 13, comma 3 (per i giudizi
di lavoro e le controversie in materia di pubblico
impiego), mentre per il giudizio per cassazione
avrebbe dovuto intervenire sulla specifica previsione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 (e non
comma 1 bis), d.P.R. n. 115/2002.
Invece, nessun intervento modificativo è stato fatto in tutte le norme in cui viene richiamato l’art.
9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, come appunto
to dell’UE, v. Corte di Giustizia UE, Sez. II, sent. 22 dicembre
2010 in causa C-279/09 DEB. L’Avvocato generale è stato l’italiano Mengozzi, che ha presentato in data 2 settembre 2010
760
nel contesto dell’art. 1, comma 1, L. n. 319/1958 e
dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, oltre
che, naturalmente, all’interno della stessa norma
speciale sulla regolamentazione delle spese giudiziali nel processo del lavoro quando non opera la gratuità fiscale.
Questo comporta anche la non applicazione al processo del lavoro in sede di appello o in Cassazione
della previsione dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma
17, L. n. 228/2012, che dispone che, quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, secondo quanto previsto
dall’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, norma quest’ultima, come precisato, inapplicabile al
contenzioso del lavoro in quanto non richiamata
dall’art. 9, comma 1 bis, T.U. sulle spese di giustizia.
Viceversa, come vedremo, la circolare del Ministero della Giustizia del 14 maggio 2012, n. 65934 (e,
soprattutto, la prassi amministrativa che ne è derivata), che interviene ad interpretare le disposizioni
contenute nell’art. 37, D.L. n. 98/2011 in materia
di spese di giustizia, precisa che anche i commi 1
bis e 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 si
applicano al contenzioso del lavoro e previdenziale, accentuando quella alterazione del giusto processo già resa manifesta dalla gratuità fiscale concessa a tutte le pubbliche amministrazioni.
L’alterazione delle regole sulle spese
di giustizia nel processo del lavoro
nella prassi amministrativa
La circ. min. n. 65934/2012, in realtà, parte già
con una lente interpretativa sbagliata, ritenendo
sostanzialmente che, con l’entrata in vigore delle
modifiche al d.P.R. n. 115/2002 introdotte dal
D.L. n. 98/2011, la gratuità fiscale nel processo del
lavoro sia l’eccezione, mentre la regola diventi
quella del costo, seppure ridotto, da sostenere per
affrontare (anche) il processo del lavoro.
Partendo da un’ottica distorta, che è quella erariale
e di finanza pubblica (con nessuna potenzialità deflattiva, dal momento che l’accesso al processo delle pubbliche amministrazioni è gratuito), il ministero ha stravolto i requisiti soggettivi di assoggetconclusioni scritte. La domanda di pronuncia pregiudiziale era
stata sollevata dal Kammergericht di Berlino con ordinanza del
30 giugno 2009.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Controversie del lavoro
tamento al contributo soggettivo delle parti private
che ricorrono alla giustizia del lavoro ritenendo arbitrariamente e contra ius che il richiamo contenuto nell’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002 al
superamento di tre volte l’importo previsto dall’art.
76, comma 1, dello stesso decreto per poter accedere al gratuito patrocinio debba essere “inteso” come
applicazione dell’intero art. 76 e delle condizioni
ivi previste per poter essere sostenuti anche economicamente dallo Stato nelle spese processuali e negli onorari da corrispondere al proprio difensore
per tutelare i propri diritti pur essendo in uno stato
di indigenza economica.
In conseguenza di questa cattiva e illecita interpretazione che stravolge il dato letterale normativo, il
reddito della parte che chiede la tutela giudiziaria
nel processo del lavoro è diventato il reddito del
nucleo familiare previsto per il riconoscimento del
gratuito patrocinio dall’art. 76, comma 2, d.P.R. n.
115/2002 (e non per tutte le ipotesi, perché quando sono oggetto della causa diritti della personalità
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si
tiene conto soltanto del reddito personale, come
previsto dallo stesso art. 76, comma 4).
L’effetto dell’alterazione delle (chiare) regole da
applicare è che da un lato sono state illegittimamente escluse le persone giuridiche dal diritto all’esenzione fiscale per aver legato le condizioni del
reddito entro cui continuare a beneficare della gratuità fiscale a quelle del nucleo familiare e non al
reddito “personale” risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, come letteralmente previsto dall’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002; dall’altro
la platea delle persone fisiche che mantengono il
diritto all’accesso gratuito alla giustizia del lavoro
si è notevolmente ridimensionata, proprio perché
si deve tener conto del reddito del nucleo familiare
e giustificare l’esonero con autodichiarazione di responsabilità per dichiarazioni mendaci e modulistica (con copia del documento di identità del richiedente), che sono previsti solo per il gratuito patrocinio, mentre per l’art. 9, comma 1 bis, d.P.R. n.
115/2002 l’unica documentazione giustificativa per
mantenere lo status di soggetto protetto dai costi di
giustizia è l’ultima dichiarazione dei redditi personali.
La sconcertante prassi amministrativa che viola le
regole del giusto processo si estende anche alle
condizioni oggettive di applicazione delle norme in
subiecta materia, perché, incredibilmente, nella circolare ministeriale del 2012 si afferma che soltanto
per le cause previdenziali vi sia, in caso di ricorso a
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
procedimenti sommari come decreti ingiuntivi e ricorsi cautelari, l’applicazione della metà del contributo unificato di 43 euro previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, ai sensi dell’art.
13, comma 3, d.P.R., mentre detta riduzione non
applicherebbe nelle cause di lavoro, comprese
quelle di pubblico impiego.
Per confermare la coerenza di questa tesi, che non
tiene conto del chiaro testo dell’art. 9, comma 1
bis, d.P.R. n. 115/2002 - che non distingue, per i
processi del lavoro, tra giudizi di primo e di secondo grado e tra processi a cognizione ordinaria e a
cognizione sommaria e quindi non consente nessuno spazio all’interpretazione ministeriale innanzi
rappresentata -, il Ministero afferma che anche
l’INPS nella cause previdenziali, quando è parte attrice o ricorrente, è assoggettato all’obbligo contributivo. Non è così, evidentemente, perché l’Istituto previdenziale è (ancora, almeno formalmente)
una pubblica amministrazione e gode della gratuità
fiscale riconosciuta dall’art. 158, d.P.R. n.
115/2002 e dalla giurisprudenza costante delle Sezioni Unite.
La “mobilità” interna all’art. 13, d.P.R. n.
115/2002 dell’applicazione di norme in materia di
spese di giustizia nel processo del lavoro che, invece, hanno una loro logica e un loro campo di applicazione ben delimitato dall’art. 9, comma 1 bis
del decreto, comporta, nell’interpretazione ministeriale e nella conseguente prassi amministrativa degli Uffici giudiziari lo stravolgimento dello stesso
art. 9, comma 1 bis con i seguenti effetti di quantificazione del contributo unificato in contrasto con
il dettato normativo:
- per tutte le cause in Cassazione in materia di lavoro e previdenza si versa il contributo unificato
previsto dall’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.
115/2002, cioè il doppio del contributo di cui all’art. 13, comma 1, disapplicando senza ragioni la
seconda parte dell’art. 9, comma 1 bis, che invece
consente la gratuità fiscale anche nei giudizi di legittimità nel caso di non superamento del limite e,
comunque, impone in questo caso, cioè dopo il superamento del limite reddituale per aver diritto all’esonero, il contributo ordinario nelle misure previste dall’art. 13, comma 1, e non quello del successivo comma 1 bis;
- per le cause in sede di appello in materia di lavoro, compreso il pubblico impiego e con esclusione
di quelle previdenziali, si versa il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n.
115/2002, cioè il contributo ordinario di cui all’art.
13, comma 1 maggiorato della metà, così disapplicando la prima parte dell’art. 9, comma 1 bis, che
761
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
Per fare sintesi e concludere, la questione del precariato pubblico decisa dalle sei sentenze delle Sezioni Unite del 14-15 marzo 2016 (7) è esemplare
come il peggior esempio di (in)giusto processo del
lavoro, anche per quanto riguarda il pagamento
delle spese di giustizia.
In particolare, in una delle sei cause discusse all’udienza del 1° dicembre 2015 (decisa con la sent. n.
4915/2016) il ricorso per cassazione era stato proposto dalla lavoratrice, che aveva lavorato come
educatrice di asilo nido per il tramite di graduatorie selettive alle dipendenze del Comune di Montignoso con contratti a tempo determinato dal 7
gennaio 2009 al 30 giugno 2009, dal 16 novembre
2009 al 22 dicembre 2009 e dall’11 gennaio 2010
al 30 giugno 2010. I “legittimi” contratti a termine
(in quanto stipulati senza violazione di norme imperative di legge, ma attraverso procedure selettive) erano stati impugnati per mancanza di ragioni
oggettive in quanto il servizio espletato era legato
a carenze non temporanee di organico mascherate
dalla copertura finanziaria regionale, quindi per
violazione dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001
con richiesta di costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sin dal primo contratto illecito o irregolare. Nei primi due gradi di giudizio
la domanda era stata rigettata per infondatezza.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. la lavoratrice ricorrente per cassazione ha proposto otto domande
pregiudiziali Ue ai sensi dell’art. 267, comma 3,
TUEF, una delle quali sulla nozione comunitaria di
ragioni oggettive, per verificare se la nozione di
“ragioni obiettive” già enunciata dalla sentenza
Adeneler della Corte di Giustizia, deve essere interpretata nel senso che tale disposizione osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una
norma quale l’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001
che introduce una clausola generale per la legittima apposizione del termine, che consente che l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato sia giustificata da una qualsiasi ragione anche
non temporanea, di natura finanziaria e organizzativa del datore di lavoro pubblico come nella fattispecie di causa. L’Avvocato generale Jääskinen
nelle conclusioni della causa Jansen (8) aveva affermato (punto 58) che le ragioni “finanziarie” per
giustificare l’apposizione di un termine contrattuale
al lavoro pubblico potrebbero vanificare il principio guida secondo il quale i contratti a tempo indeterminato devono predominare e potrebbe mettere
a repentaglio l’equilibrio tra gli interessi in gioco
quale concepito dal diritto dell’Unione, in quanto
tali disposizioni concederebbero ai datori di lavoro
del settore pubblico una troppo grande facilità di
(7) Cass., SS.UU., Pres. Rovelli - Est. Amoroso, 14 marzo
2016, nn. 4911 (Comune di Massa c. Lutri ed altri), 4912 (Comune di Massa c. Salvaggio ed altri), 4913 (Comune Massa c.
Martelli ed altri), 4914 (Comune di Massa c. Bertini) e 4915
(Milanta c. Comune di Montignoso); 15 marzo 2016, n. 5072
(Azienda ospedaliera universitaria S.Martino di Genova c. Mar-
rosu e Sardino).
(8) Presentate il 15 settembre 2011 nella causa C-313/10,
che non è stata definita dalla Corte di Giustizia perché l’amministrazione pubblica tedesca ricorrente davanti al giudice del
rinvio ha rinunciato all’appello dopo le conclusioni negative
(per la sua posizione processuale) dell’avvocato generale.
prevede che per tutti i giudizi sia di primo che di
secondo grado, compresi quelli sommari, in caso di
superamento del limite reddituale per mantenere il
diritto alla gratuità fiscale, si applica soltanto l’art.
13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, cioè il contributo ordinario di cui all’art. 13, comma 1 ridotto della metà;
- per le cause in sede di appello in materia previdenziale, si versa il contributo unificato previsto
dall’art. 13, comma 1, lett. a), e comma 1 bis in
combinato disposto, d.P.R. n. 115/2002, cioè il
contributo ordinario di cui all’art. 13, comma 1,
lett. a) maggiorato della metà, così disapplicando
la prima parte dell’art. 9, comma 1 bis, che prevede
che per tutti i giudizi sia di primo che di secondo
grado, compresi quelli sommari, in caso di superamento del limite reddituale per mantenere il diritto alla gratuità fiscale, si applica per questa tipologia di controversie soltanto l’art. 13, comma 1, lett.
a), d.P.R. n. 115/2002, pari ad euro 43;
- per le tutte le cause in materia di lavoro e di previdenza sia in sede di appello che in Cassazione, in
caso di soccombenza della parte non avente diritto
alla gratuità fiscale (e quindi con esclusione delle
pubbliche amministrazioni), si versa il doppio del
contributo unificato utilizzato per instaurare la lite,
applicando illegittimamente l’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002, così disapplicando l’art.
9, comma 1 bis che disciplina esaustivamente il regime delle spese di giustizia al di fuori del regime
di gratuità fiscale per tutte le controversie di lavoro
e di previdenza, rinviando all’art. 13, comma 1,
lett. a) per quelle previdenziali tranne i giudizi di
cassazione, all’art. 13, comma 3, per quelle di lavoro tranne i giudizi di cassazione, all’art. 13, comma
1 per i soli giudizi di cassazione.
Conclusioni: rimedi per tornare
al giusto processo del lavoro e alla
deflazione del contenzioso seriale
nei confronti dello Stato
762
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Controversie del lavoro
accesso ad una successione di contratti a tempo determinato, considerando che mansioni perfettamente identiche possono essere espletate dai dipendenti del settore pubblico e da quelli che lavorano nel settore privato (punto 59).
La Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sent.
n. 4915/2016 ha rigettato il ricorso della lavoratrice Milanta “nel merito”, ritenendo legittimi i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni finanziarie, condannandola alle spese del giudizio,
compreso il versamento del doppio del contributo
unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002. Per tornare all’esempio della
lavoratrice tedesca Jansen nella causa C-313/10, il
giudice del lavoro in primo grado aveva già riqualificato a tempo indeterminato un unico rapporto di
lavoro a termine “illegittimo” con profilo professionale di addetta ai servizi di cancelleria presso l’amministrazione giudiziaria del Land NordrheinWestfalen dal 12 dicembre 2005 al 30 giugno
2006, con contratto giustificato da stanziamenti di
bilancio temporaneamente disponibili ai sensi dell’art. 7, par. 3, della legge finanziaria del Land (v.
conclusioni dell’Avvocato generale Jääskinen,
punto 20). Dopo le conclusioni dell’Avvocato generale nel giudizio pregiudiziale, come detto, il
Land Nordrhein-Westfalen ha rinunziato all’appello e la lavoratrice Jansen lavora stabilmente presso
il datore di lavoro pubblico.
La Corte di cassazione nella sent. n. 4915/2016 tace sulla proposizione delle otto questioni pregiudiziali UE.
Con sentenza dell’8 aprile 2014 nel caso Dhabhi n.
17120/09 la Cedu ha constatato nei confronti dello
Stato italiano la violazione dell’art. 6 della Carta
EDU, relativo al diritto ad un equo processo, per
non avere la Cassazione motivato il suo rifiuto a
sollevare la questione pregiudiziale UE richiesta
dal ricorrente come Giudice di ultima istanza, ai
sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE, liquidando altresì l’equo indennizzo per la violazione dell’art. 14
Cedu e il principio di equivalenza e non discriminazione. Analoga sentenza di condanna nei confronti dell’Italia, sempre a causa del mancato rinvio pregiudiziale della Cassazione, è la decisione
Schipani del 21 luglio 2015, n. 38369/2009, in
questo caso senza liquidazione dell’equo indennizzo.
Analogo principio è stato enunciato dalla Corte di
giustizia nella sentenza Ferreira da Silva e Brito (9),
stigmatizzando la decisione della Cassazione portoghese, in materia di trasferimento di azienda, di
non disporre il rinvio pregiudiziale UE e, anzi, di
motivare in maniera errata sulla chiarezza interpretativa della giurisprudenza comunitaria sulla questione, così legittimando l’azione di risarcimento
dei danni proposta dai lavoratori nei confronti dello Stato per manifesta violazione del diritto comunitario e dell’art. 267, comma 3, TFUE commessa
dal Giudice di ultima istanza, seguendo le indicazioni della sentenza Francovich (10) della Corte di
Giustizia UE.
Quindi, l’educatrice di asilo comunale italiana che
non ha trovato giustizia nell’ordinamento interno
per l’oggettiva ingiustizia, anche sotto il profilo
delle spese processuali, del processo del lavoro soprattutto quando parte della controversia è un’amministrazione pubblica, avrà la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti sia davanti alla
Cedu sia davanti al giudice ordinario italiano per
la manifesta violazione dell’art. 267, comma 3,
TUEF, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 Cedu
commessa dalla S.C. come Giudice di ultima istanza nella sent. n. 4915/2016.
Identici rimedi potranno essere esperiti da decine
di migliaia di lavoratori precari nel pubblico impiego, che si riterranno beffati dalla liquidazione del
risarcimento del danno per abusivo utilizzo dei
contratti a tempo determinato, nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nelle sentenze
nn. 4911-4912-4913-4914/2016 (senza motivazione, e quindi con ulteriore violazione delle regole
del giusto processo) e nella sent. n. 5072/2016, l’unica decisione “motivata”.
L’ingiusto processo del lavoro provoca sempre la
moltiplicazione esponenziale del contenzioso seriale nei confronti della pubblica amministrazione.
Forse è giunto il momento per la giurisdizione di
cambiare atteggiamento culturale nei confronti del
processo del lavoro, per garantire che lo Stato e le
pubbliche amministrazioni non ricevano (più) quei
privilegi che si traducono in sostanziale impunità
degli errori organizzativi e degli illeciti commessi
nei rapporti civilistici, che a loro volta producono
alle finanze erariali più danni degli apparenti (e illeciti sulle spese processuali, che vanno dunque restituiti alle parti private che li hanno subiti) benefici economici ricevuti dalla prassi amministrativa
e da quella giudiziaria.
(9) Corte di Giustizia UE, sent. 9 settembre 2015, causa C160/14 Ferreira da Silva e Brito ed altri c. Stato portoghese.
(10) Corte di Giustizia CE, Grande Sez., sent. 19 novembre
1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90 Andrea Francovich e Danila Bonifici e altri contro Repubblica Italiana.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
763
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
Età pensionabile
Prosecuzione del rapporto di
lavoro oltre l’età pensionabile:
nodi irrisolti e spunti di riflessione
di Giovanna Pistore - Dottoranda di ricerca nelle Università di Padova e Siviglia (*)
L’articolo esamina la disciplina dell’art. 24, comma 4, D.L. n. 201/2011, che ha introdotto per i
lavoratori dipendenti la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa con il regime di stabilità sino al settantesimo anno d’età. Sono molteplici, tuttavia, i profili controversi: l’individuazione dei soggetti interessati, la natura della situazione giuridica in cui versa il lavoratore, la qualificazione del licenziamento intimato per raggiunti limiti d’età. Recentemente la S.C. si è pronunciata in materia, ma ancora molte restano le questioni insolute che richiederebbero un’ulteriore opera chiarificatrice.
Ormai sono passati anni dalla difficile estate del
2011, quando il legislatore ha messo mano al regime pensionistico cercando di porre un argine all’abnorme spesa previdenziale, per “garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’UE, dei
vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e (...) rafforzare la sostenibilità di lungo periodo
del sistema (...) (1)”.
Tra le varie norme adottate, l’art. 24, comma 4,
D.L. n. 201/2011 (2), convertito dalla L. n.
214/2011, il quale, dopo aver stabilito l’innalzamento dell’età pensionabile, prevede che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti
di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni (...). Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Norma, questa, che assume valenza trasversale,
avendo ripercussioni non solo sul piano previden(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Art. 24, comma 1, D.L. n. 201/2011.
(2) In via generale, sulla riforma pensionistica, P. Sandulli, Il
sistema pensionistico tra una manovra e l’altra, in Rivista del Di-
764
ziale, ma anche relativamente al rapporto individuale di lavoro. Il testo di legge sembra conciso,
ma rivela un’architettura contorta irta di dubbi
che stentano a diventare certezze.
A chi si applica la nuova disciplina?
Il primo dei numerosi problemi da affrontare riguarda l’individuazione dei soggetti interessati dalla
nuova disciplina. L’operazione si rivela non agevole: il lacunoso dato normativo apre a posizioni nettamente contrastanti, basate su una diversa considerazione letterale e teleologica della legge.
Dal punto di vista temporale, ci si chiede se la norma abbia un’efficacia generalizzata, o al contrario
risultino esclusi i lavoratori per cui non operano le
nuove norme pensionistiche, poiché in possesso
dei requisiti per le pensioni di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2011.
Alcune pronunce ritengono che il comma 4 dell’art. 24 riguarderebbe, nel suo complesso, solo i lavoratori che conseguano i requisiti per l’accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2012 (3). Né,
d’altro canto, sarebbe possibile opinare diversaritto della Sicurezza Sociale, 2012, 1, 1-32; M. Cinelli, La riforma
delle pensioni del “Governo tecnico”. Appunti sull’art. 24 della
legge n. 214 del 2011, Riv. it. dir. lav., 2012, 2, 385.
(3) App. Torino 24 ottobre 2013, n. 1141, in www.dplmodena.it: il riferimento, nel primo paragrafo dell’art. 24, comma 4,
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
mente considerando il successivo comma 14, per
cui nei confronti dei soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni in materia di accesso e decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore della riforma
ma si nulla dice, invece, circa la prosecuzione del
rapporto: il fatto che venga delimitata l’operatività
di determinate previsioni non consente di interpretare estensivamente altre norme attinenti a profili
diversi, nel momento in cui le stesse indichino in
maniera espressa la loro applicabilità a coloro che
conseguano il diritto a pensione secondo la nuova
normativa.
Altro filone giurisprudenziale (4), e così parte della
dottrina (5), opta per un’interpretazione estensiva.
Sul piano testuale, si afferma che gli incisi del
comma 4 relativi alla prosecuzione del rapporto
non indicano alcuna esclusione, risultando quindi
operanti per tutti coloro che scelgano di proseguire
la propria attività (6): ne sarebbe conferma, a contrario, proprio il disposto del successivo comma
14 (7), concernente in via esclusiva requisiti e decorrenze. Inoltre, da un punto di vista sistematico,
una diversa impostazione non spiegherebbe la possibilità di richiedere all’INPS la certificazione del
diritto a pensione (8), il quale avrebbe la funzione
di garantire la certezza del proprio diritto al lavoratore che potrebbe già farlo valere al 31 dicembre
2011 e intenda proseguire il rapporto. E, dal punto
di vista teleologico, questa ricostruzione risponderebbe appieno alle finalità di incentivare la prosecuzione della vita lavorativa e di risparmio di spesa
esplicitate dall’art. 24 al comma 1.
La seconda impostazione appare preferibile non solo dal punto di vista testuale, ma considerando il
generale quadro in cui è inserita la disposizione
controversa. Innanzitutto, le previsioni inerenti la
prosecuzione del rapporto sono in altri, distinti pe-
riodi, rispetto a quello che individua il campo di
applicazione dei nuovi requisiti pensionistici. Inoltre, una volontà legislativa orientata in senso
estensivo sembra potersi desumere anche da altri
indici normativi. Si pensi, ad esempio, al comma 2
dell’art. 24, in cui viene genericamente prevista
l’applicazione del metodo di calcolo contributivo
per le quote di trattamento maturate a partire dal
1° gennaio 2012, senza alcuna distinzione. Tale
previsione, quindi, concerne tutti i lavoratori in
possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, compresi coloro i quali abbiano maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre
2011 (9), a testimonianza del fatto per cui, probabilmente, il legislatore contemplava che anche i
lavoratori soggetti alle previgenti norme potessero
proseguire la loro attività lavorativa: una diversa
interpretazione risulta quindi distonica rispetto alla
mens legis esplicitata nel complesso dalla legge .
Discussa è pure l’applicabilità della norma ai giornalisti professionisti iscritti all’INPGI: ente privatizzato dal D.Lgs. n. 509/1994, ma con natura e
funzioni pubblicistiche, tant’è vero che è sottoposto a controllo della Corte dei conti e concorre al
conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche (10). La questione, anche in questo caso, deriva dal difficile coordinamento tra due distinte norme. Da un lato il comma 4 dell’art. 24 menziona i
“lavoratori e lavoratrici la cui pensione è liquidata
a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima”,
facendo pensare, pertanto, ad una sua applicabilità
anche nei confronti degli iscritti INPGI. Ma il successivo comma 24 impone alle gestioni di cui al
D.Lgs. n. 509/1994 di adottare, entro e non oltre il
30 settembre 2012, “misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ai “requisiti minimi previsti dai successivi commi” implica l’applicabilità della norma, nella sua integralità (compresi gli incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa) unicamente ai lavoratori che raggiungano l’età pensionabile dopo il 31 dicembre 2011, così pure Trib. Genova 11 novembre 2013, Est. Barenghi, con nota di V. Ferrante, Licenziamento dell’ultrasessantenne in possesso dei requisiti per la pensione (art. 24, co. 4 d.l.
201/2011): lex minus dixit quam voluit?, in Riv. it. dir. lav.,
2014, 2, 221.
(4) Trib. Torino 29 marzo 2013, Est. Buzano.
(5) M. Russo (1), Lavorare fino a settant’anni: disciplina, tutele ed effetti sul mercato del lavoro dell’art. 24 L. n. 214/2011, in
Lav. prev. Oggi, n. 5-6/2014, 273 - 290.
(6) Trib. Torino 29 marzo 2013, cit.
(7) Oppure nel comma 5, dove si esclude l’applicabilità delle disposizioni sulla c.d. finestra annuale “con riferimento esclusivamente” ai soggetti che vadano in pensione secondo il nuovo regime.
(8) Art. 24, comma 3. Certificazione che ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto: così ha specificato l’INPS nel
messaggio 24126 del 20 dicembre 2011.
(9) Disposizione interessata da vicende controverse: dapprima il legislatore si è limitato a prevedere che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dal 1 gennaio
2012 fosse calcolata con metodo contributivo ma poi, accortosi che la manovra poteva risultare controproducente, è di nuovo intervenuto, stabilendo con l’art. 1, comma 707, L. 23 dicembre 2014, n. 190, la prevalenza del calcolo retributivo o retributivo a seconda di quello che fosse il trattamento minore.
(10) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) “La ricognizione
delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata
annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella G.U. entro il 30 settembre”. L’ultimo elenco predisposto è pubblicato nella G.U. - Serie Generale n. 227 del 30
settembre 2015.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
765
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
ad un arco temporale di cinquanta anni”, sanzionando l’inottemperanza con l’applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 2 nonché di un
contributo di solidarietà (11).
La giurisprudenza risulta nettamente divisa. Alcune pronunce (12), facendo leva sul testo della legge
e sulla natura sostitutiva dell’INPGI quale desumibile da molteplici indici normativi (13), ritengono
che la norma operi anche nei confronti degli iscritti a questa gestione: il comma 24 si riferirebbe
esclusivamente agli enti che gestiscono attività di
libera professione senza il concorso finanziario dello Stato. Di diverso avviso le Sezioni Unite (14),
per cui non può ritenersi che tra le “forme esclusive e sostitutive” dell’AGO rientri alcuno degli istituti privatizzati a seguito del D.Lgs. n. 509/1994: la
circostanza che, per questi enti, l’adozione di misure di contenimento della spesa pensionistica sia disciplinata in una specifica sedes materiae (il comma
24) indica la volontà legislativa di adottare due diverse modalità di intervento. Salvo previsione derogatoria espressa, non è possibile una commistione tra i due sistemi, tanto più se si considera che la
determinazione di contribuzioni, requisiti soggettivi e modalità di godimento delle prestazioni viene
fissata in piena autonomia dagli enti privatizzati.
Sembra questa la strada da percorrere, non tanto
per la considerazione del comma 24 ché, volendo,
le due norme potrebbero essere coordinate: il legislatore può ben estendere le tutele per il licenziamento fino al settantesimo anno d’età, e allo stesso
tempo rimettere alle gestioni privatizzate la disciplina degli aspetti previdenziali. Indicativa invece
è proprio la considerazione della dibattuta formula
“forme esclusive e sostitutive” dell’AGO. Scorrendo il testo della legge vediamo che tale locuzione (15) compare, unita o spezzata, in più punti,
con riferimento ai requisiti contributivi e anagrafi-
ci per la pensione: tutti aspetti che, come detto,
nel caso degli enti ex D.Lgs. n. 509/1994 rientrano
nella loro autonomia regolamentare. È evidente,
pertanto, che con questa formula il legislatore non
intenda riferirsi alle gestioni privatizzate (e quindi
all’INPGI), lasciando presumere che si tratti di un
riferimento alle forme esclusive e sostitutive gestite
dall’INPS (16).
Altro nodo riguarda l’applicabilità della norma ai
dirigenti: questione che è possibile risolvere agevolmente, dato il generico riferimento ai “lavoratori” dipendenti. Tuttavia - come già in passato accadeva con riferimento alle vecchie ipotesi di opzione - essi continuano ad essere soggetti alla tutela
economica collettiva per il licenziamento ingiustificato e, nei casi di nullità e discriminazione, alla
disciplina statutaria.
Non è finita qui, perché occorre ora procedere all’individuazione dei datori di lavoro coinvolti. Sono due i profili controversi: l’applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni, e nei confronti dei datori
di lavoro che non integrino i requisiti dimensionali
ex art. 18 Stat. lav.
Travagliata la vicenda inerente al pubblico impiego. Di per sé, già il riferimento ai “limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” indicava chiaramente l’impossibilità di proseguire il
rapporto nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni (17). Posizione esplicitata nella circ. n.
2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
successivamente annullata dal T.A.R. Lazio (18)
nella parte in cui stabiliva l’obbligatorio collocamento a riposo a 65 anni dei dipendenti in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di
vecchiaia.
(11) Il Consiglio di amministrazione dell’INPGI ha approvato
solo in data 27 luglio 2015 la delibera contenente anche gli interventi di riforma pensionistica.
(12) Trib. Roma 26 gennaio 2015, in www.ilgiuslavorista.it,
28 maggio 2015; Trib. Roma 24 febbraio 2014, Est. Ambrosi,
reperibile al sito www.wikilabour.it; Trib. Roma 17 dicembre
2013, n. 141084, Est. Leone, pronunce che richiamano Cass.
26 gennaio 2012, n. 1098.
(13) In particolare l’art. 76 della L. n. 388/2000, per cui
l’INPGI gestisce le forme di previdenza obbligatoria dei giornalisti professionisti e dei praticanti in regime di sostitutività.
(14) Cass., SS. UU., 4 settembre 2015, n. 17589, su cui si
veda infra, nt. 40.
(15) Al comma 6, lett. a) e c) e ai commi 9, 10 e 15 bis dell’art. 24.
(16) Ossia, per le forme sostitutive, i Fondi Elettrici, Dazio,
Telefonici e Volo, l’ENPALS, il Fondo Trasporti e l’INPDAI; per
quelle esclusive l’INPDAP, i Fondi Ferrovieri e PT.
(17) In particolare, i limiti ordinamentali sono fissati nel
compimento del sessantacinquesimo anno d’età dall’art 4 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato,
e dall’art. 12, comma 1, lett. d), L. 20 marzo 1975, n. 70, per i
dipendenti degli enti pubblici, secondo statuizioni che si ritengono valide anche per le altre categorie. Ci sono, poi, dei limiti
ordinamentali speciali: ad esempio, il settantesimo anno di età
per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari, ai sensi di quanto statuito, rispettivamente, all’art. 5 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, all’art. 34 del R.D.
30 ottobre 1933, n. 1611 e all’art. 19 del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382. Sui profili problematici inerenti il pubblico impiego si
veda D. Casale, Il collocamento a riposo dall’impiego pubblico
per limite massimo d’età, dopo la riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011, LPA,
2011, 903 ss.
(18) T.A.R. Lazio Roma 7 marzo 2013, n. 2446.
766
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
È quindi intervenuto il legislatore in sede di interpretazione autentica, con l’art. 2, comma 5, D.L.
31 agosto 2013, n. 101, ai sensi del quale l’innalzamento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia non modifica i limiti ordinamentali dei singoli settori, né li rende modificabili,
salvo il trattenimento in servizio dell’interessato ex
art. 16, D.L. n. 502/1993 o la necessità di consentire al lavoratore la prima decorrenza utile del trattamento di quiescenza, ove la stessa non sia immediata.
La questione sembrava risolta, ma recentemente il
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (19), all’art. 1, comma
1, ha abrogato l’istituto del trattenimento e ridefinito la risoluzione unilaterale, relegando la possibilità di prosecuzione ai casi in cui il dipendente non
abbia maturato alcun diritto a pensione (20) al
compimento del limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, eccettuate queste ipotesi, il raggiungimento dei limiti ordinamentali è causa di automatica risoluzione del rapporto. Qualche perplessità
sulla legittimità di tali disposizioni potrebbe sorgere
alla luce della disciplina antidiscriminatoria di cui
alla Dir. 2000/78/CE (21). Queste perplessità, che
in ogni caso non avrebbero avuto ragione di essere,
alla luce di quanto statuito in sede comunitaria relativamente a disposizioni analoghe (22), sono state di recente ritenute infondate dalla Corte costituzionale (23), stante la finalità di ricambio generazionale sottesa alla normativa in esame.
Neppure semplice è la questione circa l’applicabilità o meno della disciplina in esame alle imprese
soggette alla c.d. “stabilità obbligatoria”: la criptica
formulazione della norma (per cui si dice solo che
“Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia
delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite
massimo di flessibilità”) induce a chiedersi se la tutela rafforzata in caso di recesso operi anche per i
lavoratori occupati in imprese con meno di sedici
dipendenti (con le precisazioni di cui infra).
C’è chi ritiene (24), con un riferimento alle precedenti ipotesi di opzione, che la disposizione avrebbe efficacia generalizzata, riguardando indifferentemente le imprese in area di stabilità reale o obbligatoria (25). Operazione ermeneutica certamente
apprezzabile ma non condivisibile: la nuova disciplina non permette di mutuare in toto le categorie
inerenti le vecchie opzioni, in quanto ancorate a
presupposti eterogenei rispetto a quelli cui si riferisce l’art. 24.
Le norme interessate (ossia l’art. 6 del D.L. n.
791/1981, e l’art. 6 della L. n. 407/1990, poi integrato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 503/1992)
hanno una conformazione nettamente diversa, poiché fanno riferimento, rispettivamente, alla L. n.
604/1966 e alla L. n. 108/1990, ossia a delle disposizioni che prevedono i presupposti di legittimità
del licenziamento in via trasversale. Nel caso di
specie ci troviamo di fronte ad un puntuale dato
testuale, difficilmente superabile, il quale porta a
ritenere che la disposizione riguarderebbe unicamente le aziende soggette all’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. lav. (26): facendo ipotizzare
che il legislatore abbia così deciso perché sarebbe
maggiormente difficile ed onerosa, per le piccole
imprese, la prosecuzione del regime di giustificazione necessaria del licenziamento fino al compimento del settantesimo anno d’età del dipendente (27).
Per i lavoratori soggetti alla tutela obbligatoria
continuerebbe ad operare la vecchia opzione ex
art. 6, D.L. n. 791/1981, che prevede la possibilità
(19) Si veda al proposito la circ. n. 2/2015 del Ministro per
la semplificazione e la P.A.
(20) Anche anticipata, escluse le ipotesi in cui il lavoratore
subirebbe delle penalizzazioni ai sensi dell’art. 24, comma 10,
D.L. n. 201/2011. Si veda Corte cost. 6 marzo 2013, n. 33 con
commento di C. Colapietro, La Corte ribadisce la garanzia costituzionale del trattamento pensionistico minimo, Giur. cost., 2,
2013, 621 ss. e inoltre Corte cost. 3 giugno 1991, n. 282 che
richiama a sua volta la propria precendente sent. 26 settembre
1990, n. 444 per cui “non può essere preclusa, senza violare
l’art. 38, comma 2, Cost., la possibilità per il personale in questione che al compimento del sessantacinquesimo anno-quale
che sia la data di assunzione -non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a
riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”.
(21) Che, ai sensi dell’art. 3 par. 1, opera anche nei confronti delle PP.AA.
(22) Si veda Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, cause riunite C-159/10 e C-160/10, Fuchs e Köhler. Si veda anche infra,
par. 3
(23) Corte Costituzionale 10 giugno 2016, n. 133.
(24) App. Genova 8 gennaio 2014, DRI, 2014, 3, 787 ss.,
con nota di C. Murena, Età pensionabile e tutela contro il licenziamento ad nutum nel decreto-legge n. 201/2011, ritiene la
norma operante in favore di tutti i lavoratori di imprese rientranti, quanto a dimensioni aziendali, nell’art. 18 Stat. lav.
(25) Cfr. G. Canavesi, Età pensionabile, prosecuzione del rapporto fino a settant’anni e licenziamento nella riforma pensionistica del 2011, DRI, 2013, 3, 665.
(26) M. Russo, op. cit. (1), che ravvisa una possibile disparità di trattamento del lavoratore pensionabile a seconda dei requisiti dimensionali del datore di lavoro. Contra, L. D’Ambrosio, Il licenziamento ad nutum del lavoratore in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia: disciplina e problematiche, in
Bollettino Adapt, 20 febbraio 2012, n. 6, 4.
(27) L. D’ambrosio, op. cit.; M. Tremolada, Il licenziamento
libero, in corso di pubblicazione nel Trattato diritto del lavoro diretto da Mattia Persiani e Franco Carinci, V, L’estinzione del
rapporto di lavoro subordinato.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
767
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
di proseguire il rapporto fino al sessantacinquesimo
anno d’età senza perdere quella stabilità. Alla luce
dei vigenti requisiti pensionistici la norma risulta
ormai lettera morta, ma così non era quando il
D.L. n. 201/2011 è stato adottato: le ipotesi di opzione ex D.L. n. 791/1981 e L. n. 407/1990 hanno
continuato ad operare per le lavoratrici dipendenti
del settore privato, il cui diritto a pensione decorreva (in presenza della necessaria contribuzione) al
raggiungimento del sessantaduesimo anno d’età, secondo quanto stabilito dall’art. 24, comma 6, lett.
a), D.L. n. 201 (28).
D’altronde, è pacifico che la determinazione dell’ammontare delle prestazioni previdenziali rientri
nella discrezionalità del legislatore, secondo l’idea
per cui la perdita del reddito da lavoro è accettabile
nel momento in cui ci sia un reddito alternativo di
natura previdenziale: “va apprezzato e protetto il
prolungamento dell’età lavorativa perché al lavoratore sia garantito la pensione al minimo ma non
può godere di eguale protezione e garanzia il raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo (29)”. A prescindere da eventuali giudizi di valore, nulla si può dire su una scelta legislativa in cui
viene bilanciato il diritto all’adeguatezza delle prestazioni ex art. 38 Cost., comunque garantito, con
quello di iniziativa economica nelle piccole imprese
ai sensi dell’art. 41 Cost. D’altro canto, neppure è
invocabile una pretesa disparità di trattamento (30)
in ordine al regime del recesso, disparità che infatti
può essere tranquillamente esclusa mutuando gli argomenti già sviluppati dalla Consulta per giustificare la diversità tra le sanzioni di area applicabili in
conseguenza di un licenziamento illegittimo (31).
L’inapplicabilità a questi lavoratori dell’art. 24 si
ripercuote direttamente sulle tutele operanti, riproponendo interrogativi già noti ed ancora insoluti.
Il problema maggiore sorge da un maldestro collage
normativo ossia l’abrogazione, ad opera dell’art. 6,
della L. n. 108/1990, dell’art. 11, comma 1, L. n.
604/1966, che specificamente escludeva dal campo
di applicazione della legge i lavoratori “in possesso
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia”, e la sua sostituzione col generico disposto dell’art. 4, comma 2, L. n. 108/1990, il quale
invece si limita a prevedere la recedibilità ad nutum nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni
“in possesso dei requisiti pensionistici”, senza alcuna
specificazione. Ci si continua a chiedere, quindi, se
la titolarità o il raggiungimento di quanto richiesto
per la fruizione di una pensione statale o anticipata
conducano al regime generale ex art. 2118 c.c. Le
recenti modifiche all’art. 72, comma 11, D.L. n.
112/2008 (32), per cui nel pubblico impiego il collocamento a riposo avviene al raggiungimento dei
requisiti per la pensione anticipata, potrebbero indurre ad applicare analoghi principi anche al settore privato. Ma la questione sembra avere una risposta negativa, ove si consideri la ratio sottesa alle disposizioni sul licenziamento testé citate. Quando
l’art. 4, comma 2, L. n. 108/1990 è stato adottato,
il requisito del sessantesimo anno d’età coincideva
con quello all’epoca previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Come è stato acutamente osservato (33), il legislatore, nel momento in cui ha
previsto un requisito anagrafico accompagnato da
quelli pensionistici, non intendeva effettuare un riferimento generico ma, appunto, indicare la contribuzione sottesa al trattamento di vecchiaia: principi che continuano ad applicarsi anche al caso considerato. Anche perché nel pubblico impiego il
collocamento a riposo è giustificato da un risparmio di spesa (inerente alle retribuzioni) per l’Amministrazione datrice di lavoro mentre, nel settore
privato, il risparmio di spesa pubblica, che riguarderebbe le pensioni, viene tradotto nella permanenza del rapporto di lavoro e quindi dell’obbligo
retributivo in capo al datore.
Peraltro, l’abolizione delle cc.dd. finestre mobili,
operata dal comma 5 dell’art. 24 per i lavoratori
soggetti alle nuove norme pensionistiche, ha di fatto eliminato il vuoto di tutele tra conseguimento e
percezione del diritto, limitato al breve (almeno
sulla carta) periodo intercorrente tra il raggiungimento dei requisiti e il primo giorno del mese successivo (34). Resta, invece, un problema di tutela
(28) Requisito ormai superato in forza degli adeguamenti
alla speranza di vita: dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico previsto per le donne dipendenti del settore privato - destinato costantemente a crescere - è di 65 anni e 3 mesi, fino ad
arrivare a 66 anni e 3 mesi nel 2018. Si ritiene, peraltro, che in
questo caso non vi fosse alcun onere di comunicazione in capo alla lavoratrice: anche se in un primo momento la Consulta,
adita al riguardo, ha salvato la legittimità dell’art. 6, D.L. n.
791/1981 (Corte cost. 20 giugno 2002, n. 256, con nota di A.
Pileggi (1), Limiti dell’età pensionabile e principio di parità tra i
sessi, Mass. Giur. lav., 1-2/2003, 45), nella successiva sentenza
29 ottobre 2009, n. 275 ha sancito l’incostituzionalità dell’art.
30, D.Lgs. n. 198/2006, di analogo contenuto.
(29) Corte cost. 9 dicembre 1991, n. 440.
(30) M. Russo, op. cit. (1).
(31) Corte cost. 22 luglio 1996, n. 291; 23 febbraio 1996, n.
44; 6 marzo 1974, n. 55; 14 aprile 1969, n. 81.
(32) Con il D.L. n. 90/2014.
(33) A. Pileggi (2), Età pensionabile ed estinzione del rapporto di lavoro, Roma, 1996, 38 ss.
(34) Tornano infatti ad essere applicate le regole di cui all’art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 155.
768
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
per i lavoratori in area di stabilità obbligatoria che,
avendo maturato il diritto a pensione entro il 31
dicembre 2011, abbiano continuato il rapporto: licenziabili ad nutum -, ma privi della prestazione
finché non siano decorsi i dodici mesi stabiliti dall’art. 12, D.L. n. 78/2010 (35).
Quindi la disposizione sarà operante nei confronti
dei lavoratori dipendenti da imprese che integrino
i requisiti dimensionali ex art. 18 St. lav. (anche in
forza di nuove assunzioni) con applicazione, in caso di recesso, delle tutele statutarie o di quelle previste nel D.Lgs. n. 23/2015, dato che l’art. 24 parla
“delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni”. Il decreto delegato può infatti ritenersi una
modificazione della preesistente norma statutaria
quale tutela di area (36).
Diritto soggettivo, accordo tra le parti o
qualcos’altro?
Un nodo cruciale ed estremamente dibattuto è
quello che concerne la natura della situazione giuridica in cui versa il lavoratore che voglia proseguire il rapporto. Questione, questa, che almeno fino
al recente intervento delle Sezioni Unite vedeva la
(35) Infatti, nei confronti di questi lavoratori non opera neppure l’art. 6, comma 2 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, che
prevede solo nell’ambito della tutela reale la permamenza del
regime di stabilità fino alla decorrenza della pensione.
(36) C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT, n. 273/2015. Più radicale, invece, l’orientamento (O. Bonardi, Le discriminazioni basate sull’età, in
M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano, 2007, 162; in giurisprudenza, Trib. Genova 3 dicembre
2012, n. 1605, Est. Basilico, esaminata da R. Cosio, Le discriminazioni per età: il giudice nazionale si trasforma in giudice europeo, relazione tenuta al convegno “Diritto europeo nel dialogo delle Corti”, Venezia, 25 gennaio 2013, in www.europeanrights.eu.), per cui le disposizioni sulla libera recedibilità sarebbero in contrasto con la normativa antidiscriminatoria comunitaria e l’art. 30 della Carta di Nizza (nonché, si potrebbe aggiungere, l’art. 24 della Carta sociale europea). Questa soluzione lascia non poco perplessi, poiché in questo modo non
avrebbe più ragion d’essere qualsiasi norma sulla prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile, potendo lo stesso avere durata indefinita. A tal proposito M. Russo (2), Il licenziamento discriminatorio per età pensionabile nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consultabile al sito
www.dottrinalavoro.it, sottolinea come l’art. 30 vieti un licenziamento meramente arbitrario, ma non indica quali siano le
giustificazioni valide, anche se dall’art. 21 della Carta di Nizza
si potrebbe desumere che non può essere causa di licenziamento il riferimento ad uno dei fattori di discriminazione indicati, tra cui l’età. Tuttavia, nel caso di specie rileva non solo l’età, ma anche la possibilità di conseguire un trattamento pensionistico. Pertanto, ove si concludesse per l’incompatibilità
tra libero recesso e art. 30 della Carta di Nizza, questa impostazione risulterebbe distonica rispetto alla generale disciplina
codicistica dei rapporti a tempo indeterminato. In più, esaminando le norme comunitarie citate si può osservare che ele-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
giurisprudenza nettamente divisa tra due diverse
considerazioni del dato teleologico e letterale della
legge.
Andiamo con ordine.
Alcune pronunce e una parte della dottrina, sulla
scorta delle categorie formatesi relativamente alle
previgenti ipotesi di opzione, parrebbero riconoscere la permanenza del regime di tutela verso il licenziamento quale effetto dell’esercizio di un diritto
potestativo (37). È discusso, tuttavia, se vi siano
oneri di comunicazione al datore di lavoro o meno:
a tal proposito, è stato ritenuto da alcuno che si
possa prescindere da ogni comunicazione (38),
mentre in dottrina vi è chi al contrario ritiene che
l’esercizio di tale diritto sia soggetto alle forme già
previste ex art. 6, D.L. n. 789/1981 e L. n.
407/1990 (39).
Fanno da contraltare altre decisioni di segno diametralmente opposto: la norma de qua non attribuisce un diritto, ma incide su una fattispecie negoziale presupposta e preesistente costituita da un
accordo tra le parti, a cui vengono riconnessi degli
effetti favorevoli al lavoratore sul piano previdenziale e delle tutele contro il licenziamento (40). Il
termine “incentivato” contenuto nella disposizione, riferito al proseguimento dell’attività lavoratimento comune alle stesse sia la previsione di un generale principio di giustificatezza del recesso non correlata, tuttavia, all’indicazione di una specifica sanzione, rimessa invece alla discrezionalità dei legislatori nazionali: in questo caso, la recedibilità ad nutum non è scevra da alcuna tutela, ma risulta supportata proprio dalla possibilità di usufruire del trattamento
pensionistico.
(37) Trib. Torino 29 marzo 2013, cit.; App. Genova 8 gennaio 2014, cit.; Trib. Roma 24 febbraio 2014, cit.; G. Canavesi,
op. cit.; M. Russo, op. cit. (1).
(38) Trib. Torino 29 marzo 2013, cit. per cui “non appare
d’altra parte applicabile la disposizione di cui all’art. 6 della L.
29 dicembre 1990, n. 407 che riguarda la diversa ipotesi del
raggiungimento dell’anzianità contributiva massima e che è
comunque incompatibile con la nuova normativa”.
(39) G. Canavesi, op. cit.
(40) App. Roma 6 ottobre 2014, n. 7614, in www.ilgiuslavorista.it, 26 gennaio 2015, per cui “la situazione soggettiva del
lavoratore non costituisce un diritto potestativo, atteso che il
prolungamento del rapporto di lavoro viene configurato soltanto come obiettivo oggetto di incentivazione, presupponendo
quindi pur sempre un accordo tra le parti, in mancanza del
quale opera il limite generale dei 66 (una volta 65) anni di età
anagrafica. (...) Questa interpretazione si fonda su chiari elementi letterali della norma dell’art. 24, D.L. n. 201/2011 che,
diversamente dal passato (...), non prevede una facoltà di opzione nella titolarità del lavoratore (...)”. Trib. Roma 5 febbraio
2015, Est. Baroncini, in www.ilgiuslavorista.it, 9 aprile 2015; Id.
26 gennaio 2015, cit.; 30 aprile 2014, in Nuovo notiziario giuridico, 2014, 2, 497; 17 dicembre 2013, cit. In dottrina, S. Piccininno (1), Età pensionabile flessibile e cessazione del rapporto di
lavoro nel sistema della riforma pensionistica del 2001, ADL,
2014, p. 32 ss; M. Miscione - V. Amato, Pensione di vecchiaia
e trattenimento in servizio, in Dir. prat. lav., n. 36/2014, 1903 ss.
769
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
va, non implicherebbe la vincolatività, per il datore di lavoro, della scelta operata dal dipendente,
che è invece soggetta al necessario reciproco consenso.
La questione, da ultimo, sembrerebbe risolta una
volta per tutte dalle Sezioni Unite (41), le quali
hanno recisamente negato che la norma preveda
l’insorgenza di alcun diritto potestativo in capo al
lavoratore.
La Corte articola le proprie argomentazioni in due
passaggi.
In primo luogo si cerca di ricostruire il significato
della dibattuta previsione che fa salvi dall’applicazione della norma i “limiti ordinamentali” dei singoli settori. Secondo le Sezioni Unite il riferimento a questi limiti “non può essere inteso nel senso
che la incentivazione è subordinata alla regolamentazione del rapporto di lavoro esistente nel settore preso in esame, come risultante dalle disposizioni di legge e di contrattazione collettiva allo
stesso applicabile”, dato che, altrimenti, “l’incentivazione alla prosecuzione fino a settanta anni si ridurrebbe a ben poca cosa”, ma è relativo invece alle “disposizioni che, sul piano legislativo regolano
gli specifici comparti (individuati sulla base della
disciplina del rapporto tanto sul piano della regolazione sostanziale che di quella previdenziale) di appartenenza del lavoratore e che potrebbero essere
ostativi al nuovo regime previsto dalla disposizione
in esame”. A conferma di questa conclusione, viene richiamata la norma di interpretazione autentica ex art. 2, comma 5, D.L. n. 101/2013 che, appunto, ribadisce l’intangibilità dei limiti previsti
per il collocamento a riposo nel pubblico impiego.
Entrando poi nel merito della situazione giuridica
azionata, la Corte ritiene che l’art. 24 non attribuisca alcun diritto di opzione ma semplicemente preveda, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, la possibilità di prestare il proprio lavoro anziché chiedere il pensionamento. In tal senso, secondo il Giudice di legittimità la locuzione “è incentivato... dall’operare dei coefficienti di trasformazione...” presupporrebbe “che non solo si siano create dette più
favorevoli condizioni previdenziali, ma anche che,
grazie all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto
sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.
Per cui, prosegue la sentenza, l’applicazione dell’art. 18 St. lav. non è precondizione alla prosecuzione del rapporto, ma consegue al perfezionamento della fattispecie costituita da prosecuzione consensuale del rapporto e operatività dei coefficienti
di trasformazione.
L’autorevole soluzione lascia aperti alcuni interrogativi.
Circa il riferimento ai limiti ordinamentali, è pacifico che di tali limiti, per cui opera la risoluzione
automatica del rapporto, si parli solo nell’ambito
del pubblico impiego: il legislatore (si veda supra,
par. 1) ha voluto escludere dal meccanismo di prosieguo del rapporto i lavoratori pubblici, forse proprio per quel risparmio di spesa menzionato tra gli
obiettivi della legge. Tant’è vero che successivamente, per dirimere ogni dubbio interpretativo, questa volontà è stata esplicitata dal D.L. n.
101/2013 cui si riferisce la sentenza. Ciò detto, se i
limiti richiamati dall’art. 24, comma 4 hanno valenza trasversale, ricomprendendo anche il settore
privato, resta da stabilire quali siano queste disposizioni che dal punto di vista sostanziale e previdenziale costituirebbero una preclusione al proseguimento dell’attività. In particolare, se identificassimo tali norme in quelle disciplinanti i requisiti di
accesso alla pensione, come opererebbe il meccanismo di prosecuzione, che dovrebbe invece travalicare proprio questi limiti?
Spostandoci alla natura della situazione giuridica
azionata, secondo il Collegio l’art. 24 non interviene sul sistema di libera recedibilità ma semplicemente prefigura degli incentivi previdenziali che
indurrebbero il lavoratore alla prosecuzione del
rapporto, il quale continua non per effetto dell’esercizio di un potere unilaterale del dipendente,
ma in presenza del necessario consenso datoriale.
Pertanto, una volta perfezionatosi l’accordo tra le
parti incoraggiato dalle favorevoli condizioni previdenziali, la legge vi collegherebbe la conservazione
del regime ex art. 18 Stat. lav. E qui sorge una domanda: al di là dei contrapposti orientamenti, sia-
(41) Cass. SS. UU., 4 settembre 2015, n. 17589, con nota
adesiva di V. Amato, Nessun “diritto al lavoro” fino al settantesimo anno di età, in Lav. Giur.., 2016, pp. 165 ss. e di S. Piccininno (2), Flessibilità dell’età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la riforma delle pensioni, Arg dir. lav.,
2015, 1272 ss. Meno convinto il commento di M. Russo (3),
Incentivazione al proseguimento del rapporto di lavoro fino a
settant’anni: chi, come e perché, di prossima pubblicazione in
Riv giur. lav., n. 2/2016. Tale orientamento è stato ribadito dalla
S.C. (Sez. lav.) nella sent. 1° febbraio 2016, n. 1850 e recepito
nel merito da Trib. Roma 6 ottobre 2015, n. 8437, Est. Sordi,
commentata da M. Russo, op. cit. (3); Trib. Como 21 gennaio
2016, Est. Mancini, in www.ilgiuslavorista.it, 22 febbraio 2016:
Trib. Lucca 15 gennaio 2016, in www.ilgiuslavorista.it, 12 febbraio 2016; Trib. Napoli 7 ottobre 2015 in www.ilgiuslavorista.it, 28 ottobre 2015.
770
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
mo sicuri che l’art. 24 faccia discendere dal raggiungimento di un accordo o dall’esercizio di un diritto potestativo (a seconda di come venga inteso)
l’applicazione del regime di stabilità? Viste le reticenze del legislatore, si potrebbe percorrere un’altra
via per integrare queste disposizioni nel sistema?
Esaminiamo quindi la lettera della legge, onde stabilire se effettivamente preveda la necessità di un
accordo oppure un diritto di opzione a cui venga
collegato il perdurare delle tutele.
In questa operazione può esserci d’aiuto un confronto tra l’art. 24 ed il testo degli artt. 6 del D.L.
n. 791/1981 e della L. n. 407/1990, per vedere se
ci siano analogie o diversità rispetto al passato.
L’art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 (e similmente la
norma del 1990) prevede che gli iscritti all’AGO e
alle gestioni sostitutive ed esclusive “possono optare di continuare a prestare la loro opera” (comma
1) con comunicazione al datore di lavoro almeno
sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (comma 2), che
nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato
l’opzione si applichino le disposizioni ex lege n.
604/1966 (comma 4), e il rapporto termini senza
necessità di preavviso una volta esaurito l’effetto di
tale opzione (comma 6). Ci troviamo di fronte ad
una fattispecie complessa, in cui la scelta del lavoratore, esplicitata nelle forme stabilite dalla legge,
funge da elemento costitutivo dell’estensione delle
tutele. A ben vedere, l’orientamento delle Sezioni
Unite sembra riecheggiare proprio questa costruzione, con una differenza (42): anche per la S.C. il
mantenimento del regime di stabilità è frutto di
una fattispecie a formazione progressiva tuttavia,
mentre in passato elemento di tale fattispecie era
l’opzione formalmente esercitata dal lavoratore per
proseguire il rapporto ora, con un regresso rispetto
alla previgente disciplina, questo ruolo sarebbe rivestito dall’accordo tra le parti.
Salta tuttavia all’occhio una differenza non da poco tra le precedenti disposizioni e la normativa attuale. Se prima l’opzione del lavoratore aveva
un’incidenza positiva, in quanto vi si ricollegava il
perdurare della stabilità, o negativa, poiché il suo
mancato esercizio nei termini impediva il mantenimento delle tutele, l’art. 24 non prevede nulla di
tutto questo, ma indica semplicemente la presenza
di un incentivo previdenziale e stabilisce l’applicazione dell’art. 18 St. lav. fino al conseguimento del
limite massimo di flessibilità. Il periodo inerente le
sanzioni contro il licenziamento non è retto, te-
stualmente, dal termine “incentivato” né, tanto
meno, si menziona espressamente il mutuo consenso quale condizione della tutela o comunque presupposto che delimiti il campo operativo della norma.
Quindi, posto che la disposizione nulla dice al riguardo - e ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit -, vediamo che in questo caso la paralisi della libera recedibilità non è soggetta ad alcun elemento ulteriore, sia esso un’opzione o un accordo, discendendo invece in via immediata dalla legge. Il lavoratore non ha mai un diritto potestativo a proseguire la
propria attività lavorativa, diritto che d’altro canto
non aveva neppure prima del raggiungimento dei
requisiti pensionistici. Conserva, invece, un altro
genere di diritto, cioè quello a vedere il proprio licenziamento illegittimo sanzionato con le specifiche tutele, ma è importante sottolineare che questo beneficio prescinde da una vicenda diacronica
di cui sia elemento costitutivo una decisione unilaterale o un accordo tra parti.
Ciò detto, per comprovare il nostro assunto osserviamo la lettera della norma anche attraverso l’altra lente indicataci dall’art. 12 delle Preleggi, ossia
l’intenzione del legislatore. Questa intenzione è
chiara ed esplicitata non solo dal Preambolo al decreto, ma anche dallo stesso art. 24, che al comma
1 esprime la finalità di “garantire il rispetto, degli
impegni internazionali e con l’Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e (...) rafforzare la sostenibilità di lungo periodo
del sistema pensionistico in termini di incidenza
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”. Pare in evidente conflitto con gli scopi della
norma una lettura che subordini il perseguimento
di tali interessi primari alla volontà del datore di
lavoro il quale, invece, sarebbe indotto a licenziare
un dipendente maggiormente oneroso in termini di
salario e contributi previdenziali. D’altro canto,
l’incongruenza di una simile ricostruzione emerge
pure ove si consideri che, seguendo questo orientamento, mentre la vecchia disciplina delle opzioni
vincolava il datore di lavoro alla scelta del dipendente di proseguire il rapporto, ora per assurdo la
prosecuzione non sarebbe più imposta ma rimessa
al consenso datoriale, benché il decreto sia stato
adottato proprio per conseguire il risparmio di spesa previdenziale necessitato dalla ben più grave situazione economica e dall’obbligo di far fronte agli
impegni comunitari e internazionali.
(42) Art. 6, D.L. n. 791/1981; art. 6, L. n. 407/1990.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
771
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
Quindi, mancando elementi letterali che depongano in senso restrittivo e alla luce della ratio legis,
giungiamo ad altra conclusione, ossia che l’art. 24
prevede l’estensione automatica, fino al limite progressivamente adeguato dei settant’anni d’età, del
regime di tutela, incidendo quale norma speciale
sull’art. 4 della L. n. 108/1990, nel senso che nell’ambito di applicazione dell’art. 18 St. lav. il raggiungimento dei requisiti pensionistici non determina più la perdita della stabilità. In quest’ottica,
risulta coerente con la protezione degli interessi
pubblicistici sottostanti che pure il mantenimento
delle tutele verso il licenziamento costituisca, di
per sé, un incentivo alla scelta del lavoratore di
non richiedere il pensionamento. Anche se, bisogna precisarlo, il rapporto continua come prima,
per cui il potere di recesso datoriale non viene affatto paralizzato, ma anzi può benissimo colpire pure il dipendente il cui rapporto prosegua, ove ricorrano le cause previste dall’ordinamento (si veda infra, par. 3), come ad esempio la commissione di un
illecito disciplinare, l’inidoneità alle mansioni e il
giustificato motivo oggettivo in genere, o nel caso
di licenziamento collettivo - dove, peraltro, il criterio della prossimità al pensionamento assume
piena legittimità nella costante giurisprudenza di
Cassazione (43).
D’altro canto, accogliendo l’autorevole orientamento della S.C., sorgono alcuni problemi applicativi di non poco momento che, di certo, richiederebbero un’ulteriore opera chiarificatrice.
Ad esempio, rimangono inspiegate le modalità attraverso le quali il datore di lavoro dovrebbe esplicitare il proprio consenso. Deve farlo in forma
espressa oppure bastano anche dei comportamenti
concludenti (44)? Ed entro quando deve manifestare il consenso? Ritenendo possibile anche un consenso tacito, come fa il datore che invece sia dissenziente a sapere con certezza quando il lavoratore
raggiunge i requisiti pensionistici, e quindi a bloccare un’eventuale prosecuzione della stabilità fino
al limite dell’art. 24, visto che non ha in alcun
modo accesso all’estratto conto previdenziale del
dipendente? Possiamo ipotizzare che in questo caso
vi sia un diritto di accesso agli atti che prevalga su
quello alla riservatezza del lavoratore?
Peraltro, a proposito di consenso tacito, sia consentita un’osservazione. A prescindere dall’art. 24 e
sul piano della disciplina generale, se un lavoratore
vuole continuare la propria attività potrà in ogni
caso farlo sul presupposto che non c’è estinzione
automatica del rapporto ma, per porvi fine, occorre
pur sempre un atto formale di licenziamento. E infatti, “dalla legge 1 maggio 1990, n. 108, art. 4 si
desume che, nel lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti
per la effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (...) da parte del
lavoratore determinano soltanto la recedibilità ‘ad
nutum’ del rapporto di lavoro e, dunque, il venire
meno del regime di stabilità, non già la automatica
estinzione del rapporto stesso, sicché, in assenza di
un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il
rapporto prosegue (45)”. Ma è palese che il mancato esercizio da parte del datore del potere di recedere ad nutum non implica il consenso alla prosecuzione del rapporto.
Altre questioni sorgono sulla possibilità di apporre
un termine all’accordo sulla prosecuzione. Di certo,
per quanto concerne gli accordi individuali, non
sarebbe possibile circoscriverli ad un’età più bassa
rispetto a quella prevista dall’art. 24, comma 4, pena la nullità per contrasto con norma imperativa e
l’automatica sostituzione della clausola invalida ai
sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. Al contrario, anche se risulta ipotesi di scuola - una simile operazione, preclusa alla contrattazione collettiva nazionale in quanto peggiorativa rispetto alla legge,
potrebbe essere posta in essere con un contratto ex
art. 8, D.L. n. 138/2011, che incida sulle conseguenze del licenziamento prevedendo la libera recedibilità a partire da un limite inferiore rispetto a
quello di settant’anni (progressivamente adeguato)
stabilito dalla norma.
Infine, un pregnante interrogativo di fondo: se è
necessario l’assenso del datore per la prosecuzione
del rapporto con il mantenimento della tutela, la
norma non risulterebbe inutile? Infatti un meccanismo del genere, che differisca per il lavoratore
(43) Sulla legittimità di tale criterio, ex multis Cass. 3 luglio
2015, n. 13794; 20 febbraio 2013, n. 4186.
(44) Si veda infatti Trib. Roma 6 ottobre 2015, cit., per cui il
consenso datoriale, stante il principio di libertà di forma ex art.
1350 c.c., è manifestabile anche per facta concludentia e, anzi,
sussiste “un vero e proprio onere del datore di lavoro di manifestare il proprio dissenso tempestivamente ossia prima del raggiungimento dell’indicato limite d’età” (nel caso di specie, del li-
mite d’età previsto dal contratto collettivo). Così pure Trib. Como 21 gennaio 2016, cit. Di diverso avviso, invece, Trib. Napoli
7 ottobre 2015, cit.; Trib. Roma 5 febbraio 2015, cit.
(45) Cass. 29 dicembre 2014, n. 27425; 24 aprile 2014, n.
9312; 5 marzo 2003, n. 3237; 20 aprile 1999, n. 3907: ne consegue che il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di preavviso nella risoluzione del rapporto.
772
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
pensionabile l’acausalità del licenziamento in forza
di un accordo, sarebbe comunque possibile anche
in assenza dell’art. 24, comma 4, e pure nell’ambito
della tutela obbligatoria, visto che già lo stesso art.
24, al comma 16, estendeva fino al settantesimo
anno d’età e oltre i coefficienti di trasformazione
previsti dall’art. 1, comma 6, L. n. 335/1995, senza
distinguere a seconda dei requisiti dimensionali
delle aziende coinvolte. Giova precisare, peraltro,
che nessuna distinzione è operata neppure dai successivi D.M. 15 maggio 2012 e 22 giugno
2015 (46), i quali sono intervenuti in via specifica
determinando i coefficienti fino a questo nuovo limite di flessibilità.
Tutte le questioni testé sollevate complicano notevolmente il quadro in cui si inserisce l’interpretazione data dalle Sezioni Unite e inducono ancor di
più a militare per una diversa posizione: con l’art.
24, il legislatore è pervenuto ad un risultato verosimilmente sottovalutato e non considerato, ossia
una modifica a quanto disposto dall’art. 4 della L.
n. 108/1990.
Rimane da considerare un ultimo aspetto della
norma, ossia come debba essere qualificato il licenziamento intimato per raggiunti limiti d’età.
La tematica, già affrontata con riferimento alle
vecchie ipotesi di opzione, trova oggi nuovo vigore
nella disciplina dell’art. 24 e, ancora una volta, la
giurisprudenza risulta divisa nella qualificazione
della fattispecie.
Alcune decisioni ricorrono alla categoria della c.d.
nullità virtuale (47): l’art. 24, comma 4 configurerebbe una norma imperativa e, pertanto, il licen-
ziamento intimato in sua violazione, per possesso
dei requisiti pensionistici, sarebbe nullo ex art.
1418 c.c. Questa, d’altronde, era già l’opinione che
si era formata con riferimento agli artt. 6 del D.L.
n. 789/1981 e 6 della L. n. 407/1990 (48), dai quali
la giurisprudenza ricavava un divieto di licenziamento individuale per raggiunti limiti di età che
comunque non precludeva la licenziabilità per altri
motivi. E, in questo caso, la nullità investiva non
solo il recesso, ma lo stesso rifiuto del datore di
consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa
malgrado l’esercizio della prevista facoltà. In ogni
caso, non vi sarebbe stato alcun mutamento del regime di stabilità a cui il rapporto era assoggettato, “ad esso continuando ad applicarsi, dopo l’avvenuto ripristino (...) la tutela obbligatoria (ex art. 8
legge n. 604/1966) ovvero la tutela reale (ex art.
18 legge n. 300/1970) quali erano applicabili in
precedenza, prima cioè della intervenuta causa di
nullità di diritto comune (49)”.
Ad avviso di chi scrive una simile soluzione non
può essere accolta perché, leggendo queste pronunce, possiamo vedere come le stesse muovano da
una visione forse condizionata dalle categorie inerenti alle vecchie ipotesi di opzione.
Come noto, nella teoria generale del diritto norma
imperativa è quella che impone ad un soggetto “un
dover-fare o un non-poter fare incondizionato (50)”; in questo tali disposizioni si distinguono
da quelle costitutive o di competenza, che “non prescrivono un comportamento, ma indicano l’effetto
giuridico che segue ad un determinato fatto (51)”.
Tuttavia non sempre, a fronte di una norma imperativa, vi è l’indicazione dell’effetto riconnesso alla
sua violazione: soccorre quindi la teoria della c.d.
“nullità virtuale”, elaborata proprio per individuare
le conseguenze della violazione delle norme impe-
(46) Decreti del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 e del
22 giugno 2015 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
(47) Trib. Torino 29 marzo 2013, cit.; C. App. Torino 24 ottobre 2013, cit.
(48) Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 465; Cass. 3 giugno
2000, n. 7433; 10 giugno 1998, n. 5787; 12 agosto 1997, n.
7495; 5 maggio 1995, n. 4904; 20 agosto 1993, n. 8825; 13
novembre 1992, n. 12233.
(49) Cass. 8 novembre 1999, n. 12419. Cfr. pure Cass. 14
agosto 2008, n. 21702. Si tratta di pronunce che rimandano a
Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 465, con nota di Gramiccia,
Opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro e invalidità
del licenziamento, Mass. Giur. lav., 1994, 660; Id. 8 giugno
1994, n. 225, con nota di Pileggi (3), La Corte Costituzionale ritorna sull’opzione del dirigente, Giur. cost., 1994, 3169; 18 giugno 1992, n. 309.
(50) F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I,
Milano, 1957, 47. Questo perché, come rileva G. Ferraro, Intervento, in Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Atti
delle giornate di studio di Diritto del lavoro, Modena, 18 - 19
aprile 2008, Milano, 2009, 269 ss., “L’inderogabilità qualifica
determinate norme in relazione agli interessi implicati, che sono interessi i quali investono l’intera collettività o, comunque,
interessi che riguardano una parte notevole della nostra comunità. Sono interessi superiori, per intenderci, cioè interessi che
prescindono dalla considerazione e dalla esigenza di tutela del
singolo lavoratore, che è soltanto uno strumento all’interno di
un processo più ampio, nell’ambito del quale l’Ordinamento ritiene che alcuni valori, alcuni obiettivi, alcuni principi debbano
essere tutelati con particolare rigidità”. La dottrina, tuttavia,
non è concorde sul punto: si veda ad esempio M. Novella,
L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale, Milano, 2009, 77, per cui “ai fini della configurazione di un’ipotesi di contrarietà a norma imperativa risulta del tutto ininfluente il tipo di interessi previsti dall’ordinamento attraverso la norma imperativa (...)”.
(51) M. Novella, op. cit., 22, che a questo proposito fa l’esempio della norma che collega il fatto illecito alla configurazione dell’obbligo di risarcire il danno.
Il lavoratore licenziato per
raggiungimento dell’età pensionabile
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
773
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
rative sprovviste di sanzione espressa. L’esame della
struttura normativa rivela come nella stessa non vi
sia alcun comando o divieto (si veda supra, par. 2),
ma solo un diritto a mantenere le tutele (52). Semmai, se proprio si vuole procedere ad una qualificazione, l’art. 24 non è norma imperativa, ma costitutiva, che indica solamente gli effetti connessi
(ma, si precisa, scaturenti solo in via mediata) alla
scelta del lavoratore di continuare a lavorare: in
particolare l’effetto previdenziale del calcolo dei
coefficienti di trasformazione e quello sanzionatorio di applicazione dell’art. 18 Stat. lav., fino al settantesimo anno d’età.
La giurisprudenza in parola fa quindi discendere la
nullità virtuale dalla violazione di un precetto che
non esiste. Al contrario, i presupposti a cui ricondurre l’illegittimità di tali ipotesi di recesso sono
quelli generali, pertanto il licenziamento irrogato
in ragione dell’età pensionabile, ma prima del limite massimo di flessibilità è, semplicemente, ingiustificato, con applicazione delle tutele indennitarie
previste dagli artt. 18, comma 5, Stat. lav. e 3,
comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
Ciò detto, resta da chiedersi se l’ingiustificatezza rilevi sotto altro e diverso profilo. Certa dottrina e
giurisprudenza sembrano adombrare che il riferimento al fattore età, o meglio al raggiungimento
dei requisiti anagrafico e contributivo per la pensione, possa implicare un’ingiustificatezza qualificata e, in particolare, una discriminazione per
età (53). Per tale via troverebbe sanzione anche il
licenziamento dei lavoratori occupati in imprese
soggette a stabilità obbligatoria e quello dei dirigenti, visto che la reintegrazione opera a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia o meno
caratterizzato da un regime di recedibilità ad nu-
tum. Con qualche difficoltà applicativa poiché, pure qui, si ripropongono i medesimi problemi inerenti l’esclusività o meno dell’intento discriminatorio; se in sede comunitaria prevale una nozione oggettiva della discriminatorietà (54), la giurisprudenza nazionale (55) continua ad essere assestata
su una concezione soggettiva secondo la quale è richiesta la prova (56) dell’intenzionalità ed esclusività del motivo discriminatorio, in un’impostazione
che fonde e confonde la nozione di discriminazione
e quella di motivo illecito determinante (57).
Questa, ictu oculi, sembrerebbe la conclusione cui
pervenire alla luce della Dir. 2000/78/CE: in quanto discriminazione per età, sarebbero illegittime
previsioni normative o clausole contrattuali che
prevedano la risoluzione del rapporto in ragione
del conseguimento dell’età pensionabile (58). Anche se, bisogna dirlo, la posizione della Corte di
Giustizia non è univoca, ma modulata secondo le
specifiche caratteristiche del caso concreto (59).
Una serie di considerazioni evidenziano tuttavia i
problemi sottesi a questa ricostruzione.
Già ad una prima analisi, se optiamo per la discriminatorietà ci troviamo di fronte ad un cane che si
morde la coda. Di fatto si arriva a dire che l’art. 4
statuisce che il raggiungimento dei requisiti pensionistici sia il presupposto per la libera recedibilità,
ma non possa assurgere a legittima causale del recesso, o meglio che sarebbe ammissibile il licenziamento ogniqualvolta non sia motivato da ragioni
(discriminatorie e in particolare) inerenti all’età.
Questa affermazione implica un’evidente contraddizione concettuale: a ben vedere, infatti, proprio
il fattore età opera quale fondamento (esclusivo o
con altri motivi) del licenziamento, facendo venir
meno la necessità di una giustificazione causale.
(52) E questo lo rilevava già A. Pileggi, op. cit. (2), 163 con
riferimento alle opzioni di cui al D.L. n. 791/1981 e alla L. n.
407/1990.
(53) O. Bonardi, op. cit.
(54) Si veda anche nel merito, Trib. Roma 14 ottobre 2014,
Est. Armone, in www.osservatoriodiscriminazioni.org, che rileva
come vi siano plurimi indici normativi da cui sia desumibile
una propensione del legislatore verso l’abbandono di una concezione soggettivistica in favore di una concezione oggettiva
della discriminazione (ad es. l’art. 2 del D.Lgs. n. 216/2003,
l’art. 4 della L. n. 125/1991). In dottrina (C. Cester, op. cit.) si
sottolinea che è questa, in materia di licenziamenti, la direzione indicata a livello normativo: infatti, l’art. 18, comma 1, Stat.
lav., nella versione ex lege n. 92/2012, distingue nettamente l’ipotesi di licenziamento discriminatorio da quello per motivo illecito. Ci si è chiesti se la mancata menzione, nell’art. 2,
D.Lgs. n. 23/2015, del motivo illecito riconduca ad unità le due
nozioni, con conseguente reviviscenza della connotazione soggettiva e volontaristica della discriminazione: soluzione, questa, che sembra doversi escludere, visto che il licenziamento
per motivo illecito non appare scomparso dall’orizzonte so-
stanziale della disposizione, né la formula della legge delega
pare sottintendere una diversa nozione strutturale di licenziamento discriminatorio.
(55) Cass., Sez. lav., 16 luglio 2015, n. 14928 e la giurisprudenza ivi richiamata; 8 agosto 2011, n. 17087; 9 marzo 2011,
n. 5555 e le pronunce ivi richiamate.
(56) Il cui onere è in capo al lavoratore che agisce in giudizio. Per una disamina in materia, cfr. E. Tarquini, I licenziamenti
discriminatori, in M. Cinelli - G. Ferraro - O. Mazzotta (a cura
di), Il nuovo mercato del lavoro, Milano, 2013, 253 ss.
(57) Questo anche per una circostanza di ordine meramente pratico, ossia il fatto che la casistica giurisprudenziale è dominata dai casi di licenziamento a scopi ritorsivi, mentre rari
sono gli altri casi di licenziamento discriminatorio: si veda M.T.
Crotti - M. Marzani, La disciplina del licenziamento per motivi
discriminatori o illeciti, in M. Magnani - M. Tiraboschi (a cura
di), La riforma del lavoro,Milano, 2012, 221 ss.
(58) Tra le molte, Corte di Giustizia UE 13 settembre 2011,
causa C-447/09, Prigge e a.
(59) Per una disamina in materia, D. Izzi, Invecchiamento attivo e pensionamenti forzati, in Riv. it. dir. lav., 2014, 4, 484.
774
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Dottrina
Rapporto di lavoro
Ravvisando una discriminazione per età, quindi, si
rischierebbe di far ricadere nell’alveo della discriminatorietà ogni recesso intimato ex art. 4, L. n.
108/1990, riecheggiando quella dottrina (60) - irta
di difficoltà applicative- che ampliava a dismisura
l’area del licenziamento discriminatorio e, ancor di
più, travolgendo la volontà legislativa sottesa all’art. 24, comma 4, D.L. n. 201, per cui sono esclusi dalla prosecuzione fino a settant’anni i lavoratori
delle imprese soggette a stabilità obbligatoria. E infatti nell’ambito di questo orientamento c’è chi va
direttamente oltre, concludendo per l’incompatibilità della libera recedibilità con la Dir.
2000/78/CE (61).
Ma vi sono anche altre, più pregnanti, osservazioni. Quand’anche si ritenesse che il licenziamento
per raggiungimento dei requisiti pensionistici integri discriminazione per età o, ancor di più, che
l’art. 4 della l. n. 108/1990 debba essere disapplicato per contrasto con la Dir. 2000/78/CE, in tale direttiva c’è pur sempre un articolo 6 par. 1 che
esclude la sussistenza di una discriminazione ove la
disparità di trattamento sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima,
compresi obiettivi di politica del lavoro (62), e i
mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari.
Proviamo quindi a sottoporre la norma a prova di
resistenza, modulandone l’analisi secondo i principi
comunitari.
Dal punto di vista teleologico, a più riprese la Corte costituzionale ha esplicitato che l’assenza di stabilità viene ammessa proprio perché, quale contro-
partita, i lavoratori pensionabili possono accedere
al trattamento di quiescenza: la mancata piena tutela è il riflesso giuridico dell’esigenza pratica, valutabile discrezionalmente dal legislatore, di garantire il necessario ricambio generazionale (63). Scopo,
questo, che rientra appieno tra le finalità di politica sociale indicate nella direttiva. D’altro canto, la
mancata specificazione degli obiettivi sottesi alla
norma è irrilevante visto che, secondo la giurisprudenza comunitaria, basta che essi siano desumibili
dal contesto generale della misura interessata (64).
Inoltre, si badi bene, nel caso di specie non viene
in rilievo l’età per se stessa, ma l’età unitamente alla possibilità di conseguire un trattamento di quiescenza: la stessa Corte di giustizia ha ritenuto che
le norme sulla libera recedibilità per possesso dei
requisiti pensionistici (nel caso considerato, rectius,
le clausole colletive sul pensionamento obbligatorio) non fossero irragionevoli, ma costituissero misure appropriate e necessarie “in quanto la normativa pertinente non si basa unicamente su un’età
determinata, ma prende altresì in considerazione la
circostanza che gli interessati beneficino al termine
della loro carriera professionale di una compensazione economica per mezzo della concessione di
una pensione di vecchiaia” (65).
Da ultimo, una questione trasversale al tipo di sanzione applicabile potrebbe sorgere circa il risarcimento del danno, e in particolare sulla deducibilità
a titolo di aliunde perceptum del trattamento pensionistico medio tempore percepito: se già in passato
c’era chi propendeva per una risposta affermativa (66), la giurisprudenza maggioritaria sembra in-
(60) M. T. Carinci, Il licenziamento discriminatorio o “per motivo illecito determinante” alla luce dei princìpi civilisti: la causa
del licenziamento, Riv. giur. lav., 2012, 641.
(61) O. Bonardi, op. cit., 162; cfr. anche Trib. Genova 3 dicembre 2012, cit.
(62) Benché in dottrina vi sia chi ritiene che le disparità legate al fattore età siano giustificate solo ove attuate allo scopo
di recare un vantaggio allo stesso gruppo di soggetti destinatari del trattamento (così O. Bonardi, op. cit., 125 ss.), la Corte
di Giustizia invece assume invece altra direzione, ritenendo legittimi trattamenti differenziati anche se a vantaggio di categorie diverse: ad esempio, nella tematica che ci interessa, al fine
di favorire l’occupazione giovanile e garantire un’equa ripartizione generazionale. Cfr., ex multis, Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, cause riunite C-159/10 e C-160/10, Fuchs.
(63) Corte cost. 1° febbraio 1983, n. 15; 14 luglio 1971, n.
174. D’altro canto, afferma la Corte di Giustizia, “la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità
legittima di politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri, in particolare laddove si tratta di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione”: così, richiamando la sentenza 18 novembre 2010 Georgiev, cause riunite C-250/09 e C268/09, ha statuito la Corte nella decisione del 21 luglio 2011,
Fuchs, cit., 49.
(64) Così Corte di Giustizia UE 5 marzo 2009, causa C-
388/07, Age Concern England. Ma, rileva la Corte, “Semplici
affermazioni generiche, riguardanti l’attitudine di un provvedimento determinato a partecipare alla politica del lavoro, del
mercato del lavoro o della formazione professionale, non sono
sufficienti affinché risulti che l’obiettivo perseguito da tale
provvedimento possa essere tale da giustificare una deroga al
principio in discorso, né costituiscono elementi sulla scorta dei
quali poter ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti
siano atti alla realizzazione di tale obiettivo”. Spetta quindi al
giudice nazionale verificare se la norma risponde ad una finalità legittima ed i mezzi adottati siano appropriati e necessari. In
questo senso anche Corte di Giustizia UE 21 luglio 2011, C159/10 e C-160/10, Fuchs, cit., punto 39; 12 ottobre 2010, causa C-45/09, Rosenbladt, punto 58; 12 gennaio 2010, causa C341/08, Petersen, punto 40; 16 ottobre 2007, causa C-411/05,
Palacios de la Villa, punti 56 e 57. Si veda F. Amato, Discriminazione per età: Cenerentola troverà la sua scarpetta?, in DL-Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico, 2009, 1, 96;
M. Russo, op. cit. (2). Nella giurisprudenza di merito, Trib. Genova 11 novembre 2013, cit.
(65) Corte di Giustizia UE 16 ottobre 2007, causa C-411/05,
Palacios de la Villa; così anche 5 luglio 2012, causa C-141/11,
Hörnfeldt, punto 42 e 12 ottobre 2010, causa C - 45/09, Rosenbladt, punto 48.
(66) Cfr. A. Pileggi, op. cit. (2), 133 ss., che menziona Cass.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
775
Sinergie Grafiche srl
Dottrina
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rapporto di lavoro
vece orientata in senso contrario. Questo perché
“il diritto alla pensione discende dal verificarsi di
requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge,
prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro e non si pone, di
per sé, come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche che il lavoratore
ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto
estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si
sottraggono all’operatività della regola della ‘compensatio lucri cum damno’” (67). Nel caso di specie,
poi, la declaratoria di illegittimità travolgerebbe ex
tunc il diritto al pensionamento, con conseguente
ripetizione da parte dell’ente previdenziale degli
importi percepiti, che quindi non si traducono in
un arricchimento patrimoniale per il lavoratore.
Brevi considerazioni finali
Per quanto si sia cercato di sbrogliare l’intricata
matassa legislativa, l’esame del testo normativo
evidenzia notevoli aporie che richiederebbero, in
ultima analisi, un intervento chiarificatore del legislatore. La pronuncia delle Sezioni Unite, infatti,
non sembra dirimente, e d’altronde un testo legi-
5 giugno 1996, n. 5228.
(67) Cass., SS. UU., 13 agosto 2002, n. 12194 ripresa, tra le
molte, da Cass. 15 luglio 2014, n. 16143 e 14 giugno 2007, n.
13871; Cass. 19 maggio 2000, n. 6548, con nota di C. Corsinovi, Risarcimento del danno da licenziamento illegittimo e deducibilita delle erogazioni pensionistiche percepite medio tempore
dal lavoratore, Riv. it. dir. lav., 2001, 351. Cfr. anche Fondazione
Studi Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del lavoro,
Parere 13 febbraio 2012, n. 4. Questa soluzione si spiega sulla
base dell’assunto (non pacifico in giurisprudenza) che, in materia di compensatio lucri cum damno, il pregiudizio e l’incremento patrimoniale si fondino sul medesimo fatto. Si segnala
Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26988 in cui, a fronte di
una precedente sentenza che aveva dedotto dal risarcimento
del danno quanto percepito dal lavoratore a titolo pensionistico, il datore di lavoro ha subito l’ulteriore condanna a restituire
all’ente previdenziale i ratei portati in detrazione dalle somme
corrisposte a titolo risarcitorio.
776
slativo sì lacunoso non rende di certo agevole il
compito per l’interprete. Lacunosità probabilmente
dovuta ad una tecnica legislativa convulsa, a suon
di decretazione d’urgenza, che lascia poco tempo
non solo per ponderare gli effetti della legge, ma
anche per elaborare un testo dotato di sufficiente
chiarezza sistematica.
D’altro canto, sul piano della politica del diritto,
simili operazioni lasciano senz’altro perplessi: se
scopo del legislatore è incrementare l’occupazione
giovanile, ci si rende conto che è un po’ difficile
perseguire l’obiettivo prolungando ad libitum la vita
lavorativa dei più anziani e prevedendo, quale contraltare, il palliativo di una drastica riduzione delle
tutele per i nuovi assunti (68). Ma, paradossalmente, si ritiene che solo questa possa essere la via da
percorrere se si vuole che un domani i sistemi pensionistici siano in grado di garantire pensioni adeguate anche alle future generazioni (69).
Ciò rende evidente l’urgenza di porre mano al sistema previdenziale, adottando scelte coraggiose
che abbattano privilegi acquisiti, verso la generale
corrispettività delle prestazioni in un’ottica di necessaria equità intergenerazionale.
(68) Cfr. M. Russo, op. cit. (1); M. Cinelli, op. cit. Quest’ultimo Autore rileva inoltre come tali misure possano determinare
una notevole destabilizzazione, almeno nell’immediato, nelle
programmazioni aziendali, con una possibile discrasia rispetto
a quanto delineato nello stesso decreto che prevede, all’opposto (art. 4, commi 1-7), misure di incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani, configurando una sorta di prepensionamento:
le politiche di elevazione dell’età pensionabile finiranno col “favorire le istanze di implementazione degli ammortizzatori sociali e, dunque, per porsi in contrasto, di fatto, con le politiche
di contenimento della spesa, indubbiamente rilevanti anche in
quel settore ”.
(69) Si veda, al proposito, The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU,
redatto dalla Commissione europea e dal Social Protection
Committee, il cui testo è reperibile all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro autonomo
Tutela della paternità
Indennità di maternità e diritti
del padre avvocato
Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016, n. 8594 - Pres. G. Napoletano - Rel. G. Bronzini C.E. c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Indennità di maternità - Libere professioniste - Mancata estensione della provvidenza al padre avvocato al di là delle
ipotesi espressamente previste - Discriminazione - Non sussiste
(D.Lgs. 26 marzo 2001, art. 70)
L’indennità di maternità per le libere professioniste, disciplinata dall’art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001, è finalizzata, oltre che alla protezione del nascituro e del nucleo familiare, alla tutela della salute della madre biologica
che nel periodo anteriore e successivo al parto ha una posizione non assimilabile a quella del genitore di sesso
maschile, sicché, come evidenziato nella sentenza della Corte cost. n. 285 del 2010, non è irragionevole né discriminatoria la mancata estensione al padre della relativa provvidenza oltre le ipotesi di decesso e infermità
della madre o suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione e affidamento, Né l’ordinamento comunitario, che promuove l’equiparazione tra i sessi e la tutela antidiscriminatoria dei lavoratori, preclude l’adozione di misure specifiche a tutela della salute della donna durante la gravidanza o i primi mesi di maternità.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Corte cost. 28 luglio 2010, n. 285.
Difforme
Trib. Firenze, Sez. lav., 20 giugno 2008; Trib. Catania, 2 novembre 2011.
La Corte (omissis).
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega ex art. 360 c.p.c., n. 1 e 3
la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost., violazione
e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 70 e
72, così come dichiarati illegittimi dalla corte costituzionale con la sentenza n. 385/2005 nella parte in cui non
prevedono il principio che al padre spetti di percepire in
alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita
solo a quest’ultima. La decisione di primo grado era corretta e doveva essere confermata alla luce del dispositivo
della sentenza n. 385/2005 che dichiarava l’incostituzionalità sia dell’art. 70 sia dell’art. 72, senza fare alcun riferimento ai soli casi di adozione ed affido. La decisione di
incostituzionalità riguardava tutti i casi di paternità ed
aveva un chiaro carattere precettivo non creando alcun
vuoto normativo; in ogni caso implicava un obbligo di interpretazione conforme in senso antidiscriminatorio e volto a garantire parità di trattamento per padri e madri. Tale interpretazione costituzionalmente conforme era tanto
più legittima alla stregua dell’evoluzione del diritto Europeo con la direttiva sui congedi parentali ed alla luce dell’art. 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali del
9.12.1989. Inoltre la stessa legislazione italiana mostrava
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
una chiara tendenza ad estendere anche ai padri una serie
di misure volte a rafforzare il nucleo familiare ed a proteggere ed a valorizzare i bisogni e la personalità del bambino. La più recente sentenza n. 285/2010 non conferiva alcun crisma di legittimità costituzionale alla norma impugnata (art. 70) e comunque lasciava la possibilità di una
nuova remissione alla Corte della questione o comunque
di interpretare diversamente la medesima disposizione.
Il motivo appare infondato. Giova premettere che il caso sottoposto all’attenzione di questa Corte concerne la
domanda dell’Avv.to C. di percepire, a carico della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, l’indennità di maternità D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 70
in luogo della moglie in un caso di maternità (e paternità biologica): l’Avv.to C. invoca la precettività “autoapplicativa” della sentenza n. 385/2005 che non sarebbe
limitata al caso concretamente esaminato che concerneva la fattispecie di un genitore adottivo ed in ogni
caso richiama la necessità di una interpretazione “costituzionalmente” orientata adottata dal giudice di prime
cure) e comunque coerente con le linee evolutive del
diritto sovranazionale e dello stesso diritto interno che
tenderebbe ad assimilare, nell’interesse della protezione
nel suo complesso del nucleo familiare e della valorizzazione dei bisogni del bambino, la situazione del padre e
777
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro autonomo
della madre rispetto all’evento maternità, in funzione
antidiscriminatoria.
Questa Corte osserva che questioni sollevate hanno già
trovato una condivisibile e ragionevole risposta nella
sentenza n. 285/2010 con la quale la Corte costituzionale
ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70
(sollevata dalla Corte di appello di Venezia) con riferimento proprio ad un caso nel quale si rivendicava l’indennità di maternità per un padre biologico. La Corte
delle leggi in motivazione ha affermato che “la rimettente basa il proprio dubbio di costituzionalità sul presupposto che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, non consentendo al padre libero professionista di usufruire, al posto della madre, della indennità di maternità, non tiene conto
del principio secondo cui, in ragione del preminente interesse del bambino, i genitori devono godere di analoghe tutele in ambito lavorativo e, in particolare, del fatto
che il suddetto beneficio è riconosciuto al padre adottivo, libero professionista, per effetto della sentenza n. 385
del 2005 di questa Corte, e al padre lavoratore subordinato, in applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 28.
Tale questione non tiene conto che le situazioni poste a
raffronto sono tra loro differenti, pur essendo esse accomunate dalla finalità di protezione del minore. Occorre
a tal fine rilevare che la tutela della maternità e della
paternità è frutto di un’evoluzione normativa - L. 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); L. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro); L. 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) - che
trova oggi la sua sintesi nel D.Lgs. n. 151 del 2001. Il
legislatore con quest’ultimo testo normativo ha voluto
disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della
sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l’uguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie
di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all’interesse
preminente del bambino.
Sul punto assumono rilevanza le norme che riconoscono
in condizione di parità, al padre e alla madre, indipendentemente dall’essere genitori naturali o adottivi, il
congedo parentale (D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 32 e 36)
e i riposi giornalieri (D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 39, 40
e 45). A questa evoluzione normativa ha contribuito in
modo significativo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 371 del 2003, n. 197 del 2002, n. 405 del 2001).
Dall’esame della legislazione e della giurisprudenza richiamate si evince che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere
assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al
quale le posizioni del padre e della madre risultano del
tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline.
Diversamente, le norme poste direttamente a protezione
della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla
protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al
parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali ca-
778
si, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella
del padre. Sul punto appaiono significativi il D.Lgs. n.
151 del 2001, artt. 16 e 28.
L’art. 16, nel disciplinare il congedo di maternità, stabilisce che la donna lavoratrice dipendente non può essere
adibita al lavoro nei due mesi antecedenti al parto e nei
successivi tre. L’art. 28 prevede poi che “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata
del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Al
suddetto periodo è ricollegato il godimento dell’indennità di maternità pari all’80 per cento della retribuzione
(D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22). Dalla lettura dell’art.
28 risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto
dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre,
potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e
ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre
e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica.
Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accompagna, appunto, quella della salute della madre, alla quale è
finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e
della collegata indennità. In proposito va rilevato che
questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del L. n. 903 del 1977,
art. 7 nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre lavoratore ove l’assistenza della madre al minore fosse divenuta impossibile
per decesso o grave infermità. Alla suddetta pronuncia di
incostituzionalità la Corte è giunta dopo aver affermato
che il fine perseguito dal legislatore mediante l’istituto
dell’astensione obbligatoria è quello di tutelare la salute
della donna nel periodo immediatamente precedente e
successivo al parto, tenendo conto anche delle esigenze
relazionali e affettive del figlio in tale periodo.
Pertanto, la Corte ha ritenuto irragionevole non estendere al padre il diritto all’astensione obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di maternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte odi grave impedimento della
stessa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli interessi che
l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare sono
solo quelli del minore ed è quindi rispetto a questi che
esso deve rivolgersi in via esclusiva. Tali condizioni
non ricorrono evidentemente nel caso di specie”.
Ora alla stregua delle precisazioni della Corte delle leggi
risulta del tutto evidente che la decisione del 2005 non è
auto- applicativa (self-executing), sempre che la stessa decisione possa riguardare anche casi diversi da quello
espressamente esaminato che non riguardava la paternità
biologica, essendo comunque necessario un intervento
del legislatore volto a delineare il punto di bilanciamento
tra principio di parità di trattamento tra coniugi, diritti
del bambino e protezione specifica della salute e dell’integrità psico-fisica della madre in ordine a tutte le provvidenze che sono connesse all’evento “nascita biologica”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro autonomo
La Corte delle leggi ha evidenziato come nel caso dell’indennità di maternità sussiste una specificità protettiva
(che giustifica una tutela più intensa della sola donna)
che riguarda proprio la salute della madre biologica (che
si aggiunge alle finalità concernenti la protezione del
bambino e del nucleo familiare), per cui la parità di trattamento tra coniugi- come osserva correttamente anche
la sentenza impugnata- è stata assicurata in relazione a
diverse ipotesi come l’infermità della madre o il suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione ed
affidamento che giustificano, per ragioni piuttosto evidenti, un’estensione anche al padre della provvidenza in
discorso. Il riferimento all’evoluzione del diritto sovranazionale non appare determinante e conclusivo perché
proprio l’esempio citato della direttiva sui congedi parentali dimostra come l’azione regolatrice dell’Ue abbia voluto l’equiparazione tra sessi ad un istituto in cui viene
prioritariamente in gioco l’interesse preminente del nucleo familiare (e dei minori) e non già quello alla salute
della donna- madre. Inoltre il riferimento all’art. 16 della
Carta del 1989 (prescindendosi dalla nota questione sul
carattere precettivo o meno degli impegni di cui parla il
Testo del 1989) oltre che generico non appare pertinente perché l’art. 16 certamente vuole promuovere la parità
tra sessi nell’ambito del lavoro, ma non preclude una tutela più intensa protezione della donna in presenza, come
nel caso in esame, di rischi specifici soprattutto alla salute in periodi delicati come la gravidanza ed i primi mesi
di maternità.
Questa differenziazione è peraltro resa evidente dalla
formulazione dell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che al suo capoverso precisa che “il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”. Pur non essendo la Carta direttamente applicabile come fonte vera
e propria (art. 6 TUE) al caso l’esame che non esibisce
una qualche connessione con il diritto Europeo (ex art.
51 della stessa Carta) certamente può, invece, offrire
elementi di interpretazione “libera” posto il suo carattere espressivo dei “principi comuni agli ordinamenti Europei (cfr. Corte costituzionale n. 135/2002) che si deve
presumere gli Stati membri rispettino. Pertanto la natura discriminatoria dell’esclusione dall’indennità di maternità dei genitori di sesso maschile non sembra presentare i denunciati connotati discriminatori né sotto il
profilo interno che sotto quello sovranazionale.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di
lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.
(omissis).
IL COMMENTO
di Roberta Nunin
Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione interviene in tema di diritti del padre libero
professionista, negando che alla sentenza della Corte cost. n. 385/2005 possa riconoscersi una
percettività “auto-applicativa” e ribadendo l’esclusione dei padri professionisti dalla possibilità
di fruire dell’indennità di maternità, riservata alle professioniste madri, al di fuori dei pochi casi
espressamente previsti.
Il caso
La sent. 2 maggio 2016, n. 8594, con la quale la
S.C. ha negato la possibilità di estendere (al di fuori
dei pochi casi espressamente previsti) al padre professionista la fruizione, in alternativa alla madre,
dell’indennità di maternità riconosciuta alle professioniste madri dall’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001,
(1) In argomento v. D. Gottardi (a cura di), La conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il nuovo T.U. n.
151/2001 ai sensi del d. lgs. n. 80/2015, Torino, 2016; sia inoltre consentito rinviare anche a R. Nunin, I congedi parentali dopo il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in questa Rivista, 2016, 1,
14 ss. Per la ricostruzione del quadro normativo antecedente
alla riforma, v., per tutti, M.L. Vallauri, Sub D. lgs. n. 151/2001,
in R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta (a cura di), Commentario
breve alle leggi del lavoro, Padova, 2013 (V ed.), 1499 ss.; L.
Calafà, Congedi e rapporto di lavoro, Padova, 2004; D. Gottardi, La tutela della maternità e della paternità, in L. Lenti (a cura
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
fornisce l’occasione per fare il punto sul contesto
normativo di riferimento, dopo le recenti riforme
attuate, nel quadro complessivo del c.d. “Jobs Act”,
con il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 (1).
Nel caso di specie, la pronuncia del giudice di legittimità è stata originata da una vicenda che aveva visto un avvocato presentare domanda alla Casdi), Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, Milano, 2002, 522
ss.; R. Del Punta - D. Gottardi (a cura di), I nuovi congedi, in
Lex 24, Milano, 2001; M. Miscione (a cura di), I congedi parentali, Milano, 2001. Con riguardo alle modifiche apportate al
T.U. tra il 2010 e il 2012, nel quadro del collegato lavoro e della legge “Fornero”, v. L. Calafà, Congedi, aspettative, permessi,
dopo il collegato lavoro, in Il nuovo diritto del lavoro, diretto da
A. Perulli - L. Fiorillo, II, Rapporto individuale e processo del lavoro, Torino, 2014, 365 ss.
779
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro autonomo
sa di previdenza e assistenza forense per ottenere la
fruizione dell’indennità di maternità di cui all’art.
70 del D.Lgs. n. 151/2001 in luogo della moglie,
sulla base di una presunta precettività “auto-applicativa” della pronuncia della Corte cost. n.
385/2005, che avrebbe dovuto ritenersi non limitabile al caso espressamente dalla stessa considerato e cioè alla fattispecie del genitore adottivo - in
un’ottica di interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa di tutela dei diritti dei
genitori, tendente ad assimilare la posizione del padre e della madre rispetto all’evento nascita, anche
in chiave antidiscriminatoria.
In effetti, una tale ricostruzione aveva trovato
ascolto da parte del giudice di prime cure - il Tribunale di Catania (2) - che aveva riconosciuto il
diritto del padre libero professionista a percepire
l’indennità di cui all’art. 70 in alternativa alla madre e aveva condannato all’erogazione la Cassa forense. In sede di giudizio di secondo grado, tuttavia, la Corte d’Appello di Palermo aveva ritenuto
che tale domanda dovesse essere rigettata, rilevando che la Corte costituzionale - nella sentenza in
primo grado richiamata - aveva demandato al legislatore di stabilire un eventuale meccanismo attuativo per il riconoscimento al padre di tale indennità, che tuttavia non era stato attuato; inoltre, i giudici di secondo grado avevano anche osservato come la stessa Corte costituzionale, con la successiva
sent. n. 285/2010, avesse sottolineato - in relazione
sempre all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 - la possibile giustificazione della lamentata diversità di trattamento, in relazione alla protezione specifica della
salute della madre, spettando solo al legislatore l’eventuale perequazione della minorata tutela approntata per il padre. Questa posizione è stata fatta
propria anche dalla S.C. che, con la decisione in
epigrafe, ha ribadito la carenza di un carattere selfexecuting della sentenza del 2005 della Consulta ed
ha riconosciuto il carattere non discriminatorio
dell’esclusione del padre professionista dalla possibilità di godimento dell’indennità di maternità, al
di là dei casi espressamente previsti (morte o grave
(2) V. Trib. Catania 2 novembre 2011.
(3) V. D. Gottardi, Introduzione, in D. Gottardi (a cura di), La
conciliazione, cit. 1 ss.; per un commento al quadro delle tutele
per i genitori professionisti dopo la novella sia consentito rinviare qui a R. Nunin, Diritti e tutele per i genitori liberi professionisti e lavoratori autonomi, in D. Gottardi (a cura di), La conciliazione, cit., 109 ss.
(4) Il carattere poco innovativo della riforma appare confermato, banalmente, anche dallo stesso lessico usato dal legislatore, che - ignorando completamente il dibattito degli ultimi
anni per un uso non sessista della lingua - ha ritenuto di “rinominare”, rispettivamente, il Capo XI ed il Capo XII del D.Lgs.
n. 151/2001 sostituendo alle precedenti rubriche declinate al
780
infermità della madre, abbandono del figlio, adozione e affidamento).
La tutela dei genitori liberi professionisti
nel decreto n. 80/2015
Il complesso intervento di riforma del lavoro del
2015 ha toccato anche il tema del work-life balance,
mediante una rivisitazione complessiva della materia dei congedi e delle tutele per i genitori lavoratori, operata tramite il già citato D.Lgs. n. 80/2015
con l’obiettivo di aggiornare i contenuti del T.U.
del 2001 (D.Lgs. n. 151/2001) tenendo conto anche
dei diversi interventi della giurisprudenza della Corte costituzionale succedutisi negli anni precedenti.
Tale articolata manutenzione della normativa di riferimento, se da un lato ha portato ad alcuni risultati
sicuramente apprezzabili, ha lasciato tuttavia alcuni
nodi irrisolti (3), tra i quali sicuramente uno dei più
evidenti è legato alla persistente asimmetria che, anche dopo la riforma, continua a connotare i diritti e
le tutele riconosciuti ai/alle lavoratori/trici nell’ambito delle libere professioni e del lavoro autonomo rispetto a quelle assicurate al lavoro subordinato, nonché per la confermata disparità nei diritti riconosciuti, in tali contesti, rispettivamente, alle madri ed ai
padri. L’opzione del legislatore è stata chiaramente
quella di muoversi in un’ottica di prudente continuità rispetto al passato, con una controllata e limitatissima estensione all’area del lavoro autonomo e libero-professionale di alcune tutele prima riservate al
solo lavoro dipendente, senza avere però il coraggio
di operare una riforma di carattere più radicale - anche in relazione ai problemi legati all’effettività delle
tutele stesse - e maggiormente innovativa (4), che
fosse attenta, ad esempio, al tema della difficile fruibilità dei diritti da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi titolari di rapporti caratterizzati da
elevati livelli di discontinuità e precarietà (5).
Rispetto alla posizione dei liberi professionisti - padri e madri - resta dunque innanzi tutto confermata, anche dopo la riforma, l’esclusione per professionisti e professioniste della possibilità di fruire
femminile quelle al maschile plurale (“Lavoratori autonomi” e
“Liberi professionisti”: v. artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 80/2015),
inteso quest’ultimo come comprensivo anche del genere femminile. Sul punto v., già in sede di commento allo schema del
decreto, le puntuali osservazioni critiche di D. Gottardi, Alcune
osservazioni allo schema di decreto legislativo in materia di Conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro, 2015, 2 del dattiloscritto.
(5) V. le considerazioni già espresse da chi scrive in R. Nunin, Diritti e tutele per i genitori liberi professionisti e lavoratori
autonomi, in D. Gottardi (a cura di), La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, cit., 109 ss.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro autonomo
In materia di diritti e tutele per i genitori professionisti, il legislatore del 2015 conferma dunque l’assetto regolativo precedente, che di fatto valorizza
ancora la centralità della figura materna, prevedendo (v. art. 70 D.Lgs. n. 151/2001) che alle libere
professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza - enti elencati nella
tabella D allegata al decreto n. 151/2001 (7) - sia
riconosciuto il diritto alla corresponsione di un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la
data del parto ed i tre mesi successivi alla stessa.
Tale indennità è prevista nella misura dell’80% del
solo reddito professionale percepito e denunciato
ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento considerato, che è la nascita
del bambino oppure l’aborto nel caso in cui, dopo
il compimento del sesto mese di gravidanza, quest’ultima sia interrotta per motivi spontanei o volontari (8) (v. art. 71, comma 3, D.Lgs. n.
151/2001). La misura dell’indennità dovuta deve
essere parametrata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali - con i limiti di cui subito si dirà senza che assuma rilievo la forma nella quale la
professionista esercita la propria attività libero-professionale: di conseguenza, l’indennità dovrà essere
corrisposta anche nell’ipotesi di attività svolta dalla lavoratrice avvalendosi delle forme dell’associazione professionale: in questo caso, tuttavia, dovrà
tenersi conto della ripartizione del reddito complessivo in quote tra gli associati. Inoltre sono previsti un livello minimo ed un massimale per l’indennità di maternità: essa infatti non può essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 del D.L. n. 402/1981 nella
misura risultante per la qualifica di impiegato, né
può eccedere cinque volte l’importo minimo della
prestazione, con la precisazione che, quanto al solo
massimale, resta ferma “la potestà di ogni singola
cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Mini-
(6) Limitandoci all’ambito dell’avvocatura (particolarmente
sensibile alle criticità sopra indicate, amplificate anche dal notevolissimo aumento del numero dei nuovi professionisti iscritti agli albi registrato nell’ultimo ventennio), segnaliamo che,
proprio con riguardo a tali tematiche, è stato attivato a far
tempo dal 2015 un progetto di collaborazione triennale tra la
Cassa Forense ed il Censis che si propone di indagare, tra altre
problematiche, anche la domanda di welfare degli avvocati e
delle avvocate mediante l’approfondimento di una serie di
questioni tra cui l’ingresso tardivo dei giovani nel mercato del
lavoro, l’impatto della crisi sui redditi (e sulla capacità contributiva) e le persistenti e significative divaricazioni di genere (oltre che generazionali) interne al mondo libero professionale: v.
http://notiziario.cassaforense.it. In argomento v. anche I. Troianiello, Casse di previdenza allo specchio: confronto su assistenza
Welfare e futuro, in http://newsletter.cassaforense.it.
(7) Gli enti elencati sono i seguenti: Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari; Ente nazionale
di previdenza ed assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per gli psicologi; Ente di previdenza dei periti industriali; Ente
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (limitatamente alla gestione separata per i giornalisti liberi professionisti); Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici).
(8) Nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della L. 22 maggio
1978, n. 194.
dell’istituto del congedo parentale: esclusione che
appare sempre più discutibile, laddove si ponga
mente ad un contesto che già da molti anni ha visto un significativo aumento della presenza femminile e che, nel contempo, appare sempre più segnato da una progressiva ‘proletarizzazione’ in diversi
ambiti di attività delle/dei giovani professioniste/i,
accentuato negli anni della crisi e caratterizzato da
una rilevante contrazione delle aspettative reddituali rispetto al passato e dall’emergente esigenza
(sostanzialmente ancora ignorata dal legislatore) di
ripensare completamente anche per tali lavoratori
e lavoratrici (considerati un tempo, a torto o a ragione, comunque dei privilegiati) strumenti innovativi di welfare e sostegno al reddito (6), in particolare per i più giovani, con lo specifico obiettivo
di sostenere l’esercizio delle funzioni genitoriali e
di favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale.
Le modifiche apportate si traducono quindi, nel
contesto del lavoro libero professionale, in qualche
ritocco alla normativa precedente, contenuta negli
artt. 70-73 del D.Lgs. n. 151/2001, i quali avevano
peraltro ripreso ed integrato nel T.U. le regole in
materia di tutela della (sola) maternità introdotte
a suo tempo per le libere professioniste dalla L. 11
dicembre 1990, n. 379.
Padri liberi professionisti e tutela
della genitorialità: un lungo percorso,
ancora incompleto
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
781
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro autonomo
stero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente” (art. 70, comma 3 bis, D.Lgs. n.
151/2001) (9).
Si ricorda che per le professioniste - a differenza di
quanto previsto per le lavoratrici subordinate - la
corresponsione dell’indennità di maternità non è
subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa (v. art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001),
essendo la stessa rimessa alla scelta discrezionale
della professionista: la normativa infatti, non casualmente, si esprime in termini di “indennità” e
non di “congedo” di maternità (10).
Su tale assetto regolativo la riforma del 2015 interviene proprio con specifico riguardo alla figura paterna. Infatti, delle poche modifiche apportate, la
più significativa è sicuramente l’introduzione (ad
opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 80/2015) all’art. 70
del D.Lgs. n. 151/2001 del nuovo comma 3 ter, il
quale dispone che l’indennità di maternità di cui si
è detto spetti ora anche “al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre”. Abbiamo già so-
pra richiamato la sent. n. 385/2005, con cui la
Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n.
151/2001 (11), nella parte in cui gli stessi non contemplavano il principio che al padre libero professionista potesse spettare di percepire in alternativa
alla madre l’indennità di maternità attribuita solo
a quest’ultima. In tale pronunzia, tuttavia, veniva
considerato solo lo specifico caso dei genitori adottivi e affidatari e, per tale motivo, negli anni successivi non erano mancati in giurisprudenza dei
contrasti interpretativi quanto all’applicazione dei
principi affermati dalla Consulta anche ai padri
biologici (12), con una parabola (temporaneamente) “chiusa”, cinque anni dopo, dalla sent. n. 285
del 2010, anch’essa già sopra ricordata, con la quale la Corte aveva respinto le questioni di costituzionalità relative all’art. 70 del D.Lgs. n. 151 nella
parte in cui non prevedevano la piena estensione
al padre professionista dell’indennità ivi contemplata (13).
Trattasi, dunque, proprio del punto al centro della
decisione della Corte di cassazione qui commentata.
Con l’intervento della novella del 2015 - nell’ipotesi che entrambi i genitori siano liberi professionisti - è ora consentito al padre di fruire dell’indennità di maternità in alcune gravi e specifiche ipotesi:
(9) Un massimale non era stato peraltro contemplato inizialmente dalla legge del 1990, ma esso venne successivamente
introdotto (v. L. n. 289/2003) in seguito ad alcune vicende che
avevano coinvolto in particolare la Cassa del notariato, vistasi
costretta a corrispondere delle indennità di maternità che avevano in alcuni casi raggiunto degli importi notevolissimi.
(10) Sul punto vi è stato a suo tempo un serrato dibattito in
dottrina, poi composto dall’intervento della Corte costituzionale che con la sent. n. 3/98 aveva dichiarato l’infondatezza (con
riferimento agli artt. 3, 32, 37 Cost.) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, L. n. 379/1990, nella parte in cui
prevedeva che l’indennità di maternità venisse corrisposta alle
libere professioniste senza considerare la circostanza dell’effettiva astensione dal lavoro alla luce delle caratteristiche peculiari della categoria considerata e della possibilità per le professioniste di “autogestire” i tempi e le modalità del lavoro con la
necessaria flessibilità, senza dover soggiacere a direttive eteronome e potendo comunque prevedere anche il ricorso a sostituti; la Corte, inoltre, guardando alla tutela della salute della
madre e del nascituro ex art. 32 Cost., aveva avuto pure modo
di osservare che “per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, la libera professionista non deve essere turbata
da alcun pregiudizio alla sua attività professionale”, apparendo
tale obiettivo realizzabile solo “lasciando che la lavoratrice
svolga detta funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col felice avvio della nuova vita umana”. V. Corte cost. 29 gennaio
1998, n. 3, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 226 ss., con nota di G.
Pera, Indennità di maternità senza danno?; in Mass. Giur. lav.,
1998, 550 ss., con nota di G. Della Rocca, La tutela della maternità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo; in Riv. giur.
lav., 1998, II, 385 ss. con nota di V. Lipari, Costituzionalità della
disciplina dell’indennità di maternità alle libere professioniste,
nella parte in cui non richiede l’effettiva astensione dal lavoro.
Per una sintetica ricostruzione del dibattito dottrinale prima e
dopo la sentenza della Consulta n. 3/98 sia consentito qui rinviare - anche per ulteriori riferimenti bibliografici - a R. Nunin,
L’indennità di maternità per le professioniste: le ricadute della
sentenza Corte Cost. n. 3/1998, in questa Rivista, 2000, 2, 149
ss.
(11) Sia consentito in proposito rinviare a R. Nunin, Padre
adottivo libero professionista e diritto all’indennità di maternità
in alternativa alla madre, in questa Rivista, 2005, 12, 1129 ss.,
ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici. Per un commento v. anche S. Borelli, Il padre lavoratore nella giurisprudenza costituzionale, in L. Calafà (a cura di), Paternità e lavoro, Bologna, 2007,
239 ss.
(12) V. Trib. Rovigo 21 marzo 2008, n. 29, laddove si sottolinea come spetti necessariamente al legislatore prevedere e regolamentare i casi e le modalità di godimento dell’indennità di
maternità per i liberi professionisti padri a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sent. n. 385/05. Si sforza di
dare una diversa lettura costituzionalmente orientata dell’art.
70 dopo la sentenza della Consulta, con il riconoscimento del
diritto all’indennità di maternità anche al padre libero professionista in alternativa alla madre che decida di non avvalersene, Trib. Firenze, Sez. lav., 20 giugno 2008, in Riv. giur. lav.,
2009, II, 140 ss., con nota di L. Calafà, Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005; si esprime in
senso favorevole ad un’interpretazione conforme anche M. Papaleoni, Nuove frontiere di parità: i risvolti economici, in Mass.
Giur. lav., 2008, 11, 863 ss.
(13) V. Corte cost. 28 luglio 2010, n. 285, in Riv. giur. lav.,
2010, II, 359 ss., con nota di L. Calafà, Padri liberi professionisti
e tutela economica della maternità. La parabola interpretativa
della Corte Costituzionale.
782
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro autonomo
morte, grave infermità o abbandono della famiglia
(quando vi sia l’affidamento esclusivo del bambino
al padre). Il legislatore però qui si ferma e non va
oltre, e questa è anche la soglia davanti alla quale
si arresta la Suprema Corte con la decisione in epigrafe.
Infatti la Cassazione ritiene di fare propria la cornice argomentativa già adottata dalla sent. n.
285/2010 della Consulta, peraltro già a suo tempo
criticata da una dottrina che ne aveva individuato
i limiti, riconducibili in particolare ad un equivoco
relativo alle forme ed agli strumenti di tutela esistenti per le madri libere professioniste, la cui ricostruzione risultava disattesa dalla Corte, che aveva
invece scelto di focalizzare la propria attenzione
sull’analisi delle tutele previste per il lavoro subordinato, “in un processo di omogeneizzazione argomentativa che allontana dalla realtà della normativa nazionale”, che (invece) si concentra sul sostegno economico la tutela delle libere professioniste (14). Questo profilo non viene indagato dalla
Suprema Corte, che - non valorizzando affatto la
chiave di lettura da ultimo richiamata - preferisce
secondo l’ottica tradizionale e consolidata evidenziare la circostanza che le norme in materia di congedo di maternità, oltre che alla protezione del nascituro, siano direttamente finalizzate alla tutela
della salute biologica della madre, ed in quanto tali
possano ben fondare una diversità di trattamento
dei due genitori, superabile in caso di morte, grave
infermità o abbandono della madre proprio perché,
nell’opinione della Corte, in queste fattispecie gli
interessi da tutelare risultano essere solo quelli (residui) del minore. Per negare poi il carattere selfexecuting della pronuncia della Consulta del 2005,
la Corte si limita a sottolineare - oltre che la diversità delle ipotesi che vengono in gioco (non riguardando tale decisione la paternità biologica) - anche la necessità di un intervento eventuale del legislatore per modificare l’assetto delle tutele, ritenendo che nel caso dell’indennità di maternità sussista “una specificità protettiva (che giustifica una
tutela più intensa della sola donna) che riguarda
proprio la salute della madre biologica (...), per cui
la parità di trattamento tra coniugi (...) è stata assicurata in relazione a diverse ipotesi come l’infermità della madre o il suo abbandono del nucleo familiare o nei casi di adozione ed affidamento che giustificano, per ragioni piuttosto evidenti, un’esten-
sione anche al padre della provvidenza in discorso”.
Dunque, le sollecitazioni della dottrina e della giurisprudenza di merito non trovano per il momento
accoglimento da parte della S.C., che rinvia la palla ad un legislatore che è tuttavia difficile immaginare interessato ad attivarsi nel breve/medio periodo sul punto, atteso l’eloquente silenzio in materia
nel recente intervento di riforma.
Sul piano sistematico, resta, però, una piccola perplessità che ci sembra più che legittima, alla luce
della ricostruzione operata dalla S.C. della “natura”
del congedo di maternità, e riconducibile alla contraddizione tra la lettura data dalla Cassazione di
questo istituto e la circostanza della recente introduzione nel nostro ordinamento, sia pure in via dichiaratamente sperimentale, di un “nuovo” congedo di paternità (15) (con valenza generale e non
legato, dunque, a situazioni di impossibilità/assenza
della madre come quello previsto dall’art. 28
T.U.), sia pure solo per i lavoratori dipendenti e
sia pure nella versione “sperimentale”, oltre che assolutamente “avara” e minimale (laddove confrontata con altre realtà europee), proposta dal legislatore italiano a far tempo dalla legge Fornero (v. art.
4, comma 24, lett. a, L. 28 giugno 2012, n. 92).
Con questo istituto, infatti, si riconosce sotto un
nuovo profilo - ed in modo, sia chiaro, assolutamente (ed auspicabilmente) perfettibile - l’autonomia di una genitorialità paterna egualmente meritevole di tutela e non appiattita sulla figura, sul
ruolo e sulla biologia della madre.
Sarà interessante vedere se la giurisprudenza, ancora prima di un legislatore non molto attento, riterrà di poter valorizzare questo spunto, che potrebbe
rivelarsi utile in chiave riconoscimento ai padri
professionisti della possibilità di godimento in alternativa dell’indennità di maternità, atteso che la
diversità di trattamento, riaffermata dalla S.C. ed
ancorata all’enfasi tradizionale posta sulla tutela
“biologica” della madre appare ancora meno convincente laddove si ponga mente alla circostanza
che, nel caso di specie, di “indennità” appunto si
tratta (anche per la madre) - e non di congedo atteso la mancanza per le professioniste di un obbligo sospensivo dell’attività, se non per quanto fisiologicamente legato alle esigenze immediate e
contingenti del parto e del puerperio (16).
(14) Così L. Calafà, Padri liberi professionisti, cit.
(15) Sul congedo di paternità v. L. Calafà, Il congedo di paternità, in D. Gottardi (a cura di), La conciliazione, cit., 41 ss.
(16) V. sul punto anche L. Calafà, Il congedo di paternità,
cit., in part. 42 e 62.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
783
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Società cooperative
Esclusione del socio-lavoratore
La comunicazione
dell’esclusione del sociolavoratore nelle cooperative
Cassazione Civile, Sez. lav, 1° aprile 2016, n. 6373 - Pres. Roselli - Est. Riverso - P.M. Sanlorenzo (conf.) - Sant’Andrea società cooperativa sociale c. V.C.Y.
Società cooperative - Esclusione del socio - Delibera di esclusione del socio lavoratore - Onere di comunicazione a pena
di inefficacia
(Cod. civ. art. 2533; L. 15 luglio 1966 n. 604; L. 20 maggio 1970, n. 300 art. 18; L. 3 aprile 2001, n. 142; L. 14 febbraio
2003, n. 30 art. 9)
La comunicazione dell’esclusione del socio lavoratore nelle società cooperative deve avere la forma scritta ad
essentiam alla stregua di quanto è previsto per il licenziamento individuale. Non sono legittime forme alternative di comunicazione dell’esclusione dalla società.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Non vi sono precedenti in termini.
Difforme
Corte d’Appello di Roma 7 novembre 1989.
La Corte (omissis).
Motivi della decisione
1.1 Deve essere premesso ai fini della decisione che, come risulta dalla sentenza d’appello, la lavoratrice era
stata licenziata per motivi disciplinari il 24 ottobre
2011 ed aveva impugnato il licenziamento l’8 ottobre
2012 richiedendo la tutela reale e in subordine quella
obbligatoria.
Nel costituirsi in giudizio davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, il 23 giugno 2012, la società
cooperativa Sant’Andrea, oltre ad affermare la legittimità del licenziamento, sosteneva che la lavoratrice fosse stata altresì esclusa dalla cooperativa con delibera del
31 ottobre 2011, cui aveva fatto seguito la restituzione
della quota sociale accreditata nella busta paga di ottobre 2011.
Con la decisione in primo grado, il tribunale riteneva
legittimo il licenziamento nel merito; rilevando che,
quand’anche fosse stato da ritenersi illegittimo, sarebbe
stata in ogni caso preclusa la tutela reale o obbligatoria
richiesta in ricorso in mancanza della contestuale impugnazione da parte della socia lavoratrice della delibera
di esclusione dalla cooperativa del 31 ottobre 2011”.
Avverso detta statuizione la lavoratrice V.C.Y. proponeva appello col quale censurava la pronuncia per aver
784
anzitutto ritenuto provate le condotte addebitate, affermato inoltre la proporzionalità della sanzione espulsiva
comminata, sostenuto infine che fosse precluso il ripristino del rapporto o la tutela reale, anche quando la
mancata impugnazione della delibera di esclusione fosse
dipesa dalla sua omessa comunicazione.
La Corte d’Appello di Milano ritenendo fondato il primo e il secondo dei motivi d’appello, ha sostenuto, da
una parte, che (a parte la pacifica assenza ingiustificata
dal lavoro di un giorno) non fosse stata provata la condotta di falsificazione della attestazione di regolare presenza in servizio; e dall’altra che, qualora la medesima
condotta fosse stata provata (con l’assunzione delle prove testimoniali dedotte dalla società, ma non assunte
nemmeno in primo grado), la massima sanzione espulsiva comminata alla lavoratrice non potesse comunque
ritenersi proporzionata all’effettiva gravità dei complessivi comportamenti alla stessa contestati, che non apparivano idonei a determinare una irrimediabile lesione
dell’elemento fiduciario, in considerazione della sporadicità della condotta, dell’assenza di recidiva, della sua
limitazione nel tempo; e tenuto altresì conto dell’art. 42
del CCNL di settore che, per l’assenza arbitraria da uno
a tre giorni e per la irregolarità volontaria nelle formalità del controllo delle presenze, prevedeva - in mancanza
di recidiva - la sospensione dal servizio e non già il licenziamento.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Società cooperative
Per quanto riguardava invece la tutela, la Corte - premesso che la socia, pur in mancanza di comunicazione,
sarebbe venuta a conoscenza della delibera di esclusione
“a seguito dell’avvenuta restituzione della propria quota
sociale, documentata dalla busta paga del mese di ottobre 2011” - ribadiva la tesi, già sostenuta dal tribunale,
secondo cui in mancanza della contestuale impugnativa
della delibera di esclusione dalla medesima cooperativa
non si potesse emettere alcuna pronuncia in merito all’invocata tutela reale ex art. 18 Statuto; “atteso che
detta norma è stata esplicitamente dichiarata inapplicabile ai soci lavoratori di cooperativa ogniqualvolta venga a cessare - come in questo caso - con il rapporto di
lavoro anche il rapporto associativo (v. L. n. 142 del
2001, art. 2)”. Sulla scorta di questa premessa la Corte
si limitava a dichiarare l’illegittimità del licenziamento
senza disporre tutela alcuna, neppure obbligatoria.
1.2 Contro questa pronuncia la Sant’Andrea società
cooperativa sociale ha interposto ricorso per Cassazione,
lamentando col primo motivo la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, come mod. dalla L. n. 30 del 2003, e/o dall’art. 2533 c.c.,
u.c., in quanto, non avendo la lavoratrice, socia della
cooperativa, impugnato l’atto di esclusione dalla medesima cooperativa, il recesso dal rapporto di lavoro non
poteva essere valutato in via autonoma, stante l’estinzione del rapporto di lavoro come effetto automatico
della delibera di esclusione, stabilito dalla normativa indicata.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia la stessa violazione della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, come
mod. dalla L. n. 30 del 2003, e/o dall’art. 2533 c.c.,
commi 3 e 4, in relazione al diverso piano relativo al
termine di impugnazione della delibera di esclusione ex
art. 2533 c.c., il cui definitivo decorso precluderebbe
oramai qualsiasi accertamento dell’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro, al pari di quanto accade
con il decorso del termine per il licenziamento ex L. n.
604 del 1966.
Con il terzo motivo il ricorso deduce l’omessa considerazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti, avendo la società cooperativa
esplicitato fin dalla memoria di costituzione in primo
grado che la lavoratrice fosse stata appunto esclusa dalla
compagine sociale per gli stessi fatti che le erano stati
contestati a fondamento del licenziamento; ma questo
fatto non sarebbe stato per l’appunto valutato dal giudice d’appello in tutta la sua portata.
2.- I primi tre motivi di ricorso essendo finalizzati a censurare la sentenza d’appello in relazione al nesso di pregiudizialità che intercorre tra provvedimento di licenziamento e delibera di esclusione (anche in conseguenza
dell’omessa impugnazione di quest’ultima per decorso
dei relativi termini) possono, per la loro evidente connessione, essere valutati unitariamente. Vi si sostiene
infatti che in mancanza di impugnazione nei termini
della delibera di esclusione comunque conosciuta dalla
lavoratrice; e stante gli assorbenti effetti estintivi ex lege
del medesimo provvedimento rispetto a quello di risoluzione del rapporto di lavoro; nessuna pronuncia sul li-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
cenziamento potesse essere più emessa, in base alle norme di legge citate.
2.1 In punto di fatto, deve però ritenersi pacifica la circostanza secondo cui la delibera di esclusione in oggetto, presa il 31.10.2011, non sia stata mai comunicata alla lavoratrice. La Corte milanese sostiene però che la
lavoratrice ne fosse chiaramente a conoscenza, a seguito
della restituzione della quota sociale risultante dalla busta paga del mese di ottobre 2011. Ebbene, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, ritiene
questo collegio che secondo la normativa di settore la
delibera di esclusione debba essere comunicata al lavoratore, in mancanza della quale rimanga totalmente
inefficace e non decorra alcun termine d’impugnazione.
L’art. 2533 c.c., così formulato con D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, prevede che: “L’esclusione del socio, oltre
che nel caso indicato all’art. 2531, può aver luogo: 1)
nei casi previsti dall’atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,
dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto
mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società; 4) nei casi
previsti dall’articolo 2286; 5) nei casi previsti dell’art.
2288, comma 1.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori
o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo
scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”.
La L. n. 142 del 2001, dedicata al socio lavoratore di
cooperativa, all’art. 5, mod. con la L. n. 30 del 2003,
art. 9, dispone poi che “Il rapporto di lavoro si estingue
con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto della previsioni statutarie e in conformità agli
artt. 2526 e 2527 c.c.” (recte, artt. 2532 e 2533 c.c.).
La stessa L. n. 142 del 2001, all’art. 2, dispone inoltre
che “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
lavoro subordinato si applica la L. 20 maggio 1970, n.
300, con esclusione dell’art. 18, ogni volta che venga a
cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.
2.3 Emerge dunque dalle norme appena citate che la
deliberazione di esclusione da socio possa essere presa
(art. 2533 c.c.) per una svariata gamma di motivi previsti dagli artt. 2531, 2533, 2286 e 2288 c.c., e dall’atto
costitutivo. Che la sua adozione determini ex lege l’estinzione del rapporto di lavoro, senza necessità che
venga adottato un ulteriore provvedimento estintivo
(L. n. 142 del 2012, art. 5, e art. 2533 c.c., u.c.). Che
contro la deliberazione di esclusione (art. 2533 c.c.) il
socio possa proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Ne discende
quindi che la deliberazione debba essere sempre comunicata al lavoratore e che il termine di 60 giorni per
proporre impugnazione decorra soltanto dalla comunicazione della deliberazione. Non solo, si evince ancora
dalle medesime norme che la comunicazione debba ave-
785
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Società cooperative
re una motivazione ovvero un contenuto minimo necessario finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di
difesa; un contenuto che non può essere soddisfatto dalla restituzione della quota sociale nella busta paga.
Questa tesi si impone in base ad un’interpretazione letterale e sistematica della normativa Anzitutto perché la
delibera di esclusione può essere deliberata appunto per
una varietà di motivi che vanno comunicati al lavoratore per un elementare rispetto delle garanzie di difesa;
ed inoltre perché, secondo la legge, proprio dalla comunicazione della delibera decorre il termine di decadenza
per l’impugnazione. La medesima tesi si impone inoltre
in base ad un’interpretazione logica e costituzionalmente orientata della normativa, ove si ponga attenzione
agli effetti, che la stessa società ricorrente reclama in
questo giudizio, discendenti dall’adozione della deliberazione di esclusione: la quale, ai sensi della L. n. 142 del
2003, art. 5, come mod. dalla 130/2003, determina l’estinzione ipso iure del rapporto di lavoro con assorbimento di qualsivoglia questione in merito alla sorte del
licenziamento, pur di fatto irrogato.
2.4 In effetti, la mancata tempestiva impugnazione in
giudizio della delibera di esclusione, secondo l’interpretazione della domanda demandata al giudice (da ultimo
individuato nel giudice del lavoro dalla Corte di Cassazione con ordinanze nn. 19975/2015, 24917/2014), non
consentirebbe di emettere alcuna statuizione in merito
al licenziamento, pur di fatto irrogato ed impugnato,
stante l’effetto estintivo legale che rinvenirebbe comunque dal provvedimento di natura societaria, divenuto irretrattabile. Mentre non è ammissibile l’impasse in cui
è caduta la pronuncia d’appello che ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare ma non ha applicato alcuna tutela, stante la mancata impugnazione dell’esclusione. In realtà i due rapporti che formano la complessa posizione contrattuale del socio lavoratore di cooperativa risultano collegati in base ad un nesso genetico
e funzionale, tale per cui - in linea di principio - non
può esistere l’uno senza l’altro, perché i due rapporti
stanno o cadono insieme. Perciò in presenza di un’esclusione non impugnata non può essere dichiarata l’illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro, venendo in tal modo alterata la disciplina legale sulla complessa figura; all’interno della quale l’esistenza della posizione sociale è pregiudiziale rispetto alla nascita, allo svolgimento ed alla stessa esistenza in vita del rapporto di lavoro (nesso genetico e
funzionale).
Inoltre, sotto il profilo delle tutele la medesima L. n.
142 del 2001, (artt. 2 e 5, come mod. dalla L. n. 30 del
2003), ha stabilito che siano assorbenti quelle relative
al profilo associativo; anche perché, sotto il profilo casuale, le ragioni di inadempimento lavoristico costituiscono in pari tempo altrettante ragioni di inadempimento associativo (il rapporto di lavoro serve all’adempimento del contratto sociale, mentre l’art. 2533 c.c.,
prevede come causa di esclusione dalla cooperativa l’inadempimento del contratto sociale).
2.5 In sostanza, data la gravità degli effetti che scaturiscono dalla sua adozione, essendo la delibera di esclusio-
786
ne idonea ad estinguere ad un tempo sia il rapporto associativo sia il rapporto di lavoro, essa deve essere comunicata al lavoratore.
La soluzione appare rispondente sia alla disciplina generale ex art. 2533 c.c., u.c.; sia, a maggiore ragione, a
quella speciale ex L. n. 142 del 2001, per la valenza costituzionale rivestita del rapporto di lavoro la necessità
della cui protezione non sarebbe per nulla garantita ove
potesse prodursi la sua estinzione, anche ex lege, pur in
difetto di qualsivoglia comunicazione al lavoratore dell’atto che la produce (ancorché di natura societaria).
Sarebbe poi, in ogni caso, illogico e paradossale che un
atto con effetti estintivi duplici - che autorizza a non
emettere alcun licenziamento per estinguere il rapporto
di lavoro o che renderebbe carente di interesse la stessa
controversia pendente sul licenziamento comunque già
intimato - possa essere adottato senza essere neppure comunicato al lavoratore.
Pertanto, per quanto attiene la speciale figura del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, la disciplina di
legge (ex art. 2533 c.c.) va integrata nel senso che alla
delibera di esclusione si applicano, in base ad una esigenza di coerenza logica e di sistema, quanto agli oneri
di comunicazione, i medesimi principi valevoli per il
provvedimento di licenziamento.
2.5 (n.d.r.: così nel testo originale) La tesi appena enunciata appare inoltre conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che si è pronunciata
sul tema della necessità di comunicazione della deliberazione di esclusione dalla cooperativa; sia nel settore
civile che in quello del lavoro.
In questo senso, si è espressa infatti la Sez. 1, sentenza
n. 17337 del 25 giugno 2008 allorché (in un caso in cui
il procedimento di esclusione si perfezionava con la determinazione del collegio dei “probiviri”) ha stabilito
che solo “la comunicazione di tale determinazione segna la decorrenza del termine per adire l’autorità giudiziaria, fissato in trenta giorni dall’art. 2527 c.c., comma
3, nel testo antecedente la riforma di cui al D.Lgs. n. 6
del 2003”.
La Sezione lavoro della Cassazione ha fissato gli stessi
principi con la sentenza 14143/2012, allorché ha osservato che “L’art. 2533 c.c., prevede che la delibera di
esclusione del socio possa essere impugnata nel termine
di 60 giorni dalla comunicazione della delibera stessa. È
vero che la disposizione citata, come già l’art. 2527 c.c.,
nel regime precedente la riforma del diritto societario,
non prevede formalità particolari per la comunicazione.
Però richiede che la delibera sia comunicata perché decorra il termine per impugnarla. Pertanto non è sufficiente la mera conoscenza che di fatto il socio abbia
della delibera stessa prima della sua comunicazione; sicché correttamente la corte d’appello ha fatto decorrere
il termine suddetto per l’impugnativa dalla comunicazione della delibera e non già da un momento precedente, quale quello della produzione in giudizio da parte
del socio della delibera stessa”.
Sulla funzione della comunicazione della deliberazione
si è pronunciata pure la Cassazione Sez. 1 con la sentenza n. 11558 del 9 maggio 2008 osservando che “In
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Società cooperative
tema di società cooperative, la comunicazione al socio
della delibera di esclusione adottata ai sensi dell’art.
2533 c.c., svolge la funzione d’informarlo non tanto di
ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, bensì
delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante, dal momento che su
di esse egli dovrà articolare le proprie difese; la sua incompletezza non comporta pertanto l’invalidità dell’atto, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione, non assumendo alcun rilievo, a tal
fine, la conoscenza da parte del socio degli addebiti
contestatigli nel corso del procedimento, in quanto gli
stessi possono anche non coincidere con quelli posti a
base dell’esclusione come deliberata dal competente organo societario, ben potendo accadere che gli iniziali
addebiti siano ridimensionati o riconfigurati nella decisione finale, ovvero che quest’ultima, in caso di pluralità di addebiti, si basi soltanto su alcuni di essi”.
D’altra parte l’opposizione ex art. 2533 c.c., è il solo
mezzo dato al lavoratore per far valere gli stessi vizi della relativa deliberazione, senza che si applichino al socio
lavoratore le normali azioni di nullità e annullabilità
delle delibere, ex art. 2377 c.c. e ciò spiega ancor di più
la necessita della relativa comunicazione (in tal senso
Cass. Sentenza n. 25945 del 5 dicembre 2011 “Il socio
escluso dalla cooperativa può far valere i vizi della relativa deliberazione esclusivamente mediante l’opposizione ai sensi dell’art. 2527 c.c., previgente, ratione temporis applicabile (attualmente, art. 2533 c.c., penultimo
comma), da proporre entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione, essendo tale procedimento del tutto distinto dai normali mezzi d’impugnazione delle deliberazioni assembleari, previsti dall’art. 2377 c.c. e ss.”).
2.6 Quanto al valore della produzione della delibera di
esclusione nel corso del giudizio contro il licenziamento, su cui peraltro nulla ha addotto nei motivi di ricorso
la Cooperativa ricorrente, essendo stata la questione introdotta - peraltro in via subordinata - con il ricorso incidentale dalla difesa della lavoratrice, è opportuno osservare fin da ora che, oltre nel precedente lavoristico
costituito dalla sentenza 14143/2012 (prima richiamata), la Corte di Cassazione aveva già estesamente affermato l’irrilevanza di tale forma di conoscenza con la
sentenza della Sez. 1, n. 7592 del 17 luglio 1999, chiarendo che: “La comunicazione della delibera di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2527 c.c., ha la funzione di
far decorrere il termine per l’impugnazione e di rendere
edotto il socio delle ragioni della sanzione adottata al fine di consentirgli l’esercizio delle proprie difese; per
produrre i suoi effetti la comunicazione deve essere fatta
personalmente al socio con un mezzo idoneo a garantire
che l’interessato venga direttamente a conoscenza del
provvedimento; non può ritenersi mezzo idoneo, sostitutivo della comune raccomandata, la produzione della
delibera in un giudizio pendente tra il socio e la cooperativa, che ha un oggetto diverso dall’impugnativa della
stessa delibera, poiché l’effetto della comunicazione di
documenti mediante produzione è circoscritto al processo in cui avviene e non può estendersi a rapporti non
dedotti”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
3.- Pertanto, per le ragioni fin qui addotte, in mancanza
di qualsiasi comunicazione della delibera di esclusione,
il procedimento contro il licenziamento segue il suo
corso e dovrà essere trattato in quanto tale, come un
normale giudizio su un caso di licenziamento.
E non decorre alcun termine di impugnazione ex art.
2533 c.c. Gli effetti descritti dalla L. n. 142 del 2001,
art. 2, che precluderebbero l’applicazione dell’art. 18; e
quelli ancora più radicalmente estintivi previsti dalla L.
n. 142, art. 5, come mod. dalla L. n. 30 del 2003, (che
precluderebbero l’applicazione di tutto l’apparato normativo formale, causale e remediale del licenziamento)
presuppongono che la delibera di esclusione sia stata
comunicata al lavoratore.
3.1 Da ciò consegue che vanno respinti i primi tre motivi di ricorso con i quali la cooperativa ricorrente mirava a sostenere che, pur senza comunicazione della delibera: a) l’esclusione dalla cooperativa comporti, ai sensi
dell’art. 5 cit., un sicuro effetto estintivo assorbente in
ragion del nesso di pregiudizialità che essa esercita sul
rapporto di lavoro; e perciò l’estinzione automatica del
rapporto di lavoro, senza che la Corte d’Appello potesse
pronunciare alcun accertamento sulla illegittimità del
licenziamento. b) il decorso definitivo del termine di
impugnazione della delibera di esclusione ex art. 2533
c.c., precluderebbe - pur in mancanza di formale comunicazione - qualsiasi accertamento dell’illegittimità del
recesso dal rapporto di lavoro, “al pari di quanto accade
con il decorso del termine per il licenziamento ex L. n.
604 del 1966” (soggetto peraltro invece all’onere di comunicazione); c) non sarebbe stato valutato dal giudice
d’appello in tutta la sua portata, il fatto, esplicitato fin
dalla memoria di costituzione in primo grado, che la lavoratrice fosse stata esclusa dalla compagine sociale per
gli stessi fatti che le erano stati contestati a fondamento
del licenziamento.
4.- Con il quarto motivo il ricorso lamenta la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e comunque
della L. n. 604 del 1966, art. 1 e/o art. 3, non essendosi
la Corte attenuta alla nozione di giusta causa prevista
dalla legge. Con il quinto motivo deduce violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 42 CNNL cooperative sociali
2006/2009 posto che alla lavoratrice non era stata addebitata una mera irregolarità nella formalità del controllo
presenza, come ritenuto dal giudice, bensì una condotta
che sostanziava gli elementi della truffa e che poco aveva a vedere con quanto previsto dall’art. 42 del CCNL
di settore o con una qualsiasi delle condotte ivi punite
con la sola sospensione.
I motivi di ricorso (4^ e 5^) avverso le statuizioni effettuate dalla sentenza d’appello circa l’insussistenza della
giusta causa sono inammissibili.
Va osservato in proposito che mentre non è stata mai
discussa la responsabilità della lavoratrice per il primo
addebito, ovvero la assenza ingiustificata dal lavoro per
il giorno 5.9.2011; è stata invece confutata dalla Corte
d’Appello la contestazione disciplinare relativa alla condotta di falsificazione (“falsa attestazione di mancata/erronea timbratura per il giorno 5.9.2011 consegnata in
ufficio personale in data 12.9.2011”), in quanto non
787
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Società cooperative
provata ed affermata dal primo giudice sulla base di meri indizi, di per sé non certi, né gravi, precisi e concordanti.
Va ora osservato che i motivi di ricorso in discussione
(4^ e 5^), formulati dalla cooperativa con riferimento
all’art. 360 c.p.c., n. 3, non aggrediscono questa preliminare affermazione in fatto, costituente autonoma ratio
decidendi, in difetto della cui impugnazione essa deve
quindi ritenersi passata in giudicato.
Talché a nulla varrebbe soffermarsi sui medesimi motivi
in diritto, che si occupano della nozione legale di giusta
causa o dell’interpretazione dell’art. 42 del CCNL cooperative sociali relativo alle condotte disciplinarmente
rilevanti ed ai corrispondenti provvedimenti sanzionatori.
Vero è che la stessa prova testimoniale dedotta dalla
Cooperativa, sulla condotta disciplinare in oggetto, non
è stata ammessa dalla Corte d’Appello perché ritenuta
superflua, avendo il giudice ritenuto che seppure fosse
risultata provata (anche la condotta di falsificazione) la
sanzione espulsiva irrogata per i due illeciti sarebbe stata, a parere della Corte, nondimeno sproporzionata ed il
licenziamento comunque illegittimo.
Tuttavia, poiché la sussistenza in fatto della condotta
addebitata risulta un presupposto, logicamente preliminare, a qualsiasi disamina sulla sua giusta rilevanza disciplinare, era necessario gravare la sentenza impugnata
ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa ammissione della prova da cui sarebbe risultata l’erroneità dell’affermazione della Corte in punto di responsabilità; oppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora la Corte
avesse omesso di considerare un qualche fatto decisivo
per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti e da
cui si fosse evinta la prova della responsabilità della lavoratrice negata dalla Corte. Fermo restando, in ogni
caso, il rispetto del principio di autosufficienza con la riproduzione testuale nel ricorso di tutti gli elementi indispensabili a questo giudice di legittimità per poter effettuare la valutazione sulla sussistenza della censura.
Si trattava di doglianze necessarie per contestare uno
degli aspetti autonomi della valutazione della giusta
causa quale emerge anche dalla costante giurisprudenza
di questa Corte; la quale ha da tempo chiarito che in
sede di legittimità può essere dedotto come vizio di violazione di legge soltanto la inosservanza degli elementi
definitori di carattere generale che la norma contiene
quale “fatto che non consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto”.
Mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel
fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano
il parametro normativo e le sue specificazioni, e della
loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di
fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile
in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
Peraltro, anche nel merito i due motivi si rivelano infondati; posto che non costituisce violazione di legge
l’aver considerato il fatto in contestazione, nella concretezza del suo accadimento, insuscettibile di costituire
giusta causa perché non indicativo di grave negazione
788
degli elementi del rapporto ed in particolare della carenza dell’elemento fiduciario, che non implica solo che
non sia posta in dubbio l’onestà del dipendente ma anche che non venga meno l’affidamento nella corretta
esecuzione della prestazione. Lo stesso giudizio risulta riscontrato in concreto dalla Corte territoriale in base alle circostanze, messe in luce in sentenza, sulla sporadicità della condotta, l’assenza di recidiva, la sua concentrazione nel tempo. Si tratta di affermazioni che non appaiono di per sé né illogiche né altrimenti viziate. E
che anzi risultano ulteriormente supportate dalla valutazione dell’art. 42 CCNL che per l’assenza arbitraria di
durata superiore ad un giorno e non superiore a tre e
per l’irregolarità volontaria nelle formalità del controllo
delle presenze prevede la sospensione dal servizio e non
il licenziamento.
Infatti anche la censura relativa all’interpretazione della
norma collettiva non è fondata, atteso che alla falsa attestazione di presenza in servizio si attaglia meglio la
più specifica previsione riferita alla “irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze”
piuttosto che quella assai generica, richiamata dalla
cooperativa, all’azioni in grave contrasto con i principi
della cooperativa per la quale soltanto è invece comminato il licenziamento.
5.- Da quanto fin qui osservato discende quindi l’infondatezza dei cinque motivi del ricorso principale che va
perciò disatteso.
6.- Va accolto invece il primo motivo del ricorso incidentale relativamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2533 c.c., laddove la Corte d’Appello ha
affermato erroneamente che il termine per impugnare
l’esclusione possa decorrere, pur in mancanza di formale
comunicazione, in quanto la socia sarebbe venuta a conoscenza della stessa deliberazione a seguito della liquidazione della quota sociale; liquidazione che però, alla
luce di quanto già detto, è palesemente insufficiente allo scopo di portare a conoscenza della socia lavoratrice
la deliberazione di esclusione ed il suo contenuto ai fini
delle garanzie di difesa e della decorrenza del termine di
impugnazione.
Va poi avvertito che nel caso in esame non potendosi
discutere della tutela da assicurare al socio lavoratore L.
n. 142 del 2001, ex artt. 2 e 5, stante la mancata comunicazione della delibera - non potendosi cioè riconnettere nessun effetto alla delibera di esclusione - la tutela
da assicurare al lavoratore sarà quella normale che discende dal giudizio sul solo licenziamento; sulla quale
dovrà provvedere il giudice di rinvio, esaminando il relativo capo della domanda.
7.- Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, la
ricorrente incidentale sostiene che l’impugnazione della
delibera è comunque avvenuta con l’atto di appello depositato il 6 ottobre 2012, nel termine di 60 giorni dal
deposito della delibera in giudizio il 23 giugno 2012 con
la memoria di costituzione della società cooperativa.
Nell’atto di appello la lavoratrice aveva infatti chiesto
specificamente la nullità, inefficacia, disapplicazione
della delibera di esclusione del socio mai comunicata.
Mentre lo stesso termine sarebbe soggetto a sospensione
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Società cooperative
durante il periodo feriale e pertanto non sarebbe mai
decorso.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 2, come mod.
dalla L. n. 30 del 2003, per la mancata applicazione della tutela reale, atteso che la norma esclude la tutela reale nel caso in cui sia l’esclusione a provocare il licenziamento, ma non in quello contrario allorché il rapporto
associativo sia cessato in conseguenza di un licenziamento (illegittimo), come nella fattispecie.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale lamenta
l’omessa pronuncia sulla domanda di tutela obbligatoria
L. n. 604 del 1966, ex art. 8, avanzata in via subordinata.
8.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale determina l’assorbimento degli altri tre. Va peraltro
osservato che nessuna inammissibilità del primo motivo
sussista per aver la medesima ricorrente incidentale affermato nel secondo motivo di aver impugnato la deliberazione con l’atto di appello, e di averla perciò conosciuta in conseguenza della sua produzione in giudizio
nel corso del procedimento di primo grado sul licenziamento. Si tratta infatti di un motivo presentato “in via
subordinata”, per l’ipotesi in cui fosse stata ritenuta legittima l’omessa comunicazione al socio della deliberazione di esclusione.
9.- Per le considerazioni che precedono il primo motivo
di ricorso incidentale deve essere accolto, mentre restano assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che per la decisione si uniformerà al seguente principio di diritto:
“La deliberazione di esclusione del socio lavoratore di
cooperativa ex art. 2533 c.c., e L. n. 142 del 2001, art.
5, è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto
minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell’esclusione e produce effetti al momento della
comunicazione; in mancanza della quale è tamquam non
esset. Non costituisce comunicazione della delibera di
esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua
produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento”.
(omissis).
IL COMMENTO
di Luigi Angiello
La Suprema Corte enuncia un principio di diritto sulla comunicazione dell’esclusione del socio
lavoratore nella società cooperativa, disciplinata dall’art. 2533 c.c.
La sentenza porta un importante elemento di chiarezza affermando la necessità della forma
scritta per la comunicazione dell’esclusione del socio lavoratore.
Tuttavia rimane qualche incertezza in relazione all’affermata parificazione, quanto agli oneri di
comunicazione, tra la comunicazione di esclusione ed il licenziamento, sotto il profilo del contenuto dei due atti.
Il caso
Una dipendente, nonché socia, di una Società cooperativa sociale impugnava avanti il Tribunale di
Milano il licenziamento intimatole per motivi disciplinari, chiedendo, in via principale, la tutela
reale e, in via subordinata, la tutela obbligatoria.
L’interessata, per quanto è dato di ricavare dalla ricostruzione in fatto nella sentenza qui annotata,
impugnava il licenziamento sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Sotto il profilo formale il dato più rilevante era costituito dalla mancata comunicazione all’interessata della delibera di esclusione da socia.
Sotto il profilo sostanziale la lavoratrice assumeva
che non vi sarebbero stati i presupposti per il licenziamento per motivi disciplinari.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso ritenendo legittimo il licenziamento nel merito aggiungendo, comunque, che, anche qualora il licenziamento fosse stato illegittimo nel merito, sarebbe
stata preclusa in ogni caso sia la tutela reale sia
quella obbligatoria in mancanza della impugnazione della delibera di esclusione da parte dell’interessata.
La socia - lavoratrice impugnava la sentenza che
veniva riformata dalla Corte d’Appello di Milano,
la quale, nel merito, reputava illegittimo il licenziamento, in quanto i fatti addebitati all’interessata, anche qualora fossero stati provati, non sarebbero stati tali da compromettere irrimediabilmente
l’elemento fiduciario e che, comunque, la massima
sanzione espulsiva veniva ritenuta eccessiva.
789
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Società cooperative
Sotto il profilo formale la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado in ordine alla
mancata impugnazione della delibera di esclusione
dalla Cooperativa, da parte dell’interessata, che sarebbe venuta a conoscenza dell’esclusione a seguito
dell’avvenuta restituzione della quota sociale, come
risultante dall’ultimo foglio paga.
La mancata impugnazione della delibera di esclusione avrebbe comportato - secondo i Giudici di
appello - l’impossibilità di emettere alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione dell’art.
18, L. n. 300/1970, secondo quanto stabilito dall’art. 2, L. n. 142/2001.
Da ciò la declaratoria di ingiustificatezza del recesso senza che venisse accordata né la tutela reale né
la tutela obbligatoria.
La Società cooperativa ricorreva in Cassazione
censurando la sentenza della Corte d’Appello sotto
vari profili riguardanti la declaratoria sul licenziamento in assenza di impugnazione della delibera di
esclusione. La socia lavoratrice resisteva con controricorso incidentale formulando quattro censure,
la prima delle quali riguardava la comunicazione di
recesso da socio, ai sensi dell’art. 2533 c.c., ed in
particolare le caratteristiche di detta comunicazione, avendo la Corte d’Appello reputato sufficiente,
quale comunicazione, la liquidazione della quota
sociale alla socia-lavoratrice.
La prima norma da prendere in considerazione è
l’art. 2533 c.c., concernente le modalità di esclusione del socio nelle società cooperative, per la
quale sono previsti due momenti finali: a) la delibera di esclusione del socio (1); b) la comunicazione della stessa al socio (2).
La disciplina dettata dall’art. 2533 c.c. concerne
l’esclusione del socio in generale.
Essa va raccordata con la L. 3 aprile 2001, n. 142,
parzialmente modificata dalla L. n. 30/2003, che
all’art. 9 disciplina la figura del socio lavoratore
nelle cooperative di lavoro (3).
Come è noto, il rapporto di lavoro del socio lavoratore viene considerato un rapporto speciale di lavoro con caratteri peculiari distintivi rispetto al
rapporto di lavoro subordinato.
Il tema è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinario sia per quanto concerne la coesistenza, accanto al rapporto sociale, di un ulteriore rapporto
di lavoro subordinato (o autonomo) sia per quanto
concerne lo svolgimento del rapporto sia, infine,
in relazione all’estinzione del rapporto, sub specie di
esclusione del socio lavoratore, punto focale che in
questa sede viene trattato (4).
Sulla necessità che il socio lavoratore sia posto a
conoscenza dei motivi dell’esclusione la Cassazione
si è già pronunciata in più di una occasione (5).
Così pure la S.C. si è già pronunciata sulla sufficienza di un unico atto - la delibera di esclusioneper l’estinzione automatica del rapporto di lavoro
senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento e sulla non applicabilità delle tutele previste dall’art. 7 Stat. lav. (6).
Tuttavia, ciò non significa che, in ogni caso, il rapporto sociale prevalga sul rapporto di lavoro subordinato nella fase estintiva del rapporto con il socio
lavoratore.
È stato di recente affermato dalla S.C. che qualora
la delibera di esclusione del socio lavoratore si fondi esclusivamente sul licenziamento disciplinare, in
tal caso alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento consegue l’illegittimità della delibera di
esclusione con applicazione dell’art. 18 Stat. lav.
A tale risultato si giunge sulla base di quanto stabilito dall’art. 2 della L. n. 142/2001, che prevede
l’applicazione dello Statuto dei lavoratori, salvo
che con il rapporto di lavoro venga a cessare anche
quello associativo (7).
(1) “L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea”: art. 2533,
comma 2, c.c.
(2) “Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione”: art. 2533, comma 3, c.c.
(3) Il riferimento è all’eliminazione delle parole “e distinto”,
di cui tanto si è detto.
(4) La letteratura giuridica sul tema è molto vasta. Mi limito
in questa sede a richiamare la monografia di Palladini, Il lavoro
nelle cooperative oltre il rapporto mutualistico, Padova 2006,
nella quale l’A. ricostruisce approfonditamente il tema della
qualificazione del rapporto di lavoro cooperativo, ponendo in
luce i profili di espansione del diritto del lavoro all’area cooperativa (183 ss.). Più recentemente v. Gragnoli, Collegamento
negoziale e recesso intimato al socio - lavoratore, in questa Rivista, 2007, 444 ss.; Imberti, Il socio lavoratore di cooperativa, Milano, 2012.
(5) V. Cass. 6 agosto 2012, n. 14143 e Cass. 9 maggio
2008, n. 11558, entrambe richiamate nella sentenza qui annotata.
È da rimarcare che la S.C. con la sent. n. 14143/2012 afferma l’irrilevanza della conoscenza aliunde dei motivi dell’esclusione.
(6) V. In tal senso v. Cass. 12 febbraio 2015, n. 2802 con
nota di Gamba, Questioni processuali controverse sulla tutela
del socio di cooperativa estromesso, in Riv. it. dir. lav., 2015, II,
1122 ss.
(7) In tal senso, abbastanza recentemente, Cass. 23 gennaio 2015, n. 1259, in Guida lav., 2015, n. 11, 63.
La forma dell’esclusione del sociolavoratore ai sensi dell’art. 2533 c.c.
790
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Società cooperative
L’esclusione del socio lavoratore ha dato luogo ad
un’elaborazione giurisprudenziale intensa, di cui si
è sinteticamente dato conto.
Peraltro, il tema della comunicazione dell’esclusione non è stato così diffusamente trattato.
La sentenza annotata si segnala soprattutto per l’affermazione di un principio concernente la forma
della comunicazione di esclusione e il contenuto
della stessa, di cui ora si dirà.
Come si è sopra posto in evidenza, il punto fondamentale della sentenza annotata riguarda la comunicazione della delibera di esclusione ed in particolare il contenuto della stessa.
Secondo l’opinione prevalente, cui aderisce la sentenza annotata, la comunicazione dell’esclusione
da socio vale ad estinguere entrambi i rapporti: sia
quello sociale, sia quello di lavoro subordinato (8).
Tuttavia, attesa la prevalenza del rapporto sociale
su quello lavoristico, non sono applicabili al procedimento di esclusione le tutele previste dall’art. 7
Stat. lav. per i lavoratori subordinati (9).
Ciò posto, occorre soffermarsi sui caratteri della
comunicazione della deliberazione, a proposito dei
quali alcun ausilio può essere tratto dall’art. 2533
c.c.
La S.C., dopo avere affermato la necessità della comunicazione ai fini della decorrenza del termine
per l’opposizione da parte del socio escluso, ha stabilito che “la disciplina di legge (ex art. 2533 c.c.)
va integrata nel senso che alla delibera di esclusione si applicano, in base ad una esigenza di coerenza
logica e di sistema, quanto agli oneri di comunicazione, i medesimi principi valevoli per il provvedimento di licenziamento”.
Quest’ultima affermazione pone sullo stesso piano
l’esclusione del socio e il licenziamento, per quanto
concerne gli oneri formali.
Ciò significa che anche per l’esclusione del socio è
necessaria la forma scritta, essendo da escludere la
possibilità di una comunicazione verbale (10).
A tale conclusione la Cassazione giunge - anche se
l’art. 2533 c.c. nulla dispone sulla forma della comunicazione - richiamando ragioni di coerenza logica e sistematica, che impedirebbero di trattare
differentemente, quanto alla comunicazione, l’esclusione del socio e il licenziamento, i cui effetti
nel rapporto di lavoro cooperativo coincidono.
Tale conclusione è accettabile non soltanto in virtù di un’interpretazione sistematica ma anche facendo ricorso all’analogia ex art. 12 disp. att. c.c.,
potendosi ravvisare una lacuna nell’ordinamento.
Peraltro, andando oltre la condivisione sul principio della forma scritta della comunicazione dell’esclusione, le questioni si complicano quanto alla
natura della comunicazione e al contenuto della
stessa.
Occorre chiarirsi su cosa si debba intendere per comunicazione.
Se, in particolare, la comunicazione vada intesa
come atto in sé ovvero se vada intesa quale strumento finalizzato alla trasmissione di un atto.
Qualora la comunicazione sia intesa come atto, come sarei propenso a ritenere, non potrebbe giungersi ad una perfetta parificazione, sotto il profilo
del contenuto, tra la comunicazione dell’esclusione
ed il licenziamento.
L’atto del licenziamento, come è noto, deve essere
scritto e motivato: art. 2, L. n. 604/1966, come novellato dalla L. n. 92/2012 (art. 1, comma 37), pena l’inefficacia.
L’ambito di applicazione dell’art. 2 ora citato è limitato ai licenziamenti intimati per giustificato
motivo oggettivo da datori di lavoro che abbiano
sino a 15 dipendenti.
Per i licenziamenti individuali per motivi oggettivi
intimati dai datori di lavoro, ai quali si applica
l’art. 18 L. n. 300/1970, è prevista la procedura
preventiva regolata dall’art. 7, L. n. 604/1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012,
che impone nella comunicazione di apertura oltre
all’intenzione di licenziare di “indicare i motivi del
licenziamento medesimo”.
Per i licenziamenti disciplinari l’atto di recesso deve contenere i motivi, per tali intendendosi i fatti
previamente contestati al dipendente.
(8) In tal senso v. Cass. n. 2802/2015 cit.; in dottrina, v. Laforgia, Il lavoro in cooperativa, in Mass. Giur. lav., 2012, 850 (ivi
ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
(9) Cfr. Vincieri, Esclusione e licenziamento: quali tutele per il
socio lavoratore di Cooperativa, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 866;
in precedenza, molto chiaramente, Zoli, Le modifiche alla riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, Padova, 2005, 1146
e Gragnoli, op. cit., 451. In giurisprudenza v. Cass. 12 febbraio
2015, n. 2802 e Cass. 5 luglio 2011, n. 14741.
(10) Nel senso della necessità della forma scritta v. Cass.
12 gennaio 1988, n. 143: in quel caso la necessità della forma
scritta venne affermata sulla base di una disposizione dello
Statuto della Cooperativa, mentre con riferimento all’art. 2527
c.c. all’epoca vigente, la S.C. affermò che la comunicazione
dell’esclusione “deve essere sufficiente a far conoscere al socio contenuto e motivi della decisione”. Difforme App. Milano
7 novembre 1989, in Giur. it., 1990, 2, 595.
Il principio affermato nella sentenza
annotata
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
791
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Società cooperative
Sicché, nell’ambito dei licenziamenti individuali, il
recesso, quale atto unilaterale motivato, va trasmesso (comunicato) al lavoratore nella sua interezza, non essendo possibile distinguere l’atto dalla
comunicazione dello stesso, che è chiaramente
strumentale.
Di contro, la comunicazione dell’esclusione del socio lavoratore va intesa quale atto, distinto dalla
delibera di esclusione.
La comunicazione potrebbe, in ipotesi, coincidere
con la delibera di esclusione, in caso di trasmissione in toto della stessa.
Ma non pare che ciò sia richiesto, potendo essere
sufficiente, come viene affermato nel principio di
diritto enunciato nella sentenza annotata, “un contenuto minimo necessario costituito dalle ragioni
dell’esclusione”.
La sentenza annotata è in linea, quindi, quanto al
contenuto della comunicazione di esclusione, con
il precedente orientamento della S.C. la quale aveva già affermato, senza nulla statuire sulla forma,
che la comunicazione dell’esclusione non necessariamente deve contenere in modo specifico i motivi dell’esclusione, essendo “sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo,
conseguendosi in tal modo la finalità prevista dalla
legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese” (11).
Ciò significa, quindi, che fermo il requisito della
forma scritta, le ragioni a sostegno dell’esclusione
possono legittimamente essere indicate in modo
succinto, dovendosi però necessariamente far riferimento, per relationem, alla delibera di esclusione.
La non perfetta equiparazione tra la forma del licenziamento e quella dell’esclusione lascia margini
di incertezza circa il contenuto della comunicazione scritta di esclusione del socio, che comunque
deve essere tale da porre in condizione l’escluso di
valutare l’opportunità di proporre opposizione.
Ciò implica che nella comunicazione scritta vi deve essere il riferimento alla delibera di esclusione e
alle ragioni dell’esclusione, non necessariamente
da indicarsi in modo specifico, come invece è richiesto nei licenziamenti individuali, come si è
detto.
Il principio di diritto enunciato nella sentenza annotata offre certamente elementi di chiarezza in ordine alla forma della comunicazione di esclusione,
anche se, come si è visto, l’equiparazione con la
forma del licenziamento lascia spazio a margini di
incertezza.
La pronuncia si pone, sotto tale profilo, nel solco
di quella linea di tendenza, volta ad avvicinare
sempre di più, per molti aspetti, la figura del sociolavoratore a quella del lavoratore subordinato sia
dal punto di vista sostanziale che processuale.
Pur riaffermandosi, con indirizzo che può dirsi ormai consolidato, la prevalenza del rapporto sociale
sul rapporto di lavoro subordinato, si tende ad applicare le tecniche di tutela del lavoratore subordinato al socio lavoratore di cooperativa.
Ciò detto sotto un profilo strettamente formale, riguardante la fase terminale del rapporto, restano in
gran parte irrisolti i numerosi problemi scaturenti
dall’interferenza tra il rapporto di lavoro sociale e
quello di lavoro subordinato.
In particolare, come si è già posto in rilievo, la giurisprudenza anche recente della Cassazione (12) in
taluni casi ha fatto prevalere, nella fase estintiva, il
rapporto di lavoro sul rapporto sociale stabilendo
l’applicazione dell’art. 18 Stat. lav., pur in presenza
di una delibera di esclusione del socio.
Stabilire quali siano le gravi inadempienze del socio previste dall’art. 2533, n. 2, c.c. e quali siano le
inadempienze del lavoratore in relazione al rapporto di lavoro subordinato potrebbe essere molto arduo in parecchi casi.
Tale distinzione appare particolarmente difficoltosa
in ipotesi di cessazione del rapporto sulla base del
solo atto di esclusione.
Qualora venga accertato che “nella sostanza” il
rapporto di lavoro subordinato si sia risolto per motivi disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario, dovrebbe trovare applicazione la
disciplina giuslavoristica e, quindi, trattandosi di licenziamento per motivi soggettivi, l’art. 7 Stat.
lav. (13).
La questione non è di poco conto, qualora la Società cooperativa, come accade spesso, decida di
procedere con le regole del diritto societario limi-
(11) Cass. 18 giugno 2004, n. 11402; conforme in dottrina,
Vincieri, op. cit., 866. Parzialmente difforme la posizione di Zoli, op. cit., 1146 il quale afferma che la delibera di esclusione
“dovrà essere idonea a consentire all’interessato di conoscere
esattamente gli addebiti mossigli, a prescindere da una contestazione preventiva ed ai soli fin della garanzia del socio di
esercitare con piena cognizione di causa il diritto di opposizione attraverso l’impugnazione della delibera stessa”.
(12) V. Cass. n. 1259/2015, cit.
(13) La S.C. nella citata sent. n. 1259/2015 afferma: “Ciò
che rileva è che si sia avuta l’estromissione dalla società, con
conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato per
792
Brevi considerazioni conclusive
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Società cooperative
tandosi a comunicare, per iscritto e con motivazione adeguata, l’esclusione.
In tali ipotesi, qualora fossero ritenute di natura disciplinare le ragioni addotte dalla Società, prenderebbe il sopravvento il rapporto di lavoro subordinato con l’applicazione della disciplina giuslavoristica (art. 18 Stat. lav. oppure L. n. 604/1966 oppure le regole dettate dal jobs act in tema di licenziamenti individuali).
Il che porterebbe, nella maggior parte dei casi, ad
esiti meno favorevoli rispetto alla tutela prevista
dal diritto societario in ipotesi di annullamento
della delibera di esclusione con i noti effetti ex
tunc (14).
Insomma, un bel pasticcio formale, procedimentale
e sostanziale, intorno al quale ci sarà ancora molto
da discutere.
motivi disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare
detta estromissione, con illegittimità anche della risoluzione
del rapporto di lavoro. In altri termini ciò che conta è la sostanza…”.
(14) V. Sulle forme di tutela del socio lavoratore puntuali os-
servazioni di Gragnoli, Collegamento negoziale e recesso intimato al socio lavoratore, cit., 452, il quale afferma che “non desta troppa preoccupazione il mancato operare dell’art. 18 St.
lav.” e che “il socio non è in una posizione molto deteriore rispetto a quella che deriverebbe dall’art. 18 St. lav.”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
793
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
Onere della prova e repechage
L’epilogo in tema di repechage
e onere probatorio
Cassazione Civile, Sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592 - Pres. Venuti - Rel. Patti - P.M. Mastroberardino - P.A. c. H.S.p.a.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Onere della prova, del repechage in capo al datore di lavoro - Esclusione di allegazione a carico
(legge n. 604/1966, artt. 5; cod. proc. civ. art. 414, nn. 3 e 4; cod. civ. art. 1175, 1206, 1375)
In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità dei repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento stesso, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo posto a carico del lavoratore, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi
spettanti alla parte deducente la giustificatezza del licenziamento.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass. 18 marzo 2016, n. 4509.
Difforme
Cass. 14 gennaio 2016, n. 496 - Trib. Milano 13 gennaio 2016 - Cass. 23 settembre 2015, n. 18780.
La Corte (omissis).
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e vizio
di motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria,
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per
mancato accertamento dell’effettiva cessazione, al di là
del suo accorpamento ad altra, dell’attività della divisione Applicazioni Industriali e della soppressione delle
proprie mansioni, senza alcuna giustificazione di ciò,
nonostante la specificità al riguardo delle doglianze in
appello.
Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175,
1375, 2697 e 2729 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non ritenuto inadempimento dalla società datrice all’obbligo
di repechage, pure con motivazione insufficiente e contraddittoria.
Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175,
1375, 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, per erronea ripartizione dell’onere della
prova, non posto a carico, secondo più rigoroso indirizzo
interpretativo di legittimità, del datore di lavoro, senza
alcun coinvolgimento collaborativo del lavoratore, come invece per altro indirizzo di minor rigore.
794
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175,
1375 c.c. e vizio di motivazione illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata esatta
valutazione della disponibilità manifestata allo svolgimento di mansioni anche inferiori, con la lettera del 25
marzo 2009 in risposta a quella datoriale di licenziamento senza preavviso del 17 marzo 2009, nell’impossibilità di manifestare prima una tale disponibilità, essendo all’oscuro della determinazione della propria datrice,
con la conseguente inapplicabilità al caso di specie del
principio acriticamente recepito dalla Corte territoriale,
riguardante tuttavia ipotesi diversa di previa conoscenza
della situazione dai lavoratori (prima oggetto di demansionamento impugnato giudizialmente e quindi) licenziati.
Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175 e
1375 c.c. e vizio di motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omessa
valutazione del proprio carico familiare nella valutazione della preferenza datoriale per la conservazione dell’incarico di direttore della divisione Geotecnica al
dr.B. in proprio danno.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e vizio di motivazione, per mancato accertamento dell’effettiva cessazione
dell’attività della divisione Applicazioni Industriali e
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Controversie del lavoro
della soppressione delle mansioni del lavoratore, è
inammissibile.
Sotto il profilo di violazione di legge, al di là della formale enunciazione della sua rubrica, esso non integra
gli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che
motivatamente si assumano in contrasto con le norme
regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038;
Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006,
n. 12984).
Né qui rileva una questione di sindacabilità, sotto il
profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio
applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente la clausola generale del giustificato motivo obbiettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3),
che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione
giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini
del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di un determinato comportamento del lavoratore nell’ambito del giustificato
motivo (piuttosto che della giusta causa di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434;
Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514).
E ciò per la sindacabilità, da parte della Corte di Cassazione, dell’attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la
contestazione del giudizio valutativo operato in sede di
merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento,
esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n.
6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095): con limitazione, alla luce dell’esperienza applicativa della Corte, almeno
nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del
merito sia chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, del controllo di legittimità alla verifica di ragionevolezza della sussunzione del fatto e quindi ad un
sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ben lontano da
quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 18
novembre 2010, n. 23287).
Ed infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di
norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto
e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della
decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la
norma non sia stata applicata quando doveva esserlo,
ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,
ovvero che sia stata male applicata (Cass. 15 dicembre
2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sic-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
ché, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di
diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione
del fatto incontestata; al contrario del sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che
invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione
tra le parti.
Ciò che appunto si verifica nel caso di specie, in cui si
controverte, non tanto (e per le ragioni dette) di esatta
interpretazione di norme né di corretto esercizio del
processo di sussunzione della fattispecie concreta in
quella astratta regolata dalla disposizione di legge denunciata (correttamente individuata nell’integrazione
del giustificato motivo oggettivo dal processo di riorganizzazione aziendale comportante l’accorpamento della
divisione già diretta da P. in quella Geotecnica, per crisi economica e finanziaria), quanto piuttosto di accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in
giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento (effettiva soppressione delle mansioni del
lavoratore):
e pertanto sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione
a condizione che la contestazione non si limiti ad una
censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli
standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti
nella realtà sociale (Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).
Parimenti inammissibile è il denunciato vizio di illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più
deducibile per l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5 (di denuncia “per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti”), applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata in data posteriore (13
febbraio 2013) al trentesimo giorno successivo a quella
di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di
conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (12 settembre 2012), secondo la previsione dell’art. 54, comma 3
del decreto legge citato.
Esso ha, infatti, introdotto nell’ordinamento un vizio
specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che,
qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
795
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie.
Sicché, detta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Ed è pertanto
denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa
ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).
Né l’omesso esame di elementi istruttori integra in sé il
suddetto vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 10 febbraio 2015, n.
2498): con la conseguente preclusione nel giudizio di
cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro
valutazione a fini istruttori (Cass. 21 ottobre 2015, n.
21439).
Il secondo (violazione e falsa applicazione della L. n.
604 del 1966, art. 3, artt. 1175, 1375, 2697 e 2729 c.c.
e vizio di motivazione, per non ritenuto inadempimento
dalla società datrice all’obbligo di repechage) e il terzo
motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 604
del 1966, art. 3, artt. 1175, 1375, 2697 e 2729 c.c., per
erronea ripartizione dell’onere della prova al riguardo)
sono congiuntamente esaminabili per la loro stretta
connessione.
Essi sono fondati.
Il collegio è ben consapevole di un consolidato indirizzo
di questa Corte, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della L. n.
604 del 1966, art. 3 (accanto ad uno di chiara affermazione dell’onere datoriale della prova dell’impossibilità
di impiegare il lavoratore in altre mansioni compatibili
con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso
era precedentemente adibito: Cass. 12 luglio 2012, n.
11775; 26 marzo 2010, n. 7381; Cass. 13 agosto 2008,
n. 21579; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769; Cass. 9 giugno 2004, n. 10916; Cass. 1 ottobre 1998, n. 9768;
Cass. 26 ottobre 1993, n. 9369), secondo cui, se indubbiamente un tale onere competa al datore di lavoro,
tuttavia esso conseguirebbe da un (diverso e propedeutico) onere, a carico dello stesso lavoratore che impugni
il licenziamento, di allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro per la sua utile ricollocazione, in virtù di
un preteso obbligo di collaborazione nell’accertamento
di un possibile repechage (Cass. 6 ottobre 2015, n.
19923; Cass. 3 marzo 2014, n. 4920; Cass. 8 novembre
2013 n. 25197; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18025; Cass.
796
26 aprile 2012, n. 6501; Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040;
Cass. 18 marzo 2010, n. 6559; Cass. 22 ottobre 2009, n.
22417; Cass. 19 febbraio 2008, n. 4068; Cass. 9 agosto
2003, n. 12037; Cass. 12 giugno 2002, n. 8396; Cass. 3
ottobre 2000, n. 13134): in una sorta, per così dire, di
cooperazione processuale.
Tuttavia, come chiaramente si evince dall’integrale lettura delle sentenze citate, un tale indirizzo imperniato
su una netta (e inedita) divaricazione tra onere di allegazione (in capo al lavoratore) e di prova (in capo al
datore di lavoro) è meramente tralaticio, fondandosi su
una petizione di principio (secondo cui “il lavoratore,
pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava
per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere
di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage”) assunta come postulato, in quanto affatto argomentata nel suo fondamento giuridico.
Per trovare una spiegazione, occorre risalire ad una lontana sentenza, che, premesso l’onere datoriale, in tema
di licenziamento per giustificato motivo obiettivo secondo costante orientamento della medesima Corte, di
provare l’impossibilità di una diversa utilizzazione, trattandosi di circostanza pur sempre ricollegabile alle generali “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”,
ha offerto la seguente giustificazione: “Pur sussistendo...
siffatto carico probatorio sul datore di lavoro, resta peraltro pur sempre a carico del lavoratore, ricorrente in
giudizio per ottenere l’annullamento del licenziamento,
l’onere di dedurre ed allegare, in osservanza delle prescrizioni sulla forma della domanda dettate dall’art. 414
c.p.c. (secondo cui la domanda deve contenere, tra l’altro, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali (essa) si fonda”: n. 3 cit. art. 414), le specifiche
circostanze e ragioni costituenti i presupposti di tale
azione. E pertanto - con riferimento al caso che qui interessa-è da ricondurre a tale onere, del lavoratore ricorrente, il dedurre e l’allegare circostanze di fatto e ragioni di diritto costituenti il fondamento della affermata illegittimità del licenziamento intimato per giustificato
motivo oggettivo: e così la insussistenza di un giustificato motivo, ovvero l’inadeguatezza in tal senso del motivo addotto dal datore di lavoro, ed anche la possibilità,
comunque, di una sua diversa utilizzazione nell’impresa
con mansioni equivalenti... Sarà poi onere del convenuto datore di lavoro, in opposizione alle suddette deduzioni e allegazioni attinenti agli elementi essenziali dell’azione contro di lui proposta, fornire la prova ai sensi
della L. n. 604 del 1966, art. 5 cit. (che in sostanza contiene una specificazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., comma 2) dei fatti impeditivi dell’azionato diritto ad ottenere l’annullamento del licenziamento: e fornire quindi la prova della sussistenza delle
ragioni produttive e organizzative aziendali di cui alla L.
n. 604 del 1966, art. 3 cit. (ed in particolare, nel caso
di specie, la prova della sostenuta riduzione dell’attività
imprenditoriale per diminuzione degli appalti), nonché
la prova che non v’era comunque possibilità di una diversa e adeguata utilizzazione del dipendente. Ma ove
una siffatta possibilità di diversa utilizzazione (che costi-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Controversie del lavoro
tuisce elemento di fatto certamente collegato, ma pur
sempre differenziato e distinto rispetto alle vere e proprie ragioni di carattere organizzativo, produttivo e funzionale riferite alla attività aziendale dal citato art. 3)
non sia stata neppure allegata dal ricorrente tra gli elementi posti a fondamento dell’azione e tra i presupposti
della sua domanda, non v’è ragione logica per cui il
convenuto debba chiedere di provare la insussistenza di
una tale circostanza, in quanto appunto nemmeno prospettata dalla parte interessata a farla valere” (Cass. 23
ottobre 1998, n. 10559).
Appare evidente come i principi testualmente riportati
(e che, si ribadisce, costituiscono la giustificazione del
consolidato indirizzo qui confutato) non possano essere
condivisi, e non solo perché già in precedenza smentiti,
in particolare da due sentenze, secondo cui:
“l’onere della prova della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe e quelle
svolte in precedenza, pur dovendo essere mantenuto entro limiti di ragionevolezza sì che può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze probatorie di
natura presuntiva e indiziaria... non può tuttavia essere
posto direttamente o indirettamente a carico del lavoratore, neppure al solo fine della indicazione di posti di
lavoro assegnabili invero, pur dovendosi tener conto
della specificità dei vari settori dell’impresa, la superfluità del lavoro del dipendente licenziato deve essere valutata entro l’ambito dell’intera azienda e non già con riferimento al singolo posto ricoperto, nel senso che grava interamente sul datore di lavoro la dimostrazione
della impossibilità di utilizzare il dipendente in altro
settore della stessa azienda” (Cass. 7 luglio 1992 n.
8254); “La prova... dell’impossibilità di un diverso impiego della lavoratrice licenziata nell’azienda, senza dequalificazione, gravava per intero anch’essa sul datore di
lavoro e non poteva quindi trasferirsi neppure in parte
sulla lavoratrice (pur se al solo fine dell’indicazione di
posti di lavoro a lei assegnabili). Non si vede in realtà
come sia esigibile un’indicazione del genere da parte del
lavoratore licenziato, che è estraneo all’organizzazione
aziendale, e l’indirizzo in tal senso di questa Corte... può
dirsi costante” (Cass. 18 aprile 1991, n. 4164).
Con la loro enunciazione si ritiene, in buona sostanza,
che la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse (cd. repechage) sia
elemento costitutivo della domanda di impugnazione
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
perciò nell’onere di allegazione del lavoratore medesimo, cui il datore di lavoro opponga il fatto impeditivo
“dell’azionato diritto ad ottenere l’annullamento del licenziamento”:
in esso inclusa la negazione della “possibilità di una diversa e adeguata utilizzazione del dipendente”, purché“allegata dal ricorrente tra gli elementi posti a fondamento dell’azione e tra i presupposti della sua domanda”.
Ma in realtà non è così, perché, se è indubbio che nel
giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la causa petendi sia data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al da-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
tore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, è pur vero che l’indicazione (pur “possibile” da parte del “lavoratore” che si sia fatto “parte diligente”) di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze idonee a comprovare
l’insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento,
comporti l’inversione dell’onere della prova (Cass. 5
marzo 2015, n. 4460, con espresso richiamo sul punto
di Cass. 7 luglio 1992, n. 8254, che in proposito, giova
ribadire, ha testualmente affermato che: “l’onere della
prova della impossibilità di adibire il lavoratore allo
svolgimento di mansioni analoghe e quelle svolte in
precedenza... non può tuttavia essere posto direttamente
o indirettamente a carico del lavoratore, neppure al solo
fine della indicazione di posti di lavoro assegnabili”).
Ora, la L. n. 604 del 1966, art. 5 è assolutamente chiaro
nel porre a carico del datore di lavoro “l’onere della
prova della sussistenza... del giustificato motivo di licenziamento”: ed in tale senso esso è interpretato in ordine
al controllo giudiziale dell’effettiva sussistenza del motivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, addotto dal datore di lavoro, essendo invece insindacabile la scelta dei criteri di gestione dell’impresa,
espressione della libertà di iniziativa economica tutelata
dall’art. 41 Cost. (Cass. 14 maggio 2012, n. 7474; Cass.
11 luglio 2011, n. 15157).
Ed in esso rientra il requisito dell’impossibilità di repechage, quale criterio di integrazione delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro
ed al regolare funzionamento di essa, nella modulazione
della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo
lavoratore licenziato, derogabile soltanto quando il motivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile (dovendo in tal caso il datore di lavoro pur sempre improntare l’individuazione
del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e
buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art.
1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto
obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse:
Cass. 28 marzo 2011, n. 7046) ovvero in caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali (per incompatibilità del repechage
con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da
un regime di libera recedibilità del datore di lavoro:
Cass. 11 febbraio 2013, n. 3175).
Ed allora, la domanda del lavoratore è correttamente
individuata, a norma dell’art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, da
un petitum di impugnazione del licenziamento per illegittimità e da una causa petendi di inesistenza del giustificato motivo così come intimato dal datore di lavoro, cui incombe pertanto la prova, secondo la previsione della L. n. 604 del 1966, art. 5, della sua ricorrenza
in tutti gli elementi costitutivi, in essi compresa l’impossibilità di repechage: senza alcun onere sostitutivo
del lavoratore alla sua controparte datrice sul piano dell’allegazione, per farne conseguire un onere probatorio
797
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
(offrendogli, per così dire, l’affermazione del fatto da
provare).
Si tratterebbe di una divaricazione davvero singolare, in
quanto inedita sul piano processuale, nel quale l’onere
della prova è modulato in coerente corrispondenza con
quello dell’allegazione, come inequivocabilmente stabilito dall’indicazione dei requisiti della domanda (“esposizione dei fatti... sui quali si fonda la domanda” e “indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente
intende avvalersi”: art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5, con previsione del tutto analoga a quella dell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 4 e 5), in funzione di una corretta ripartizione
dell’onere probatorio secondo la previsione dell’art.
2697 c.c., a norma del quale ciascuna delle parti deve
provare i fatti a fondamento delle proprie domande o
eccezioni, espressione del rispettivo onere di allegazione, nell’evidente indisgiungibilità dei due piani (Cass.
s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951: in riferimento ad allegazione e prova della titolarità della posizione giuridica
vantata in giudizio; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21847 e
Cass. 19 agosto 2009, n. 18399: in riferimento all’onere
di provare le proprie allegazioni soltanto ove non specificamente contestate da controparte).
La patrocinata ricostruzione sistematica della ripartizione dei rispettivi oneri di allegazione e di prova tra le
parti nella fattispecie in esame trova piena conferma
anche ove ricondotta ai principi in tema di responsabilità da inadempimento, di cui la normativa di carattere
generale in materia di licenziamenti (come principalmente stabilita dalla L. n. 604 del 1966 e dalla L. n.
300 del 1970, art. 18) costituisce specificazione, essendo
applicabile agli effetti del licenziamento, qualora non
operi detta normativa, la disciplina civilistica dell’inadempimento (Cass. 22 luglio 2004, n. 13731).
Sicché, in base a tali principi, il creditore attore (lavoratore impugnante il licenziamento come illegittimo) è
onerato della (allegazione e) prova della fonte negoziale
(o legale) del proprio diritto (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte (illegittimo esercizio del diritto di
recesso per giustificato motivo oggettivo), mentre il debitore convenuto (datore di lavoro) è onerato della prova del fatto estintivo (legittimo esercizio del diritto di
recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza
dei suoi presupposti, tra i quali, come detto, anche l’impossibilità di repechage): in coerenza con i principi di
persistenza del diritto (art. 2697 c.c.) e di riferibilità o
vicinanza della prova (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n.
13533). E tale principio di riferibilità o vicinanza della
prova, conforme all’esigenza di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore a reagire all’inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore, in quanto nella migliore disponibilità degli elementi per dimostrare le ragioni del
proprio comportamento, ormai di consolidata applicazione (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1665; Cass. 14 gen-
798
naio 2013, n. 2016; Cass. 2 settembre 2013, n. 20110;
Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 6 giugno 2012, n.
9099), trova coerente riscontro anche nel caso di specie: per la maggiore vicinanza di allegazione e prova
dell’impossibilità di repechage al datore di lavoro, non
disponendo il lavoratore, al contrario del primo, della
completezza di informazione delle condizioni dell’impresa, tanto più in una condizione di crisi, in cui esse mutano continuamente a misura della sua evoluzione e degli interventi imprenditoriali per rimediarvi o comunque indirizzarne gli sbocchi. Ciò che, d’altro canto, da
tempo è stato ben presente a questa Corte, avendo in
particolare essa osservato: “non si vede in realtà come
sia esigibile un’indicazione del genere” (ossia dei posti
assegnabili) “da parte del lavoratore licenziato, che è
estraneo all’organizzazione aziendale” (Cass. 18 aprile
1991, n. 4164, che ha anche sottolineato la costanza di
un indirizzo in tal senso della Corte).
In via conclusiva, si comprende allora come la tralaticia
affermazione di una sorta di cooperazione processuale
del lavoratore, e più in generale di ogni parte, sul piano
dell’allegazione in favore della controparte sia priva di
alcun fondamento normativo;
soltanto sul piano sostanziale un tale obbligo di cooperazione è, infatti, previsto tra le parti, siccome tenute
ad un comportamento di collaborazione, conforme ai
principi di correttezza e di buona fede, a norma degli
artt. 1175, 1206 e 1375 c.c., quale obbligazione collaterale alle principali (Cass. 6 febbraio 2008, n. 2800;
Cass. 16 gennaio 1997, n. 387).
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del
quarto (violazione e falsa applicazione della L. n. 604
del 1966, art. 3, artt. 1175 e 1375 c.c. e motivazione illogica, per mancata esatta valutazione della disponibilità manifestata allo svolgimento di mansioni anche inferiori) e del quinto motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175 e 1375
c.c. e motivazione contraddittoria, per omessa valutazione del proprio carico familiare nella valutazione della
preferenza datoriale per la conservazione dell’incarico di
direttore della divisione Geotecnica al dr. B.), discende
coerente l’accoglimento dei due motivi congiuntamente
scrutinati, con la cassazione della sentenza impugnata
in relazione ad essi e rinvio, anche per la regolazione
delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto:
“In materia di illegittimo licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione
e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore
licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di
licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione
al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari
principi processuali una divaricazione tra i due suddetti
oneri, entrambi spettanti alla parte deducente”.
(omissis).
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Controversie del lavoro
ILCOMMENTO
di Carmelo Romeo
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sembra sia giunta al capolinea di un lungo e frastagliato percorso interpretativo in tema di riparto dell’onere probatorio circa la sussistenza o meno
del c.d. “repechage”. Quest’ultima decisione, infatti, nel segno di un’esaustiva ricostruzione delle modalità di prospettazione della domanda di impugnativa del licenziamento e, soprattutto,
nell’obbiettivo di fare chiarezza riguardo i contenuti e l’ampiezza del carico probatorio del datore
di lavoro, approda ad un coerente risultato con l’esclusione di ogni margine, anche residuale e
di mera allegazione, a carico del lavoratore licenziato.
Il nuovo orientamento della Suprema Corte
sul tema del repechage
Con la sentenza che qui brevemente si annotata la
Cassazione ha finalmente chiuso il cerchio sulla dibattuta e nota vicenda del riparto dell’onere della
prova in materia di repechage del lavoratore licenziato; segnatamente sull’eventuale diritto di quest’ultimo di essere “ripescato” e, quindi, utilmente
ricollocato a lavoro all’interno dell’azienda, stabilendone la ricaduta probatoria sulla parte datoriale.
A ben vedere, è il caso di avvertire subito, nel segno della massima trasparenza e immediatezza, come quest’ultimo orientamento giurisprudenziale finisca ora, senza tentennamenti, per porre interamente a carico del datore di lavoro la dimostrazione, certa e inconfutabile, che non vi sia in concreto alcuna possibilità di reinserimento del lavoratore nella compagine dell’organico aziendale, escludendo a carico di quest’ultimo qualsiasi prova, sia
pure soft, anche di semplice allegazione di possibili
e concreti reinserimenti.
Sotto tale (e centrale) profilo, la decisione in commento - la quale come primo motivo fa il punto,
tra l’altro, sull’omesso esame di un fatto storico
della controversia, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369,
comma 2, n. 4,c.p.c. - rappresenta indubbiamente
una svolta, ora finale e sicuramente emblematica.
E ciò nel paradigma relativo al riparto dell’onere
probatorio in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e, segnatamente, sulle con(1) In generale per un ricostruzione dell’istituto, cfr. M.
Proietti, Il licenziamento e l’obbligo di repechage: il lavoratore
deve essere avvisato se rischia il posto, in www.ilsoleventiquattrore.com che esemplifica i casi pratici più ricorrenti.
(2) Si v. il commento di D. Zanetto, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l’obbligo di repechage dopo la riforma Fornero, a Trib. Milano 20 novembre 2012, in questa Rivista, 2013, 6, 581 ss., ove si sostiene che la mera violazione
dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro esclude
(on) la “manifesta insussistenza del fatto” e la conseguente tu-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
crete aspettative del lavoratore licenziato di essere
riadibito al lavoro. Per certi versi, come si avrà modo di spiegare meglio nel prosieguo della riflessione, quest’ultima sentenza finisce per semplificare, e
non di poco, il precedente orientamento giurisprudenziale che aveva tradizionalmente operato un sistema di ripartizione complesso e articolato dell’onus probandi, proprio sulla tematica del repechage (1). Si viene così a realizzare il totale e definitivo rovesciamento del principio generale i forza del
quale colui che agisce in giudizio per far valere una
sua pretesa ha l’onere di dimostrare i fatti sui quali
si fonderebbe detta pretesa, ben riassunta nel noto
brocardo latino onus probandi ei incumbit qui agit,non qui negat.
Orbene, la pronuncia qui al vaglio sembra indubbiamente concludere, il lungo percorso (2), a volte
accidentato e contraddittorio, sulla prova assoluta
e inconfutabile circa la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente, introducendo un
principio di maggior favore per il lavoratore licenziato, che non dovrà più essere onerato - come stabiliva la precedente giurisprudenza - di un’allegazione relativa alle concrete possibilità circa la materiale realizzazione del repechage.
Sotto il profilo metodologico la sentenza, diversamente da altre recenti decisioni adottate sempre
dalla stessa Cass., Sez. lav. (3), si apprezza soprattutto per un’ampia e articolata motivazione e tiene
conto, in forma ineccepibile, dei precedenti arresti
difformi della stessa Corte. Un tale modus operandi,
tela reale. Il Tribunale di Milano, riconosce nel caso in questione la sola tutela risarcitoria. Secondo Zanetto, “viene così fornita una prima interpretazione giurisprudenziale del sibillino
art. 18, comma 7, Stat. lav., come modificato dalla recente Riforma Fornero”.
(3) Mi permetto di rinviare al mio commento critico Due
sentenze gemelle della Suprema Corte che estendono la tutela
reintegratoria in materia di licenziamento, a Cass. 13 ottobre
2015, nn. 20540 e 20545, in Mass. Giur. lav., 2015, 12, 850 ss.
799
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
a ben vedere, consente indubbiamente, non solo
una ricostruzione sistematica degli istituti in questione, ma anche l’approdo ad una nuova interpretazione attraverso un ragionamento declinato essenzialmente sul piano della incongruenza di un riparto dell’onere della prova sull’argomento. In verità, è proprio l’ampiezza motivazionale in questione, nonché l’esaustiva spiegazione relativa all’approdo ad un diverso (e più convincente) indirizzo
interpretativo, che fa apprezzare nel suo complesso
il decisum della Corte.
L’articolazione dell’onere della prova prima
della decisione commentata
I precedenti arresti della giurisprudenza, nel merito
della problematica qui selezionata, avevano stabilito che, pur essendo il datore di lavoro tenuto a
provare - anche mediante elementi presuntivi e indiziali -l’impossibilità di una differente utilizzazione
del lavoratore, ciò non escludeva che parimenti il
lavoratore licenziato avrebbe dovuto operare con
una fattiva collaborazione nell’accertamento di un
possibile repechage. Sullo specifico argomento si segnala, sia pure come ultima espressione della predetta interpretazione, una pur recente sentenza
della S.C. (4). Orbene, senza approfondire (del)
l’evidente e palese difficoltà di tale incombente
probatorio, quest’ultima decisione, in verità, aveva
inteso onerare il lavoratore di una sua precisa “collaborazione” nell’accertamento del risultato finale
e poi, solo successivamente, il datore di lavoro
avrebbe avuto l’onere di provare in concreto la
non utilizzabilità dei posti di lavoro nell’ambito
aziendale, utili per una possibile ricollocazione del
dipendente licenziato.
A ben vedere, tale orientamento, peraltro risalente
anche a precedenti decisioni (5), incide profondamente sul riparto dell’onere probatorio, atteso che
(4) Cfr. Cass., Sez. lav., 14 gennaio 2016, n. 496, in questa
Rivista, 2016, 4, 401 ss.
(5) Sul punto cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22 417, in questa Rivista, 2010, 1, 88 ss., la quale ha stabilito il diverso principio che la prova della mancata utilizzabilità del lavoratore licenziato in altra mansione non deve essere intesa in modo rigido, “dovendosi esigere dallo stesso lavoratore, che impugni
il licenziamento, una collaborazione nell’accertamento di un
possibile repêchage, mediante l’allegazione della esistenza di
altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato. A tale allegazione corrisponde l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze
indiziarie, come la piena occupazione negli altri cantieri e l’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare”. È di tutta evidenza che, in tale decisione,
viene sancito il principio di un parziale assorbimento dell’onere
800
finisce con l’essere il lavoratore a dover prospettare
ab imis la concreta e tangibile possibilità di un suo
recupero nell’organizzazione dell’impresa. A fronte
di una tale allegazione di specifiche circostanze di
fatto dovrà essere successivamente il datore di lavoro a provare l’impossibilità di continuare ad utilizzare il predetto dipendente, ad esempio attesa l’inesistenza di mansioni equivalenti. Il predetto
orientamento, tra l’altro, emerge dalla stessa giurisprudenza di merito che aveva finito per ammettere l’onere, a carico del lavoratore, di prospettare
una diversa utilizzazione nell’ambito aziendale (6).
Sempre in tema di onere di allegazione da parte
del dipendente licenziato, inoltre, si segnala il caso
di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore
che, fermo l’onere della prova sul datore circa il
reimpiego in mansioni equivalenti, dovrà il primo
fornire le necessarie allegazioni per un possibile ricollocamento, che sia compatibile (mente) all’inidoneità fisica sopravvenuta (7). La precedente giurisprudenza aveva parimenti stabilito, riguardo l’inidoneità del lavoratore, che non vi fosse l’onere
di una prova assoluta e inconfutabile da parte del
datore di lavoro, atteso che la prova avrebbe potuto anche emergere dallo stesso contraddittorio tra
le parti in causa (8).
Onere della prova ad esclusivo carico
del datore
La decisione commentata, invece, a differenza da
quanto stabilito nei precedenti arresti della giurisprudenza, esonera del tutto il lavoratore, che impugni il licenziamento, dell’onere di allegazione
dell’esistenza di altri posti di lavoro. In altri termini, quest’ultimo orientamento trova discutibile la
divaricazione concettuale in punto di onere della
prova, tra un compito di allegazione in capo al lavoratore e un onere della prova in carico al datore,
della prova in merito alla possibilità di reimpiego del lavoratore
licenziato in capo a quest’ultimo. Più in particolare tale carico
probatorio deve consistere nell’indicare gli altri posti di lavoro
esistenti e non occupati dai dipendenti, conformi con la qualifica e le mansioni del dipendente licenziato.
(6) Cfr. sempre questa Rivista, 2014, 10, 930 ove viene riportata una giurisprudenza di merito in tema di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage, a cura di F. Collia e F. Rotondi.
(7) Cfr. sull’argomento Cass. 10 marzo 2015, n. 4757, in
questa Rivista, 2015, 6, 635, con nota redazionale di C.A. Giovanardi. Ma, anche Cass. 3 marzo 2014, n. 4920, in Dir. lav. e
rel. Ind., 2015, 1, 6.
(8) Sul punto specifico si rinvia al commento di G. Guarnieri, alla già citata sentenza di Cass., Sez. lav., 14 gennaio 2016,
n. 496, in questa Rivista, 2016, 4, in particolare a pag. 403, ove
si riportano numero precedenti sostanzialmente conformi.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Controversie del lavoro
sostenendo che trattasi di una costruzione meramente speciosa e tralatizia, “fondandosi su una petizione di principio secondo la quale il lavoratore
ha comunque un preciso compito di deduzione e di
allegazione”.
Ovviamente, il lavoratore, all’atto della redazione
della domanda giudiziale di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non
potrà che rispettare i principi indicati dall’art. 414
c.p.c., ferma la diversa circostanza che dovranno
gravare interamente sul datore di lavoro resistente
le ragioni circa la concreta sussistenza delle contingenze economiche relative all’attività produttiva,
ove siano impeditive e ostative della riadibizione
del lavoratore licenziato in altre mansioni, sia pure
sempre compatibili con la qualifica rivestita.
Orbene, una tale allegazione, nella fase di redazione del ricorso, non comporta affatto l’inversione
dell’onere della prova, ma solo una coerente e opportuna formalizzazione dell’atto introduttivo del
giudizio che, per l’appunto, deve essere rispettoso
dei termini indicati dalla norma sulla forma della
domanda. D’altro canto, vi è da dire pure che anche la precedente giurisprudenza aveva affermato (9) come l’onere della prova non può e non deve essere posto direttamente o indirettamente a carico del lavoratore, “neppure al solo fine dell’indicazione dei posti di lavoro a lui assegnabili”, con
un’evidente apertura riguardo il più recente orientamento qui in esame.
La verità è che la decisione qui in commento si
ispira ad una lettura assolutamente pacifica della
portata dell’art. 5 della L. n. 604/1966 che sul punto impone direttamente a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza della
giustificatezza del motivo di licenziamento.
Dunque, sullo specifico argomento è apprezzabile il
netto distinguo tra coerenza della domanda del lavoratore nel rispetto dei principi indicati dall’art.
414,nn. 3 e 4,c.p.c., nel segno di un petitum volto
all’impugnazione del licenziamento per palese illegittimità, nonché, sempre nel segno di una causa
petendi di inesistenza del giustificato motivo, ma
totale incombente probatorio a carico del datore
che dovrà, nel segno negativo, dimostrare la mate-
riale impossibilità del repechage. In tale prospettazione l’intero onere della prova è, quindi, posto a
carico del datore, senza che il lavoratore abbia alcun onere integrativo, sostitutivo o di fattiva collaborazione con quest’ultimo per la ricerca della verità. D’altro canto, sarebbe veramente illogico pensare che possa trovare concreto riscontro un meccanismo di collaborazione tra le parti del processo,
quando queste risultano, per citare una metafora,
“l’un contro l’altra armate”. Si tratterebbe, infatti,
di una prospettiva davvero singolare e al di fuori di
ogni principio di effettività.
Si conferma, pertanto, che la sentenza in commento suggerisce di prendere le distanze da una divaricazione dell’onere probatorio bifasico. Esso dovrà,
invece, essere, nel caso qui in discussione, interamente posto a carico del datore e ciò nel segno di
una lettura plausibile della norma dell’art. 2697
c.c., secondo la quale ciascuna delle parti deve provare i fatti a fondamento delle proprie domande,
ovviamente rivisitata dalla lex specialis ex art. 5 sui
licenziamenti individuali. Nello specifico, poi, la
sentenza richiama, in generale, in riferimento all’argomento dell’allegazione e prova della titolarità
della posizione giuridica vantata in giudizio, una
recente sentenza delle Sezioni Unite (10) che non
riguarda, però, lo specifico del processo del lavoro.
È, tuttavia, anche vero che un onere della prova
additivo a carico del lavoratore, in via teorica, potrebbe egualmente configurarsi. Potrebbe essere nel
caso in cui egli voglia ottenere un ulteriore ristoro
rispetto ai criteri ripristinatori e risarcitori stabiliti
dalla legge. In altri termini, è onere del lavoratore
provare l’ulteriore danno nascente dal licenziamento, al di là dei canoni di cui alla L. n. 604/1966 e
dall’art. 18 dello Stat. lav.
Diversamente, nel caso che qui ci occupa, la prova
della legittimità del recesso grava esclusivamente
sul datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare
la veridicità (e fondatezza) del fatto estintivo e
cioè la solidità del provvedimento di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, ovviamente nella
ricorrenza di tutti i suoi presupposti e tra essi l’impossibilità di repechage.
(9) Cfr. Cass. 5 marzo 2015, n. 4460, in Argomenti, 2015, 3,
649 con nota di Marranca che ha così stabilito. “Nel giudizio
di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni
inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica
rivestita grava sul datore di lavoro. L’indicazione da parte del
lavoratore, che può farsi parte diligente, di un posto di lavoro
alternativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze ido-
nee a comprovare l’insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, non comporta l’inversione dell’onere della prova”.
(10) Cass., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951, in Pluris data
2016 che così ha statuito in generale. “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la
negazione, da parte del convenuto”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
801
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Controversie del lavoro
Conclusioni
Volendo trarre adesso talune considerazioni conclusive è il caso di ribadire che la soluzione prospettata dalla sentenza in commento suggerisce
una via decisamente agevole, proprio in ragione
della semplificazione dell’incombente probatorio,
non più ripartito, ma interamente posto a carico
della parte che deduce la legittimità del licenziamento: il datore di lavoro è tenuto a provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse compatibili.
Ma, vi è di più: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da esigenze
aziendali per la soppressione del posto di lavoro cui
era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare, “non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento
di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione
del principio di correttezza e buona fede, di aver
prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni
inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale” (11).
La soluzione, in verità, semplifica le regole del gioco e rende più giusta la ripartizione dei criteri relativi all’incombente probatorio, atteso che v’è indubbiamente una maggiore vicinanza alla sfera del
datore di lavoro della prova, in quanto il lavoratore licenziato non può certo disporre della comple-
tezza di informazioni di cui gode il primo, soprattutto, afferma la sentenza in commento, “in una
condizione di crisi in cui mutano continuamente
la misura della sua evoluzione e gli interventi imprenditoriali per rimediarvi o comunque indirizzarne gli sbocchi”.
In tale direzione la sentenza finisce per dare una
decisiva spallata alla tralatizia affermazione “di una
sorta di cooperazione processuale” tra le parti, nel
senso della già denunciata manifesta illogicità di
una via siffatta, non certo percorribile date le contrapposte esigenze e gli interessi del tutto inconciliabili.
A mio giudizio non è seriamente praticabile un
principio di cooperazione processuale tra datore di
lavoro e lavoratore, atteso che solo nella fase dello
svolgimento del rapporto e in conformità ai principi civilistici di correttezza e buona fede (cfr. artt.
1175, 1375, 2104 e 2105 c.c.), possono trovare accesso soluzioni volte alla collaborazione tra creditore e debitore.
Diversamente, sul piano processuale (rectius: conflittuale) non è preconizzabile una soluzione protesa ad uno scambio di informazioni tendente alla ricerca della verità, considerato che il rapporto sostanziale, non solo è cessato con il licenziamento,
ma si è instaurato un contenzioso che vede le due
parti in causa in posizioni diametralmente opposte,
incompatibili con qualsiasi forma di unanime cooperazione processuale.
(11) Cfr. testualmente Cass. 8 marzo 2016, n.4509, già citata in precedenza.
802
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
Tutela delle condizioni di lavoro
Il mobbing attenuato: lo straining
Cassazione Civile, Sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291 - Pres. Stile - Est. Tria - P.M. Sanlorenzo
- M.F. c. Azienda Ospedaliera Spedali civili di (omissis)
Lavoro subordinato (rapporto di) - Tutela delle condizioni di lavoro - Art. 2087 c.c. - Norma di chiusura del sistema a tutela dei diritti fondamentali del lavoratore - Violazione - Conseguenze - Obblighi di astensione del datore di lavoro Straining - Prova presuntiva del danno da “straining”
(Cod. civ. artt. 1175, 1375, 2059, 2087; Cost. artt. 2 e 32)
L’art. 2087 c.c., è norma di chiusura del sistema prevenzionale ed è suscettibile di interpretazione estensiva in
ragione del rilievo costituzionale del diritto alla salute nonché dei principi di correttezza e buona fede cui deve
ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi di tale norma il datore è tenuto ad astenersi dall’imporre al lavoratore condizioni lavorative “stressogene” (c.d. “straining”) che possono ledere i suoi diritti fondamentali. A tal fine il giudice del merito, pur se accerti l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad
unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se alcuni
dei comportamenti denunciati, esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale, possano essere
considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di
lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass., Sez. lav., n. 18927/2015.
Difforme
Non sono stati rinvenuti precedenti difformi.
La Corte (omissis).
Motivi della decisione
(Omissis)
8.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Si contesta la statuizione con la quale la Corte d’appello
ha escluso la configurabilità di un caso di mobbing ed ha,
invece, qualificato la vicenda come straining. Si sottolinea che l’erroneità di tale assunto emerge, ictu oculi.
dal fatto che la Corte bresciana ha riconosciuto la sussistenza di un complesso di condotte illecite tenute sia
dal primario prof. P. (che ha anche subito una condanna per il reato di ingiuria al riguardo) sia dall’Amministrazione ospedaliera reiterate nel tempo e ciononostante ha qualificato la fattispecie come straining quando
questo fenomeno, diversamente dal mobbing, si riscontra
nelle ipotesi in cui l’atto lesivo è unico.
8.1.- Il motivo, come si è detto, è integralmente inammissibile, per impropria applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
A ciò può aggiungersi che - come esattamente afferma
la Corte territoriale - le nozioni di mobbing e straining
sono nozioni di tipo medico-legale, che non hanno
autonoma rilevanza ai fini giuridici e servono soltanto
per identificare comportamenti che si pongono in con-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
trasto con l’art. 2087 cod. civ. e con la normativa in
materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.
9.- Con il quinto motivo si denunciano: a) in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione
degli artt. 1223, 2043, 2087 e 2059 cod. civ.; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”; e) violazione degli artt. 2, 3, 32, 35 e 41
Cost.
Si contesta la parte della sentenza impugnata in cui è
stata negata la sussistenza di un danno da perdita di
chance (per mancanza di specifica allegazione in ordine
a possibili progressi lavorativi o mutamenti professionali
osteggiati dalla condotta datoriale) nonché di un danno
patrimoniale e non patrimoniale ulteriore rispetto al riconosciuto danno biologico.
Si sottolinea che ai fini del danno per la lesione dell’immagine e della professionalità nonché da perdita di
chance avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati
i seguenti elementi: la subita privazione degli incarichi
professionali, la riduzione ad un solo giorno alla settimana dell’attività nel Laboratorio di Neuropsicologia
(di cui prima era responsabile), la sottrazione della responsabilità dei letti di degenza nella Clinica di Neurologia e delle consulenze rimaste a carico esclusivo del
Prof. P. e della sua equipe nonché la contemporanea assegnazione a turni di Pronto soccorso di sei ore.
803
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
Inoltre, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare anche un autonomo danno morale ed esistenziale, derivante dall’emarginazione e dallo stravolgimento del tenore di vita subiti dalla M. in un lungo periodo di tempo.
9.1.- Il motivo è inammissibile sia per la parte di denuncia del vizio di motivazione sia per la parte in cui,
senza specifiche argomentazioni, si prospetta la violazione delle norme costituzionali suindicate. È, invece, infondato per la parte in cui si denuncia la violazione delle norme codicistiche richiamate.
9.2.- Infatti, com’è noto, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, specialmente a partire da
Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972, ha affermato
che: “La liquidazione del danno non patrimoniale deve
essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente
per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia,
sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno
biologico e del danno morale continuano a svolgere
una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto
pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” (Cass.
15 gennaio 2014, n. 687).
Ebbene, la Corte territoriale si è attenuta a tale orientamento in quanto ha affermato che, ancorché il danno
conseguente allo straining in linea teorica avrebbe potuto essere aggiunto al danno biologico, tuttavia la liquidazione di tale ultimo danno come effettuata dal giudice di primo grado era da considerare tale da comprendere esattamente sia la misura della sofferenza patita
dalla M. sia il danno psichico permanente subito.
Nella stessa ottica la Corte bresciana ha poi escluso un
autonomo danno morale ed esistenziale, perché già
compreso nella sovrabbondante liquidazione del danno
biologico ed ha anche escluso la risarcibilità di un danno da perdita di chance, per mancanza di specifica allegazione in ordine a possibili progressi lavorativi o mutamenti professionali osteggiati dalla condotta datoriale,
aggiungendo altresì che un simile danno non è neppure
configurabile, nella specie, in quanto alla perdita parziale (meramente diagnostica) di professionalità si è accompagnato l’acquisito della professionalità inerente le
scelte riabilitative da ritenere ugualmente importante e
professionalmente qualificante.
La ricorrente contesta solo la prima statuizione - peraltro senza il dovuto rispetto del principio di specificità
dei motivi del ricorso per cassazione - ma nulla dice in
merito alla seconda, che comunque rappresenta una ratio decidendi autonoma idonea da sola a sostenere il rigetto della liquidazione del danno da perdita di chance.
(Omissis)
11.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione
all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 e 113
cod. proc. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4,
error in procedendo, nullità della sentenza.
Si sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione laddove, dopo l’esclusione della ricorrenza
804
del mobbing, la Corte ha riqualificato la fattispecie come
straining, essendo soltanto due i “fatti eclatanti” posti in
essere dal Prof. P., che però avrebbero innescato una
reazione che si è cronicizzata a causa della situazione lavorativa disagevole in cui operava la M.
11.1.- Il motivo - inammissibile per la denuncia di nullità della sentenza, come si è detto - è infondato per la
censura di ultrapetizione.
AI riguardo va ricordato, in linea preliminare, che è ius
receptum che il vizio di “ultra” ed “extra” petizione - derivante dalla violazione del principio di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) ricorre soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti,
ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e
non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita
non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al
di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendo resta libero non solo
d’individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base
della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma di rilevare, altresì,
indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la
mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia
costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte,
in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (vedi, per tutte: Cass. 1 ottobre
1994, n. 7977; Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940; Cass.
16 maggio 1998, n. 4923; Cass. 5 ottobre 1998, n.
9887; Cass. 28 agosto 2003, n. 12265; Cass. 31 gennaio
2006, n. 2146; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. 26
ottobre 2009, n. 22595).
Inoltre, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua
cognizione, il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali
la stessa sia contenuta, in quanto deve anzi avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere,
quale desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante, senza limitare la sua
pronuncia in relazione alla prospettazione letterale della
pretesa, occorrendo accertare il suo effettivo contenuto
sostanziale, tenendo conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l’ampiezza della pretesa medesima secondo criteri logici che permettano di rilevare l’effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (Cass. n. 830 del 2006; 2 dicembre 2004, n. 22665;
Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 26 settembre
2011, n. 19630).
Incorre, infatti, nel vizio di omesso esame il giudice che
limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale
della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo contenuto sostanziale della stessa (Cass. 14 novembre 2011,
n. 23794).
Ciò ancor di più nel rito del lavoro nel quale la necessità di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di
cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi
del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
in coerenza con l’art. 6 CEDU, comporta l’attribuzione
di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di
merito - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che,
comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto
scopo (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410).
11.2.- Comunque, non sussiste violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il
giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa
posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a
quello richiesto (Cass. 30 settembre 2015, n. 19502;
Cass. 5 novembre 2009, n. 23490; Cass. 26 aprile 1971,
n. 1232).
11.3.- Nella specie i fatti storici presi in considerazione
dalla Corte territoriale sono i medesimi sui quali si è
pronunciato il Tribunale e sui quali quindi si è svolto il
contraddittorio delle parti, solo che la Corte d’appello
ha ritenuto di qualificarli applicando la nozione di tipo
medicolegale dello straining anziché quella del mobbing.
Peraltro, è pacifico che lo straining consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il
carattere della continuità delle azioni vessatorie, come
può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento,
dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro. In tutte le suddette ipotesi: se la condotta
nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma prive di continuità si è in presenza dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a
sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o pscichici. Pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile sempre
in applicazione dell’art. 2087 cod. civ. ma può anche
dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti (vedi, per tutte: Cass., 6 Sezione penale, 28
marzo - 3 luglio 2013, n. 28603).
11.4.- Detto questo, come già si è rilevato, ai fini giuridici ciò che conta è che, nella specie, sia stata accertato
il compimento di una condotta contraria all’art. 2087
cod. civ. e alla successiva normativa in materia, di importazione comunitaria, senza che abbia rilievo - sotto
il profilo di una eventuale ultrapetizione - la originaria
prospettazione della domanda giudiziale in termini di
danno da mobbing e non da straining, in tale diversa qualificazione (mutuata dalla scienza medica) è stata effettuata dalla Corte bresciana lasciando inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuendo un bene
diverso da quello domandato o introducendo nel tema
controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 23 marzo
2005, n. 6326; Cass. 1 settembre 2004, n. 17610; Cass.
12 aprile 2006, n. 8519).
12. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione
degli artt. 1173, 2087, 1225, 2043, 2055, 2056, 2059
cod. civ.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, er-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
ronea, illogica e/o contraddittoria motivazione nel punto in cui, nonostante l’esclusione del mobbing e del demansionamento, si è affermata la responsabilità anche
dell’Azienda per il riconosciuto danno biologico, per la
situazione lavorativa disagevole in cui la M. è stata
mandata a lavorare.
Si sottolinea che i due fatti sicuramente offensivi dai
quali la Corte d’appello ha desunto la sussistenza del
danno da straining - il referto stracciato in presenza di
un paziente e la scheda di valutazione negata, rispettivamente posti in essere il (omissis) - sono da ascrivere a
due condotte di impeto del P., non riferibili in alcun
modo all’Azienda, neppure in termini di prevedibilità
dell’evento.
D’altra parte, tali due episodi sono antecedenti al trasferimento della attuale ricorrente alla Riabilitazione Funzionale (che, peraltro, come la stessa Azienda precisa, è
avvenuto nell’(omissis) n.d.r. v. p. 57 del controricorso),
legittimamente disposto nell’esercizio dello ius variandi che compete al datore di lavoro.
Di qui la contraddittorietà, illogicità e comunque insufficienza della motivazione, non avendo la Corte bresciana chiarito le ragioni della contestata decisione.
12.1.- Il motivo è inammissibile in quanto, a parte l’invocazione impropria dell’art. 360 c.p.c., n. 5, tutte le
censure si risolvono in una inammissibile critica della
valutazione delle risultanze probatorie operata dalla
Corte bresciana.
Né va omesso di rilevare che l’Azienda Ospedaliere, dopo il primo episodio ingiurioso, anziché restare sostanzialmente inerte avrebbe dovuto adottare concrete misure e una adeguata vigilanza, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 dal D.Lgs. n. 81 del
2008, art. 28 e dalle norme contrattuali conseguenti
(vedi: Cass. 11 settembre 2008, n. 22858; Cass. 20 luglio 2013, n. 18093).
Peraltro, la Corte d’appello fa esplicito riferimento allo
svolgimento della prestazione professionale in un “ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse
nei confronti del benessere lavorativo” e queste affermazioni non sono utilmente prese in considerazione negli atti difensivi del presente giudizio di cassazione della
Azienda Ospedaliera.
(Omissis)
18.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2087 e 2697
cod. civ., per avere la Corte bresciana affermato la ricorrenza dello straining, pur non sussistendone i presupposti - come delineati dalla scienza medica - peraltro
neppure dedotti e tanto meno provati.
18.1.- Anche questo motivo non è da accogliere.
È pacifico che i fatti sui quali si è pronunciata la Corte
d’appello sono sempre i medesimi discussi e provati in
giudizio e sui quali vi è stato un ampio contraddittorio
fra le parti. È anche noto che lo straining è una forma
attenuata di mobbing e che, in ogni caso, entrambe tali
nozioni sono proprie della scienza medica, mentre, ai fini giuridici, ciò che conta è l’accertata esistenza di una
condotta intenzionale ingiuriosa - e penalmente sanzionata a tale titolo - mossa da motivazione discriminante,
805
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
da cui è nata una situazione di stress lavoro-correlata.
Tanto basta per la affermazione della responsabilità dell’attuale ricorrente incidentale ex art. 2087 cod. civ. e
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28.
19.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art.
360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, essendovi nella sentenza “un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, laddove
la Corte d’appello dopo aver affermato che per la sussistenza dello straining sono stati fissati sette parametri
tassativi e necessari, aggiunge che nella specie tali parametri sono stati riscontrati, ma poi argomenta tale riscontro solo con riguardo a cinque di tali parametri, peraltro in modo insufficiente.
Peraltro, di tali parametri ne sussisterebbe solo uno cioè
l’ambiente lavorativo, quindi non essendo configurabile
lo straining, la Corte bresciana avrebbe affermato la sussistenza di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in
assenza dei necessari presupposti.
19.1.- Il motivo, come si è detto, è, in linea generale,
inammissibile in quanto benché nella relativa rubrica si
faccia riferimento ad un “omesso esame” di un “fatto
decisivo e discusso tra le parti”, nelle relative argomentazioni non si fa altro che riferirsi sostanzialmente al testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per il profilo della motivazione contraddittoria.
Inoltre, essendo la nozione dello straining una nozione
appartenente alla scienza medica - come anche nella
sentenza impugnata viene sottolineato - i “fatti” che, ad
avviso del ricorrente incidentale, sono stati omessi non
sono fatti giuridici e, come tali, non hanno rilevanza
decisiva. A ciò va aggiunto, per precisione, che la Corte
d’appello ha espressamente ritenuto presenti i primi
cinque parametri che caratterizzano lo straining per la
scienza medica, mentre non ha espressamente fatto riferimento agli altri due parametri, rappresentati dall’andamento secondo fasi successive e dell’intento persecutorio. Tuttavia, il fatto stesso che siano stati accertati due
comportamenti posti in essere dal P. forieri di danno e
che sia stato affermato il carattere intenzionale e discriminatorio - affermazione, quest’ultima, che, nel presente ricorso incidentale, non viene efficacemente contestata - della condotta di P. ben possono indurre a considerare implicitamente sussistenti anche i due parametri
non espressamente elencati e, quindi, ad escludere che anche solo dal punto di vista logico, visto che, dal punto di vista giuridico, ciò non rileva - non vi sia alcuna
contraddizione nella specificazione operata dalla Corte
bresciana in merito alla rinvenuta sussistenza, nella specie, di tutti e sette i parametri dello straining in oggetto.
In ogni caso, a prescindere dalle definizioni e dalle classificazioni di tipo medico, ciò che conta, in questa sede,
è che il CTU ha accertato che il comportamento illecito in argomento come ricostruito senza contestazioni,
ha determinato una lesione di carattere permanente sull’integrità psico-fisica della lavoratrice, la quale risulta
aver riportato un danno biologico permanente quantificato nella misura del 10%.
20.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 2087 e 2697
806
cod. civ., per avere la Corte territoriale condannato il
P. al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma di
denaro “esorbitante” (specialmente in considerazione
della operata riqualificazione della fattispecie), sull’erroneo presupposto che fossero stati provati i relativi danni.
Infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di
lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di
cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione
del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa
in base alla qualifica professionale rivestita - lesione
che, per l’appunto, si profila idonea a determinare una
dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume
di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale
tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa (vedi, per tutte:
Cass. SU 24 marzo 2006, n. 6572).
20.1.- Il motivo è infondato.
In merito alla quantificazione del danno subito dalla M.
la Corte d’appello ha affermato che la liquidazione di
tale danno come effettuata dal giudice di primo grado
rispecchiava esattamente la misura della sofferenza patita e il danno psichico permanente subito dalla dottoressa senza che questo comporti alcuna duplicazione di voci di danno (come invece ritenuto dall’Azienda e dal
P.) ed ha aggiunto che, d’altra parte, diversamente da
quanto richiesto dalla M., non residuava alcuna altra
voce di danno risarcibile né a titolo di perdita di chance (privo di allegazioni) né per un autonomo danno
morale ed esistenziale (già compreso nella sovrabbondante liquidazione del danno biologico).
Da ciò si desume che il danno è stato - discrezionalmente, ma motivatamente - così liquidato in quanto
comprensivo di tutte le voci (esistenziale, biologico,
morale) di danno alla persona.
20.2.- Il relativo onere probatorio è quello previsto per
la violazione dell’art. 2087 cod. civ. Al riguardo va considerato che, grazie al carattere di “norma di chiusura”
del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta
alla suddetta disposizione codicistica nonché all’ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta
norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali
deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l’obbligo datoriale di “tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”, sancito da questa norma, nel senso di includere anche l’obbligo della adozione di ogni misura “atipica” diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure
di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione
tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire
ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggres-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
sioni conseguenti all’attività criminosa di terzi (Cass. 22
marzo 2002, n. 4129).
Questo implica, reciprocamente, l’obbligo del datore di
lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti
che possano ledere, già di per sé, la personalità morale
del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro
stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, bum out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di
quanto affermato anche dalla Corte costituzionale; vedi
per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5
novembre 2012, n. 18927).
A ciò è da aggiungere che - poiché, in base al “diritto
vivente”, nell’interpretazione delle norme il canone
preferenziale dell’interpretazione conforme a Costituzione è rinforzato dal concorrente canone dell’interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria e
con la CEDU - al fine della corretta individuazione della potenzialità lesiva (nei detti termini) delle indicate
condotte, si deve tenere conto anche degli esiti del lungo processo evolutivo che si è avuto in ambito comunitario, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
giustizia, in materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in genere e in particolare nei rapporti di lavoro, che ha portato - a partire dalla introduzione dell’art. 13 nel Trattato CE (Trattato di Amsterdam del
1997) divenuto poi art. 19 TFUE in materia di azioni
positive e art. 141 TCE, ora art. 157 TFUE in materia
di non discriminazione, che si limitavano a prevedere
dei divieti strettamente funzionali ai differenti settori di
competenza e di intervento dell’originaria CE - all’affermazione di un generale principio di uguaglianza analogo
a quello previsto da molte delle Costituzioni degli Stati
membri, declinato nei due diversi aspetti dell’uguaglianza e della non discriminazione, con un ulteriore rafforzamento, al livello di normativa primaria, per effetto dell’adozione della Carta di Nizza, ora Carta dei diritti fondamentali della UE, i cui artt. 20, 21 e 23 riconoscono
rispettivamente in linea generale l’uguaglianza davanti
alla legge, il principio non discriminazione e il principio
di parità tra uomini e donne e la necessità di adottare
azioni positive.
Tale processo, poi proseguito in sede comunitaria e nazionale, ha portato, nel corso del tempo e principalmente per effetto del recepimento di direttive comunitarie,
alla conseguenza che anche nel nostro ordinamento
condotte potenzialmente lesive dei diritti fondamentali
di cui si tratta abbiano ricevuto una specifica tipizzazione, come discriminatorie (in modo diretto o indiretto).
Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) - che esige che
il Giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel
corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni
per mezzo degli altri e quindi esclude che il Giudice,
avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda
in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla
conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. 9 marzo 2012, n. 3703) - consente attraverso
la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti
(caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o pro-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
fessionale, altre circostanze del caso concreto) di poter
risalire coerentemente, con un prudente apprezzamento,
al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si
serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione
delle prove (vedi per tutte: Cass. 5 novembre 2012, n.
18927 cit.).
Ciò, del resto, è conforme al consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità in materia di prova
del danno da demansionamento (Cass. SU 22 febbraio
2010, n, 4063; Cass. SU 24 marzo 2006, n. 6572 del
2006; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 26 novembre 2008, n. 28274), oltre che trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa in materia di mobbing
(Cons. Stato 21 aprile 2010, n. 2272).
Tali principi sono applicabili anche nell’ipotesi dello
straining individuata dalla scienza medica come forma
attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, le quali,
ancorché finalisticamente non accumunate, possono risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati, di cui si è detto (arg. ex Cass. sez. 6
pen. 8 marzo 2006 n. 31413).
20.3.- La Corte bresciana, nella determinazione dei
danni in argomento si è attenuta, con congrua e logica
motivazione, a tutti i suindicati principi, sicché anche
da questo punto di vista, la sentenza impugnata non
merita alcuna censura.
5 - Conclusioni.
21.- In sintesi, tutti i ricorsi devono essere respinti. In
considerazione della reciproca soccombenza le spese del
presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le
parti, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
(omissis).
807
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
IL COMMENTO
di Carmela Garofalo (*)
Il contributo trae spunto dalla sentenza Cass. n. 3291/2016 che ha riconosciuto ad una lavoratrice il risarcimento del danno da straining. La decisione in commento offre lo spunto per definire i
contorni di questa fattispecie, mutuata dalla scienza medica, ma posta in una posizione di secondo piano rispetto al mobbing, e mostra il favor della giurisprudenza verso un ampliamento
della tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro di fronte ai comportamenti datoriali che in violazione dell’art. 2087 c.c. possono cagionare un danno alla loro salute psico-fisica.
La sentenza in commento offre un interessante spunto di riflessione sul fenomeno dello “straining”, fino
ad oggi, relegato ai confini più della scienza medica
che giuridica, e ombreggiato dal fenomeno del mobbing largamente più diffuso da circa un ventennio
nei dibattiti dottrinali e nelle aule di giustizia.
Benché spesso venga utilizzato il concetto di mobbing per definire ogni situazione di malessere e disagio sul luogo di lavoro, nell’ambito nel panorama
giurisprudenziale si vanno sempre con maggiore
precisione delineando alternative per descrivere
varie situazioni di conflittualità lavorativa che meritano ugualmente di essere tutelate.
Di contro si deve prendere atto della scelta del legislatore di abdicare al proprio ruolo regolativo su
questo tema e di demandare alla magistratura il
compito di stabilire e definire le tutele dei lavoratori che subiscono pregiudizi alla propria salute psico-fisica a seguito di azioni ostili e persecutorie
compiute a loro danno nel luogo di lavoro.
Si comprende perciò l’atteggiamento cauto sino ad
ora mostrato dai giudici che, in tema di mobbing,
hanno circoscritto il più possibile i confini del fenomeno onde prevenire azioni pretestuose, se non
temerarie, ed evitare lo svuotamento del potere direttivo di cui il datore di lavoro è titolare per controllare al meglio la propria attività (1).
Ciò significa che non si può classificare come mobbing qualsiasi forma di conflitto nel posto di lavoro,
in quanto il mobbing ha radici più profonde ed è caratterizzato da un’azione sistematica, premeditata
consciamente o inconsciamente ai danni della vittima, con l’intento di danneggiarla o espellerla.
Quindi la prima condizione per parlare di mobbing è
il requisito temporale: le violenze psicologiche devono essere regolari, sistematiche, frequenti e durare
nel tempo (almeno sei mesi secondo una certa giurisprudenza) (2); a ciò si aggiunge la necessità di dimostrare l’intento persecutorio del mobber, cioè la
finalità illecita di discriminare, emarginare o recare
altrimenti pregiudizio alla vittima, ritenuto addirittura un elemento costitutivo della fattispecie (3).
Pur tuttavia, non si può tacere che esistono situazioni lavorative in cui i lavoratori maturano un
senso di disagio che si ripercuote sulla propria salute psico-fisica e che seppur non riconducibili al
mobbing non possono rimanere impunite ove si accerti che siano state deliberatamente provocate ai
danni di un determinato lavoratore. Anche siffatti
comportamenti illeciti posti in essere dal datore di
lavoro con particolare ostilità ed avversione verso
il proprio dipendente, infatti, possono integrare
una violazione dell’art. 2087 c.c. e necessitare di
un’adeguata e congrua sanzione sul presupposto
che il lavoro, come più volte affermato dalla giurisprudenza, non rappresenta solo un mezzo di guadagno, ma anche una forma di importante estrinsecazione della personalità dell’individuo sul luogo di
lavoro, tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost. (4).
Lo straining nasce infatti proprio dall’esigenza di
voler dare una tutela (anche risarcitoria) a coloro
che, pur subendo vessazioni, determinanti danni fisici rilevanti, non possono godere di alcuna tutela
poiché i maltrattamenti subiti sono privi della fre-
(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
(1) Cfr. T.A.R. Campania, n. 599/2013 in cui si ribadisce la
necessità di tracciare un linea di demarcazione tra “l’esigenza
di tutelare i lavoratori che rimangano vittime di iniziative persecutorie e la necessità di evitare l’eccessiva e patologica valutazione di ogni screzio in ambito lavorativo, che non deve comportare alcuna sanzione giuridica per qualsivoglia scorrettezza
o per qualunque evento negativo occorso nel luogo di lavoro”.
(2) V. ex plurimis Cass. n. 17698/2014; Cass. n.
12725/2013; Cass. n. 12048/2011; Cass. n. 7382/2010; Cass.,
n. 3785/2009.
(3) V. A. Pizzoferrato, Mobbing e danno esistenziale: verso
una revisione della struttura dell’illecito civile, in Contr. e impr., I,
2002, 307, che parla proprio di necessità dell’intenzione molesta, e quindi del dolo o della colpa dell’agente; E. Gragnoli,
Mobbing, in DRI, 2003, 1051; T. Greco, Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro, Milano, 2009; G. Loy, Il “mobbing”:
profili giuslavoristici, in Dir. lav., 2005, I, 267.
(4) Cfr. Cass. n. 12553/2003, n. 15686/2002 e n. 8835/1991.
Premessa
808
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
quenza prevista ovvero più genericamente non possono farsi rientrare nell’accezione di mobbing elaborata dalla dottrina e successivamente recepita dalla
giurisprudenza.
Il fenomeno dello straining, come quello del mobbing, viene mutuato dalla scienza medica, a dimostrazione che le vicende turbative della serenità
del prestatore di lavoro all’interno dei luoghi in
cui egli è chiamato a svolgere la propria opera professionale, integrano una di quelle fattispecie in
cui il diritto e la psicologia si incontrano, in un
ambito nel quale una scienza si trova a non poter
fare a meno dell’altra.
Ed è sempre lo psicologo Harald Ege che dà una
definizione di straining come “una situazione di
stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima
subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è
rispetto alla persona che attua lo straining, in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in
maniera discriminante” (5).
Ege, durante i colloqui con le vittime di soprusi e
violenze psicologiche sul posto di lavoro, si è reso
conto che, gran parte di queste persone, pur essendo convinte di essere state mobbizzate, in realtà
avevano subito una forma di vessazione diversa.
Pur non essendo vittime di mobbing, risultavano
comunque, essere state sottoposte a trattamenti ingiusti e discriminanti sul posto di lavoro. Dopo varie riflessioni, l’Autore identificò dal punto di vista
della psicologia del lavoro quei conflitti organizzativi non rientranti nel mobbing, ma comunque
comprendenti situazioni lavorative stressanti, ingiuste e lesive, quali per esempio la dequalificazione o l’isolamento professionale, con il termine originale ed esclusivo di straining.
Il termine straining deriva dall’inglese “to strain”, e
letteralmente può essere tradotto come “tendere”,
“mettere sotto pressione”, “stringere”. Il significato
del verbo inglese “to strain”, inoltre, è molto vicino a
quello di un altro verbo inglese, “to stress”, ed infatti,
il legame tra straining e stress occupazionale è evidente, poiché in una situazione di straining, l’aggressore o strainer, tenderà, sempre, a far cadere la propria vittima in una condizione particolare di stress.
Si tratta, in questo caso, di un tipo di stress, che
potremmo definire superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali
(5) H. Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme
di conflittualità sul posto di lavoro, Milano, 2005, 70.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
interazioni organizzative. Esso, infatti, è diretto nei
confronti di una vittima o di un gruppo di vittime
in maniera intenzionale, e con lo scopo preciso di
provocare un peggioramento permanente della
condizione lavorativa delle persone coinvolte.
Ecco dunque che lo straining rappresenta una condizione psicologica posta a metà strada tra il mobbing e il semplice stress occupazionale, tant’è che
lo straining può anche essere considerato quale naturale anticamera del mobbing. Il datore di lavoro
potrebbe cominciare a vessare il proprio dipendente con comportamenti integranti lo straining per
poi decidere di intensificare la forza lesiva e la frequenza dei propri atti discriminatori fino ad arrivare a porre in essere un vero e proprio mobbing attraverso la persecuzione psicologica, la violenza morale e l’emarginazione.
Di contro lo straining potrebbe essere facilmente
scambiato per un semplice caso di stress occupazionale, se non fosse per il fatto che la vittima di solito lo percepisce come mobbing, data l’alta componente di intenzionalità e di discriminazione.
Lo straining nella giurisprudenza
La definizione di straining elaborata in campo medico è stata recepita dalla giurisprudenza italiana
attraverso l’ormai famosa sentenza 21 aprile 2005
n. 286 del Tribunale del Lavoro di Bergamo (6),
che è stata la prima sentenza in tema di straining.
In quella occasione il Giudice del Lavoro fu chiamato a pronunciarsi sul caso di una lavoratrice posta in condizione di totale e forzata inattività per
più di due anni e per corroborare il proprio convincimento si avvalse della consulenza tecnica di ufficio proprio dello psicologo Harald Ege. Quest’ultimo, nell’analizzare la vicenda, sebbene ritenne sussistenti alcuni elementi costitutivi del mobbing quali l’ambiente lavorativo, in cui si svolsero i fatti, la
durata della conflittualità, superiore ai sei mesi
(tempo ritenuto necessario per configurare un caso
di mobbing), la tipologia delle azioni ostili, alcune
delle quali tipiche del mobbing, come ad esempio
l’isolamento ed il cambiamento delle mansioni lavorative, il dislivello tra gli antagonisti, in quanto
la vittima si trovava in posizione di inferiorità rispetto alle decisioni dei superiori, non ravvisò altri
elementi caratterizzanti la fattispecie. Pur nell’assenza di alcuni elementi tipici del mobbing, il CTU
arrivò alla conclusione che il comportamento tenuto nei confronti della ricorrente fosse stato
(6) Cfr. Trib. Bergamo 21 aprile 2005.
809
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
ugualmente fonte di un danno alla salute, riconducibile al diverso fenomeno dello straining.
Pertanto il Giudice del Lavoro di Bergamo, accertò
che il danno subito dalla ricorrente non poteva essere ricondotto al mobbing, ma allo straining, facendo
propria la definizione del fenomeno data dallo stesso
Ege e condannò la società resistente al risarcimento
del danno biologico in quanto, a prescindere dalle
definizioni e dalle classificazioni, il CTU aveva accertato che il comportamento illecito tenuto dal datore di lavoro aveva determinato una lesione all’integrità psicofisica della lavoratrice, la quale risultava
aver riportato un danno biologico permanente sostanziatosi in una patologia diagnosticabile come
“disturbo depressivo-ansioso” (consistente in disturbi alimentari e del sonno, insicurezza, tendenza all’isolamento e alla esclusività degli affetti, agorafobia,
diffidenza generalizzata verso gli estranei).
Successivamente nel 2007 una seconda pronuncia,
emessa dal Tribunale di Sondrio (7), ritornò sull’argomento, affrontando questa volta il caso di un
dipendente soggetto ad alcuni spostamenti di ufficio a breve distanza l’uno dall’altro, privato di collaboratori e di pratiche e sottoposto a pressioni e
bruschi richiami da parte del superiore. Anche in
questo caso, ad avviso del CTU nominato dal Giudice del Lavoro, la strategia negativa attuata dal
datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente, pur non presentando le caratteristiche del
mobbing in quanto mancavano la frequenza e l’adeguatezza delle azioni, si inquadrava tuttavia nel diverso fenomeno dello straining definito come una
situazione lavorativa conflittuale in cui la vittima
subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (e quindi non rientranti nei parametri del mobbing), tuttavia tali da provocare una
modificazione in negativo, costante e permanente,
della sua condizione lavorativa.
Dunque il Giudice del Lavoro concluse dichiarando l’illegittimità del comportamento della società
datrice, in quanto fondato su un motivo discriminatorio e mosso da un intento espulsivo (e quindi
contrario ai principi di correttezza e buona fede)
che aveva determinato nella lavoratrice il danno
risarcibile.
L’ultima e più importante pronuncia in materia di
straining, prima di quella in commento, proviene
proprio dalla VI Sezione Penale della Corte di cas-
sazione (8), che ha accolto il ricorso di un dipendente di banca, vittima di una serie di comportamenti vessatori esplicatisi nei suoi confronti (sottrazione di compiti di alta responsabilità in favore
di un’altra dipendente, aspre ed ingiustificate critiche alla sua professionalità, convocazione di un incontro intersindacale finalizzato a criticare il suo
comportamento proprio nel periodo in cui si era
messo in ferie per riprendersi dalla dure critiche ricevute dai suoi superiori, svolgimenti di mansioni
meramente esecutive e ripetitive con allocazione
in un “vero e proprio sgabuzzino, spoglio e sporco,
con mansioni dequalificanti, meramente esecutive
e ripetitive”). Questa situazione oltre ad integrare
una dequalificazione del lavoratore, gli aveva procurato una grave lesione, e cioè “un’incapacità di
attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un
periodo di tempo superiore a 40 giorni”.
Le pronunce richiamate, consentono sin qui di individuare i tratti caratteristici dello straining. Se,
infatti, i tratti distintivi del mobbing sono la sistematicità, la frequenza e la regolarità delle vessazioni perpetrate ai danni della vittima da un singolo o
da un gruppo di persone, nello straining, viceversa,
i soggetti coinvolti sono destinatari di azioni ostili
sporadiche, ma con effetti simili al mobbing: problemi di autostima e salute, turbative professionali e
di serenità familiare, che si ripercuotono sovente
sulla qualità della vita del soggetto.
Nella pratica, però, il confine tra i due fenomeni
può presentarsi meno definito, come testimoniato
dai casi innanzi esaminati nei quali alla sottrazione
di mansioni si sono sommati ulteriori comportamenti del datore di lavoro aventi contenuto persecutorio; nel complesso, dalle prime sentenze edite
pare che una particolare aggressività nel comportamento del datore di lavoro (manifestata per la repentinità o la natura eclatante o per le circostanze
del demansionamento, ovvero il concomitante verificarsi di altri atti o provvedimenti volti ad isolare anche dal punto di vista umano il lavoratore)
sia considerata dalla giurisprudenza elemento costitutivo dello straining, in quanto rivelatrice del precipuo intento persecutorio ad esso sotteso (9).
Quanto all’intento persecutorio, è sufficiente nello
straining che siano riscontrati uno scopo politico ed
un obiettivo discriminatorio, ovverosia una scelta
consapevole sia della vittima che delle vessazioni
(7) Cfr. Tribunale di Sondrio 7 giugno 2007; sullo straining v.
altresì Trib. Brescia 15 aprile 2011, in DL, 2011, 3, 637 con nota di D. Bonsignorio, Straining e autotutela del lavoratore: qual
è il confine della reazione legittima?; Trib. Massa 11 ottobre
2011.
(8) Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 28603/2013, in ADL, 2014, 1,
182, con nota di S. Di Stasi, Una eccellente sintesi di presente e
futuro: la Suprema Corte riconosce la rilevanza giuridica dello
“Straining”.
(9) Cfr. Bonsignorio, Straining e autotutela: qual è il confine
della reazione legittima?, op. cit., 643.
810
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
da perpetrare, laddove, nel mobbing, il disegno vessatorio realizzato deve racchiudere in sé i caratteri
dello scopo politico e dell’obiettivo conflittuale (10) oltre che presentare una carica emotiva e
soggettiva (11).
Lo straining nella sentenza
Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291
La sentenza in commento si colloca indubbiamente
nella scia tracciata dalle pronunce prima menzionate, ma per analiticità delle argomentazioni sviluppate, costituisce diritto vivente in tema di straining.
Anche in questo caso agiva in giudizio una dipendente di un’Azienda Ospedaliera per vedersi risarcire il danno da demansionamento e da mobbing.
In sede di gravame, era stata respinta la prima domanda e confermato invece il diritto al risarcimento dei danni in relazione ad una situazione di stress
lavorativo subito dalla lavoratrice ricondotta non
al mobbing, ma allo straining, facendo richiamo alla
responsabilità ex art. 2087 c.c. secondo cui “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.
A differenza che nelle pronunce sin qui analizzate,
ove viene sempre riconosciuta l’inerenza del demansionamento ad una strategia di straining, la
Cassazione nella pronuncia in esame conferma la
decisione della Corte di Appello di Brescia di
escludere il danno da dequalificazione in quanto,
pur se nel periodo immediatamente successivo al
trasferimento della lavoratrice, vi fossero state indubbie difficoltà logistiche e organizzative, non era
emerso alcun danno alla professionalità, del resto
difficilmente conciliabile dal punto di vista concettuale con il conferimento di un incarico di direzione di una struttura semplice, da cui anzi era derivato un arricchimento professionale.
Viene escluso altresì il mobbing in quanto gli unici
due episodi provati (consulenza effettuata dalla
dottoressa in reparto senza il consenso del primario
cui quest’ultimo ha reagito con un atteggiamento
(10) V. H. Ege, Mobbing conoscerlo per vincerlo, Milano,
2001, 63 il quale riferisce il termine “scopo politico” alle motivazioni che sono alla base dell’azione del mobber. Tra queste
si può annoverare l’ambizione, l’invidia, la gelosia, l’antipatia,
la diversa convinzione politica e religiosa della vittima, la sua
provenienza, il sesso, il tipo di qualifica e di educazione ricevuta. Se manca lo scopo politico, ossia la motivazione, il conflitto
è destinato a spegnersi nel tempo, poiché la carica emotiva
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
aggressivo culminato con il gesto di stracciare la
relazione di consulenza della lavoratrice e quello
della mancata consegna da parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa)
non avevano dato luogo ad un vero e proprio mobbing, mancando l’elemento della oggettiva frequenza della condotta ostile, al di là della soggettiva
percezione da parte della lavoratrice di una situazione di costante emarginazione.
Ciò, tuttavia, non ha impedito alla lavoratrice di
ottenere il risarcimento da straining.
Infatti i giudici di legittimità hanno ritenuto, che
pur in assenza di demansionamento o di mobbing,
le condotte vessatorie ed ostili perpetrate dal primario nei confronti della dottoressa le avevano
procurato un danno biologico quantificato dal
CTU nella misura del 10%, in ragione di un “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato” e potevano essere ricondotte
allo straining.
Nella sentenza si possono individuare quattro passaggi essenziali che richiedono una specifica e separata trattazione.
La nozione di straining
La Corte di Cassazione fa propria la definizione di
straining ormai consolidata e cioè una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione
degli strumenti di lavoro. In tutte le richiamate
ipotesi se la condotta nociva si realizza con un’azione unica ed isolata o comunque con più azioni, ma
prive di continuità si è in presenza dello straining,
che può produrre una situazione stressante, causativa di gravi disturbi psico-somatici o psico-fisici o
solo psichici. Pertanto, pur mancando il requisito
della continuità nel tempo della condotta, essa può
essere sanzionata, sia in sede civile ex art. 2087 c.c.
sia in quella penale, se ne ricorrono i presupposti.
Dal punto di vista definitorio, i giudici di legittimità nulla aggiungono rispetto a quanto già stabilito
dalla scienza medica e recepito nelle prime sentenze sul tema alle quali viene fatto peraltro esplicito
rinvio per relationem.
può alimentarlo per un breve periodo. Per esserci mobbing invece il conflitto deve perdurare per molto tempo, e questo si
realizza solo se il mobber ha un preciso obiettivo.
(11) V. H. Ege, Mobbing conoscerlo per vincerlo, op. cit., 63
il quale riferisce il termine “carica emotiva” al flusso emozionale che sottostà al conflitto che toglie i freni inibitori e lo porta
sul piano personale e soggettivo fornendo coraggio necessario
per attuare le azioni mobbizzanti.
811
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
Emergono anche in questo caso i tratti caratterizzanti dello straining inteso come una situazione lavorativa conflittuale in cui la vittima ha subito
azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel
tempo (e quindi non rientranti nei parametri del
mobbing), tuttavia tali da provocare una modificazione in negativo costante e permanente della sua
condizione lavorativa e ripercussioni non solo sulla
salute in senso stretto, con sintomi psicosomatici
anche gravi, spesso sconfinanti nella patologia vera
e propria, ma anche a livello di autostima e di qualità della vita in senso lato. In alcuni casi tali effetti sono del tutto paragonabili, se non a volte addirittura più gravi, a quelli derivanti da un’azione
mobbizzante vera e propria.
Per rilevare una situazione di straining deve essere
presente e attestata almeno un’azione ostile, che
abbia una conseguenza duratura e costante a livello
lavorativo e un carattere intenzionale e discriminatorio. La vittima di straining, dunque, deve aver subito almeno una azione negativa che non si è esaurita, ma che continua a produrre i suoi effetti a livello lavorativo a lungo termine ed in modo costante (per esempio un cambio di mansioni e/o di
qualifica, uno spostamento/ trasferimento penalizzante, una perdita di chance, la soppressione di un
bonus, etc).
È evidente dunque la differenza rispetto al mobbing,
per la cui configurabilità sono necessarie più azioni
ostili, che si ripetono con sistematicità e con una
certa frequenza (almeno alcune volte al mese) e
per un certo periodo di tempo (almeno sei mesi).
La vittima dello straining deve poi essere confinata
in una posizione di costante inferiorità rispetto ai
suoi aggressori: essa non ha più le stesse capacità e
possibilità di azione e di gestione del conflitto rispetto a prima e rispetto ai suoi aggressori e quindi
non è più in grado di tutelare i propri diritti (nel
senso del rispetto delle sue mansioni, della sua professionalità, del suo ruolo, delle sue competenze,
etc.).
Infine, per essere inquadrata nello straining l’azione
ostile deve avere carattere intenzionale e/o discriminatorio, ossia deve essere deliberatamente predisposta ai danni di una certa persona o di un certo
gruppo di persone, a cui deve essere riservato un
trattamento diverso, in senso negativo, rispetto agli
altri.
Il potere qualificatorio del giudice
Se sul piano definitorio si può quindi riscontrare
una perfetta coincidenza tra la sentenza in com-
mento e la giurisprudenza precedentemente formatisi sul tema, un aspetto rilevante trattato dai giudici di legittimità è quello del potere qualificatorio
del giudice che pur ove accerti l’insussistenza di un
intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi, in modo da potersi configurare una condotta di
mobbing, è tenuto a valutare se dagli altri elementi
dedotti, per caratteristiche, gravità, frustrazione
personale o professionale, altre circostanze del caso
concreto, possa presuntivamente risalirsi al fatto
ignoto dell’esistenza del più tenue danno da straining.
La Suprema Corte affronta tale profilo in quanto
parte ricorrente contestava la decisione della Corte
territoriale di riqualificare la fattispecie come straining, dopo aver escluso la sussistenza del mobbing,
andando in ultrapetizione.
I giudici di legittimità ricordano che il vizio di ultrapetizione, derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
(art. 112 c.p.c.), ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni
azionate dalla parti, ovvero su questioni estranee
all’oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio,
attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (12); al di fuori di tali
specifiche ipotesi il giudice, nell’esercizio del sua
potestas decidendi, resta invece libero, non solo di
individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a
base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalla parti, ma di rilevare, altresì, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.
Conseguentemente i giudici non sono tenuti ad
uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti
di causa, ma devono avere riguardo al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere, tenendo anche conto delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in
modo da ricostruire l’effettiva volontà della parte
in relazione alle finalità concretamente perseguite.
Alla stregua di tale ragionamento, il vizio di ultrapetizione è escluso allorché il giudice, qualificando
giuridicamente in modo diverso, rispetto alla prospettazione della parte, i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene
della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a
quello richiesto.
(12) Sul punto cfr. Cass. n. 13876/2016.
812
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
Tanto si è verificato nel caso affrontato dalla sentenza in commento, laddove, una volta accertato il
compimento di una condotta contraria all’art.
2087 c.c., senza dare rilievo all’originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing e non da straining, la Corte territoriale era giunta ad una diversa qualificazione senza
mutare il petitum e la causa petendi e senza attribuire alla lavoratrice un bene diverso da quello domandato (13).
Tale conclusione, che si ritiene di condividere,
produce un impatto di notevole importanza ai fini
processuali e sostanziali in quanto consente al lavoratore che sostiene di aver subito un danno da
mobbing, di non vedersi rigettare la domanda qualora non si ravvisino i requisiti costitutivi della fattispecie, ma di ottenere in ogni caso un risarcimento del danno, seppur in forma attenuata. E ciò assume ancora più valore di fronte al difficile e rigoroso onere probatorio che incombe sul lavoratore
nei giudizi di mobbing (14), il cui mancato assolvimento porta, il più delle volte, al rigetto delle pretese risarcitorie.
Indubbiamente in questo modo viene ampliata la
tutela del lavoratore nei casi di condotte vessatorie
ed ostili compiute dal datore di lavoro che, una
volta accertate, garantiscono sempre un risarcimento in favore della vittima per violazione dell’art. 2087 c.c., a prescindere dall’originaria qualificazione della domanda giudiziale.
I sette parametri per la sussistenza dello straining
Interessante è altresì la sentenza quando affronta la
problematica della valutazione da parte dei giudici
dei sette parametri individuati dalla scienza medica
(Metodo H. Ege 2002) per qualificare la condotta
di mobbing (15). Invero tali requisiti valgono anche
per lo straining, sebbene con talune differenze. I
sette requisiti sono i seguenti:
(13) In tal senso v. anche Cass. n. 8519/2006; Cass. n.
6326/2005; Cass. n. 17610/2004.
(14) Sia consentito il rinvio a C. Garofalo, Mobbing e onere
della prova, in Giur. it., 2016, 6, 1428 ss. ed ivi ampi riferimenti
di dottrina e giurisprudenza.
(15) V. H. Ege, La valutazione peritale del Danno da Mobbing, Milano, 2002, 69.
(16) Il test LIPT Ege Professional (versione modificata ed
ampliata del noto Leymann Inventory of Psychological Terrorism) è uno degli strumenti più usati in Europa per la rilevazione del grado di conflittualità nei contesti organizzativi. Tale
questionario contiene una lista di azioni ostili, suddivise in cinque categorie (Attacchi ai contatti umani, Isolamento sistematico, Cambiamenti di mansioni, Attacchi alla reputazione, Violenza e minacce di violenza), che il soggetto deve indicare di
aver subito; vi sono poi domande relative alla frequenza e alla
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
1. Ambiente lavorativo: lo straining, così come il
mobbing, è un fenomeno che si sviluppa e prende
forma nei luoghi di lavoro;
2. Frequenza: a differenza del mobbing, che richiede
comportamenti vessatori che si verificano almeno
1 volta al mese, nel caso dello straining, come già
detto, può essere sufficiente anche una sola azione
lesiva, purché le conseguenze risultino avere una
durata costante;
3. Durata: così come nel mobbing, il conflitto deve
perdurare per almeno 6 mesi;
4. Tipo di azioni: le azioni devono appartenere ad
almeno una delle categorie del LIPT Ege e non ad
almeno due categorie del medesimo test, come richiesto per il mobbing (16);
5. Dislivello tra gli antagonisti: la vittima, così come nel mobbing, deve essere cosciente della sua posizione di inferiorità rispetto al suo carnefice e tale
soggezione può andare oltre quella naturale rinveniente dal rapporto lavoratore/datore;
6. Andamento secondo fasi successive: occorre che
la vessazione abbia raggiunto la seconda fase delle
4 individuate da Ege nel caso di mobbing (17);
7. Intento persecutorio: è necessario che venga riscontrato un intento persecutorio e/o un obiettivo
discriminatorio.
Con riferimento ai richiamati sette parametri, la
Corte di cassazione precisa che essi appartengono,
come la definizione stessa di straining, alla scienza
medica e non hanno una valenza prettamente giuridica. È indubbio che essi possono supportare il
convincimento del giudice circa la sussistenza o
meno della condotta vessatoria, ma non possono
da soli fondare una decisione giudiziale non essendo fatti giuridici di rilevanza decisiva.
Viene così stabilito che, a prescindere dalle definizioni e dalle classificazioni di tipo medico, ciò che
conta ai fini dell’indagine giudiziale, è che il CTU
accerti che il comportamento illecito riconducibile
allo straining abbia determinato una lesione di cadurata del trattamento negativo e alle conseguenze psicofisiche patite. Le segnalazioni vengono poi integrate ed eventualmente corrette e/o ridimensionate da un successivo colloquio
specialistico, nel corso del quale, se necessario, l’esperto procede a valutare anche le attuali condizioni psicofisiche ed “esistenziali” del soggetto.
(17) V. H. Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre
forme di conflittualità sul posto di lavoro, op. cit. Il modello Ege
prevede 4 fasi: la prima fase è quella in cui l’azione ostile viene
posta in essere; la seconda fase è quella nella quale la vittima
prende coscienza delle conseguenze dirette dell’azione discriminatoria, si convince che la conseguenza di quella azione
avrà carattere duraturo; la terza fase è caratterizzata dall’insorgenza dei danni psico-fisici, mentre nella quarta fase la vittima
lascia il suo posto di lavoro.
813
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
rattere permanente dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
Emerge nuovamente il favor lavoratoris mostrato
dai giudici di legittimità laddove, non ritenendo
necessaria o rilevante la compresenza di tutti i sette parametri, agevolano ulteriormente l’onere probatorio incombente sul lavoratore.
La conclusione a cui perviene qui la Suprema Corte sembrerebbe, tuttavia, discostarsi da una recente
pronuncia di legittimità (18) nella quale, invece, il
decisum del giudice recepisce integralmente le risultanze della perizia, allegata agli atti, eseguita da
uno dei massimi esperti di mobbing il quale, esaminata la vicenda lavorativa, aveva riscontrato la
presenza contestuale di tutti i citati sette parametri.
A parere di chi scrive il contrasto tra le due pronunce è solo apparente, potendosi invece riscontrare tra di esse un rapporto di complementarietà
in considerazione del fatto che il giudice di merito,
nel momento in cui fonda il proprio convincimento sulle risultanze della CTU medico-legale disposta, indirettamente si avvale del metodo di indagine proposto da Ege (i sette parametri tassativi) per
accertare la sussistenza dello straining (o del mobbing). Di contro, sulla base del principio del ‘iudex
peritus peritorum’, al giudice è consentito, in ogni
caso, valutare la complessiva attendibilità delle
conclusioni peritali e, se del caso, disattendere le
sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie (19). Ben può
accadere, quindi, che seppur il CTU riscontri la
presenza dei summenzionati sette parametri, il giudice ritenga non integrata la fattispecie di straining/mobbing con contestuale rigetto della domanda
attorea di risarcimento del danno.
L’onere probatorio
L’ultimo aspetto trattato dalla sentenza in commento riprende l’annosa questione dell’onere probatorio previsto in caso di violazione dell’art. 2087
c.c. a cui è riconducibile anche il fenomeno dello
straining.
Il principio della ripartizione dei carichi probatori
valido per le cause di dequalificazione professionale, spesso associate a fattispecie di vero e proprio
(18) V. Cass. n. 10037/2015.
(19) V. ex plurimis Cass. n. 23592/2010; Cass. n.
13530/2009; Cass. n. 11440/1997.
(20) V. Cass. n. 1258/2015; Cass. n. 826/2015, in D&G,
2015, 21 gennaio (s.m.) con nota di S. Calvetti, Inadempimento
parziale e onere della prova; Cass. n. 15659/2015; Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 6205/2010; Cass. n. 15677/2009; Cass.,
SS.UU., n. 13533/2001, in Foro it., 2002, I, 770 con nota di P.
814
mobbing, vale anche nei casi di straining, vertendosi
sempre in tema di responsabilità contrattuale ex
art. 2087 c.c.
Come affermato dai giudici di legittimità nella decisione in esame, l’art. 2087 c.c., alla stregua del
diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. e dei
principi di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., impone al datore di lavoro l’obbligo di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possono ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei
principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come il mobbing, straining, burn out,
molestie, stalking e così via.
Da ciò deriva la ripartizione degli oneri probatori
secondo le regole di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.,
con conseguente parziale inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697, comma 1, c.c., per
quanto attiene alla presunzione legale della colpa.
Sicché, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale (20), grava sul lavoratore l’onere di
provare l’inadempimento e il nesso causale tra questo e il danno patito, mentre incombe sul datore di
lavoro, l’onere di provare l’assenza di colpa (21).
Il lavoratore deve quindi dimostrare gli elementi di
fatto che concretizzano la condotta vessatoria posta
in essere dal datore o da un superiore gerarchico
(ben potendosi qui richiamare i sette parametri tassativi previsti dal modello Ege). Al datore di lavoro spetta, invece, provare che gli elementi di fatto
dedotti non costituiscono, singolarmente considerati, altrettante violazioni dell’obbligo di protezione e, in ogni caso, che tali episodi non sono collegati tra loro da un finalismo orientato a vessare, discriminare e accerchiare il lavoratore; o, ancora,
che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione dipendente da causa a
lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
Ma la Suprema Corte accanto ai consolidati assunti richiamati, menziona, in maniera additiva, il
lungo processo evolutivo che si è avuto in ambito
europeo in materia di diritto antidiscriminatorio e
antivessatorio, a partire dall’art. 13 del Trattato di
Amsterdam (ora art. 157 TFUE) sino all’affermazione di un principio di uguaglianza declinato nei
Laghezza, Inadempimenti ed onere della prova: le sezioni unite
e la difficile arte del rammendo.
(21) In tal senso, ex plurimis Cass. n. 9209/2015; Cass. n.
10529/2008, in Riv. it. dir. lav., 2008, 4, II, 795 (s.m.) con nota
V. Pasquarella, La natura contrattuale della responsabilità ex art.
2087 c.c.: conferma dell’orientamento già da tempo dominante; Cass. n. 10441/2007.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Lavoro subordinato
due diversi aspetti dell’uguaglianza e della non discriminazione poi rafforzato ulteriormente, a livello
di norma primaria, con l’adozione della Carta di
Nizza, ora Carta dei diritti fondamentali della
Unione Europea.
Tale processo ha portato, nel corso del tempo e
principalmente per effetto del recepimento di direttive comunitarie, alla conseguenza che anche
nel nostro ordinamento condotte potenzialmente
lesive dei diritti fondamentali di cui si tratta abbiano ricevuto una specifica tipizzazione, come discriminatorie (in modo diretto o indiretto).
I contorni di questa complessa normativa sono divenuti più netti, soprattutto, a partire dall’entrata
in vigore dei D.Lgs. nn. 215 e 216 del 2003, nei
quali sono stati specificamente individuati alcuni
fattori di discriminazione (orientamento sessuale,
religione, convinzioni personali, handicap, età, razza, origine etnica) e, quanto all’onere della prova,
si è stabilito che, quando la vittima fornisce elementi di fatto desunti anche da dati di carattere
statistico, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori per una delle
ragioni prese in considerazione, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione, cioè principalmente della insussistenza
dell’elemento psicologico.
La ricostruzione del quadro normativo a cui è pervenuta la sentenza in commento (22), tuttavia,
merita alcune precisazioni, in quanto seppur è rinvenibile una continuità tra le fattispecie di straining/mobbing e i comportamenti discriminatori
(nello specifico le molestie), entrambi lesivi della
dignità della persona, non si possono ritenere pienamente utilizzabili nel primo caso i rimedi posti a
tutela delle discriminazioni ed in particolare quelli
di tipo processuale.
È indubbio che la vittima di mobbing o di straining
è spesso anche vittima di discriminazioni nelle ipotesi in cui le condotte vessatorie assumono connotati discriminatori, essendo rivolte nei confronti di
persone che si trovino in una delle condizioni tutelate dal diritto antidiscriminatorio (es. portatori di
handicap fisici o psichici, appartenenti a minoranze etniche o a un determinato sesso, etc.). In simili
ipotesi il fenomeno considerato assume una particolare natura, poiché le condotte illegittime presentano un’ulteriore carica di antigiuridicità che
legittima il lavoratore ad avvalersi delle tutele so-
stanziali e processuali previste dal diritto antidiscriminatorio.
Tuttavia è vero anche il contrario e cioè che nelle
fattispecie di mobbing o straining può non riscontrarsi un motivo discriminatorio in capo all’agente,
il quale può porre in essere condotte indirizzate nei
confronti di un soggetto, privo di qualità personali
riconducibili ai divieti di discriminazione. In questo caso l’interrogativo da porsi è se le tecniche di
tutela contro le discriminazioni sono adatte a combattere, in assenza di una specifica normativa in
materia, tali fenomeni di vessazioni sui luoghi di
lavoro.
A parere di chi scrive la risposta è negativa per
due ordini di ragione. Il primo attiene alla specialità della disciplina processuale in materia antidiscriminatoria che non può estendersi in via analogica
in casi non tipizzati dalla legge. Il secondo riguarda
il regime di presunzioni utilizzabili nel diritto antidiscriminatorio incompatibile con le fattispecie di
mobbing/straining.
Si pensi in particolare alla rilevanza dei dati statistici prevista dagli artt. 40, D.Lgs. n. 198/2006 e
28, D.Lgs. n. 150/2011 che implicano un giudizio
comparativo, difficilmente realizzabile nei casi di
condotta mobbizzante. Lo stesso dicasi con riferimento alla tutela inibitoria prevista dall’art. 38,
D.Lgs. n. 198/2006 per la quale il giudice ordina la
cessazione del comportamento e la rimozione degli
effetti, a cui si può associare quella risarcitoria, vista come ulteriore domanda a cui il ricorrente è legittimato rispetto ai rimedi principali. Sotto questo
profilo si delinea pertanto una differenza rispetto
all’elaborazione più generale in tema di mobbing,
che ha visto viceversa prevalere la tecnica di tipo
risarcitorio. A ciò si devono aggiungere le ulteriori
sanzioni accessorie previste nel diritto antidiscriminatorio (la sanzione penale se il datore di lavoro
non ottempera all’ordine del giudice, l’esclusione
da appalti e la revoca di benefici pubblici, il pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo
nell’ottemperare all’ordine del giudice solo per le
discriminazioni di genere) che non possono essere
estese al mobbing o allo straining.
Infine la possibilità prevista dall’art. 37, D.Lgs. n.
198/2006 di esperire l’azione collettiva quando non
sono individuabili in modo immediato e diretto le
vittime delle discriminazioni che non si presta ad
essere utilizzata nelle fattispecie di mobbing/straining caratterizzate da una dimensione tendenzialmente individuale.
(22) Sul punto v. Cass. n. 18927/2012.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
815
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Lavoro subordinato
Pertanto sotto questi profili, la divergenza tra il diritto antidiscriminatorio e le fattispecie di mobbing
o di straining rimane ampia, lasciando aperto l’interrogativo sull’effettività della tutela conseguibile.
Tuttavia, non si può trascurare l’argomentazione
che viene complessivamente sostenuta nella sentenza in commento e che fa leva sulle presunzioni
utilizzabili dal giudice anche in via esclusiva, attraverso un prudente apprezzamento e facendo ricorso
“a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo
e nelle valutazioni delle prove”. La prova presuntiva consente al giudice, attraverso la complessiva
valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale,
altre circostanze del caso concreto) di poter risalire
coerentemente al fatto ignoto, ossia all’esistenza
del danno.
Ecco come, per quel che riguarda l’onere della prova, a prescindere dalla normativa antidiscriminatoria, nel nostro ordinamento processuale è previsto
che, nel rito del lavoro, il principio dispositivo deve essere contemperato con quello della ricerca
della verità materiale, con l’utilizzazione da parte
del giudice anche di poteri officiosi oltre che della
prova per presunzioni, alla quale, specialmente in
casi come quello in oggetto, va attribuito precipuo
rilievo.
E come anche affermato dai giudici di legittimità
nelle sentenza in commento, ciò, è conforme al
consolidato orientamento in materia di prova del
danno da demansionamento. In questa fattispecie
infatti il lavoratore non ha solo l’onere di allegare
e provare i fatti costitutivi del lamentato demansionamento, ma deve anche provare il danno subito in conseguenza e per effetto di esso, non potendosi accogliere la teoria del danno in re ipsa. La
prova del danno subìto può essere, però, fornita
con tutti i mezzi che l’ordinamento processuale pone a disposizione, ivi compresa la prova per presunzioni sulla base di elementi di fatto relativi alla
qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa; tipo di professionalità colpita; durata del demansionamento; esito finale della dequalificazione
o altre circostanze del caso concreto (23).
In questo senso, può rinvenirsi una continuità (ma
non una sovrapponibilità) fra il regime probatorio
utilizzato nel diritto antidiscriminatorio e quello
proprio delle condotte di mobbing/straining, pur non
(23) V. Cass. n. 4063/2010; Cass. n. 6572/2006; Cass. n.
29832/2008; Cass. n. 28274/2008.
(24) Cfr. Girelli N., La protezione del benessere psicofisico
816
potendosi invocare in quest’ultima ipotesi la responsabilità risarcitoria nel caso in cui manchi la
dimostrazione, neppure in via presuntiva, dell’esistenza di un effettivo pregiudizio.
Conclusioni
In conclusione non può non riconoscersi alla sentenza in commento il pregio di aver definito in
maniera analitica i contorni dello straining, una fattispecie, come visto, che, a differenza del mobbing,
si concretizza in comportamenti vessatori da parte
del datore privi dei caratteri della frequenza e della
ripetitività, potendosi manifestare anche in una sola azione ostile nei confronti del lavoratore.
O che si tratti di mobbing o di straining, i giudici sono chiamati ad accertare la sussistenza in capo al
lavoratore di un danno alla sua integrità psico-fisica eziologicamente riconducibile al comportamento vessatorio del datore di lavoro o del superiore
gerarchico che deve risarcito sulla base della percentualizzazione individuata dal consulente tecnico
di ufficio.
Tuttavia l’emersione di tale fenomeno non fa altro
che amplificare il vuoto normativo esistente in
questa materia delegata integralmente al contributo giurisprudenziale.
Se da un lato con la pronuncia in commento si irrobustisce la tutela dei lavoratori destinatari di
condotte vessatorie nei luoghi di lavoro, dall’altro
lato però si rischia di annullare l’intento dimostrato dai giudici in materia di mobbing, richiamato
nella premessa del presente contributo, di condannare comportamenti ostili posti in essere dal datore
di lavoro o dal superiore gerarchico esclusivamente
nei casi di maggiore gravità, per evitare che qualsiasi decisione imprenditoriale non condivisa si tramuti in vessazione o persecuzione (24).
Sicché si può concludere rinnovando l’auspicio di
un intervento del legislatore, al fine di soddisfare
una necessaria esigenza di certezza giuridica, ed
evitare il rischio, diametralmente opposto, di
espandere oltremisura, attraverso le pronunce della
magistratura, i comportamenti integranti le fattispecie, con la conseguenza di comprimere il diritto
del datore di effettuare le proprie scelte in equilibrio ed autonomia, seppur con il sacrificio fisiologico delle aspettative dei dipendenti.
dei lavoratori: mobbing, molestie sessuali, straining, op. cit.,
472.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
Rassegna della Cassazione
a cura di Carlo Alberto Giovanardi, Guerino Guarnieri, Giuseppe Ludovico, Giorgio Treglia
CONTROVERSIE DEL LAVORO
DANNO DA DEMANSIONAMENTO E SINDACATO
DELLA CASSAZIONE SULLE MASSIME D’ESPERIENZA
ADOTTATE DAL GIUDICE DI MERITO
Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 maggio 2016, n. 10536
- Pres. Nobile - Rel. Manna - P.M. - Fuzio (conf.) - Amministrazione provinciale di Roma c. F.B.F.
Il giudizio di cassazione è limitato al sindacato sulle
massime di esperienza adottate nella valutazione delle
risultanze istruttorie, nonché alla verifica della correttezza logico - giuridica del ragionamento seguito dal
Giudice di merito, senza che ciò possa tradursi in un
nuovo accertamento o nella ripetizione dell’esperienza
conoscitiva propria dei gradi precedenti.
Il caso
Nel 2012 la Corte d’Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, condannava la Amministrazione Provinciale di Roma al risarcimento del danno da demansionamento in favore di una lavoratrice, “relativamente al periodo intercorso dal 20 settembre 2000 alla data di deposito
del ricorso introduttivo del giudizio”. Secondo la Corte di
merito, infatti, “la dipendente aveva patito, nel passaggio
dalle mansioni svolte presso l’Ufficio beni storici e antropologici dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Roma
a quelle di addetta all’Ufficio Studi, uno svuotamento significativo, per qualità e quantità, delle proprie attribuzioni,
per l’effetto riportando un danno alla professionalità e un
danno biologico”. Contro tale pronuncia proponeva ricorso
in cassazione l’Amministrazione Provinciale di Roma, cui è
successivamente “subentrata ex lege la Città Metropolitana
di Roma Capitale, che a tal fine ha depositato memoria”.
Tale ricorso era basato su di un solo, articolato, motivo,
con il quale veniva denunciata la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., degli artt. 112 e 115
c.p.c., e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata genericamente motivato basandosi su pretesi riscontri della deposizione” di un solo testimone, “il tutto in contrasto con la specifica motivazione resa dal Tribunale, con
le controdeduzioni svolte dall’amministrazione e con i numerosi documenti acquisiti in corso di causa. Da essi risulta - prosegue il ricorso -l’atteggiamento antagonistico e aggressivo della controricorrente rispetto ai compiti affidatile
presso l’Ufficio Studi”, inoltre, sempre secondo la ricorrente, la sentenza d’appello aveva travisato il significato della
deposizione dello stesso teste, “nel senso che nei primi
tempi (cioè dall’ottobre al dicembre 2000) dopo la sua costituzione tutto l’Ufficio Studi, e non soltanto la ricorrente,
aveva avuto poco lavoro da svolgere in considerazione delle difficoltà di avvio della nuova unità organizzativa”. Infine,
“era stata la stessa controricorrente a chiedere di passare
all’Ufficio Studi” e la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., aveva altresì “erroneamente ritenuto provati il demansionamento e il supposto danno patrimoniale
alla professionalità della dipendente, essendo invece ne-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
cessario a tal fine dimostrare fatti e circostanze da cui presumere che in concreto vi fosse stata una perdita delle cognizioni acquisite nel precedente incarico, ovvero l’impossibilità d’un loro aggiornamento”.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso, condannando altresì il
datore di lavoro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, “liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro
4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come
per legge”. La S.C., infatti, dopo avere preliminarmente appurato che il ricorso conteneva tutte le “indicazioni necessarie al fine di intendere il significato delle censure in relazione agli atti richiamati”, e quindi sfuggiva al rigetto per
“difetto di autosufficienza” (così come richiesto preliminarmente dalla controricorrente), ha poi rilevato che lo stesso
ricorso, “ad onta dei richiami normativi in esso contenuti,
in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del
materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinché
se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta
dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di
motivazione”. Alla Cassazione infatti “spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla
correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi
in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti”. E, a
sua volta, “il controllo in sede di legittimità delle massime
di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta,
che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare
questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con
massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere
congetture”. Invece nel ricorso non era stato evidenziato
“l’uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di
regole inferenziali”, bensì erano state soltanto segnalate
“possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che
costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di
quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza”. Infine, nel ricorso non erano stati isolati, come invece si sarebbe dovuto, “singoli passaggi argomentativi per
evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e
manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di
causa)”, ma si è invece ritenuto “di poter enucleare vizi di
motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un
accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema”. Quanto poi alla prova
del demansionamento, e del relativo danno, secondo la
Cassazione i giudici di merito avevano “accertato uno
svuotamento quantitativo e qualitativo delle mansioni all’atto del passaggio della controricorrente all’Ufficio Studi
e, quel che più conta, un suo isolamento rispetto al contesto organizzativo e relazionale dell’ambiente di lavoro, cir-
817
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
costanze da cui i giudici d’appello hanno correttamente ricavato una presumptio hominis di impoverimento professionale proiettato nel futuro”; inoltre, “trattandosi di presunzione, consentita anche a fronte d’un accertato demansionamento, non è indispensabile la dimostrazione positiva
d’una vera e propria impossibilità di aggiornamento”.
I precedenti
In senso conforme (e sempre con riferimento al motivo di
ricorso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. nel testo precedente
alla radicale modifica operata nel 2012) si vedano, richiamate in motivazione Cass., Sez. trib., 4 febbraio 2004, n.
2090, in Mass. Giust. civ., 2004, 198 (secondo la quale “In
tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a
sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere
nella circostanza che la determinazione o la valutazione
delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell’art.
116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del
proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le
varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti
con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua
motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito”), e Cass., SS.UU., 11 giugno 1998, n. 5802, ivi,
1998, 1283 (per la quale il vizio di motivazione “sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in
senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere
di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti
del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra
le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione”. Ricordiamo che, invece, dal 2012, si
ritiene invece che il controllo della Cassazione sia ora limitato alla verifica della presenza, o meno, del c.d. “minimo
costituzionale” motivazionale: cfr. ad es. Cass., Sez. lav., 7
aprile 2016, n. 6763, in corso di pubblicazione su questa
Rivista, e Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053, in Corr.
giur., 2014, 1241 ss., con nota di Glendi. Sui limiti al sindacato della Cassazione sull’utilizzo delle c.d. “massime d’esperienza” da parte del giudice di merito, v. poi Cass., Sez.
III, 13 novembre 2015, n. 23201, in Mass. Foro it., 2015,
781, che (in una interessante fattispecie, in cui si discuteva
se l’incendio di un immobile fosse stato, o meno, provocato dalla “autocombustione del fieno ammassato dai convenuti” in un locale del medesimo edificio), ha affermato che,
in caso di prova per presunzioni (art. 2729 c.c.), il “percorso logico-giuridico” seguito dal giudice di merito è sindacabile solo nella misura in cui “siano stati pretermessi, senza
darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili
massime di esperienza, un’oggettiva portata indiziante”,
nonché Cass., Sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 777, ivi, 34;
Cass., Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20313, in Mass. Giust. civ.,
2011, 1402; Cass., Sez. III, 28 ottobre 2010, n. 22022, ivi,
2010, 1377 (secondo cui “Il giudice è tenuto ad avvalersi,
come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove, che l’argomentazione di tipo presuntivo,
818
delle massime d’esperienza -o nozioni di comune esperienza-, da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici.”); Cass., Sez. lav., 26 giugno 2004, n. 11919,
in Foro it., 2004, I, 179 ss.
Per quanto poi concerne in particolare la prova del demansionamento ed i criteri di liquidazione del relativo danno,
cfr. Cass., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572, in questa Rivista, 2006, 661 ss., con nota di Sorgi, e 773 ss., con nota di
Petracci (ed anche, ad es., in Foro it., 2006, I, 2334 ss., con
nota di Cendon, in Riv. it. dir. lav., 2006, 687 ss., con nota
di Scognamiglio, e in Giur. it., 2006, 1359 ss., con nota di
Bordon), nonché Cass., Sez. lav., 1° marzo 2016, n. 4031,
Cass., Sez. lav., 10 novembre 2015, n. 22930, in Mass. Foro
it., 2015, 777; Cass., Sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12253, in
Giur. it., 2015, 2683 ss., con nota di De Feo, e in Riv. it. dir.
lav., 2015, 998 ss., con nota di Gargiulo; Cass., Sez. lav., 26
gennaio 2015, n. 1327, in Mass. Foro it., 2015, 53; Cass.,
Sez. lav., 18 marzo 2014, n. 6230, in questa Rivista, 2014,
711; Cass., Sez. lav., 8 gennaio 2014, n. 172, in Giur. it.,
2014, 918 ss., con nota di D’Amelio, e in questa Rivista,
2014, 404; Cass., Sez. lav., 16 ottobre 2013, n. 23530, ivi,
2014, 183; Cass., Sez. lav. 19 aprile 2012, n. 6110, ivi,
2012, 720; Cass., Sez. lav., 23 novembre 2011, n. 24718,
ivi, 191; Cass., Sez. lav., 1° giugno 2002, n. 7967, in Mass.
Giust. civ., 2001, 945 (secondo cui la liquidazione del danno
“può avvenire anche in via equitativa, eventualmente con
riferimento all’entità della retribuzione risultante dalle buste
- paga prodotte in giudizio”). Sul tema si segnala anche
che, secondo Trib. Ravenna 22 settembre 2015, in questa
Rivista, 2016, 183 ss., con nota di Aiello, “Non è applicabile
la nuova normativa in materia di ius variandi, ex art. 2103
c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 81/2015, qualora il
demansionamento, fatto generatore del diritto alla tutela
reintegratoria e risarcitoria, si sia prodotto nel vigore della
legge precedente”.
Guerino Giuarnieri
DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NEL DISPORRE
LA RINNOVAZIONE DELLA CTU
Cassazione Civile, Sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8881 Pres. Amoroso - Rel. Riverso - P.M. Sanlorenzo (conf.) D.M.L. c. Comune di Cercemaggiore
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio,
atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i
poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è
neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.
Il caso
Nel 2013 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la
sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda
con quale la ricorrente aveva richiesto l’annullamento, per
incapacità naturale, delle proprie dimissioni da vigile urbano, rassegnate nell’agosto del 2006, con conseguente ripristino del rapporto e condanna del Comune convenuto “al
pagamento delle retribuzioni dovute o al risarcimento del
danno”. I giudici d’appello, “alla luce delle prove raccolte
in primo grado e della ctu ivi espletata”, avevano infatti ritenuto “che la ricorrente versasse in uno stato ansioso depressivo che ben può configurare un disturbo della personalità NAS senza determinare uno stato di incapacità natu-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
rale; e che la ricorrente era stata indotta alle dimissioni da
legittimi motivi personali e/o familiari come da ella addotto
tanto nella lettera di dimissioni, tanto nella richiesta” di
riammissione in servizio presentata nel febbraio del 2007.
La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo motivo venivano dedotti; a) un “vizio di motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697
c.c.”; b) il travisamento dei fatti e la illogicità della sentenza
per contraddittorietà della consulenza tecnica d’ufficio; c)
un vizio di motivazione “su un fatto deciso del giudizio e
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c.”; in
sintesi, con questo motivo si lamentava che “la Corte di
merito avesse escluso la prova della incapacità naturale” e
non avesse “esaminato le censure rivolte nell’appello alla
consulenza tecnica posta a base della sentenza di primo
grado”. I giudici di merito sarebbero inoltre caduti in contraddizione quando, recependo le conclusioni della consulenza tecnica, avevano “da una parte sostenuto che la” lavoratrice “fosse affetta dal disturbo della personalità NAS e
dall’altra che le dimissioni fossero state rassegnate per motivi personali”. Con il secondo motivo, invece, veniva dedotto un “vizio dl motivazione per omessa ammissione di
prova testimoniale e mancato rinnovo” della consulenza
tecnica.
La decisione
La S.C. ha esaminato congiuntamente questi due motivi di
ricorso, considerandoli legati da “connessione logica”, dopodiché li ha ritenuti entrambi inammissibili, condannando
altresì la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate “in Euro 100 per esborsi ed in Euro
3000 per compensi professionali, oltre accessori di legge e
spese generali al 15%”. Anzitutto, secondo la Sezione Lavoro “non è vero che la Corte avrebbe escluso la prova sullo stato di incapacità transitoria della lavoratrice al momento delle dimissioni. Il giudizio d’appello ha invece confermato la conclusione presa dal primo giudice sulla scorta di
prove testimoniali e documentali univoche, assunte nel
corso del giudizio e non fatte oggetto di alcuna censura in
appello. La conclusione è altresì fondata sulla consulenza
tecnica d’ufficio la quale ha pure concluso - sulla scorta
del parere della psichiatra - che la ricorrente, pur avendo
avuto stati di ansia associati a sintomi psicotici, non ha tuttavia subito alcun annullamento o riduzione della capacità
di intendere e di volere al momento delle dimissioni”. E
“nemmeno è vero”, prosegue la sentenza, “che la Corte
non avrebbe esaminato le censure rivolte alla ctu nell’atto
di appello. Al contrario, la sentenza si sofferma sui motivi
per cui le crisi di cui soffriva la ricorrente non potevano
aver comportato incapacità naturale al momento del dimissioni attraverso un’autonoma disamina dei fatti ed una ricostruzione storica dello svolgersi degli accadimenti a confutazione dei rilievi del gravame”. Infine viene ricordato
che, secondo una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, “non sussiste vizio di motivazione allorché il giudice di merito non proceda alla rinnovazione della ctu”: infatti il giudice di merito, anche nel processo del lavoro, non è
mai tenuto, neppure dinanzi ad una precisa istanza in tal
senso, a ordinare lo svolgimento di una seconda consulenza tecnica d’ufficio, essendosi qui nell’ambito un suo potere esclusivo e discrezionale, del cui mancato esercizio non
è pertanto neppure tenuto a rendere conto in sede di motivazione.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
I precedenti
In senso conforme si veda, anzitutto, espressamente richiamata in motivazione, Cass., Sez. lav., 24 settembre 2010,
n. 20227, in Mass. Giust. civ., 2010, 1261, la cui massima è
identica a quella qui sopra riportata e nella cui fattispecie
la S.C., “nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato
che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un’esplicita
motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito”), nonché Cass., Sez. lav., 5 febbraio 2004, n. 2151, in Mass. Foro it., 2004, 131, e Cass.,
Sez. III, 19 luglio 2013, n. 17693, ivi, 2013, 707 s., secondo
cui “il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito”. In senso contrario si vedano. comunque Cass., Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9379, in
Mass. Giust. civ., 2011, 657, secondo la quale “In tema di
consulenza tecnica d’ufficio, il giudice è tenuto a motivare
sul rigetto della argomentata richiesta di rinnovazione delle
indagini tecniche rivolta dalla parte”, e Cass., Sez. III, 2
agosto 2004, n. 14775, in Mass. Foro it., 2004, 1158, per la
quale “se la parte chiede la rinnovazione delle indagini tecniche, specificando le ragioni della richiesta, il giudice è libero di disporla o meno, ma nel caso in cui non la disponga, a differenza del caso contrario, è tenuto a motivare sul
punto”.
In tema di rinnovazione della CTU e di discrezionalità del
giudice, v. poi anche Cass., Sez. lav., 15 gennaio 2014, n.
684, in questa Rivista, 2014, 403; Cass., Sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19572, in Mass. Foro it., 2013, 723; Cass., Sez.
lav., 9 agosto 2012, n. 14338, ivi, 2012, 643 s. (per la quale
“il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali
del giudice di merito valutare l’opportunità di rinnovare le
indagini peritali va coordinato con il principio dell’effetto
devolutivo dell’appello, sicché, qualora l’appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento
del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di
appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della
sentenza che vi aderisca”); Cass., Sez. lav., 31 marzo 2011,
n. 7494, in Mass. Giust. civ., 2011, 510; Cass., Sez. lav., 29
aprile 2010, n. 9379, in questa Rivista, 2010, 726; Cass.,
Sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23063, in Mass. Giust. civ., 2009,
1522 (qui la S.C. “ha cassato la sentenza di merito che aveva acriticamente recepito le risultanze della c.t.u. di secondo grado, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni
che avevano portato ad escludere la fondatezza delle conclusioni raggiunte dalla consulenza espletata in primo grado”); Cass., Sez. lav., 27 febbraio 2009, n. 4850, ivi, 2009,
336; Cass., Sez. II, 19 marzo 1999, n. 2541, in Mass. Giust.
civ. 1999, 615.
Infine, sempre in tema di CTU, ma relativamente ad altra
problematica, si veda Cass., Sez. lav., 19 dicembre 2013, n.
2848, in questa Rivista, 2014, 280, per la quale, “Posto che
la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di
prova, ma solo uno strumento di controllo dei fatti costituenti la prova, il lavoratore che adduca di aver subito condotte discriminatorie e persecutorie è gravato del relativo
onere probatorio, non essendo sufficiente riportarsi ad episodi riferiti” dal consulente tecnico.
Guerino Guarnieri
819
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
ANCORA SUI LIMITI SOGGETTIVI ALLA PROVA
TESTIMONIALE
Cassazione Civile, Sez. lav., 22 aprile 2016, n. 8180 Pres. Di Cerbo - Rel. Tricomi - P.M. Celentano (conf.) O.N.V. c. Emmebi S.r.l.
L’incapacità a testimoniare è correlabile soltanto a un
diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua
assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o
processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto
della vertenza, anche in qualche modo connessi (nella
specie, è stato ritenuto capace di testimoniare il lavoratore che aveva querelato il ricorrente, quale autore dell’aggressione subita).
Il caso
Nel 2014 la Corte d’Appello di Bologna respingeva l’appello proposto da un lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Modena, che, nel 2012, “aveva rigettato la domanda del lavoratore di declaratoria di nullità o illegittimità del
licenziamento irrogatogli”, in seguito ad una colluttazione
con altri colleghi, e di “condanna del datore di lavoro alla
reintegra e al risarcimento dei danni”. Il soccombente proponeva quindi ricorso in cassazione, per sei motivi, ed il
datore di lavoro resisteva con controricorso. In particolare
con il terzo motivo di ricorso veniva dedotta “la violazione
e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. avendo la Corte
d’Appello ritenuto... capace di deporre” il lavoratore che
(stando alla narrativa del ricorrente), aveva aggredito il ricorrente stesso e lo aveva colpito, e pertanto doveva essere considerato “incapace”, in quanto palesemente “legittimato a partecipare al giudizio sia come interventore principale, sia come interventore ad adiuvandum, e comunque,
vi sarebbe stata mancanza di motivazione su questo punto”. Il teste, inoltre, aveva presentato contro il ricorrente
“una denuncia querela”, nella quale proponeva una diversa
ricostruzione dei fatti, asserendo di essere stato lui a ricevere il pugno al volto, il che confermava la sua legittimazione sia ad intervenire nel giudizio, in via principale, per il risarcimento del danno subito, sia ad intervenire “ad adiuvandum, poiché sulla circostanza oggetto della querela la
società datrice di lavoro aveva fondato il licenziamento”. E
comunque “l’attendibilità del teste doveva ritenersi nulla,
atteso che lo stesso non potrebbe che confermare quanto
oggetto della denuncia”.
La decisione
La Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso ed ha
quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio, liquidate “in Euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre euro cento per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge”. Per quanto poi specificamente concerne il terzo motivo, al riguardo la Cassazione ha rilevato che già la Corte
d’Appello aveva posto correttamente in evidenza come il
teste contestato “non fosse titolare di alcun interesse giuridico (e non fattuale) che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, determinandone l’incapacità a testimoniare. Né può rilevare in proposito la presentazione di querela”. È infatti ormai sufficientemente pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “l’interesse
che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art.
820
246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed
attuale, che comporta o una legittimazione principale a
proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad
intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati.
Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto,
che un testimone può avere a che venga decisa in un certo
modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia,
a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza,
potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità
delle relative deposizioni”. Quanto poi alla fattispecie concreta, si trattava di un giudizio vertente tra un datore di lavoro ed un dipendente, ed avente ad oggetto un’impugnativa di licenziamento, e quindi non vi era alcun margine per
configurare in capo al teste “un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio”.
Ciò posto, la S.C. ha anche rilevato che, comunque, la, presunta, incapacità del teste, derivante da fatti ben noti al ricorrente, avrebbe dovuto “essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, (salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicché, in mancanza di tale tempestiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata”. Invece nel
formulare il motivo di ricorso per violazione dell’art. 246
c.p.c. il ricorrente non aveva né allegato di avere ottemperato a tale onere, né, tantomeno, indicato in quale scritto
difensivo, o in quale verbale d’udienza, fosse stata tempestivamente sollevata la relativa eccezione.
I precedenti
In senso conforme e proprio con riferimento ad una, pretesa, incapacità da colluttazione, nonché per l’affermazione
che l’eventuale incapacità del teste deve essere tempestivamente fatta valere, a pena di decadenza, già nel giudizio
di merito, cfr., anzitutto, Cass., Sez. lav., 25 novembre
2014, n. 25015, in questa Rivista, 2015, 194 s., e in Riv. dir.
proc., 2015, 1216 ss., con nostro ampio commento. Richiamate in motivazione si vedano poi anche Cass., Sez. lav.,
21 ottobre 2015, n. 21418, in Mass. Foro it., 2015, 703 (anche per l’affermazione che l’eventuale riunione di cause
connesse promosse da più lavoratori non farebbe insorgere l’incapacità a testimoniare ciascuno nella causa dell’altro); Cass., Sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3051, in Mass.
Giust. civ., 2011, 199 (per la quale nel giudizio tra INPS e
datore di lavoro, “avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a
testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati”, e che abbia già transatto la propria lite con il datore
di lavoro). Tra le più recenti si veda poi anche Cass., Sez.
lav., 25 gennaio 2016, n. 1256, in Mass. Foro it., 2016, 55,
per la quale “Nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell’obbligo contributivo, sussiste l’incapacità a testimoniare del lavoratore
i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia,
che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art.
421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa”.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
In campo non lavoristico, cfr. inoltre Cass., Sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314, in Mass. Giust. civ., 2010, 713 (“che, in
un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di
persone”, ha affermato che “gli altri soci della medesima
non sono incapaci a deporre, perché l’esito della causa
non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale; né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità delle quote non sia in
discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio”), nonché, sull’incapacità a testimoniare del
c.d. terzo danneggiato in un incidente stradale, anche se
abbia rinunciato al risarcimento, Cass., Sez. III, 18 aprile
2016, n. 7623, e Cass., Sez. III, 29 settembre 2015, n.
19258, in Mass. Foro it., 2015, 626.
Nel senso che “La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta
a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come
nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti
sanata ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.”, cfr.
poi Cass., SS.UU., 23 settembre 2013, n. 21670, in Mass.
Foro it., 2013, 686 s., e conformi v. Cass., Sez. lav., 25 novembre 2014, n. 2505, cit.; Cass., Sez. lav., 19 agosto
2014, n. 18036, in questa Rivista, 2014, 1123, e già Cass.,
SS.UU., 13 gennaio 1997, n. 264, in Mass. Giust. civ.,
1997, 46.
Con riferimento ad una problematica diversa, ma collegata,
segnaliamo infine la, recentissima, Cass., Sez. lav., 19 maggio 2016, n. 10347, per la quale la deposizione di un testimone “può essere ritenuta attendibile anche limitatamente
a determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del
narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole
di credito, non sussista un rapporto di causalità necessaria
o l’una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell’altro”.
Guerino Guarnieri
LAVORO SUBORDINATO
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE ED ESIGENZE
DELL’IMPRESA
Cassazione Civile, Sez. lav., 30 maggio 2016, n. 11126 Pres. Nobile - Est. Esposito - P.M. Giacalone (diff.) - Ric.
San Raffaele S.p.a. - Res. F.S.
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento
datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e non può
essere ampliato al merito della scelta operata dall’imprenditore che non deve presentare necessariamente
i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il
trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte
adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di
appello che, con riguardo al trasferimento di una terapista della riabilitazione, aveva affermato che il datore
di lavoro non aveva provato la inutilizzabilità della
sua prestazione lavorativa presso la sede di provenienza, né l’impossibilità di adottare presso di essa
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
una diversa soluzione organizzativa, alternativa al trasferimento).
Il caso
La dipendente di una casa di cura veniva assunta a tempo
indeterminato in qualità di terapista della riabilitazione. Le
parti del contratto di lavoro raggiungevano, nel tempo, un
accordo scritto, a mezzo del quale il rapporto di lavoro si
trasformava definitivamente in part - time per 24 ore settimanali e svolgimento della prestazione dal lunedì al sabato
dalle 9,30 alle 12.
Dopodiché la datrice proponeva una variazione dell’orario
con previsione di turni pomeridiani e con avvertimento
che, in caso di rifiuto, si sarebbe proceduto ad un trasferimento presso altra sede, ove, a dire della datrice, vi era esigenza di personale con la qualifica rivestita dalla terapista.
La lavoratrice opponeva un netto rifiuto, anche avuto riguardo alle proprie esigenze familiari; la stessa continuava
a svolgere la propria attività di lavoro nei modi e nei luoghi
di sempre.
A causa del rifiuto di cui sopra, la società, all’esito di un
procedimento disciplinare, provvedeva a licenziare in tronco la propria dipendente.
Avverso tale provvedimento, la lavoratrice proponeva ricorso al tribunale competente, il quale rigettava la domanda.
Contro la pronuncia di primo grado, interponeva appello la
soccombente e la Corte territoriale accoglieva le domande
disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro.
In particolare la Corte di merito osservava che la società
non aveva provato la sussistenza di un effettivo nesso causale fra le esigenze derivanti dalla riorganizzazione aziendale addotta ed il mutamento dell’orario di lavoro concordato
con la lavoratrice e neppure l’inutilizzabilità della prestazione della medesima nella nuova sede, oppure ancora l’impossibilità di adottare, presso tale sede, una diversa soluzione organizzativa alternativa al trasferimento e meno gravosa per la dipendente.
L’azienda soccombente proponeva ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi di impugnazione; la prestatrice
d’opera resisteva con controricorso.
La decisione
La. S.C. critica severamente l’operato dei giudici di secondo grado, accusandoli di aver trattato confusamente le
questioni attinenti all’immutabilità dell’orario nel lavoro a
tempo parziale, nonché quelle relative alla presunta illegittimità dapprima del disposto trasferimento e poi dell’intervenuto licenziamento.
Ed infatti occorreva verificare, in primo luogo, l’incidenza,
nell’ambito dell’orario part-time, del trasferimento, alla luce
dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti il controllo giurisdizionale, relativo alle ragioni tecniche
del trasferimento, deve essere diretto ad accertare che vi
sia corrispondenza fra il provvedimento adottato e le finalità tipiche dell’impresa, ma non può dilatarsi fino a comprendere il merito della scelta operata dall’imprenditore.
Scelta che non deve presentare i caratteri dell’inevitabilità,
essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle
possibilità che il datore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Di più, la predetta scelta imprenditoriale fra più soluzioni
organizzative è insindacabile da parte del giudice e non è
necessario che l’imprenditore dimostri l’inevitabilità del
provvedimento di trasferimento, sotto il profilo della sicura
inutilizzabilità del dipendente presso la sede di provenienza.
821
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
In conclusione la Corte territoriale non si è attenuta ai principi di cui sopra, essendosi erroneamente addentrata nel
merito delle valutazioni imprenditoriali.
Quanto sopra ha portato ad un procedimento argomentativo viziato; pertanto il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione,
cui è affidato anche il regolamento delle spese.
I precedenti
Cass. 28 aprile 2009, n. 9921, in CED 2009; Cass. 2 marzo
2011, n. 5099, ivi, 2011.
Giorgio Treglia
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DOVERI DI VERIFICA
DEL GIUDICE
Cassazione Civile, Sez. lav., 26 maggio 2016, n. 10950 Pres. Venuti - Est. Manna - P.M. Servello (diff.) - Ric.
M.G. - Res. Casa di Cura Città di Roma S.p.a.
Il giudice di secondo grado, investito del gravame con
cui si chieda l’invalidazione d’un licenziamento disciplinare, deve verificare che l’infrazione contestata, ove in
punto di fatto accertata o pacifica, sia astrattamente
sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di
tale delibazione, deve poi, anche d’ufficio, apprezzare in
concreto (e non semplicemente in astratto) la gravità
dell’addebito, essendo pur sempre necessario che esso
rivesta il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente
sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la
futura correttezza dell’adempimento della prestazione
dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo
atteggiarsi del lavoratore rispetto all’adempimento dei
suoi obblighi.
Il caso
Il dipendente di una casa di cura ritiene di ridurre il suo
tempo di lavoro, fino a svolgere la propria prestazione per
sole tre ore al giorno.
Tale fatto gli comporta la notifica di una contestazione disciplinare e, espletato il procedimento di cui all’art. 7 Stat.
lav., la successiva irrogazione di un licenziamento per giusta causa.
Ne nasce un contenzioso regolato dalla L. n. 92/2012.
Sia l’ordinanza della prima fase, che la successiva sentenza
- emessa a seguito di opposizione - che, infine, la sentenza
della Corte territoriale su reclamo, confermano la totale legittimità dell’intimato recesso.
Avverso la sentenza di secondo grado, il lavoratore ha promosso ricorso per cassazione, affidato a ben otto motivi di
gravame; la società ha resistito con controricorso.
La decisione
Con la pronuncia in breve commento, la S.C. chiarisce importanti principi in tema di poteri del giudicante ai fini della
corretta individuazione dell’eventuale giusta causa di licenziamento.
Innanzitutto è precisato che la sentenza di merito premette
di non potersi pronunciare sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, rispetto all’infrazione contestata, per “difetto specifico di reclamo”.
Ora, per la S.C. trattasi di errore evidente, in quanto il giudice di merito deve sempre valutare la sussistenza o meno
del rapporto di proporzionalità tra l’infrazione del lavoratore
822
e la sanzione irrogatagli, tenendo conto delle circostanze
oggettive e soggettive della condotta del lavoratore e di
tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento
della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c.
In sostanza, il giudice di merito, laddove gli si richieda di
giudicare in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare, deve verificare che l’infrazione contestata sia
astrattamente inquadrabile nella specie della giusta causa
o del giustificato motivo, per poi apprezzare in concreto la
gravità dell’addebito.
La sentenza impugnata, ad avviso della S.C., non si è attenuta a tale principio ritenendo di dover fermare la cognizione alla sola gravità del fatto in astratto, solo perché la parte
non avrebbe mosso una specifica censura in ordine alla
proporzionalità della sanzione, trattando solo il tema dell’insussistenza dell’addebito.
Tuttavia l’apprezzamento relativo, come detto, alla proporzionalità fra sanzione ed illecito disciplinare deve essere svolto anche d’ufficio; “diversamente risulterebbe interrotta la sequenza logica “fatto norma effetto giuridico”
attraverso la quale si afferma l’esistenza di un fatto sostenibile sotto una norma che adesso i colleghi un dato effetto giuridico” (così specificamente si legge nella motivazione).
La sentenza affronta poi gli altri motivi di gravame, ritenendoli infondati e, alla conclusione del proprio argomentare,
cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti la medesima corte d’appello, in diversa composizione, indicando
il principio di diritto riportato nella massima.
Pertanto il ricorso è soltanto parzialmente accolto ed al
giudice di merito è demandato il compito di riesaminare
l’intera questione soprattutto con riguardo alla proporzionalità o meno del licenziamento disciplinare in relazione
all’addebito di cui è causa, proprio al fine di valutare tutti
gli aspetti oggettivi, quali la gravità della condotta e l’entità del danno arrecato. Pure egli dovrà compiere una valutazione degli aspetti soggettivi, quali il grado della colpa o
l’intenzionalità della condotta e della sua intensità, avendo così conferma o smentita che il fatto, oggetto di contestazione disciplinare, sia stato tale da minare irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nei confronti del
proprio dipendente.
I precedenti
Cass. 11 aprile 2011, n. 8456, in Mass. Giur. it., 2006; Cass.
23 gennaio 2002, n. 736, in Not. giur. lav., 2002; Cass.
2000, n. 1144, in D&G, 2000, 6; Cass. 14 luglio 2015, n.
14670, in CED, 2015.
Giorgio Treglia
VENDITA DI PRODOTTI ON LINE DURANTE L’ORARIO
DI LAVORO ED INSUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA
DI RECESSO
Cassazione Civile, Sez. lav., 16 maggio 2016, n. 10020 Pres. Nobile - Est. Spena - P.M. Giacalone (conf.) - Ric.
Mille Uno SpA - Res. R.A.
Non rappresenta una giusta causa il licenziamento di
un dipendente che vende prodotti online durante l’orario di lavoro se la vendita non interessa i clienti del datore di lavoro da cui dipende ed è svolta in un tempo
determinato.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
Il caso
Il dipendente di una società, che gestiva una sala per il gioco del bingo, cominciava ad esercitare una propria attività
commerciale. In particolare, durante l’orario di lavoro, vendeva prodotti di vario genere (fra cui pillole antirussamento), rivendita di ricariche, prodotti afferenti a scommesse
sportive.
Venuta a conoscenza dei fatti, la datrice riteneva di dover
considerare risolto per giusta causa il rapporto di lavoro e,
pertanto, attuata la procedura di cui all’art. 7 Stat. lav. provvedeva, come detto a licenziare in tronco il proprio dipendente.
Questi se ne adontava e, pertanto, si rivolgeva alle cure del
giudice di primo grado con il rito previsto dalla L. n.
92/2012.
Il tribunale adito, sia nella prima fase che in quella di opposizione, rigettava il ricorso, affermando la sussistenza di
una giusta causa di recesso.
La Corte territoriale, adita su reclamo del lavoratore soccombente, era di contrario avviso; ed infatti, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il rapporto di
lavoro, condannando la datrice al pagamento di 18 mesi di
retribuzione.
Più specificamente, i giudici di secondo grado ritenevano
non proporzionata la sanzione, in ragione della prova dell’esercizio delle predette attività commerciali nei confronti
dei soli colleghi di lavoro e non anche della clientela della
sala bingo, della mancanza di danno alla società, del limitato arco temporale di svolgimento degli episodi contestati.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione
la società, affidando l’impugnazione a due motivi di gravame. Resisteva il lavoratore che proponeva anche un ricorso
incidentale.
La decisione
Nel proprio ricorso principale la società valorizzava alcuni
aspetti del comportamento posto in essere dal proprio dipendente, quali: il carattere illecito della condotta, lo scopo
di lucro dell’attività svolta, la normativa sul divieto di esercitare attività di intermediazione, le ipotetiche ripercussioni
sulla sala gioco, ove si fosse diffusa la notizia di un commercio non autorizzato al proprio interno.
La S.C. ha ritenuto di dover spostare l’attenzione su altre
questioni, ovvero sul fatto, per come accertato dalla sentenza di merito e sul potere discrezionale di valutazione
delle prove da parte del giudice.
In particolare è detto che, rispetto ai fatti accertati dalla
sentenza, la valutazione di insussistenza della giusta causa
di recesso appariva esente da censure. Infatti la sentenza
di secondo grado aveva chiarito che era stata attuata una
mera proposta di vendita ai colleghi di lavoro di merce e di
abbonamenti ad un sito internet di scommesse sportive,
senza esibizione della merce e senza interruzione della prestazione di lavoro e senza esercitare attività di persuasione
verso il colleghi stessi. Di più la corte territoriale avrebbe
valutato anche la breve durata delle singole condotte ed il
limitato arco temporale di verificazione dei fatti (il periodo
prenatalizio).
Francamente la motivazione, in parte qua, desta qualche
perplessità, anche perché la sentenza in breve commento
non fa alcun cenno ai principi che informano ogni rapporto
di lavoro subordinato e, segnatamente, quelli indicati negli
artt. 2104 e 2105 c.c. (dovere di diligenza nella prestazione
e obbligo di fedeltà).
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Ad ogni buon conto, la pronuncia affronta poi la tematica
relativa al secondo mezzo di impugnazione, ovvero l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio consistente
nella circostanza che il lavoratore aveva un doppio listino
prezzi: per i beni da vendere ai colleghi e per quelli da vendere alla clientela. Sul punto è chiarito che il fatto storico
della eventuale attività di vendita di prodotti a terzi era stato esaminato dal giudice di merito, con la conseguenza
che la censura riguardava, in realtà, il mancato esame di
elementi di prova e la mancata ammissione di mezzi istruttori; ipotesi queste non rientranti nel disposto di cui all’art.
360, n. 5, c.p.c.
La S.C., su tale ultimo punto, ha chiarito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame circa
un fatto decisivo previsto dalla norma; e ciò quand’anche il
fatto storico sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice di merito, anche se questi non abbia dato conto
di tutte le risultanze istruttorie astrattamente rilevanti.
Per quanto sopra il ricorso principale è stato rigettato.
In ordine al ricorso incidentale formulato dal lavoratore, lo
stesso è stato dichiarato inammissibile, poiché non erano
state individuate, nel libello di riferimento, le statuizioni della sentenza oggetto di censura e neppure erano stati articolati specifici motivi di ricorso. Qui la S.C. ricorda che il
giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato dai
motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica. Dunque il
motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività
e della specificità, in modo che il vizio denunciato rientri
nelle categorie previste dall’art. 360 c.p.c.
I precedenti
Cass., SS.UU., 22 settembre 2014, n. 19881, in Dir. prat.
trib., 2015, 4, 730 con nota di Dalla Bontà; Cass., SS.UU.,
7 aprile 2014, n. 8053, in questa Rivista, 2014, in Foro it.,
2015, 1, 1, 210, in Corr. giur., 2014, 10, 1241 con nota di
Glendi. Sui fondamenti del giudizio di cassazione, cfr. Cass.
28 novembre 2014, n. 25332, in CED 2014; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959, ivi, 2014; Cass. 17 settembre 2013,
n. 21165, in CED 2013.
Giorgio Treglia
BADGE, CONTROLLO A DISTANZA E LICENZIAMENTO
Cassazione Civile, Sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904 Pres. Venuti - Rel. Patti - P.M. Mastroberardino (conf.) Grandi stazioni Spa c. C.F.
È illegittimo il licenziamento fondato sui dati risultanti
dal badge elettronico in uso al dipendente se le modalità di rilevazione dei dati di entrata e uscita, incluse le
pause, non sono state concordate con le rappresentanze sindacali né autorizzate da parte della DTL.
Il caso
In base ai dati acquisiti tramite badge, la società, contestando alcune anomalie consistenti nella non coincidenza
delle timbrature in entrata e in uscita rispetto agli orari di
lavoro, procedeva al licenziamento per giusta causa. Su
ricorso del lavoratore, il Tribunale e la Corte d’Appello di
Napoli (quest’ultima con sentenza del 28 dicembre 2012)
dichiaravano non utilizzabili ai fini del recesso i dati acquisiti, specificatamente a causa dell’illegittimità dell’impianto di rilevazione aziendale, realizzante un controllo a distanza dei lavoratori, in violazione dell’art. 4 della L. n.
823
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
300/1970, in quanto avvenuto in assenza di accordo scritto con le rappresentanze sindacali o, in difetto, di autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro. Nel caso di
specie, il lavoratore, a seguito della declaratoria di illegittimità del recesso, era stato reintegrato nel proprio posto,
con conseguente condanna della società al risarcimento
del danno dalla data di estromissione e fino a quella di effettiva reintegrazione.
La decisione e i precedenti
Va anzitutto premesso che l’art. 4 della L. n. 300/1970, modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, dispone che impianti audiovisivi e altri strumenti da cui derivi anche il controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati
solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale e possono
essere installati dopo accordo con la RSU, le RSA o le associazioni sindacali (in difetto di accordo tali impianti e
strumenti possono essere installati su autorizzazione della
DTL o del Ministero). La stessa norma prevede che tale disposizione non si applica agli strumenti usati dal lavoratore
per rendere la prestazione e a quelli di registrazione degli
accessi e presenze; e, infine, che le informazioni raccolte ai
sensi di quanto sopra sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro purché sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del Codice della Privacy.
Orbene, nel ricorso la società evidenzia che il badge elettronico in dotazione ai dipendenti non configura un dispositivo rientrante nella previsione normativa, in quanto non
consente il controllo a distanza dell’attività lavorativa, ma
tale allegazione non è stata ritenuta fondata in quanto anche la rilevazione dei dati di entrata e uscita con un apparecchio predisposto dal datore, utilizzabile anche per il controllo dei doveri di diligenza (rispetto dell’orario di lavoro e
correttezza nell’esecuzione della prestazione), non concordata con il sindacato né autorizzata dalla DTL, si risolve in
un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul
quantum della prestazione, rientrante nella fattispecie ex
art. 4 della L. n. 300/1970.
Nel caso di specie, è stato accertato che il badge, con tecnologia RFID, consistente in un chip ivi contenuto e in un
lettore collegato in rete con l’ufficio del personale, consentiva la trasmissione on line, alla centrale operativa di tutti i
dati acquisiti con la lettura magnetica del badge del lavoratore, riguardanti non solo l’orario di entrata e uscita, ma
anche le sospensioni, i permessi, le pause, così realizzando
il controllo costante e a distanza circa l’osservanza dei dipendenti del loro obbligo di diligenza, sotto il profilo del rispetto dell’orario di lavoro.
In argomento si vedano: Cass. 27 maggio 2015, n. 10955,
in Foro it., 2015, I, 2316; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722,
in Mass. Giur. lav., 2012, 553; Cass. 23 febbraio 2010, n.
4375; in Riv. it. dir. lav., 2010, 3, II, 564; Cass. 1° ottobre
2012, n. 16622, in D&G, 2012, 2; Cass. 17 luglio 2007, n.
15892, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2008, II, 358, con nota di
A. Bellavista.
Carlo Alberto Giovanardi
“PISOLINO” SUL POSTO DI LAVORO E LICENZIAMENTO
Cassazione Civile, Sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9486 Pres. Napoletano - Rel. Esposito - P.M. Celentano
(conf.) - C.R. c. Società Autostrade per l’Italia S.p.a.
824
È legittimo il licenziamento per giusta causa intimato
nei confronti di un dipendente il quale, pur essendo addetto al pattugliamento notturno dell’autostrada, durante il turno di servizio sia stato sorpreso mentre era
intento a dormire in auto.
Il caso
Un lavoratore, adibito al pattugliamento notturno di un
tratto di autostrada, disposto dalla società concessionaria
allo scopo di intervenire in caso di necessità o di pericolo,
era stato sorpreso mentre dormiva all’interno dell’auto di
servizio. La società datrice di lavoro, ritenendo che tale
condotta, commessa nel pieno dell’orario di lavoro, costituisse totale inadempimento della prestazione lavorativa
affidata, procedeva - anche alla luce del fatto che l’interessato non era intervenuto neppure in seguito a una
chiamata da parte della centrale, condizionando altresì le
modalità di intervento del collega - al licenziamento per
giusta causa.
La Corte d’Appello di Ancona, con sent. del 22 gennaio
2013, ritenendo che la violazione che era stata accertata e
contestata fosse di gravità tale da giustificare l’immediato
recesso, modificando la decisione del tribunale, rigettava la
domanda del lavoratore e dichiarava legittima la risoluzione
del rapporto a seguito di licenziamento.
La decisione e i precedenti
Il lavoratore ricorre quindi davanti alla S.C., lamentando di
essere notoriamente diabetico e come, nonostante ciò, era
stato adibito a turni notturni, che egli non era mai incorso
in provvedimenti analoghi, riconducibili alle ipotesi di recidiva, o in altre sanzioni disciplinari, e infine che sarebbe
stato violato il principio di proporzionalità tra i fatti commessi e la sanzione disciplinare applicata.
Tutti tali motivi sono però stati disattesi dalla Cassazione,
la quale ha evidenziato - richiamando l’operato della Corte
d’Appello - come le modalità di commissione del fatto contestato apparissero significative di un inadempimento
preordinato e sistematico della obbligazione lavorativa;
nonché come si fosse trattato di un fatto della massima
gravità, in quanto tale di per sé solo idoneo a compromettere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro, non
potendosi attribuire qualsivoglia rilevanza alla considerazione della condotta tenuta dal lavoratore in epoca anteriore
ai fatti oggetto di giudizio.
Del pari, i giudici hanno ritenuto inconsistente il motivo
d’appello fondato sulla pretesa lesione del principio di proporzionalità, confermando quindi la decisione della Corte
territoriale, la quale aveva ritenuto che il fatto addebitato al
lavoratore fosse certamente idoneo a minare in radice il
rapporto fiduciario con la controparte, il che ha condotto al
rigetto del ricorso, alla convalida del provvedimento espulsivo e, infine, alla condanna del lavoratore al pagamento
delle spese di giudizio.
In tema di giusta causa di licenziamento si rimanda a:
Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743, in Dir. prat. lav., 2008,
39, 2242; Cass. 26 luglio 2011 n. 16283, in Mass. Giust.
civ., 2011, 7-8, 1117; Cass. 3 gennaio 2011 n. 35, ibidem,
1, 9; Cass. 15 novembre 2006, n. 24349, in questa Rivista,
2007, 5, 518; Cass. 7 luglio 2006, n. 15491, ibidem; 2007,
I, 85; Cass. 21 aprile 2005, n. 8305, ibidem, XI, 1087; Cass.
19 agosto 2004, n. 16260, ibidem, 2005, IX, 845; Cass. 23
agosto 2004 n. 16628, ibidem, 2005, 2, 182.
Carlo Alberto Giovanardi
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
TRASFERIMENTO E LICENZIAMENTO
Cassazione Civile, Sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8882 Pres. Amoroso - Rel. Riverso - P.M. Sanlorenzo (diff.) Farmaceutici Damor S.p.a. c. M.S.
In assenza di una disposizione normativa o contrattuale
che imponga al lavoratore di rendere nota in maniera
esplicita l’accettazione del proprio trasferimento ad altra sede, è illegittimo il licenziamento disciplinare disposto per siffatta ragione: a tal fine, all’invio del certificato medico di malattia non può essere attribuito il significato di rifiuto del trasferimento.
denza - entro i 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione
della relativa comunicazione.
In giurisprudenza si vedano: Cass. 22 marzo 2005, n. 6117,
in Dir. prat. lav., 2008, 24, 1425; Cass. 4 ottobre 2004, n.
19837, in Or. giur. lav., 2004, 943; Cass. 23 marzo 2012, n.
4709, in CED, 2012; Cass. 15 maggio 2004, n. 9290, in
Guida dir., 2004, 25, 65. Per ulteriori approfondimenti cfr.:
F. Rotondi: Dir. lav. e rel. Ind., Milano, 2014, 291.
Carlo Albero Giovanardi
PREVIDENZA
Il caso
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il
15 gennaio 2013, riformando la decisione del Tribunale di
Ascoli Piceno, accoglieva la domanda di annullamento del
licenziamento intimato a un lavoratore e condannava la società alla reintegrazione del dipendente nel proprio posto di
lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista
dall’art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, in misura pari
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, oltre a contributi e spese.
I giudici dell’appello avevano infatti stabilito che non esisteva alcun obbligo del lavoratore di comunicare al datore
l’accettazione del proprio trasferimento ad altra sede: nel
caso di specie, in mancanza di tale espressa accettazione
era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo per soppressione del posto. Non solo: secondo
la Corte territoriale, essendo il lavoratore caduto in malattia
dopo l’annunciato trasferimento, l’invio del certificato medico da parte sua, appunto dopo la richiesta del datore di
pronunciarsi sull’accettazione o meno del trasferimento,
aveva valore di accettazione dell’ordine di mutamento della
sede di lavoro.
La decisione e i precedenti
Contro la sentenza di secondo grado ricorre la società allegando, in particolare, l’esistenza di un obbligo di correttezza e buona fede del dipendente (ex artt. 1175 e 1375 c.c.),
consistente nell’obbligo di rispondere alla richiesta di accettazione o meno del trasferimento disposto da parte del
datore di lavoro. Tale prospettazione è stata però disattesa
dai supremi giudici, i quali hanno ritenuto che tale questione fosse assorbita, così come deciso in appello, dal valore
da attribuirsi al certificato di malattia inviato nel frattempo.
Proprio a tale proposito, la motivazione della sentenza in
commento evidenzia come il datore di lavoro, una volta ricevuto un atto che, come nel caso del certificato medico di
malattia, produce effetti sospensivi sul rapporto di lavoro,
prima di licenziare il dipendente, avrebbe potuto chiedere
espressamente a quest’ultimo di specificare la propria volontà in merito, ove residuassero dubbi sul suo proposito di
trasferirsi nella nuova sede all’esito della malattia, come
peraltro affermato dall’interessato già nella lettera di impugnazione del recesso.
In argomento merita rilevare come il novellato art. 2103 del
codice civile, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 3
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che il lavoratore
non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
Infine, va ricordato che, ai sensi dell’art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183, il trasferimento deve essere impugnato da parte del lavoratore dissenziente - a pena di deca-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
SUI PRESUPPOSTI DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
IN FAVORE DEL CONIUGE DIVORZIATO
Cassazione Civile, Sez. lav., 5 maggio 2016, n. 9054 Pres. G. Napoletano - Rel. A. Doronzo - P.M. M. Matera
(conf.) - INPS c. C.F.
In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, come consentito
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al
coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6,
una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui
valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini
della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei
confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere
che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori
pretese di contenuto economico e, in particolare, che
possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex
coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come
tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o
(in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.
Il fatto
Il giudice di appello confermava la condanna in primo grado dell’Inps al pagamento della pensione di reversibilità in
favore della coniuge divorziata del defunto già pensionato,
ritenendo che il diritto di abitazione in favore del coniuge
costituito in sede di scioglimento del matrimonio con contestuale rinuncia di quest’ultima all’assegno di mantenimento avesse funzione alternativa all’assegno di divorzio,
con la conseguente sussistenza del diritto alla pensione di
reversibilità. Contro questa decisione l’Inps ricorreva in cassazione, mentre controparte resisteva con controricorso.
La decisione e i precedenti
Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità tornano nuovamente ad occuparsi della condizione costituita
dalla percezione dell’assegno divorzile richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato. L’art. 9, comma 2, L. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 13 della L. 6
marzo 1987, n. 74, subordina infatti il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità alla sussistenza di tre
differenti condizioni: il mancato passaggio a nuove nozze,
l’origine del rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae
origine il trattamento pensionistico, che deve essere ante-
825
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
riore alla sentenza di divorzio e, infine, la titolarità dell’assegno di divorzio. Su tale ultimo requisito l’art. 5 della L. 28
dicembre 2005, n. 263 ha chiarito, con norma di interpretazione autentica, che le disposizioni di cui all’art. 9, commi
2 e 3, della l. n. 898 del 1970, “si interpretano nel senso
che per titolarità dell’assegno (...) deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n.
898 del 1970”.
Sul punto la Corte costituzionale ha ripetutamente chiarito
che la pensione di reversibilità assolve ad una funzione di
tipo solidaristico nei confronti del coniuge divorziato, il
quale “avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della
pensione i mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di
questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un
diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il
rapporto coniugale” (Corte cost. 4 novembre 1999, n. 419,
in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 198, con nota di Quadri;
Corte cost. 17 marzo 1995, n. 87, in Dir. fam., 1996, 13,
con nota di Frezza; Corte cost. 7 luglio 1988, n. 777, in Dir.
lav. 1988, II, 508).
Prima delle precisazioni contenute nell’art. 5 della L. n. 263
del 2005, la giurisprudenza di legittimità aveva invece discusso in ordine al fatto se fosse necessaria l’effettiva titolarità in concreto dell’assegno divorzile (in questo senso
l’orientamento maggioritario: Cass. 9 giugno 2011, n.
12546, in Foro it. 2011, I, c. 2697; Cass. 24 maggio 2007,
n. 12149; Cass. 5 agosto 2005, n. 16560, in Giur. it. 2006,
1369, con nota di Sgroi; Cass. 13 marzo 2006, n. 5422, in
Giust. civ. 2006, I, 1723; Cass. 27 novembre 2000, n.
15242, in Giur. it., 2001, 1111, con nota di Castagnaro) oppure se fosse sufficiente la titolarità in astratto dei relativi
requisiti pur in assenza del concreto godimento dell’assegno in forza di uno specifico provvedimento giudiziale (in
questo senso l’orientamento minoritario: Cass. 10 settembre 1990, n. 9309, in Foro it., 1991, I, 800; Cass. 12 novembre 1994, n. 9528, in Giust. civ., 1995, I, 943; Cass. 17 gennaio 2000, n. 457; Cass. 4 aprile 2001, n. 4925, in Mass.
Giust. civ., 2001, 685; Cass. 25 marzo 2005, n. 6429, in
questa Rivista, 2005, n. 7, 690).
L’art. 5 della L. n. 263 del 2005 ha risolto la questione,
chiarendo - come già detto - che per titolarità dell’assegno
deve intendersi il suo effettivo riconoscimento da parte del
tribunale. La norma non ha invece chiarito se alla titolarità
dell’assegno di divorzio possa essere equiparata - come
ammesso dal comma 8 dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970 la corresponsione di una somma di danaro una tantum o di
altra utilità diversa dalla erogazione periodica di una somma di danaro, o ancora dal trasferimento o dalla costituzione di un diritto, come l’usufrutto o l’abitazione. Secondo
l’orientamento maggioritario, il diritto alla pensione di reversibilità spetterebbe soltanto nel caso in cui, in sede di
regolamentazione dei rapporti economici al momento del
divorzio, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale una tantum, posto che
ove il tribunale, nel pronunciare la sentenza di divorzio, abbia ritenuto equa la corresponsione in una unica soluzione
della somma concordemente proposta, “emette un giudizio di definitiva composizione della questione, atteso l’accertato presupposto che la soluzione prescelta sia idonea
ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del
beneficiario del trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento” (così Cass. 30 dicembre 2015,
826
n. 26168, ord.; Cass., 8 marzo 2012, n. 3635, in questa Rivista, 2012, 509-510; Cass. 3 luglio 2012, n. 11088; Cass.
18 luglio 2002, n. 10458, in Foro it. 2003, I, 3278; Cass. 14
giugno 2000, n. 8113, in Corr. giur., 2000, 1312, con nota
di Liguori). In senso diametralmente opposto si sono invece pronunciate alcune decisioni, secondo le quali sarebbe
indifferente, ai fini della spettanza della pensione di reversibilità, la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione
anziché con versamenti periodici (Cass. 29 luglio 2011, n.
16744, in Giust. civ., 2012, I, 390; Cass. 5 agosto 2005, n.
16560, cit.) ovvero l’attribuzione dell’usufrutto sulla casa
coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione (Cass. 28 maggio 2010, n. 13108, in
Giust. civ., 2011, I, 2662).
La decisione in commento intende dare continuità al primo
degli orientamenti sopra esposti, ritenendo che il diritto
dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità ha uno dei suoi
necessari elementi genetici nella titolarità “attuale” dell’assegno, sicché solo nel caso in cui lo stesso benefici di una
erogazione economica a carico dell’ex coniuge al momento del decesso di costui, ha ragion d’essere - nella medesima prospettiva solidaristico-assistenziale - la sua sostituzione con la pensione di reversibilità (o di una sua quota), allo
scopo di continuare ad assicurare il sostentamento economico prima assicuratogli dal coniuge deceduto con l’assegno periodico di divorzio.
Giuseppe Ludovico
ERRONEO PROSPETTO CONTRIBUTIVO E RESPONSABILITÀ
DELL’INPS
Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016, n. 8604 Pres. P. Venuti - Rel. A. Doronzo - P.M. G. Servello (diff.)
- G.F. c. INPS
L’assenza di valore certificativo del prospetto contributivo, in quanto non emesso all’esito di un procedimento
amministrativo all’uopo specificamente avviato su richiesta formale dell’interessato, non costituisce causa
di esonero dalla responsabilità gravante sull’INPS nelle
ipotesi in cui contenga informazioni inesatte.
Il fatto
Il giudice di appello, confermando la decisione di primo
grado, respingeva la domanda proposta dall’assicurato di
condanna dell’INPS al risarcimento dei danni patiti a causa
della mancata percezione del trattamento pensionistico derivante dall’erronea comunicazione della sua situazione
contributiva. La Corte motivava la propria decisone, ritenendo che il semplice prospetto contributivo sul quale l’assicurato aveva fatto affidamento, non avesse valore certificativo ai sensi dell’art. 54 della L. n. 88 del 1989, trattandosi peraltro di un documento privo di indicazioni circa la data o la sottoscrizione del funzionario responsabile. Detto
prospetto peraltro risaliva al 2001, per cui il lavoratore ben
avrebbe potuto richiedere un nuovo estratto contributivo
con requisiti certificativi prima di accettare la risoluzione
del rapporto di lavoro. Contro questa decisione l’assicurato
ricorreva in cassazione, mentre l’INPS resisteva con controricorso.
La decisione e i precedenti
I giudici di legittimità sono stati ripetutamente chiamati a
pronunciarsi sulla responsabilità dell’Inps per erronee comunicazioni agli assicurati che trova fondamento nella pre-
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
visione di cui all’art. 54 della L. n. 88 del 1989 che impone
“agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva
dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi
alla propria situazione previdenziale e pensionistica”, disponendo altresì che “la comunicazione da parte degli enti
ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
Un costante orientamento dei giudici di legittimità ha chiarito, al riguardo, che la responsabilità dell’ente derivante
dalla violazione di tale disposizione ha natura contrattuale,
con conseguente applicazione delle regole in materia di riparto degli oneri probatori che impongono all’INPS la dimostrazione della non imputabilità dell’errore che ha causato il danno (tra le più recenti Cass. 27 gennaio 2014, n.
1659, in questa Rivista, 2014, 409; Cass. 1° marzo 2012, n.
3195; Cass. 16 gennaio 2012, n. 448, in questa Rivista, 2012, n. 4, 408; Cass. 30 marzo 2010, n. 7683, in
Mass. Giust. civ., 2010, 490; Cass. 10 febbraio 2010, n.
3023, in questa Rivista, 2010, n. 4, 409; Cass. 10 novembre
2008, n. 26925, in questa Rivista, 2009, n. 4, 413; Cass. 15
giugno 2005, n. 12823; Cass. 17 agosto 2004, n. 16044, in
questa Rivista, 2005, n. 1, 82; Cass. 24 aprile 2004, n.
7859, in Dir. lav e rel. Ind., 2005, 478, con nota di Rausei;
Cass. 17 dicembre 2003, n. 19340, in questa Rivista, 2004,
595; Cass. 24 gennaio 2003, n. 1104, in questa Rivista,
2003, n. 6, 578; Cass. 8 aprile 2002, n. 5002, in Mass. Giur.
lav., 2002, 599, con nota di Parise; Cass. 22 maggio 2001
n. 6995, in Mass. Giust. civ., 2001, 1034; Cass. 19 maggio
2001, n. 6867, ibidem, 1011; Cass. 18 novembre 2000, n.
14953, in Mass. Giust. civ., 2000, 2373, Cass. 8 novembre
1996 n. 9776, in Foro it., 1997, I, 1895; con riguardo all’applicabilità dell’art. 54 della L. n. 88 del 1989 anche agli enti
previdenziali con personalità giuridica di diritto privato
(Cass. 27 gennaio 2014, n. 1659, in questa Rivista, 2014, n.
4, 409; Cass. 1° marzo 2012, n. 3195, in Mass. Giust.
civ., 2012, 3, 249; Cass. 17 maggio 2003, n. 7743, inedita).
Altrettanto prevalente è risultato finora l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell’ente previdenziale e il conseguente diritto dell’assicurato al risarcimento del danno sarebbero esclusi ove l’errore sia contenuto in comunicazioni non richieste dall’assicurato, stante
il riferimento dell’art. 54 alle sole comunicazioni richieste
da quest’ultimo, ovvero nei casi in cui in dette comunicazioni siano presenti elementi che dovrebbero condurre l’assicurato ad approfondire i dati riportati senza riporre alcun
affidamento sulla loro correttezza (così Cass. 17 aprile
2014, n. 8972, in questa Rivista, 2014, 715; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28023; Cass. 8 novembre 1996, n. 9776,
in Foro it., 1997, I, 1895; Cass. 19 maggio 2001, n. 6867, in
Mass. Giust. civ., 2001, 1011; Cass. 22 maggio 2001, n.
6995, in Mass. Giust. civ., 2001, 1034; Cass. 17 dicembre
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
2003, n. 19340, in questa Rivista, 2004, 595; Cass. 28 marzo 2008, n. 8118, in Il civilista, 2008, n. 11, 24, con nota di
Cimatti; Cass. 30 marzo 2010, n. 7683, in Mass. Giust.
civ., 2010, 490; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1660, in Mass.
Giust. civ., 2012, 126).
Soltanto alcune sporadiche decisioni, contrapponendosi all’orientamento maggioritario, avevano ritenuto comunque
sussistente la responsabilità dell’INPS, facendo leva sull’affidamento riposto dall’assicurato nei confronti delle informazioni fornite dall’ente previdenziale, ritenendo la tutela
del legittimo affidamento “un principio generale tanto dell’ordinamento costituzionale interno, quanto del diritto e
dell’ordinamento comunitari” che ricorre “in qualunque
ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o
comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato” (Cass. 8 settembre 2015, n. 17773; Cass. 19 settembre 2013, n. 21454, in questa Rivista, 2013, n. 11,
1043; cfr. Cass. 1° marzo 2012, n. 3195, cit., che, con riguardo ad un ente previdenziale di diritto privato, ha ritenuto ugualmente meritevole di tutela l’affidamento dell’assicurato, pur non risultando applicabile l’art. 54, L. 9 marzo
1989 n. 88).
Con la decisione in commento i giudici di legittimità ritengono di doversi uniformare all’orientamento minoritario in
ragione del principio della tutela del legittimo affidamento
del cittadino che è immanente in tutti i rapporti di diritto
pubblico, ritenendo in tale logica che la mancanza di valore
certificativo del documento, in quanto non emesso all’esito
di un procedimento amministrativo specificamente avviato
su richiesta formale dell’interessato, non possa configurare
una causa di esonero dalla responsabilità gravante sull’INPS. La tutela del legittimo affidamento dell’assicurato
sarebbe tale in definitiva da giustificare la responsabilità
dell’ente in qualunque ipotesi in cui la pubblica amministrazione abbia fornito notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, anche ove
tali informazioni siano contenute in un documento - come
l’estratto conto assicurativo - che è privo di valore certificativo ai sensi dell’art. 47 della L. n. 88 del 1989.
Gli effetti di questo principio sono fortemente mitigati tuttavia dalla precisazione secondo la quale, pur escludendosi
in via generale l’obbligo dell’assicurato di verificare l’esattezza dei dati forniti dall’INPS, incombe al medesimo l’onere, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., di adottare una
condotta attiva o positiva idonea a limitare le conseguenze
dannose del comportamento inadempiente del debitore
per la cui valutazione la pronuncia in commento rinvia all’esame del giudice di merito.
Giuseppe Ludovico
827
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
Rassegna del merito
a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi
APPALTO
L’ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE AI FINI
DELLA CONFIGURABILITÀ DI UN’INTERPOSIZIONE ILLECITA
DI MANODOPERA
Tribunale di Firenze 27 aprile 2016 - Giud. Gualano T.C. c B.P.S. S.r.l. e N.P. S.p.a.
Sussiste un’interposizione illecita di manodopera tutte
le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del
committente una prestazione lavorativa rimanendo in
capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione,
pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità
della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una
reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Il caso
La ricorrente adiva il Tribunale di Firenze promuovendo un
ricorso nei confronti di due società, lamentando che fra le
stesse si fosse configurata un’ipotesi di somministrazione
irregolare/fraudolenta di manodopera e chiedendo conseguentemente la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti della società committente.
La ricorrente allegava, in particolare, di essere stata assunta con un contratto a tempo indeterminato con una delle
società resistenti ma di aver svolto sin da subito la propria
attività lavorativa a vantaggio dell’altra società resistente,
allegando tutta una serie di circostanze rilevatrici dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo
a quest’ultima, tra cui l’assoggettamento al controllo e alla
direzione dei dipendenti di tale società che impartivano delle direttive quotidiane per l’attività da svolgere, stabilendo
priorità e tempi di lavoro.
Entrambe le società si costituivano ritualmente in giudizio
contestando tutte le avversarie allegazioni e chiedevano il
rigetto del ricorso promosso dalla lavoratrice.
La decisione
Il Tribunale di Firenze ha evidenziato come i criteri distintivi
fra appalto lecito ed interposizione illecita siano ora previsti
dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, ossia, essenzialmente, l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio di impresa e
l’organizzazione, da parte del medesimo appaltatore, dei
mezzi necessari. Sicché, possono ritenersi leciti quegli appalti che, seppur espletati con prestazioni di manodopera o
con mezzi modesti, costituiscano un servizio a sé, svolto
con organizzazione e gestione autonoma da parte dell’appaltatore, con conseguente assunzione dei rischi economici, senza l’ingerenza del committente su tale organizzazione (specialmente con riferimento ai dipendenti dell’appaltatore).
Ciò posto, il Tribunale ha quindi ricordato il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura
un’ipotesi di interposizione illecita negli appalti tutte le volte in cui l’appaltatore non eserciti alcun ruolo decisivo nel-
828
l’organizzazione della prestazione lavorativa messa a disposizione del committente (che deve essere finalizzata alla
realizzazione di un risultato produttivo autonomo), limitandosi invece ai soli compiti di gestione amministrativa del
rapporto quali (ad esempio) la retribuzione dei dipendenti,
le loro ferie, ecc.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha appurato dall’istruttoria di causa che la lavoratrice avesse svolto la propria attività lavorativa nell’ambito di un contratto di appalto
intercorso fra le società resistenti ma che l’attività della ricorrente fosse stata di fatto assorbita nell’organizzazione
aziendale della società committente, essendo la società appaltatrice rimasta del tutto estranea allo svolgimento dell’attività lavorativa della lavoratrice.
Infatti, la ricorrente svolgeva la propria attività usufruendo
delle informazioni e dei dati consultabili dal sistema informatico della società committente. Un rilevante numero di
email tra di essa e i dipendenti della società committente
(sin dall’instaurazione del rapporto di lavoro) dimostravano,
inoltre, come quest’ultima esercitasse nei confronti della
lavoratrice un costante potere di direzione e controllo sull’attività e sulla tempistica di lavoro della lavoratrice medesima.
Il Tribunale di Firenze ha precisato che le suesposte evidenze sono state ulteriormente rafforzate anche dai prospetti
delle ore lavorate dalla ricorrente, dai quali è stato possibile
evincere il controllo della società committente sull’attività
lavorativa della lavoratrice.
Le considerazioni di cui sopra sono state considerate dal
giudice di merito talmente dirimenti dal rendere assolutamente marginali tutta una serie di circostanze dedotte avverso le richieste della ricorrente, tra cui il fatto che alla
medesima fosse stato consegnato un badge, l’account
email, l’orologio marcatempo e il codice di accesso diversi
rispetto a quello dei lavoratori dipendenti della società
committente.
Per tali motivi, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso
promosso dalla lavoratrice e ha conseguentemente dichiarato, ex art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003 la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società
committente e la ricorrente.
I precedenti
Cass., Sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6343, in Mass. Giust.
civ., 2013, secondo cui viene violato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro tutte le volte in cui l’appaltatore metta disposizione del committente delle prestazioni
di lavoro senza più esercitare, nei confronti di esse, alcun
potere di organizzazione della prestazione finalizzata alla
realizzazione di un risultato produttivo autonomo e limitandosi alla mera gestione amministrativa dei rapporti; Cass.,
Sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18922, in D&G online, 2012,
7 novembre, secondo cui si verifica un’interposizione illecita di manodopera tutte quelle volte in cui l’appaltatore si limiti a gestire amministrativamente i rapporti di lavoro coinvolti nell’appalto, restando privo di un apprezzabile potere
organizzativo delle prestazioni dei rapporti medesimi;
Cass., Sez. lav., 17 febbraio 2010, n. 3681, in Mass. Giust.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
civ., 2010, 2, 217, secondo cui nell’ambito di appalti endoaziendali, in cui la realizzazione di alcune attività del committente viene affidata ad un appaltatore esterno, si concretizza l’ipotesi di interposizione illecita di manodopera tutte
quelle volte in cui l’appaltatore resti privo di una reale organizzazione della prestazione e si limiti, viceversa, alla gestione amministrativa dei rapporti (retribuzione, pianificazione delle ferie, ecc.).
La dottrina
R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel
rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2008, 2, 129; R. De Luca Tamajo, Tra le righe del d. lgs. n. 276/2003 (e del decreto
correttivo n. 251/2004): tendenze e ideologie, in Riv. it. dir.
lav., 2004, 4, 521.
Filippo Collia
LAVORO SUBORDINATO
INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2,
L. N. 604/1966
Tribunale di Messina 9 giugno 2016 - Giud. Pavan Concetta Ciotto c. Gioielleria Francesco Sofia di Lucrezia Sofia e C. S.p.A.
Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare
in forma scritta il licenziamento, con la specificazione
dei motivi che lo hanno determinato, a pena di inefficacia dell’atto di recesso datoriale. Nei rapporti sottratti
al regime della tutela reale di cui all’art. 18 della L. n.
300 del 1970, il licenziamento inefficace per vizio formale ai sensi dell’art. 2 della L. n. 604/1966, non produce
effetti sulla continuità del rapporto di lavoro e non può
applicarsi la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 8
della L. n. 604/1966, che riguarda la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.
Vertendosi in materia di contratto a prestazioni corrispettive, l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla
continuità del rapporto di lavoro non può determinare il
diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace,
bensì solo il risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche eventualmente determinato tenuto
conto delle mancate retribuzioni.
Il caso
La lavoratrice, dipendete di una società che non integrava i
requisiti per l’applicazione dell’art. 18 Stat. lav., veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo.
Nella lettera di licenziamento il datore di lavoro non specificava le ragioni della risoluzione del rapporto limitandosi all’indicazione per cui il licenziamento era connesso ad una
riduzione di personale.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la dipendente chiedeva che
fosse accertata e dichiarata l’inefficacia del licenziamento
con conseguente condanna del datore di lavoro a ripristinare il rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione dalla data del licenziamento alla
re immissione in servizio.
La lavoratrice inoltre chiedeva la corresponsione di alcune
spettanze retributive maturate e non corrisposte.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle
domande.
La decisione
Il Giudice affronta e decide la vicenda facendo riferimento
alla disciplina dell’art. 2 della L. n. 604/1966, come novellato dalla L. n. 92/1912, in cui si prevede che il licenziamento
sia comunicato al dipendente unitamente all’indicazione
specifica delle motivazioni.
Nel caso di specie, in considerazione del testo delle lettera
di licenziamento, il Giudice ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito di specificità delle motivazioni di cui al
citato art. 2, L. n. 604/1966.
Avendo a mente tale carenza della lettera di licenziamento,
il Giudice determina la sua inefficacia a produrre la risoluzione del rapporto.
Sotto questo profilo, vertendosi in un’ipotesi in cui non era
applicabile l’art. 18 e quindi essendo esclusa la specifica
disciplina ivi prevista, il Tribunale richiama i principi civilistici in tema di contratti a prestazioni corrispettive condannando la società resistente a ripristinare il rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato nelle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito dal licenziamento
alla riammissione in servizio.
In particolare in ragione della dichiarata inefficacia per violazione dell’art. 2, L. n. 604/1966 il Tribunale esclude l’applicabilità dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 8, L. n.
604/1966 riservata all’ipotesi in cui il licenziamento non
fosse stato sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
I Precedenti
Successivamente alla novella del 2012 Trib. Roma 18 settembre 2014, in www.ilgiuslavorista.it, 21 maggio. Sulla tutela connessa all’inefficacia Cass., SS.UU., 27 luglio 1999,
n. 508, in Riv. it. dir. lav.; Cass. 30 agosto 2010, n. 18844,
in Mass. Giust. civ., 2010, 9, 1202; Cass. 18 maggio 2006,
n. 11670, in DL Riv. critica dir. lav., 2006, 3, 936; Cass. 18
agosto 2003, n. 12079, in Mass. Giust. civ., 2003, 7-8; Cass.
20 dicembre 2002, n. 18194, in Mass. Giust. civ., 2002,
2227.
Francesco Rotondi
L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI PREVENTIVA
CONTESTAZIONE NEL CASO DI REITERATI SPOSTAMENTI
DI RESIDENZA DEL LAVORATORE
Tribunale di Firenze 28 aprile 2016 - Giud. Torcini - E.C.
c A. S.r.l.
L’obbligo di preventiva contestazione, imposto dall’art.
7, comma 2, L. n. 300 del 1970 al datore di lavoro intenzionato ad adottare un provvedimento disciplinare contro il lavoratore, deve ritenersi soddisfatto - in virtù dei
doveri di correttezza e diligenza (artt. 1175 e 1176 c.c.)
gravanti su entrambe le parti del contratto obbligatorio
sinallagmatico - attraverso l’invio della contestazione
all’indirizzo del destinatario, senza che questi possa
contrapporre spostamenti reiterati e di breve durata.
Il caso
Il ricorrente adiva il Tribunale di Firenze allegando di aver
lavorato (con mansioni di cuoco) alle dipendenze della società convenuta con un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con una retribuzione che veniva successivamente ed illegittimamente ridotta dalla società me-
829
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
desima. Il lavoratore chiariva altresì che il rapporto professionale tra le parti si era progressivamente deteriorato e
che il medesimo era stato destinatario inizialmente di provvedimenti disciplinari e che il rapporto si era infine risolto
per l’illegittimo licenziamento del medesimo.
Il lavoratore precisava, in particolare, che il licenziamento
era da ritenersi illegittimo anche perché formalmente viziato, non essendo stata inviata la lettera di licenziamento
presso l’indirizzo del lavoratore medesimo tramite lettera
raccomandata.
La società resistente si costituiva ritualmente in giudizio
precisando, anzitutto, che il licenziamento fosse pienamente legittimo, essendosi i rapporti tra le parti deteriorati al
punto che fosse impossibile l’ulteriore prosecuzione del
rapporto di lavoro. La società medesima precisava, inoltre,
che il licenziamento fosse anche formalmente legittimo,
poiché essa aveva inviato la lettera di licenziamento presso
l’indirizzo del lavoratore conosciuto (che peraltro non si era
preoccupato di modificare in seguito ai suoi spostamenti).
Conseguentemente, la società resistente chiedeva il rigetto
del ricorso.
La decisione
Relativamente all’asserito vizio formale del licenziamento
lamentato dal lavoratore, quest’ultimo ha argomentato che
la società avrebbe ben potuto ricavare l’indirizzo corretto
cui inviare la lettera di licenziamento da quelli che erano indicati nelle giustificazioni presentate dal ricorrente avverso
le contestazioni disciplinari mossegli.
Il Tribunale di Firenze ha precisato, tuttavia, che tali argomentazioni spese dal lavoratore non sono condivisibili, poiché graverebbero il datore di lavoro di un peso che non gli
compete, ossia la ricerca e l’utilizzo dello strumento più
idoneo alla realizzazione degli effetti cui è destinata a produrre tale comunicazione. Viceversa, sempre secondo i giudici di merito, spetta (secondo i canoni di correttezza e diligenza ex artt. 1175 e 1176 c.c.) al lavoratore comunicare al
proprio datore di lavoro la variazione del proprio indirizzo.
Infatti, l’obbligo di preventiva contestazione di cui all’art. 7,
comma 2, L. n. 300/1970 può ritenersi soddisfatto, secondo i canoni di correttezza e diligenza di cui agli artt. 1175 e
1176 c.c. che gravano entrambe le parti del rapporto sinallagmatico, con l’invio di tale comunicazione all’indirizzo del
lavoratore conosciuto, senza che quest’ultimo possa eccepire i propri brevi e reiterati cambi di residenza. Tale principio può essere esteso anche alla consegna della lettera di
licenziamento, tant’è che il lavoratore avrebbe dovuto comunicare in modo chiaro al datore di lavoro il proprio cambio di residenza (essendo peraltro suo onere quello di fornire prova di non aver potuto avere conoscenza effettiva della lettera di licenziamento), senza che quest’ultimo fosse
tenuto a ricercarlo o a desumerlo dalle comunicazioni inviategli a giustificazione nei precedenti procedimenti disciplinari (le cui lettere di contestazione erano peraltro state
inviate al medesimo indirizzo di cui alle lettera di licenziamento contestata dal lavoratore).
Nonostante quanto suesposto con riferimento alla doglianza formale del licenziamento impugnato dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha comunque accolto le argomentazioni del lavoratore nel merito del provvedimento espulsivo.
La resistente non ha, infatti, fornito alcuna prova della veridicità della violazione addebitata al lavoratore e posta a
fondamento del licenziamento del medesimo e che, anzi,
dall’istruttoria è stato possibile desumere l’esistenza di un
clima particolarmente conflittuale tra le parti che ha lasciato presumere al giudice di merito che tale asserita violazio-
830
ne non fosse altro che un pretesto per espellere un lavoratore non più gradito.
Con riferimento all’unilaterale riduzione della retribuzione
del ricorrente, il Tribunale di Firenze ha appurato dall’istruttoria di causa che ciò fosse effettivamente avvenuto in
conseguenza dell’assunzione di una nuova cuoca da parte
della società resistente. Tale nuova assunzione aveva determinato, tuttavia, una diminuzione non concordata e non
giustificata dell’orario di lavoro e della retribuzione del ricorrente, con conseguente violazione del principio di immutabilità della retribuzione.
Conseguentemente, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore e ha condannato la società
resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria e delle
differenze retributive spettanti al ricorrente a causa dell’illegittima riduzione della retribuzione da parte della società
medesima.
I precedenti
Cass., Sez. lav., 10 agosto 2006, n. 18150, in Mass. Giust.
civ. 2006, 7-8, secondo cui è legittima la contestazione
dell’addebito recapitata presso il primo indirizzo fornito all’azienda, essendo irrilevanti e non conformi al principio di
diligenza i reiterati e ravvicinati spostamenti di residenza
del lavoratore.
La dottrina
M. Borzaga, I recenti orientamenti della Cassazione con riguardo alla regolarità della comunicazione degli addebiti disciplinari alla legittimità del licenziamento conseguentemente
irrogato, in Riv. it. dir. lav., 2009, 3, 570; M. Vinciguerra,
Sulla presunzione di conoscenza della comunicazione del licenziamento all’indirizzo indicato dal lavoratore ai fini della
reperibilità, in Riv. it. dir. lav., 2005, 4, 929.
Filippo Collia
LICENZIAMENTO ORALE E DIMISSIONI: RIPARTIZIONE
DELL’ONERE PROBATORIO
Tribunale di Firenze 24 marzo 2016 - Giud. Carlucci C.G.T. c. Azienda A.L.P. in persona del titolare R.F.
Nel procedimento avente ad oggetto il quomodo della
risoluzione del rapporto di lavoro, nell’alternativa tra licenziamento verbale e dimissioni, il giudice del merito
è tenuto ad una indagine accurata che tenga conto del
complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo l’art. 2697, comma 1, c.c. relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto da parte del ricorrente (licenziamento verbale), ma
anche il comma 2 relativo alla prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto da parte del convenuto (dimissioni). Di talché, in mancanza di dimostrazione delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito
della forma scritta del licenziamento, prescritta dalla
legge a pena di nullità, resta a carico del datore di lavoro.
Il caso
Il lavoratore ha proposto ricorso nei confronti dell’azienda
agricola datrice di lavoro chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento orale intimato con ogni
conseguenza reintegratoria e risarcitoria, condannare parte
convenuta al pagamento del TFR e di differenze retributive
maturate. Da ultimo il ricorrente chiedeva la condanna al
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Sintesi
versamento dei contributi previdenziali per tutta la durata
del rapporto di lavoro.
In particolare il ricorrente deduceva di avere lavorato alle
dipendenze della ditta individuale agricola per circa un anno per poi essere allontanato verbalmente.
Nell’ambito di detto periodo deduceva di avere svolto mansioni di autista addetto alla consegna dei prodotti alimentari, da inquadrarsi al livello A1 del CCNL Operi Agricoli.
Si è costituita l’azienda agricola resistente chiedendo il rigetto del ricorso. Sulla risoluzione la datrice di lavoro ha
contestato la ricostruzione dei fatti allegando di avere formulato una contestazione disciplinare il 26 aprile 2014 effettivamente ricevuta dal ricorrente. Sulle differenze retributive ha eccepito la decadenza dalla indicazione dei mezzi
istruttori.
RAPPORTO DI LAVORO
LA RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE
DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA PER LE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE VANTATE DAI LAVORATORI
Tribunale di Firenze 27 aprile 2016 - Giud. Torcini - L.D.
c. Circolo MCL e M.S.
Non è configurabile la responsabilità personale e solidale con l’associazione non riconosciuta del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell’associazione ove i relativi rapporti non siano stati instaurati (mediante stipulazione
dei relativi contratti) dal rappresentante medesimo.
Il caso
La decisione
Il tribunale di Firenze affronta preliminarmente il tema delle
differenze retributive considerando fondata la domanda nei
limiti delle differenze di retribuzione rigettando la richiesta
del TFR e ciò a motivo del riconoscimento dell’inefficacia
del licenziamento intimato oralmente.
Sul tema del licenziamento orale, il Tribunale richiama ai fini della propria decisione la giurisprudenza in tema di ripartizione dell’onere della prova del licenziamento orale e dell’eventuale prova di fatti modificativi ed estintivi del diritto
nel caso di specie rappresentati dalle dimissioni.
Sotto questo profilo il Tribunale statuisce che ove occorre
individuare le modalità di risoluzione del rapporto, nell’alternativa fra licenziamento verbale e dimissioni, si impone
un’indagine accurata da parte del giudice di merito, che
tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo
l’art. 2697, comma 1, c.c. relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto da parte del ricorrente (licenziamento verbale) ma anche il comma 2 relativo alla prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto da parte del convenuto (dimissioni).
In ragione di tale ripartizione dell’onere della prova, determina che in mancanza di dimostrazione delle dimissioni
“l’onere della prova che concerne il requisito della forma
scritta del licenziamento, prescritta per legge a pena di nullità, resta a carico del datore di lavoro, dal momento che
nella normativa limitativa dei licenziamenti la prova che
grava sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione
del rapporto di lavoro, mentre la prova delle dimissioni sostenute del datore, aventi valore di eccezione, grava sul
convenuto”.
Alla luce della citata impostazione il Tribunale accoglie le
domande del lavoratore sulla risoluzione del rapporto.
I precedenti
Cass. 5 maggio 2015, n. 8927, in D&G, 2015, 6 maggio;
Cass. 19 ottobre 2011, n. 21684, in Mass. Giust. civ., 2011,
10, 1482; Cass. 21 settembre 2011, n. 19236, in D&G online, 2011, 29 settembre; Cass. 27 agosto 2007, n. 18087, in
Mass. Giust. civ., 2007, 7-8; Cass. 20 maggio 2005, n.
10651, in Riv. it. dir. lav., 2006, 2, 454; Trib. Milano 30 aprile 2014; Trib. Arezzo 19 gennaio 2012; Trib. Bergamo 12
aprile 2006.
Francesco Rotondi
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
La ricorrente adiva il Tribunale di Firenze lamentando di
aver svolto, dall’ottobre 2012 al novembre 2013, l’attività di
barista presso il circolo resistente senza essere né regolarizzata né regolarmente retribuita, ricevendo unicamente
un importo fisso mensile. Conseguentemente, la ricorrente
chiedeva al Tribunale adito di accertare l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato fra la medesima ed il suddetto circolo e la condanna in solido del medesimo e del rispettivo legale rappresentante alle differenze retributive e
alla regolarizzazione previdenziale della lavoratrice.
Successivamente alla prima udienza, si costituiva unicamente il legale rappresentante del circolo, il quale contestava le avversarie pretese eccependo, in particolare, la
nullità della notifica effettuata nei suoi confronti, la prescrizione dei crediti della lavoratrice e comunque la propria carenza di legittimazione passiva, poiché non era più il legale
rappresentante del circolo in questione. Il circolo risultava
irreperibile.
La decisione
Pronunciandosi anzitutto sulle eccezioni preliminari sollevate dal legale rappresentante del circolo resistente, il Tribunale di Firenze ha precisato che l’omessa indicazione delle
ricerche sulla reperibilità del destinatario nella relata non
costituisce causa di nullità della notificazione, essendo comunque sufficiente che la notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. venga effettuata successivamente ed in forza dell’acquisizione della certificazione anagrafica attestante la residenza (soprattutto se il destinatario ha abbandonato l’originaria residenza senza curarsi di aggiornare le relative registrazioni anagrafiche).
Ciò posto, il giudice di merito ha ricordato che secondo
quanto disposto dall’art. 38 c.c., delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute rispondono personalmente e
solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e
per conto delle medesime. Tuttavia, tale responsabilità non
può che essere riconosciuta nei confronti di chi pone concretamente in essere l’atto negoziale da cui derivano tali
obbligazioni, sicché (con riferimento agli obblighi retributivi
dei lavoratori dipendenti) non può essere riconosciuta la responsabilità del legale rappresentante dell’associazione riconosciuta se egli non ha concretamente contribuito ad instaurare i rapporti di lavoro da cui derivano le pretese avanzate in giudizio. In altri termini, non è la mera titolarità della
carica che comporta la responsabilità personale e solidale
di cui all’art. 38 c.c., bensì la concreta attività negoziale posta in essere e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’associazione non riconosciuta e terzi.
831
Sinergie Grafiche srl
Giurisprudenza
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
Nel caso di specie, il legale rappresentante del circolo non
ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro lamentato dalla
lavoratrice, ma è stato altresì appurato che egli non era
mai intervenuto né nell’instaurazione del rapporto di lavoro
della ricorrente né nella sua successiva cessazione.
In applicazione dei suesposti principi (e considerando che il
circolo ha, nel frattempo, provveduto alla regolarizzazione
contributiva della ricorrente), il Tribunale di Firenze ha respinto le domande della ricorrente e ha disposto l’integrale
compensazione delle spese di lite.
I precedenti
Cass., Sez. lav., 11 maggio 2004, n. 8919, in Mass. Giust.
civ. 2004, 5, secondo cui il rappresentante di un’associazione non riconosciuta non può essere chiamato a rispondere personalmente e solidalmente con l’associazione medesima per gli obblighi retributivi dei rapporti di lavoro che
non siano stati instaurati dal rappresentante medesimo;
Cass., Sez. III, 29 dicembre 2011, n. 29733, in Mass. Giust.
832
civ., 2011, 12, 1890, secondo cui nell’ambito delle associazioni non riconosciute la responsabilità personale grava
esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione medesima, senza che l’eventuale
successione di cariche comporti alcuna successione del
debito in capo al soggetto subentrante; Cass. Sez. III, 24
ottobre 2008, n. 25748, in Riv. not., 2010, 2, 456, secondo
cui la responsabilità personale e solidale di chi agisce in
nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è
connessa alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, derivando invece dall’attività negoziale concretamente posta in essere per conto di essa.
La dottrina
L. D’Amelio, Sul fondamento dell’art. 38, seconda parte,
cod. civ., in Riv. not., 2010, 2, 460.
Filippo Collia
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Sintesi
Novità legislative
ed amministrative
a cura di Alessia Muratorio
Attività ispettiva
CHIARIMENTI IN ORDINE AL REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE IN CASO DI “DISCONOSCIMENTO”
DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA EFFETTUATA IN REGIME DI TRASFERTA
Messaggio INPS 16 giugno 2016, n. 2862
L’INPS è tornata a fornire chiarimenti in materia di sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riferimento all’applicazione della
sanzione di infedele registrazione sul LUL (Libretto Unico Lavoro), riprendendo la nota della Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche prot. n. 11885 del 14 giugno 2016. In essa vengono premessi i richiami in generale alle ipotesi in cui la condotta di infedele registrazione è integrata da scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro; si è altresì ribadito che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione
o compenso corrisposti. In relazione alla non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, la fattispecie si può configurare tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato
abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo. Tale difformità si configura sicuramente nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti
ad altro titolo, con fine evidentemente elusivo. Qualora, invece, il personale ispettivo riscontri che sotto la voce
trasferta siano state erogate somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti, la difformità rilevata, oltre a determinare l’applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, comporta la registrazione di
un dato - la voce trasferta - che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base
delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro. Il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione quindi ove la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa, sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che non trovi
riscontro nella concreta esecuzione della prestazione. Occorre però sempre che dall’infedele registrazione sul
LUL derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
Depenalizzazione
LA DEPENALIZZAZIONE PARZIALE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
NEI CHIARIMENTI INPS
Circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121
Dopo il Messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, l’INPS è tornata sulla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali per chiarire il nuovo quadro normativo (D.Lgs. n. 8/2016, attuativo della
L. n. 67/2016; art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, L. n. 638/1983), alla luce delle
indicazioni fornite dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro (nt. 3 maggio 2016,
prot. 29/0002839/P). Il testo originario della norma, infatti, puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’INPS. L’evidente appesantimento del carico
di lavoro degli organi giudiziari ha determinato il legislatore a riscrivere la norma che, nella versione attuale, opera
un distinguo legato al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino
a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui. Diversamente, se l’importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si
applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, fattispecie dequalificata in illecito
amministrativo. La previsione di non punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi permane, applicando la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. Ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui l’INPS precisa che l’arco temporale di riferimento per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
833
Sinergie Grafiche srl
Normativa
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
il 31 dicembre di ciascun anno civile. Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della
Gestione Separata nonché i datori di lavoro agricoli, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia
sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 6 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Pertanto, il valore soglia sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo
in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell’omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia.
Ai fini della gestione di tali atti, prima di procedere alla notifica della violazione, per ciascuna annualità dovrà essere accertato se nei confronti del medesimo responsabile, avuto riguardo alla posizione contributiva aziendale
contraddistinta dal medesimo codice fiscale, esistano ulteriori atti relativi a procedimenti penali distinti ma relativi
al medesimo anno oggetto di lavorazione. L’INPS procederà anche a verificare se, al momento della trasmissione
degli atti, siano in corso accertamenti per omissioni non riconducibili alle denunce già effettuate e oggetto di trasmissione da parte dell’Autorità giudiziaria: una volta completata l’attività di cancellazione di ciascuna denuncia
oggetto di trasmissione da effettuare, solo all’esito della verifica le Sedi potranno procedere con atti distinti per
ciascun anno considerato e secondo i procedimenti di seguito descritti, alla notifica dell’accertamento dell’avvenuta violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio; entro trenta giorni dalla notifica, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione; entro tre mesi dovrà avvenire il versamento delle ritenute omesse. L’assenza del pagamento nei termini assegnati
consentirà l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’annualità considerata l’importo di euro 10.000, seppure l’illecito assuma in tali casi rilevanza penale, si dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.
Disabili
L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ NEI RECENTI CHIARIMENTI DELL’INPS
Circolare INPS 13 giugno 2016, n. 99
A seguito delle modifiche introdotte all’art. 13, L. n. 68/1999 dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS. La richiesta di fruizione
deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. L’Istituto, a seguito dell’inoltro delle domande di autorizzazione alla fruizione del beneficio effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e
la disponibilità di risorse. Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante
l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore
di lavoro mediante conguaglio nelle denunce con Il beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate. In breve, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore. L’incentivo può essere legittimamente fruito per l’assunzione di lavoratori disabili
che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; i lavoratori disabili che
abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle menzionate tabelle; i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1°
gennaio 2016, ovvero per le forme associative, il lavoro a domicilio, le assunzioni a tempo indeterminato a scopo
di somministrazione. Misura e durata dell’incentivo sono parametrati al grado di disabilità riscontrato, ferme restando le consuete condizioni per l’utilizzo (ad esempio l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli altri obblighi di legge ecc.). In ragione della
più volte richiamata finalità di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa
delle persone disabili nel mondo del lavoro, nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di disabili, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro può godere per il medesimo lavoratore di entrambi i benefici purché la misura complessiva degli incentivi non superi la misura del 100% dei costi
salariali. L’INPS ne fornisce in conclusione le indicazioni operative per il godimento.
834
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Sinergie Grafiche srl
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Sintesi
Malattia
GLI INDIRIZZI OPERATIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE ESENZIONI
DALLA REPERIBILITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95
Con propria circolare, l’INPS ha fornito gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle
esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato, allegando altresì le linee guida per l’individuazione
delle patologie che danno diritto agli esoneri. In breve, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; ovvero connessa a stati patologici sottesi o connessi
a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. I lavoratori interessati sono quelli con
contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi i lavoratori iscritti alla gestione
separata dell’INPS. Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, le linee guida elaborate dall’INPS e dal Ministero sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una
delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita”/“invalidità”; nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità
cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini dell’esclusione del
lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’INPS e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di
eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità. L’INPS ha già provveduto ad effettuare le modifiche procedurali finalizzate a recepire, nell’ambito del flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, le informazioni che consentono di selezionare i certificati relativi alle patologie esonerative.
Pensioni
IL RICONOSCIMENTO E LA SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN FAVORE DEI FIGLI
STUDENTI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA
Messaggio INPS 21 giugno 2016, n. 2757
L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento ed alla sospensione del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio (c.d. periodo di vacatio studii), ovvero nel periodo di svolgimento di attività lavorativa. In particolare si legge che il figlio superstite o
equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota
di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed
il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati. Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da
quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
Quanto al periodo di attività, Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività
lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti. Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della
morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non
ha diritto alla pensione ai superstiti. Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo
da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione. Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione,
dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti. In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca
del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento
pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo
di svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di
pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
835
Sinergie Grafiche srl
Normativa
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Sintesi
Sostegno al reddito
LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CIGO ED IL NUOVO PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE
Messaggio INPS 1° luglio 2016, n. 2908
Prima della pubblicazione di una circolare sul piano interpretativo e sotto il profilo applicativo dei contenuti del
D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 circa i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale
ordinaria, l’INPS è intervenuta per fornire le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria. Il nuovo procedimento di concessione resta competenza esclusiva delle sedi
INPS, con riguardo alla concessione della prestazione cui segue la soppressione delle Commissioni provinciali CIGO; fondamentale è l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande. I criteri
fissati dal decreto derivano da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai
requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse: resta il criterio di brevità di durata e di transitorietà.
Ai fini della concessione della CIGO, l’azienda deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa
come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente. L’INPS ha facoltà di richiedere
un supplemento istruttorio con richiesta anche d’integrazione della documentazione ai fini procedimentali. Anche
la richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria,
poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza. L’INPS
sottolinea che, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di
supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione
temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di
appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande. Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento
che hanno determinato l’INPS all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività. La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016; per le domande
presentate dal 29 giugno non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale. Per le domande presentate precedentemente, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame
ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio.
836
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/
00134998_2016_08-09_0837.3d
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
il Lavoro nella giurisprudenza
Indici
INDICE DEGLI AUTORI
22 marzo 2016, n, n. 5592 ...............................
1 aprile 2016, n. 6373 .....................................
Angiello Luigi
La comunicazione dell’esclusione del socio-lavoratore nelle cooperative........................................
22 aprile 2016, n. 8180 ...................................
2 maggio 2016, n. 8594 ..................................
789
Collia Filippo
Rassegna del merito.......................................
4 maggio 2016, n. 8881 ..................................
828
De Michele Vincenzo
Le spese di giustizia nel giusto processo del lavoro
tra legge e prassi ministeriale............................
757
753
757
808
817
Guarnieri Guerino
Rassegna della Cassazione...............................
817
Izzi Daniela
Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale ..........................
748
Tribunali
830
Firenze 27 aprile 2016.................................... 828; 831
Firenze 28 aprile 2016.....................................
829
Messina 9 giugno 2016...................................
829
Normativa e prassi
Circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95....................
Messaggio Inps 16 giugno 2016, n. 2862 .............
Messaggio Inps 21 giugno 2016, n. 2757 .............
817
Messaggio Inps 1 luglio 2016, n. 2908.................
Circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121 ....................
Miscione Michele
La fine del precariato pubblico ma non solo per la
scuola ........................................................
26 maggio 2016, n. 10950 ...............................
Circolare INPS 13 giugno 2016, n. 99 ..................
Ludovico Giuseppe
Rassegna della Cassazione...............................
20 maggio 2016, n. 10536 ...............................
Firenze 24 marzo 2016....................................
Giovanardi Carlo Alberto
Rassegna della Cassazione...............................
13 maggio 2016, n. 9904 .................................
30 maggio 2016, n. 11126 ...............................
Garofalo Carmela
Il mobbing attenuato: lo straining .......................
10 maggio 2016, n. 9486 .................................
16 maggio 2016, n. 10020 ...............................
Galleano Sergio
Le spese di giustizia nel giusto processo del lavoro
tra legge e prassi ministeriale............................
4 maggio 2016, n. 8882 ..................................
5 maggio 2016, n. 9054 ..................................
Frediani Marco
Dimissioni, nuova forma smaterializzata ad substantiam e diritto al ripensamento............................
2 maggio 2016, n. 8604 ..................................
794
784
820
777
826
818
825
825
824
823
822
817
822
821
835
834
833
835
836
833
745
Muratorio Alessia
Novità legislative ed amministrative ....................
833
INDICE ANALITICO
779
Appalto
Nunin Roberta
Indennità di maternità e diritti del padre avvocato....
Pistore Giovanna
Interposizione illecita di manodopera
Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile: nodi irrisolti e spunti di riflessione ..........
L’attività dell’appaltatore ai fini della configurabilità di
un’interposizione illecita di manodopera (Tribunale di
Firenze 27 aprile 2016)....................................
764
Romeo Carmelo
L’epilogo in tema di repechage e onere probatorio ..
799
Rotondi Francesco
Rassegna del merito.......................................
828
Treglia Giorgio
Rassegna della Cassazione...............................
817
828
Controversie del lavoro
Ctu
Discrezionalità del giudice nel disporre la rinnovazione della Ctu (Cassazione Civile, Sez. lav., 4 maggio
2016, n. 8881) ..............................................
818
Danno da demansionamento
Danno da demansionamento e sindacato della Cassazione sulle massime d’esperienza adottate dal giudice di merito (Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 maggio 2016, n. 10536) ........................................
INDICE CRONOLOGICO
DEI PROVVEDIMENTI
Onere della prova
Giurisprudenza
Cassazione Civile
19 febbraio 2016, 3291 ...................................
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
817
803
L’epilogo in tema di repechage e onere probatorio
(Cassazione Civile, Sez. lav., 22 marzo 2016, n.
5592), commento di Carmelo Romeo ..................
794
837
ABCompos - 3B2 v. 11.0.3108/W Unicode-x64 (Dec 17 2013) - {A_LEGALE}0912_16-LAGI8-9/
00134998_2016_08-09_0837.3d
Numero Demo
il Lavoro nella giurisprudenza
- Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Indici
Responsabilità ente previdenziale
Prova testimoniale
Ancora sui limiti soggettivi alla prova testimoniale
(Cassazione Civile, Sez. lav., 22 aprile 2016, n. 8180)
820
Spese di giustizia
Le spese di giustizia nel giusto processo del lavoro
tra legge e prassi ministeriale, di Vincenzo De Michele e Sergio Galleano ...................................
757
Precariato nella scuola
La fine del precariato pubblico ma non solo per la
scuola, di Michele Miscione .............................
Associazione non riconosciuta
777
Lavoro subordinato
La responsabilità del rappresentante dell’associazione non riconosciuta per le differenze retributive vantate dai lavoratori (Tribunale di Firenze 27 aprile
2016) .........................................................
831
Età pensionabile
Dimissioni
753
Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile: nodi irrisolti e spunti di riflessione, di Giovanna Pistore ...............................................
Licenziamento
Licenziamento discriminatorio
Badge, controllo a distanza e licenziamento (Cassazione Civile, Sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904) .....
823
Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale, di Daniela Izzi........
Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazionale, di Daniela Izzi ........
748
Società cooperative
829
La comunicazione dell’esclusione del socio-lavoratore nelle cooperative (Cassazione Civile, sez. lav, 1
aprile 2016, n. 6373), commento di Luigi Angiello ...
Inefficacia del licenziamento per violazione art. 2, L.
n. 604/1966 (Tribunale di Messina 9 giugno 2016) ...
745
Rapporto di lavoro
Tutela della paternità
Dimissioni, nuova forma smaterializzata ad substantiam e diritto al ripensamento, di Marco Frediani .....
826
Pubblico impego
Lavoro autonomo
Indennità di maternità e diritti del padre avvocato
(Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016, n.
8594), commento di Roberta Nunin ....................
Erroneo prospetto contributivo e responsabilità dell’INPS (Cassazione Civile, Sez. lav., 2 maggio 2016,
n. 8604)......................................................
L’assolvimento dell’obbligo di preventiva contestazione nel caso di reiterati spostamenti di residenza
del lavoratore (Tribunale di Firenze 28 aprile 2016)...
829
Licenziamento disciplinare e doveri di verifica del
giudice (Cassazione Civile, Sez. lav., 26 maggio
2016, n. 10950).............................................
822
Licenziamento orale e dimissioni: ripartizione dell’onere probatorio (Tribunale di Firenze 24 marzo 2016)
830
‘‘Pisolino’’ sul posto di lavoro e licenziamento (Cassazione Civile, Sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9486) ..
824
Trasferimento e licenziamento (Cassazione Civile,
Sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8882) ......................
825
Vendita di prodotti on line durante l’orario di lavoro
ed insussistenza di una giusta causa di recesso
(Cassazione Civile, Sez. lav., 16 maggio 2016, n.
10020) .......................................................
822
764
748
784
Straining
Il mobbing attenuato: lo straining (Cassazione Civile,
Sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3291), commento di
Carmela Garofalo...........................................
803
Trasferimento del lavoratore
Trasferimento del lavoratore ed esigenze dell’impresa (Cassazione Civile, Sez. lav., 30 maggio 2016, n.
11126) .......................................................
821
Previdenza
Pensione di reversibilità
Sui presupposti della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato (Cassazione Civile, Sez.
lav., 5 maggio 2016, n. 9054) ............................
838
825
il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2016
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
itinera
GUIDE GIURIDICHE IPSOA
LAVORO
La guida affronta, con taglio pratico, tutti gli istituti di
diritto del lavoro e sindacale, evidenziando gli aspetti
maggiormente interessati dal contenzioso.
Partendo dall’ inquadramento generale della disciplina
normativa, sono poste in rilievo le questioni interpretative
dando ampio spazio alla casistica giurisprudenziale e ai
casi pratici.
La guida è aggiornata con i decreti attuativi del D.L.
n. 34 del 20/03/2014, convertito nella Legge n. 78 del
a cura di
16/05/2014 e ribattezzato Jobs Act. Un dovuto richiamo è
GIACINTO FAVALLI
Studio TRIFIRÒ AND PARTNERS
stato fatto anche al D.D.L. sul lavoro autonomo (c.d. Jobs
Pagine: 1472 - cod. 00201535
Il volume è corredato da clausole contrattuali, esempi,
€ 90,00
Act autonomi), datato 22/01/2016.
schemi riepilogativi e segnalazioni bibliografiche per
ulteriori approfondimenti. Un dettagliato indice analitico
Acquista
su www.shop.wki.it
Y94ESCL.indd 1
Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città
Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie
Contattaci
02.82476.794
[email protected]
Y94ESCL
rende la consultazione estremamente efficace.
18/04/16 12:32
Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
TRATTATO DI DIRITTO DEL LAVORO
diretto da
Mattia Persiani e Franco Carinci
Acquista
su www.shop.wki.it
Y76ES_CL.indd 1
Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città
Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie
Contattaci
02.82476.794
[email protected]
Y76ESCL
OGNI VOLUME DEL TRATTATO SI AVVALE
DI UNA PLURALITÀ DI APPROCCI E DI METODI
PER «RECUPERARE A SISTEMA
IL DIRITTO VIVENTE DEL LAVORO»
22/03/16 11:14