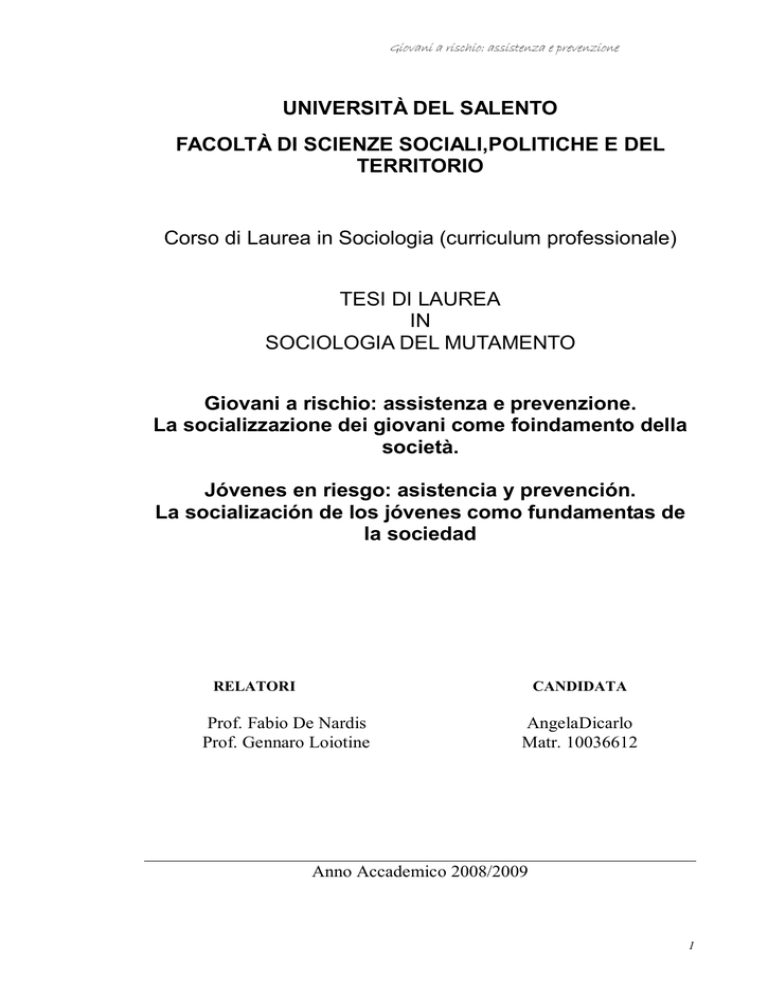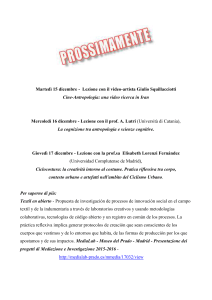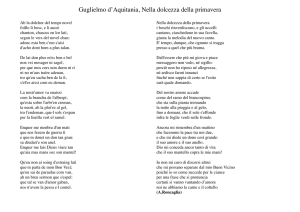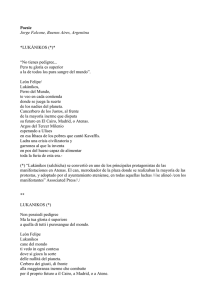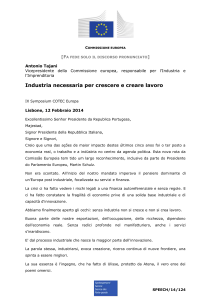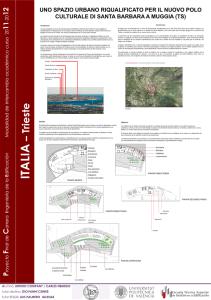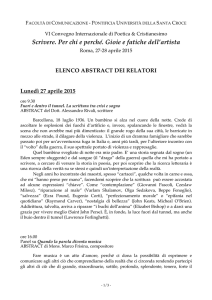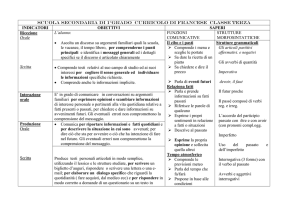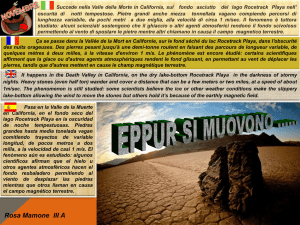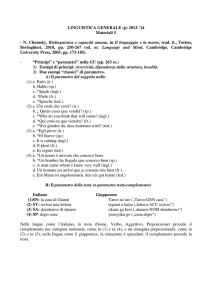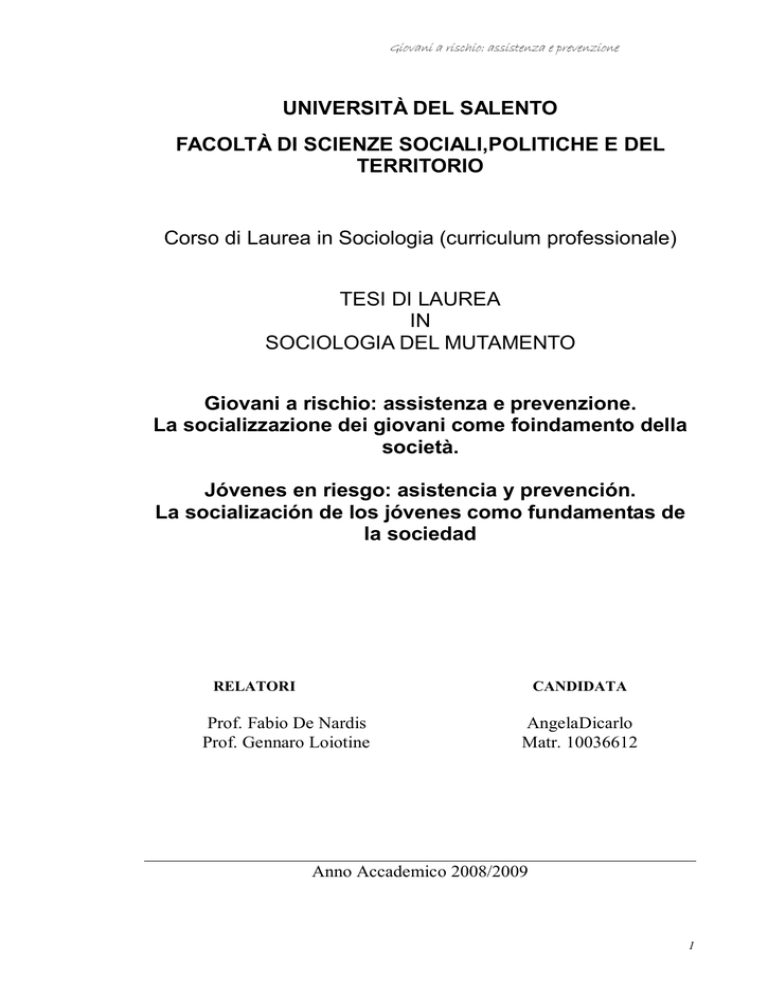
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
FACOLTÀ DI SCIENZE SOCIALI,POLITICHE E DEL
TERRITORIO
Corso di Laurea in Sociologia (curriculum professionale)
TESI DI LAUREA
IN
SOCIOLOGIA DEL MUTAMENTO
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione.
La socializzazione dei giovani come foindamento della
società.
Jóvenes en riesgo: asistencia y prevención.
La socialización de los jóvenes como fundamentas de
la sociedad
RELATORI
CANDIDATA
Prof. Fabio De Nardis
Prof. Gennaro Loiotine
AngelaDicarlo
Matr. 10036612
Anno Accademico 2008/2009
1
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
INDICE
Introducciòn (E); 2 / Introduzione (I); 5
Capitolo 1
I giovani e l’integrazione sociale
1.1 La formazione dell’identità; 7
1.2 Il processo di integrazione dei giovani; 10
1.3 La formazione flessibile; 13
Capitolo 2
La tutela dei giovani. Assistenza o Prevenzione?
2.1 Dal “giovane oggetto di tutela” ai “giovani soggetti del
diritto”; 16
2.2 Il piano della prevenzione: l’esempio del “Centro Allegra
Compagnia di Mesagne”; 19
2.3 El plan de la asistencia: el ejemplo de la “Asociaciòn
Mensajeros de la Paz de Madrid”; 45
2.4 Analogías y diferencias entre España e Italia (E); 54
2.4 Analogie e differenze tra Spagna e Italia (I); 59
Conclusiones (E); 64 / Conclusioni (I); 66
Bibliografia; 68
Appendice (Apèndiz); 69
2
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Introducción (E)
Cuando cierto discurso empeza con “Los jovenes de hoy...”, la mayoria de las
veces no augura nada bueno.
Cuando un joven viene envuelto en un echo que no se refleja en la normalidad
se tiende a culparlo sin preguntarse sobre el porquè este habria tomado aquel
comportamiento.
No es mi intención defender estos actos ilícitos pero querría sólo fijar la
atención sobre el echo que detrás de cada acción, lícita o no, hay siempre una
marea de situaciones que han llevado el joven a asumir aquel comportamiento,
situaciones que caracterizan el ambiente en el que él ha crecido. Entonces si
quisiéramos verdaderamente solucionar el problema, antes de pensar en las
distintas maneras de punir al joven que ha cometido aquel echo no lícito,
tendriamos que preocuparnos de reparar el ambiente en el que ha vivido,
estudiar su historia e intentar contestar a sus particulares necesidades de
manera que pueda ser reinsertado en la sociedad y no resulte estigmatizado o
marginado; esto comportaría problemas aún más complicados, por ejemplo:
si ya un joven no es capaz de socializar con sus compañeros de clase ¿cómo
podemos pensar que este mismo joven pueda en el futuro relacionarse con
otros chicos que provienen de otros paises, con culturas distintas,etc?; además
si este fenómeno lo mutlplicamos por un millón podrían surgir problemas
serios como la intolerancia a otras religiones, el razismo, la xenofobia,...
Es importante intentar solucionar los que hoy resultan ser pequeños problemas
pues si se descuidan podrían prejudicar la marcha y la organización da la
sociedad entera. Entonces para que los individuos puedan integrarse de
manera mejor a la sociedad no sólo es necesario imponerles unas reglas, sino
también es importante obrar de modo que se adapten espontáneamente a la
sociedad ya desde jovenes; y todo esto es posible sólo si se piensa en los
jóvenes en su concreteza y si se ofrece asistencia relacionada con sus
particulares exigencias particulares.
3
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Además de todo esto si quisiéramos tutelar los jóvenes de manera más
completa tendríamos que desarrollar el plan de asistencia sin olvidar aquel de
la prevención que prevé la reparación del ambiente en el que estos viven.
Propio para esto introduciré mi experiencia en el “Centro Allegra Compagnia
di Mesagne” que se sitúa en el plano de la prevención y en la “Asociación
Mensajeros de la Paz” de Madrid que principalmente actúa en el plano de la
asistencia, introduciéndose también poco a poco en el de la prevención, ambos
con el objetivo de permitir una sana formación y educación de los chicos, para
que los jovenes puedan hacer frente a los obstáculos de la vida y construir el
fundamento de la sociedad.
4
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Introduzione (I)
Quando un certo discorso ha inizio con “I giovani d’oggi…”,la maggior parte
delle volte non preannuncia niente di buono.
Quando un giovane viene coinvolto in un fatto che non rispecchia la normalità
si tende a dargli la colpa senza interrogarci sul perché questo abbia assunto
quel comportamento.
Non è mia intenzione difendere questi atti illeciti ma vorrei solo porre
l’attenzione sul fatto che dietro ad ogni singola azione che sia lecita o no c’è
sempre una marea di situazioni che hanno indotto il giovane ad assumere quel
comportamento, situazioni che caratterizzano l’ambiente in cui questo è
cresciuto. Quindi se volessimo realmente risolvere il problema, prima di
pensare ai mille modi per punire quel giovane che ha commesso quel fatto
illecito, dovremmo preoccuparci di risanare l’ ambiente in cui ha vissuto,
studiare la sua storia e cercare di rispondere ai suoi particolari bisogni in
modo che possa essere reinserito nella società e non stigmatizzato e in seguito
emarginato; questo comporterebbe problemi sempre più complessi, per
esempio: se già un giovane non è in grado di socializzare coi suoi compagni di
classe come possiamo pensare che questo stesso giovane possa in futuro
relazionarsi con altri ragazzi provenienti da altri paesi, con culture
differenti,…; se poi questo fenomeno lo moltiplichiamo per un milione
potrebbero iniziare problemi seri come l’intolleranza verso le altre religioni, il
razzismo, la xenofobia.
È importante cercare di risolvere quelli che oggi risultano essere piccoli
problemi perchè se trascurati potrebbero pregiudicare l’andamento e
l’organizzazione dell’intera società. Quindi affinché gli individui possano
integrarsi al meglio nella sociètà non è solo necessario imporre loro delle
regole ma è importante fare in modo che si adattino spontaneamente alla
società fin da giovani; e ciò è possibile solo se si pensa ai giovani nella loro
concretezza e si offre assistenza in base alle loro particolari esigenze.
5
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
E inoltre se volessimo tutelare i giovani in maniera più completa dovremmo
sviluppare si il piano dell’assistenza ma senza dimenticare quello della
prevenzione che prevede il risanamento dell’ambiente in cui questi vivono.
A questo proposito introdurrò la mia esperienza presso il “Centro Allegra
Compagnia” di Mesagne che si colloca sul piano della prevenzione e la
“Asociaciòn Mensajeros de la Paz” di Madrid che si colloca principalmente
sul piano dell’assistenza ma che poco a poco sfocia in quello della prev,
entrambi con l’ obiettivo di permettere una sana formazione ed educazione dei
ragazzi, per far si che i giovani possano superare gli ostacoli della vita e
costituire il pilastro della società.
6
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Capitolo 1
I giovani e l’integrazione sociale
1.1 La formazione dell’identità
Tutta la storia del pensiero sociologico si è aggirata attorno alla relazione che
lega l’individuo alla società cercando di trovare un nesso capace di spiegare i
vari fenomeni che hanno avviato il mutamento continuo della società e
cercando di stabilire quanto la società sia in grado di influenzare la
formazione dell’individuo.
Esistono varie teorie circa la formazione dell’identità dell’individuo e ognuna
di queste si distingue dall’altra a seconda di quale fattore sociale influenzi
l’individuo, ossia a seconda di quanto la società orienti l’agire individuale.
Tra le tante teorie rientra quella di Parsons1 che distingue tra “la struttura dei
codici”(ossia i valori della società) e “la personalità individuale”; l’identità
non agisce, ma controlla il processo d’azione, mettendo in relazione quelli che
sono i valori della società e quelli dell’individuo creando un sistema unitario e
condiviso di valori. Poi quella di Turner2 che distingue tra “l’immagine di
sé”(ossia come la società ci definisce in ogni situazione che ci coinvolge) e la
“concezione di sé”(ossia la percezione che l’individuo ha della sua continuità
nel tempo); l’identità viene organizzata e integrata da quelli che sono i valori
della società a seconda della situazione in cui ci troviamo. Successivamente
compare Goffman3 dicendo che l’identità non è unica ma molteplice; secondo
questo autore l’individuo ha tante identità tante quante sono le maschere che
1
Talcott Parsons (1902-1979) è stato uno dei padri degli studi sociologici americani. Introdusse nella
sociologia statunitense l’elaborazione di concetti e teorie sistemiche. Il funzionalismo di Parsons si rifà agli
influssi di alcuni dei principali sociologi europei come Max Weber, Emile Durkheim e Bronislaw Malinowski.
2
Ralph H.Turner ( 1919- )Rientra tra gli studiosi appartenenti alla scuola dell’interazionismo simbolico
formatosi, così come Goffman, nella Università di Chicago.
3
Erving Goffman (Canada, 11 giugno 1922 - Filadelfia, USA, 19 novembre 1982) fu un sociologo canadese. Il
principale contributo di Goffman alla teoria sociale è la sua formulazione dell’interazione simbolica nel suo
La vita quotidiana come rappresentazione del 1959.
7
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
pone per ogni scena di cui l’individuo si fa protagonista (ossia a seconda di
quale atteggiamento o comportamento assume in ogni interazione con gli altri
assumendo solo quella che secondo lui sarà condiviso dall’altro, conservando
però una propria autonomia). E ancora Berger4 col concetto di “mondo base”
che si rifà a sua volta del concetto di “mondo della vita quotidiana”di Shutz,
ossia un mondo intersoggettivo che precede l’individuo costituito da una serie
di significati, conoscenze e valori ; l’individuo, attraverso il processo di
socializzazione primaria, interiorizza questo mondo nel quale orienta la
propria azione tra le varie alternative, salvaguardando però le vecchie
conoscenze apprese precedentemente. Ulteriori contributi alla conoscenza
della costruzione sociale della realtà sono stati forniti da Mead e Cooley 5 che
hanno insieme idealizzato una sorte di premessa alle diverse teorie di tipo
fenomenologico ed etnometodologico:
Cooley sviluppa il concetto del “Sé specchio”(Noi siamo ciò che gli altri
vedono di noi); ogni individuo costruisce la propria identità tenendo conto
degli altri.
Mead invece distingue “l’organismo fisico dal Sé” (l’altro generalizzato,il
senso oggettivato); il Sé diventa oggetto di se stesso ed emerge nel momento
in cui l’individuo, interagendo con altri, è in grado di distaccarsi dalla
situazione in quello stesso momento assumendo solo quel comportamento, tra
le varie alternative, che l’altro secondo lui condividerà. Distingue poi il Sé tra
Io e Me: il Me è l’aspetto socializzato del Sé, un particolare ruolo che
l’individuo copre, ossia l’insieme di atteggiamenti che l’individuo apprende
dagli altri. Dato che nella società l’individuo è chiamato a coprire più ruoli si
parla di tanti Me; di conseguenza il compito dell’Io diventa quello di
4
Peter L.Berger (17 marzo-1919) ,seguendo le indicazioni di Shutz ,insieme a Thomas Luckmann hanno voluto
sintetizzare in un solo punto la concezione della realtà sociale come fatto esterno di Durkheim e la concezione
della società come prodotto dell’interazione dotata di senso degli attori sociali di Weber.
5
Gorge Herbert Mead(1863-1931),Charles Horton Cooley(1864-1829); il Sè è per Mead il risultato dell’
oggettivazione che l’ individuo opera di se stesso nel momento in cui considera se stesso nel medesimo modo
in cui lo considerano gli altri. Questo stesso aspetto viene elaborato anche da Cooley che sottolinea
l’importanza delle immagini che gli individui hanno di sé e degli altri, in quanto elementi costitutivi della realtà
sociale.
8
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
coordinare i Me: è la parte attiva del Sé, ossia la risposta agli atteggiamenti
degli altri.
L’insegnamento teorico di Mead si sviluppò nell’ Università di Chicago in
cui a partire dal 1892 fu reso attivo il dipartimento di sociologia in cui
lavorava uno tra i sociologi più rappresentativi di questa corrente di pensiero,
ossia Thomas6 che aveva impostato la ricerca sociale come analisi degli
atteggiamenti e dei valori che influenzano il comportamento sociale;
distingueva tra “Attenzione”(ossia l’atteggiamento mentale che prende nota
del mondo esterno e lo manipola) e “Definizione della situazione”(ossia le
rappresentazioni per mezzo delle quali gli individui valutano determinate
situazioni e si predispongono ad agire). Per comprendere l’azione sociale non
è tanto importante considerare i dati oggetti della situazione in cui l’azione
sociale ha luogo ma è utile individuare le percezioni soggettive che comunque
riconducono alla situazione specifica.
Infine abbiamo Giddens7 che sviluppa il concetto del “progetto riflessivo del
sé” ricollegandosi al concetto di strutturazione.
La teoria sociologica in un modo o nell’altro cerca di mettere in luce il fatto
che la società orienti l’azione dell’individuo facendo notare quindi
l’importanza che questa debba cambiare man mano che gli individui che la
6
William T.Thomas(1863-1947) è stato un sociologo statunitense. È stato a capo della scuola di Chicago fino
al 1918, anno in cui è stato arrestato e costretto a dimettersi per lasciare il posto a Robert Park. Si occupò
molto della condizione degli immigrati in America. Scrisse gli immigrati e l'America, ma la sua opera più
importante rimane Il contadino polacco in Europa e in America scritta con Florian Znaniecki ed edito nel
1920, da cui è tratta la "definizione della situazione". La definizione della situazione, chiamata anche Teorema
di Thomas, è il suo enunciato, coniato nel 1928: “Se gli uomini definiscono reali le situazioni esse saranno
reali nelle loro conseguenze”[Thomas 1909,17; cfr. anche Thomas e Znaniecki 1920]
Questa affermazione di Thomas è stata considerata una delle "leggi" più importanti delle scienze sociali, e il
suo successo è dato anche dalla sua longevità. Sembra infatti che questa regola sia così generale ed astratta
da poter essere applicata a diversi contesti sociali e in diversi periodi. Molti contributi importanti alla
socilogia della conoscenza sono inseriti in linea con William Thomas, come ad esempio il fondamentale testo”
La realtà come costruzione sociale” pubblicata nel 1966 ad opera di Peter L. Berger e Thomas Luckmann.
7
Anthony Giddens((Londra, 18 gennaio 1938) è un sociologo e politologo britannico.
A partire dal presupposto del carattere duale della struttura , in quanto dimensione che determina l’azione e
ne è a sua volta determinata, articola la sua teoria dell’azione sociale , considerando quest’ultima come un
elemento di trasformazione e utilizzando principalmente tre concetti: la struttura, che rappresenta l’insieme
delle regole imposte dal sistema sociale; il sistema, come insieme delle relazioni riprodotte tra attori e
collettività , organizzate come pratiche sociali normali; la strutturazione, ossia l’insieme delle condizioni che
governano la continuità o la trasformazione delle strutture e quindi la riproduzione dei sistemi
sociali.[Giddens 1984,25].
9
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
compongono cambiano, affinché non siano gli stessi individui a rispondere ai
bisogni che l’organizzazione sociale necessita per sopravvivere.
1.2
Il processo di integrazione dei giovani
Partendo dal presupposto che sia la società a determinare la formazione
dell’identità dell’individuo nel momento in cui ci si riferisce al giovane e al
suo processo di integrazione nella società quest’ ultimo si riduce alla sola
ruolizzazione nella società, ossia al suo adattamento passivo che pregiudica lo
sviluppo dell’identità del giovane e quindi l’organizzazione dell’intera società
in quanto i suoi bisogni saranno stati trascurati creando cosi squilibri nelle sue
relazioni sociali.
Affinché la socializzazione del giovane costituisca una base solida della
società è necessario superare questa falsa contrapposizione tra individuo e
società e parlare invece di rapporto dialettico tra individuo e società; affinché
la società possa rispondere alle esigenze tanto dei giovani quanto degli
individui in generale è necessario che ci sia uno scambio reciproco tra questi.
Il giovane inizia il suo processo di integrazione nella società fin dai suoi primi
mesi di vita, difatti la prima agenzia di socializzazione risulta essere la
famiglia. I genitori trasmettono ai loro figli tutti i valori, le norme, il modello
sociale a cui appartengono. In un primo momento sembra che questo processo
avvenga esclusivamente in un ambito privato indipendentemente dalla società,
ma in realtà è giusto il contrario: i genitori trasmettono tutto ciò che la società
ha imposto loro, il giovane rivive lo stesso condizionamento che hanno subito
i genitori nel loro processo di socializzazione. La famiglia è in realtà uno
strumento che la società utilizza per far si che i giovani condividano
spontaneamente quei valori, quelle norme che permettono a quella società di
continuare a sopravvivere. Il giovane in questo caso diventa oggetto della
società, e tutte le sue esigenze vengono dimenticate per far si che prevalgano
quelle della organizzazione sociale.
10
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Se l’integrazione del giovane alla società si limita a questo non si può parlare
di socializzazione ma solo di ruolizzazione che permette al giovane di entrare
a far parte di quella forma sociale senza però che la forma sociale si adatti a
questo.
Nel momento in cui si supera invece la concezione che sia il giovane a doversi
adattare alla società si può parlare di socializzazione del giovane come
fondamento della società:
sé vi è uno scambio reciproco tra famiglia, società e giovane vuol dire che si
sta dando una maggiore attenzione a quest’ultimo e questo permette di
considerare e di rispondere ai suoi bisogni specifici.
Vari studi hanno dimostrato che è importante considerare il giovane nella sua
concretezza poiché trascurare la storia specifica del giovane condannerebbe
questo a problemi fisici, psicologici e emotivi.
Uno dei bisogni più importanti risulta essere il legame costante con la madre
nei primi anni di vita e i giovani che sono soggetti alla carenza di questo
legame sono di solito quelli istituzionalizzati o in affidamento.
Tra i vari studi rientrano quelli di Spitz , Bowlby e la Bender 8 che dimostrano
le conseguenze negative della mancanza di un legame affettivo tra madre e
figlio e quanto sia importante la prevenzione. A questi studi si aggiungono poi
le ricerche di D’Armento e Soldi9 che hanno dimostrato la connessione tra la
delinquenza minorile e la carenza delle cure materne.
Il tutto si ricollega alla teoria di Piaget 10 circa lo sviluppo del bambino: la
madre è per il bambino una sorte di ponte con il mondo esterno, e se questa
8
Spitz, Bowlby e la Bender hanno studiato approfonditamente molti casi clinici di bambini cresciuti in
condizioni affettivamente deprivanti, hanno conseguentemente evidenziato come questo stato carenzialei
produca effetti diversi, sempre negativi, a seconda del tipo di separazione, dell'età del bambino, della presenza
o assenza di un precedente rapporto con la madre.
Fra questi effetti si trova: un progressivo rallentamento delle funzioni psicofisiche, difficoltà o impossibilità di
stabilire adeguate relazioni interpersonali fino ai casi più gravi di deterioramento irreversibile delle funzioni
cognitive, gravi alterazioni della sfera affettiva.
9
Indagine effettuata nel territorio salentino, in paricolare nel distretto di Lecce.
10
Jean Piaget(1896-1980).Fonda le basi per un nuovo metodo di ricerca sui processi di apprendimento e sullo
sviluppo cognitivo nell’infanzia ; sviluppa la teoria psicogenetica dello sviluppo cognitivo.
11
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
manca il bambino non sa come orientarsi e tende ad assumere comportamenti
sbagliati.
1.3
La formazione flessibile
Affinché i giovani siano in grado di integrarsi nella società e rispettare le
norme e i valori che questa impone è necessario prima di tutto che la società
dimostri tolleranza verso le diversità e solidarietà verso coloro che non sono in
grado di adempiere alle loro necessità.
Affinché il giovane possa sentirsi accettato nonostante le diversità non è
sufficiente agire a livello micro ma anche a livello macro cercando di creare
un ambiente sano dove solidarietà e tolleranza siano i presupposti della società
che permettono al giovane “a rischio”di superare i suoi ostacoli.
Uno dei fenomeni che oggi caratterizza la nostra società risulta essere l’
immigrazione e molte volte i giovani a rischio sono proprio i giovani
provenienti da altri paesi o i “nostri”giovani che non sono abituati all’idea di
condividere il loro mondo con chi non la pensa come loro o con chi proviene
da culture differenti.
È importante superare l’idea che l’integrazione corrisponda all’adeguamento o
soffocamento delle diverse culture alla nostra e cercare invece di assimilarla
senza condannarla, specie oggi con la globalizzazione che tende ad eliminare i
confini spazio-tempo e permettere alle minoranze di procedere con la propria
cultura nel nostro paese.
La società non deve essere stabile, ma deve cambiare cosi come cambiano gli
individui che la compongono.
È necessario che i giovani sviluppino la capacità di adattarsi e di convivere
con culture differenti, cambiando cosi come cambia la società.
La scuola oltre alla famiglia o alle altre organizzazioni che si occupano dei
giovani hanno questo compito: la formazione del giovane non può limitarsi
all’insegnamento di determinate discipline o alle buone maniere, ma deve
12
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
essere una formazione mirata innanzitutto alla interculturalità; la formazione
flessibile si fonda sull’idea che la formazione del soggetto non deve essere
stabile o precedentemente impostata, ma deve predisporre il soggetto ai
cambiamenti e alle influenze straniere.
Ciò che permette questo tipo di formazione è la dialettica tra unità e
mantenimento delle diversità, ossia un’educazione interculturale che a sua
volta si basa sulla educazione alla comunicazione. Il nesso tra educazione e
comunicazione è la volontà all’ascolto.
La comunicazione è il mezzo necessario per giungere all’interculturalità. È il
mezzo necessario per mettere ordine nella società. Bisogna educare alla
comunicazione in modo tale che la comunicazione sia dialogo, scambio,
confronto e non l’imposizione della maggioranza sulla minoranza evitando
cosi spiacevoli situazioni per i giovani a rischio.
Purtroppo ancora oggi assistiamo ad una vera e propria crisi dell’integrazione:
nella maggior parte dei paesi, cosi come in Italia, la sequenza immigrazioneintegrazione quasi non esiste, in quanto molte volte la figura del criminale
viene associata all’immigrato, specie a causa dei media che tendono a dar
maggior rilievo a fatti che coinvolgono quest’ultimi.
Per favorire una maggiore integrazione è necessario prima di tutto eliminare i
pregiudizi, migliorare le politiche sociali per immigrati, sensibilizzare i
cittadini al fenomeno affinché questi non vengano emarginati e proteggere le
famiglie di immigrati: la protezione della famiglia immigrata non si riferisce
solo al sostegno economico o materiale di queste, ma anche al fatto di creare
delle famiglie aperte verso l’esterno e autonome all’interno. Il giovane
proveniente da queste famiglie per una buona integrazione e per evitare di
assumere comportamenti devianti deve avere la possibilità di scegliere su
quali valori fare riferimento senza subire il totale condizionamento da parte
dei genitori o la totale influenza esterna; la diversità religiosa ad esempio deve
costituire un luogo di dialogo e non un motivo di scontro. (Art.22 “L’Unione
rispetta la diversità culturale, linguistica e religiosa”).
13
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
La formazione flessibile mira a una identità dialogale che permette al
“giovane a rischio” di integrarsi nella società grazie alla tolleranza e alla
solidarietà degli altri e alla sua voglia di relazionarsi.
14
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Capitolo 2
La tutela dei giovani. Assistenza o Prevenzione?
2.1
Dal “Giovane oggetto di tutela” ai “Giovani soggetti
del diritto”
Cosi come dal punto di vista sociologico ci si è resi conto che la
socializzazione dei giovani è importante per l’intera società e il suo
funzionamento, anche dal punto di vista giuridico si è pensato di tutelarli
maggiormente proprio perché sono la base della società.
Questa considerazione ha fatto si che sin da bambino il giovane dal punto di
vista giuridico non venisse più considerato oggetto da tutelare, ma il soggetto
portatore di diritti, diritti che in qualche modo non solo devono essere
riconosciuti, ma anche tutelati implicando in questa tutela l’intervento pratico
dello stato.11
11
Oggi si parla in modo particolare di Stato sociale, “il WELFARE STATE”,lo stato che tutela i diritti e
interviene praticamente affinchè i soggetti possano rivendicare i propri diritti nel momento in cui questi
vengano violati, compresi i minori che a partire dalla “Convenzione di Strasburgo del 1996” hanno la
possibilità di partecipare attivamente a tutte le procedure che li riguardano davanti all’autorità
giudiziaria, direttamente o indirettamente attraverso persone o organismi competenti che li
rappresentino. Il minore diventa a pieno titolo soggetto processuale: può stare in giudizio, agire, essere
presente ed ascoltato. Questo tipo di stato viene appunto definito “Stato interventista” che si
contrappone allo Stato di diritto, una forma di stato che si limita a riconoscere i diritti dei cittadini,
affermatosi per la prima volta con la Rivoluzione francese.
Il passaggio dallo stato di diritto allo stato sociale si è avuto soprattutto perché la produzione è passata
in secondo piano, l’attività di produzione diventò subordinata alla tutela della persona: all’avere, che
era l’oggetto di tutela privilegiato dal codice, si sostituisce l’essere: l’uomo viene tutelato per ciò che è e
non per quello che possiede; cambia la gerarchia dei valori: la proprietà non costituisce un attributo
della persona ma solo uno strumento per affermare la propria personalità.
Comunque sia oggi sarebbe erroneo parlare di Welfare State in quanto lo stato ha perso in un certo
senso il suo ruolo da protagonista nelle politiche sociali. Il Welfare State è l’insieme delle condizioni che
creano benessere e tutela sociale, condizioni create esclusivamente dallo stato. A partire dagli anni
settanta, anni in cui si susseguivano numerosi fenomeni sociali come lo sviluppo industriale, la
femminilizzazione del mercato del lavoro, ecc., inizia la crisi del Welfare State: lo stato riduce la spesa
pubblica, in particolare la spesa sociale, perde il ruolo da protagonista e riemergono gli altri attori
sociali passando ad un Welfare misto che è quello che caratterizza la nostra società. Con lo shock
petrolifero del 1973 ci fù un’immediata inflazione a livello internazionale e ripetute svalutazioni delle
monete nazionali che provocarono un’immediato rallentamento della crescita economica, l’aumento
della spesa pubblica e quindi la deciione di un taglio netto alla spesa sociale. Oggi gli attori sociali
rilevanti per le politiche sociali risultano essere principalmente quattro: lo stato, il mercato, la famiglia,
ma soprattutto il settore non profit che occupa maggior rilievo soprattutto sul piano dell’assistenza
sociale,(proprio come l Asociaciòn Mensajeros de la Paz di Madrid).
15
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Cosi facendo lo stato ha la possibilità di subentrare nel privato e regolarizzare
i comportamenti devianti rendendo concreta la tutela dei giovani12.
Ciò permette non solo di curare il danno, ma anche di prevenirlo. Questa idea
di considerare i giovani come soggetti del diritto deriva dal contributo fornito
dalle scienze dell’ infanzia, che a partire dagli anni Sessanta cambia appunto
la visione dell’ infanzia permettendo di analizzare il bambino da un altro
punto di vista: difatti, se ad esempio consideriamo il caso dell’ adozione,
l’obiettivo dell’ istituto dell’adozione non è più quello di inserire il bambino
in una famiglia che gli assicuri un’esistenza materiale adeguata, ma in una
famiglia che sappia rispondere ai suoi specifici bisogni.
È con la Convenzione ONU13 degli anni Sessanta che i diritti dei bambini
entrano per la prima volta nel mondo giuridico internazionale: la tutela del
bambino non è più una promessa o un atto di benevolenza da parte degli adulti
ma un vero e proprio diritto alla protezione. Gli articoli della Convenzione
idealizzano un mondo a misura del bambino che presuppone non solo il
miglioramento del piano di assistenza, ma anche la formazione di un piano di
prevenzione: la tutela a partire da quel momento non avviene più solo a
posteriori ma si parla invece di “prevenzione di danni al minore”, che rientra
nelle quattro sfere d’azioni rese possibili proprio dalla Convenzione ONU
degli anni Sessanta; oltre a questa difatti abbiamo anche “la partecipazione del
12
Legge 151/75: con questa legge in Italia venne introdotto il Nuovo diritto di famiglia che dà la
possibilità all’ordinamento giuridico di subentrare in uno spazio privato e regolare tre tipi di relazioni
familiari: le relazioni di coppia (il matrimonio,il divorzio), le relazioni genitori-figli ossia i diritti dei figli
e le responsabilità dei genitori (la filiazione, l’adozione e l’affidamento e infine le relazioni parentali al
di fuori del nucleo per regolare le situazioni patrimoniali. Questa regolamentazione da parte dello Stato
può essere intesa sia come un contributo alla formazione della famiglia moderna come spazio del privato
e degli affetti (dato che ha reso fine alle strategie familiari) sia come una fonte di controllo della famiglia
se viene intesa come un’istituzione, un discorso che a sua volta riconduce al considerare la famiglia lo
strumento della società come mezzo per imporre ai giovani le sue regole e i suoi valori.
13
Prima della Convenzione ONU tanti altri documenti internazionali erano stati già promossi a tutela del
bambino, tra i quali:
La “Dichiarazione sui Diritti del Fanciullo del 1924” che per la prima volta riconosce
effettivamente alcuni diritti del bambino (il diritto ad ottenere sostegni adeguati in caso di
disadattamento;il diritto ad una normale crescita psicofisica).
La “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959”(il diritto a crescere sano;il diritto ad un
nome e ad una nazionalità; il diritto per bambini minorati a ricevere assistenza; il diritto ad
essere amato, compreso nell’ambito della sua famiglia; il diritto ad un’educazione adeguata; il
diritto ad essere tutelato da ogni forma di crudeltà o sfruttamento).
16
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
minore nelle decisioni che lo riguardano”, “la protezione del minore da ogni
forma di discriminazione, sfruttamento o abbandono” e infine “la disponibilità
di risorse per garantire al minore a rischio tutte le cure necessarie”.
La Convenzione ONU si basa principalmente su quattro principi: la “non
discriminazione” (indipendentemente da razza, sesso o religione gli stati
firmatari si impegnano nell’ offrire assistenza e prevenzione); “la priorità del
minore”;il “diritto alla vita”; e infine una maggiore considerazione verso le
opinioni dello stesso bambino.
Un
ulteriore
progresso
viene
poi
promosso
successivamente
dalla
“Convenzione Europea di Strasburgo del 1996”.
Per tutelare i giovani è comunque insufficiente introdurre delle leggi: la legge
costituisce solo il primo passo; nonostante oggi esistano numerose leggi che
tutelano i giovani e che soprattutto puniscono la violenza sui minori o le
devianze avviate da questi stessi, la legge costituisce soltanto uno dei punti di
partenza. Importante è l’impegno della collettività nel rispetto dei giovani per
poter poi procedere con assistenza e prevenzione insieme.
2.2
Il piano della prevenzione: l’esempio del Centro
Allegra Compagnia di Mesagne
Come operare sul piano della prevenzione
Il fenomeno della devianza giovanile deve essere risolto innanzitutto con la
prevenzione che implica un programma rivolto al miglioramento delle varie
realtà sociali che circondano i giovani e ad una maggiore qualificazione di
quest’ultimi.
La delinquenza minorile è una realtà polimorfa difatti molteplici sono le cause
che inducono i giovani ad assumere comportamenti devianti: le difficoltà
nell’inserimento del mondo del lavoro, situazioni scomode all’interno della
famiglia (create da genitori iperprotettivi o totalmente disinteressati), la scarsa
17
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
integrazione degli immigrati, l’abbandono dell’istruzione o anche i fenomeni
devianti (come la mafia) presenti nella realtà sociale in cui giovani vivono.
Come vediamo è conseguenza di numerose problematiche tanto che gli
interventi devono essere attuati contemporaneamente in vari ambiti,( tra cui la
lotta alla povertà, la riduzione della disoccupazione, lo sviluppo della cultura e
dell’istruzione, la promozione di politiche sociali a sostegno della famiglia e
della genitorialità), e tanto da rendere inefficiente l’assistenza come strumento
per risolvere effettivamente il problema della devianza giovanile.
L’inserimento sociale dei giovani deve avvenire prima che questi vengano
esclusi attraverso la formazione professionale, la sensibilizzazione ai
fenomeni devianti che interessano il territorio particolare in cui i giovani
crescono e infine spingendo i giovani a crearsi degli interessi attivi per passare
il tempo libero.
Il modo migliore per aiutare i ragazzi non è solo quello di aiutarli nel
momento di bisogno, ma prepararli ad eventuali rischi che potrebbero
danneggiarli insegnando loro a riconoscerli ed evitarli in modo che possano
allontanarsi spontaneamente da situazioni poco raccomandabili. È importante
che i giovani siano in grado di riconoscere eventuali rischi prima che lo faccia
l’adulto che subentra in un’eventuale situazione solo per proibire al giovane
un’ ipotetico comportamento deviante.
Prevenire il disagio giovanile 14 vuol dire anche aver rispetto per i giovani: il
rispetto verso i giovani implica innanzitutto l’impostazione della mentalità
14
“ Il disagio giovanile non è, e non va confuso, con il naturale ed evolutivo disagio adolescenziale. Il
primo che frequentemente si innesca e si rafforza nel secondo, esprime la condizione difficile e
problematica di alcuni giovani. Il secondo è riferito ad alcuni aspetti di un processo psicodinamico di
un’età di per sé difficile. Gli adolescenti a volte sono in crisi perché quello che a loro capita è iscritto in
questo percorso di transizione psicologica , emotiva e sociale che li può fare soffrire ma che comunque li
condurrà verso una dimensione di adultità. Uscire da questo percorso costruito dalla natura per
imboccare, anche inconsapevolmente, strade più rischiose è un’eventualità non una probabilità,
condizionata comunque da numerose variabili”.(pag.149 di “Tra regole e carezze” di Alessandro
Costantini)
È bene quindi delle volte non allarmarsi e non esagerare su quelli che sono i tipici atteggiamenti tipici
degli adolescenti: l’essere iperprotettivi potrebbe poi innescare altre modalità di comportamento
giungendo poi alla vera e propria devianza.
18
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
dell’adulto-educatore su due principali principi che contribuiranno alla
costruzione di una relazione reciproca tra giovani e società agevolando e
facilitando quindi la loro tutela sul piano della prevenzione: da una parte
l’indipendenza del giovane e dall’altra il risanamento ambientale. È bene che i
giovani si sentano liberi di fare esperienze senza che sia l’adulto a dover
decidere per lui, anche se delle volte è necessario che gli adulti intervengano
per far si che l’ambiente in cui i giovani vivono sia adatto a loro e privo di
fenomeni che potrebbero pregiudicare la sua formazione.
La risoluzione del disagio giovanile si colloca principalmente sul piano della
prevenzione in quanto scaturisce da come i giovani vivono la loro quotidianità
o da quante e quali regole gli adulti impongono loro: nella nostra società i
giovani hanno tante opportunità di svago,(sale giochi, palestre, navigazione in
internet,…) e proprio l’opportunità di scegliere liberamente tra le tante crea
una certa confusione facendo perdere di vista i valori che dovrebbero invece
garantire al giovane una buona condotta; il disagio giovanile non caratterizza
solo una fascia di giovani, non si riferisce solo ai soggetti provenienti da
famiglie problematiche; oggi il problema tocca un po’ tutti, tant’è vero che
spesso chi fa uso di cocaina,extasy e di sostanze stupefacenti forti in generale
sono proprio quei giovani che provengono da famiglie agiate. Prevenire vuol
dire anche abbandonare i pregiudizi e accettare il problema del disagio
giovanile come quel fenomeno che riguarda l’intera società, naturalmente
senza che si arrivi all’esasperazione, dato che spesso vi è la tendenza a
ingigantire il problema dove non c’è; solo se si ha una buona conoscenza del
fenomeno sarà possibile individuare la causa e individuare gli strumenti per
soluzionarlo. Dare priorità al piano della prevenzione come strumento per
soffocare la devianza giovanile presuppone una chiara definizione del
problema; se si continua a generalizzare sul problema non si sarà mai in grado
di intervenire nei tempi giusti: il disagio giovanile è spesso causa del cattivo
19
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
ruolo educativo della società, della famiglia e della scuola e se non si
apprende a dare più spazio ai giovani piuttosto che dargli contro, i
comportamenti di aggressività e trasgressività tenderanno a crescere fino a
divenire fonte di intolleranza e razzismo. Oggi, come non mai, i media non
fanno altro che focalizzare l’ attenzione su episodi di bullismo nelle scuole,
l’intolleranza verso chi è diverso, la poca disciplina ,il vandalismo, gli scippi,
ecc. e questo è conseguenza della mancanza di comunicazione tra adulti e
giovani e la poca disponibilità da parte della società delle volte a creare degli
spazi destinati ai giovani affinchè questi possano aprirsi alla socializzazione,
formarsi in modo sano ed evitare quindi questi comportamenti.
Il bullismo nelle scuole è una delle forme di aggressività che pian piano si sta
evolvendo in un vero e proprio fenomeno deviante caratterizzante l’intera
società e non solo quartieri poco raccomandabili come avveniva in passato;
riguarda soprattutto quelle fasce di età che rientrano nelle scuole elementari e
medie inferiori. Si tratta di un comportamento legato all’aggressività fisica,
verbale e psicologica; non si tratta di normali litigi che avvengono tra studenti,
ma di veri e propri soprusi che costantemente, con violenza fisica o
psicologica, vengono imposti su soggetti particolarmente deboli e indifesi,
suscitando in loro poca autostima, il senso di isolamento e di emarginazione.
Occuparsi del bullismo non significa contrastare questo fenomeno nelle
scuole, ma creare una vera e propria strategia preventiva contro l’aggressività
che potrebbe poi sfociare nei vari ambiti della società nelle relazioni tra
studenti, genitori, insegnanti e nelle relazioni da adulti.
Il professor Smith, uno degli studiosi più accreditati sull’argomento in un
convegno15 sul bullismo, ha affermato che questa strategia deve divenire una
vera e propria politica governativa scolastica, proprio come è accaduto in
Gran Bretagna, che riconoscendo l’importanza sociale del fenomeno e della
sua incidenza sulle forma di aggressività violenta dei giovani, ha finanziato
piani di intervento e prevenzione del bullismo in tutte le scuole del territorio
15
Bologna 2001
20
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
nazionale, giungendo a sanzionare economicamente perfino le scuole
inadempienti.
Questa strategia si propone principalmente tre obiettivi:
-prevenire l’aggressività;
-promuovere il dialogo per evitare l’aggressività;
-contenere l’aggressività.
Il primo obiettivo sarà possibile solo se gli adulti saranno consapevoli del
proprio ruolo e capaci di creare per gli studenti contesti relazionali ed
educativi significativi. Gli adulti, tanto i genitori, insegnanti che altre persone,
devono cercare di essere più vicino possibile alla crescita dei giovani; questo
non vuol dire limitarsi a imporre loro una disciplina rigida per evitare una
cattiva condotta ma cercare di creare una relazione che si basi principalmente
sul rispetto reciproco. È importante sviluppare con gli studenti una vera e
propria cultura del “fare insieme” e dello “stare insieme” in modo che possano
avere dei punti di riferimento nella loro crescita.
Esistono varie metodologie di prevenzione e tra queste il “Circle Time”: è uno
strumento tecnico che viene utilizzato per attivare la partecipazione dei
ragazzi e per condurre un gruppo dal punto di vista socio-affettivo, ossia delle
relazioni che si instaurano tra i vari componenti; è un metodo di lavoro che
viene proposto per affrontare, contrastare o prevenire il bullismo come
fenomeno presente in un gruppo di classe, ma può essere usato anche per un
qualsiasi altro argomento in quanto favorisce la partecipazione emotiva di tutti
i partecipanti e permette un confronto equilibrato e maturo tra le persone. Se
questo metodo viene utilizzato in maniera costante potrebbe prevenire il
disagio giovanile (difficoltà relazionali, abbandono scolastico, comportamenti
sociali a rischio) e potrebbe contribuire a far si che i giovani siano più
propensi all’educazione all’autonomia, alla responsabilizzazione, all’aumento
dell’autostima, alla fiducia negli altri. Il percorso del metodo può essere
sintetizzato in 10 punti:
-gli alunni si siedono in cerchio nell’aula;
21
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
-è preferibile che il numero dei partecipanti non superi i 20 in quanto tutti
devono avere la possibilità di intervenire e interagire;
-dura per l’intero anno scolastico per un’ora e mezza alla settimana;
-i tempi e le modalità per organizzare il cerchio vengono decise insieme per
far partecipare tutti sin dal principio in maniera attiva;
-i componenti del cerchio devono essere distribuiti in maniera uniforme, in
modo che nessuno sia preminente all’altro favorendo cosi la comunicazione
che in questa maniera diventa circolare ed efficace: “tutti ascoltano tutti”;
-democraticamente vengono stabilite le regole(intervenire uno per volta,
ascoltare in silenzio chi parla,…);
-ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni;
-si passa alla tecnica del “brainstorming”16: liberamente sono gli stessi
partecipanti che propongono gli argomenti per la discussione;
-può essere proposto un tema qualsiasi: sesso, amore, droga, rapporti coi
genitori,…;
-il conduttore dovrà cercare di coinvolgere tutti senza tirar fuori le proprie
opinioni in modo da non influenzare i partecipanti.
L’ obiettivo è quello di far vivere ai giovani l’esperienza del “fare insieme” e
dello “stare insieme”in modo che possano sviluppare il senso di socialità e
promuovere il rispetto tra loro stessi.
Questo modello è utile per prevenire un qualsiasi fenomeno deviante difatti
viene spesso utilizzato nei centri educativi, proprio come il “Centro Allegra
Compagnia di Mesagne”.
Il secondo obiettivo accenna al dialogo, che in particolar modo deve
interessare la famiglia, dato che rimane questa la prima vera e propria agenzia
di socializzazione; comunicare correttamente nella relazione genitori-figli
aiuta senza dubbio a migliorare le relazioni personali, il modo di vedersi e di
comprendersi. L’adulto deve impostare la relazione sulla comunicazione in
quanto ci deve essere un continuo scambio tra figlio e genitore; si possono
16
“tempesta di cervelli, di idee.”
22
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
riassumere tre importanti tecniche di comunicazione che rendono ancor più
efficace il dialogo:
1. MESSAGGIO IO: è importante che l’educatore-genitore metta a
confronto i propri sentimenti col proprio figlio. Mi riferisco al fatto di
evitare di utilizzare messaggi in seconda persona, ossia: “ Non ti
permettere mai più…, Ti comporti come un bambino…”;in questo caso
i sentimenti dell’adulto non vengono comunicati e il giovane potrebbe
interpretare questi messaggi come un volerli incolpare senza però
capire il perché realmente quel comportamento da lui assunto sia
ritenuto inaccettabile. È importante far capire quali sono le
conseguenze delle sue azioni senza dare giudizi e riferirsi al
comportamento specifico senza generalizzare con frasi del tipo: “ è
sempre la stessa storia…, sei sempre cosi…”. È bene fornire ulteriori
esempi: se un genitore è in ritardo e il figlio ancora non è pronto è bene
che la madre non inizi a generalizzare su quel comportamento ma che
spieghi come si sente nel caso in cui tardassero nuovamente
all’appuntamento; i messaggi in prima persona devono essere sinceri e
devono incoraggiare i ragazzi a fare altrettanto. Quindi se ritorniamo
all’esempio della madre in ritardo alla frase “ogni volta è la stessa
storia” si sostituisce “siamo in ritardo e io sono agitata e se non saremo
puntuali farò una brutta figura”; in questo modo la madre fa capire al
figlio le conseguenze pratiche delle sue azioni e li responsabilizza
rispetto al comportamento da tenere.
2. L’ASCOLTO ATTIVO: è una tecnica che richiede l’attenzione verso
l’altro, la concentrazione sui sentimenti che esso esprime e sui
problemi emotivi che stanno dietro le sue parole. È bene evitare di
esprimere liberamente le nostre opinioni e di voler imporre il proprio
punto di vista, l’obiettivo deve essere quello di entrare in contatto con i
sentimenti dell’altro. Questa tecnica si divide in quattro momenti
fondamentali:
23
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
-
il silenzio: la rinuncia a intervenire, a dire le proprie opinioni per
concentrarsi su ciò che l’altra persona cerca di esprimere faticosamente;
-
i messaggi di accoglimento: messaggi che rafforzano l’ascolto
silente(“ti sono vicino, ti capisco”);
-
l’incoraggiamento a parlare;
-
la riflessione sul pensiero dell’altro; dare l’appoggio senza mai
esprimere il proprio giudizio.
3. LA NEGOZIAZIONE: il cosiddetto metodo senza perdenti, il creare
punti d’incontro tra le esigenze del figlio e del genitore.
Queste tecniche nel loro insieme rafforzano il rapporto tra genitori e figli
dando la possibilità ai giovani di esprimere le proprie preoccupazioni e avere
dei punti di riferimento in modo che possano rendersi conto di eventuali
rischi.
Il terzo obiettivo si riferisce al fatto di “dover dire no”: l’educatore deve
comunque porre dei limiti per far si che i giovani sappiano quando fermarsi.
È necessario quindi, tanto per il bullismo che per tutti gli altri comportamenti
devianti, che avvenga un cambiamento educativo basato sullo scambio
relazionale tra giovani e società in modo da organizzare un piano di
prevenzione che possa mirare a rispondere ad ogni particolare esigenza, (dalla
costruzione di piccoli spazi fisici per i ragazzi ad un vero e proprio
risanamento ambientale che implica il soffocamento di tutti i fenomeni
devianti del territorio
Storia del centro di aggregazione giovanile
“Allegra Compagnia” di Mesagne (Brindisi)17
“EDUCARE ALLA RELAZIONE COME ALTERNATIVA ALLA MAFIA”:
quando su un territorio i ragazzi hanno maggiore dimestichezza con vicende
malavitose e con dinamiche di microcriminalità che con il libero dipanarsi della
propria adolescenza, ci si deve chiedere se i loro comportamenti devianti
17
Da “Animazione Sociale –novembre 2008 ”,Il mensile degli operatori sociali.
24
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
costituiscano un trend generazionale o se siano alimentati da una cultura locale
accondiscendente a una mentalità di tipo mafioso. Solamente se si offrono
modelli di vita alternativi in spazi di libera espressione
aggregazione e socialità, i ragazzi possono cambiare i propri modi di pensare e
agire nella realtà sociale in cui vivono”.
<Mesagne è una piccola città della provincia di Brindisi, a vocazione
prevalentemente agricola. Durante gli anni Ottanta, il suo territorio è stato
fortemente interessato dal coinvolgimento di un gran numero di cittadini in
attività criminose, tanto da trovarsi al centro di quel grave fenomeno mafioso
tristemente noto come “Sacra corona unita”.
La situazione sociale che si è venuta a determinare ha avuto inevitabilmente
pesanti ricadute negative sulla popolazione minorile e giovanile. Bambini e
ragazzi hanno subito i contraccolpi di questa evoluzione o perché membri di
famiglie impegnate nelle vicende della Sacra corona unita(orfani di morti
ammazzati, figli di detenuti) o perché dediti alla microcriminalità. Malgrado
questa città non avesse una tradizione mafiosa, negli anni successivi molti
giovani furono protagonisti di fatti di cronaca delinquenziale. Le strade e le
piazze, un tempo luoghi di aggregazione libera e informale in cui ragazzi e
bambini potevano giocare e trascorrere il tempo libero, da un certo momento
in poi si trasformarono in veri e propri luoghi di paura.
A questo clima di intimidazione la città ha cercato di reagire ed una della
iniziative proposte fu il centro aggregativo “Allegra Compagnia” dal quale è
poi nata una vera e propria rete di servizi per l’infanzia e l’adolescenza unica
nel territorio pugliese.
Nel 1997 l’amministrazione comunale, dando seguito a iniziative forti di lotta
alla mafia, nate sulla scia dei mutamenti politici e culturali verificatisi agli
inizi degli anni Novanta, attivò il progetto di “Mesagne città sicura”, con
l’intento di estendere la lotta alla mafia a iniziative preventive e protettive nei
confronti della popolazione minorile. Il progetto “Mesagne città sicura” trova
cosi proseguimento nel progetto “Adolescenze in campo”, che si traduce nella
25
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
creazione di uno “sportello si solidarietà giovanile”, una struttura costruita
attorno ad un nucleo di dodici educatori, formati attraverso un corso di
aggiornamento pensato su misura per questo progetto, affiancati da un equipe
di consulenti scientifici esterni.
L’obiettivo principale era quello di proporsi come strumento e occasione di
comunicazione per i giovani del territorio, offrire opportunità per stare
insieme, promuovere una socializzazione positiva e attivare interventi a
carattere preventivo, dove la prevenzione è intesa soprattutto come
promozione di opportunità e risorse.
Il primo intervento dello sportello sul territorio è rappresentato da una serie di
attività decentrate (animazione territoriale), funzionale ad avviare un aggancio
dei ragazzi e delle ragazze. Nasce cosi “Quartieri animati”, un contenitore di
diverse attività rivolte ai giovani dai dodici ai diciotto anni.
Nell’ambito di questa iniziativa vengono realizzate attività sportive, giochi di
quartiere ed escursioni guidate. La scelta di effettuare le diverse attività nei
diversi quartieri della città era data dalla volontà di essere presenti li dove
prende forma la quotidianità degli adolescenti e di trasformare i loro spazi
abituali in luoghi che tornino a vederli protagonisti.
Successivamente dagli stessi ragazzi che aderirono al progetto arrivò la
richiesta di avere uno spazio tutto per loro, un luogo fisico dove potersi
incontrare ed esprimere liberamente. Il Comune di Mesagne decise quindi di
intervenire e mettere a disposizione una casa. Lo sportello a questo punto si
trasforma cosi in un intervento complesso articolato in tre servizi: uno
sportello informativo rivolto a giovani e adolescenti, un centro di
aggregazione giovanile e il servizio di educativa domiciliare. Dopo numerosi
incontri furono gli stessi ragazzi a chiamare quel luogo che per loro
rappresentava una seconda casa “Allegra Compagnia”, un nome che richiama
appunto il carattere accogliente, allegro e familiare che lo rappresenta. Allegra
compagnia ha da quel momento l’ obiettivo di promuovere opportunità di
incontro e socialità, attraverso esperienze educative, espressive e di aiuto e
26
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
supporto alla crescita, svolgendo una funzione di raccordo tra enti locali e la
realtà degli adolescenti del territorio.
Le attività del centro si configurano come proposte educative e d’incontro
attraverso itinerari di esperienza extrascolastica di tipo aggregativo e
socializzante. Esse diventano dei pretesti per promuovere la costruzione di
una conoscenza di sé e solo dopo di acquisire determinate conoscenze, abilità
o competenze.
Nella ricerca “Libera” 18sulla criminalità mesagnese, tali iniziative erano
finalizzate a qualificare il tempo libero dei ragazzi connotandolo di valenza
formativa ed educativa: era necessario sviluppare gli interessi dei ragazzi,
sostenendoli nel difficile processo di crescita, utilizzando il gruppo come
luogo privilegiato di confronto.
Nell’ottobre del 2004 un importante avvenimento coinvolge Allegra
Compagnia: l’assegnazione di un’abitazione confiscata e la visita di don
Ciotti, presidente nazionale di Libera che inaugurò la nuova sede.
L’incontro con Libera prosegui e si ampliò nell’estate di quell’anno attraverso
il rapporto con l’associazione Acmos che opera a Torino.
Il centro Allegra Compagnia è un servizio nuovo, unico nella provincia
organizzatosi in un territorio privo di una cultura laica dell’educazione, dove
gran parte dei luoghi di aggregazione apparteneva alle associazioni
parrocchiali e sportive.
A Mesagne , realtà prevalentemente rurale, cosi come in tutta la Puglia,
l’attenzione laica ai problemi socioeducativi ha un passato recente, ed è figlia
della necessità di contenere e prevenire un crescente disagio giovanile.
Disagio che, se per alcuni versi non è diverso dalle altre zone dell’ Italia,
legato alle trasformazioni in senso consumistico della società in cui viviamo,
nella nostra città è frutto anche di una crescente crisi occupazionale e
dell’incontro con una cultura di tipo mafioso che lentamente si andava
insinuando nel tessuto sociale: la mancanza di lavoro, infatti, ha visto molti
18
Associazione Libera, “La criminalità organizzata nel territorio mesagnese, Mesagne 2006,p.167.
27
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
giovani transitare verso la nascente organizzazione mafiosa, che prometteva
guadagni facili e prestigio criminale.
“Allegra Compagnia”: perchè strumento di
prevenzione?
Il Centro di aggregazione giovanile “Allegra Compagnia” è nato
come
risposta ai bisogni sociali che sorgevano negli anni novanta; in particolare è
stato ideato per far si che i ragazzi provenienti da famiglie problematiche,
specie quelle legate alla mafia, avessero un punto di riferimento per evitare
che anch’essi voltassero per quella strada.
Un punto di riferimento che non può limitarsi allo spazio fisico, ma che deve
essere inteso soprattutto come spazio mentale, ossia come un ambito
relazionale in cui i giovani abbiano la possibilità di esprimere la loro
personalità senza subire il condizionamento dei loro genitori, che delle volte
tendono a trasmettere in maniera passiva ciò che la società ha imposto, loro
facendo ricadere i ragazzi nei loro stessi errori.
Uno dei problemi della società contemporanea è che oggi i nostri ruoli sociali
coincidano con la nostra identità facendoci dimenticare che siamo noi a dover
scegliere in ciò che vogliamo credere e su quali valori far riferimento. Ed è
proprio per questo che dobbiamo creare questi spazi: spazi in cui il ragazzo
abbia la possibilità di relazionarsi coi suoi coetanei, col contesto in cui vive al
di là della famiglia, con le differenze culturali che caratterizzano ormai il
nostro territorio; spazi in cui sia il ragazzo stesso a decidere della sua
personalità. Se non ci dovessimo dirigere su questa traiettoria, il giovane
tenderebbe ad una mentalità chiusa portandolo a non relazionarsi con tutto ciò
che è differente dalla sua quotidianità e a assumere comportamenti delle volte
devianti a causa della scarsa disponibilità all’ascolto dimostrata nei loro
confronti e a causa dei fenomeni devianti già presenti nel territorio. Dobbiamo
fare in modo ,invece, che la quotidianità del ragazzo venga caratterizzata da
questi continui rapporti con l’esterno, in modo che da adulto possa avviare dei
28
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
rapporti sani. Inoltre non dovremmo preoccuparci solo di risanare l’ambiente
in cui il ragazzo vive, ma preparare il giovane a sfruttare le proprie capacità in
maniera che ognuno di loro possa trovare la sua strada e riemergere da questo
ambiente.
A questo proposito dobbiamo la persistenza del Centro Allegra Compagnia
che,in un certo senso,sembra essersi evoluto: non si limita solo a creare uno
spazio come alternativa alla strada, ma cerca soprattutto di insegnare ai
ragazzi a saper sfruttare tutte le loro capacità in modo tale che in futuro siano
capaci di incrementare le loro competenze e crearsi un avvenire migliore.
Il centro offre una serie di attività che coinvolgono varie tipologie di ragazzi
provenienti da ambienti familiari differenti, ma nonostante questo riescono a
formare un unico gruppo dimostrando, quindi ,che creando degli spazi di
ascolto il giovane sia più propenso alla socializzazione con gli altri piuttosto
che alla mentalità chiusa imposta dall’ambiente da cui proviene
Tra le attività proposte dal centro:
29
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
“Break-dance”
30
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
“Spray-art”
-
31
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
“Escursioni”
32
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Oltre a queste vengono preparati degli spettacoli che cercano di coinvolgere e
avvicinare in maniera più uniforme tutti i ragazzi indipendentemente dalla
loro attività preferita ,come accade per la preparazione del dramma “Romeo e
Giulietta”che comporta la collaborazione di tutti i ragazzi: gli appassionati di
canto,ballo,recitazione,musica e cosi via.
Il Centro Allegra Compagnia è comunque un contesto che, nonostante le varie
attività, si apre anche a ragazzi che non hanno nessuna abilità particolare, se
non quella di voler finalmente trovare figure su cui finalmente poter contare.
Le educatrici svolgono un ruolo chiave che si basa specialmente sulla volontà
di ascoltare i loro problemi, le loro opinioni, le loro idee volta per volta.
Il centro rappresenta uno degli strumenti che si collocano sul piano della
prevenzione in quanto parte dal presupposto che i giovani debbano essere
considerati dalla loro concretezza.
“Allegra compagnia” a confronto con la
realtà scolastica del territorio mesagnese:
intervista all’educatrice del centro allegra compagnia
1)
Allegra Compagnia nasce nel 1999 su una progettazione che
l’amministrazione comunale da tempo cercava di mandare avanti a causa
degli episodi di delinquenza che si erano susseguiti nel territorio
mesagnese, in particolare l’insorgere della “Sacra Corona Unita”:
sappiamo infatti che parecchi giovani vennero e ancora oggi sono
coinvolti in questo fenomeno. Perché si pensò che un centro di
aggregazione giovanile potesse contribuire più delle altre associazioni
giovanili al soffocamento del disagio sorto in quegli anni?
<Il centro nasce e continua ad essere strumento di prevenzione, anche se in un
primo momento nell’anno 1999 si era proposto di creare anche un servizio di
recupero; inizialmente era presente un equipe ben organizzata con otto
educatori, tra cui uno psicologo, un’assistente sociale e un pedagogista e di
conseguenza furono organizzati due tipi di servizi: da una parte lo “Sportello
33
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
di solidarietà giovanile”(quattro educatori andavano presso le case dei ragazzi
segnalati dai servizi sociali e con il pretesto del sostegno scolastico si cercava
di dare un maggiore supporto educativo), dall’altra il servizio offerto
all’interno dello stesso centro che comprendeva una serie di attività ricreative.
Dopo l’estate del 1999, a seguito del progetto “Quartieri Animati” gli stessi
ragazzi che avevano partecipato a questo progetto ci chiesero di creare un
piccolo spazio dove potessero continuare a stare insieme dando vita cosi ad
Allegra Compagnia, che in quegli anni era collocato in uno stabile diverso da
quello attuale: era uno stabile grande, la parte superiore era destinata al
sostegno scolastico per quei ragazzi che in casa avevano situazioni difficili
dando loro la possibilità per almeno qualche ora di allontanarsi da quell’
ambiente inadatto alle loro esigenze; le altre aree delle stabile costituivano
l’area ricreativa. Inizialmente il centro era frequentato solo da quel gruppo
segnalato dai servizi sociali, man mano, invece, si aggregarono altre tipologie
di
giovani in quanto all’epoca le alternative erano offerte solo dalle
parrocchie o dalle associazioni sportive che a loro volta non erano predisposti
e adatti alle esigenze dei giovani in quanto veniva a mancare la continuità che
invece offre il nostro centro(il nostro centro rimane aperto anche la sera ,
mentre le altre associazioni tendono ad offrire determinati servizi solo in
maniera saltuaria).
Il fatto che pian piano il centro diveniva “il centro di tutti” poco a poco
Allegra Compagnia si andava a distinguere dalle altre associazioni offrendo
più delle altre, dato che dava la possibilità ai giovani di socializzare
nonostante le diversità garantendo al territorio un servizio in più,
(l’integrazione tra i giovani del territorio avveniva in maniera spontanea senza
il bisogno che questi avessero alcuna abilità particolare, cosa che accade
invece nelle associazioni parrocchiali o sportive).>
2)
Oggi Allegra compagnia è collocato in un altro stabile che in qualche
modo lo ha contraddistinto dalle altre associazioni, un luogo pieno di
significato: il centro ha sede difatti in uno stabile confiscato alla mafia
rendendo ancor più visibile l’obiettivo dello stesso centro, il risanamento
34
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
ambientale. È senza dubbio un buon dettaglio, ma non ho fatto a meno di
notare le carenze e la mancanza di strumenti di questa struttura. Non
crede che con gli anni sia stato enfatizzato troppo questo particolare per
nascondere la promessa non mantenuta di ristrutturare lo stabile?
< In verità l’unica cosa che ci mantiene in vita è il fatto di trovarci in un bene
confiscato alla mafia che ci è stato assegnato da Don Ciotti, il prete che a
livello nazionale si occupa della lotta contro la mafia iniziata in maniera più
intensiva a seguito delle stragi di Falcone e Borsellino. Se non avessimo
questo particolare il centro oggi non esisterebbe più. L’amministrazione
comunale vuole chiudere,il progetto è in esaurimento,i laboratori con gli
esperti svaniranno, non ci sarà più il sostegno scolastico: tutto si sfuma. C’è
un problema di fondo, per gli altri non siamo importanti, è questo il problema.
Con la nuova amministrazione siamo stati snobbati.>
3)
L’attenzione per il sociale tende quindi a diminuire, come se lo spiega?
Questa è stata sempre una prerogativa della sinistra, e dato che siamo ormai
capitanati da un’amministrazione di destra il tutto prende significato. Non
rientra proprio nella cultura della destra questo tipo di attenzione , ma anche a
livello nazionale. Questi servizi sono considerati superficiali; non hanno
nemmeno valutato la situazione. C’è ignoranza politica. Questo riassume in un
certo senso la storia della politica italiana: politicamente questo centro è nato
in un momento comodo, comodo per la pubblicità solo di quel momento, dopo
di che è stato abbandonato a se stesso: gli educatori rimangono due, non si
prevede nessuna sostituzione. Il comune non ha abbastanza soldi o forse è
solo perché per alcuni non è un bene essenziale. Nessuna priorità, nessuno
strumento, nessuna ristrutturazione: l’ edifico non è a norma, sono 8 anni che
aspettiamo gli inizi dei lavori. Adesso si parla di un nuovo progetto, pero tutto
rimane un forse. Forse ci sarà una rinascita, o una nuova attenzione verso
questi servizi, ma fino ad adesso tutto tace. Purtroppo offriamo poco perché l’
equipe non è al completo, ci sono lacune, mancano le figure professionali e
noi purtroppo dobbiamo improvvisare il tutto.
4)
35
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Il centro si proponeva quindi di costituire uno strumento di prevenzione
del territorio, quindi cosa può essere migliore della stretta collaborazione
con le scuole che conoscono e formano questi stessi giovani. Sono a
conoscenza del fatto che comunque sono state poche le attività create in
comune con le scuole; pensa che la causa sia stata la mancanza di
professionalità del centro dovuta alla scarsa organizzazione dell’equipe a
pregiudicare i rapporti con le scuole? O crede che ci sia una sorte di
pregiudizio generale nei confronti dei centri socio-educativi da parte delle
scuole o delle famiglie, nel senso che si creda che siano rivolti solo ai
cosiddetti giovani a rischio?
<No, non credo. La scuola tende ad essere un contesto a sé! Nel senso che la
scuola si dimostra aperta per attività di ritorno; si continua a vivere in un
ottica da solisti: si apre solo nel momento in cui ci sarà qualcosa di ritorno alla
stessa scuola: tutto si muove per garantire alla scuola autonomia: si parla di
una scuola competitiva ; è una scuola che si propone, che vende, che si fa dei
clienti: i ragazzi. Negli anni ci siamo offerti di creare delle attività in comune
che coinvolgessero tutte le tipologie dei ragazzi presenti nelle scuole, ma la
scuola tende a riconoscere questo centro come uno spazio destinato solo a
“giovani a rischio”, ragazzi con problemi: è una scuola che ancora non si apre
a un discorso di rete, al lavoro col territorio, ad un’ educativa comune. Le
stesse professoresse si sono rivolte solo nei casi di alcuni ragazzi difficili
nonostante sia stato sollecitato il fatto di coinvolgere tutti senza distinzioni. Lo
ribadisco: il centro è per tutti.
Abbiamo anche proposto degli incontri in mattinata, delle attività ricreative
nel pomeriggio, ma alcune volte non ci è stato possibile nemmeno entrare
nelle classi per fare la promozione. Ad un certo punto ci è stato detto che
avrebbero mandato loro i ragazzi se ne avessero avuto bisogno. La scuola si
rapporta solo nel momento in cui ha delle situazioni che non sa gestire
,rivolgendosi poi alle strutture comunali dato che la maggior parte delle volte i
percorsi individualizzati mancano.
Fino al 2004 il nostro centro, oltre alla prevenzione, si proponeva anche l’
obiettivo di contenere il disagio tanto che la scuola tendeva a mandarci solo i
ragazzi difficili creando cosi un vero e proprio “luogo ghetto.”Qui arrivavano
i ragazzi segnalati, si era venuto a creare un ghetto che oramai non poteva più
36
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
aiutarli; il centro risultava inutile, si era trasformato in un luogo che in qualche
modo li giudicava, li stigmatizzava; il centro era solo per giovani a rischio.
Dopo di ciò il pregiudizio è continuato a crescere nel paese.
Dal 2004 c’è stato un cambiamento e si è cercato di farlo diventare il centro di
tutti: la struttura sin dall’inizio non offriva molto, mancavano gli strumenti,
era carente, ma per lo meno cominciava ad assumere un significato diverso. Il
centro segna la voglia di risanare il territorio, di combattere i fenomeni
devianti, si propone come strumento di prevenzione rivolto a tutti i giovani del
territorio mettendo in evidenza il fatto che la
devianza giovanile non è
caratteristica esclusivamente dei giovani a rischio ma di tutti.
Condivido il fatto che la scuola cerchi maggiore professionalità per
collaborare nelle attività,come psicologi, pedagogisti e forse è proprio per
questo che non mostra disponibilità nella collaborazione, ma penso anche che
spesso decida di agire in questi termini non per i ragazzi stessi, ma per il
prestigio della scuola. La scuola cerca progetti che coinvolgano personaggi
noti e si rifiuta di collaborare con noi per non passare in secondo piano.
La scuola deve e vuole vendere.
Ti faccio un esempio: “Parlarne per crescere” è un laboratorio di discussione
ideato da noi collaboratrici con il supporto di psicologi, pedagogisti; questo è
l’unico progetto a cui la scuola si è dimostrata interessata solo perché faceva
comodo utilizzare la nostra professionalità gratuitamente.
Noi non vogliamo sostituirci ai progetti educativi della scuola; noi
subentriamo nel tempo libero dei giovani: solo chi sta nel tempo libero si può
accorgere di cose che nella scuola non puo notare; qui i ragazzi esprimono la
libertà, nella scuola c’è costrizione, ed è nella libertà che il disagio nel gruppo
può venir fuori per soluzionarlo. “Parlarne per crescere” è nato
spontaneamente nella vecchia struttura in cui i ragazzi spontaneamente
decidevano di affrontare temi che spesso li vedevano protagonisti
(sesso,droga,…) con le educatrici tanto che decidemmo di far ricorso a figure
professionali.
37
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Le attività nelle scuole vengono fatte per vendere,la scuola si sponsorizza , lo
fa per fama :poco centra il futuro dei giovani.
Fino a quando si sono voluti avvalere delle nostre competenze ci hanno
appoggiato,dopo di che ci hanno scartato. Non si tratta di pregiudizi ma di
mancanza di rispetto, di poca correttezza nei nostri confronti.
La scuola deve vendere e preferisce collaborare con personaggi illustri
piuttosto che con delle piccole realtà come la nostra.
L’ autonomia della scuola prevale sulle vere esigenze dei giovani e nonostante
i vari progetti non è ancora uscita fuori dai vecchi modelli di insegnamento
che non preparano i giovani al mondo esterno e a quella che sarà poi la loro
quotidianità.
Considerazioni conclusive
A mio avviso credo che tutte queste difficoltà abbiano in comune
un
problema di fondo: Mesagne è un contesto che vive in una mentalità chiusa ,
imprigionata nelle tradizioni , nei pregiudizi, tendente al patriarcato, dove i
giovani non hanno la possibilità di esprimersi come vogliono, non perchè non
possano farlo ma in quanto non sono nemmeno consapevoli di doverlo e
poterlo fare. Il territorio deve essere risanato dalla delinquenza, senza
dimenticare il peso dell’ignoranza. Si deve crescere in ogni direzione: la
cultura diventa uno strumento indispensabile
affinché i giovani possano
perseguire liberamente il proprio diritto all’autodeterminazione. Però cultura
che non si esaurisce alla sola istruzione.
È importante che il territorio non rimanga vuoto, che ci siano più spazi in cui
i giovani apprendano a rispettarsi, ad essere più tolleranti, verso chi ha il
colore della pelle diverso, verso chi ha delle preferenze sessuali differenti ,
verso le donne,….
Il fatto di essere cresciuta in un piccolo paese e di vedere cose che in altre
realtà nemmeno esistono mi lascia sperare che un giorno anche Mesagne,
38
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
cosi come altre piccole realtà vicino alla nostra, possa crescere; si tratta solo di
questo, aiutare i giovani a crescere. Solo cosi sarà possibile lo stare e il fare
insieme e il miglioramento dell’ intero territorio. - Parità, comprensione,
solidarietà, apertura - è questo ciò che dovremmo trasmettere ai giovani
nell’era globale per una società ordinata ma in continuo mutamento.
2.3
El plan de la asistencia: el ejemplo de la Asociaciòn
Mensajeros de la Paz de Madrid
Como orientarse en materia de asistencia
Por lo general la asistencia social tiene como objetivo ayuadar a los individuos
para que estos tengan todo lo que hace falta para vivir, cosas que no son solo
cosas materiales sino tambien afecto, proteccion, ecetera. La manera mejor
para garantizar esto es ententar cambiar la vieja concepcion de asistencia a los
menores: es decir que es importante aclarar que la familia es el medio mas
apto para la formacion y el desarrollo del niño y del joven y de consecuencia
es importante que la asistencia asegure la permanencia de estos en aquella y
que opere para perfeccionarla, fortificarla y consolidarla, cosa que por lo
contario no pasaba en el pasado pues el niño vivia en el istituto.
Podriamos definir asistencia como la proteccion, la orientacion y la
promocion de la familia; la asistencia tiene que crear unos sistemas
alternativos a la familia de origen del joven cuando esta misma presenta
desventajas que pueden molestar la formacion de la identidad del joven.
Hace falta entonces:
-
Ententar solucionar todos los problemas economicos y educativos de la
familia de origen para que el menor pueda volver a vivir en ella;
39
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
-
Cuando resulta imposible que el menor vuelva a vivir con su familia
hay que crear otro medio familiar que pueda sostituir la familia
original: adopcion, familia sustituta, etc.
-
Cuando uno de los medios familiares precedentes son incapazes de
brindar al menor hay que crear otros sistemas: las casas hogares o
pequeños hogares;
-
Seria mejor elegir los institutos que alojan un gran numero de menores
solo como ultima alternativa o como sistema transitorio pues
reproducen muy poco la vida familiar.
En los ultimos quince años el sistema de pequeños hogares o casas hogares se
ha considerado como algo nuevo y revolucionario sino esto constituye por lo
contrario un regreso a las fuentes.
Tenemos que tener en cuenta que, desde siempre, la forma mas generalizada
de asistencia al niño abandonado fue la que naturalmente se ofrecia en otras
familias, parientes o no. Esta forma era la mas espontanea para atender la
necesidad, poniendo en practica la solidaridad humana; en el pasado era
posible entregar los niños sin familia a los vecinos para que atendieran a su
ciudado y educacion19. Historicamente esto resulta ser la primera aplicacion
de esta filosofia asistencial, aunque es de presumir que la accion no estaba
fundada en los mismos principios psicologicos y pedagogicos que hoy rigen:
es decir dotar al niño de una madre o de una familia que para su mejor crianza
y educacion reemplace a la natural, partiendo simplemente del principio de
respeto a los derechos del niño de recibir atencion y formación personalizada
en el seno de una familia.
En el sistema de pequeños hogares o casas hogares estaran dos grupos
diferentes de menores: aquellos cuya evolucion familiar esta operando y
puede ser que sean reintegrados en un tiempo prudencial, por lo general no
muy corto, y aquellos otros para los cuales esa posibilidad surge como remota.
19
Así resulta en las actas de la Casa de Expositos creada en 1779 durante el Virreynato.
40
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Hay que tener claro que el nuevo hogar no reemplazara ni competira con el de
origen; sera su sustituto hasta tanto aquel pueda retomar su rol fundamental.
El sistema de casas hogares para formar un conjunto que pueda asistir
verdaderamente al niño tiene que respetar unos puntos fundamentales:
-
favorecer el desarrollo de la personalizacion, socializacion y
transmision de valores de los mayores a los menores;
-
la individualizacion como presupuesto basico de todas las acciones;
-
el desarrollo de relaciones e interacciones entre todos los miembros;
-
la generacion de relaciones afectivas, de la autoestima, del respeto, de
la conducta solidaria, de los ideales del bien comun, de la generosidad,
del ejercicio de la voluntad, de la responsabilidad personal y social, ect;
-
la integracion en la comunidad;
-
la desestigmacion del menor por su integracion familiar y social y por
su formacion espiritual y educativa.
Presentacion Asosiacion Mensajeros de la
Paz de Madrid
“CARTA DE UNA ADOLESCENTE20
21 de Marzo de 1997
<...Gracias a Mensajeros de la Paz, yo he podido seguir luchando para forjar
un mañana para mi hija. Mientras he estado en Mensajeros me he dado cuenta
que ahí no he sido un número, un historial o un informe, como lo he sido en el
hogar provincial y en Amaltea, sino que me han tratado como a una persona.
He conocido lo importante que son algunas cosas como por ejemplo, sentir que
esa es tu casa, que ahí estas segura y no te van a echar a la calle cuando
cumplas la mayoría de edad; que puedes seguir luchando, haciéndote más
persona día a día, y muchas cosas más; aprender el valor que tiene una cosa
tan común como sentarte a la mesa a comer con las personas que convives,
que son totalmente diferentes a tí, pero que sin embargo están en la misma
situación o parecida y necesitan el mismo amor que tu puedas necesitar....r>
20
Desde sito web de la Asociacion
41
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Pili”
Muchos niños y jóvenes siguen necesitando apoyo social para salir de la
marginación. Son niños y jóvenes maltratados por la vida, cuya mayor
carencia es la de un Hogar y una familia que les cuide y les quiera.
La actividad principal de "Mensajeros de la Paz" consiste en acoger en los
distintos "Hogares Funcionales" con que cuenta la Asociación a niñas, niños y
jóvenes, que por problemas graves, viven fuera de un hogar familiar propio,
estable y organizado.
La “Asociacion Mensajeros de la Paz” es una Obra Social Declarada de
Utilidad Publica, cuyos fines son acoger en “Hogares Funcionales” a menores
privados de ambiente familiar o abandonados y a jovenes en dificultad social.
La Asociacion Mensajeros de la paz de Madrid surge en 1996, pero el primer
Hogar Funcional fue puesto en marcha en Oviedo el año 1967.
Desde el 1997 el presidente de la Asociacion Mensajeros de la Paz de Madrid
es Rodrigo Perez Perela.
La Asociacion Mensajeros de la Paz –Madrid forma parte del conjunto de
Mensajeros de la Paz: esta tiene su origen en el Proyecto de Regionalizacion
iniciado en el 1996; a `partir de esa fecha se ha constituido como una entidad
con personalidad juridica propia.
Su historia se puede reasumir en unas fases:
-1962: surge en Oviedo
- 1968: Casas de familias, hoy Hogares Funcionales
-1971: Proyeccion Nacional: Mensajeros de la Paz
-1980: Nueva Expansion: Colaboracion con las Comunidades Autonomas
-1991: Primer Hogar para niños con patologias especiales
-1992: Medalla de Oro de la Solidaridad
-1994: Premio Principe de Asturias de la Concordia
-1995: Expansion en America Latina: Peru, Ecuador, Mexico, Estados Unidos
y Bolivia.
42
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
-1995: Constitucion de la Asociacion “Edad Dorada” para ancianos
-1995: Constitucion de la Fundacion Telefono Dorado
-1996: Constitucion de Mensajeros de la Paz- Madrid
-1997: Creacion de Centros de Dia
-1998: Informatizacion del programa educativo de la Asociacion
-2000: Instalacion de Internet en los Hogares y Centros de Dia de Madrid
-2002: Formacion ocupacional.
Por lo que concierne sus proyectos se pueden distinguir siete tipos:
CASAS: son pisos o casas normales con dos educadores que atienden a
grupos de hermanos en numeros de 4 a 6.Hacen la vida de qualquier niño de
su edad. Este programa atiende a 130 menores.Dentro de este programa se
integran otros dos: “el programa Teseo21”y “el programa Camina22”.
PISOS: este programa atiende a 30 jovenes de uno y otro sexo que llegan a la
Asociacion con 16 años de edad y con una fuerte institucionalizacion. Dentro
de este programa se integran, a su vez, los programas “Convinvencia 23 y
“Columbia24”.
CENTROS DE DIA: estos recursos atienden a una poblacion de 125 menores
en horario extraescolar con la finalidad de evitar los problemas que una
desestructuracion familiar pudiera ocacionar.
TRABAJO DIRECTO CON FAMILIAS: asistencia a domicilio
PROGRAMA DE “REFUERZO EDUCATIVO” INDIVIDUALIZADO
PARA ESCOLARES.
PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO
FORMACION OCUPACIONAL: para jovenes entre los 16 y 25 años de
edad.
21
Este programa esta constituido por un grupo de niños con VHI, síndrome de Dwn y paralisis celebral y
que, a pesar de los esfuerzos de la Asociación, no han podido ser adoptados todavía.
22
Ete atiende a un grupo reducidos de niños que han ingresado con graves e importantes pertubaciones.
23
Se trata de favorecer la integración desde el respecto y la tolerancia de aquellos menores no
acompañados que proceden de otros paises, principalmente del Zagreb, encorporandolos en pisos con
nuestros jóvenes.
24
Este programa se realiza en un piso que, a modo de lanzadera, ayuda a jovenes que habiendo cumplido
ya los 18 años, necesitan cierto tiempo para desarrollar las aptitudes necesarias para asumir determinadas
obligaciones corespondientes a la mayoria de edad.
43
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Encuentro con el presidente de la
Asociacion Mensajeros de la Paz de Madrid
-Rodrigo Pérez Perela25, roza ya los
sesenta años, lleva desde los comienzos en Mensajeros de la Paz. Tuvo la
suerte de nacer en Ribadesella ( Asturias ) y está casado. Estudió teología,
magisterio, pedagogía y derecho. Es abogado y funcionario en excedencia. Es
el responsable general de MpazM donde lleva ya 11 años. Considera Madrid
como una plaza difícil y complicada, pero no menos apasionante. Ha
trabajado en muchas CCAA y guarda un recuerdo especial de su paso por
América Latina. Cree en la necesidad de la investigación social y espera
mucho de las Nuevas Tecnologías.-
Durante el encuentro estuvo comentandome toda la historia de la asociación y
como en los años se ha ido desarrollando, hablandome de la importancia del
plan de prevención y de asistencia a los menores, de las dificultades
economicas y cuanto hay que hacer todavia en el campo social.
Entre todo, hablando de cuanto fuera importante asistir tanto los menores de
España cuanto los de los Paises del Tercer Mundo, una frase en particular me
llamó la atención: “...tenemos que preocuparnos de los jovenes que viven
aqui; eso no quiere decir que hay que elegir, hay que hacer las dos cosas; hay
que preocuparse de los que viven en paises no desarrollados y también de los
que estan aqui...”; después siguiò disiendome: “ ¿A ti que te gusta, la playa o
25
Fuente www.elmenordigital.net
44
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
la montaña?..la ciudad o el campo? La <o> no tiene que existir sino hay que
hablar con la <y>”. Creo que lo que estuvo entendando explicarme es que
tenemos que abrirnos, ententar obrar por una comunidad que no se acaba a los
limites del territorio en el que vivimos; hay que obrar tanto en el plan de la
prevención como en el de asistencia para que esta utopía de comunidad global
pueda volverse realidad.
Después pasó a la presentación del proyecto de “El menor digital” y me contò
de la importancia de internet como medio de colaboración, participación,
integración, prevenciòn, asistencia, información y comunicación. Se trata de
un periodico virtual en el que colabora gente que apartenece a distintos paises,
gente común o con competencia; esta dividido en varios sectores y cada sector
contiene noticias de distintas regiones: España, Europa, Norteamérica,
Latinoamérica, Paises Árabes y Resto del Mundo. El echo de que pueda
colaborar cualquiera, demuestra cuanto se pretende usarlo como herramienta
que facilite la colaboración entre todos; esta claro sin embargo que cada uno
colabore siempre en relación a sus competencias: por ejemplo, en mi caso el
señor Pérez me ofreció colaborar poniendo una o dos veces a la semana unas
noticias de Italia que se refieran a los menores traduciendo el titulo en español
pero poniendo la noticia en italiano, o de escribir un artculo sobre los centros
de día de Italia pues mi tesis habla tambièn de esto; pero también hay gente
que tiene mas competencia y que intenta crear una verdadera red social que
pueda ayudar a crear un trabajo común. El echo que las noticias salen en
idioma original o que mandan a la fuente original ya es un signo de querer la
participación de cualquiera permitiendo también a los que non conozcan el
idioma de ponerse en contacto o coger informaciones de otros paises.
Después me habló de otro proyecto que ententa ocuparse de jovenes que
tienen ya la mayor edad y que después de esta el ayuntamiento pretiende que
se vayan de los hogares contribuyendo de esta manera a que estos se
encuentran en situación de riesgo social.
Finalmente otra cosa que dijo el señor Perez me llamó la atención: “...la cosa
mas importante son los chicos; yo siempre he trabajado para que mis chicos
45
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
tengan una vida normal; lo importante es defender los derechos de estos
chabales, ¡porque se lo merecen!...”.
Para esta asociación es importante ofrecer a estos chicos asistencia, lugares
donde vivir, jugar, aprender sin que estos pero pierdan la posibilidad de hacer
una vida “normal”, como los demás digo. Es importante que estos jovenes
siempre tengan la sensación que sean como los demás para que puedan tener
buenas relaciones y para que se redusca el riesgo que estos se vuelvan los
rechazados de la sociedad.
46
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
2.4
Analogías y diferencias entre España e Italia (E)
En este contesto creo que hacer una comparación entre España e Italia, ( y por
tanto una comparación entre el plan de asistencia y aquello de la prevención),
sea en algun sentido la contradición de todo lo que habría querido trasmitir
verdaderamente.
Desde el pricipio he querido poner en evidencia la importancia de obrar en las
dos direcciónes, pues creo que están estrictamente conectadas la una a la otra:
no se puede pensar en solucionar el fenómeno de la desviación juvenil
ofreciendo ayuda sólo a aquellos que ya forman parte de esta, ni abandonarlos
e intentar salvar aquellos que aún resultan estraños al problema; como
podemos ver todo debe concretarse en un único plan de protección.
La confirmación de lo que he dicho la he tenido a través de mi breve
esperencia en el “Centro Allegra Compagnia di Mesagne” y aquella en la
“Asociación Mensajeros de la Paz de Madrid”: no obstante estos centros han
sido creados para obrar en dos direcciones distintas, poco a poco ha resultado
dificil delimitar las dos tipologías de intervención; idear y construir un plan de
prevención y un plan de asistencia separadamente serìa util sólo para la
organización de los recursos, el espacio de intervención, para el investigador,
pero concretamente resultaría ineficaz e inútil: en esto caso si contribuiría a la
sola construcción de modelos abstractos que en teoría podrían funcionar pero
en la realidad no, pues no tendrían en cuenta posibles variables. Variables que
de ninguna manera deben descuidarse, pues no se trata de números o de
casos, sino de personas y de las condiciones ambientales en las que estas
viven; entonces aún hipotéticamente por ejemplo “Allegra Compagnia” ha
sido ideado como instrumento para garantizar la cura del territorio,
personalmente me ha sido posible constatar que también los pequeños
problemas de cada sujeto no vengan descuidados. La idea que une las dos
tipologías es el echo de considerar el joven en su concreteza para un
mutamiento común; esto es uno de los puntos fundamentales que asegura la
mutación de la sociedad y que se puede constatar retratando la teoría
47
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
sociológica26, entendiendo por mutamiento el cambio de la organización
social para que pueda satisfacer aún más las necesidades de los individuos que
cambian con el paso del tiempo.
Para una comparación de igual medida entre España e Italia preferíría
comparar sólo el plan de la prevención, de echo en Madrid he decidido ir a un
centro socio-educativo parecido a “Allegra Compagnia”: la “Asociación
Mensajeros de la Paz” de Madrid además de ofrecer asistencia disponendo
para los jovenes de unos hogares en los se puedan vivir, ha creado también los
centros de día para que los jovenes que tengan problemas en us casas tengan
la posibilidad de salir de esta y evitar que también estos chicos entren en la
segunda tipología de intervención, osea que vengan enviados a los hogares
creados por la asociación.
Dadas las enormes dimensiónes de Madrid, la ciudad está dividida por barrios,
así que en cada barrio “la Asociación MpazM” ha decidido crear un centro de
día en relacción a las problematicas de cada barrio. Yo personalmente he
estado en el centro que se encuentra en el barrio de “Hortaleza”, exactamente
en la zona de “San Lorenzo” que está en la zona norte de Madrid capital.
De el encuentro con la coordinadora, Alicia Calvo Rojo, me ha sido posible
encontar las problematicas que estos centros, no obstante se encuentran en
distintos paises, encuentran en su destino: así como “Allegra Compagnia”,
también este centro de día de Hortaleza tuvo que sufrir una disminución del
equipo, de echo también en el caso de Madrd los educadores han disminuido,
así que la coordinadora obra en primera persona, como educadora,
descuidando obligatoriamente la organización, obrando además de manera
superficial, pués la falta de recursos economicos: hay que señalar que por lo
general la “Asociación MpazM” tuvo un recorte de casi el 50% en los
recursos económicos, tanto que a comparación con los varios proyectos
resutan totalmente insuficientes.
26
Sobre el individualismo metodologico.
48
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
El problema resulta ser siempre el mismo: si las instituciones tienen que
recortar los gastos, empiezan desde el campo social; lamentablemente esta
manera de pensar de que estos proyectos son como algo más en el campo de la
prevención y de la asistencia hace que la posibilidad de un mutamiento global
sea menos concreta, un cambio general de la sociedad que ponga en primer
plan el individuo y no las necesidades de la organización social.
Procedendo con el analisis de los servicios ofrecidos por el centro de
Hortaleza, también aqui, así como en “Allegra Compagnia”, me ha sido
posible evidenciar algunas carencias: por ejemplo la falta de internet; internet
es lo que hoy une a las nuevas generaciones, es su medio de comunicación, es
lo los ayuda a crear relaciones, sobretodo para los jovenes con problemas que
con este medio tienen, en vez, menores dificultades. Internet podria llegar a
ser definido como un espacio social en el que los jovenes tengan la posibilidad
de socializar, de integrarse, de aprender y entonces ¿cómo es posible que
todavía hoy los ayuntamientos no lo dispongan de manera imediata? Debemos
considerar como un verdadero fallo según mi punto de vista el echo que no se
utilizan estas herramientas, sobretodo en un ámbito como el centro de día en
el que el joven podría tener la posibilidad de utilizar libremente este espacio
teniendo también la posibilidad de que lo orienten, pues no tenemos que
olvidar sin embargo que internet es un lugar no protegido que podría orientar
de manera equivocada al joven aún mas si este no tiene puntos de referencia o
alguien que pueda ayudarlo a orientarse.
Otro aspecto común a los dos centros es la escasa colaboración con la escuela:
a través de la entrevista con la educadora de “Allegra Compagnia” ha
resultado que la escuela tiende a definir estos centros como lugares para
jovenes en riesgo rechazando la idea de que sean centros para todo el mundo,
así que la colaboración con la escuela se limita a la señalación por esta misma
de unos estudiantes que tienen dificultades en el aprendizaje causado en
primer lugar por problemas familiares; la misma cosa ocurre en el centro de
Hortaleza: la escuela señala a los jovenes que presentan problemas a los
servicios sociales y después estos se asignan a los centros de día. Una de las
49
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
diferencias pricipales entre los dos tipos de centro está en el echo de que en el
centro de Hortaleza puedan aceder sólo los que resultan en los registros de los
servicios sociales, cosa que , a contrario de “Allegra Compagnia” estigamtiza
aún más a los jovenes que forman parte de estos, creando en ellos una
sensación de diversidad que pueda prejudicar negativamente las relaciónes
con otros que viven, por lo contrario, en una situación de “normalidad”.
Desgraciadamente el problema otra vez es un problema que está en la base de
la sociedad: todavía no es comprendida la importancia de crear espacios
comunes, es decir espacios en los que al mismo tiempo acogen jovenes en
riesgo y no, para una socializació común, para que además puedan evitar crear
grupos no compatibles. Sin embargo “la Asociación MpazM” de Madrid ha
demostrdo que este es uno de sus objetivos, de echo los jovenes que viven en
los hogares creados por la asociación hacen una vida normal: la asociación
non los “encierra”, sino intenta facilitar sus integraciones en la sociedad,
ayudándolos a entrar en la cotidianidad de sus coetaneos que viven una vida
“normal”(común).
Sin obiar las problematicas análogas a los dos centros socio-educativos, hay
que decir que en el centro de Hortaleza hay una colaboración mayor con las
institucones independientes a la asociación; de echo cada vez que uno de los
jovenes presenta unos problemas (poca higiene, poca participación en lo
deberes,...) rápidamente las educadoras señalan el problema a los servicios
sociales: como podemos ver el margen entre el plan de asistencia y prevención
es minimo: de la asistencia a la prevención, de la prevención a la asistencia, de
los jovenes al joven o al contario; todo es un circulo vizioso y debe ser tal si
se quiere realmente solucionar el problema y no sólo dejarlo en una esquina.
50
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
2.4
Analogie e differenze tra Spagna e Italia (I)
In questo contesto credo che fare un confronto tra Spagna e Italia, (e quindi un
confronto tra il piano dell’assistenza e quello della prevenzione), sia in un
certo senso la contraddizione di tutto quello che avrei voluto in realtá
trasmettere.
Fin dall’inizio ho voluto mettere in evidenza l’importanza di operare in
entrambe le direzioni, in quanto credo siano strettamente connesse l’una
all’altra: non si puo’ pensare di risolvere la devianza giovanile offrendo solo
aiuto a coloro che ne fanno gia’ parte ne abbandonare questi ultimi e cercare
di salvare coloro che ancora risultano essere estranei al problema; come
vediamo il tutto si deve esaurire in unico piano di protezione.
La conferma di quanto detto l’ho avuta grazie alla mia breve esperienza verso
il “Centro Allegra compagnia di Mesagne” e quella della “Asociación
mensajeros de la paz di Madrid”: nonostante questi siano stati ideati per
operare in due direzioni distinte, pian piano in realtá é risultato difficile
delimitare le due tipologie d’intervento; ideare e costruire un piano della
prevenzione e un piano dell’assistenza separatamente sarebbe utile solo per
poter organizzare le risorse, lo spazio d’intervento, per il ricercatore, ma
concretamente risulterebbe inefficiente e inutile: si contribuirebbe in questo
caso alla sola costruzione di modelli astratti che in teoria potrebbero
funzionare ma in realtá no, in quanto non terrebbero conto di eventuali
variabili. Variabili che in nessun caso devono essere trascurate, perche’ non si
parla di numeri, di casi, ma di persone e delle condizioni ambientali in cui
queste vivono; quindi anche se ipoteticamente per esempio “Allegra
Compagnia” é stato ideato come strumento per garantire il risanamento del
territorio, personalmente mi é stato possibile constatare che anche i piccoli
problemi di ogni singolo soggetto non vengono trascurati. L’idea che
accomuna entrambe le tipologie é il fatto di considerare il giovane nella sua
concretezza per un mutamento comune; questo é uno dei punti fodamentali
che assicura il mutamento della societá e che si puo constatare ripercorrendo
51
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
la storia del pensiero sociologico27, intendendo comunque sia per mutamento
il cambiamento dell’organizzazione sociale affinché possa soddisfare
maggiormente i bisogni degli individui che col tempo si susseguono e
cambiano.
Per un confronto alla pari tra Spagna e Italia preferirei mettere a confronto,
invece, solo il piano della prevenzione, tanto che a Madrid ho deciso per ovvie
ragioni di recarmi in un centro socio-educativo simile ad Allegra Compagnia:
la “Asociaciòn Mensajeros de la paz de Madrid” oltre ad offrire assistenza
mettendo a disposizione dei giovani gli “hogares” (le case famiglia) in cui
poter vivere, ha creato anche “los centros de día”, che sarebbero dei centri
socio-educativi in cui giovani che hanno problemi in casa hanno la possibilità
di starne fuori per evitare che anche questi passino alla seconda tipologia
d’intervento, ossia che vengano trasferiti alle case famiglie create appunto
dall’associazione.
Data la grandezza della capitale spagnola, Madrid è divisa nei cosiddetti
“barrios”: ognuno di questi rappresenta un gruppo di quartieri e ogni gruppo
ha un proprio comune; proprio per questo motivo, la “asociacion MpazM” ha
deciso di creare in ogni “barrio” un centro socio-educativo relativamente alle
problematiche che caratterizzano i vari quartieri. Io personalmente mi sono
recata al centro che si trova nel “barrio Hortaleza”, precisamente nella zona di
“San Lorenzo” che la ritroviamo nella zona nord di Madrid capitale.
Dall’incontro con la coordinatrice del centro, (Alicia Calvo Rojo), mi è stato
possibile individuare le problematiche che questi centri, nonostante la
collocazione in diversi paesi, sono destinati ad incontrare: così come “Allegra
Compagnia” anche “El Centro de día de Hortaleza” ha subito una graduale
diminuzione dell’equipe, difatti anche in questo caso gli educatori sono
diminuiti, tanto che la coordinatrice opera in prima persona, come educatrice,
lasciando poco spazio, per forza di cose, all’area organizzativa, operando per
di più in maniera più frivola data la mancanza di risorse economiche: c`é da
27
Mi riferisco alla parte relativa all’individualismo metodologico..
52
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
segnalare che in generale la “Asociaciòn MpazM” ha subito un taglio netto
delle risorse economiche a sua disposizione, quasi di un 50%, che a confronto
con i vari progetti messi a punto dall’associazione risultano essere nettamente
insufficienti. Il problema risulta essere sempre lo stesso: se il governo ha dei
tagli da fare, il primo sarà sempre nel campo sociale; purtroppo questa
tendenza a ritenere questo tipo di iniziative come un qualcosa aggiuntivo
nell’area della prevenzione e dell’assistenza rende sempre meno concreta la
possibilità di un mutamento sociale globale, un netto cambiamento della
societá in generale che metta finalmente in primo piano l’individuo e non più i
bisogni dell’organizzazione sociale.
Procedendo con l’analisi dei servizi offerti dal centro di Hortaleza, anche qui,
così come in Allegra Compagnia, mi è stato possibile sottolineare una certa
carenza: per esempio la mancanza di internet; internet è ciò che unisce le
nuove generazioni, è il loro mezzo di comunicazione, è ciò che li stimola a
creare delle relazioni, specie per i giovani con problemi che con questo mezzo
hanno invece minori difficoltà. Internet potrebbe essere definito come uno
spazio sociale in cui giovani hanno la possibilità di socializzare, d’integrarsi,
di apprendere, quindi com’è possibile che ancora oggi le amministrazioni
stentino ad usufruirne? Dobbiamo considerare come un vero e proprio errore,
dal mio punto di vista, il fatto di non sfruttare questi strumenti, specie in un
ambito, come “el centro de día”, in cui il giovane potrebbe avere non solo la
possibilità di usare liberamente questo spazio ma anche di essere guidato,
perchè comunque non dobbiamo dimenticare che intenet è un “luogo” di
socializzazione non protetto che potrebbe ulteriormente disorientare il giovane
se questo non ha dei punti di riferimento o qualcuno che lo guidi.
Altra cosa che accomuna i due centri è la scarsa collaborazione con la scuola:
dall’intervista con l’educatrice di Allegra Compagnia è risutato che la scuola
tende a definire questi centri come luoghi per i giovani a rischio, rifiutando
l’idea che questi siano dei centri destinati a tutti, tant’è vero che la
collaborazione della scuola si limita alla segnalazione degli studenti che hanno
difficoltà nell’apprendimento causato principalmente dai problemi familiari;
53
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
la stessa cosa avviene per il centro di Hortaleza: la scuola segnala i giovani
che presentano dei problemi ai servizi sociali e dopo di che questi vengono
assegnati al centro. Una delle differenze principali tra i due tipi di centri è il
fatto che nel centro di Hortaleza possano accedere solo coloro che risultano
nel registro dei servizi sociali, cosa che, a differenza di “Allegra Compagnia”,
stigmatizza maggiormente i giovani che ne fanno parte suscitando in loro una
sensazione di diversità che potrebbe ricadere negativamente nei rapporti con
altri che vivono invece in una situazione di “normalità”. Purtroppo il problema
ancora una volta é un problema di fondo: ancora incopresa è l’importanza di
creare spazi comuni, ossia spazi che allo stesso tempo accolgano giovani a
rischio e non, per una socializzazione comune, affinchè si possa evitare di
creare dei gruppi incompatibili. La Asociacòn Mensajeros de la Paz ha
comunque dimostrato che quanto detto rientra nei loro obiettivi, difatti i
giovani che vivono negli “hogares” creati dall’associazione fanno una vita
normale: l’associazione non li “chiude”, ma cerca di facilitare la loro
integrazione nella società, aiutandoli ad entrare nella quotidianità dei loro
coetanei che vivono una vita “normale”.
Nonostante le problematiche che accomunano i due centri socio-educativi, c’é
da dire che nel centro di Hortaleza c’è una maggiore collaborazione con le
istituzioni indipendenti all’associazione; difatti ogni qualvolta uno dei giovani
presenta dei problemi particolari immediatamente le educatrici segnalano il
problema ai serviza sociali: come vediamo la soglia tra il piano della
prevenzione e dell’assistenza è minima; dall’assistenza alla prevenzione, dalla
prevenzione all’assistenza, dai giovani al giovane o viceversa: il tutto è un
circolo vizioso, e deve essere tale se si vuole realmente risolvere il problema
della devianza giovanile e non solo accantonarlo.
54
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Conclusiones (E)
¿Si los jovenes son la base de la sociedad, los jovenes hacen de esta una
“sociedad del riesgo”?
Los riesgos siempre han existido: “no son una invención de la modernidad”
(Beck: 1992°,21); lo que ha sido producto de la modernoidad son los aspectos
que definen los riesgos que contribuyen de esta forma a la configuración de la
sociedad postmoderna como una “sociedad del riesgo 28”.
Pa dar una contestación a esta pregunta tendría que existir, antes de nada, una
exsacta definición del riesgo: “el riesgo representa la probabilidad que una
persona o una cosa sufran un daño, por efecto de una determinada fuente, osea
el peligro”; esto nos deja entender que en realidadel riesgo no es algo real , de
cocreto sino la suposición de “alguien”que en relación a su propio mundo
percibe un determinado factor como algo que pueda provocar lo que según el
es un daño; esto no quiere decir que efectivamente el riesgo es tal como es,
pero el peligro si que lo es.
Todo esto reconducido a los jovenes en riesgo nos dejha entender que en
realidad para evitar aqul posible riesgo no deberiamos concentarnos en esto
que es abstarcto, sino en al fuente que es real: como consecuencia para
solucionar la devianza jeuvenil no se debería obrar en el jovenes en riegso,
sino en la fuente que podría generar aquel riesgo.
Todo es relativo, subjetivo, pero el objetivo, en qualcuier proyecto de
solucionar un fenomeno social, tendría que ser lo de individuar la objetividad
en lo subjetivo, osea actuar en relación al echo concreto sin perder de vista la
fuente que representa lo que es la parte general: se debería pensar siempre en
que “la objetividad no es una mito.”
Los jovenes en riesgo son una construcción de la sociedad, no son la menaza
sino la consecuencia de unas distintas situaciones que inducen los individuo a
adoptar unas actitudews y otros a percebir estas como peligrosas.
28
Urlich Beck creió el termino “risk society” en el 1984.
55
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Por todo lo que he dicho creo que sea mas adeguado en materia de devianza
juvenil orientarse en principio en el plan de la preveción iendo poco a poco
en el nivelk micro en el momento que se presentan unas situacione
particulares.
Seguramente el querer ententar la objetividad en los planes de la prevención
muchaz veces hace que la asistencia sea menor por cada persona, pero para
evitar esto sería coreto ponerse como finalidad “ayudar el individuo”, tenendo
como punto de referencia el echo que para solucionar estos tipos de
fenomenos no será nunca posible desarrollar una verdadera estrategia
escntifica, pués el objeto de esta estrategia no es un objeto costante, sino un
subjeto que cambia de manera continua fortemente influido por el ambiente a
su alrededor.
56
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Conclusioni (I)
Se i giovani sono la base della societá, i giovani a rischio fanno
di questa una “societá del rischio”?
I rischi sono sempre esistiti: “non sono un´invenzione della modernitá”(Beck:
1992a,21); ció che é stato prodotto dalla modernitá sono gli aspetti che
definiscono i rischi che contribuiscono cosí alla configurazione della societá
postmoderna come una “societá del rischio 29”.
Il giovane a rischio é prodotto della stessa società: è la società che lo definisce
tale e di conseguenza è la società che nel suo insieme deve collaborare
affinchè questi stereotipi cessino di esistere attraverso lo scambio reciproco tra
individuo, istituzioni e società in generale.
Per dare una risposta a questa domanda dovrebbe esistere, innanzitutto, una
precisa definizione del rischio: “il rischio rappresenta la probabilitá che una
persona o una cosa subiscano un danno, per effetto di una determinata fonte,
ossia il pericolo”; ció ci lascia intedere che in realtá il rischio non é un
qualcosa di reale, di concreto ma la supposizione di “qualcuno”, che in
relazione al proprio mondo, percepisce un determinato fattore come un
qualcosa che possa provocare ció che secondo lui é un danno; ció non vuol
dire che effettivamente il rischio sia tale, contrariarmente il pericolo peró lo é.
Tutto ció ricondotto ai cosidetti giovani a rischio ci fa intendere che in realtá
per evitare quel eventuale rischio non dovremmo concentrarci su quest’ultimo,
che é astratto, ma sulla fonte che é reale: di conseguenza per soluzionare la
devianza giovanile non si dovrebbe operare sul giovane a rischio, ma sulla
fonte che potrebbe generare quel rischio. Il tutto é relativo, soggettivo, ma
l’obiettivo, in un qualsiasi progetto di risoluzione ad un fenomeno sociale,
dovrebbe essere quello di individuare l’obiettivitá nella soggettivitá, ossia
agire in relazione al fatto concreto senza perdere di vista, peró, la fonte che
29
Urlich Beck creó il termine “risk society” nel 1984.
57
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
rappresenta ciò che é la parte generale: si dovrebbe tenere a mente che
“l’oggettivitá non é un mito” 30 .
I giovani a rischio sono una costruzione della società, non sono la minaccia
ma la coseguenza di una serie di situazioni che inducono gli individui ad
adottare determinati comportamenti e altri a percepire questi come pericolosi.
Premesso tutto questo, credo che sia adeguato, in tema di devianza giovanile,
orientarsi inizialmente sul piano della prevenzione, indirizzandoci pian piano
anche
livello micro man mano che si presentano determinate situazioni
specifiche.
Sicuramente il voler ricercare l’oggettività nei piani della prevenzione spesso
implica una minore assistenza a livello individuale, ma per evitare ció sarebbe
corretto porsi come finalitá “aiutare l’individuo”, avendo come punto fermo il
fatto che per soluzionare questo tipo di fenomeni non sarà mai possibile
elaborare una vera e propria strategia preventiva e assistenziale scientifica, in
quanto l’oggetto di tale strategia non é un oggetto costante, ma un soggetto in
continuo mutamento fortemente condizionato dall’ambiente che lo circonda.
58
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Bibliografia
Andreoli Vittorino, “Giovani”. Milano: Rizzoli 1995
Antonimi Walter, “Condotta deviante e servizi di assistenza nella
legislazione minorile”. Napoli: Novene, c1982
Juli E. Aparicio [et al.] “Pequeños hogares : una alternativa válida de
asistencia para menores.” Buenos Aires : Hvmanitas: Asosiación
Argentina para Unicef, 1986
Claudio Baraldi, Elisa Rossi (a cura di) “La prevenzione delle azioni
giovanili a rischio”. Milano: Angeli 2002
Beck, Ulrich, “La sociedad del riesgo global”Madrid : Siglo Veintiuno,
D.L.2002
Bernuz Beneitez, María José (a cura di) “De la protección de la infancia a
la prevención de la delincuencia”Zaragoza: El justicia de Aragòn,1999
Borzaga Carlo, “Manuale di politica sociale”. Milano, Angel 2005
Buccoliero Elena, “Bullismo, bullismi: le prepotenze in adolescenza
dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento”. Milano: F.Angeli 2005
Franco Cambi, Grazia Dell'Orfanello, Sandra Landi ( a cura di) “Il
disagio giovanile nella scuola del terzo millennio : proposte di studio e
intervento”. Roma : Armando, 2008
Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli, Antonio De Lillo (a cura di), “Giovani
del nuovo secolo: quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in
Italia. Bologna: Il mulino, 2002
Castro Enrique de, ” ¿Hay que colgarlos? : una experiencia sobre
marginación y poder”. Madrid: Editorial Popular, D.L. 2008
59
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
G. Cattanei ... [et al.]”Socializzazione del bambino, processo educativo e
scelte didattiche”. Brescia : La scuola, c1990
Cicognani, Elvira.”Genitori e adolescenti”. Roma : Carocci, 2003
Costantini,Alessandro“Tra regole e carezze : comunicare con gli
adolescenti di oggi”. Roma:Carocci, 2002
Crespi, Franco,” Il pensiero sociologico”. Bologna : Il mulino, c2002
Vito A. D’armento, “Atti del Convegno I diritti dell'infanzia : Lecce,15-16
dicembre 1979”. Lecce : Adriatica editrice salentina, [1985?]
De Leo, Gaetano, ”L'adolescenza lunga : problemi psicosociali e
criminologici dei giovani adulti”. Milano : UNICOPLI, 1992 (stampa
1995)
Octavio García Pérez (director), José Luis Díez Ripollés, Fátima Pérez
Jiménez, Susana García Ruiz (a cura di),” La delincuencia juvenil ante los
juzgados de menores”. Valencia : Tirant lo Blanch, 2008
Kazdin, Alan E.,”Conducta antisocial : evaluación, tratamiento y
prevención en la infancia y adolescencia” Madrid : Pirámide, 2001
Matza, David,”Come si diventa devianti”. Bologna : Il mulino, 1976
Miguel Melendro Estefanía, “Estrategias educativas con adolescentes y
jóvenes en dificultad social: el tránsito a la vida adulta en una sociedad
sostenibile”. Madrid : UNED, 2007
Merico Maurizio, “Giovani e società”.Roma : Carocci, 2004
José Carlos Mingote, Miguel Requena ( a cura di),” El malestar de los
jóvenes : contextos, raíces y experiencias”. Madrid : Díaz de Santos, 2008
60
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Montero Hernánz, Tomás, “Los debates abiertos sobre la delincuencia
juvenil en España”. Madrid: La Ley-Actualidad, 2009
Felipe Morente Mejías (dir.) ; Inmaculada Barroso Benítez, Mario
Domínguez Sánchez (coor.), Gillian Green, “El laberinto social de la
delincuencia : jóvenes adolescentes en la encrucijada”. Madrid :
Dykinson, 2008
Franca Pinto Minerva,” Mediterraneo : mare di incontri
interculturali”.Bari:Progedit, 2004
Rizzo, Ritalma,” Socializzazione e adozione fra integrazione e critica”.
Lecce : Adriatica, c1992
San Juan Otermin, Juan, “Los jóvenes ante el problema de la
delincuencia”.Pamplona : Emilio García Enciso, 1910
Santo, Annamaria ”Socializzazione e comunicazione”. (1978)
Semeraro, Angelo “Pedagogia e comunicazione : paradigmi e
intersezioni”.Roma : Carocci, 2007
Segre, Sandro “La devianza giovanile : cause sociali e politiche di
prevenzione”.Milano : F. Angeli, 1996
61
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Appendice (Apéndice)
Articolo pubblicato su www.elmenordigital.net il 4 Giugno 2009.
(Articulo publicado en www.elmenor.digital.net el 4 Junio de 2009)
Figura 1-2: presentazione dell'articolo nel quotidiano virtuale "El menor digital" dell' associazione
MpazM . ( Presentaciòon dell articulo en el periodico virtual “El menor diital” de la asociaciòon
MpazM.
62
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Martes, 04 de Junio de 2009
“Diez abrazos en una sola tarde”.
Un día en el centro de Hortaleza.
-Madrid, Centro de día “Celia Viñas”- He pasado unas pocas
horas con diez niños del centro de día de Hortaleza; el más
pequeño tenía cinco años, el mayor diez. Es el grupo más
pequeño que frecuenta el centro.
Soy una estudiante italiana de sociología y mi tesis me ha
llevado hasta Madrid para hacer una pequeña investigación sobre
los jóvenes que se encuentran en una situación de riesgo. He
tratado este problema desde varios puntos de vista, haciendo
referencia a las teorías sociológicas, he tratado de informarme
sobre la metodología que se utiliza en estos centros, no obstante
algo empezaba a faltar. Estos son problemas reales, y tal como
son, si verdaderamente se quieren analizar hay que verlos de
cerca.
Hasta que llegaron los niños estuve con la coordinadora y la
educadora, las dos me enseñaron el centro y me presentaron las
distintas actividades que ahí se realizan; estuve pensando todo el
tiempo en como organizarme el trabajo o de que hablar y seguí
así hasta que llegó la primera niña, en aquel momento me olvidé
de todo esto. Ni siquiera pasaron cinco minutos, y ya esta
pequeña me estuvo hablando como si me conociera desde
siempre; poco a poco empezaron a llegar los demás. Intenté
acercarme a ellos mientras estaban de recreo antes de empezar
los deberes, “¡qué fácil fue relacionarme con ellos!”.
Seguramente alguien pensará que no hay nada de raro en que sea
muy fácil relacionarse con los niños, pues por su naturaleza son
mas sociables que los adultos, pero tengo que ser sincera y
admitir que casi tenía prejuicios en las actitudes que pudieran
tomar estos niños: no creía que pudieran tener toda esta gana de
jugar, aprender, relacionarse con gente extraña como yo después
de venir de lugares como sus casas en los que tienen mil
problemas, porque hay que tener claro que son niños señalados
por los servicios sociales y asignados a estos centros; esto me
sorprendió bastante. Los niños tienen una fuerza que los adultos
poco a poco se dejan atrás; tienen mucha curiosidad por conocer
un mundo lejano y de enfrentarse con esto, de echo no dejaban de
63
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
hacerme preguntas sobre Italia, por ejemplo querían que les
hablara un poco en italiano.
La idea de estos centros no sólo es crear un lugar donde estos
niños puedan relacionarse con aquellos que tengan sus mismos
problemas, sino que descubran que fuera de su realidad existe
también otro mundo en el que pueden tener mas oportunidades
de vivir una vida distinta de la que hacen.
Cada niño tiene su historia y es muy importante que estas
historias se compartan para que así puedan darse cuenta de que lo
que les sucede no depende de ellos, sino de las dificultades que
pueden encontrar sus familias, y para que entiendan que no son
los únicos en vivir situaciones particulares. De este modo podrían
encontrar alternativas a lo que suelen hacer, como por ejemplo la
delincuencia en la calle o la dependencia a las drogas. Modificar
estas conductas no quiere decir que haya que dejar atrás las
particularidades que caracterizan a cada niño y su origen, como
las distintas tradiciones que heredan de sus padres, sino justo lo
contrario, debemos intentar crear una sociedad donde las distintas
culturas puedan convivir, una sociedad donde una cultura no se
imponga a la otra, y para hacer esto hay que empezar de lo
particular de la sociedad (como las historias individuales) para
extender en seguida esta mentalidad a la sociedad entera en la
que el niño o el joven pueda expresar libremente sus opiniones,
sus problemas, profesar su religión, etc.
Los niños son los fundamentos de la sociedad, hay que
protegerlos antes de que entren en situación de riesgo y no sólo
cuando el riesgo ya se ha hecho realidad.
Los niños no tienen culpa, no son ellos que eligen donde
nacer, donde vivir y con quién vivir y en aquellos casos
desfavorables donde no están asistidos como merecen debe
actuar la sociedad, una sociedad que no solo se refiere a las
instituciones sino también al compromiso que cada individuo
debe tomar para ayudar a los niños a que cambien una realidad
que todavía se muestra cerrada a la interculturalidad.
Entonces ¿que mejor manera de enseñar a estos niños a tener
una mentalidad más abierta que permitiéndoles frecuentar un
lugar donde puedan relacionarse con culturas diferentes?
El problema es que las instituciones validan estos centros sólo
como lugares alternativos a la calle: no es así, es mucho más; es
el principio de un mundo intercultural.
64
Giovani a rischio: assistenza e prevenzione
Como ya he dicho, si quisiéramos analizar y también
solucionar los problemas de los jóvenes en riesgo, hay que verlos
de cerca; yo no he tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo
con ellos ni ver como son los hogares creados por la asociación
donde viven otro jóvenes, tan solo he tenido la posibilidad de
conocer estos diez niños que en una sola tarde me han dado
afecto sin que yo le pudiera ofrecer nada; por tanto pido a
cualquiera de intentar corresponder a lo que los niños nos dan,
mucho más que “un abrazo o una sonrisa”, ofreciéndoles una
sociedad no a dimensión de adultos, sino un mundo que sea
también de y para ellos.
Los niños tienen un peso en la sociedad todavía superior de lo
que se piensa y es por esto que hay que defender y hacer realidad
sus derechos. Los niños no son objeto de tutela, sino ésta es un
derecho esencial de los niños.
Angela Dicarlo
65