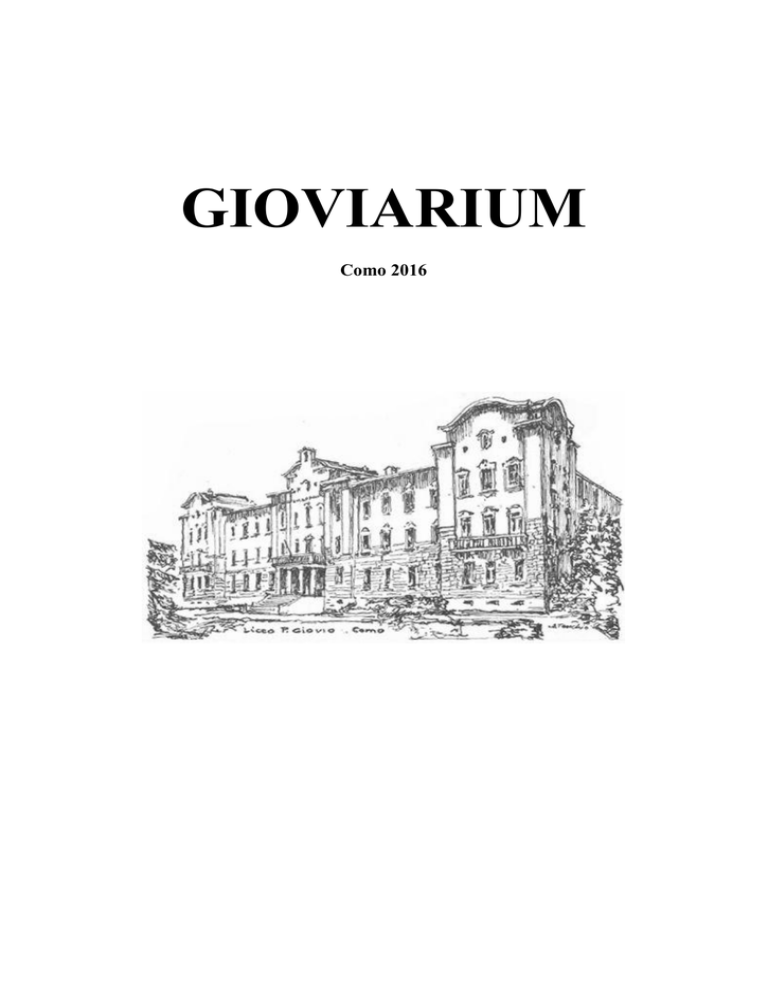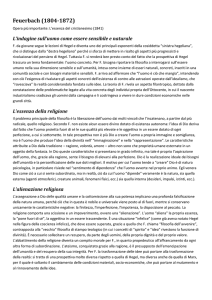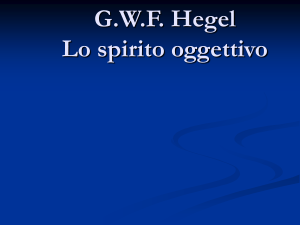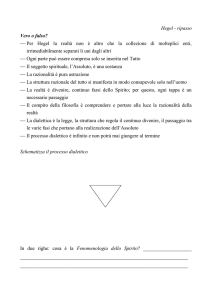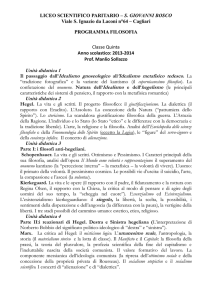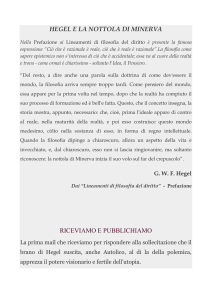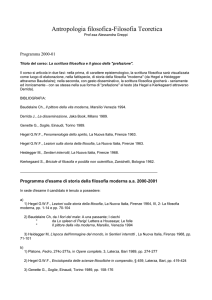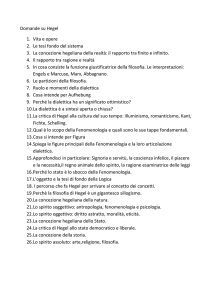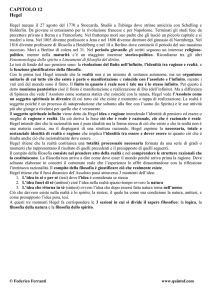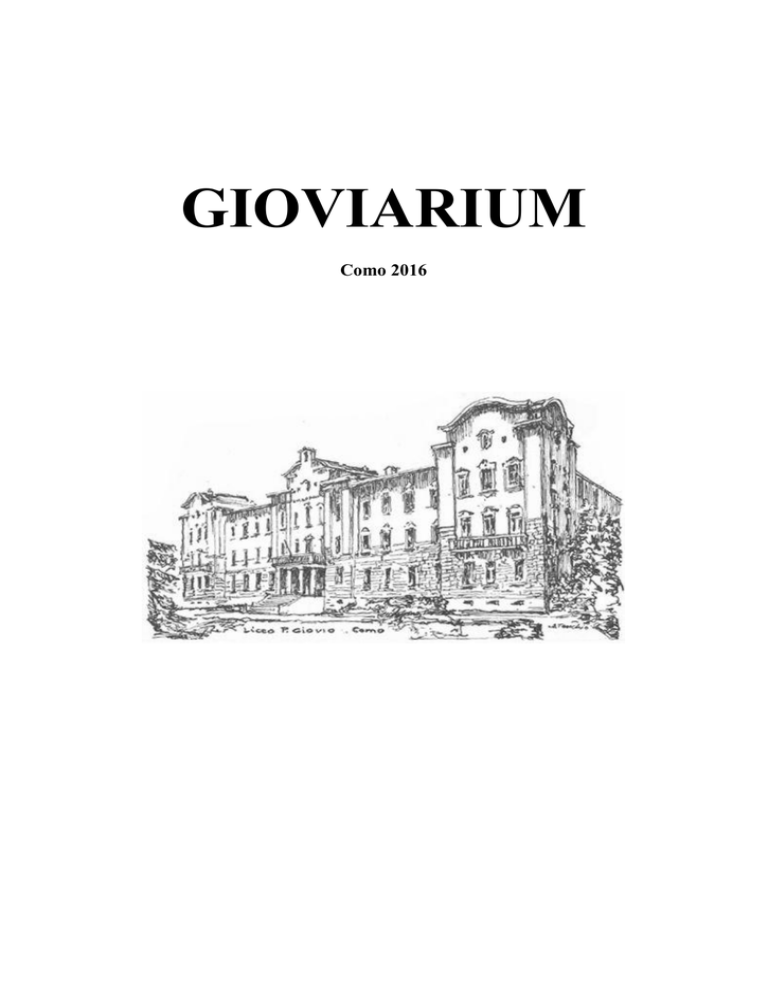
GIOVIARIUM
Como 2016
PREFAZIONE
Abbiamo riunito in questo agile testo (pro manuscripto) alcuni articoli
elaborati in questi anni e già ospitati in parte sul sito del nostro Liceo.
Ci sembrava giusto aprire la rassegna con un profilo di Paolo Giovio, per
meglio conoscere questo illustre letterato comasco, cui dobbiamo il nome del nostro
Liceo. Non poteva poi mancare una presentazione della recente attività poetica del
collega Alessandro Quattrone.
Seguono alcuni saggi di storia della filosofia antica, moderna e contemporanea.
Questo lavoro, sia ben chiaro, non è una pubblicazione, ma semplicemente
l’idea di quanto si potrebbe realizzare in futuro.
Infatti per una pubblicazione concreta ci vorrebbe un progetto che fosse
finanziato e che nascesse da un lavoro condiviso.
Questa raccolta va quindi considerata come un esperimento ed un prototipo di
un eventuale annuario o di un libro miscellaneo che sia il risultato di un iter reale di
confronti e di sinergie.
Il Comitato Editoriale
1
SOMMARIO
Paolo Giovio, un simbolo del Rinascimento (L. Picchi)
Tra ombre e distanze la poesia di Alessandro Quattrone (L. Picchi)
Simmel e la modernità (P. Scilironi)
L’amore platonico (G. Giudice)
Hegel nella cultura francese del Novecento (P. Scilironi)
2
PAOLO GIOVIO, UN SIMBOLO DEL RINASCIMENTO
Luigi Picchi
Considerare la figura di Paolo Giovio significa avvicinarsi al Rinascimento
attraverso uno dei suoi personaggi più emblematici e completi.
Difatti nell’uomo e nel personaggio Paolo Giovio possiamo ritrovare le caratteristiche
salienti di quell’epoca.
Il Nostro nasce a Como nell’aprile del 1483 da Luigi Zobio, notaio di famiglia
patrizia, e da Elisabetta Benzi, appartenente ad una gens originaria dell’Isola
Comacina, economicamente non potente, ma prestigiosa e considerata patrizia.
Il cognome Zobio venne latinizzato in Iovius quando Paolo si trovava a Roma,
proprio all’inizio della sua carriera.
Morto il padre, il fratello maggiore Benedetto provvide all’educazione di
Paolo, cui seguirono a Milano le lezioni di retorica di Demetrio Calcondila e Giano
Parrasio, quindi i corsi universitari a Pavia.
Nel 1506 è a Padova per frequentare le lezioni di filosofia e di medicina.
L’anno dopo continua gli studi di medicina a Pavia, dove si è trasferito uno dei suoi
maestri, Marcantonio Della Torre.
Documento di questa illustre formazione patavina sono le Noctes, una raccolta
di testi pluridisciplinari (filosofia naturale, medicina, metafisica e logica).
Nel 1512, neolaureato, si trasferisce a Roma; qui diventa lettore di filosofia
morale presso lo Studio Romano. Insegnare, però, non gli piace: preferisce dedicarsi
alla storiografia.
Passato al servizio dei Medici come medico ed umanista (a quel tempo era
pontefice Leone X, cioè Giovanni de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico), Giovio
si lega al cugino del Papa, il cardinale Giulio de’ Medici.
Nel cenacolo antimediceo degli Orti Oricellari, nostalgico della repubblica e
contrapposto alla Roma medicea, conosce Machiavelli.
Non c’è da stupirsi se Giovio, cortigiano dei Medici, frequenta alcuni dei loro
avversari: Paolo era famoso all’epoca per autonomia di giudizio e per schiettezza
intellettuale.
3
Nel 1521 durante la guerra a fianco degli Spagnoli contro i Francesi per il
reintegro degli Sforza a Milano, Giovio, al seguito del cardinale Giulio de’ Medici,
assiste, impotente, al sacco di Como da parte degli imperiali. Intanto, mentre lavora
alle Historiae sullo scenario storico contemporaneo, licenzia monografie di un certo
spessore: De romanis piscibus, trattato di ittiologia e il De optima victus ratione,
trattato di dietetica.
Il Papa Clemente VII tronca l’alleanza con l’Impero; questo determina
quell’evento traumatico che fu il Sacco di Roma (1527) da parte di truppe protestanti.
Il Pontefice ricompensa Giovio per la sua fedeltà, concedendogli il vescovado di
Nocera.
È il 1528 e Giovio scrive il Dialogus de viris et foeminis aetate nostra
florentibus. Continua ad occuparsi di etnografia e geografia. Dopo aver dato alle
stampe uno studio sulla Russia, la Moschovia (1525), ecco il Commentario delle cose
de’ turchi (1532) dove dimostra di conoscere molto bene la politica ottomana.
Quando Paolo III Farnese sale al soglio pontificio, Giovio entra al servizio del
nipote Alessandro Farnese.
Ben addentro agli ambienti che contano, sempre aggiornato ed informato,
Paolo è il consigliere ideale per chi vuole muovere i primi passi sulla strada del
potere.
Giovio spera inutilmente in una ripresa della politica filoimperiale grazie
all’intervento dei Farnese, i quali, invece, finiscono per appoggiare i Francesi.
L’edificazione del Museo a Como in via Borgovico e l’amicizia più stretta con
esponenti della fronda filoimperiale, lo spingono ad allontanarsi dai Farnese, evitando
così di partecipare al Concilio di Trento.
Le ragioni della sua assenza sono dovute anche alla sua mentalità aperta,
avversa ai dogmatismi che si facevano sempre più strada attraverso gli irrigidimenti
del Concilio. Giovio crede nel dialogo e nel confronto, magari anche con il
movimento dell’evangelismo italiano e come lui il suo amico cardinale inglese,
Reginald Pole.
Il Museo di Borgovico è una villa destinata ad ospitare la ricca collezione di
ritratti di celebrità, i vip dell’epoca; non solo hortus conclusus oraziano, ma anche
laboratorio mnemotecnico, collezione di eroi modello, uomini illustri, degni di
elogio.
Nascono così gli Elogia (recentemente editi da Einaudi nel 2006) finalizzati a
illustrare, a guisa di brevi biografie, i quadri.
4
I rapporti con il pontefice, la corte papale e Roma in generale si fanno sempre
più difficili, non solo a causa delle delusioni politiche e di carriera (a Giovio è negato
il titolo di vescovo di Como), ma soprattutto per il clima sempre meno libero e
aperto.
Così nel 1549 Giovio si trasferisce a Firenze.
Qui scrive delle Vitae e finalmente pubblica le Historiae e il Dialogo
dell’imprese militari e amorose, un trattato di emblematica, la disciplina che associa
epigraficamente un motto di due parole ad una figura araldica o allegorica.
A Firenze si sente più libero: il suo epistolario testimonia contatti con
intellettuali “pericolosi”, sospetti al Concilio di Trento.
Nel dicembre del 1552 Giovio si spegne a Firenze, sfuggendo così
probabilmente alle persecuzioni che si sarebbero abbattute ben presto sui pensatori
eterodossi. La sua tomba è collocata nel chiostro di San Lorenzo dove lo ricorda una
statua di Francesco da Sangallo.
Paolo Giovio era un brillante uomo mondano, oltre che un ottimo e simpatico
conversatore.
Amava la buona tavola (De romanis piscibus e il Carmen facetum), le belle
donne (Dialogus de viris et foeminis aetate nostra florentibus), la vita tranquilla.
Era insomma il tipico prelato rinascimentale, per cui le responsabilità morali,
pastorali e religiose erano all’ultimo posto.
Fu anche accusato di essere adulatore e opportunista a fini carrieristici.
Ai suoi tempi Giovio era considerato il “padre della storia”, quella
contemporanea, attorno cui ha raccolto numerose informazioni e testimonianze
dirette da amici, conoscenti e personalità dell’epoca.
In questo senso il suo epistolario è una miniera di informazioni e di dati sulla
vita del tempo, il cantiere di un raffinato “gazzettiere” che utilizza un volgare da
conversazione, venato di lombardismi e latinismi.
Merito di Giovio è anche l’aver posto attenzione al mondo orientale, asiatico
ed extraeuropeo in genere (De legatione Basilii Magni Principis Moschoviae;
Commentario de le cose de’ Turchi).
Eclettico e poligrafo, ha scritto biografie (Elogia virorum litteris illustrium,
Vitae, Vite degli artisti), si è occupato, oltre che di araldica, di geografia (Descriptio
Britanniae, Scotiae, Hyberniae et Orchadum; Descriptio Larii Lacus).
Ma la sua opera principale sono gli Historiarum sui temporis libri (“Libri delle
Storie del suo tempo”) pubblicati in Firenze tra il 1550 e il 1552, quarantacinque libri
5
dedicati al cinquantennio che va dalla discesa nel 1494 del re francese Carlo VIII in
Italia fino alla pace di Crépy nel 1547 (sono andate perdute, però, alcune sezioni: dal
libro V al X e dal XIX al XXIV).
Si tratta di una colorita e pittoresca storiografia a base di guerre, battaglie e
personaggi illustri (re, generali, diplomatici), ricca di dettagli e descrizioni. L’opera
già allora riscosse un certo successo per la bellezza delle caratterizzazioni e per la
visione ampia degli scenari, per la dovizia di informazioni e per l’eleganza dello stile
narrativo, sensibile anche a strutture modellate sul parlato con impasti linguistici
veramente originali nel tentativo di piacere al grande pubblico, non solo ai letterati.
Per un maggiore approfondimento si ricorda il volumetto miscellaneo
realizzato nel 2002 dal nostro Liceo: Paolo Giovio. Guida alla Lettura, NodoLibri
con saggi di Emilio Russo, Andrea Luppi, Paolo Ceccoli, Vincenzo Guarracino,
Marcello Mochetti, Claudio Fontana e Margherita Giglio.
6
TRA OMBRE E DISTANZE LA POESIA DI ALESSANDRO QUATTRONE
Luigi Picchi
Alessandro Quattrone, professore di Lettere nel nostro Liceo, dopo quasi un
ventennio di silenzio editoriale (Passeggiate e inseguimenti è del 1993 e Rifugi
provvisori del 1996 entrambi presso Book Editore, Bologna) ha pubblicato nel giro di
tre anni un paio di raccolte di poesie, Prove di lontananza (Book Editore, 2013) e
L’ombra di chi passa (Puntoacapo Editrice, Alessandria 2016).
La prima è una cospicua silloge nella quale si approfondisce e si sviluppa, in
un gioco di sapienti variazioni, il tema della distanza rispetto al mondo.
Lo spirito non può che essere quello dolente dell’elegia; infatti un senso di
tenue malinconia pervade i versi, sempre eleganti e composti:
Vagando per la spiaggia deserta
svanisco ma non gemo, ascolto il suono
estremo della vasta solitudine
che come una marea fa il suo ritorno.
Sembra di trovarsi davanti al famoso quadro di Caspar David Friedrich:
Monaco sulla spiaggia.
Il poeta avverte il bisogno di prendere le distanze dalla realtà, non per
separarsene sdegnosamente, ma per meglio comprenderla e decifrarla, per meglio
osservarla, come quando, dovendo scattare una foto, si retrocede per meglio mettere a
fuoco un soggetto.
Proprio a questo riguardo, sul sito Carteggi Letterari in una recensione del
31.12.14, scrive Daniela Pericone: «l’atto della visione, lo sguardo del poeta si pone
come elemento fondativo del discorso poetico, agisce da filtro e nel contempo
consente l’accesso all’esistente», così «lo sguardo assurge a gesto essenziale e a
scelta discriminante di contatto con l’altro, in cerca di una redenzione personale che
va al di là del rapporto amoroso».
Dal momento poi che la vita è di passaggio rispetto a se stessa, la vita si ignora
e non è sempre consapevole di sé, mentre il poeta guadagna per sé e per tutti un
livello superiore di consapevolezza come in questa poesia dove si celebra il kairòs:
7
L’ora perfetta io l’ho conosciuta
è immota e in movimento
è quiete e turbamento
provvisoria come l’estasi del ramo
che perderà il frutto.
La musa del poeta, sorta di rielkiana Euridice riemersa dagli inferi, è senza
volto e senza voce: «ma tu ascolti la mia profezia/soltanto perché vana» e la donna
s’innerva nella Natura, nella terra e nella vegetazione:
Tuttavia il giorno che svanisti
si udì un lieve mormorio
qualcosa come un breve
giuramento di radici.
Così l’inanità degli sforzi umani e dei tentativi di contatto è un presupposto in
questa avventura lirica: non è una dolorosa scoperta, ma un dato di fatto:
Ma non ti voglio attendere o inseguire:
continuo nel mio fervido chiarore
a spargere colori, primavera
tremenda nel suo accendersi invano.
Testimoni di questa segreta desolazione, anche nelle giornate di sole e nel
fervore delle stagioni, sono soprattutto le piante e i fiori con i loro nomi precisi,
qualche animale o qualche oggetto, punti focali nell’aura nebulosa di questo limbo
esistenziale.
La rondine sa cos’è il richiamo
cos’è il ritorno, il lieve turbamento.
Il lampo sa che cos’è la solitudine
del durare un istante illuminando.
Altrettanto precisa è la geografia europea: Reggio Calabria, Como, Monza,
Berna, la Provenza, la Normandia, l’Irlanda anche se come scrive ancora Daniela
Pericone: «non fa differenza se si tratti di paesaggi stranieri […] o delle città del sud
8
e nord d’Italia […], estremi fisici e simbolici di una duplice condizione esistenziale e
di carattere forgiato ad accogliere e comporre le diversità» (sempre sul sito Carteggi
Letterari, recensione del 31.12.14).
La sensazione complessiva è quella di una sorta di diario e di album per
raccogliere momenti solo apparentemente idilliaci, ma in realtà svuotati della loro
funzione di idillio, per diventare teatro di una solitudine allo stato puro dove solo la
poesia può annullare la lontananza per un contatto autentico e proiettare un fascio di
luce nelle nebbie del mistero.
La forza di questa poesia sta nell’intensità dell’epigramma che è ormai la
misura più consona all’indole poetica ed espressiva di Quattrone:
Essere il colore dell’acero
sotto il raggio di aprile
offrire al giorno un tiepido
clamore di rami e sperare.
Vi propongo, a questo punto, la lettura integrale di due liriche dedicate a Como.
Ammiriamo il gesto dei palazzi,
ammiriamo il duomo con i suoi portali,
cogliamo il festoso andare delle strade
urbane verso i monti verdeggianti.
Inferi e mostri lasciamoli stare
tra le pagine di libri sonnacchiosi.
Usciti ad osservare, ora godiamo
delle rapide lusinghe architettoniche
che la città ci rivolge al passaggio.
E cosa importa se noi camminiamo
insieme, lieti, solo per comprare
un regalo, un semplice regalo?
Il lago si addormenta volentieri
nei nostri occhi ingenui: dobbiamo
proseguire in fretta, senza cedere
a scrupoli o ricatti metafisici.
9
Qui c’è tutta la spensieratezza di un momento di shopping, attività caratteristica
della nostra città, probabilmente nelle vie suggestive del centro storico, visto che si fa
riferimento alla presenza dell’architettura artistica al cui cospetto avviene la
passeggiata. Interessante la chiusa che invita orazianamente al carpe diem.
Ti addito il falco che vedi sicuro
far cerchi crudeli nell’aria,
adocchiare la preda sconvolta
sull’acqua verdastra serale,
ti addito il falco per non dirti come
nel flutto solenne, calmissimo,
si perda la mia voce illimitata.
Qui invece la città sembra sparita, non esiste, così da sgombrare il campo e da
lasciare libera la visuale all’evento venatorio del falco in picchiata sulla preda; è un
momento di pura e selvaggia natura, la natura primitiva e secolare dove quel falco
non è quello metafisico di Montale, ma è un falco reale, di sempre, predatore per
istinto, solo che nella chiusa enigmatica della lirica a tuffarsi nell’acqua immota del
lago non è il rapace, ma la voce del poeta.
Passando quindi alla seconda silloge, recentissima, si può subito dire che il suo
titolo ricorda l’io lirico di Ossi di seppia, attento all’ombra stampata dal sole a terra e
sui muri: l’ombra come immagine di precarietà e di vacuità.
E proprio all’insegna della transitorietà e della fragilità scorre la rassegna di
situazioni e ritratti dell’album/galleria di Quattrone, ancora una volta poeta elegiaco
dai toni misurati e assorti, attento ai ritmi precisi del verso:
Rose secche, quale mano pallida
o forse fervida vi ha composte
per l’eternità nel vaso freddo?
In questa terzina la mummificata natura morta è un paradossale e ossimorico
monumento alla eternità.
La realtà, «questo placido/purgatorio dove non accade niente/di quel che si
vorrebbe», pulita da riferimenti troppo espliciti e riconoscibili e resa quindi
essenziale, raggiunge un’aura metafisica e paradigmatica:
10
Le rovine, e tutto ciò che di antico
rimane a consolare i nostri occhi
troppo mortali, accettano una legge
severa dalla voce sussurrata.
Intanto sembrano dicano al viandante
l’amore che ha la terra per i resti,
un amore affannoso, temerario
contro il tempo e i suoi gelosi divieti.
Trovo nelle liriche di Quattrone istanze crepuscolari e barocche ben assortite e
bilanciate, una sintesi di opposti, una fastosa malinconia, non priva di ironia:
Celebra le montagne che non vede
seduto sul divano, e ha pensieri
innevati e desideri limpidi.
Se qualcuno entrando all’improvviso
se ne accorgesse, riderebbe forse,
come ridono di certo le montagne
candide che lui non vede
e celebra restando lì seduto
Ma il più bel ritratto di che cosa è il poeta oggi è questo umoristico autoritratto
Esco nell’alba invernale
con il mio cappotto dalle tasche
piene di vecchi foglietti inutili,
di biglietti per la spesa
e appunti illeggibili,
e non c’è un nome sacro o almeno umano
sui rettangoli di carta,
non un nome
da ricordare o da dimenticare.
Non escluderei poi anche una certa tendenza a creare nella poesia suggestioni e
note narrative, a riprova che oggi molti elementi narrativi sono stati parassitati dalla
lirica, avvicinando così la poesia alla prosa e viceversa:
11
Forse un giorno vedrà il bagliore
di un fuoco millenario,
che lo farà immortale per pochi minuti.
Intanto esplora una musica deserta,
un territorio esteso per chi freme
illuso di poter aver un regno.
Oppure come in questo ritratto femminile.
Seduta sul treno ad inventarsi
un altro amore, ad investigare
le prime luci di una città invisibile,
si abbandona alla corsa, a un certo punto,
intorpidita, invadendo all’improvviso
chi la guarda senza più sognare.
Nella raffigurazione assorta che Quattrone dà di situazioni o persone trovo una
sorta di sospensione metafisica come la si può trovare nei dipinti della corrente
Novecento (Felice Casorati ed Antonio Donghi, ad esempio).
Ma lo stesso poeta mi ha confidato i debiti con il Pascoli di Myricae dove la
rappresentazione del reale assurge a simbolo e a piccola allegoria esistenziale.
Infatti nella prima lirica della raccolta c’è tutta la filosofia di vita in cui
inquadrare l’intero libro: una specie di schopenhaueriana Noluntas:
Sapessimo imitare la saggezza
delle cose ferme al loro posto
da mesi o da decenni,
noi anime in continuo movimento
senza una terra né un giardino
dove obbedire muti alle stagioni,
sapessimo restare immobili
come quadri appesi alle pareti,
con i nostri colori che chiedono solo
di avere una forma e una cornice.
12
Avere forma, cornice, cioè un limite, un perimetro dove situarsi, riconoscersi,
percepirsi: la nostalgia per l’uomo aristotelico dopo le devastanti sbornie
superomistiche di primo Novecento, al ricerca di un ubi consistam classico e
tradizionale.
Più avanti infatti Quattrone precisa che «La nobiltà è un’ansia/capace di aver
forma/e nella forma requie.».
Non per niente, per sfuggire al senso di sradicamento e di smarrimento,
Quattrone insegue feticci classicheggianti e ogni tanto ci regala veri e propri cammei
da Antologia Palatina:
Anfora colma di vino paziente,
ninfea silenziosa sull’acqua,
ombra necessaria nella stanza,
fuoco acceso per chi sa vederlo.
Chi è saggio ritorna al classico o comunque lo rimpiange e lo rievoca tentando
una sintesi tra l’inquietudine moderna, caotica e lacerata, e quella antica, misurata e
apollinea, utilizzando il classico come antidoto ai devastanti veleni contemporanei.
13
SIMMEL E LA MODERNITA’
PIERGIORGIO SCILIRONI
1. Georg Simmel è forse il sociologo che meglio ricostruisce il panorama della
modernità colto nel contesto, al tempo stesso generale e specifico, delle sue
manifestazioni fondamentali, da quelle, per così dire strutturali e sistemiche,
(razionalizzazione, differenziazione funzionale, specializzazione etc.) a quelle
ritenute per lo più transitorie, fugaci, fortuite. In questo contesto i rapporti tra cultura
e tecnica all’interno della città e della società, diventano luoghi in cui si sviluppano
processi diversissimi tra i quali, quelli relativi alla disaggregazione e alla
distanziazione, costituiscono, per molti versi, un continuum con la nostra epoca.
Simmel ha una sensibilità straordinaria nel rilevare non solo gli aspetti positivi, ma
anche le fratture, determinate dalla modernità. Il diritto, l’intellettualità, il denaro
diventano forme che introducono inevitabilmente nella "totalità della vita" delle
contraddizioni. Per brevità potremo soffermarci rapidamente solo su alcuni di questi
temi cercando di accennare alla presenza attiva di Simmel nella società
contemporanea nella quale il capitalismo con le sue contraddizioni, le sue ideologie,
sta sprigionando, sotto gli occhi dell’umanità globale, gli spiriti animali di cui parlava
Sombart. Prendiamo la questione delle forme. C’è una notevole assonanza tra Freud e
l’ultimo Simmel della Lebensanschauung e del Konflikt der modernen Kultur. Il
primo individua il conflitto nella repressione delle pulsioni, il secondo nella
“tirannia” delle forme, nel disagio della cultura. Il mutamento continuo dei contenuti
della cultura è indice ad un tempo della fecondità della vita, ma anche della sua
profonda contraddizione “in cui sta il suo eterno divenire e mutarsi di fronte
all’obbiettiva validità e l’autoaffermarsi delle sue manifestazioni e forme, con le quali
o nelle quali essa vive” (Simmel 1976, p.107). La vita muore e diviene costantemente
nel rapporto dialettico con le forme che si autonomizzano raggiungendo “una validità
superiore al momento ed emancipata dalla pulsione della vita stessa” (Simmel 1976,
p.108). Ciò determina “una latente opposizione che scoppia ora in questo ora in quel
campo del nostro essere e agire” (Simmel 1976, ibid.).
Il significato della vita non consiste in alcun suo fine determinabile, “ma nello
svolgimento di se stessa, mediante il quale acquista, pel fatto che diviene sempre più
vita, un valore che si eleva all’infinito” (Simmel 1976, ibid.]. Coi mutamenti culturali
che “divergono” rispetto ai lenti mutamenti del passato, con lo sviluppo di nuove
forme che vogliono abbattere le vecchie, si va determinando una sorta di
“opposizione contro la forma in generale” (Simmel 1976, p.113). Quando la vita
diventa cultura precipita inevitabilmente in un conflitto:
14
Questa vita deve o generare forme o muoversi entro forme. Noi siamo, sì
immediatamente la vita, e con questo si congiunge un sentimento, di cui non si può
dare una più precisa descrizione, di essere, di forza, di moto verso una meta; ma noi
tale sentimento possediamo solo nella forma che esso ogni volta assume, la quale,
come ho già sottolineato, nel momento del suo presentarsi si mostra appartenente ad
un altro ordine, fornito di diritto, e significato attinti da sé, e che afferma e pretende
un’esistenza sopravitale” (Simmel 1976, p. 132).
2.Il conflitto, si potrebbe dire, tra “mondi vitali” e forme apre una contraddizione
profonda rispetto all’essenza della vita stessa che è caratterizzata da una “dinamica
fluttuante”, dall’incessante differenziazione d’ognuno dei suoi momenti” e vincolata
dalla necessità di realizzarsi solo nel suo opposto cioè in una forma.
I processi di razionalizzazione danno vita a patologie che mortificano spesso le
coscienze, le capacità di donne e uomini:
“La razionalità oggettiva veicolata dalle istituzioni, dai saperi e dalle forme di vita,
si affida a meccanismi “giroscopici” di autoregolamentazione, che certo transitano
attraverso la coscienza individuale, ma solo in forma di automatismi anonimi,
respingendo – per loro natura – l’intervento di un pensiero non preventivamente
piegato a una tecnica, non instradato su percorsi virtualmente già programmati e
preordinati. Senza un supplemento di energia soggettiva, ogni tentativo imprevisto di
modificazione, di reinterpretazione e di riquadramento delle procedure o dei
contenuti specifici in contesto di senso diversi o più articolati (ossia ogni risoggettivazione dell’oggettività) rischia di venire ignorato o penalizzato” (Bodei
2002, p. 184).
Non solo non scegliamo di nascere ma non possiamo neppure evitare le trappole
della vita. Tempo e spazio sono impastati di caos e caso, ci condizionano
profondamente incatenandoci definitivamente alle forme, alla pena “d’esser così e di
non poter più essere altrimenti” (Pirandello 1993, p. 51).
In uno dei brani più noti de L’umorismo, Pirandello analizza i modi umani di
fissare, di dare un che di stabile alle fluttuazioni della coscienza, ai sentimenti, alle
emozioni, alle passioni, appunto, a questa sorta di “io multiplo” che si agita in noi:
La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme
stabili e determinate, dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme
che si muovono in mezzo ad altre immobili, e che però possono seguire il flusso della
vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano, il movimento, già a poco a poco
rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d’arrestare, di fissare in noi questo
flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte
le finzioni che creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci (Pirandello
1986, p. 159].
15
I temi oggetto della riflessione e dell’esperienza teatrale di Pirandello sono pure al
centro del pensiero filosofico, sociologico, e letterario. Le filosofie di Nietzsche, di
Bergson, di Simmel, in particolare, e quelle sviluppate nelle opere letterarie di Proust
e di Pirandello si muovono in una duplice prospettiva: o nel senso di potenziare il
proprio io o in quello “di schiodarsi da un destino segnato in anticipo, di custodire in
sé, in forma di abbozzate personalità multiple, una ricchezza di possibili sviluppi, non
bloccati, almeno nel desiderio, dalle scelte compiute nel passato” (Bodei 2002, p.13).
3.La forma narrativa si presta particolarmente ad esprimere questo disagio che è
moderno e postmoderno al tempo stesso nel rapporto complesso, doppio, prismatico
con la realtà e con noi stessi. Fino alle sue manifestazioni più profonde:
Ciò che angoscia il soggetto, molto più che la morte imminente, è innanzitutto la
sua non-realtà, la sua non-esistenza. Sarebbe il male minore la morte se si potesse
essere certi d’aver almeno vissuto: ora è proprio di questa vita, per quanto peritura
possa essere, di cui viene a dubitare il soggetto nello sdoppiamento della personalità.
Nelle coppia malefica che unisce l’io ad un altro da sé fantomatico, il reale non è
dalla parte dell’io, ma dalla parte del fantasma: non è l’altro che mi sdoppia, sono io
che sono il doppio dell’altro” (Rosset, in Davico Bonino 2004, pp. XII-XIII).
Simmel scava in un contesto il cui framework continua ad essere con tutte le
diversità storiche, ancora il nostro “tardo moderno”, post-moderno”, “dopo moderno”
o come lo si voglia ancora definire. Si pensi, tra l’altro, non solo al Disagio della
civiltà di Freud, alle patologie del moderno rilevate da Habermas,(a cominciare dalla
colonizzazione dei mondi vitali operata dai sistemi), allo sviluppo dell’industria
culturale e dell’ideologia capitalista analizzate da Horkheimer e Adorno, all’opera di
Proust, di Musil,di Canetti e ad altre opere narrative, ma soprattutto al modo stesso in
cui “ancora oggi pensiamo alle previste e impreviste conseguenze dell’avventura
moderna” (Bauman 2002, p. IX)
Peter Berger e Thomas Luckmann hanno parlato di smarrimento dell’uomo
moderno e contemporaneo:
“E’ possibile che il discorso sulla crisi di senso dell’epoca contemporanea di fatto
non sia altro che una ulteriore forma di disorientamento nella vita degli uomini
moderni. Quello che qui ci giunge all’orecchio non è forse la riproposizione più
recente di un antico lamento? Quel lamento in cui si esprime il tormento che sempre
ha colto l’uomo di fronte ad un ordine del mondo che incomincia a vacillare? E il
lamento sulla vita umana come vita per la morte non fa forse emergere di nuovo il
dubbio che una tale vita possa trovare il suo significato soltanto in una storia salvifica
16
di tipo trascendente, o al contrario non fa piuttosto erompere la disperazione che un
tale significato non esista?” (Berger e Luckmann tr. it. 2010, p.7].
Il saggio su Le metropoli e la vita dello spirito individua, proprio in apertura, i
problemi di fondo della modernità, la cifra di un’intera epoca, riassunta nella “pretesa
dell’individuo di preservare l’indipendenza e la particolarità del suo essere
determinato di fronte alle forze preponderanti della società, dell’eredità storica, della
cultura esteriore e della tecnica” (Simmel 1995, p. 35).
Ma la difesa della vita soggettiva sembra sempre tragicamente soccombere di
fronte alla violenza della metropoli. Essa agisce sull’intensificazione della vita
nervosa, accelera e altera l’immagine sensorio-spirituale della vita, determina ritmi,
fagocita spazi, modifica la sentimentalità e le relazioni affettive. La metropoli come
sede dell’economia monetaria riduce tutte le qualità e le specificità al livello di
domande che riguardano solo la quantità: il tempo diventa il tempo del calcolo. Essa
impone uno schema rigido e sovraindividuale e riproduce l’indifferenza e il blasé
come “attutimento della sensibilità rispetto alle differenze fra le cose” (Simmel 1995,
p. 43). E soprattutto nella metropoli domina, diffusa e capillare, l’indifferenza. La
sfera dell’indifferenza è all’origine di un groviglio di sentimenti, di passioni di
emozioni la cui manifestazione esterna più percepibile è la stravaganza
metropolitana; ma essa può capovolgersi rapidamente in aggressione e odio. E’
sorprendente l’attualità del pensiero simmeliano, in una fase in cui nel nome di una
concezione aberrante della globalizzazione, si potenziano processi omologanti. Di
particolare importanza e di rilievo epistemologico è la sua analisi dell’uomo come
“essere che distingue” (Simmel 1995, p.36).
4. La coscienza dell’uomo è prodotto di una differenza la quale è frutto di processi
che Marx definirebbe “astrazioni determinate” e che Simmel, definisce come
“astrazioni dalla totalità del reale”. Con riferimento a Luhmann, potremmo parlare di
processi selettivi dalla prassi che “selezionano “dalla complessità esterna o interna
delle cose delle serie unilaterali, dando luogo così ai grandi sistemi di interessi della
cultura” [Simmel, tr. it.1984 p.124]. Cogliere le distinzioni significa attuare un
processo conoscitivo significativo, essere permeabile nel rapporto con gli altri e con
le cose, mantenere viva la sensibilità cercare ed elaborare le informazioni, ridurre la
complessità: proprio l’esatto contrario del modo di essere del blasé analizzato da
Walter Benjamin:
“Ciò significa che la sua coscienza viene stimolata dalla differenza tra
l’impressione del momento e quella che precede; le impressioni che perdurano, che si
differenziano poco, o che si succedono e si alternano con una regolarità abitudinaria,
17
consumano meno coscienza che non l’accumularsi veloce di immagini cangianti, o il
contrasto brusco che si avverte entro ciò che si abbraccia in uno sguardo, o ancora il
carattere inatteso di impressioni che si impongono all’attenzione” (Simmel, 1995,
ibid.).
L’interazione sociale è frutto sia della capacità di distinguere, sia dello scambio,
essendo quest’ultimo non solo condizione del valore economico, ma anche “forma di
vita”. Già nella Vienna di Musil la realtà contemporanea, identica allo spettacolo di
se stessa, si sovrappone al senso barocco del mondo quale teatro in cui si recitano,
anche senza saperlo, ruoli e parti di significato universale” (Magris,1986, p.178-179).
Sono temi simmeliani che saranno ripresi in grandi romanzi, ma anche nella scienze
sociali e naturali. Si pensi in particolare a Laws of Form (1969) di Spencer Brown in
cui è delineata una logica coerente e completa basata su 'distinzioni', che Maturana e
Varela identificano come “il cognitivo atto elementare da uno sfondo e uno sfondo
come il dominio in cui si distingue un soggetto" (Maturana e Varela 1985, p. xxii). Il
dato di partenza di Spencer- Brown sono le idee - fondamentali come convergenti in
un principio interdisciplinare - della “distinzione” (distinction), l’idea
dell’“indicazione” (indication) e l’idea per la quale non possiamo fare un’indicazione
senza tracciare una distinzione (1).
In una realtà che abbandona le concezioni prospettivistiche per una concezione
sempre più “aprospettica” non è più possibile un rapporto intelligente con il proprio
tempo tutto fondato sulla relazione semplice tra un Io ingenuo e un mondo
monoprospettico e ben strutturato. Come sostiene Peter Sloterdijk “l'universum
diviene qui un multiversum e l’atomon individuale un polytomon, ente sfaccettato
dalle molteplici divisioni” [Sloterdijk 1992, p.396]. Sloterdijk delinea addirittura i
contorni di un vero e proprio cinismo mediale per il quale i mezzi di comunicazione
di massa agiscono sulla società come climatizzatori artificiali delle coscienze. Nel
vortice dei media ogni Weltanschauung diventa in modo sempre più netto
“un'immagine di seconda mano, mutuata da sensali e imbonitori” (Sloterdijk 1992,
ibid). L’analisi di Sloterdijk tocca toni che, a ben guardare la realtà odierna, sarebbe
assurdo definire apocalittici:
“I notiziari inondano la coscienza tele-infetta con frammenti di universo
sminuzzati in particole informazionali; simultaneamente il mondo esterno è risolto in
fluorescenti paesaggi a forma di notiziario che “nevicano” in un tubo catodico di
qualità scadente, altrimenti noto sotto il nome di “coscienza individuale”. Di fatto, i
media possiedono la capacità di riorganizzare ontologicamente il reale in quanto
inerente alle nostre teste. Che tutto cominci in modo totalmente innocuo, fa parte del
gioco. La gente legge i giornali; pensa di registrare cose che la “interessano”; dagli
anni Venti ascolta anche la radio, s'affretta lungo vie sovraffollate, piene di réclames,
ammira vetrine dalle offerte allettanti. La gente abita città che altro non sono se non
18
dei mass-media in cemento armato, fasciati tutt'intorno da reti di segni e
comunicazioni: un traffico continuo preposto a dirigere il moto delle maree umane.
La metropoli ci appare come un gigantesco boiler che pompa il plasma dei soggetti
attraverso un sistema tubistico-semantico” (Sloterdijk 1992, p.397).
Sloterdijk richiama una pagina significativa di Fuga senza fine di Joseph Roth
(1927) in cui una Berlino che richiama in qualche modo la metropoli simmeliana, è
così descritta:
Vedemmo uno che correva in preda a furia omicida e una processione; la prima di
un film, una ripresa cinematografica, il salto mortale di un saltimbanco a Unter den
Linden, uno scippato, l’asilo dei senzatetto, una scena d’amore in pieno giorno al
giardino zoologico, una colonna delle affissioni girevole, tirata da asini, tredici locali
per coppie omosessuali e lesbiche [...]
Era di nuovo il periodo in cui letterati, attori, registi cinematografici e pittori
guadagnavano dei bei soldi. Era il periodo della stabilizzazione della moneta tedesca,
si aprivano nuovi conti bancari, persino i periodici più estremistici guadagnavano
corposi onorari nei supplementi letterari dei quotidiani borghesi. Il mondo era già
consolidato a tal punto che i feuilletton potevano permettersi di essere rivoluzionari....
In questo nuova condizione gli Io si riducono a mezzi, a funzioni di questo
“sistema tubistico-semantico”:
“L’Io e il mondo, ciascuno nel suo proprio status di fluidificazione, pervengono
entrambi alle strozzature ontologiche che stanno a monte delle mille e una teorie
moderne della "crisi"” (Sloterdijk1992, ibid.).
La nuova condizione medi-ontologica assesta il colpo decisivo alla metafisica
classica e dissolve la vecchia aspirazione alla totalità e la rappresentazione stessa
dell’individuo come tutto indivisibile. Secondo Sloterdijk, nessuno meglio di Robert
Musil, “su un piano di superba ironia, ha saputo formulare la giustapposizione tra la
vecchia e la nuova condizione dell’individuo. Il punto di riferimento è un brano del
capitolo 54 di Der Mann ohne Eigenschaften, di Musil il romanzo che effettua, di
fronte alle tesi della “non salvabilità del sé” (das unrettbar Ich), “un prolungato
sforzo teso a questo salvataggio” (Berger 1992, p.9).
E’ degno di lode chi ancor oggi serba aspirazione a essere un tutto”, disse Walter.
“Oh, non ce n’è più”, significò Ulrich. “Ti basta una sola occhiata sul giornale. E’
zeppo di una sua immensa opacità. Vi si parla di talmente tante cose da travalicare la
vis intellectiva di Leibniz. Eppure non lo si nota nemmeno; siamo mutati. Non c’è più
19
un uomo intero innanzi a un mondo intero, ma piuttosto un quid humanum che
aleggia nel brodo di cottura universale” (Musil 1971, p.211).
Non c’è più l’uomo nella sua interezza. E forse non c’è mai stato. Ma è certo che
non è più l’individuo a governare il proprio “sé”:
“Questo stesso processo di disintegrazione si applica anche al sé. Detto in altri
termini, diventa sempre più difficile vedere il “sé” come il centro delle azioni
dell’individuo. Piuttosto, queste azioni vengono ad essere percepite come eventi che
accadono all’individuo, separate da lui, e spiegabili in termini di cause esterne
(sociali) o interne (organiche e psichiche). Il soggetto di Cartesio, che era capace di
dire cogito ergo sum, si dissolve nel flusso di oggettività di Mach. La soggettività
moderna si rovescia al di fuori di sé stessa” (Berger 1992, p.13).
La tecnica come spirito cristallizzato spinge l’individuo a reagire: “Così,
l’elemento più personale, per salvarsi, deve dar prova di una singolarità e una
particolarità estreme: deve esagerare per farsi sentire, anche da se stesso” (Simmel
1995, p.55). Si potrebbe operare u confronto fra la metropoli razionalizzata di Georg
Simmel, città del cervello e dell’intelletto, con la metropoli fatata di Leopold Bloom:
il protagonista di Ulysses di James Joyce città del segno e della magia. Sembrano due
mondi diversi, separati, inaccostabili. Eppure, hanno ragione tutti e due, perché
parlano di cose diverse:
Simmel pensa alla città della produzione; Joyce, a quella del consumo. Nella
prima, vige il duro “disincanto” di Max Weber; nella seconda, al contrario, il
“bisogno di reincanto” [Moretti, 1994: 124]. Quello della modernità è il mondo delle
dicotomie, dei dualismi, un mondo sdoppiato come afferma Ernest Gellner, tra
“standardizzazione e anomia”. Moretti, ne estrapola il paradosso della pubblicità:
“prendere dei prodotti standardizzati, e farli sembrare unici (Moretti 1994, p.125).
5. Il quadro intellettuale e spirituale dipinto da Robert Musil è quello di un’epoca in
cui, con le sue stesse parole “lo spirito rassomiglia a un mercato pubblico”
“Così - scrive Musil - lo spirito è il grande fabbricante di alternative, di “secondo i
casi”, ma lui stesso non si lascia mai afferrare e quasi si potrebbe credere che solo suo
effetto sia la distruzione. Ogni progresso è un guadagno nel particolare e uno
smembramento nell’insieme; c’è un aumento di potenza che sbocca in un progressivo
aumento d’impotenza, e non lo si può negare” (Musil 1972, pp.146-147).
Potenza e impotenza crescono assieme in una simbiosi inestricabile quasi a segnare
il ritmo inafferrabile della modernità scandito dal flusso perenne del denaro:
20
“Nessun simbolo dell’assoluto carattere dinamico del mondo è più chiaro del
denaro. Il significato del denaro consiste nel fatto che esso viene ceduto; non appena
si ferma non è più denaro nel suo valore e nel suo significato specifico. L’effetto che
esercita in determinate circostanze in stato di quiete consiste nell’anticipazione del
suo movimento ulteriore. Non è altro che il portatore di un movimento nel quale tutto
ciò che non è movimento risulta completamente cancellato, è, per così dire, actus
purus; vive in una continua autoestraneazione da ogni punto dato e costituisce così il
polo opposto e la diretta negazione di ogni essere per sé” (Simmel 1984, p. 717).
Il danaro come simbolo fondamentale della società in quanto “riflette le sue forme
e i suoi movimenti”, è la cifra della modernità, ma anche l’elemento costante che
caratterizza tutte le sue trasformazioni, le sue crisi, le sue evoluzioni. Ogni teoria del
moderno o del postmoderno rischia di essere incomprensibile senza tenere conto del
dato strutturale del continuo movimento e delle continue metamorfosi del denaro. E’
questo un dato inconfutabile sul quale convergono Simmel, Benjamin e Musil:
“Plasticità, fluidità, metamorfosi: sono proprio gli emblemi nei quali Georg
Simmel, nella Filosofia del denaro e Walter Benjamin nel Passagen-Werk, fissano il
volto della modernità. Sullo sfondo di queste due monumentali enciclopedie
dell’epoca “nuova” l’interpretazione della Zivilisation abbozzata da Musil mostra
interamente il proprio spessore. Soprattutto su un punto l’analisi di Musil rivela una
piena sintonia con i principali tratti della fenomenologia della vita metropolitana
delineata da Simmel all’inizio del secolo, e poi successivamente ampliata da
Benjamin: sulla capacità di aderire alla logica della modernità senza alcun
pregiudizio, ma senza mai cedere, nello stesso tempo, alle effervescenti mitologie del
progresso. La modernità sfugge, infatti, per Simmel come per Benjamin, ad ogni
proiezione mitografica. E’ animata, certo, da una strenua, febbrile carica progettuale,
ma si tratta, comunque, di un progetto che rimane perennemente “incompiuto”
rispetto agli schemi tradizionali della filosofia della storia. Incompiuto, bloccato dalla
logica stessa che regola la vita moderna. Un compito bloccato dalla fluidità che secondo Simmel - il denaro impone come unico valore: fluidità, o meglio relativismo,
che vanifica, dissolve, la consistenza di ogni telos che non sia quello del puro
“scambio”, sulla cui forma interamente si modella la cultura moderna...” (Mazzarella
1995, p.65).
La sociologia di Simmel come "scienza delle relazioni in cui viene elaborato sia
l’individuale sia il collettivo", è aperta in modo, per molti versi interdisciplinare e
cosmopolitico, alla complessità.
La riflessione sulla modernità è stata spesso al centro della riflessione sociologica
e, più in generale, di tutte le scienze sociali. A partire dalla seconda metà del XIX
secolo le estetiche che analizzavano i processi di transizione alla società moderna si
21
collegavano alle manifestazioni moderniste e a movimenti d’avanguardia che si
proponevano programmaticamente di esprimere i “tempi nuovi”. Ma forse nessuno si
rende conto meglio di Simmel che la comprensione e spiegazione della modernità
non dipende tanto da una reductio ad unum, quanto dall’individuazione del nuovo,
della diversità, della differenza. Per cogliere questi passaggi, le modalità specifiche
attraverso le quali il “nuovo” si fa sistema, “coesione sociale” non è necessaria una
teoria compatta della società quanto, piuttosto, una ricerca ed una cooperazione
interdisciplinare tra le scienze. Questo spirito di ricerca caratterizzerà la sociologia
“atipica” di Simmel la cui opera costituisce un ponte straordinario tra la modernità
colta nei suoi processi originari e ciò che, con termine general generico, viene
definito “post-moderno”.
Come non riflettere su quanto la “postmodernità” si riveli come il regno della
pluralità, della eterogeneità, della destrutturazione, dello spettacolo”. La storia del
“postmoderno” è una vecchia e discontinua storia che si è sviluppata all'insegna di
contraddizioni e di paradossi. Ha fatto notare Niklas Luhmann che la società moderna
si trova oggi di fronte a se stessa. Ma non basta certamente che si concepisca solo
come “risultato della sua storia” (Luhmann 1987, p. 97) in quanto “questa descrizione
contiene troppo poca informazione” (Luhmann, ibid.).
Si passa con grande facilità dal “postindustriale” al “postmoderno” alla
“posthistoire” per cui a ragione sostiene Luhmann che una descrizione temporale
della società dipende, per la sua integrazione, dalla sua descrizione strutturale, allo
stesso modo procedono insieme teoria dell’evoluzione e teoria dei sistemi. Da questo
punto di vista l’opera di George Simmel continua a fornirci strumenti importanti per
riflettere criticamente sulla società contemporanea, sulle sue ideologie, sulle sue
contraddizioni, sui suoi miti.
Charles Baudelaire nell’introdurre il concetto di “modernité” in un saggio del 1863
(Baudelaire 1962) ne sottolineava gli aspetti di fluidità, dinamismo e libertà: moderno
come ciò che è “transitorio, fugace, fortuito”.
Alla fine di una Saison en enfer, scrive Roberto Calasso, dopo un capoverso
ruvido e corrusco, squillano cinque parole: Il faut être absolument moderne”. Il
perché non viene detto. Il moderno fiorisce “senza perché”, come la rosa di Angelus
Silesius” (Calasso 2008, p. 201].
22
Ma da quel transitorio, fugace e fortuito prenderà corpo l’industria moderna a
cominciare da quella della cultura le cui caratteristiche saranno descritte anche da
George Simmel, Joseph Roth, Walter Benjamin e Robert Musil:
“L’industria culturale-espressione di Adorno e Horkheimer- che già suonava
obsoleta poco tempo dopo essere stata introdotta – ebbe il suo inizio ufficiale a Parigi
nei primi anni di luigi Filippo. Si dettero in quel momento le condizioni
indispensabili perché il fenomeno si manifestasse: innanzitutto la stampa quotidiana,
che in futuro si sarebbe ramificata nella pluralità dei media ma allora li comprendeva
tutti, aumentò fortemente le tirature e abbasso altrettanto fortemente i prezzi,
ricorrendo per la prima volta in modo sistematico alla pubblicità…Così, accanto alla
macchina a vapore e alla fotografia, la pubblicità prese posto fra le novità decisive
nella prima metà dell’Ottocento. Pubblicità significa innanzitutto che certi oggetti
cominciano a parlare e produrre immagini. E’ un processo all’inizio risibile e goffo,
ma dagli sviluppi incalcolabili. Nata come appendice della produzione, la pubblicità
riuscirà un giorno a invertire il rapporto: gli oggetti vengono prodotti perché certe
immagini, certi nomi, certe parole trovino un supporto. La moda è un accorgimento
per rendere più erotico questo continuo debordare dalle immagini, assimilandolo alla
incessante mutevolezza del desiderio. Modello e fondamento della pubblicità è
l’inquietudine insanabile della vita mentale, la cui patria morale è la delectatio
morosa (Calasso 2008, p.57).
Calasso coglie le origini di un fenomeno della produzione e della riproduzione
allargata dell’ideologia del capitalismo che Simmel descrive allo statu nascenti, che
Marx analizza strutturalmente, e che
successivamente Adorno e Horkheimer
svilupperanno come “industria culturale” piegata alla logica del capitale e della
merce, e Guy Debord come “società dello spettacolo”. Horkheimer e Adorno
sostengono che con la perdita del sostegno sociale rappresentato dalla religione, con
la “dissoluzione degli ultimi residui della società precapitalistica, la crescente
differenziazione tecnica e sociale e la tendenza allo specialismo”, si determina un
“caos sociale”, una “concentrazione dello spirito” diretto a celebrare “l’elogio del
ritmo d’acciaio”, il “potere totale del capitale”, il dominio della tecnica la razionalità
della quale, per i francofortesi, non è altro che “la riproduzione e ramificazione
sociale della pratica e dell’ideologia capitalistica” (Adorno e Horkheimer 2010).
Nella Philosophie des Geldes Simmel approfondisce alcuni di questi processi che
sviluppa in relazione alla sua analisi del denaro come medium per molti versi legata a
23
quella marxiana. Scrive Marx nei Manoscritti economico filosofici del 1844 il denaro
come medium fondamentale, onnipotente, dell’ideologia capitalista che penetra
profondamente nei mondi vitali, condizionando l’esistenza stessa degli uomini:
“Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di
appropriarsi tutti gli oggetti, è così l’oggetto in senso eminente. L’universalità della
sua proprietà è l’onnipotenza del suo essere; esso vale quindi come ente
onnipotente… Il denaro è il lenone fra la vita e il mezzo di vita dell’uomo. Ma ciò
che mi media la mia vita mi media anche l’esistenza degli altri uomini (Marx 1969,
p.252).
Senza voler fare alcuna forzatura, come non mettere in un rapporto di continuità il
“medium denaro” col “medium spettacolo” che ha conquistato un ruolo di primo
piano nella società contemporanea che il leader della corrente situazionista Debord
definisce come “società dello spettacolo”? Lo spettacolo ha occupato l’intera scena
sociale e rende visibili soltanto le relazioni fondate sulla merce, diventa un bene
economico, un medium, una sorta di equivalente generale come il denaro.
Parafrasando proprio l’incipit del Capitale (2), Debord così apre il suo La società
dello spettacolo:
Tutta la vita delle società nelle quali predominano le condizioni moderne di
produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli (3).
L’era della globalizzazione sembra coincidere con lo sviluppo di quella che
Debord caratterizza come unbroken continuity, come ininterrotta continuità dello
spettacolo che ha penetrato profondamente le strutture della quotidianità. Per Debord
lo spettacolo diventa un vero e proprio “regno autocratico dell’economia di mercato”
che ha aderito a una irresponsabile sovranità e alla totalità delle nuove tecniche di
governo che accompagnano questo regno. La costituzione del potere dello spettacolo
implica una profonda trasformazione sociale che ha radicalmente cambiato l’arte del
governo. Esso può essere definito come crogiolo, come simbolo dei simboli, come
produzione individuale e sociale di movimento e visibilità; ha a che fare soprattutto
con le facoltà visive, col “mostrare e mostrarsi”. Lo spettacolo ha occupato l’intera
scena sociale e rende visibili soltanto le relazioni fondate sulla merce. Ad esso ci
accostiamo non solo per “mostrarci” e “mostrare”, ma anche per cercare di “vederci”,
per “rispecchiarci”.
24
Simmel continua ad insegnarci che esistono altre relazioni ben più significative di
quelle fondate sulle merci che possono aiutarci se non a colmare, almeno ad attenuare
“la mancanza di qualcosa di definitivo nel centro dell’anima” (Simmel 1984, p. 681].
25
Note
1) Ogni “indicazione” per Spencer- Brown implica “dualità”. Non è possibile “produrre
qualcosa” senza “cooprodurre ciò che esso non è”. Ogni “dualità” implica “triplicità”: ciò
che la cosa è, ciò che non è, e i confini esistenti tra essi” [Spencer- Brown 1994, p. ix).
Come Spencer- Brown spiega, nel primo capitolo di Laws non è posibile “indicare”
(indicate) qualcosa senza “definire” (defining) due stati, e non è possibile “definire due
stati” senza “creare tre elementi”. Nulla esiste in realtà in modo separato dagli altri. Scrive
James Joyce: “Quando hai percepito quel cesto come una cosa una e poi l’hai analizzato
secondo la sua forma e percepito come una cosa, tu fai la sola sintesi che sia logicamente ed
esteticamente ammissibile. Tu vedi che in quel cesto è la cosa che è e nessun’altra. Lo
splendore di qui parla san Tommaso è la quidditas scolastica, l’essenza di una cosa” (Joyce
1976, p.359).
2) Il famoso incipit del primo libro del Capitale, così recita: «La ricchezza delle società nelle
quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una “immane raccolta
di merci”» [Marx 1967-1968, I, 45].
3) Cfr. Debord 1990, p. 85. Scrive inoltre Debord: «Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che
l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo» [Debord,1990, 92].
26
Riferimenti bibliografici
Baudelaire C. (1962), Le peintre de la vie moderne, in Curiosités esthétique:
l’art romantique, Paris 1962.
Bauman Z (2002) tr. it. Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori,
Milano (ed. or. 2000).
Berger L. Luckmann (2010), tr.it. Lo smarrimento dell’uomo moderno, il
Mulino, Bologna (ed. or.1995).
Bodei R. (2002), Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze,
Feltrinelli, Milano.
Debord G. 1990, trad.it. Commentari sulla società dello spettacolo e La società
dello spettacolo, Milano, Sugarco, (ed. or.1967)
Horkheimer M., W. Adorno,T. trad.it. Dialettica dell’illuminismo, Einaudi,
Torino, 2010 (ed or.1944).
Joyce J. (1976), tr.it. Dedalus. Ritratto dell’artista da giovane, Adelphy, Milano,
1976. (ed.or. 1917).
Luhmann N. (1987), Modernità e differenziazione sociale, in Mari (a cura di)
Moderno postmoderno. Soggetto, tempo sapere nella società attuale, Feltrinelli,
Milano.
Luhmann N.(1981), Gesellschaftstheoretische Grundlagen, in Politische
Theorie in Wohlfartsstaat, Olzog Verlag, München-Wien.
Lukács G., Georg Simmel, in Simmel, G. trad. it. La moda, Mondadori, Milano,
1998 (tr. or.1895).
Magris C. (1986), La casa di Canetti, in Id., Danubio, Garzanti, Milano.
Marx K. (1969), trad. it. Manoscritti economico-filosofici del 1844, in Id. Opere
filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma, 1969, (ed. or. 1844)
Maturana H.R. Varela F.G. (1985), tr. it Autopoiesi e cognizione. Marsilio,
Padova, (ed.or. 1980).
27
Mazzarella A. (1995), Parole sul “grembo del nulla”. Musil e l'artificialità dei
segni, in “Cultura tedesca”, n. 3, aprile
Moretti F. (1994), Opere mondo. Saggio sulla forma epica dal Faust a
Cent'anni di solitudine, Einaudi, Torino.
Musil R. (1972), tr.it. L'uomo senza qualità, Einaudi, Torino, 2 vol,.(ed.
or.1930-1933)
Pirandello L. (1993), Uno, nessuno, centomila, Feltrinelli Milano, (ed.or. 1926).
Pirandello L.(1986), L’umorismo, Mondadori, Milano (ed.or. 1908).
Rosset C. (1993), Le Réel et son double, Gallimard, Paris.
Simmel G. (1984), Filosofia del denaro, tr. it. di A. Cavalli, R. Liebhart, L.
Perucchi, a cura di A. Cavalli e L. Perucchi, utet, Torino (ed. or. 1900).
Simmel, G (1976), Il conflitto della cultura moderna, in id. Il conflitto della
cultura moderna, a cura di C. Mongardini, Bulzoni (ed. or. 1918).
Spencer- Brown G. (1969 –1994), Laws of Form, limited edition, BookMasters,
Ashland, Ohio.
Sloterdijk, P. (1983), trad. it.Critica della ragion cinica, Milano, Garzanti,1992
Simmel G. (1982), La differenziazione sociale, tr. it. e cura di B. Accarino,
prefaz. di F. Ferrarotti, Laterza, Roma-Bari (ed. or. 1890).
Simmel G. (1984), tr.it. Filosofia del denaro, a cura di A. Cavalli e L. Perucchi,
UTET, Torino (ed. or. 1900).
Simmel G. (1989), Sociologia, tr. it. di G. Giordano, introd. di A. Cavalli,
Comunità, Milano (ed. or. 1908).
Simmel G. (1995), Le metropoli e la vita dello spirito, introd. e cura di P.
Jedlowski, Armando, Roma (ed. or. 1903).
28
L’AMORE PLATONICO
Gianfranco Giudice
Eros è il fuoco della filosofia platonica, il motore della negazione del corpo
irripetibile. Ciò che mi ha sempre colpito della filosofia platonica, è la costante e
sistematica insistenza con cui il grande ateniese torna sul corpo, non su una generica
materia diveniente, quando il filosofo pone il tema metafisico per eccellenza: la
distinzione fra essere e divenire, idea e sensazione, scienza e opinione, insomma
ripetibile e irripetibile. E’ una autentica ossessione quella platonica, perché ciò che
appare più urgente da negare rendendolo ipso facto ripetibile, è proprio la corporeità,
la più autentica minaccia alla potenza della metafisica, col suo essere dato
irreversibile, dato per sempre. Bisogna sottolineare che man mano che la storia della
metafisica si allontana dal modello platonico, sembra perdere la consapevolezza della
propria radice che scaturisce dalla negazione della corporeità; per questo è importante
tornare all’ idealtipo platonico della metafisica, perché lì si palesa in maniera
chiarissima lo scioglimento del corpo nella soluzione chimica della metafisica intesa
come scienza del ripetibile; la medicina dell’anima platonica da questo punto di vista
è l’autentico modello universale di ogni scienza universale dei corpi.
Lèon Robin nel suo classico La Thèorie platonicienne de l’Amour pubblicato
nel 1908 (ed. it. a cura di G. Reale, CELUC, Milano 1973), definisce la natura
sintetica dell’amore platonico, con particolare riferimento ai tre dialoghi in cui
Platone affronta il tema dell’Amore, il Liside, il Simposio e il Fedro; dialoghi di cui
lo studioso francese stabilisce anche la successione cronologica così come indicata.
“L’Amore – scrive Robin – risulta dunque, anche qui, una sintesi della natura mortale
con quella immortale” (ibidem, p. 142). La natura sintetica e intermediaria
dell’amore, di cui è espressione il mito della nascita di Eros da Penia e Poros che
leggiamo nel Simposio, è forza che trasforma ciò che è mortale, per antonomasia il
corpo, in ciò che è immortale e vero, in quanto forma assoluta e ripetibile. Secondo
Robin l’esigenza di mediazione fra mondo di quaggiù e mondo sopraceleste è
strutturale nella filosofia platonica, per questa ragione l’erotica con la sua forza
sintetica, è centrale nel discorso platonico. “L’Amore, che unisce gli esseri, rende
possibile la comunione fra la terra e il cielo. E’ una relazione in perpetuo movimento
fra Non – Essere e l’Essere; tuttavia il Non – Essere che sussiste in lui è un Non –
Essere relativo, in fondo al quale vi è il desiderio a l’aspirazione verso l’Essere”
29
(Ibidem, p. 159). Il possesso duraturo dell’Essere può dunque essere dato solo dal
superamento del corpo, segnato indelebilmente dal Non – Essere; il desiderio è spinta
verso l’essere nella misura in cui si stabilisce la natura nichilista del corpo. Robin
sottolinea come Platone colleghi il discorso sull’Amore a quello che riguarda
l’Anima, proprio perché come ci dice il Fedro “la natura dell’Anima è
essenzialmente sintetica nel senso, anzitutto, che ogni anima è legata ad un corpo
vivente” (Ibidem). L’Anima è in relazione con le Idee, stabilisce una relazione con
l’Assoluto attraverso la negazione – superamento della corporeità irripetibile. Questa
funzione dell’Anima è possibile grazie al fatto che, come nota lo stesso Robin, “la
totalità del corporeo ( ) è posta nel seno stesso dell’Anima “
(Ibidem, p. 160 ). Platone inserisce dunque il corporeo nell’Anima, con la distinzione
fra anima mortale e anima immortale, al fine di operare più facilmente la sussunzione
della corporeità irriducibile nella forma assoluta e ripetibile della verità.
A proposito della evoluzione nella concezione platonica dell’anima che supera
il dualismo più rigido e ingloba la sfera del somatico nello psichico, riporto una
annotazione che Mario Vegetti fa nella sua Guida alla lettura della Repubblica di
Platone (Laterza, Bari 1999): “Occorre rilevare la straordinaria novità che Platone
introduce con la sua teoria della scissione dello psichico. In primo luogo, essa
determina l’obsolescenza di una vecchia e illustre posizione di pensiero, con solide
radici religiose nella tradizione orfico – pitagorica, che aveva ancora svolto un ruolo
dominante nel Fedone platonico: l’opposizione radicale, insieme ontologica e morale,
di anima e corpo, nella quale la prima rappresentava la polarita ‘divina’, immortale,
incontaminata, il secondo invece il veicolo di contaminazione, di impurità morale e
conoscitiva, di mortalità. In questo quadro, il corpo veniva pensato come la sorgente
inesauribile dei desideri e delle conseguenti passioni, altrettanti ‘ chiodi che
conficcano l’anima nel corpo ‘ (83 d – e). La Repubblica compie per questo aspetto
una svolta teorica decisiva, attribuendo senza incertezze desideri e passioni alle
istanze irrazionali dell’apparato psichico (437 c). La corporeità resta esclusa, o
collocata sullo sfondo, della dinamica conflittuale intrapsichica, né la Repubblica, a
differenza di quanto accadrà nel Timeo, prospetta alcuna forma di localizzazione
somatica delle istanze in cui in cui l’io risulta articolato e scisso” (Ibidem, p. 56). La
corporeità è dunque assorbita e sussunta nell’anima, così che la sua irriducibilità
possa essere governata e controllata nella macchina ripetibile della verità assoluta. Se
pensiamo all’analisi che Hegel fa nella sezione dedicata all’ Antropologia dell’
Enciclopedia delle scienze filosofiche, dove l’anima rappresenta esattamente la
30
negazione del corpo ( su questo mi permetto di rinviare al § 60 del mio scritto Per
una filosofia dell’irripetibile), allora possiamo davvero misurare come abbiamo già
osservato, l’importanza della filosofia platonica nel definire la forma stessa del
pensare metafisico come controllo e ripetizione della singolarità irripetibile, ovvero
nichilismo del corpo. Lo stesso Vegetti, traendo la conclusione del suo discorso in
termini di filosofia politica scrive infatti: “Le conseguenze di questa svolta teorica
sono di eccezionale importanza. Se infatti nel Fedone la polarità anima /corpo
determinava la concezione della vita filosofica come una ascesi morale e intellettuale,
un progressivo rescindimento dei vincili che legano l’anima al corpo, insomma come
una preparazione alla morte e resurrezione, la Repubblica, interiorizzando il conflitto
nell’anima stessa, apre la via a una politica dell’anima tutta mondana, al progetto di
una strategia di condizionamento educativo del soggetto, destinato a superare quel
conflitto in un orizzonte di pacificazione situato nella città degli uomini e non nel
mitico aldilà delle anime ‘pure’ e dei loro dei “ (ibidem, p. 56 – 57). Insomma per
Vegetti la svolta teorica che la Repubblica opera nella concezione dell’anima,
inglobando il somatico, per Platone è necessaria al fine di rendere possibile una
prospettiva politica sulla giustizia.
Robin con riferimento al Fedro, ricorda come per Platone la parola Eros viene
da ptèros, ovvero “alato”; dunque Eros è la forza che mette le ali all’anima
immortale, e gli permette di liberarsi dal suo essere intrigata con la corporeità; “è
nella Pianura della Verità che l’Anima cercherà il nutrimento che le conviene” (La
teoria platonica dell’amore, cit. p. 163). L’anima mortale condivide lo stesso destino
ontologico del corpo, ovvero la negazione e sottomissione all’anima immortale che
rappresenta il tramite con la verità eterna, metafisica, la quale appare segnata
inevitabilmente dal segno negativo del nichilismo. La funzione mediatrice e
demonica dell’anima rappresenta l’essenza stessa dell’anima immortale che governa,
come racconta il mito dell’auriga e dei corsieri del Fedro, le parti mortali dell’anima.
Come abbiamo già ricordato, è da notare la coincidenza di vedute a proposito della
funzione negatrice – mediatrice dell’anima, tra l’analisi platonica e quella hegeliana,
contenuta nelle dedicate all’ “Antropologia” nell’ Enciclopedia delle scienze
filosofiche. Ricordiamo in proposito la nota che Hegel fa seguire al §389
dell’Enciclopedia, dove il filosofo tedesco nel delineare l’emergere dello spirito
soggettivo attraverso la negazione della corporeità irripetibile e immediata, scrive:
“La questione circa l’immaterialità dell’anima non può avere alcun interesse; salvo
31
che la materia non venga ancora rappresentata come alcunché di vero, da una parte, e
lo spirito, dall’altra, come una cosa. … Ma nello spirito in quanto concetto, la cui
esistenza non è l’individualità immediata, ma la negatività assoluta, la libertà, - onde
l’oggetto o la realtà del concetto è il concetto stesso, - l’esser fuori di sé, che
costituisce la determinazione fondamentale della materia, si è volatilizzato del tutto
facendosi l’idealità soggettiva del concetto, l’universalità. Lo spirito è la verità
esistente della materia: è questa verità per l’appunto, che la materia medesima non ha
verità nessuna” (G. W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, traduzione di
B. Croce, Laterza, Bari 1989). Hegel, coerentemente con la logica metafisica intesa
come scienza del ripetibile istituita da Platone; supera il dualismo materia – spirito
nella identità del concetto, dell’Assoluto ripetibile che non a caso viene rappresentato
dalla forma del circolo. Ma anche su questo va ricordato il nesso profondo che nella
tradizione metafisica platonica e aristotelica esiste tra il percorso infinitamente
ripetibile della forma circolare (identificabile col tempo platonico inteso come
l’“immagine mobile dell’eternità”), e l’eternità intesa come forma che si ripete e si
replica attraverso l’infinita negazione di ogni sua “apparente” singolarizzazione e
materializzazione.
Tornando a Platone, ciò che mette le ali all’anima elevandola sul piano della
verità eterna, è la stessa forza che permette all’Intelletto di accedere alla scienza e
all’universalità ripetibile che supera e nega insieme il corpo irripetibile a cui è legata
inestricabilmente l’anima mortale. L’anima razionale è l’organo della scienza, ovvero
della conoscenza eterna e ripetibile (replicabile circolarmente all’infinito, dunque
senza novità di sostanza); la circolarità assoluta della verità metafisica equivale
logicamente e ontologicamente alla negazione delle singolarità irriducibili. Robin
nell’opera a cui stiamo facendo riferimento, pone giustamente il problema del
significato della presenza nell’uomo della parte mortale e corruttibile dell’anima.
Questa parte corruttibile dell’anima è strettamente intrecciata col corpo, ed ha
una sua precisa funzione nella logica dell’essere che degrada; ovvero in quella
gerarchia ontologica che caratterizza il platonismo e tutte le forme di platonismo che
si succederanno nella storia del pensiero. L’essere per Platone si pone secondo un
ordine gerarchico, da un massimo (Il Bene – Bello, l’Uno) ad un minimo di
consistenza ontologica (lo spazio – materia, la chora); è evidente che intrinseco a
questa visione dell’essere è l’idea di negazione, infatti solo andando dal più al meno,
ovvero sottraendo e negando l’essere, è possibile istituire una gerarchia. L’alternativa
32
all’essere gerarchico è l’essere pieno, compatto, piatto, lineare. La sottomissione
della corporeità necessita nella logica gerarchica dell’essere, che come abbiamo detto
è logica di negazione e sottrazione dell’essere, di un’anima mortale che funga da
mediatrice tra il piano della ragione eterna e il corpo mortale. La scienza della
ripetizione è la scienza della negazione; la negazione si ripete istituendo la gerarchia
dell’essere e degli esseri. Secondo Robin l’Anima nel suo atto essenziale per Platone
è amore; infatti l’Anima “non è un’Idea, ma soltanto un ente che è imparentato con
l’Idea, in ente che le somiglia. Ma d’altra parte, a causa della sua caduta, è legata a
delle parti mortali, si trova imprigionata nel Sensibile e, per questo, è privata delle
Idee; essa manca dunque di ciò che si addice alla sua natura; prova ne è che l’Anima,
quando riesce a liberarsi dalla schiavitù che il corpo le impone, si innamora della
Verità, e la Verità è ciò che possiede la semplicità e la purezza della Cosa in sé
“(ibidem, p. 188). L’Amore è dunque forza mediatrice, tensione verso l’Assolto, da
intendersi come progressivo superamento e negazione della materialità irripetibile, a
vantaggio della forma (idea) eterna. Il senso profondo dell’Amore platonico è
pertanto la sua forza negatrice, il suo essere forza del negativo che si manifesta
attraverso la ripetizione del discorso, la ripetizione della dialettica che istituisce il
ripetibile metafisico. Vedremo in modo preciso questo punto quando analizzeremo il
testo del Simposio, vero monumento al nichilismo platonico. La corporeità è
costituita da irripetibili, da infiniti e imperfetti irripetibili, laddove la perfezione
attiene alla forma ripetibile, la cui essenza è armonia e finitezza. La forma eterna, in
quanto modello, è ripetizione assoluta, forma ripetibile, finitezza che nella metafisica
platonica (e in tutta la metafisica classica) si lega ai concetti di misura e armonia che
caratterizzano la verità (metafisica). La forma metafisica è “uno”, laddove i corpi
imperfetti sono infinita molteplicità. Credo che in questo crocevia teorico vada
collocata quella “ paura dell’infinito “che caratterizza le metafisiche platonica e
aristotelica, ovvero la linea vincente del pensiero antico, rispetto alla linea perdente
degli atomisti, che invece proprio sul concetto di molteplicità infinita costruiva una
immagine del mondo fondata sul caso e la necessità, ovvero su una eternità
dell’irriducibile e irripetibile, e non su una eternità fondata sulla forza del modello
ripetibile che sottomette negando, la molteplicità infinita alla forma assoluta; così
come avviene grazie alla forza di Eros, grazie alla quale l’Anima immortale, pur
legata al corpo, “trova nell’Amore un mezzo per liberarsi dal corpo, per realizzare
nella virtù la perfezione della sua essenza e raggiungere in tal modo le realtà
assolute“ (cfr. L. Robin, op. cit. , p. 194). L’Amore è forza, proprio perché si radica
33
nella corporeità ed in particolare nell’anima mortale. Eros è forza che rende attiva la
forma ripetibile nel suo essere negazione del corpo, anzi dei corpi; giacché si può
parlare di corporeità, secondo una corretta ontologia, solo in termini plurali. La
grandezza del pensare platonico sta proprio nel suo radicare la negazione metafisica
nelle stesse fibre della corporeità, il che dà una forza formidabile alla sua teoresi, che
si fa ipso facto politica, trasformazione, paideia. Robin coglie benissimo questo
punto quando osserva che “lo stupore, principio della scienza, è parente prossimo del
turbamento dal quale vengono presi gli amanti” (ibidem, pp. 200-201). Se lo stupore
è la molla della scienza, allora questo stupirsi e meravigliarsi si radica nel turbamento
che è corpo, passione e financo appetito; ma lo stupore attiva la forza del negativo
che tanto affonda le proprie radici nella corporeità, quanto arriva a negare quella
stessa corporeità nel sapere assoluto. La bellezza che traluce nei corpi, come ci dice
Platone in un celebre luogo del Simposio, in realtà li illumina per cancellarli nel loro
essere irripetibili.
L’amore fisico è condannato da Platone nel Timeo, in quanto delirio,
manifestazione dell’anima inferiore che si ribella alla ragione; la passione degrada
l’intelligenza e dunque va governato – negato dalla ragione, precisamente dall’anima
razionale. Il che significa che la forza erotica va posta sotto il governo dell’anima
razionale, che la utilizza al fine di superare la corporeità nella forma assoluta e
ripetibile. La problematizzazione platonica dell’omosessualità si colloca in questo
contesto. Scrive Robin: “L’amore per i giovani è superiore all’amore per le donne
proprio in quanto è più suscettibile di affrancarsi dalla passione carnale e di
raggiungere lo scopo conoscitivo e morale dell’amore” (ibidem, p. 216). Lo stesso
Robin ricorda tuttavia la condanna platonica della pederastia nelle Leggi (1), e la
limitazione dell’amore carnale allo scopo riproduttivo. Ma allora perché l’amore
omosessuale maschile è superiore? Lo è, certo, a condizione che sia rivolto alla
conoscenza e non alla passione carnale, come scrive Robin; resta tuttavia il fatto che
esiste anche una tendenza omosessuale maschile che si radica nella pura corporeità,
ed è tutta da conquistare da parte ragione. L’omosessualità è del tutto irriducibile alla
logica della ri-produzione e conservazione della specie, dunque è del tutto irriducibile
alla logica del ripetibile, come invece avviene per l’eterosessualità in cui la
conservazione della specie da ragione dell’atto sessuale nella sua carnalità portatrice
di appetiti e di piacere. L’amore eterosessuale è riconducibile alla ragione, proprio
perché rende possibile eternizzare la specie; infatti come scrive Robin, “il desiderio
dell’eternità che è la radice della generazione fisica, che ne è il principio e che ne
34
fissa contemporaneamente i limiti, è dunque anche la ragione profonda dell’amore
filosofico. Ma l’eternità alla quale esso aspira è, almeno, un’eternità vera, quella che
è conferita dal possesso del Vero assoluto e dell’Essere assoluto” (ibidem, p. 218).
L’eternità colta dalla filosofia è la vera eternità, in quanto forma assoluta e ripetibile.
Nel caso dell’omosessualità, ciò che resta, irriducibile, è il piacere limitato a
chi lo prova, senza alcuna possibilità di riprodurre la forma in altro che nega la
corporeità immediata di chi, coppia omosessuale, vive il piacere e il senso irripetibile
di un rapporto d’amore che è animacorporeità inestricabile, data per sempre ed eterna
proprio nel suo essere unica. Ma allora, riprendendo Foucault, possiamo dire che per
Platone la superiorità dell’amore per i giovani, si lega proprio alla necessità di
rispondere alla sfida più forte che la società del tempo poneva alla logica e alla
scienza metafisica del ripetibile, ovvero l’omosessualità maschile con il suo essere
puro ricettacolo di piacere e senso irripetibile; ecco che allora l’amore per il maschio
da parte del maschio, si rovescia per Platone in qualcosa di superiore, pura ricerca del
Vero assoluto e dell’Essere assoluto, proprio per moltiplicare la sua forza negatrice di
ciò che è pura irripetibilità, ovvero piacere e senso irriducibile ad altro che non sia
coppia omosessuata.
Amore è mediatore tra Sentimento e Ragione; il cuore della metafisica
platonica è istituito dalla forza negatrice posta al servizio della ragione. Nel Fedro
Platone pone il delirio, che rappresenta una sorta di rivincita della corporeità, come
condizione della ripetibilità della forma eterna. Amore è demone mediatore; il suo
essere medio lo rende positivo, tuttavia la sua positività esprime la forza negatrice
che supera e nega la materialità nella forma assoluta e ripetibile della Scienza, della
Verità.
“Come l’Anima – scrive Robin - , l’Amore introduce dunque nel divenire
mobile dei fenomeni un principio di stabilità, di ordine e di unione “ ( ibidem, p.
233). Secondo Robin l’Amore è la tendenza attiva verso l’idea, in tal senso l’Amore è
forza del negativo, negazione dell’eternità irripetibile del corpo e sua ripetizione nella
forma assoluta. La forza motrice dell’Amore è rappresentata pertanto dalla tensione
verso la forma ripetibile, la cui essenza è ordine, misura e l’armonia. Se il corpo
irripetibile è eternità nel senso dell’evento la cui novità è data per sempre; la forma è
eterna in quanto extratemporale, oppure in quanto data da sempre e per sempre; in
entrambi i casi si tratta di eternità intesa come ripetibilità.
35
Nella nostra analisi della metafisica platonica come modello della metafisica
come scienza del ripetibile, facciamo ora riferimento all’analisi che Giovanni Reale
fa di Eros come demone mediatore, a partire dal suo celebre paradigma ermeneutico
che assume le dottrine orali di Platone, come punto di riferimento essenziale per
comprendere il senso più profondo della filosofia platonica, e anche per interpretare
in maniera più ricca i dialoghi. Non abbiamo la competenza per entrare nel merito
della validità di tale paradigma interpretativo, che pure non è condiviso da molti
interpreti e studiosi del grande filosofo greco. Ciò che ci interessa sottolineare è il
fatto che, anche prendendo come riferimento il paradigma delle agrafa dogmata, la
cui esistenza, al di là del loro significato per la comprensione della filosofia platonica,
è testimoniata innanzitutto da Aristotele; possiamo trovare un riscontro forte per
comprendere lo strutturarsi della scienza metafisica, intesa come scienza della
ripetibilità.
Il testo di Reale che prendiamo in considerazione è Eros dèmone mediatore e il
gioco delle maschere nel “Simposio” di Platone (Ed. Rizzoli, Milano 1997). Se,
come osserva Reale, Eros è l’altra faccia della dialettica; allora davvero la metafisica
come scienza del ripetibile si inscrive nel corpo, e per la precisione si inscrive
attraverso la negazione della corporeità. La verità socratico – platonica sull’Eros, che
è messa scena in quello che Reale definisce il “gioco delle maschere “del Simposio, è
una verità scritta attraverso una dialettica che nega il corpo che ama l’altro corpo, ed
in ciò istituisce un essere irripetibile e irriducibile a qualunque idea, se non negando
sé stesso. Eros è un Essere intermedio, è un dèmone che ci mette in tensione rispetto
a quello che non siamo; ma allora l’essenza di Eros è il negativo la mancanza. Scrive
Reale che Eros “è desiderio e capacità di procreare nel Bello, sia a livello fisico del
corpo, sia al livello spirituale dell’anima. Muovendo dalla bellezza dei corpi sale alla
bellezza delle anime, e poi alla bellezza che è nelle attività umane e nelle leggi, e,
poi, altresì, alla bellezza che è nelle scienze, per giungere, infine, al vertice delle
visione e della contemplazione del Bello assoluto” (op. cit., p. 28). Eros è forza
ascendente verso il bello assoluto, che coincide col Bene supremo; ma salire significa
negare via via tutti i gradini che costituiscono la strada che ci conduce verso il Bello
supremo, che essendo appunto “supremo”, non potrà che essere pura negazione;
negazione dell’essere eterno e irripetibile, che al massimo potrà essere apparenza del
bello, non certo la sua verità.
Secondo Reale il Simposio contiene alcuni concetti e messaggi rivoluzionari,
tra questi ne riprendiamo due; il primo: “Capovolgimento radicale del senso etico –
36
educativo dell’Eros maschile “; il secondo: “Metafisica della Bellezza e suo nesso
strutturale con l’erotica” (ibidem, p. 30). Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo
precedentemente osservato che Eros maschile, proprio perché accettato e legittimato
nella cultura greca aristocratica, è la quintessenza della irripetibilità, in quanto
irriducibile alla funzione naturale della riproduzione. Ecco che allora per Platone
diventa centrale e strategico rovesciare Eros maschile nella via dia accesso
privilegiata per la Verità. Da elemento di massima sfida, Eros maschile diventa
elemento di massima affermazione e costruzione di una strategia di verità. Per quanto
riguarda la Metafisica della Bellezza, abbiamo già osservato come l’idea di Bellezza
equivale alla negazione del corpo irripetibile. Eros in quanto mediatore è la macchina
della negazione, capace di penetrare nei tessuti più intimi della irripetibilità corporea.
Dalla corporeità si produce la ripetibilità dell’idea metafisica di Bellezza, grazie alla
spinta e alla dinamica di Eros mediatore.
Nel Simposio secondo Reale è in scena una grande gara fra la poesia e la
filosofia, gara che si conclude con la vittoria della filosofia sulla poesia; ciò rimanda
al confronto fra apollineo e dionisiaco; laddove l’apollineo rimanda alla filosofia e il
dionisiaco alla poesia; dunque l’esito messo in scena dal Simposio è per Reale la
vittoria dell’apollineo sul dionisiaco, che si scatena nel finale del dialogo col
personaggio di Alcibiade. Il tema del rapporto filosofia – poesia è centrale anche
nella Repubblica, e lo vedremo successivamente quando analizzeremo alcuni passi
del grande dialogo platonico; quel che possiamo fin da ora osservare è il nesso logico
– ontologico strettissimo che esiste tra la dimensione del corpo irripetibile e la follia
irrazionale rappresentata da Dioniso, e quello che si stabilisce tra filosofia, ovvero
scienza della verità metafisica, e logos ripetibile rappresentato da Apollo, dio solare
della conoscenza profetica. Anche Werner Jaeger osserva a proposito del Simposio
che Platone cerca di gettare un ponte tra Apollo e Dioniso, cercando di mettere al
sevizio della sua idea la forza di Dioniso e di Eros; ha scritto lo studioso tedesco di
Patone: “Vive in lui la certezza che la filosofia riempie di senso nuovo, e trasforma in
un valore positivo, tutto ciò che è vita, anche quello che sta ai confini oltre i quali il
pericolo comincia” (Cfr. W. Jaeger, Paideia. La formazione dell’uomo greco, vol. 2,
La Nuova Italia, Firenze 1978, p. 306). Il pericolo è la follia del corpo, le energie
irrazionali di cui è portatore. Di fronte a questa sfida, e in particolare come vedremo
di fronte alla sfida della pederastia, secondo Jaeger con la filosofia dell’amore
Platone cerca “una giustificazione ideale del rapporto erotico” (ibidem, p. 310).
37
Reale interpreta il Simposio come un gioco di maschere che Socrate – Platone vuole
rivolgere, con la forza de discorso, verso la Verità che supera e nega ogni posizione
parziale, via via rappresentata dai diversi personaggi protagonisti del dialogo. Scrive
Reale che “per Platone stesso l’amato, anche nel migliore dei casi, non può essere se
non una immagine o un riflesso dell’Eros dell’amante” (ibidem, p. 62). Se l’amato è
innanzitutto un corpo, l’amante in quanto tale, può oltrepassarlo, il che significa
negarlo. La Verità di Eros consiste dunque nel superamento – negazione del corpo
amato; nella negazione dell’irripetibilità corporea nella ripetizione di Eros, vera
coazione a ripetere.
Il tema della pederastia è centrale nel Simposio, né poteva essere altrimenti in
un testo che tratta di Eros ed ha come sfondo la società greca e si rivolge in
particolare alla parte colta e aristocratica della società di Atene. La pederastia è difesa
in particolare dal personaggio di Pausania; come scrive Reale, “le idee che Pausania
esprime dovevano essere quelle più diffuse fra gli Ateniesi colti e di alto rango, al
fine di giustificare, dal punto di vista etico, la pederastia” (ibidem, pp. 66-67).
Abbiamo già osservato che la pederastia rappresentava una sfida formidabile per la
metafisica del ripetibile; per questo la filosofia platonica dell'Eros può in un certo
senso essere considerata come la risposta a quella sfida; il risultato è la piena
legittimazione dell’erotica omosessuale (maschile), intesa come forza e motore per la
ricerca della verità metafisica. Ciò è essenziale per la costruzione dell’ordine politico,
il che è del tutto coerente con la motivazione prima del pensare filosofico platonico,
ovvero la ricostruzione della polis.
“Il nocciolo del discorso – scrive Reale – sta dunque in questo: è bello che
l’amato conceda i propri favori all’amante in vista della sapienza e della virtù. E in
quanto questo Eros costringe sia l’amante che l’amato a prendersi cura della virtù, è
Eros Celeste, e ha un grande valore anche politico, perché, mediante la virtù che fa
nascere negli amati e negli amanti, porta ogni vantaggio alla Città e ai cittadini
“(ibidem, p. 76). Attraverso la distinzione tra Eros Uranio o Celeste ed Eros
Pandemio o Volgare, Platone definisce l’Eros filosofico come forza metafisica che,
superando e negando la dimensione corporea e sensibile, coglie il Bello assoluto.
L’Eros sessuale è dunque solo un primo gradino destinato ad essere negato dal vero
Eros, quello filosofico. Certo, possiamo osservare che qualche filo continua a tenere
legato l’uno all’altra le due forme di erotica; infatti come leggiamo nel Fedro, la
sapienza è una forma di mania e di delirio, in un certo senso è una forma di follia,
seppure di un grado più elevato rispetto al delirio e alla follia dell’erotica sessuale;
38
tuttavia pur ad un grado metafisico, resta qualcosa di delirante e di folle; possiamo
chiamarla delirio e follia del negativo, laddove l’erotica sessuale è delirio e follia del
positivo.
A questo punto, come abbiamo detto, vediamo come secondo l’analisi di
Giovanni Reale entrano in gioco nel Simposio le dottrine non scritte di Platone, e
verifichiamo anche su questo terreno la forza costruttiva della metafisica del
ripetibile, così come si definisce nella scienza platonica. Il riferimento è il discorso di
Aristofane con la sua rappresentazione mitologica degli uomini di forma sferica; i
sessi erano tre: uomo – uomo, donna – donna, uomo – donna. Dal discorso
aristofanesco emerge che Eros “è il rimedio che consegue al male della divisione in
due; è la ricerca dell’altra metà, ossia il fare di ‘due uno’ e il tentativo di risanare, in
questo modo, ossia in funzione dell’‘uno’, la scissione diadica dell’umana natura “
(ibidem, p. 103). Secondo Reale qui c’è un preciso riferimento alle dottrine orali di
Platone; dottrine che hanno come due principi supremi l’Uno, che corrisponde al
Bene, e la Diade indeterminata di grande – e – piccolo, che corrisponde al Male. Eros
sarebbe dunque secondo tale prospettiva, l’aspirazione perenne di ogni esserci verso
l’uno originario che coincide col Bene – Bello. La Diade rappresenta la forma del
molteplice, la forma della dispersione e della frantumazione irriducibile ad ogni
forma assoluta e ripetibile. Da questo punto di vista l’Uno, che ha la preminenza
assoluta tra i due principi supremi, rappresenta la forma assoluta della ripetibilità, la
forma che nega ogni frantumazione diadica in funzione di una reductio ad unum. In
tal senso la metafisica dei principi (cuore delle dottrine orali), è una metafisica della
ripetizione. I numeri ideali sarebbero la prima produzione dei principi supremi, e
quale forma è massimamente ripetibile se non quella numerica? Dai numeri ideali si
degraderebbe via via alle Metaidee o Idee generalissime e poi in via subordinata alle
Idee meno generali fino agli enti matematici, che a loro volta si suddividono
nell’abito dell’aritmetica, della geometria, dell’astronomia e della musica. L’anima
rientrerebbe in questo ambito come numero semovente. All’ultimo gradino di questa
gerarchia c’è il mondo sensibile che si suddivide a sua volta in mondo sopralunare e
mondo sublunare. cfr. G. Reale, Introduzione a H. Kramer, Platone e i fondamenti
della Metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1989, p. 23). Se dobbiamo individuare la
forma stessa, la funzione che rende possibile a partire dall’Uno e dalla Diade,
l’istituzione della gerarchia ontologica, tale forma è quella della ripetizione. L’Uno è
il vertice assoluto dell’essere; l’Uno null’altro è se non la possibilità di ripetere la
forma negando la molteplicità diadica di grande – e – piccolo.
39
Eros è forza unificatrice che ci pone in tensione verso l’Uno; ma “l’Uno e
l’Intero di cui parla Platone, non sono affatto l’aggiunzione di una metà all’altra
metà, ossia una mera somma di parti. […] Dunque, cercare di diventare da due uno
significa cercare il Bene che è l’Uno trascendente, Misura suprema di tutte le cose,
che tutto unifica a differenti livelli e in differenti modi, come Platone spiegava
proprio con le sue ‘dottrine non scritte ‘ “(G. Reale, Eros, cit. p. 110). E’ importante
sottolineare che la tensione dell’Eros filosofico verso l’Uno non è una somma di
parti, perché le parti in gioco nella tensione amorosa sono i corpi irripetibili, laddove
la Forma dell’Intero, dell’Uno, è ripetizione; pertanto non produce una somma, che
rimarrebbe irripetibile essendo irripetibili le parti, bensì attua una negazione che
invece è ripetibile all’infinito. Inoltre la ripetizione dell’atto negativo è priva di
novità; immagine di una circolarità assoluta come il tempo lo è dell’eternità per
Platone; l’irripetibilità e la tensione erotica tra corpi irripetibili è invece novità
assoluta, puro evento. Jaeger coglie appieno questo punto quando scrive che “con
questo porre l’oggetto di Eros in un sommo bene da lui desiderato, quello che
appariva un mero impulso irrazionale, è da Platone spiritualizzato e riempito di
significato profondo. D’altra parte, però, sembra che con questa interpretazione vada
perduto il significato limitato, proprio e primo, di Eros, cioè il desiderio di un bello
individuale, particolare “(op. cit., p. 326). Il bello individuale, particolare, è il bello
incarnato in una corporeità unica e irripetibile, che certo non può essere conservata,
anzi è negata nel Bello metafisico. La liberazione dell’idea universale del bello dalle
sue apparenze finite, è infatti precisamente definita da Jaeger come “un processo
graduale dal corporeo allo spirituale” (ibidem, p. 329).
Il cuore del discorso platonico su Eros, come è noto, lo espone nel racconto di
Socrate la sacerdotessa Diotima di Mantinea. Eros è amore, desiderio di quelle cose
di cui si avverte la mancanza; per questo Eros è demone mediatore tra non essere ed
essere, essendo figlio di Penia (mancanza) e Poros (espediente), come racconta il
mito. Come sottolinea Reale, è a questo punto che si apre il sipario della Verità su
Eros, dopo che nel corso del dialogo ci si è liberati e purificati dalle false conoscenze.
Reale vede in questa teoria di Eros – demone mediatore, un riferimento preciso alla
metafisica dei principi contenuta nelle dottrine orali; “ Eros nella sua struttura
bipolare in senso dinamico esprime quella tendenza sempre crescente, a vari livelli,
del principio materiale ( la Diade indefinita di grande – e – piccolo) a ricevere il
principio formale ( l’Uno e l’azione determinante dell ‘Uno, che coincide con il bene)
, elevandosi, così fecondato, sempre più in alto verso il principio primo e supremo
40
dell’Uno – Bene. E proprio nel suo riprodursi perennemente, e nel suo realizzarsi
continuamente a vari livelli, in questa dimensione dinamico – bipolare, Eros
garantisce la stabilità e il permanere dell’essere “(Eros, cit., pp. 174 – 175). Eros è
forza unificatrice che si “riproduce perennemente “, ovvero è ripetibilità e
unificazione della materialità corporea; la materia aspira all’unificazione, cioè aspira
ad essere negata e ripetuta nell’Uno. Da questo punto di vista la procreazione fisica è
espressione di Eros come tendenza a procreare nel bello e aspirazione all’immortalità;
tuttavia questo è ancora un gradino imperfetto rispetto alla immortalità ed eternità di
carattere metafisico che può essere garantita solamente dalla negazione assoluta di
qualunque elemento irripetibile, segno inequivocabile della corporeità. Il vero amante
ama quell’unica e identica bellezza che si ripete in tutti i corpi belli, non certo la
singolarità corporea nella sua bellezza unica e irripetibile; l’idea del bello traluce in
tutti i corpi che diciamo belli senza esaurirsi in alcuno di essi; anzi questi sono tutti
negati e superati dall’idea assoluta di bellezza. Come scrive Reale, “il vero amante
ama il corpo bello non già nel suo essere corpo, ma piuttosto, in modo determinante,
nel suo essere bello. […] l’Eros del corpo per Platone, se rettamente inteso, porta
subito oltre, a un secondo gradino della scala d’amore, ossia al gradino dell’anima “
(ibidem, pp. 208 e 210 ). L’anima in tal senso è davvero la negazione del corpo, vero
organo della filosofia intesa come conoscenza della verità, del bello che si ripete
eternamente nella forma dell’armonia, dell’ordine e della simmetria. Eros come forza
creatrice del giusto ordine e della giusta misura, osserva sempre il Reale, è per
Platone anche potenza formatrice dello Stato.
Il punto che a me appare davvero essenziale nella teoria platonica dell’amore, è
costituito dal fatto che la forza metafisica e negatrice di Eros sia radicata nelle fibre
stesse della corporeità, da cui il motore erotico si mette in movimento nell’ascesa
verso l’intellegibile. La forza erotica che fonda la metafisica del negativo è tanto più
irresistibile quanto più trabocca dalla materialità corporea.
Breve antologia di testi platonici sull’amore tratti dal “Simposio” con note di
commento.
“[Fedro] … Perché io non so dire un bene maggiore per l’adolescente che quello
d’aver subito un valoroso amante e per l’amante d’aver il suo innamorato. Il principio
41
che deve essere di guida per tutta la vita agli uomini desiderosi di vivere nobilmente,
né la parentela, né gli onori, né la ricchezza, nulla insomma può così bene ispirarlo
come l’amore” (Platone, Opere complete, vol. 3, Laterza, Roma – Bari 1979, 178 c,
trad. di P. Pucci, come tutte quelle che seguono della stessa opera).
“[Fedro] … Senz’altro quel che dice Omero, che in alcuni eroi il dio inspira la furia,
questa furia è Amore che la dona agli amanti, come cosa sua “(179 b).
“[Fedro] … Gli è che l’amante è qualcosa di più divino che chi è oggetto d’amore,
perché egli è pieno di dio. … “(180 b).
“[Pausania] L’Amore compagno di Venere Volgare è veramente volgare e agisce a
casaccio, ed è quello che amano gli uomini da poco. Costoro prima di tutto amano
non meno le donne dei fanciulli, e poi di questi amano i corpi più delle anime, e
infine prediligono le persone più insulse, tutti intenti come sono al loro fine,
indifferenti del modo, se bello o meno. D’onde capita loro di imbattersi a caso, talora
nel bene, tal’ altra nel male. Gli è anche che questo Amore procede dalla dea molto
più giovane dell’altra, e partecipa per la nascita tanto del maschio che della femmina.
. Ma l’altro procede da Afrodite Urania che innanzitutto non partecipa della femmina,
ma solo del maschio (ed è questo l’amore per i fanciulli), e che poi è più antica e
inesperta di sfrenatezza. Onde coloro che sono ispirati da tal amore si rivolgono al
maschio, ammirandone la natura più forte e l’intelligenza più viva “(182 181 a – c).
“[Pausania] … sotto questo aspetto si potrebbe pensare invece che qui la pederastia
sia ritenuta vergognosissima. Ma così sta il fatto, credo. Non è semplice; e, come
osservavo all’inizio, in sé e per sé non è né bella né brutta, ma se ben compiuta è
bella, se disonorevolmente compita è vergognosa. Vergognosa è dunque bassamente
compiacere un uomo da nulla, bello è invece compiacere nobilmente una persona
eccellente. E’ da nulla quell’amante volgare che concupisce più il corpo che l’anima
perché tale uomo non è amante duraturo in quanto cerca una cosa che non dura, e così
insieme allo sfiorire del corpo che amava, egli ‘ si dilegua e vola via ‘, facendo torto a
molte sue parole e promesse. Ma colui che ama l’anima, che è parte nobile, rimane
amatore per la vita, in quanto fuso con una cosa che dura “(183 d – e).
“[Pausania] Rimane alla nostra norma di condotta una sola via per permettere che
l’amato si conceda onorevolmente al suo amante. Esiste cioè da noi la regola che,
come per gli amanti non è piaggeria né infamia essere disposti a servire qualsiasi
servitù agli amati, così ecco rimane un’altra sola servitù volontaria e onorevole per
gli amati, e questa è quella che ha per fine la virtù “(184 b – c).
42
“[Pausania] … Ecco che queste due norme, quella che regge l’amore per i fanciulli e
quella che governa l’amore per la saggezza e altre virtù, debbono concorrere allo
stesso fine se deve risultare onorevole che l’amato si conceda all’amante “(184 c).
Nell’ambito della problematizzazione platonica dell’omosessualità (tema centrale nel
discorso di Pausania), possiamo notare come l’Amore volgare sia quello che spinge
verso i corpi delle donne non meno che dei fanciulli. L’attrazione per il corpo
femminile trova una propria giustificazione nella dimensione della riproduzione; si
tratta in tal caso della ripetizione biologica, il primo gradino nella definizione della
struttura metafisica del ripetibile la cui vetta è rappresentata nel Simposio dall’Idea
del Bello in sé, pura forma la cui essenza è negazione - superamento di ogni bellezza
incarnata che, per quanto perfetta, mai sarà la forma perfetta del ripetibile in quanto
tale. Il rapporto uomo – uomo sta dalla parte di Eros volgare, Pandemio, se è rivolto
unicamente al corpo; in tal caso è ancora più diabolico dell’amore per il corpo
femminile. Infatti in tal caso c’è sempre la via d’uscita della ripetibilità biologica;
nel caso dell’amore omosessuale (maschile, in quanto di omosessualità femminile
non è proprio il caso di parlarne, considerato il ruolo che alla donna veniva
assegnato in quel tempo), la sfida è estrema perché o soccorre la verità assoluta,
oppure è solo attrazione corporea chiusa unicamente nell’irripetibilità e
irriducibilità di due corpi erotici. Eros celeste, Uranio, come leggiamo nel Simposio
non partecipa della femmina, ma solo del maschio; per questo il vero amore è quello
dell’uomo maturo (amante) nei confronti del fanciullo (amato), perché solo
attraverso questo rapporto si possono salire i gradini della conoscenza che,
superando e negando ogni singolarità corporea, arrivano fino alla verità, alla
Bellezza in sé, pura armonia e simmetria, pura forma ripetibile attraverso
l’indefinita, illimitata e molteplice corporeità. La sfida dell’amore è la sfida della
follia nei confronto del logos; ricordiamo che nel Fedro Platone include l’amore
nella sfera della follia. Se la sfida dell’erotismo che si sviluppa nel rapporto
corporeo tra l’uomo e la donna è superata dalla logica della riproduzione biologica
(per quei tempi si trattava di una logica non metafisica, tuttavia immodificabile); la
sfida dell’amore omosessuale tra due maschi, è superata da Platone grazie alla
logica metafisica che definisce la verità come pura ripetizione della forma. Per la
cultura del tempo, solo l’uomo aveva l’intelligenza per salire i gradini nella scala
della verità; Platone può così vincere la minaccia estrema dell’omosessualità
maschile alla logica del ripetibile, trasformando il piacere irripetibile in energia
disponibile, che negando e scarnificando il corpo erotico ne lascia un mero
simulacro metafisico: il Bello in sé che dunque nella sua essenza è pura negazione.
Scrive a proposito del Simposio Camille Dumouliè (Le dèsir, trad. it., Einaudi,
Torino, 2002, p. 20 ): “Nel bagliore della sua purezza, infatti, il bello non può in
ogni caso essere uno specchio. Anzi, a rigor di logica, non è nulla. O è qualcosa di
43
definibile solo con formule negative. La bellezza ‘ semplice ed eterna ‘ ‘ non si rende
visibile ‘ come un volto, o delle mani, o qualche altra forma corporea, né come un
discorso o una conoscenza […] ‘. Qual è dunque il volto di questa bellezza senza
volto? Se la funzione del bello è quella di guidare il desiderio verso un’immortalità
che è il nome glorioso della morte stessa, se, dunque, il suo ruolo è quello di tessere
un velo d’illusione tra il desiderio e la pulsione di morte, il Bello in sé corrisponde a
quel momento di supremo piacere in cui il velo delle belle apparenze sta per
lacerarsi “. Secondo Dumouliè il bello in sé di Platone anticipa la “metafisica
negativa di Plotino, per il quale il bello in sé è l’ultimo bagliore dell’Essere prima
dell’identificazione suprema con il Non – Essere dell’Uno “. Il Bello in sé è dunque
Negazione e Ripetizione.
“Ed ecco quel che disse Eurissimaco: Penso che sia necessario, dal momento che
Pausania non è andato sufficientemente a fondo del discorso che però ha bene
iniziato, che sia necessario, dico, cercare di completare la fine mancante. Buona mi è
parsa la sua distinzione di due Amori; che però Amore viva non solo nelle menti
umane e tenda verso i belli ma anche verso molte altre cose e viva i altre nature, cioè
nei corpi di tutti gli animali e nelle piante della terra, e per dirla in una parola in tutti
gli esseri, tutto ciò mi par d’averlo osservato bene dalla medicina, l’arte nostra … .
Perché la medicina, per dirla in breve, è la scienza delle inclinazioni amorose del
corpo verso la pienezza e il vuoto, e chi sappia riconoscere in esse la buona e la
cattiva inclinazione, questi è medico espertissimo” (185 e – 186 d).
“[Eurissimaco] La medicina dunque, come vi sto dicendo, è tutta governata dal dio
Amore, e così pure la ginnastica e l’agricoltura” (186 e).
Il medico Eurissimaco riporta il discorso su amore dal cielo alla terra; non a caso fa
riferimento alla distinzione introdotta da Pausania tra Afrodite Celeste e Terrestre.
La dimensione terrestre di Eros viene dal medico – scienziato rivalutata, proprio
perché il criterio di giudizio non è morale, come accadeva nel discorso di Pausania,
bensì scientifico. Pertanto amore è come una energia cosmica colta nella sua
materialità, nel suo essere forza di riempimento e svuotamento; il pieno e il vuoto
con i loro equilibri relativi producono la salute di cui la medicina è la scienza ma
anche l’arte, memori dell’esperienza ippocratica di cui rimane più di una eco in
Platone. Nella sua materialità, o meglio corporeità, possiamo dire che Eros sia
dunque forza e potenza che afferma la vita, laddove Eros come forza metafisica che
tende al Bello in sé, è potenza negatrice scorporante e scarnificante.
“[Aristofane] Ecco dunque da quanto tempo l’amore reciproco è connaturato negli
uomini: esso ci restaura l’antico nostro essere perché tenta di fare di due una creatura
44
sola e di risanare così la natura umana. Ognuno di noi è dunque la metà di un umano
resecato a mezzo com’è al modo delle sogliole: due pezzi da uno solo; e però sempre
è in cerca della propria metà” (191 d).
“E quanti risultano tagliati da quell’essere misto che allora si chiamava androgino,
sono grandi amatori di donna, ed è da questo ceppo che provengono per lo più gli
adulteri; e parallelamente le donne che da qui provengono vanno folli per gli uomini
e sono adultere; invece quante donne risultano parte di femmina, per nulla pensano
agli uomini, ma più volentieri sono inclinate alle donne, e da questo sesso le tribadi; e
quanti infine sono parte di maschio danno la caccia al maschio e finché sono
fanciulli, cioè fettine di uomini, amano gli uomini e godono a giacersi e ad
abbracciarsi con gli uomini. E questi sono i migliori fra i fanciulli e i giovani perché
sono i più vicini alla natura” (191 e – 192 a).
Nel famoso mito raccontato da Aristofane viene presentata una antropologia
fantastica secondo la quale la conformazione degli uomini primitivi era doppia
rispetto a quella attuale (a forma sferica), e la distinzione sessuale prevedeva il sesso
maschile, quello femminile e l’androgino. Giove al fine di difendersi dalla loro
tracotanza taglia questi esseri doppi in due parti separate e li adatta dal punto di
vista fisiologico affinché possano procreare. La differenziazione nell’attrazione
sessuale dipende dalla natura primitiva dell’umanità. Il mito aristofanesco riporta il
discorso sul piano della metafisica, dopo la parentesi medico – scientifica introdotta
da Eurissimaco. Se l’amore reciproco restaura l’antico nostro essere perché cerca di
riportare all’uno ciò che era due, allora la forza di Eros in termini metafisici
possiamo dire che sia la negazione del due, della differenza, a vantaggio
dell’unificazione. Eros è forza unificatrice più che mediatrice; Amore raggiunge
l’Uno in quanto nega il Due. Se in termini materiali Amore e forza equilibratrice del
pieno e del vuoto, in quanto forza metafisica Eros è forza negatrice della differenza e
affermatrice dell’Uno; in tal senso l’Uno (evocato miticamente dagli uomini palla) è
pura forza annichilente come abbiamo già osservato.
“[Socrate] Non è forse Amore, in primo luogo amore di qualche cosa, e poi di quelle
cose di cui si trovi privo?” (200 e).
Il discorso socratico del Simposio inizia con alcune puntualizzazioni sul significato
stesso del concetto di Amore, che mettono in rilevo il carattere di mancanza e di
carenza impliciti nell’esperienza stessa di chi ama qualcosa o qualcuno. Possiamo
dire che l’idea di negazione appartenga strutturalmente al concetto stesso di Eros
come chiarirà successivamente il grande discorso della sacerdotessa Diotima di
45
Mantinea raccontato da Socrate. Nel mito raccontato da Diotima Eros è concepito il
giorno della nascita di Afrodite, quando durante il banchetto tenuto dagli dei Penia
si accoppiò con Poro. Poiché Eros è figlio di Espediente e Povertà, ha i caratteri di
entrambi e dunque è demone mediatore.
“[Socr. / Diotima] Chi sono allora, o Diotima, replicai, quelli che si applicano alla
filosofia, se escludi i sapienti e gli ignoranti? Ma lo vedrebbe anche un bambino,
rispose, che sono quelli a mezza strada fra i due, e che Amore è uno di questi. Poiché
appunto la sapienza lo è delle cose più belle e Amore è filosofo, e in quanto tale sta in
mezzo fra il sapiente e l’ignorante” (204 a – b).
Il vero amante è il filosofo; il vero uomo erotico come vedremo alla fine del dialogo,
è Socrate nel suo incarnare la Filosofia. La filosofia per Platone è forza negatrice
del contingente; questa è la forma del pensiero metafisico come pensiero negativo.
La natura dell’amante per Platone è superiore a quella dell’amato; l’amante incarna
perfettamente il desiderio e la sua forza negatrice.
“[Socr./ Diotima] Possiamo dunque, continuava lei, dire semplicemente che gli
uomini amano il bene ? Si, risposi. E che? Non si deve aggiungere che amano anche
possedere il bene? Va aggiunto, sì. E non solo possederlo, ma anche possederlo
sempre? Va aggiunto anche questo. Riassumendo quindi, l’amore è desiderio di
possedere il bene per sempre. Verissimo dissi io “(206 a).
La struttura del pensare metafisico trasfigura il Bello in Bene, stabilendo una loro
sostanziale equivalenza. Passare dal Bello al Bene significa sottolineare i caratteri
formali e di equivalenza universale della bellezza; significa affermare la ripetibilità
della forma che alla fine dell’ascesa erotica possediamo per sempre. L’eternità della
forma coincide con la sua ripetibilità universale (mi sovviene a questo proposito
l’idea del denaro come equivalente universale di Marx).
“[Socr. / Diotima] Poiché dunque l’amore è sempre questo, riprese lei, in quale modo
e in quali azioni lo zelo e la tensione di coloro che lo perseguono possono essere
chiamati amore? […] Te lo dirò io, allora – è la procreazione nel bello, secondo il
corpo e secondo l’anima. […] Tutti gli uomini, o Socrate, sono pregni nel corpo e
nell’anima, e quando giungono ad una certa età, la nostra natura fa sentire il desiderio
di procreare. Non si può partorire nel brutto, ma nel bello, si. L’unione dell’uomo e
della donna è procreazione; questo è il fatto divino, e nel vivente destinato a morire
questo è immortale: la gravidanza e la riproduzione. Ma è impossibile che queste
avvengano in ciò che è disarmonico. E il brutto è disarmonico a tutto ciò che è
46
divino; il bello invece gli si accorda; così che bellezza fa da Sorte (Moira) e da
Levatrice (Ilitia) nella procreazione “(206 b – d).
“[Socr. / Diotima] Perché la riproduzione è il qualcosa di sempre nascente e
immortale per quanto è possibile a un essere mortale. …Da ciò consegue come
necessario che l’amore sia anche amore dell’immortalità” (207 a).
“[Socr. / Diotima] Giacché qui si ritorna allo stesso discorso: la natura mortale cerca
con ogni mezzo, di perpetuarsi e di essere immorale. E può riuscirvi solo per questa
via, mediante la riproduzione, perché lascia sempre un giovane al posto di un
vecchio” (207 d).
“[Socr. / Diotima] Ché in questo modo sia salva ogni esistenza mortale, pur non
rimanendo come quella divina, sempre assolutamente uguale a se stessa, ma in
quanto ciò che invecchia e se ne va, lascia al suo posto un’altra esistenza giovane,
identica a quella di prima. Con questo espediente, o Socrate, il mortale partecipa
dell’immortalità sia per il corpo sia quanto al resto. L’immortale tiene altra via. Non
ti meravigliare dunque, se ogni essere tiene caro per natura il proprio germoglio:
perché è in vista dell’immortalità che in ognuno procede cotanto zelo e amore “(208
b).
Si partorisce nel bello perché il bello – bene è la forma, la perfezione che si ripete
infinitamente negando ogni contingente. Senza forma che si ripete, è impossibile la
procreazione; in tal senso la procreazione è semplice trasmissione della forma, come
chiarirà meglio la metafisica biologica di Aristotele. Dal punto di vista della
corporeità l’eternità è conseguita unicamente attraverso la riproduzione biologica;
la procreazione è un atto di negazione/ affermazione della forma eterna. Nella
riproduzione il bello è la forma negatrice che si riproduce negando l’irripetibilità del
corpo. L’accoppiamento uomo – donna trova il proprio senso metafisico
nell’assolvere alla funzione biologica della riproduzione, grazie alla quale la pura
forma del vivente si perpetua in quanto nega ogni sua manifestazione singolare e
irripetibile. L’accoppiamento uomo – uomo, non potendo trovare alcun senso nella
riproduzione biologica, lo trova unicamente nell’accedere alla verità metafisica,
attraverso un percorso conoscitivo e pedagogico tra amante e amato che sublima la
follia irriducibile e irripetibile (anche nel senso che non può dar luogo ad alcuna
riproduzione biologica) dell’eros omosessuale (maschile). L’omosessualità femminile
come abbiamo visto è derubricata a mero sfregarsi di corpi in preda alla voluttà
erotica (le tribadi che abbiamo incontrato in un passaggio precedente).
47
“[Socr. / Diotima] Chi vuole rettamente procedere a questo fine – disse – conviene
che fin da giovane cominci ad accostarsi ai bei corpi e dapprima, se il suo iniziatore
lo inizia bene, conviene che s’affezioni a quella persona sola e con questa produca
nobili ragionamenti ; ma in seguito deve comprendere che la bellezza di un qualsiasi
corpo è sorella a quella di ogni altro e che, se deve perseguire la bellezza sensibile
delle forme, sarebbe insensato credere che quella bellezza non sia una e la stessa in
tutti i corpi. Convinto di ciò deve diventare amoroso di tutti i bei corpi e allentare la
passione per uno solo, spregiandolo e tenendolo di poco conto. Dopo di ciò giunga a
considerare che la bellezza delle anime è più preziosa di quella del corpo, cosicché se
qualcuno ha l’anima buona ma il corpo fiorisca di poca bellezza, egli ne sia pago lo
stesso, lo ami, ne sia premuroso, e produca e ricerchi ragionamenti tali da rendere
migliori i giovani per essere poi spinto a contemplare la bellezza nelle attività umane
e nelle leggi, e a vedere come essa è dappertutto affine a se stessa finché non si
convinca che la bellezza del corpo è ben piccola cosa “ ( 210 a – c).
“[Socr. / Diotima] Chi sia stato educato fin qui nelle questioni d’amore attraverso la
contemplazione graduale e giusta delle diverse bellezze, giunto che sia al grado
supremo dell’iniziazione amorosa, all’improvviso gli si rivelerà una bellezza
meravigliosa per sua natura, quella stessa, o Socrate, in vista della quale ci sono state
tutte le fatiche di prima: bellezza eterna, che non nasce e non muore, non s’accresce
e non diminuisce, che non è bella per un verso e brutta per l’altro, né ora sì e ora no;
né bella e brutta secondo certi rapporti; né bella qui e brutta là, né come se fosse bella
per alcuni ma brutta per altri. In più questa bellezza non gli si rivelerà con un volto né
con mani, né con altro che appartenga al corpo, e neppure come concetto o scienza,
né come risiedente in cosa diversa da lei, per esempio in un vivente, o in terra, o in
cielo, o in altro, ma come essa è per sé e con sé, eternamente univoca, mentre tutte le
alte bellezze partecipano di lei in modo tale che, pur nascendo esse o perendo, quella
non s’arricchisce né scema, ma rimane intoccata” (210 e – 211 b).
Siamo ai passaggi cruciali e famosi del grande discorso di iniziazione ai misteri
d’amore rivolto dalla sacerdotessa Diotima a Socrate. La Bellezza traluce nel corpo,
ma questo è solo l’inizio della scala che porta alla Bellezza in sé e per sé. La
gerarchia è possibile solo grazie alla forza della negazione che consente di
oltrepassare ogni momento relativo per lasciare spazio solo all’Assoluto. Il Bello in
sé è univoco, non cresce né decresce, è pura ripetizione di se stesso, pertanto non
può incarnarsi in alcun volto o mani. La Bellezza pura rimane intoccata proprio in
virtù del suo essere pura negazione come abbiamo già osservato precedentemente.
L’eternità dell’idea di bello coincide col suo essere ripetibilità e negazione; il cuore
del pensare metafisico in tal senso è davvero il nichilismo come sostiene Emanuele
48
Severino, ma a questo punto possiamo dire che il cuore della metafisica sia il
nichilismo che equivale al carattere ripetibile della verità.
“[Socr. / Diotima] Ecco che quando uno partendo dalle realtà di questo mondo e
proseguendo in alto attraverso il giusto amore dei fanciulli, comincia a penetrare
questa bellezza, non è molto lontano dal toccare il suo fine. Perché questo è proprio il
modo giusto di avanzare o di essere da altri guidati nelle questioni di amore:
cominciando dalle bellezze di questo mondo , in vista di quella ultima bellezza salire
sempre, come per gradini, da uno a due e da due a tutti i bei corpi e dai bei corpi a
tutte le belle occupazioni, e da queste alle belle scienze e dalle scienze giungere
infine a quella scienza che è la scienza di questa stessa bellezza, e conoscere
all’ultimo gradino ciò che sia questa bellezza in sé “ (211 b – c).
“[Socr. / Diotima] Che cosa allora dovremmo pensare, se capitasse ad uno di vedere
la bellezza in sé, pura, schietta, non tocca, non contagiata da carne umana né da
colori, né da altra vana frivolezza mortale, ma potesse contemplare la stessa bellezza
divina nell’unicità della sua forma?” (211 e).
Carne umana, colori, vane frivolezze mortali: sono questi tratti indistinguibili
dell’irripetibilità che la bellezza in sé, nella unicità ripetibile della sua forma, non
può che negare per sempre, eternamente.
Passando dalle scienze alla scienza delle scienze, ovvero alla scienza del bello in sé
(l’ascesa dialettica descritta in altri dialoghi platonici) si acquisisce la forma stessa
dell’epistème in quanto pura ripetibilità e negazione assoluta del contingente. Il
culmine della scienza è la forma del ripetibile coincidente con il Bello in sé.
“[Socrate] Mio caro Alcibiade – disse – rischi di non essere affatto sciocco se per
caso son vere le cose che dici di me e se c’è dio sa quale potere in me che ti potrebbe
rendere migliore. Ecco tu vedresti in me una irresistibile bellezza del tutto
incomparabile pure alla grazia delle tue forme: se avendola scoperta cerchi di
appropriartene barattando bellezza con bellezza, miri a guadagnarci non poco alle
mie spalle! Via, in cambio di una bellezza apparente tenti di guadagnarci una bellezza
vera e calcoli, alla lettera, di scambiare ‘oro con rame’ “(218 d – e).
“[Alcibiade] Malgrado tutti questi miei sforzi, costui di tanto mi superò, sdegnò e
derise la mia bellezza, e la offese …eppure credevo che valesse qualcosa, o giudici
(ché voi siete giudici della superbia di Socrate) … ebbene, sappiatelo, lo giuro, per gli
dei e per le dee, dormii con Socrate e mi levai né più né meno che se avessi dormito
col padre o con un fratello maggiore” (219 c- d).
49
L’irruzione di Alcibiade alla fine del Simposio rappresenta in un certo senso la
chiusura del cerchio. La bellezza fisica di Alcibiade rispetto alla bellezza interiore di
Socrate (a cui fa da contraltare la sua bruttezza fisica esteriore) è come il rame
rispetto all’oro. Non ci può essere umiliazione maggiore per la bellezza corporea
incarnata da Alcibiade; il corpo erotico è negato dalla bellezza in sé a cui perviene
la scala che accede alla realtà metafisica illustrata dalle parole della sacerdotessa
Diotima. L’omosessualità maschile è trasfigurata nella ricerca della verità eterna e
ripetibile dell’idea che nega ogni contingenza, a partire da quella corporea in cui
può solo albergare un pallido e scolorito riflesso della Bellezza assoluta. La
negazione del corpo è la verità della negazione del Bello/Bene in sé (ricordiamo che
in sé equivale a non in altro).
50
Note
1) Vediamo precisamente cosa scrive Platone nelle Leggi a proposito dell’omosessualità ( trad.
di A. Zadro, in Platone, Opere complete con testo greco, CD-ROM a cura di G. Iannotta,
A.Marchi, D. Papitto, Laterza Multimedia, 1999). L’Ospite ateniese discute con Clinia di
Creta e Megillo di Sparta sulla costituzione e le leggi della città; ad un certo punto
afferma:“ Ebbene, se ora proseguendo prenderemo in esame quello che ci propone l’ordine
già esposto, o Clinia e tu ospite spartano - voi sapete che tocca di parlare della saggia
temperanza dopo il coraggio- credete che troveremo qualche cosa di notevole nelle vostre
due costituzioni rispetto a quelle altre dei popoli che a caso siano ordinati, così come
abbiamo notato or ora riguardo alla guerra?… Par difficile, ospiti, che tutto ciò che riguarda
le costituzioni, ancora quand’è discorso così come sul piano dei fatti, riesca in qualche modo
ad avere una validità indiscussa. C’è il pericolo, come per i corpi, di non poter prescrivere a
uno di questi una pratica senza che questa stessa risulti da una parte dannosa, dall’altra utile
ai nostri corpi. Perché anche questi "ginnasi" e i "pasti in comune" sono ora di giovamento
in moltissimi casi allo stato ma nelle sedizioni sono una difficoltà, lo mostrano i figli dei
Milesi e dei Beoti e dei Turii. E ancora pare che quest’uso abbia corrotta una antica legge di
natura che dovrebbe governare sempre i piaceri sessuali non solo degli uomini ma anche
delle bestie. E di questi mali si potrebbero accusare primi i vostri stati e tutti gli altri poi che
fanno uso larghissimo dei "ginnasi "; e sia che di questo argomento si pensi per gioco o
seriamente, bisogna riconoscere che tale piacere sembra esser stato attribuito dalla natura al
genere femminile e a quello dei maschi in quanto fra loro si uniscono per la generazione, ma
l’unione dei maschi coi maschi, o delle femmine con le femmine è contro natura, atto
temerario creato fin da principio da disordinato piacere” (Leggi I, 636 a - d ).
L’accoppiamento tra maschio e maschio (che coinvolge in particolare giovani maschi) e tra
femmina e femmina è contro natura perché inutile rispetto alla riproduzione, essendo tutto
compresso nella meccanica del piacere. Il tema ritorna nel libro VIII delle Leggi, laddove si
tratta del controllo dei magistrati sul rispetto delle leggi da parte dei cittadini; infatti è
evidente che è assai difficile controllare la sfera privata delle persone, soprattutto per quanto
attiene i comportamenti sessuali. Si domanda infatti Clinia: ” Come potranno, in tale stato,
star lontani dai desideri che molti molte volte trascinato a conseguenze estreme, desideri da
cui il discorso, nel tentativo di diventar legge, comanderebbe di astenersi? E non v’è dubbio
che non c’è da meravigliarsi se le norme stabilite fin qui terranno a freno la maggior parte
dei desideri - il divieto infatti di appropriarsi di una ricchezza eccessiva è non piccolo aiuto
alla saggia temperanza; così tutto il sistema educativo è stato regolato adeguatamente allo
stesso scopo, e, oltre a ciò, lo sguardo dei magistrati, costretto a non guardare altrove, ma
invece a guardare sempre da questa parte e in particolare i giovani, è sufficiente a controllare
le altre passioni, per quanto ciò è possibile agli uomini - ma io domando come si potrebbe
guardarsi dagli amori per i bambini, maschi e femmine, e per le donne che sostituiscono
l’uomo, e per gli uomini che fanno da femmina, cose dalle quali infinite conseguenze sono
derivate agli uomini, per i singoli privatamente e per gli stati interi? (Leggi VIII, 835 e – 836
51
b). Se Sparta e Creta sono modelli da seguire per molte questioni, non lo sono affatto per
quanto concerne l’etica sessuale; dice infatti L’Ospite ateniese: “E infatti mentre tutta Creta
e Sparta ci danno un aiuto, io direi, non piccolo per molte altre questioni, lo danno a noi che
stiamo stabilendo leggi diverse dai costumi comuni, tuttavia per gli amori - diciamolo pure
perché siamo fra di noi – ci sono del tutto contrarie. Se infatti qualcuno seguendo la natura
stabilisse la legge in vigore prima di Laio affermando che era giusto non accoppiarsi con
giovani di sesso maschile, per le relazioni sessuali, come se questi fossero donne, e portasse
a testimonianza la natura degli animali mostrando che nessuno di loro maschio tocca a tale
scopo un maschio perché è contro la natura, userebbe forse di un argomento persuasivo ma
in assoluto disaccordo a quanto si usa fare nei vostri stati. Inoltre ciò che noi diciamo dover
essere oggetto della perenne vigilanza del legislatore non si accorda a queste abitudini. Noi
infatti cerchiamo sempre quale delle leggi che vengono poste conduce alla virtù e quale no;
e allora, rispondetemi, se noi anche concediamo nelle nostre leggi che queste vostre
abitudini sono belle cose o almeno non affatto disoneste, per quale aspetto potrebbero
aiutarci nei confronti della virtù? “(Leggi VIII, 836 b – 836 d). Ma quali leggi possono
domare quella che per Platone è una delle passioni più sfrenate nell’uomo, ovvero il piacere
sessuale; una energia che prorompe nell’uomo e nella donna, senza preoccuparsi troppo che
la coppia sia eterosessuale. Leggiamo: “ATEN. E’ corretto dunque ciò che ora si è detto e
cioè che il legislatore, che intende domare una delle passioni che dominano di più gli
uomini, può scoprire facilmente il modo di realizzare la sua intenzione e cioè che
infondendo un carattere sacro a questa tradizione e confermandola nel suo essere identica
presso di tutti, schiavi, liberi, bambini, donne, in tutto lo stato, in tal modo avrà realizzato a
proposito di questa legge la sua più sicura stabilità. MEG. E’ del tutto vero; ma bisogna
vedere come sarà possibile far sì che tutti vogliano accettare di dire una cosa siffatta. ATEN.
Giusta osservazione; proprio questo infatti era ciò che dissi e cioè che io avevo un’arte per
formulare questa legge relativa all’usare secondo natura delle unioni per la procreazione dei
figli, astenendosi dall’unione fra maschi ed evitando la soppressione deliberata del genere
umano e evitando che il seme sia gettato su pietre e macigni, dove esso non potrà trovare
luogo adatto alle sue radici e mai potrà assumere la propria natura capace di generare,
astenendosi da ogni campo femminile nel quale ciò che vien seminato non accetteresti mai
dovesse germogliare. Se una tal legge acquisterà permanenza e potere, come ora ha potere
sugli accoppiamenti fra genitori e figli, se vincerà, come è giusto, anche su ogni altro
rapporto illecito, essa ha con sé infinito numero di beni. E infatti è stabilita in modo
conforme alla natura, prima di tutto, e poi essa dal furore e dalla follia erotica e da tutti gli
adulterii tien lontano gli uomini e da tutti gli eccessi nel mangiare e nel bere e lega i mariti
alle loro mogli e molti altri vantaggi potrebbero derivarne, se qualcuno potesse diventare
signore di questa legge. Può darsi però che si ponga davanti a noi un uomo giovane e
ardente, gonfio di molto seme, e sentendo la legge che da noi vien posta ci insulterà come se
noi ponessimo regole sciocche ed impossibili e riempirà tutto delle sue grida; ed è
guardando proprio a queste cose che io dissi quella frase, che [c] cioè ho un’arte, per un
verso la più facile di tutte, per un altro la più difficile, un’arte in relazione alla stabilità di
52
questa legge una volta enunciata. E’ infatti facilissimo capire che è cosa possibile e come lo
è - diciamo infatti che una volta adeguatamente consacrata questa regola, ogni anima
renderà sua suddita e la farà temere o obbedire senza eccezione alle leggi stabilite, ma ora
siamo giunti a un punto tale che non ci pare che ciò potrebbe avvenire nemmeno in tal caso,
tanto quanto non si crede possibile che tutto uno stato possa vivere tutta la sua esistenza
praticando l’usanza dei "pasti in comune", e mentre ciò i fatti provano e da voi accade
tuttavia neppure nei vostri stati sembra che sia secondo la natura che ciò si realizzi anche per
il genere femminile. E’ questa un’altra ragione, la forza della incredulità, per cui ho detto
che ambedue queste pratiche incontrano serie difficoltà ad essere stabilmente fissate con
leggi” Leggi VIII, 838 d – 839 d ). L’accoppiamento eterosessuale fra adulti è ciò che
differenzia gli esseri umani dagli animali; infatti l’Ateniese afferma: “ Poiché dunque siamo
giunti a questo punto trattando di questa legge, e siamo caduti per la corruzione dei molti, in
una difficoltà, io affermo che la nostra legge deve assolutamente procedere e dire, su questo
stesso argomento, che non bisogna che i nostri cittadini divengano inferiori agli uccelli ed a
molti altri animali i quali riuniti, al momento della nascita, in grandi greggi fino all’età della
procreazione, non ancora accoppiati, si conservano puri e casti da nozze illecite, e poi,
raggiunta quella età, il maschio si accoppia, per simpatia, alla femmina, la femmina al
maschio e vivono santamente e rettamente il tempo rimanente mantenendosi fedeli ai primi
patti d’amore. I nostri cittadini debbono essere dunque migliori degli animali” (Leggi VIII,
840 d – e). Infine, se proprio alle tentazioni di Eros non si può resistere, dopo avere orientato
le energie corporee verso altro, allora che almeno ci si accoppi di nascosto: “ E se i nostri
cittadini si lasciano corrompere dagli altri Greci e dalla maggior parte dei barbari vedendo e
sentendo dire che quell’Afrodite che viene chiamata ‘Colei che è senza legge’, presso di
quelli ha grandissima potenza e così divengono incapaci di dominarla, bisogna che i custodi
delle leggi in funzione di legislatori escogitino per loro [841a] una seconda legge. CLIN.
Quale legge consigli loro di stabilire, se quella stabilita ora sfugge loro dì mano? ATEN.
Evidentemente la legge che segue la prima da vicino ed è seconda dopo di quella. CLIN.
Quale legge dici? ATEN. E’ possibile, l’abbiamo visto, rendere quanto più si può priva
d’esercizio la forza dei piaceri, orientando verso un’altra parte del corpo per mezzo di
esercizi faticosi l’afflusso e il nutrimento del piacere stesso. Si potrebbe raggiungere questo
scopo se non ci fosse una generale impudicizia nell’uso dei rapporti sessuali. Infatti, se per
[b] la vergogna, quelli usassero dei rapporti sessuali più di rado, con poca frequenza,
avrebbero per sé in Afrodite una padrona più debole. Sia presso di loro ritenuta cosa bella il
nascondersi nel fare questi atti, e questa norma sia praticata come norma di costume e per
una legge non scritta, e sia turpe il non nascondersi, ma non in modo da non agire in questo
senso assolutamente. Così ciò di cui si è parlato e che è venuto ad essere bello e turpe nella
nostra legge in base a un criterio di secondo grado potrà essere in tal modo stabilito, ed avrà
appunto una correttezza di secondo grado, e coloro che sono corrotti nella [c] loro natura,
quelli che noi chiamiamo ‘inferiori a se stessi’ e formano un unico genere, li
comprenderanno tra altri generi e li costringeranno a non violare la legge. CLIN. Quali
sono? ATEN. Il rispetto degli dei, l’amor dell’onore e l’aver desiderio non dei corpi ma
53
delle anime belle nella loro indole. Queste cose dette ora come in una favola non sono che
cose che ci auguriamo, ma se mai si realizzassero, sarebbero ciò che vi ha di migliore in tutti
gli stati. E forse, se dio vorrà, noi potremmo imporre, [d] sull’amore, almeno una di queste
due condizioni: o che nessuno osi toccare nessun altro cittadino legittimo, nessun’altra
persona libera se non la propria moglie e che nessuno semini semi illegittimi e bastardi nelle
concubine e semi infecondi negli uomini, contro natura, oppure, d’altra parte, bandita
completamente l’omosessualità fra maschi, nei riguardi delle donne ci si comporti in modo
che se qualcuno si unirà con un’altra oltre a quelle entrate in casa sua con l’auspicio degli
dèi e nozze regolari e sacre, [e] le abbia comprate o se le sia procurate in qualsiasi altro
modo, e tutti gli altri, uomini e donne, se ne accorgano, noi risulteremo dare una giusta legge
probabilmente stabilendo per legge che sia privato di ogni onorificenza civile come se fosse
realmente uno straniero. Questa (sia che bisogni dire che è una legge sola sia che sono due)
valga come legge a disciplinare tutta la materia relativa ai piaceri sessuali e tutti gli amori,
quanti sono i modi con cui [842a] gli uomini si congiungono insieme mossi da siffatti
desideri e per cui agiscono qualche volta in modo onesto, qualche altra disonesto. MEG. E
allora molto volentieri io accetterei questa tua legge, ospite, e Clinia dica lui stesso che cosa
ne pensa. CLIN. Parlerò quando riterrò che ne sia giunto il tempo opportuno, Megillo, ora
lasciamo che l’ospite proceda ancora nella sua esposizione delle leggi. MEG. E’ giusto”
(Leggi VIII 840 e – 842 a).
54
HEGEL NELLA CULTURA FRANCESE DEL NOVECENTO
Piergiorgio Scilironi
A partire dagli studi del Dilthey (1905) e del Nohl (1907) le interpretazioni
della filosofia di Hegel sono state oggetto di una rinnovata considerazione, che hanno
permesso di ridimensionare molti luoghi comuni sedimentatesi lungo la seconda metà
dell’Ottocento .Da questo momento si sono aperte prospettive che mirano a
considerare la Fenomenologia in maniera più autonoma rispetto al sistema,
prospettive che hanno trovato la maggior espressione speculativa in ambito francese
con la cosiddetta Hegel-renaissance degli anni trenta e quaranta (Wahl, Kojève,
Hyppolite, Koyrè),ma che ha datoi suoi frutti anche da noi (Della Volpe, De Negri).
Dopo la seconda guerra mondiale, in Francia, ci si trova davanti ad una prospettiva
filosofica che, per quanto varia, ha come punto di fuga un pensiero «essenzialmente
umanista» (1).
Sia se si guardi a realtà esistenzialistiche cristiane o atee, o che si guardi a
realtà personalistiche interamente cristiane, il tappeto sonoro su cui i filosofi cantano
le loro dottrine ha come tonalità di impianto la nozione di «realtà-umana», che sta a
significare la volontà di rifondare in senso profondo l’uomo, ossia di sostituire a tale
nozione singola - vertice e sintesi di un concetto unitario e sostanzialistico
proveniente dalle “ radici” della metafisica - una nozione onnicomprensiva, ma
neutralizzata di umanità. Sicuramente questa fu anche una reazione a ciò che per
lungo tempo imperò nelle università francesi, fino alla fine degli anni ’20, cioè a
filosofie come lo Spiritualismo, il bergsonismo (nei nomi di Alain Brunschvicg,
Bergson e i loro epigoni).Tuttavia questa reazione che portava o presumeva essere
una neutralizzazione-rifondazione dell’anthropos nella sua unità non-metafisica, nonspeculativa, era in un certo qual modo come la «fedele» eredità della fenomenologia
trascendentale di Husserl e dell’ontologia fondamentale di Sein und Zeit di
Heidegger, opera conosciuta (tra l’altro in parte) in Francia insieme a Was ist
Metaphysik? e Kant und das Problem der Metaphysik.
E, fatto molto importante, la riscoperta “tutta francese” di alcuni testi di Hegel,
che dopo il 1930 pervade definitivamente ogni dibattito filosofico in vari modi e
sfumature (2). Importante è ora riprendere le fila del discorso e riallacciarmi a quanto
ho detto all’inizio. Cosa significa avere come sfondo di un progetto la nozione di
«realtà-umana»? Perché quella singola nozione è sintomatica di tante altre
suggestioni che vanno rilevate? Innanzitutto occorre dire che «realtà-umana» è la
traduzione francese del termine tedesco heideggeriano Dasein, traduzione che
Derrida definisce «mostruosa, ma tanto più significativa» dal momento che «sia stata
allora adottata, che abbia regnato grazie all’autorità di Sartre» e «che dà molto a
55
pensare sulla lettura o non-lettura di Heidegger in quest’epoca, e sull’interesse che
c’era allora a leggerlo o a non leggerlo in tal modo».
Questa traduzione, secondo Derrida, è stata proposta da H. Corbin per la prima
volta, e, se così fosse, non resta che pensare che fu successivamente divulgata ad un
pubblico assai particolare da A.Kojève nelle sue lezioni hegeliane sulla
Fenomenologia dello Spirito, che dal 1933 fino al 1939 egli tenne presso l’École
Pratique des Hautes Études di Parigi. Oppure c’è un’altra possibilità, cioè che Corbin
abbia in realtà tradotto inizialmente Dasein con “esistenza” e solo dal 1938 abbia
optato per una traduzione diversa (quella appunto di «realtà-umana» mutuata
successivamente da Sartre), dopo che ebbe partecipato alle lezioni di Kojève, iniziate
nel 1933, in cui già compare tale interpretazione-traduzione sulla scorta del testo
hegeliano: «Ora, l’analisi del “pensiero”, della “ragione”, dell’ “intelletto”,ecc. –in
generale del comportamento cognitivo, contemplativo, passivo di un essere o di un
“soggetto conoscente”- non scopre mai il perché o il come della nascita della parola
“Io”, e, quindi, dell’autocoscienza, cioè della realtà umana.” (3).
Se così fosse, alla radice di tutto ci sarebbero le lezioni kojèviane a cui
parteciparono una lista cospicua di personaggi (4). Questa seconda ipotesi si può
ricavare da una nota di Denis Hollier contenuta nella sua famosa raccolta sul
«Collegio di sociologia» (5), la rivista di Georges Bataille, Michel Leiris, Roger
Callois, cui parteciparono tra gli altri anche Kojève, Klossowski, Walter Benjamin,
Hans Mayer. Al di là di queste considerazioni e tornando all’analisi derridiana di
questo momento particolare francese, con i suoi intenti e con le sue reali riuscite, si
dice che la pretesa «neutralizzazione dei presupposti metafisici», «che costituivano da
sempre il concetto dell’unità dell’uomo» non va a compimento, e che «peraltro […]
l’unità dell’uomo non viene interrogata in se stessa». Anche se «il tema della storia è
molto presente nel dibattito di quest’epoca, la storia dei concetti viene poco praticata;
per esempio, non viene mai interrogata la storia del concetto di uomo. Tutto si svolge
come se il segno “uomo” non avesse alcuna origine, alcun limite storico, culturale,
linguistico. E nemmeno alcun limite metafisico». Continua Derrida «non soltanto
l’esistenzialismo è un umanismo, ma il terreno e l’orizzonte di quello che Sartre
chiama a quel tempo la sua “ontologia fenomenologica” (è il sottotitolo dell’Essere e
il nulla) rimane l’unità della realtà umana. Tale ontologia fenomenologica non è altro
che una descrizione delle strutture di questa unità, e per tanto è un’antropologia
formata da un amalgama filosofico hegeliano-husserliano -heideggeriano, che
ciononostante non rompe con le antropologie classiche di stampo schiettamente
metafisico. Dice Derrida che aldilà delle «rotture marcate da questa antropologia […]
non viene interrotta una familiarità metafisica con ciò che, con tanta naturalezza,
mette in rapporto il noi del filosofo con “noi-uomini”, col noi nell’orizzonte
dell’umanità».
56
Questa onnicomprensività pervasiva «del segno “uomo”» butta giù la maschera
e (dalle pretese neutralizzazioni e indeterminatezze che dovevano sospendere i
sempiterni presupposti concettuali dell’unità dell’uomo) rivela «nient’altro che
l’unità metafisica dell’uomo e di Dio, il rapporto dell’uomo a Dio, il progetto di farsi
Dio come progetto costitutivo della realtà-umana». Ciò si può confrontare in quei
«motivi metafisici» (6) sartriani al termine dell’Essere e il nulla riguardo alla totalità
dell’in-sé e del per-sé. La ricerca di una conciliazione («una unità metafisica
dell’essere» o «totalità dell’ente») fra coscienza e mondo, che non è avvenuta e, in
realtà, non poteva avvenire. La trascendenza dei due poli metafisici è assoluta nella
loro diversità ontologica: «l’in-sé è essere, il per-sé è nulla […], nel duplice senso di
annullamento della fatticità esistente e di pro-gettamento di un essere che non-è
ancora» (7). Ma questa aspirata totalità dell’in-sé e del per-sé è l’unità della realtà
umana nel suo progetto: «l’essere in-sé e l’essere per-sé erano dell’essere; e questa
totalità dell’ente, in ci essi trovavano composizione, si legava a se stessa, si
rapportava e appariva a se stessa attraverso il progetto essenziale della realtà umana».
«Ogni realtà umana è una passione, in quanto progetta di perdersi per fondare
l’essere e per costituire contemporaneamente l’in-sé che sfugge alla contingenza
essendo il proprio fondamento, l’Ens causa sui, che le religioni chiamano Dio. Così
la passione dell’uomo è l’inverso di quella di Cristo, perché l’uomo si perde in quanto
uomo perché Dio nasca. Ma l’idea di Dio è contraddittoria e ci perdiamo inutilmente;
l’uomo è una passione inutile.» (8)
Pertanto, Sartre conclude che «il per-sé e l’in-sé sono uniti da un legame
sintetico che non è altro che il per-sé stesso» (9), questa unità sintetica è determinata
come mancanza, «…il per-sé si determina nel suo essere come mancanza.» (10). La
realtà-umana, come coscienza per-sé è l’unità della totalità dell’ente: quindi essendo
il per-sé determinato nel suo essere come mancanza, l’unità della totalità dell’ente è
mancanza, la realtà-umana è mancanza. Una mancanza che è coscienza infelice, che è
mancanza di totalità dell’ente, mancanza di Dio, mancanza di essere Dio. «…l’ens
causa sui resta, […] (come il) mancato» (11).
Questa mancanza, intesa quindi come non-identità permanente a sé del
soggetto, come coscienza non identica a sé, è sempre spinta dal desiderio e dall’Altro
(che è anche in una lettura antropologica per eccellenza, desiderio) verso una
dialettica che da allora diverrà banco di prova per molti intellettuali e filosofi
francesi. L’Altro verso cui il soggetto (come coscienza) tende, può essere totalmente
Altro (e quindi aldilà di ogni inutile sforzo) oppure Altro come Assoluto (quindi
raggiungibile in un tempo differito) o ancora un Altro desiderio (quindi un’altra
coscienza che io però desidero nel gioco di riconoscimenti riconosciuti); tutto ciò non
cambia nulla in questa struttura fondamentale, poiché secondo la tesi heideggeriana,
di cui Sartre è verifica, «ogni umanismo rimane metafisico» (12) essendo l’umanismo
un nome per dire onto-teologia.
57
Tutto ciò è servito solamente a chiarire l’appartenenza dei vari atteggiamenti
esistenzialistici (atei o cristiani), delle varie filosofie (spiritualistiche o
personalistiche, sia di destra che di sinistra) o del marxismo classico, ad uno stesso
territorio: quello dell’umanismo o antropologismo. Tale radice comune, che trasferita
alla politica, raccoglie insieme marxismo, discorso social-democratico e democraticocristiano, nasce o viene “tirata su” dalle letture antropologiche di Hegel: quella che
appunto fa Kojève nelle sue lezioni sulla Fenomenologia dello spirito; tali lezioni
avvengono in un clima culturale che vede contemporaneamente la scoperta e lettura,
sempre in tal senso, degli inediti giovanili di Marx: i Manoscritti del 1844, accessibili
solo dal 1932, tradotti parzialmente nel1933 e successivamente pubblicati nel 19351937 (13).
Ciò coincide con la prima traduzione francese di Kierkegaard nel 1929 (Le
journal du séducteur) che aprirà la così detta “Kierkegaard-Renaissance” francese.
Ma non basta, in questo periodo appare anche la fenomenologia husserliana(Husserl
legge nel 1928 le Cartesianische Meditationen alla Sorbonne, tradotte nel 1931)
grazie alle pubblicazioni di E. Lévinas La théorie de l’intuition dans la
phénoménologie de Husserl (1930) e di Gurvitch, Les tendances actuelles de la
philosophie allemande (1930); anche se in ordine cronologico il primo a parlare di
Husserl in Francia fu V. Delbos con il suo Husserl, sa critique du psychologisme et
sa conception d’une logique pure, un articolo di un volume collettaneo sulla filosofia
tedesca (1912) (14).
Infine, come ho già detto, c’è, in quest’epoca, la conoscenza dello Heidegger di
Sein und Zeit o per lo meno della sua analitica esistenziale, che viene letta e
interpretata su motivi antropologisti.
Ciò, come è noto, porterà lo stesso filosofo tedesco ad intervenire per porre freno a
questo atteggiamento peculiare dell’esistenzialismo francese verso la sua filosofia,
quando nel 1947 pubblica la Lettera sull’umanismo che è una risposta ad una
«inchiesta» del francese Jean Baufret su tale concetto.
Infatti sarà una presa di posizione polemica verso l’esistenzialismo francese;
quello più popolare esploso dopo la seconda guerra mondiale grazie soprattutto a
Sartre, ma anche verso le sue radici ed elaborazioni precedenti condotte negli anni
Trenta.
Per quanto riguarda la ricezione del pensiero hegeliano in terra francese, ci si
trova di fronte ad uno spartiacque o a una vera e propria Hegellosigkeit, che separa
gli hegeliani ottocenteschi come V. Cousin, H. Taine e A. Vera (vero e proprio
diffusore dell’hegelismo in Francia), dal primo ventennio del Novecento: periodo in
cui si comincia a registrare un notevole incremento verso il pensiero del filosofo
tedesco, testimoniato da una rinascita non solo di «studi hegeliani», ma anche da
posizioni critiche ed atteggiamenti teoretici che dimostrano una presenza attiva del
filosofo (15).
58
A partire dalle prime discussioni che videro Hegel al centro dell’attenzione,
come quelle tra Berthelot, Delbos e Boutroux nel 1907 alla Sociéte française de
philosophie (lo stesso anno della pubblicazione del saggio di Croce su Hegel –
tradotto da H. Buriot nel 1910- e della pubblicazione delle hegeliane Theologische
Jugendschriften –la celebre raccolta di testi giovanili curata da H. Nohl), il vero e
proprio acclimatamento sul suolo francese si ebbe negli anni Trenta. Fiorirà allora la
stagione della Hegel-Renaissance, e da allora Hegel non uscirà più da questa nazione.
Ed è proprio da questo tardivo recupero del pensiero hegeliano che discendono
le tipiche peculiarità dell’hegelismo francese: innanzitutto non si è mai formata una
vera e propria “scuola” hegeliana, con il conseguente risultato che qui esso non ha
assolto quel ruolo organico che si è verificato altrove, e, in secondo luogo, un certo
Hegel fu considerato insuperabile proprio perché in Francia non si verificò, per
quanto riguarda la filosofia, lo storiografico susseguirsi prospettico di esiti storicoteorici, con il risultato che, il filosofo tedesco, venne letto e interpretato insieme a gli
esiti primo-novecenteschi della filosofia (e con gli strumenti concettuali propri di
ognuno di essi).
Una riflessione puramente storico-storiografica sulla totalità dell’opera
hegeliana non ci fu mai. Hyppolite afferma infatti che «la scoperta di Hegel a partire
dal 1930 (data considerata, all’unanimità, come inizio del renouveau hegeliano (16))
fu contemporanea alla scoperta dei suoi avversari, l’esistenzialismo e il marxismo»
(17); e ciò fa dello Hegel francese un qualcosa di a sé stante.
Nel 1930 in Francia si scopriva nello stesso momento l’Hegel giovane (in
particolare la Fenomenologia), gli inediti giovanili di Marx, Kierkegaard, Husserl ed
Heidegger. Bisogna comunque dire che, all’indomani della guerra, i primi ad
appassionarsi a letture insolite per il clima cultural-accademico francese, furono i
surrealisti, che nonostante non fossero filosofi di professione, si avvicinarono con un
intuito “avanguardistico” ad Hegel, Feuerbach, Marx e Freud. Essi divulgarono il
nome di Hegel a tutta una nuova generazione di filosofi, che si oppose per reazione al
clima accademico parigino, orientato verso un ritorno al pensiero scientifico kantiano
e cartesiano e prevenuto (politicamente) nei confronti dei “classici” tedeschi per un
loro condizionamento indiretto alle cause della guerra. Scrive André Breton: «da
quando ho conosciuto Hegel, o meglio l’ho presagito attraverso i sarcasmi […] del
mio professore di filosofia, il positivista André Cresson, mi sono sentito imbevuto
delle sue idee e per me il suo metodo ha eclissato tutti gli altri. Laddove la dialettica
hegeliana non funziona, per me non c’è né pensiero né speranza di verità» (18),
Breton sta parlando degli anni intorno al 1912, ma anche successivamente la
situazione non è molto diversa.
Scrive, infatti, Sartre: «quando avevo vent’anni, nel 1925, non esisteva una
cattedra di marxismo all’Università e gli studenti comunisti si guardavano bene dal
ricorrere al marxismo o anche solo di nominarlo nelle loro esercitazioni; sarebbero
59
stati bocciati a tutti gli esami. L’orrore della dialettica era tale che persino Hegel era
sconosciuto» (19). Comunque, la testimonianza più interessante può essere quella di
H. Lefebvre, che dopo aver detto di aver letto Hegel, per poi approdare a Marx, sotto
l’invito di Breton, scrive che, ancora nel 1930, Léon Brunschvicg gli rifiutava
indignato la tesi su Hegel che era andato a proporgli (20).
Non è, pertanto, un caso che il clima culturale dell’epoca, condizionato da un
certo spirito revanscista e da un equivoco nazionalismo, abbia affidato la riscoperta
hegeliana a pensatori stranieri, emigrati in Francia tra gli anni ’20 e ’30. Basti pensare
al polacco Meyerson, ai tedeschi Groethuysen e Basch, e ai russi Koyré e Kojève.
Riprendendo il filo cronologico del discorso, voglio terminare la parentesi surrealista
dell’ “invito alla lettura di Hegel” dicendo che le parole in favore di questo filosofo
non furono solo approssimative, e a dimostrazione di questo mi pare sufficiente
l’esperienza, che da lì ha preso in parte le mosse, di Queneau e Bataille (21).
Ma bisogna aspettare il 1928 ed il 1929 prima di trovare due filosofi “di
professione” che inizino ad occuparsi di Hegel: Jean Wahl e Dimitriu Rosca.
Il primo, dopo intensi studi su Cartesio, sul Pragmatismo e su Platone, scrive il più
importante studio su Hegel mai apparso prima in territorio francese, è il 1929 ed il
libro, che raccoglie un insieme di studi, si intitola: Le malheurde la conscience dans
la philosophie de Hegel (22).
Il secondo pubblica nel 1928 una traduzione del Leben Jesu, corredandola di una
significativa introduzione critica. La loro attività, comunque, risulta ben circoscritta e
omogenea in un momento particolare, quello cioè del più intenso influsso diltheyano,
sia per quanto riguarda le suggestioni sia le acquisizioni interpretative, che aveva
avviato quest’ultimo riguardo a Hegel. Dilthey infatti «vedeva, non a torto,
l’opportunità di una rivalutazione della categoria hegeliana dello “spirito oggettivo”,
che diveniva di fatto la strada per una riscoperta di Hegel, e soprattutto del primo
Hegel. E’ in questa prospettiva che nasce uno dei capolavori della storiografia
filosofica di Dilthey, quella Storia della giovinezza di Hegel (23), che, insieme
all’impulso dato allo studio dei manoscritti giovanili inediti [è lo stesso Dilthey a
spingere l’allievo H. Nohl a farsi editore dei manoscritti giovanili inediti di Hegel,
ritrovati in quegli anni a Berlino, e sulla base dei quali venne scritta l’opera
diltheyana…], può essere considerata a buon diritto all’origine della HegelRenaissance del nostro secolo» (24).
Se per Dilthey il “giovane Hegel”può essere considerato una tappa in una organica
linea di sviluppo del proprio percorso filosofico,che vedeva Hegel inserito nella
dinamicità del romanticismo tedesco, ed era così inquadrato in una continuità che
andava dall’idealismo “classico” alla filosofia della vita; non è così per Wahl, che
investe Hegel di risonanze concrete ed esistenziali, e non guarda al “giovane” Hegel
in senso organico, ma circoscrive le sue analisi a singoli testi e a singole “figure”, che
ritiene esemplari per tutta la condition humaine, al di là di ogni periodizzazione
60
storica. L’esistenzialismo francese attingerà a piene mani da questa visione. Rosca,
nella sua introduzione alla Vie de Jésus (25), è molto chiaro rispetto al senso che egli
attribuisce all’esegesi diltheyana e alla novità di essa. Per lui la riscoperta del
“giovane Hegel” coincide con la scoperta di un Hegel esoterico, ma anche più umano
rispetto alla glaciale personificazione di Hegel con il tardo sistema berlinese.
Comunque sia, per Rosca, come per Wahl,non si deve separare di netto la
produzione hegeliana o la vita hegeliana, ma bisogna parlare di “reale continuità” e
non di “salto” fra il periodo “mistico” di Francoforte e il periodo “sistematico” di
Jena. Infatti, lo stesso Rosca non si sottrae ad una personale ridefinizione del
misticismo e del teologismo hegeliani, e insiste sul fatto che Hegel, anche nei primi
scritti a carattere teologico, non è mai teologo nel modo di affrontare le peculiari
problematiche.
Tale atteggiamento, rivela Rosca, del giovane teologo-filosofo, si potrà
riscontrare anche più tardi nel sistema dell’idealismo assoluto, ma in modo tale da
dissimulare la loro origine religiosa. Pur non contestando la validità della tesi
diltheyana del misticismo, Rosca ritiene che quello di Hegel sia un misticismo
dinamico, e non un misticismo dell’inerzia teso a perdersi nel Tutto. C’è in questo
approssimarsi a Hegel, la volontà di ricostruire e giustificare l’unità di sviluppo
spirituale che presiede alla scansione biografico speculativa dell’Hegel “romantico e
mistico”.
Wahl e Rosca hanno un atteggiamento verso il filosofo tedesco, che consente
quasi in tutto tranne nel fatto che il secondo si distacca assai poco dalla lettera
dell’esegesi diltheyana, mentre Wahl distaccandosi da essa ravvisa già nell’Hegel
della Vita di Gesù elementi fichtiani, romantici e prefeuerbachiani (26).
Anche se questa fase degli studi hegeliani in Francia, che può anche essere
definita “post-diltheyana”, e che ha come rappresentante simbolo l’opera di Wahl,
rimane confinata un po’ in se stessa, senza una grossa risonanza accademica, è
comunque una tappa importante, direi quasi uno snodo fondamentale tra l’immediato
precedente e ciò che avverrà.
Infatti nel 1930, e poi definitivamente nel 1931, ci sarà un forte impulso agli
studi hegeliani e, conseguentemente una forte reazione contro la filosofia
spiritualistica e neocriticista. Sarà il periodo in cui il panorama filosofico francese
sarà dominato dalle “tre H.”: Hegel, Husserl ed Heidegger. Iniziamo a notare lo
sviluppo significativo che subisce la situazione a causa di uno strano intreccio di
recensioni che nel 1930 avviene sulla «Revue philosophique»: Wahl recensisce la
monografia di A. Koyré dedicata a J. Böhme (mistico tedesco già caro a Wahl) uscita
l’anno precedente (27); Koyré recensisce (di risposta) il libro di Wahl uscito
anch’esso, come sappiamo, nel 1929 (28).
A Hegel, lo studioso russo, era arrivato dopo anni di studio sulla filosofia della
religione, toccando autori come Cusano, Anselmo, fino ad arrivare a Cartesio e
61
Böhme, che fu argomento della tesi per il doctorat ès lettres discussa nel 1927. Wahl,
nella sua recensione, mettendo in evidenza il rapporto tra Hegel e Böhme, porta
conferma alle tesi esposte nel suo libro del 1929 sullo Hegel “romantico e mistico”
alla luce delle acquisizioni koyréiane. Afferma che Koyré espone il fondamento del
pensiero di Böhme e tali concezioni gli appaiono assai prossime a quelle sviluppate
più tardi da Hegel; vede nell’idea böhmiana della rivelazione la prossimità di quella
hegeliana dell’identità tra interno ed esterno, oppure interpreta la costante
contrapposizione luce/tenebre, come affermazione della necessità della sintesi. Wahl
in questa entusiastica recensione, continua le correlazioni tra i due autori e, nelle idee
böhmiane di mondo come divenire e lotta, ma al contempo eternità, oppure nell’idea
che la realtà più profonda non è assenza di determinazione, ma ricchezza di
determinazioni, vita contrastata e armoniosa, legge l’anticipazione di idee che si
ritroveranno nella filosofia hegeliana.
A.Koyré, allora trentottenne e appena nominato directeur d’études della V
sezione dell’École pratique, nel 1930 compie il suo esordio “hegeliano” sia con una
importante relazione sulla condizione degli studi hegeliani in Francia (29) tenuta
all’Aia durante il I Congresso hegeliano nell’Aprile del 1930, sia con la suddetta
recensione al libro di Wahl su Hegel.
In quest’ultima, l’autore smorza subito i toni entusiastici usati da Wahl e
avanza delle riserve e perplessità verso l’interpretazione hegeliana tracciata nel
Malheur, affermando che è ben vero che il pensiero hegeliano ricalchi il ritmo del
pensiero mistico, che in esso si possa ritrovare l'esperienza di Lutero e di Böhme, ma
che Hegel non si può appiattire su questo senza che gli sia riconosciuta la sua vera
identità: la meditazione hegeliana era fin dall’inizio orientata verso il sistema, tale
idea era presente già nel 1800 e misconoscerlo significa togliere profondità e slancio
al suo pensiero.
Già in ciò Koyré prende le distanze nettamente da Wahl, ma proseguendo, i
suoi toni si fanno sempre meno mediati e viene totalmente allo scoperto circa la
distanza che lo separa dalla visione wahliana di Hegel. Afferma testualmente: «Devo
confessare che, malgrado il libro di Wahl, non credo molto alla disperazione vissuta
di Hegel; e il suo […] è un tragico pensato, non un tragico vissuto. Certo,Hegel sa di
aver bisogno di lotta, di opposizioni e di sofferenze per nutrire il movimento dello
spirito; ma il tragico, che è reale per l'uomo, non lo è affatto per Dio.
Per Dio -come per Hegel- la tragedia è già superata» (30). E chiudendo la
recensione dice: «Un Hegel più umano; ma occorre ad ogni costo umanizzare Hegel?
La sua grandezza risiede proprio nella sua inumana freddezza.
Non nel fatto di aver chiamato “amore” quel che in seguito avrebbe chiamato
“nozione”, ma, al contrario, nell’aver finito col chiamare “nozione” quel che aveva
cominciato col chiamare “amore”» (31).
62
Da questo momento, essi daranno vita a due versanti opposti interpretativi, pur
rimanendo globalmente nella temperie culturale “concreta” e “antropologica” tipica
dell’entre-deux-guerres.
Si può dire oramai iniziato l’hegelismo francese, e mentre Wahl inizia a
spostare nettamente il suo Hegel dal lato di Kierkegaard (32), Koyré, da parte sua,
leggerà lo Hegel di Jena alla luce della fenomenologia e dell’esistenzialismo tedeschi,
rispettivamente cioè di Husserl ed Heidegger. Questi contrapposti atteggiamenti
interpretativi saranno fondamentali per tutta la filosofia francese degli anni ’30 e ’40,
da Koyré e, per così dire, dal suo Hegel ateo-esistenzialistico, discenderà la lettura
“di sinistra” di Kojève e su quest’ultima si formerà l’esistenzialismo ateo di Sartre.
Dallo Hegel religioso e mistico di Wahl deriverà, invece, sia un certo
esistenzialismo romantico-trascendentale alla Gabriel Marcel, sia l’ermeneutica
hegeliana “di destra” di padre Niel e dell’intero côté cristiano. Personaggio assai
importante per gli studi hegeliani, e che trae giovamento da ambe due le letture, sarà
Jean Hyppolite.
Dal 1930 al 1933 Alexandre Koyré è, come già sappiamo, directeur d’études
presso la V sezione dell’École Pratique, e in uno dei suoi corsi tratta la Logik e la
Realphilosophie dello Hegel jenese; frutto di ciò sarà il noto saggio del 1934 Hegel a
Jena (33), in cui si annuncia, pur prudentemente, la lettura in chiave heideggeriana
che tanto influenzerà la Renaissance francese.
Punto di snodo sono due paragrafi dell’Enciclopedia (34) hegeliana, il 258 e il
259, in cui si analizza e si definisce il tempo (35), e dove Koyré non manca di
chiamare in questione lo Heidegger di Sein und Zeit (pubblicato sette anni prima) nel
tentativo di far reagire la categoria hegeliana dell’esser-fuori-di-sé, con la concezione
heideggeriana del tempo, in modo tale da ridurre l’Aufhebung al movimento fluido
delle estasi. Ma le formule che Hegel usa nell’ambito della Filosofia della natura,
vengono usate o ricondotte, da Koyré, alla specifica struttura della autocoscienza
umana, secondo un’operazione di mediazione tipica dell’esistenzialismo (36).
Tutto ciò è molto importante perché sarà ripreso, consapevolmente, alla lettera
da A. Kojève, così che, quanto in Hegel designa il tempo naturale, diverrà la cifra
distintiva della sfera antropologica rispetto all’essere statico-naturale (e basterebbe
questo per immaginare tutta l’ontologia dualista kojèviana ripresa poi da Sartre) (37).
Koyré con una esegesi che spazia dagli scritti jenesi fino all’Enciclopedia,
traduce il concetto di tempo hegeliano nel fondamento ontologico della dialetticità
dell’essere. Ne risulterà una identificazione di uomo e tempo che comporterà la
conversione dello spirito al processo di autotemporalizzazione e di auto-differimento
della storia: «La dialettica del tempo è la dialettica dell’uomo. Solo perché l’uomo è
essenzialmente dialettico, ossia negatore, è possibile la dialettica della storia, anzi la
storia stessa» (38). Al di là delle difficoltà, che si vengono a creare proseguendo le
analisi koyréane, a noi interessa ora raggiungere un risultato ben preciso, cioè vedere
63
come Kojève usi tale esegesi, e cosa riprenderà l’esistenzialismo francese da
quest’ultimo. C’è un punto delle lezioni di Kojève su Hegel (di cui si parlerà più
avanti) in cui, facendo esplicito riferimento a Koyré, si dice: «Il testo in questione
[Hegel a Jena] mostra chiaramente che il Tempo, a cui Hegel pensa, è quello che, per
noi, è il Tempo storico (e non il tempo biologico o cosmico).
Difatti, questo tempo è caratterizzato dal primato dell’Avvenire. Nel Tempo
che la Filosofia pre-hegeliana prendeva in considerazione il movimento andava dal
Passato verso l’Avvenire, passando per il Presente. Nel Tempo di cui parla Hegel,
invece, il movimento prende origine nell’Avvenire e va verso il Presente passando
per il Passato: Avvenire_Passato_Presente(Avvenire). Ed è appunto questa la
struttura specifica del Tempo propriamente umano, cioè storico» (39).
Già in Koyré, pertanto, sono inscritti i presupposti teorici per teorizzare due
distinte temporalità, destinate a divergere nella radicalizzazione di Kojève fino a
porre un cuneo nell’ontologia di Hegel, che sottoposta alla trazione dei due interpreti
russi, si spacca, aprendo una feritoia da cui uscirà l’esistenzialismo francese.
Nella sua interpretazione Koyré, infatti, si è trovato di fronte ad una grossa
difficoltà: l’infinitezza dello spirito, che non si lascia facilmente ridurre a tempo,
senza che non si scada in una “cattiva infinità”.
Per Koyré l’in-finito trae la sua determinazione nella relazione dialettica con il
finito; in una tale opposizione, che sembra forse più fichtiana che propriamente
hegeliana, l’infinito deve negare il finito e interiorizzarlo, e quindi finitizzarsi esso
stesso nel movimento che trae incessantemente il secondo verso il primo, in un
continuo scambio delle parti. L’unità dei due momenti, che sono pensati in un
rapporto logico, ma mai in una prospettiva di quieta unità, richiama la dialettica
dell’eternità e del tempo, che poi diventa dell’istante e del tempo. Essa fornisce il
modello per comprendere come il movimento dell’eternità accada all’interno del
dominio fenomenico. Ed è proprio qui che l’analisi di Koyré assume il più alto
spessore di originalità teoretica (40).
Procedendo, oramai è chiaro che tale taglio ermeneutico porta a concepire due
distinte temporalità: il tempo astratto della fisica, quello newtoniano e kantiano, delle
formule e degli orologi, e quello che l’autore stesso definisce il «tempo “stesso”,
della realtà spirituale del tempo», che «non scorre uniformemente, non è un mezzo
omogeneo attraverso il quale passiamo, non è né numero del movimento, né ordine
dei fenomeni. E’ arricchimento, vita, vittoria. E’ esso stesso […] spirito e concetto».
Questa distinzione lo porterà a elaborare una duplice chiave per l’esegesi del
tempo storico: userà l’epistemologia della storia di Marx, per corrispondere
all’escatologia innescata dal futuro, ma, poiché tale modello confuta la circolarità del
sistema, Kojève, lo sincronizzerà, lo congiungerà con l’esistenzialismo di Heidegger;
quest’ultimo infatti, deponendo nel futuro la necessità empirico/trascendentale della
morte, consente la pensabilità della chiusura dell’umano-storico.
64
In conclusione, l’umanizzazione della negatività, l’antropologizzazione dello
spirito (divenuto storia) (41), e la separazione dell’esistenza dialettica rispetto al
regno ontico della vita, sono i temi fondamentali e comuni tanto a Kojève che
all’esistenzialismo francese in generale, e, come si è visto, trovano le loro radici in
queste letture “hegeliane”.
In ultima analisi, gli strumenti concettuali che Kojève usa, e che pone alla base della
sua interpretazione hegeliana, sono due, ed entrambi possono essere specificati con
proposizioni testuali dell’articolo di Koyré: «Insistiamo sul termine umano, perché,
ancora una volta, correttamente intesa, la Fenomenologia dello spirito è una
antropologia» (42), la prima; «“Il tempo è il concetto medesimo che è là” (der
daseiende Begriff selbst). L’essere per sé, autocosciente, è dunque essenzialmente
negatore e temporale» (43), la seconda.
Per quanto riguarda la prima frase, è facile notare che in questo modo la
Fenomenologia è mozzata, sia in alto, sia in basso, cioè l’indagine su questo testo non
terrà mai conto della religione e della natura. La seconda frase è una vera e propria
forzatura ermeneutica del testo hegeliano.
Così Koyré da una parte ritaglia nella Fenomenologia il profilo dell’essere
autenticamente dialettico, l’uomo; dall’altra, completa la prima, con la riduzione
metafisica del concetto al tempo storico. L’assoluto hegeliano, viene sobbalzato fuori
dal sistema e dal fondamento intemporale su cui riposava, e si ritrova gettato nel
vortice relativistico del tempo. Accade allora che il sistema di Hegel si apre alla
possibilità del futuro così da legarne il destino alla responsabilità etica dell’agire; in
tal modo sul terreno preparato da Koyré; si vengono ad inserire tutte le possibili
dialettiche marxiste, che su questo ritrovato concret hegeliano, tenteranno di avviare
la loro aspirazione ad un messianismo radicalmente ateo.
Koyré, da parte sua, è consapevole del problema e nel suo testo lascia al
sistema di Hegel una possibilità di realizzazione: «Così, solo il carattere dialettico del
tempo rende possibile una filosofia della storia, ma nello stesso tempo il carattere
temporale della dialettica la rende impossibile dal momento che, lo si voglia o meno,
la filosofia della storia ne costituisce un arresto. Non si può prevedere il futuro, e la
dialettica hegeliana non ce lo consente, poiché la dialettica, espressione del ruolo
creativo della negazione, ne esprime insieme la libertà. La sintesi è imprevedibile: è
impossibile costruirla; si può solo analizzarla. La filosofia della storia, e – quindi – la
filosofia hegeliana, “il sistema”, sarebbero possibili solo se la storia fosse terminata,
se non ci fosse più futuro, se il tempo potesse fermarsi. Può darsi che Hegel l’abbia
creduto. Può darsi che abbia creduto che fosse non solo la condizione essenziale del
sistema […] ma anche fosse già realizzata, che la storia fosse effettivamente
terminata e che proprio per questo egli potesse – avesse potuto - suggellarla» (44).
Questa è l’ambigua eredità che Koyré lascia a Kojève, insieme alla sua
cattedra. Solo l’estinzione del futuro consente all’assoluto di compiersi nel tempo.
65
Ma tutto ciò è molto di più di quanto possa apparire in un primo momento, infatti, in
quelle ultime tre parole («potesse – avesse potuto –suggellarla.») entra in scena un
assunto fondamentale per il dibattito filosofico a seguire: la fine della storia.
Pensiero della fine come compito futuro, fissamento di una meta prospettica o
decretazione di uno stato di fatto, la fine della storia diviene la condizione della
possibilità del concetto; quest’ultimo che nelle prime ipotesi aveva per contenuto solo
il tempo, ora ha, quale oggetto, la comprensione concettuale della fine. Tale
difficoltà, porterebbe a far cadere la fine della storia dentro e fuori sé stessa, ma
comunque nel tempo.
E se così è, il discorso della fine, comunque sia, soggiacerà al primato
trascendentale del futuro, diverrà escatologia: così non dirà più “la storia è finita”, ma
“la storia ha da finire”, determinando conseguenze relativistiche. Kojève cadrà
consapevolmente in questa “trappola” aperta da Koyré, convinto che si trattasse del
problema filosofico per eccellenza. Ripercorrendo dopo molti anni il passaggio del
testimone da parte del collega-amico Koyré, affermerà: «Nel corso degli anni, ho
letto tre volte questo scritto [la Fenomenologia] da un capo all’altro senza capirne
nulla [..]. E’ allora che il mio amico Alexandre Koyré diede inizio alla sua
interpretazione della Fenomenologia all’ École Pratique des Hautes Études (alla
Sorbonne). Egli parlò del Tempo hegeliano, e questa fu per me, come si dice, una
rivelazione» (45). Alexandre Kojève nasce a Mosca nel 1902 da una famiglia della
ricca borghesia, imparentata con quella di Vasilij Kandinsky, suo zio. Il padre muore
nel 1905 in Manciuria, nella battaglia tra Russia e Giappone, ma nonostante la sua
condizione di orfano, può accedere ugualmente ad una educazione privilegiata, grazie
ai capitali del secondo marito della madre che è un ricco gioielliere. Frequenta,
infatti, il prestigioso liceo moscovita “Medvednikov”. Già da questi anni si interessa
a problematiche filosofiche che rivelano una attenzione specifica a temi metafisici,
religiosi e politici.
Di tutto ciò noi siamo informati tramite un Diario filosofico, che lui tiene dal
1917 fino al 1920, in cui raccoglie tutte le sue riflessioni giovanili (46). Nel 1918
viene arrestato dai bolscevichi per dei commerci illegali, condannato, trascorre in
carcere un breve periodo. Nonostante si dichiarasse comunista, tra il 1919 e il 1920,
decide di espatriare in Polonia, insieme all’amico Georges Witt, ma al termine di
questo clandestino e avventuroso viaggio, vengono presi e arrestati con l’accusa di
essere due spie bolsceviche.
Nell’estate dello stesso anno esce dal carcere, e recuperata, grazie all’amico,
parte dei beni rimasti in Russia, va a Berlino, per poi ripartire poco dopo verso
l’Italia. Sempre il Diario filosofico ci informa che, in questo periodo, la sua
riflessione si concentra attorno a temi esistenziali: una «filosofia dell’In-esistenza»,
come Kojève stesso la definì, che vede il pensiero come segnato da una mancanza
strutturale originata dalla coscienza della morte. Tali riflessioni avranno la loro
66
prosecuzione in uno scritto che tenta una conciliazione tra prospettiva buddista e
metafisica cristiana: I fini ultimi dell’etica del cristianesimo e del buddismo (47),
datato Luglio 1920. Il buddismo in Kojève rimarrà un riferimento costante in tutta la
sua opera, lui stesso alluderà sempre all’importanza che ha rivestito per comprendere
a pieno talune problematiche filosofiche, sia in ambito hegeliano che heideggeriano
(48). Durante questo stesso anno, precisamente nel soggiorno romano, si inizia ad
interessare di problemi estetici e redige lo scritto Sull’In-esistente nell’arte e sull’arte
dell’In-esistente (49).
Nel 1921 si trasferisce ad Heidelberg dove segue i corsi di filosofia (tra i quali
quelli di Jaspers, con cui ha anche uno scambio epistolare ancora inedito), e
approfondisce lo studio del buddismo e delle lingue orientali (sanscrito, cinese,
tibetano).
Dopo un anno di studi, insoddisfatto del clima accademico e provinciale di
Heidelberg, riparte per Berlino, ma riesce a terminare gli studi, e, tornato ad
Heidelberg, si addottora nel Febbraio del 1926 in filosofia e in lingue orientali.
Relatore della sua tesi su Soloviev è Jaspers (50). Nel frattempo aveva iniziato una
relazione sentimentale con la sua futura moglie Cécil Shoutak, che era già sposata
con il fratello minore di Alexandre Koyré. Fatto sta che quando Koyré conobbe
questo pretendente, nonostante le sue intenzioni iniziali fossero di intervenire nella
faccenda in favore del fratello, decise poi di tenere le parti del rivale; di lì nascerà una
grande amicizia e una reciproca stima intellettuale che porterà Koyré, nel 1933, ad
affidare la sua cattedra proprio a Kojève.
Torna a Berlino, ma, nauseato dal montante clima politico, decide di partire,
nel 1926, alla volta di Parigi, dove segue i seminari di Koyré all’École Pratique,
approfondisce lo studio di Soloviev e delle lingue orientali. Dimostra, però, grande
interesse anche per la matematica e la fisica, di cui prenderà lezioni private dal 1928
al 1931 (su quest’ultimo interesse avrà sicuramente influito Koyré). La crisi che, in
questi anni, colpisce la Borsa annienta gli investimenti di Kojève, mettendolo in gravi
ristrettezze economiche, a cui cerca di sottrarlo Koyrè offrendogli di collaborare alla
rivista «Recherches philosophiques», da lui diretta (51). Il 1933 è un anno
particolarmente importante per Kojève, ottiene, infatti, il diploma all’École Pratique
discutendo una voluminosa tesi sulla filosofia religiosa di Soloviev (52), e
immediatamente dopo vince il dottorato alla Sorbonne presentando lo scritto dal
titolo L’idée du déterminisme dans la phisyque classique et dans la physique
moderne (53). A suo dire però, lo scritto più importante di questo periodo è
L’athéisme del 1931, rimasto inedito; c’è da notare anche una fitta corrispondenza
con lo zio Kandinsky che ora è stata raccolta e pubblicata (54).
Comunque il fatto saliente di questo anno è la chiamata presso l’École Pratique
come successore di Koyré. Costui infatti decide di abbandonare la cattedra di
filosofia delle religioni all’École Pratique per partire alla volta dell’università del
67
Cairo, e propone al Ministero come suo supplente proprio Kojève, che viene
chiamato a sostituirlo. Così a partire dall’anno accademico 1933-34, Kojève inizierà
l’interpretazione della filosofia di Hegel dal punto in cui l’aveva lasciata il suo
predecessore, riprendendo il taglio ermeneutico e le riflessioni di quest’ultimo. Dal
momento che Koyré aveva preso in esame, procedendo geneticamente, i testi
giovanili fino al periodo di Jena, a Kojève toccherà la Fenomenologia dello spirito;
da quel momento, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale (quindi dal 1933
al 1939), quel seminario diventerà il punto di incontro e di discussione dei giovani
intellettuali francesi: Raymond Queneau, Georges Bataille, Jacques Lacan, Eric
Weil,Maurice Merleau-Ponty, André Breton, Raymond Aron, Roger Callois, Pierre
Klossowski, padre Fessard, Henry Corbin, Robert Marjolin e lo stesso Koyré, erano
tutti uditori di quelle lezioni. Il suo seminario divenne in pochi anni leggendario, le
discussioni che esso suscitava si trasferirono dalle aule universitarie ai salotti
culturali, ai circoli letterari, ai laboratori politici e sociologici, insomma le riflessioni
di Kojève formarono tutta la cultura francese a venire, dalla letteratura alla
psicoanalisi, dalla filosofia alla politica (55).
Per quanto riguarda la presenza di Sartre al seminario, nell’elenco completo dei
partecipanti anno per anno non compare; anche se è notorio che lo Hegel di Sartre sia
quello dell’interpretazione kojèviana.
Sicuramente Sartre conosceva bene l’articolo del filosofo russo apparso su
«Mesures» nel Gennaio del 1939 (successivamente apposto da Queneau all’inizio
dell’Introduzione alla lettura di Hegel, con il titolo A guisa di introduzione), che è
una traduzione commentata della sezione A del capitolo IV della Fenomenologia,
intitolata «Autonomia e dipendenza dell’Autocoscienza: signoria e servitù».
Scrive Remo Bodei, in un saggio su Kojève (56), che il tema della
consapevolezza di sé stessi, presuppone il rapporto consapevole con altre
autocoscienze: il poter dire «io», presuppone lo «sdoppiarsi al proprio interno
rispecchiandosi dapprima in un “io” diverso dal proprio», e ciò accade perché «la
relazione diretta» della coscienza «con l’oggettività non è sufficiente […] a far
sorgere l’autocoscienza, poiché “l’uomo si ‘perde’ nell’oggetto conosciuto”, viene
assorbito e quasi risucchiato da esso». Al termine di questa osservazione, Bodei,
riporta in nota che Sartre nelle sue opere, sia letterarie che filosofiche, sviluppa
proprio questo tema «in un’efficace interazione di fenomenologia hegeliane e
husserliana, allorché contrappone la coscienza non-tetica (dissipata nel ‘reale’,
esposta al rischio di farsi “assorbire dalle cose come carta assorbente” oppure di
perdersi, disintegrandosi o sciogliendosi nell’altro come se il mondo avesse “un foro
di scarico, al centro del suo essere”) a quella tetica, in grado di ritornare in se stessa e
di pensarsi quando l’individuo è “visto” dall’Altro (il tutto in relazione alla più
generale teoria dell’uomo come “desiderio di essere”)» (57). La nota termina col
68
rimando a due opere sartriane, L’essere e il nulla e Il rinvio, in cui tale tema viene
notevolmente considerato.
Per quanto riguarda Sartre, mi sembra che a questo punto, sia chiaro il debito
verso la riflessione kojèviana; si può comunque confrontare un articolo di Fessard, in
cui si tratta della reticenza dei partecipanti al seminario a citare il debito verso di esso
(58).
Si noti inoltre, che c’è un assente d’eccezione, Jean Hyppolite, che evitò il
seminario di proposito per paura di rimanere influenzato dalla forza persuasiva di
Kojève (59). Mobilitato nel 1939, Kojève non viene direttamente impegnato nelle
operazioni al fronte, ma successivamente partecipa attivamente alla resistenza.
Catturato dalla polizia tedesca, riesce a evitare il plotone d’esecuzione; nello
stesso anno (1943) scrive un libro concepito durante la guerra come chiarificazione
della sua filosofia politica, Linee di una fenomenologia del diritto (60), che viene
pubblicato postumo. Gli scritti successivi, tutti per lo più inediti, sono interamente
dedicati ad una specie di filosofia geo-politica, che, partendo dalle sue teorizzazioni
sulla fine della storia, e notando le contraddizioni con gli eventi scaturiti dal secondo
conflitto mondiale, cerca di definire la situazione politica mondiale come un periodo
di transizione, in cui il Weltgeist hegeliano, superata la forma dello stato nazionale,
tende alla mondializzazione, soggiornando nella mediazione degli imperi. Tra il 1945
ed il 1968, Kojève entra in una seconda vita: il suo allievo Robert Marjlion, che nel
frattempo era divenuto un alto funzionario del Ministero dell’Economia, lo chiama
per rivestire l’incarico di “chargè de mission” presso la DREE (Direction des relation
économiques extérieures): cominciava la sua nuova carriera di alto funzionario negli
organismi economici europei e internazionali; il 4 Giugno del 1968 è l’ultimo giorno
di vita di Kojève, si trova a Bruxelles per una riunione del Mercato Comune Europeo,
e dopo aver preso la parola brevemente, si accascia per un infarto.
La fortuna degli studi kojèviani è stata più forte in America che in Europa, dove è
difficile trovare una monografia esauriente sul suo pensiero.
Negli USA, stranamente, oltre a opere monografiche (61), sono stati scritti
molti articoli e saggi, ed anche una notevole traduzione di opere edite e inedite. Fu
importato sulla scia di Leo Strauss con il quale intrattenne un importante dialogo sul
rapporto tra filosofia e potere (62). La ricezione statunitense, forse a causa di una
lettura straussiana del pensiero kojèviano, è orientata a leggerlo come paradigma di
un pensiero reazionario, che pone in primo piano i valori aristocratici dell’onore e
della lotta contro l’omologazione genealogicamente perpetuata nella storia del
cristianesimo, e lo condanna ad un pragmatismo etico che giustificherebbe ogni sorta
di totalitarismo. Comunque, il messaggio politico che si può trovare nelle concezioni
kojèviane (per esempio la fine della storia), è facilmente strumentalizzabile: c’è, chi
vi vede il rappresentante dello stalinismo francese, ma solitamente il giudizio che si
69
incontra, è quello di un pensiero destrorso, in senso aristocratico ed iperstatalista.
Tuttavia c’è anche chi vi ha rilevato un ideale essenzialmente a-politico.
Una possibile spiegazione di questa ricezione americana, è l’enorme risonanza
che ha avuto il libro The Closing of the American Mind (63) di Allan Bloom, che,
essendosi sempre dichiarato allievo di Kojève, ne alimentò l’immagine di destra. Ciò
si deve al fatto che il sopracitato libro trae ispirazione da una famosa nota
dell’Introduzione, aggiunta posteriormente alla seconda edizione del 1968 (64), in cui
Kojève dichiara di vedere nell’American Way of Life, la ricaduta dell’uomo nella
predetta condizione post-istorica dell’animalità.
Bloom da qui è partito per una ricognizione delle fonti ispiratrici che
soggiacciono al pensiero del russo, rinvenendole in una linea nietzscheana, che
distanziandosi dalla solita lettura marxista della teoria dell’“ultimo uomo”, lo lega
alla così detta “rivoluzione conservatrice”, che porta la sua interpretazione hegeliana
dal versante che va da Spengler a Schmitt.
Francis Fukuyama, allievo di Bloom e apostolo (a suo dire) di Kojève, è invece
persuaso che il russo sia il paladino del moderno liberalismo borghese, e nel recente
libro La fine della storia e l’ultimo uomo (65) distorce nuovamente il pensiero
kojèviano; partendo dalla nota che ispirò il suo maestro, Fukuyama approda ad
un’interpretazione diversa: Kojève sarebbe il profeta del trionfo mondiale del
liberalismo borghese, e quindi della democrazia. E’ da notare come, dalla “nota
aggiunta” o dal carteggio con Strauss, la tradizione americana rinvenga in Kojève i
tratti tipici di concezioni conservatrici, l’ermeneutica europea, invece, quelli della
sinistra hegeliana. Resta comunque il fatto che in America, per quanto personali,
distorte o superficiali, ci siano all’attivo molte più pubblicazioni sul pensiero del
russo; in Italia o in Francia, invece, questa assenza si deve forse al bilancio tutto
sommato negativo che si è fatto della sua interpretazione hegeliana e della riflessione
filosofica che si ricava da essa.
Mario Rossi (66) afferma, senza riserve, che l’interpretazione umanistica di
Kojève è «personalissima (per non dire del tutto arbitraria)» (67), la sua analisi di
Hegel si basa esclusivamente sulla dialettica tra signoria e servitù, Hegel viene
trattato come se avesse scritto una serie di proposizioni simili che discendono
unilateralmente da essa, «e dalla quale tutto il resto dipende».
Che Hegel abbia voluto fondare e delineare una dialettica dell’assoluto (della
quale l’uomo, e soprattutto il singolo, l’individuo, non è che un momento); che abbia
descritto questa dialettica come una dialettica dell’estraneazione o alienazione
dell’assoluto, che così si particolarizza, si determina; e che il ritorno in sé della
condizione estraniata sia una riconquista che l’assoluto compie in sé stesso: di tutto
questo Kojève non tiene alcun conto.
«Per lui il soggetto della dialettica è l’uomo, e in questa sezione, non
l’autocoscienza come momento dell’assoluto, ma l’autocoscienza in quanto essa
70
significa che… l’uomo si differisce dalla bestia» (68), e continua in nota, «quanto alla
scoperta dell’ “ateismo” di Hegel, e cioè del “superamento” della religione nel sapere
assoluto, sappiamo ormai non solo come essa non sia affatto nuova, ma anche come
sia destinata, in quanto convalida della filosofia speculativa, a convertirsi in una
suprema posizione teologica.
Con la differenza che la teologia negativa di Bauer s’inserisce nello sviluppo
storico della critica della Sinistra hegeliana che fece da ambiente e da sfondo alla
formazione di Marx, dopo il quale, infatti, non si sa a che cosa potrebbe servire una
sua riesumazione» (69).E commentando una nota - in cui Kojève loda Heidegger per
aver ripreso i temi hegeliani della morte, pur rimproverandogli di trascurare i
complementari temi della lotta e del lavoro (con la conseguenza di non riuscire a
rendere conto della storia); e loda Marx per aver mantenuto quegli stessi
temi(caratterizzando la sua filosofia in senso “storicista”), ma rimproverando a
quest’ultimo di aver trascurato il tema della morte, con la conseguenza di non vedere
che la rivoluzione è necessariamente ed essenzialmente sanguinosa (70), Rossi
afferma che si tratta di una «dichiarazione estremamente pericolosa, perché sembra
indicare che le simpatie di Kojève non vadano tanto alla sostanza “storicista” del
marxismo, quanto ad una metafisica del sangue di carattere romantico degenerante
che, per fortuna dei “marxisti”, è semplicemente l’opposto del marxismo, e non può
far pensare, con buona pace di Kojève (che però scriveva questa frase nel 1939), alle
contemporanee interpretazioni naziste di Hegel». E Aggiunge: «Ma su questo punto
speriamo di esserci sbagliati» (71).
Conclude quindi sarcasticamente il commento a Kojève dicendo: «Questi
pochi accenni speriamo bastino a convincere il lettore che, per quanto suggestive o
simpatiche possano riuscirgli le pagine di A. Kojève che abbiamo esaminate, pure,
queste non hanno pressoché nulla a che fare né con Hegel né con la Fenomenologia
dello spirito. Cerchiamo […] di spiegare Hegel non con Heidegger, né con Marx, né,
putacaso, col neopositivismo logico, ma con Hegel stesso» (72).
Non è facile trovare accuse così poco velate, ma è facile imbattersi in
dichiarazioni che responsabilizzano l’operato del russo in Francia: «Comunque sia, è
difficile comprendere i giudizi favorevoli o sfavorevoli a Hegel che si incontrano in
Weil, Aron, Fessard, Lacan o Merleau-Ponty, per citare che questi, senza trovarsi
innanzi all’immagine forgiata nel crogiolo kojèvano; si può dire senza partito preso
che lo Hegel al quale la cultura francese, per circa mezzo secolo, ha avuto accesso è
stato, in modo praticamente esclusivo, “lo Hegel di Kojève”» (73).
Allora parlare di Kojève significa tirare in ballo la filosofia francese, che non
mise le radici su Hegel, ma sulla filosofia di Kojève nascosta tra le righe del suo
commento alla Fenomenologia. L’enorme diffusione, che ebbe il libro di Kojève in
Francia, è fuori discussione, il problema sembra essere che «questo testo e il
sentimento che esso sveglia sono spesso ciò che resta di Hegel quando si è
71
dimenticato tutto» (74) o per di più che «l’esistenza del libro del signor Kojève, come
“momento storico” […] dell’influenza attiva di Hegel in Francia, contraddice a tal
punto il contenuto reale riconosciuto da lui al pensiero di Hegel da farla quasi
apparire demenziale» (75).
Derrida appare molto più cauto. Egli scrive che «la lettura neo-marxista e paraheideggeriana della Fenomenologia dello spirito da parte di Kojève è interessante.
Chi lo contesterà? Essa ha giocato un ruolo formatore e non trascurabile, sotto molti
aspetti, per una certa generazione di intellettuali francesi, subito prima o subito dopo
la guerra» (76).
Di conseguenza chi attacca Kojève attaccherebbe tutti quegli intellettuali a cui
Derrida allude. Derrida escluso o compreso? Kojève era chiaramente consapevole
dell’ambiguità a cui stava dando vita nel depositare il suo pensiero all’interno di
quello hegeliano, così che chi tende a dissociare Kojève da Hegel e rendere il suo
commento una semplice interpretazione inautentica, fa il gioco di Kojève; ma chi lo
accetta alla lettera e lo lega, nel bene o nel male, al nome di Hegel fa ugualmente il
gioco di Kojève, nel senso che, comunque, ha legato il destino delle proprie
riflessioni a quelle di Hegel (77). In una lettera di Kojève a Tran-Duc-Thao, datata 7
Ottobre 1948, c’è chiaramente scritto: «Vorrei tuttavia segnalare che il mio lavoro
non aveva il carattere di uno studio storico; mi interessava relativamente poco sapere
ciò che Hegel stesso abbia voluto dire nel suo libro; ho fatto un corso di antropologia
fenomenologica servendomi dei testi hegeliani, ma dicendo solo quello che
consideravo essere la verità, lasciando cadere tutto ciò che, in Hegel, mi sembrava un
errore. Così, rinunciando al monismo hegeliano, mi sono coscientemente distaccato
da questo grande filosofo. D’altronde il mio corso era essenzialmente un’opera di
propaganda destinata a colpire gli animi.
Ecco perché ho volutamente rafforzato il ruolo sella dialettica del Signore e dello
Schiavo …» (78), allo stesso modo, il russo, dichiara che il tema della “vanità”, o del
“desiderio di desiderio”, non esistono in Hegel e di averle introdotte perché la sua
intenzione era quella di fare una interpretazione e non un commento (79).
Lacan e Girard, che hanno importato di netto quest’ultimo concetto, devono molto a
Kojève.
Sappiamo oramai che l’interpretazione di Kojève del testo hegeliano, si può
chiamare “umanista” e “antropologica”, ed è per questa via che essa va ad inciampare
sulla morte o sul problema della finitezza, trasformandosi in un hegelismo della pura
libertà-negatività; del resto sull’identificazione tra libertà e morte, Kojève è molto
chiaro: «La filosofia “dialettica” o antropologica di Hegel è, in ultima analisi, una
filosofia della morte (o, che poi è lo stesso, dell’ateismo)» (80), e «non c’è libertà
senza morte, […] solo un essere mortale può essere libero. Si può anzi dire che la
morte è la “manifestazione” ultima e autentica della libertà» (81). E su questo assunto
72
riposa tutto il problema della lettura di Hegel data da Kojève. Sottolineiamo che il
problema della mortalità (troppo)umana, non è affatto un problema hegeliano.
Per Hegel il sapere assoluto (lo dice il termine stesso) non è in alcun modo un
sapere o una scienza dell’uomo finito; la Scienza della Logica (82), che in un certo
senso è la monografia sul sapere assoluto, è definita da Hegel come «l’esposizione di
Dio, com’egli è nella sua eterna essenza prima della creazione della natura e di uno
spirito finito»83, ciò vale anche per la Fenomenologia, che illustrando le varie figure
della coscienza e del sapere umano, arriva alla manifestazione fenomenologica
dell’assoluto. Tale assoluto Hegel nella «Prefazione» designa anche come «vita dello
Spirito», «che sopporta la morte e in essa si mantiene» (84): quasi una
Kenosi (85) dello spirito, che dunque diviene fenomenalità finita, e che «nell’assoluta
devastazione» sa «ritrovare sé» guadagnando «la sua verità», volgendo «il negativo
nell’essere» (86).
Pertanto il fatto che muoia lo spirito che si è finitizzato, non pone alcun
problema ad Hegel, perché tale è la condizione (attraverso la molla del superamento)
della manifestazione assoluta dello spirito come identità della sostanza e del soggetto,
dell’in sé e del per sé, dell’identità e della differenza: «Che la Sostanza sia
essenzialmente Soggetto, ciò è espresso in quella rappresentazione che enuncia
l’Assoluto come Spirito» (87).
Ora, in Hegel è lo spirito che si finitizza e soffre la propria morte per meglio
rivelarsi a sé stesso, ma, se noi intendiamo e proponiamo di tradurre questo “spirito”
con “uomo”, otteniamo quello che ha fatto Kojève; infatti nel commentare il primo
capoverso di pagina 19 (cito direttamente dall’edizione italiana) della «Prefazione»
alla Fenomenologia, scrive: «E’ questo il senso del passo della Prefazione alla PhG
sopra citato. Interpretato sul piano ontologico, il passo significa che la Totalità
(infinita) dell’Essere (o dell’Uno-che-è) non si rivela da sé a se stessa, ma è rivelata
da una delle sue parti (limitate), la quale rivela anche se stessa. Metafisicamente
parlando, il passo significa che lo Spirito, cioè l’Essere il quale si rivela da sé a se
stesso, non è Dio, ma l’Uomo-nel-Mondo» (88). Allora, usando le parole di Hegel, il
dolore, la pazienza e il travaglio del negativo, non vanno attribuiti all’assoluto o a
Dio, ma ad una «parte limitata» di esso, cioè l’uomo. In questo modo si è compiuto il
definitivo passo per entrare nell’interpretazione kojèviana, perché così la
Fenomenologia diviene un’«antropologia» ed una «scienza dell’uomo» (89).
Le interpretazioni a questo punto sono due. Se l’assoluto hegeliano fosse
identico all’uomo, si otterrebbe una riappropriazione da parte dell’uomo della sua
essenza infinita, assegnata fino ad allora a Dio.
E questa, come già sappiamo, è la tesi della sinistra hegeliana, che Kojève, in
un certo senso, fa propria quando scrive: «In via generale, l’antropologia hegeliana è
una teologia cristiana laicizzata. E Hegel se ne rende conto perfettamente. A più
riprese, egli ripete che tutto quanto la teologia cristiana dice è assolutamente vero, a
73
condizione che non venga applicato a un immaginario Dio trascendente, bensì
all’Uomo reale che vive nel mondo. Il teologo fa dell’antropologia senza rendersene
conto».
Per Kojève questo vuol dire che è finita l’alienazione religiosa ed inizia
l’umanismo ateo; di lì a poco Sartre dirà «L’esistenzialismo è un umanismo».
Ma il secondo punto è il vero problema, cioè, come può l’uomo prendere il posto
dell’assoluto se ne è solo una «parte limitata»? Kojève stesso sa bene che l’uomo è
finito e mortale, e lo si deduce da quel «Uomo-nel-Mondo» che chiude la precedente
citazione, poiché allude, chiaramente, all’ «Inder-Welt-Sein» di Heidegger e più in
generale a tutta l’analitica esistenziale esposta in Sein und Zeit.
Kojève è sicuramente tra chi ha contribuito maggiormente ad introdurre
l’analitica esistenziale in Francia, e tale analitica è presentata esplicitamente da
Heidegger come analitica della finitezza, cioè, mentre nella tradizione metafisica si
era sempre pensato l’uomo sullo sfondo di un essere infinito, Heidegger propone di
invertire la corrente e di pensare l’essere nei termini di finitezza radicale; ma tutto
questo lungo e complesso discorso heideggeriano, non significa affatto che l’essere
venga “riassorbito” nell’uomo, come invece sembra faccia Kojève.
Heidegger non ha mai pensato ad un essere di cui si possa appropriare l’uomo;
l’essere, quale lo definisce Heidegger, è l’essere dell’«essente che noi siamo», ma
soltanto nel senso in cui è l’essere di un essente che non ha il suo essere in sé.
Ed è per questa ragione che Heidegger chiama «l’essente che noi siamo»
Dasein, così che non si possa confondere con l’“uomo” dell’antropologia filosofica
(90), quest’ultimo, infatti, lo si dovrebbe ancora pensare nell’orizzonte di ciò che
Heidegger chiama il Vorhandensein, cioè «l’essere-a-portata-di-mano», una categoria
fondamentale del modo di essere degli enti che il Dasein incontra nel mondo.
Questa categoria assieme alla Zuhandenheit,«utilizzabilità», indica un modo di
essere delle cose, e precisamente quello in cui si trovano quando l’esserci (Dasein) si
rapporta loro nell’atteggiamento osservativo e constatativo, un atteggiamento di tipo
teoretico; al contrario, quando l’esserci si rapporta all’ente secondo l’atteggiamento
praticopoietico, esso allora si rivela sotto l’aspetto categoriale dell’utilizzabilità, e
rispetto alla Vorhandenheit la Zuhandenheit ha un carattere primario, è, cioè, il modo
d’essere in cui il Dasein incontra, innanzitutto e per lo più, l’ente. L’esserci, invece,
«ek-siste», la sua «essenza» è l’«esistenza», ed è gettato (geworfen) in essa senza
essere a fondamento di sé stesso, e contemporaneamente proiettato (entworfen)
dinanzi a sé verso il proprio essere. Al contrario dell’essente che sussiste nel mondo
(Vorhandensein), l’esserci deve essere al di là di ogni essente (di tutto ciò che è), e
per questo tanto è più libero quanto è fondamentalmente finito.
E’ condannato a scegliere tra diverse possibilità che gli si offrono (quindi a
negare tale possibilità per qualche altra), oltrepassando di continuo ogni essente,
caratterizzandosi, così, in quanto «trascendente puro e semplice». In questo modo
74
l’uomo non raggiungerebbe mai il suo essere, la sua realizzazione la otterrebbe nella
possibilità estrema, ossia nel momento della sua morte, il momento impossibile in cui
non “ek-siste” più, in cui non è più (nicht- mehr-Dasein). La libertà dell’esserci, che
gli consente di oltrepassare ogni essente, è una «libertà-per-la-morte» (Freiheit zum
Tode), pertanto inappropriabile; l’esserci finché ek-siste è un «essere-per-la-morte»
(Sein-zum-Tode). Heidegger è tradotto da Kojève in questo modo: l’«essere umano
non è altro che […] la morte che vive una vita umana» (91).
Così si dovrebbe essere compreso quanto il Dasein heideggeriano sia diverso
sia dallo spirito hegeliano, sia dall’uomo dell’umanismo ateo; ciononostante è proprio
un amalgama del genere che costituisce la definizione di «realtà-umana» data da
Kojève. Costitutivo di tale «realtà-umana» è un altro concetto fondamentale di
Kojève, cioè quello di «Desiderio»: «L’ uomo» in quanto Autocoscienza […] è
cosciente di sé, della sua realtà e dignità umane, e in questo si differenzia
essenzialmente dall’animale, che non va oltre il livello del semplice Sentimento di sé.
[…] Ora, l’analisi del “pensiero”, della “ragione”, dell’“intelletto”, […] non scopre
mai il perché o il come della nascita […] dell’autocoscienza, cioè della realtà umana.
L’uomo che contempla è “assorbito” da ciò che contempla; il “soggetto conoscente”
si “perde” nell’oggetto conosciuto. La contemplazione rivela l’oggetto, non il
soggetto. E’ l’oggetto, non il soggetto, a mostrarsi nel e mediante - o, meglio ancora,
come - atto di conoscere.
L’uomo “assorbito” dall’oggetto che contempla non può essere “richiamato a
sé” se non da un Desiderio […]. E’ il Desiderio (cosciente) di un essere a costituire
quest’essere come Io e a rivelarlo come tale […]. E’ il Desiderio a trasformare
l’Essere, rivelato a sé da se stesso nella coscienza (vera), in un “oggetto”, rivelato a
un “soggetto” da un soggetto diverso dall’oggetto e “opposto” ad esso. Solo nel e
mediante, o meglio ancora, come, “suo” Desiderio, l’uomo si costituisce e si rivela- a
sé e agli altri- come un Io, come l’Io essenzialmente diverso dal non-Io, e
radicalmente opposto al non-Io. L’Io (umano) è l’Io di uno del- Desiderio» (92).
Come sappiamo, Hegel tratta dell’«autocoscienza» nel capitolo IV della
Fenomenologia, ossia della coscienza per la quale l’oggetto non è più l’oggetto «in
sé» della conoscenza teorica, descritta nei tre capitoli precedenti («certezza
sensibile», «percezione», «intelletto»), ma l’oggetto «per sé» di una libertà attiva.
L’autocoscienza non contempla l’oggetto (fuori di sé), bensì lo “appetisce”,
“concupisce” «per sé», «l’autocoscienza […] è concupiscenza, appetito» (93), scrive
Hegel, essa non conosce alcuna alterità che non riduca immediatamente a se stessa.
Appetendo se stessa attraverso l’altro, essa nega l’altro; e, questa prima fase
dell’autocoscienza, è per Hegel quella della «Vita», che si sviluppa da sé, a partire da
sé, e che quindi è «indipendente» dall’altro. Ma tale vita naturale resta
profondamente inconscia e inconsapevole di sé («tale unità non è in pari tempo per se
stessa» (94)), essa non si sa libera, non si vede vivere; nega immediatamente tutto ciò
75
che essa non è, «è quindi l’infinito movimento che consuma quel calmo mezzo, è la
vita come vivente» (95), e come tale non dispone di alcuno specchio per vedere se
stessa, abbisognerà, quindi, che si medi: si opponga a se stessa e si rifletta per
“sapersi”, e allora affronterà la morte, negherà se stessa come vita naturale e
acquisterà la libertà come coscienza di sé.
Questo è il momento che interessa tanto a Kojève, perché c’è l’io umano in
opposizione alla vita naturale; anche se, in Hegel, questa opposizione si presenta
come una auto-opposizione «della vita», che acquista coscienza di sé attraverso la
prova della morte, in Kojève diverrà una opposizione radicale dell’uomo alla vita
naturale ed immediata, un dualismo netto, preciso e mai superato in quanto
caratteristica essenziale dell’umanità: «L’uomo […] si differenzia essenzialmente
dall’animale» per il fatto che affronta la morte e così «oltrepassa la realtà data» (96),
la realtà propriamente umana, è la realtà che differisce da sé, che si nega di continuo
come realtà.
Di colpo, tutto questo, non ha più nulla di hegeliano, ci troviamo dentro un
brutale dualismo ontologico irriducibile, che Kojève stesso descrive come
«indispensabile» e come «il principale compito filosofico dell’avvenire» (97). Da un
lato, infatti,abbiamo l’essere naturale, cosale, sostanziale, sempre identico a se stessoquello che Kojève chiama «l’Essere puro e semplice» oppure il «Reale»-, dall’altro,
invece, abbiamo l’essere non naturale, che «annienta nell’Essere» (98), negando,
oltrepassando, trascendendo ogni «Reale», quello che Kojève chiama
indifferentemente, l’«Uomo», il «Soggetto», il «Desiderio» oppure il «Discorso»
(99). Sembra, allora, che Kojève abbia reinterpretato le due categorie heideggeriane
di Dasein e Vorhandensein, adattandole al discorso hegeliano, e ribattezzandole per
l’occasione «realtà-umana» e «realtà data»; allo stesso modo, l’impianto caratteristico
dell’ontologia dualistica kojèviana sembra far leva sulla «differenza» heideggeriana
dell’essere e dell’essente, qui drasticamente reinterpretata in termini di differenza tra
due regioni dell’essente.
E’ evidente che questo amalgama filosofico che Kojève costruisce, unendo
Heidegger ed Hegel, scontenta entrambi i filosofi e i puristi della storia della
filosofia: non si capisce, infatti, come Hegel potrebbe acconsentire ad un assoluto
scisso in due, e ad una dialettica bloccata sul momento della «riflessione» finita.
E dal canto suo Heidegger rifiuta di riconoscere all’essere un potere di
annientamento, di cui potrebbe semplicemente appropriarsi l’essere umano (vedi la
già citata Lettera sull’umanismo che può essere considerata una risposta sia a Kojève
che a Sartre, in quanto suo “erede filosofico”).
Ma vediamo brevemente come la chiave di volta del discorso kojèviano poggi
sull’efficacia di un termine, o meglio dire sull’effetto di traduzione di un termine, dal
tedesco al francese, della resa, cioè, della Begierde con désir (100). Per Kojève, si
trattava, forse, di evitare il possibile appiattimento del termine tedesco sullo spettro
76
semantico dell’istinto e del bisogno naturale, dimenticando il carattere spirituale,
riferentesi, cioè, alla sfera dello spirito inteso come quell’ «io che è noi e noi che è
io», che certamente è operante in Hegel. Ma al di là delle successive forzature, che
Kojève fa del testo hegeliano, l’effetto di tale traduzione è certamente di grande
portata. Se il termine tedesco va inteso correttamente nel senso di appetito e/o
concupiscenza, come lo ha tradotto il De Negri, con cui si fa riferimento ad una
funzione del vivente all’interno della coscienza, e quindi già pronta a trapassare
nell’autocoscienza (confronta la triade spinoziana di conatus, appetitus, cupiditas), la
resa kojèviana scatena invece tutt’altra catena semantica.
Désir, ed il suo relativo italiano desiderio, discendono dal latino desiderium,
che letteralmente significa” aver cessato di contemplare gli astri a scopi augurali” o,
in altri termini, l’essere stati privati della protezione delle stelle (101). Pertanto il
desiderio è caratteristico, etimologicamente, di una situazione di privazione, da una
stato precedente di protezione degli astri, a una condizione di non salvaguardia.
L’uomo non contempla più gli astri a scopi augurali, ma si è venuta a creare una
frattura tra esso e le stelle, e allora il desiderio designa tale situazione di mancanza,
ma non nel senso biologico naturale, la cui soddisfazione è regolata dall’istinto, bensì
è proprio di una mancanza essenzialmente umana: quell’impossibilità per il soggetto,
che Hegel attribuiva alla coscienza vivente, di poter attingere alla felicità che
deriverebbe dalla sempre riconquistata identità con sé. C’è, nel desiderio, il rimando
alla “mancanza ad essere”, quindi allo stato di scissione del soggetto, ed è l’effetto
della rottura inevitabile dalla natura “mitica”, in senso stretto, dal potere mitico degli
astri (che però è già un prodotto della cultura chiamato ad esorcizzare la natura del
desiderio).
«Se l’uomo de-sidera, non è tanto perché ha cessato di fare tutt’uno con la
natura, quanto perché è l’effetto di un dis-astro. La necessità divina ed astrale non
governa più l’ordine del cosmo, le stelle non rispondono più alle domande degli
uomini e gli auguri non sono più in grado d’interpretare i presagi che giungono o
confusi od ambigui. Come diceva Plutarco, è perché Pan è morto e la natura è
ammutolita, che l’uomo si trova catapultato nell’universo del desiderio e della
catastrofe. Da ciò deriva quel significato secondario, ma non per questo meno
decisivo, del desiderio, che consiste nel fatto che, mentre desiderare è rivolgersi al
futuro, la sua soddisfazione coincide con il ripristino di uno stato che appartiene al
passato: un tempo mitico perché anteriore al tempo proprio del desiderio.
Quest’ultimo è governato da un movimento temporale complesso: mentre,
infatti, si dispone nell’attesa del futuro, è in realtà dal passato che attende il ritorno di
ciò che desidera. Allora, desiderare significa, anche, aver fede nel fatto che ciò che si
ritiene perduto, sopravviva e possa ritornare un giorno a noi dall’avvenire, come se,
insistendo in un altro tempo da quello della nostra coscienza, esso non solo fosse
77
eterno, ma anche superasse d’un balzo il tempo finito dell’esistere umano e ci venisse
incontro, cioè ci attendesse, nel punto d’incrocio fra il tempo e l’eternità» (102).
E dopo questa digressione, tornando al testo hegeliano dell’interpretazione che ne dà
Kojève, vediamo quando il desiderio che desidera se stesso nel suo oggetto, diviene
propriamente «umano» e non «naturale» o «animale». Ebbene, per Kojève, ciò
accade nel momento in cui il desiderio si dirige verso un oggetto non naturale: poiché
esso stesso, il desiderio, diviene allora quell’oggetto, facendolo proprio e
conseguentemente sopprimendolo. Ma quell’oggetto altro non è che un altro
desiderio anzi, in un certo senso, lo stesso desiderio. «Perché ci sia Autocoscienza,
occorre dunque che il Desiderio si diriga verso un oggetto non-naturale, verso
qualcosa che oltrepassi la realtà data.
Ora, la sola cosa che oltrepassi questo reale dato è lo stesso Desiderio» (103).
In Kojève, si deve notare, ancora l’uso frequente delle maiuscole per le parole chiave,
oggi completamente in disuso; e qui, infatti, compare “Desiderio”, come a
sottolineare che non si tratta del desiderio di questo o quello, bensì, del Desiderio,
nella sua essenza di Desiderio. E questo Desiderio in quanto Desiderio, dirà Kojève,
cos’è mai se non un desiderio di vuoto? «Infatti, il Desiderio, assunto come tale, cioè
prima della sua soddisfazione, è in realtà solo un niente rivelato, un vuoto irreale.
Dato che il Desiderio è la rivelazione di un vuoto, la presenza dell’assenza di una
realtà, esso è essenzialmente altro dalla cosa desiderata, altro da una cosa, da un
essere reale statico e dato, eternamente mantenentesi nell’identità con se stesso.
Il Desiderio che si dirige verso un altro Desiderio, assunto in quanto Desiderio,
creerà dunque, mediante l’azione negatrice e assimilatrice che lo soddisfa, un Io
essenzialmente altro dall’ “Io” animale» (104). E continua, «Quest’Io che si “nutre”
di Desideri sarà anch’esso nel suo stesso essere Desiderio, creato nella e dalla
soddisfazione del suo Desiderio.
E, dal momento che il Desiderio si realizza in quanto azione negatrice del dato,
l’essere di questo Io sarà azione. Quest’Io non sarà come l’“Io” animale, “identità” o
eguaglianza con sé, ma “negatività-negatrice”. Detto altrimenti, l’essere di questo Io
sarà divenire, e la sua forma universale non sarà spazio, ma tempo. Dunque, per
quest’Io il mantenimento nell’esistenza significherà: “non essere ciò che è (in quanto
essere statico e dato, in quanto essere naturale, in quanto ‘carattere innato’) ed essere
(ossia divenire) ciò che non è”. Quest’Io sarà così la sua propria opera:
sarà(nell’avvenire) ciò che è diventato mediante la negazione (nel presente) di ciò che
è stato (nel passato), dato che questa negazione è stata effettuata in vista di ciò che
esso diverrà. […] Quest’Io è divenire intenzionale, evoluzione voluta, progresso
cosciente e volontario. E’ l’atto di trascendere il dato che gli è dato e che esso stesso
è. Quest’Io è un individuo (umano), libero (di fronte al reale dato) e storico (in
rapporto a se stesso). E’ questo, e soltanto questo, l’Io che si rivela a sé e agli altri
come Autocoscienza».
78
Il Desiderio umano è dunque Desiderio che si desidera come desiderio
insoddisfatto: pura negatività (in termini hegeliani), pura trascendenza (in termini
heideggeriani). Ma in questo amalgama hegelo-heideggeriano, in che senso il
Desiderio “si” desidera, come altro o come se stesso? Vediamo che in Hegel il
desiderio desidera se stesso attraverso la negazione dell’altro, ed è per questo che
Hegel parla di uno «sdoppiamento dell’autocoscienza: essa si desidera nell’altro che
essa stessa è, e deve dapprima alienarsi in un altro desiderio per potersene poi
riappropriare e riconoscerlo come proprio, e così soddisfare l’appetito. Al contrario,
se il desiderio viene definito, in termini para-heideggeriani, come trascendenza verso
il nulla, è chiaro che esso “si” desidera come negatività pura e alterità assoluta:
questo Desiderio (con la maiuscola) “si” desidera come Altro (con la maiuscola), al di
là di se stesso e di ogni «io».
Kojève potrà, anzi arriverà, a dire in un codice esplicitamente ambiguo da poter
essere interpretato in entrambi i sensi, che il Desiderio è «Desiderio di Desiderio», o
anche che è «Desiderio del Desiderio dell’altro». E in questo codice “bi-fronte”, il
desiderio umano si definisce, kojèvianamente, come Desiderio che si dirige verso un
altro Desiderio umano: quello che desidera è di essere desiderato da un altro- vale a
dire di essere «riconosciuto» - come puro desiderio di “nulla”. Non c’è altro
Desiderio davvero umano che il «Desiderio di riconoscimento», e non c’è «realtà
umana» che non sia «realtà riconosciuta» o «realtà sociale»: «Se la realtà umana è
una realtà sociale, la società umana è umana solo in quanto insieme di Desideri che
reciprocamente si desiderano come Desideri. […] Così, per esempio, nel rapporto tra
l’uomo e la donna, il Desiderio è umano unicamente se l’uno non desidera il corpo
bensì il desiderio dell’altro, se vuole “possedere” o “assimilare” il Desiderio assunto
come tale, se cioè vuole essere “desiderato”, “amato” o, meglio ancora,
“riconosciuto” nel suo valore umano, nella sua realtà di individuo umano. Parimenti,
il Desiderio che si dirige verso un oggetto naturale è umano soltanto nella misura in
cui è “mediato” dal Desiderio di un altro che si dirige sullo stesso oggetto: è umano
desiderare ciò che gli altri desiderano, perché lo desiderano. […] La storia umana è la
storia dei Desideri desiderati» (105). Però, c’è un problema che non fa che acuirsi,
procedendo la lettura, cioè non si capisce da dove provenga il Desiderio di
riconoscimento, poiché in linea con l’ontologia dualistica, la realtà umano-sociale
sorge ex abrupto dalla realtà naturale, senza alcuna mediazione o transizione, né si
capisce in che modo possa essere soddisfatto, dal momento che, come dice Kojève,
esso sia un puro desiderio di nulla. L’unica soluzione, allora, dalla realtà umana,
affinché possa farsi riconoscere e desiderare come Desiderio allo stato puro, sarebbe
quella di morire, di negarsi totalmente come vita animale e realtà data.
Kojève, per risolvere tale problema, ricorre a Hegel: sarà la lotta per il
riconoscimento e la dialettica che ne discende, del servo e del signore. La lotta per il
riconoscimento è definita da Kojève «di puro prestigio», poiché le coscienze vi si
79
battono per nulla. Però accade che una delle due coscienze in lotta ha avuto paura
della morte, cioè del Desiderio più proprio(inconscio), e allora ha preferito
riconoscere l’altra –unilateralmente- come sua signora: iniziando così il lungo
processo della Storia e del Lavoro, come Lotta per un riconoscimento finale e
definitivo. Così, però, sarà solo alla fine della Storia che l’Uomo potrà soddisfare il
suo autentico.
Desiderio umano, solo nel momento in cui non sarà più un Uomo, ma diverrà
un Saggio (assunto fondamentale e consequenziale in Kojève di cui qui è impossibile
trattare): «Ma se l’opposizione della “tesi” e dell’ “antitesi” ha senso solo all’interno
della conciliazione mediante la “sintesi”, se la storia, nel senso forte della parola, ha
necessariamente un termine finale, e se l’uomo che diviene deve raggiungere il suo
apice nell’uomo divenuto, se il Desiderio deve portare alla soddisfazione, se la
scienza dell’uomo deve avere il valore di una verità definitivamente e universalmente
valida, l’interazione del Signore e del Servo deve alla fine condurre alla loro
“soppressione dialettica”» (106).
Il servo, come noteranno Bataille e Lacan, è restato in vita, è arretrato di fronte
alla morte, la «Signora assoluta»: pertanto, il Desiderio che ha trovato soddisfazione
alla fine, non è in alcun modo quello messo in gioco all’inizio, cioè il puro Desiderio
di morte.
Quest’ultimo, infatti, come insiste Kojève, posto come Desiderio umano, non
può essere soddisfatto: non c’è alcun modo di poter fare esperienza di questa pura
negatività che «egli stesso è», se non differendola di continuo, o meglio,
desiderandola.
Se il Desiderio veramente umano è il desiderio che si desidera come desiderio
di nulla, allora l’uomo non potrà mai incarnare altro che il desiderio di se stesso, il
desiderio impossibile di sé. L’uomo, allora sembra, essere il nome di quella categoria
che è l’impossibile, poiché diverrebbe per sua propria essenza “colui che è sempre al
di là di sé”.
80
Note
(1) In questa prima parte tutte le parole o interi periodi riportati tra virgolette, salvo
mia esplicita indicazione, sono citazioni testuali tratte da Jacques Derrida, Fini
dell’uomo, in Margini della filosofia, trad. it. di M. Iofrida, Einaudi,Torino 1997.
(2) Si arriverà ad affermare che il punto di vista filosofico di Hegel «è l’unico
direttamente accessibile a un uomo moderno, poiché quest’uomo (a meno che non sia
un grandissimo filosofo) non può far altro che essere ‘hegeliano’ (a rigore senza
saperlo)». Frase di Alexandre Kojève tratta da Les romans de la Sagesse, in
«Critique», 60, 1952, p. 389.
(3) Alexandre Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, Milano 1996, p.
17.
(4) Vedi Raymond Queneau, Segni, cifre e lettere, Einaudi, Torino 1981, p. 365-372.
(5) Denis Hollier, Il collegio di sociologia, ed. it. a cura di M. Galletti, Bollati
Boringhieri, Torino 1991, p. 518.
(6) J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, il Saggiatore, Milano (1965) 1991, p. 741.
(7) S. Moravia, Introduzione a Sartre, Laterza, Bari (1973) 1996, p. 82.
(8) J.-P. Sartre, op. cit., p. 738.
(9) ibid., p. 741.
(10) ibid., p. 751.
(11) Ibid., p. 744. Traduzione leggermente modificata.
(12) M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, in Segnavia, Adelphi, Milano 1987, p.
275.
(13) Sulla loro entusiastica ricezione vedi, E. Mounier, Les cinq étapes d’ “Esprit”, in
«Dieu vivant», 16, 1950.
(14) Bisogna dire però che nel momento in cui l’autorità del pensiero husserliano
arriva in Francia rimane del tutto inavvertita e senza effetto la critica
dell’antropologia in esso contenuta.
(15) Per un inquadramento storico di questa situazione francese rispetto a Hegel, si
possono vedere in lingua italiana due opere di facile reperibilità: A. Negri, Hegel nel
Novecento, Laterza, Roma-Bari 1987, in particolare pp. 42-51 e R. Salvadori, Hegel
in Francia. Filosofia e politica nella cultura francese del Novecento, De Donato, Bari
1974. E anche W. Biemel, Die Phänomenologie und die Hegel-Renaissance in
Frankreich, in «Stuttgarter Hegel-Tage, 1970», n. 11, Bouvier, Bonn 1974, pp. 643655.
(16) «Di Hegel, in Francia, non si era mai neppure sentito parlare fino agli anni ’30
circa se non da V. Cousin, che, nel XIX secolo, lo impoverisce senza pietà»: J.-P.
Aron, I moderni, Feltrinelli, Milano 1985, p.8. Ma anche R. Queneau,op. cit.; G.
Canguilhem, Hegel en France, in «Revue d’histoire et de philosophie religieuses», 4,
81
1948-49, pp.282-297;R. Garaudy, Prospettive dell’uomo, Einaudi, Torino 1972,
p.275.
(17) J. Hyppolite, Figures de la pensée philosophique, Paris 1971, 2 voll., p.233.
(18) A. Breton, Entretiens, N.R.F., Paris 1952, p.152
(19) J.-P.Sartre, Critica della ragione dialettica, Il Saggiatore, Milano 1963, p.25.
(20) H. Lefebvre, Le temps des méprises, Paris 1975, pp.49 e 198.
(21) R. Queneau, op. cit.
(22) J. Wahl, Le malheur de la coscience dans la philosophie de Hegel, Rieder, Paris
1929; trad. it. La coscienza infelice nella filosofia di Hegel, Laterza, Roma-Bari 1994.
(23) W. Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels (1905), in Gesammelte Schriften, IV,
Leipzig 1921; trad. it. Storia della giovinezza di Hegel e Frammenti postumi, Guida,
Napoli 1986.
(24) F. Bianco, Introduzione a Dilthey, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 102.
(25) D. Rosca, Vie de Jésus, Paris 1928.
(26) J. Wahl, op. cit., pp. 43-50. (Il riferimento è alla traduzione italiana dell’opera).
(27) J. Wahl, rec. a A. Koyré, La philosophie de Jacob Böhme, in «Revue
philosophique»,
3-4,
1930,
pp.
315-6.
(28) A. Koyrè, rec. a J. Wahl, Le malheur de la conscience dans la philosophie de
Hegel, «Revue philosophique», 7-8,1930, p.136.
(29) A. Koyré, Rapport sur l’état des études Hégéliennes en France, ora in Études
d’histoire de la pensée philosophique,Colin, Paris 1961; trad. it. Rapporto sullo stato
degli studi hegeliani in Francia, in AAVV, Interpretazioni hegeliane,La Nuova
Italia, Firenze 1980.
(30) A.Koyré, rec. cit., p. 141.
(31) Ibid., pp. 142-3.
(32) J.Wahl, Hegel et Kierkegaard, in «Revue philosophique», n. 11-12, 1931,
numero speciale dedicato al centenario hegeliano; e successivamente dello stesso,
Hegel et Kierkegaard, in Verhandlungen des dritten Hegelskongresse von 19. bis 23.
April in Rom, Tübingen 1934; poi riprodotti dall’autore come cap. IV e sua
Appendice in Études kirkegaardiennes, Aubier, Paris 1938.
(33) A. Koyré, Hegel à Jéna, in «Revue d’histoire et de philosophie religieuses», XV,
1935, pp. 420-458.Precedentemente aveva già scritto un altro importante saggio
hegeliano (Note sur la langue et la terminologie hégéliennes, in «Revue
philosophique», n. 11-12, 1931) in cui accenna temi poi ripresi in Hegel à Jéna.
Entrambi i saggi sono tradotti in Interpretazioni hegeliane.
(34) G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830),
Laterza, Roma-Bari 1984.
(35) A. Koyré, op. cit., p. 148. Cito la traduzione italiana dell’opera.
82
(36) «Il fatto è che il tempo hegeliano è, anzitutto, un tempo umano, il tempo
dell’uomo. Anche l’uomo, infatti, è uno strano essere che “è quel che non è e non è
quel che è”», ibid. p. 157.
(37) «Detto altrimenti, l’essere di questo Io sarà divenire, e la sua forma universale
non sarà spazio, ma tempo. Dunque, per questo Io il mantenimento nell’esistenza
significherà: “non essere ciò che è (in quanto essere statico e dato, in quanto essere
naturale, in quanto “carattere innato”) ed essere (ossia divenire) ciò che non è», A.
Kojève, op. cit., p. 19.
(38) A. Koyré, op. cit., p. 165.
(39) A. Kojève, op. cit. p. 457.
(40) Questa analisi, se pur fondamentale, è improponibile in tale contesto, poiché
richiederebbe un approfondimento a sé stante; rinvio pertanto direttamente alle
pagine in questione di A. Koyré, op. cit., pp. 156-159.
(41) Esemplare questo passo di Koyré, che potrebbe essere attribuito tranquillamente
anche a Kojève, in cui dice che la Fenomenologia dello spirito non è altro che
«un’analisi delle strutture essenziali dello spirito umano, della costituzione, nel e
attraverso il pensiero e l’attività dell’uomo, del mondo umano in cui egli vive», ibid.,
p.159.
(42) Ibid.
(43) Ibid. p. 164; la citazione tedesca è tratta da G.W.F.Hegel, Fenomenologia dello
spirito, La Nuova Italia, Firenze1996, p. 491.
(44) A.Koyré, op. cit., pp. 166-167.
(45) A. Kojève, Le concept, le temps et le discours: introduction au système du
savoir, Gallimard, Paris 1990, p. 32. Tra l’altro si può notare una gaffe involontaria di
Kojève, poiché Koyré tenne i suoi corsi sugli scritti immediatamente precedenti alla
Fenomenologia, ma mai su di essa. Fu lo stesso Kojève, che prese il suo posto nel
1933, ad iniziare a trattare quest’opera.
(46) Su tali scritti, molti de quali sono ancora inediti e non tradotti dal russo, si veda
D. Auffret, Alexandre Kojève. La philosophie, l’Etat, la fin de l’Histoire, Grasset,
Paris 1990.
(47) Inedito, alcuni estratti sono in Auffet, op. cit.
(48) «C’est ainsi que l’étude des écrits bouddhistes (que j’ai pratiqués pendant de
longues années) est extrêmement fructueuse tant pour la compréhension de la
Religion et de la Théologie (“philosophique” ou autre) en général, que pour
l’élucidation de certains problèmes proprement philosophiques, voir hégéliens», in A.
Kojève, Essai d’une histoire raisonnée de la philosophie paï enne, Gallimard, Paris
1968, tomo I, p. 164.
(49) Cfr. Auffret, op. cit.
83
(50) Die religiöse Philosophie Wladimir Solowijeffs, dissertazione parzialmente
pubblicata come A.Koschewnikoff, Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowijews,
Cohen, Bonn 1930. Cfr. Auffret, op. cit., p. 443.
(51) Sull’attività di Kojève come recensore, vedi Auffret, op. cit., pp. 443-444.
(52) La philosophie religieuse de Soloviev, discussa nel 1933 ed edita
successivamente in due numeri della «Revue d’histoire et de philosophie religieuses»,
rispettivamente il n. 14 (1934) e il n. 15 (1935), con il titolo La métaphysique
religieuse de Vl. Soloviev
(53) Le livre de Poche, Paris 1990.
(54) In Vassily Kandinsky, corrispondances avec Zervos et Kojève, Hors-Série, Paris
1992, tale edizione contiene anche il saggio che Kojève scrisse sulla pittura dello zio,
Les peintures concrètes de Kandinsky, nel 1936, pubblicato con il titolo Pourquoi
concret, in «XX Siècle», n. 27, 1966-74.
(55) Comunque sull’importanza dell’insegnamento di Kojève per la filosofia francese
del dopoguerra, oltre ai già citati Queneau e Auffret, si veda V. Descombes, Le Même
e l’Autre, Minuit, Paris 1979; J.-M.Besnier, La politique de l’impossible, La
Découverte, Paris 1988; G.Jarczyk-J.-P.Labarrière, De Kojève à Hegel, Albin Michel,
Paris 1996; M.S. Roth, Knowing and History. Appropriations of Hegel in TwentiethCentury France, Cornell Press, Ithaca 1988; J.P.Butler, Subjects of Desire. Hegelian
Reflections in Twentieth Century France, Columbia University Press, New York
1987; B. Drury Shadia, Alexandre Kojève. The Roots of Postmodern Politics, St.
Martin’s Press, New York 1994.
(56) R. Bodei, Il desiderio e la lotta, introduzione a A. Kojève, La dialettica e l’idea
della morte in Hegel, Einaudi, Torino 1991, è in realtà la ristampa dell’edizione
precedente, datata 1948, uscita senza alcuna introduzione all’opera di Kojève.
(57) R. Bodei, op. cit., p. X.
(58) G. Fessard, Hegel, le Christianisme et l’Histoire, Presses Universitaires de
France, Paris 1990, p. 268.
(59) J. Heckman, Hyppolite and the Hegel Revival in France, in «Telos», 16, 1973,
pp. 128-145.
(60) Jaca Book, Milano 1989.
(61) Per esempio: B. Drury Shadia, op. cit.; B. Cooper, The End of History: An Essay
on Modern Hegelianism, University of Toronto Press, Toronto 1984.
(62) A. Kojève-L. Strauss, De la Tyrannie, Gallimard, Paris 1954-1983 (trad. ing. On
Tyranny, The Free Press, New York
1991, con in appendice The Strauss-Kojève Correspondence).
(63) Simon and Shuster, New York 1987.
(64) Nella trad. it. è alle pp. 541-544.
(65) Rizzoli, Milano 1992.
84
(66) M. Rossi, Da Hegel a Marx. I. La formazione del pensiero politico di Hegel,
Feltrinelli, Milano 1970.
(67) Ibid. p. 373.
(68) Ivi.
(69) Ibid., p. 446.
(70) Cfr. A. Kojève, op. cit., p. 717.
(71) M. Rossi, op. cit., p. 447.
(72) Ibid., p. 374.
(73) Jarczyk-Labarrière, De Kojève à Hegel, cit., p. 30.
(74) Id., Les premiers combats de la reconnaissance. Maîtrise et servitude dans la
Phénoménologie de l’esprit de Hegel, 1987, p. 9.
(75) G. Canguilhem, Hegel en France, cit., p. 298.
(76) J. Derrida, Spettri di Marx, Cortina Edizioni, Milano 1994, p. 94.
(77) Per questa interpretazione vedi D. Auffret, introduzione a A.Kojève, L’idée du
déterminisme…, cit., p. 9.
(78) In Jarczyk- Labarrière, op. cit., pp. 64-66.
(79) Ibid.
(80) A. Kojève, Introduzione…, cit., p.669.
(81) Ibid., p. 690.
(82) Laterza, Roma-Bari 1978.
(83) Ibid., p. 41.
(84) G. F. W. Hegel, Fenomenologia…, cit., p. 19.
(85) Vedi: San Paolo, Lettera ai Filippesi, 2-6,8.
(86) Hegel, op. cit., p. 19.
(87) Ibid. p. 14.
(88) A. Kojève, op. cit., p. 683
(89) Ibid., p. 23.
(90) Vedi: M. Heidegger, Essere e tempo, Utet, Torino 1969, § 10, p. 110.
(91) A. Kojève, op. cit., p. 682.
(92) Ibid., pp. 17-18.
(93) G. F. W. Hegel, op. cit., p. 114.
(94) Ibid., p. 111.
(95) Ibid., p. 113.
(96) A. Kojève, op. cit., pp. 17 e 19.
(97) Kojève rimprovera Hegel di avere «esteso la sua ontologia dialettica
“antropologica” alla Natura», dando atto alle gravi conseguenze che discendono da
questo errore «monistico» hegeliano, altresì gli unici due filosofi che abbiano tentato
di porre il problema della ontologia dualista, ma in modo «insufficiente», sono stati
Kant e dopo di lui Heidegger. Per tutte queste considerazioni: A. Kojève, op. cit., pp.
603-605.
85
(98) Ibid. p. 575.
(99) Per quest’ultimo vedi: ibid., pp. 680-681.
(100) Scrive J. Hyppolite: «In francese noi abbiamo tradotto il termine tedesco
Begierde usato da Hegel con désir e non con appétit. Il fatto è che questa Begierde
contiene più di quanto non sembri a tutta prima: pur confondendosi inizialmente con
l’appétit sensibile in quanto dà sui diversi oggetti concreti del mondo, reca in sé un
significato infinitamente più ampio. Nel fondo in tale appetire (désir) l’autocoscienza
cerca se stessa e si cerca nell’altro», in J.Hyppolite, Genesi e struttura della
«Fenomenologia dello spirito» di Hegel, La Nuova Italia, Firenze 1972, p. 196.
(101) Per tale riflessione vedi, B. Moroncini, Il discorso e la cenere, Guida, Napoli
1988, p. 203.
(102) Ibid., p.204.
(103) A. Kojève, op. cit., p. 19.
(104) Ivi.
(105) Ibid., p. 20.
(106) Ibid., p. 23.
86