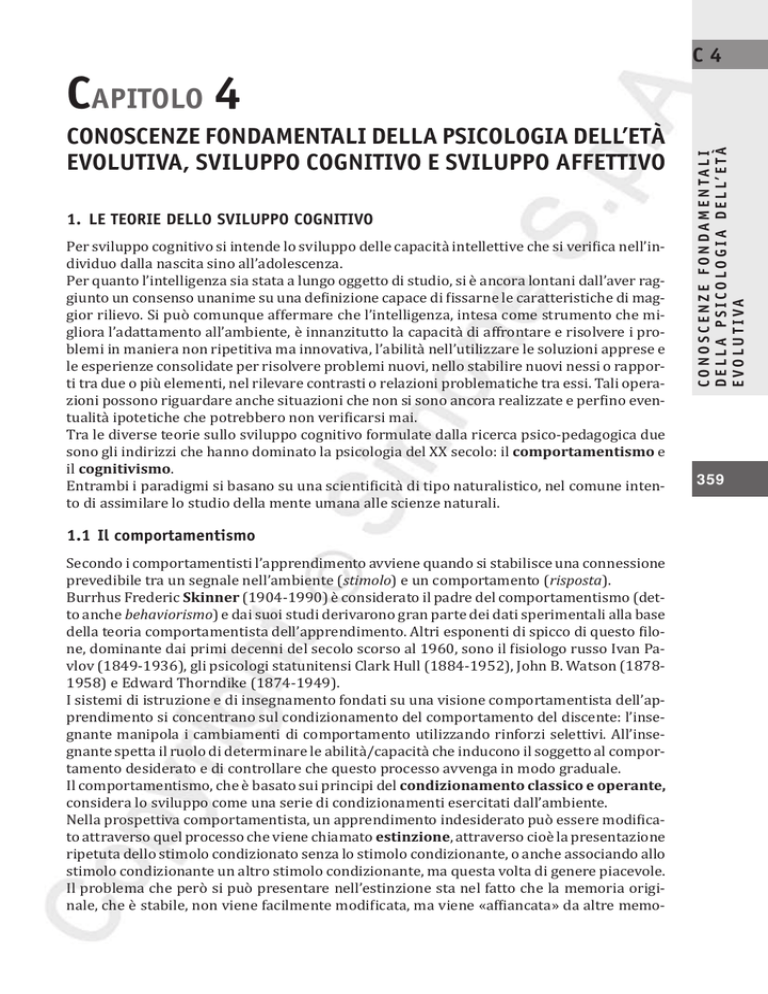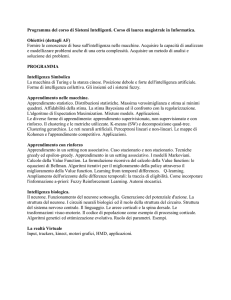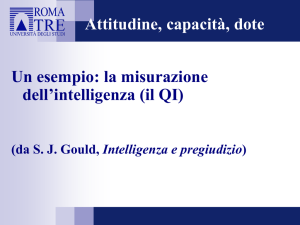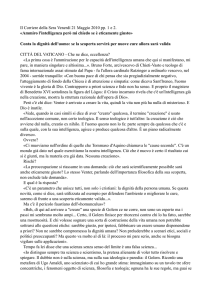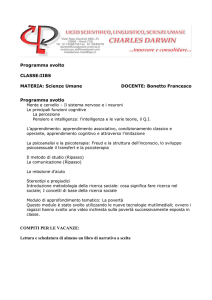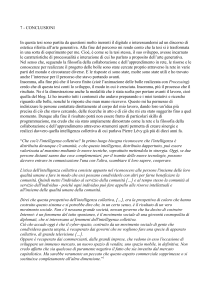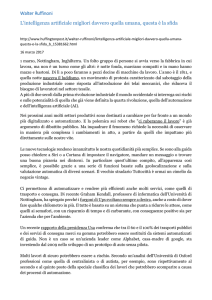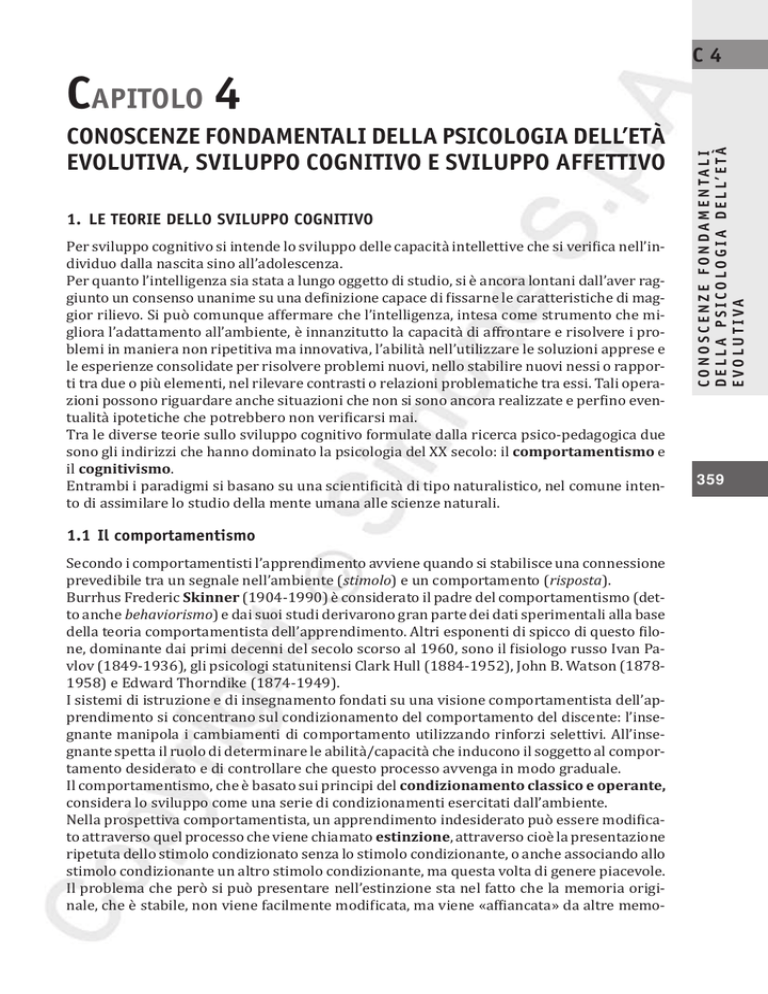
Conoscenze fondamentali della psicologia dell’età
evolutiva, sviluppo cognitivo e sviluppo affettivo
1. Le teorie dello sviluppo cognitivo
Per sviluppo cognitivo si intende lo sviluppo delle capacità intellettive che si verifica nell’individuo dalla nascita sino all’adolescenza.
Per quanto l’intelligenza sia stata a lungo oggetto di studio, si è ancora lontani dall’aver raggiunto un consenso unanime su una definizione capace di fissarne le caratteristiche di maggior rilievo. Si può comunque affermare che l’intelligenza, intesa come strumento che migliora l’adattamento all’ambiente, è innanzitutto la capacità di affrontare e risolvere i problemi in maniera non ripetitiva ma innovativa, l’abilità nell’utilizzare le soluzioni apprese e
le esperienze consolidate per risolvere problemi nuovi, nello stabilire nuovi nessi o rapporti tra due o più elementi, nel rilevare contrasti o relazioni problematiche tra essi. Tali operazioni possono riguardare anche situazioni che non si sono ancora realizzate e perfino eventualità ipotetiche che potrebbero non verificarsi mai.
Tra le diverse teorie sullo sviluppo cognitivo formulate dalla ricerca psico-pedagogica due
sono gli indirizzi che hanno dominato la psicologia del XX secolo: il comportamentismo e
il cognitivismo.
Entrambi i paradigmi si basano su una scientificità di tipo naturalistico, nel comune intento di assimilare lo studio della mente umana alle scienze naturali.
1.1 Il comportamentismo
Secondo i comportamentisti l’apprendimento avviene quando si stabilisce una connessione
prevedibile tra un segnale nell’ambiente (stimolo) e un comportamento (risposta).
Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) è considerato il padre del comportamentismo (detto anche behaviorismo) e dai suoi studi derivarono gran parte dei dati sperimentali alla base
della teoria comportamentista dell’apprendimento. Altri esponenti di spicco di questo filone, dominante dai primi decenni del secolo scorso al 1960, sono il fisiologo russo Ivan Pavlov (1849-1936), gli psicologi statunitensi Clark Hull (1884-1952), John B. Watson (18781958) e Edward Thorndike (1874-1949).
I sistemi di istruzione e di insegnamento fondati su una visione comportamentista dell’apprendimento si concentrano sul condizionamento del comportamento del discente: l’insegnante manipola i cambiamenti di comportamento utilizzando rinforzi selettivi. All’insegnante spetta il ruolo di determinare le abilità/capacità che inducono il soggetto al comportamento desiderato e di controllare che questo processo avvenga in modo graduale.
Il comportamentismo, che è basato sui principi del condizionamento classico e operante,
considera lo sviluppo come una serie di condizionamenti esercitati dall’ambiente.
Nella prospettiva comportamentista, un apprendimento indesiderato può essere modificato attraverso quel processo che viene chiamato estinzione, attraverso cioè la presentazione
ripetuta dello stimolo condizionato senza lo stimolo condizionante, o anche associando allo
stimolo condizionante un altro stimolo condizionante, ma questa volta di genere piacevole.
Il problema che però si può presentare nell’estinzione sta nel fatto che la memoria originale, che è stabile, non viene facilmente modificata, ma viene «affiancata» da altre memo-
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
Capitolo 4
C4
359
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
360
rie che permettono di apprendere che in quella tale altra situazione o in un altro contesto
non c’è da avere paura.
Per esempio, il topolino che era stato condizionato ad aver paura di un suono attraverso una
scarica elettrica del pavimento della gabbia in cui era stato messo, esposto ripetutamente al
suono non più accompagnato dalla scarica elettrica, può non provare più paura del suono,
ma la reazione di paura nei confronti del suono si ripresenterà qualora il topolino verrà posto in un contesto differente; l’animale avrà insomma imparato che in quella gabbia ma non
in un’altra, non deve più temere il suono (il pavimento della gabbia è una rete metallica).
La ragione di questo istinto è da rintracciare, probabilmente, nel fatto che sul piano evolutivo avere paura si è rivelata una strategia efficace per la sopravvivenza della specie. 1.2Il cognitivismo
Nella seconda metà degli anni Cinquanta del XX secolo si diffonde la prospettiva del cognitivismo, nella quale confluiscono i contributi di discipline diverse: oltre alla psicologia sperimentale di impronta neocomportamentista, la linguistica, la teoria dell’informazione e la
cibernetica, le neuroscienze e la filosofia della mente.
Secondo i cognitivisti l’acquisizione della conoscenza ha carattere costruttivo, l’informazione viene connessa a dati già presenti nella memoria a lungo termine e la sua elaborazione è
influenzata dal modo in cui la costruzione precedente è stata strutturata. L’apprendimento,
perciò, non è mai solo replica delle informazioni, iscrizione su di una lavagna di nuovi segni; la conoscenza è prodotto di una costruzione attiva del soggetto, e non di un condizionamento da parte dell’ambiente.
L’idea di base di questo approccio teorico è che ci sono degli schemi cognitivi, delle credenze che organizzano la nostra esperienza mentale e che sono state costruite nel tempo attraverso l’esperienza. Questi schemi cognitivi fanno sì che nel momento in cui si presentano
nuovi stimoli, questi vengono processati o compresi nei termini degli schemi esistenti, producendo un modo automatico di rispondere alle sollecitazioni. Il funzionamento di questi
sistemi è stato chiarito per l’apprendimento motorio.
Facciamo un esempio: quando si impara a guidare un’automobile per la prima volta, si devono avere a mente tutti i differenti componenti – il volante, la leva del cambio, i pedali –
ma con l’esercizio lo si fa in modo automatico, senza neppure pensarci. Questo meccanismo sembra essere mediato da cicli paralleli separati, attraverso cui le informazioni sono
processate dal cervello.
I neuroni, le cellule nervose deputate alla produzione e allo scambio di segnali; costituiscono l'unità funzionale del sistema nervoso cioè la più piccola struttura in grado di eseguire
tutte le funzioni cui è preposto. Il cervello umano ne contiene circa 100 miliardi. Attraverso i dendriti, le fibre ramificate che trasportando i segnali nervosi, il neurone riceve impulsi provenienti da altri neuroni o, nel caso di neuroni sensoriali, prodotti da stimoli ambientali. I neuroni presenti nella corteccia prefrontale svolgono funzioni deputate alla decisione, alla pianificazione e all’adattamento a nuove situazioni. Grazie ai circuiti di neuroni che
svolgono un ruolo di «controllo cognitivo», l’individuo è in grado di adattare gli atteggiamenti mentali, i pensieri e, conseguentemente, i comportamenti, in funzione del contesto
in cui si trova, oppure sulla base di un’informazione sopraggiunta.
La ragione per cui il funzionamento a livello neurale è più chiaro per il comportamento motorio parrebbe evidente: questa cascata di segnali non coinvolge il sistema limbico, ovvero
non chiama in causa le emozioni e «il sentimento di ciò che accade». Si tratta di un tipo di
apprendimento in cui considerazioni molto concrete divengono – attraverso la ripetizione
– automatiche (come anche certe regole di grammatica o di matematica) e non richiedono
un coinvolgimento emotivo.
La prospettiva cognitivista ha trovato una notevole corrispondenza con le acquisizioni delle neuroscienze, anche perché nella propria evoluzione teorica anziché isolarsi in un rigido
dogmatismo – come è stato per il comportamentismo – ha sempre conservato interesse e
apertura nei confronti delle altre discipline.
1.3 Il costruttivismo
Un’evoluzione del cognitivismo, centrato sul modello all’insegnamento è il costruttivismo,
secondo cui l’azione didattica va impostata in modo da stimolare un impegno attivo dei discenti nell’apprendimento.
In questo approccio vi è spesso il rifiuto del modello della classica relazione di apprendimento basata generalmente su lezioni frontali e che viene considerata, in una posizione un
po’ radicale, come «travaso» della conoscenza dalla mente del docente a quella dello studente, con quest’ultimo in posizione succube e passiva. Si tratta di posizioni che sottovalutano
l’attività di rielaborazione interna operata da ciascun individuo, nei confronti di qualunque
stimolo, e di come il bisogno di conoscenza possa essere soddisfatto anche in una posizione solo ricettiva, a cui possa seguire una rielaborazione personale.
1.4 La teoria di Piaget
Nella teoria di Jean Piaget (1896-1980), formulata a partire dall’osservazione delle risposte dei bambini a diversi compiti cognitivi, è contenuta quella concezione che è definita degli stadi di sviluppo in cui lo sviluppo mentale è descritto come una transizione tra stadi
ben definiti, come una «trasformazione discontinua» attraverso livelli che caratterizzano i
diversi periodi dell’età evolutiva. Questa ipotesi viene negata da alcune correnti psicologiche che vi oppongono una concezione dello sviluppo come processo continuo.
Piaget concepisce lo sviluppo mentale come una «trasformazione discontinua» attraverso degli «stadi di sviluppo» che si succedono via via e che caratterizzano i diversi periodi
dell’età evolutiva, con transizioni che si verificano dopo lunghi stati stazionari, durante i quali sembra che non cambi nulla.
Questa osservazione, che può apparire per certi versi sconcertante, è rifiutata da alcune correnti di psicologia dello sviluppo, che ritengono che l’esperienza del mondo esterno, fluendo in modo incessante, comporti uno sviluppo continuo.
I sostenitori di tali correnti affermano che Piaget avrebbe osservato un campione di bambini non significativo, in quanto limitato per appartenenza ad una classe sociale culturalmente elevata, e quindi ricca di stimolazioni; lo psicologo svizzero avrebbe trascurato, quindi,
l’influenza dell’ambiente sociale in cui il bambino si trova immerso.
Le due affermazioni – sviluppo continuo e influenza dei rapporti sociali – sono state considerate di frequente come se appartenessero ad un’unica unità, ma in realtà, sebbene in entrambi i casi si prenda in considerazione il fattore «ambiente esterno», una cosa è la continuità o meno dell’esperienza e dello sviluppo, e altra è l’interazione con l’ambiente.
La prima, che prevede un fluire continuo dell’esperienza interiore, sembra non considerare in alcun modo l’uso originale che dell’esperienza esterna l’organismo può fare nella sua
crescita e l’eventuale procedere della rielaborazione con ritmi discontinui. Si tratta in fondo di una posizione molto vicina al behaviorismo di Skinner, per il quale non esiste l’evento mentale ma solo una sequenza di stimoli e risposte.
La seconda affermazione, che rimprovera a Piaget una generalizzazione indebita delle sue conclusioni e una scarsa attenzione alla diversità degli ambienti di sostegno, in realtà nulla dice circa la
presenza di transizioni brusche nello sviluppo cognitivo, ma semplicemente sottolinea l’importanza dell’interazione con l’ambiente, il rapporto con il mondo esterno, che è ipotesi compatibile – e in ogni caso confermata – sia con uno sviluppo continuo che con uno sviluppo discontinuo.
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
361
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
1.5Il modello delle reti neurali
La psicologia cognitivista ha elaborato un modello connessionista della conoscenza, il
modello delle reti neurali. Nella corteccia cerebrale i circuiti neuronali e le mappe che sostengono le reti di memoria si sviluppano a partire dai livelli inferiori, quelli differenziati e
strutturati per primi, e cioè dalle aree corticali sensoriali e motorie fino ai livelli superiori, le
aree corticali di associazione. Inferiore e superiore non rappresentano un giudizio di valore
come nel linguaggio comune, ma sono riferiti alla costruzione della mappa citoarchitettonica della corteccia, secondo la sequenza con cui avviene la maturazione.
Secondo l’ipotesi formulata dallo psicologo canadese Donald Hebb nel ’49, neuroni che vengono eccitati contemporaneamente una volta tenderanno a essere attivati insieme anche
in seguito, cioè a venire collegati. Ciò significa che la stimolazione di determinate reti neurali modifica la loro probabilità di venire alterate in futuro. Se un circuito è stato eccitato in
passato, la sua probabilità di esserlo nuovamente aumenta, in maniera direttamente proporzionale alla ripetitività della sua attivazione.
Ne deriva un modello di memoria distribuita, che avvalora l’ipotesi che la conoscenza
sia direttamente contenuta nelle connessioni interneurali e che sia questo ciò che
produce la successione dei pensieri (con altra terminologia, che fa evolvere le distribuzioni di attività).
2. Lo sviluppo del linguaggio
362
Il linguaggio è un sistema di segni che, usati in modi regolari di combinazione e secondo regole convenzionalmente stabilite, permettono di comunicare pensieri ed emozioni.
Il linguaggio è la capacità che caratterizza la specie umana rispetto a tutte le altre specie; infatti, nessuna specie animale possiede la complessità del linguaggio umano; gli animali certamente pensano e sono dotati di forme di comunicazione anche molto sofisticate, utilizzano codici che permettono loro di comunicare attraverso la trasmissione di diversi segnali,
ma non possiedono una grammatica e una sintassi.
Nel linguaggio possiamo individuare un dizionario di simboli (le parole), un insieme di regole (la grammatica), e un criterio con cui le parole sono unite in frasi (la sintassi); ogni lingua include unità di suono (fonemi), che vengono fuse in unità di significato (morfemi: le
singole parole, e anche suffissi e prefissi) per poi essere unite a formare le parole.
Il linguaggio è il codice di comunicazione e di riflessione mediante il quale l’esperienza soggettiva può essere condivisa in modo efficace e con precisione. In termini evolutivi, l’acquisizione del linguaggio e delle strutture del linguaggio ha rappresentato per le popolazioni
Cro-Magnon (in altre parole, noi) un indubbio vantaggio, rispetto per esempio alle popolazioni Neanderthal, la cui capacità di simbolizzare era molto più limitata.
Nello sviluppo mentale del bambino l’acquisizione del linguaggio ha un ruolo importante
come organizzatore e trasformatore dell’informazione che egli sta raccogliendo.
La comunicazione verbale si sviluppa gradualmente in una dinamica di interazione, generalmente con la madre, interazione nella quale ha un ruolo fondamentale la comunicazione
non verbale come lo sguardo, l’espressione del viso, certi movimenti ecc.
La complessità di questa interazione si può osservare facilmente durante l’allattamento; la
madre dialoga incessantemente, con lo sguardo, coi sorrisi, con quei vezzeggiamenti tipici
della prima infanzia la cui mancanza compromette grandemente lo sviluppo.
Dapprima il bambino emette dei suoni: p, b, m, t a, in relazione allo sviluppo neurologico e
muscolare; poi un balbettio, le prime sillabe («ma/ma») e intorno ai 12-18 mesi le prime
parole. Utilizza la grammatica dopo il primo anno, mentre il suo linguaggio diventa più ricco e si raffina in forme grammaticali e sintattiche corrette.
La relazione fra pensiero e linguaggio è uno dei temi più ampiamente discussi da psicologi,
psicolinguisti, linguisti e antropologi.
Il pensiero precede il linguaggio o ne dipende? Possiamo pensare perché sappiamo parlare, oppure possiamo pensare anche senza l’ausilio del linguaggio?
Poiché il linguaggio ha una stretta relazione con il pensiero, la funzione cognitiva del linguaggio è una funzione fondamentale e molti studi hanno affrontato questo tema.
Nell’ipotesi comportamentistica di Skinner il linguaggio è considerato solo uno dei tanti
comportamenti che l’individuo apprende mediante associazione tra stimoli ambientali e risposte, attività motoria appresa col condizionamento operante,
Nell’ipotesi del linguista e antropologo statunitense Benjamin Lee Whorf (1897-1941), detta del determinismo linguistico, il linguaggio determina il pensiero e il comportamento; i nostri pensieri sarebbero inseparabili dalle parole che usiamo per esprimerli, le quali costituiscono una specie di stampo per i processi logici e percettivi: la lingua, con le sue
strutture, determinerebbe la maniera di pensare e di percepire il mondo (relativismo
linguistico). Whorf riconduce l’origine del linguaggio interamente al contesto sociale e sostiene che, in ciascuna lingua, la struttura grammaticale non è soltanto uno strumento di
riproduzione per esprimere idee, ma essa stessa dà forma alle idee, è il programma a guida dell’attività mentale dell’individuo, dell’analisi delle sue impressioni, delle sintesi degli
oggetti mentali di cui si occupa. La struttura di una lingua influenza il modo di pensare del
parlante, quindi la sua cultura.
Sulla base delle sue ricerche antropologiche applicate in particolare alla lingua indiana hopi,
il linguista americano si rese conto dell’impossibilità di poter trasmettere in un altro idioma certi concetti; giunse perciò alla conclusione che le differenze delle lingue sono indicative di diverse concezioni del mondo, e quindi di differenze culturali (ipotesi della relatività linguistica). Chi «conosce» linguisticamente il mondo in un certo modo ne sarà influenzato di conseguenza, ovvero il linguaggio influenzerebbe la percezione e la memoria delle
cose, e quindi il pensiero.
2.1 La funzione simbolica del linguaggio in Piaget
Secondo il modello di sviluppo di Jean Piaget, il linguaggio dipende dal pensiero; l’acquisizione del linguaggio è inserita nella linea dello sviluppo cognitivo, non è altro che un sottosistema all’interno di una più generale capacità cognitiva, la «capacità simbolica», ed entrambi dipendono dall’intelligenza stessa, che è anteriore al linguaggio e indipendente da
esso. Il linguaggio ha una funzione ausiliaria nello sviluppo del pensiero. Piaget ha notato che il linguaggio ch’egli definisce «egocentrico» (ripetizioni ecolaliche o giochi di suoniparole, monologhi, monologhi collettivi, in cui il bambino coinvolge gli altri nell’azione, ma
senza preoccuparsi di essere ascoltato o compreso) cede progressivamente il passo a quello «socializzato».
Secondo Piaget, il linguaggio fa parte delle funzioni simboliche umane insieme ad altri processi dell’attività rappresentativa.
2.2 Il linguaggio sociale di Vygotskij
Per Lev Vygotskij (1896-1934) il linguaggio è sociale, e ha una funzione regolatrice del
pensiero, che è una costruzione sociale; per lo psicologo sovietico, linguaggio e pensiero hanno sequenze evolutive autonome, che si integrano poi in un processo di reciproco
influenzamento («il pensiero – scrive Vygotskij – non è semplicemente espresso in parole;
esso viene ad esistere attraverso di esse»).
Vygotskij distingue anche fra linguaggio comunicativo e linguaggio regolativo. Verso i tre
anni d’età il bambino usa il linguaggio come strumento per comunicare con gli altri, ma par-
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
363
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
364
la ad alta voce anche quando è da solo, come se il verbalizzare i pensieri lo aiutasse nel regolare le azioni.
Il linguaggio sarebbe innanzitutto sociale, e solo in seconda istanza verrebbe interiorizzato.
L’idea centrale di Vygotskij è che lo sviluppo psichico è guidato e influenzato dal contesto
sociale, e cioè legato al luogo e al momento storico in cui l’individuo si trova a vivere.
2.3Bruner: linguaggio come processo cognitivo
Per Jerome Bruner il linguaggio è un processo cognitivo: linguaggio e pensiero sono costruiti socialmente, cioè nella relazione, e primariamente nelle interazioni madre-bambino:
è la madre che insegna al bambino un uso intenzionale del linguaggio.
Bruner ritiene che tutti i processi di apprendimento riguardino la costruzione/assimilazione di un linguaggio adeguato ai fenomeni mentre li si osserva in una situazione socializzata
e socializzante, insieme al gruppo dei pari e degli adulti che svolgono un compito educativo e di trasmissione della cultura, con la messa a punto di un linguaggio analitico personale, ricco di sfumature, in grado di restituire in maniera ricca e coerente i processi analizzati.
2.4L’innatismo di Chomsky
La posizione innatista è espressa principalmente da Noam Chomsky, il quale ritiene che
ci sia un dispositivo innato nell’acquisizione del linguaggio dipendente dalla maturazione biologica.
Per Chomsky l’intelligenza umana dipende da «una struttura innata, sufficientemente ricca
da spiegare la disparità tra l’esperienza e la conoscenza». Chomsky distingue una struttura superficiale e una struttura profonda: l’una determina l’interpretazione fonetica, l’altra
ne specifica quelle funzioni grammaticali che svolgono un ruolo nel determinare l’interpretazione semantica.La competenza linguistica, che presiede all’uso effettivo di una lingua, è
l’abilità di assegnare strutture profonde e superficiali a un campo infinito di frasi, di correlare queste strutture in maniera adeguata e di assegnare un’interpretazione semantica e fonetica alle coppie di strutture profonde e superficiali. La competenza è, per Chomsky, la capacità di produrre frasi nuove, e si fonda su una grammatica universale.
Chomsky ristabilisce la priorità del pensiero nei confronti del linguaggio e, supponendo
strutture mentali innate, rivendica un ruolo attivo dell’individuo nel creare relazioni tra oggetti o enti, nel cercare analogie e regole nel flusso dei dati dell’esperienza. Chomsky parla di idee innate, ossia di una predisposizione genetica al linguaggio. Esisterebbe cioè un
meccanismo cerebrale chiamato LAD (Language Acquisition Device, cioè stratagemma di acquisizione del linguaggio) che permette di cogliere la struttura grammaticale della lingua.
Conoscere una lingua significa poter creare e riconoscere frasi che potrebbero non essere
mai state udite in precedenza.
Anche secondo Steven Pinker, psicologo di origini canadesi allievo di Chomsky, i centri sintattici del bambino sono geneticamente predeterminati. Egli ritiene che alla base del linguaggio esistano dei moduli innati della mente, geneticamente determinati, specializzati per comprenderlo e per produrlo, e sui quali si innesterebbe solo successivamente l’apprendimento «ambientale» di una particolare lingua: italiano, inglese, tedesco e così via. I
bambini verrebbero al mondo con una stessa «grammatica universale» e poi apprenderebbero una lingua specifica invece di un’altra; il motivo per il quale i neonati non sanno parlare fin dai primi istanti di vita risiede nel fatto che le strutture cerebrali che supportano il
linguaggio richiedono tre anni per maturare, ed hanno bisogno dell’attivazione fornita da
chi si occupa del bambino (caregiver).
Un ulteriore aspetto che distingue il linguaggio dal codice di segnali è la varietà delle lingue, ciascuna con le proprie regole e la propria struttura. Inoltre, ogni lingua corrisponde
ai concetti, ai valori, alle conoscenze di una determinata cultura, per cui per capire davvero
ciò che viene detto in un determinato idioma, non è sufficiente conoscerne il vocabolario,
ma acquisirne le logiche legate al contesto che lo determinano.
2.5 Linguaggio e strutture neurali La struttura lessicale e grammaticale delle diverse lingue è molto differente: dal punto di vista neurologico questo corrisponde alla formazione di differenti mappe neurali.
Una lesione in aree diverse provoca deficit differenti; una persona può essere in grado di capire perfettamente quello che le si sta dicendo ma non essere in grado di spiegarlo.
Ogni lingua, inoltre, ha una sua collocazione anatomica; un danno cerebrale in una certa
area potrebbe significare aver perso una capacità in una lingua e non in un’altra, può accadere di non aver perduto la capacità di comprendere le parole scritte ma non essere più in
grado di comprendere la lingua parlata o viceversa.
I neurofisiologi hanno individuato nell’emisfero sinistro, con l’area di Broca e l’area di Wernicke, le zone deputate rispettivamente alla produzione e alla comprensione del linguaggio; ma con le nuove tecniche di indagine si è potuto verificare come nella produzione del
linguaggio siano coinvolte molte altre aree.
Nell’emisfero sinistro vi sono strutture per l’elaborazione di parole e frasi e strutture di mediazione per i vari elementi lessicali e per la grammatica; un’area cerebrale diversa media
i verbi e un’altra i sostantivi. I concetti veri e propri vengono elaborati in gruppi di strutture neurali distribuite nei due emisferi in molte regioni sensoriali e motorie; per esempio le
aree attivate dall’ascolto delle parole sono diverse da quelle che sono attivate dalla visione
delle stesse parole e da quelle attivate dalla loro pronuncia. I gruppi di strutture neurali che
elaborano i concetti veri e propri sono distribuiti nei due emisferi in molte regioni sensoriali
e motorie; le aree attivate dall’ascolto sono diverse da quelle che sono attivate dalla visione
delle parole stesse e da quelle che corrispondono alla pronuncia, e così via.
Il linguaggio è rappresentato soprattutto nelle aree dell’emisfero sinistro, ma anche
l’emotivo emisfero destro concorre all’elaborazione dei concetti. Come è chiaro a tutte le
madri, i bambini avvertono sensazioni, emozioni, ma non hanno le parole per dirlo: compito della madre è quello di trovare la risposta, verbale o non verbale, a ciò che il bimbo prova, che per retroazione la inserirà nel proprio repertorio. I due emisferi non maturano contemporaneamente e comunicano tra di loro principalmente attraverso il corpo calloso, che
è un insieme di fibre nervose. Come per tutte le strutture neurali, sono le cure del caregiver a permetterne lo sviluppo.
L’emisfero sinistro è dominante riguardo al linguaggio, in particolare nell’uso della grammatica, nel ragionamento analitico, nella risoluzione di problemi, nella capacità di trarre inferenze e di interpretare. È inoltre maggiore la capacità di controllo dei movimenti fini di
dita, mani, braccia e dei muscoli legati all’esplicazione del parlare, dunque bocca e lingua.
Le aree che percepiscono le intonazioni della voce sono localizzate nel lato destro, in una
regione omologa all’area di Wernicke. Il loro ruolo è quello di elaborare la melodia del linguaggio, l’aspetto emozionale, quello cioè che utilizziamo per comunicare i nostri sentimenti.
Le persone che hanno subito danni all’emisfero sinistro, riescono molto spesso a sopperire
al loro deficit grazie alla comprensione degli aspetti «emozionali» dei discorsi, alla prosodia.
Si tratta dunque di una situazione molto complessa; nei casi di danni all’emisfero sinistro
si evidenzia in modo drammatico come il linguaggio venga danneggiato, ma anche come la
formulazione dei concetti non dipenda dal linguaggio stesso. Negli esperimenti split-brain
(ovvero dei cervelli divisi, condotti cioè su pazienti – solitamente epilettici – a cui era stato
sezionato il corpo calloso per impedire il passaggio dell’accesso epilettico da un emisfero
all’altro) venivano mostrate ai pazienti immagini all’emisfero destro, impossibilitato a pas-
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
365
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
366
sare le informazioni all’emisfero sinistro; si vide che essi non erano in grado di descrivere
verbalmente l’immagine, ma che ne avevano compreso il concetto rappresentato.
Il linguaggio dunque dà il nome alle cose, permette di formulare i concetti in modo chiaro, comunicabile e suscettibile di riformulazione: ma la formazione dei concetti precede il linguaggio.
Così come per tutte le funzioni neurali, anche l’acquisizione del linguaggio non dipende solo
da fattori trasmessi filogeneticamente, ma anche dai fattori ambientali. Se il bambino cresce
in un ambiente deprivato non svilupperà questa capacità; ma se verrà inserito in un contesto stimolante, e all’interno di quella determinata finestra temporale entro la quale può svilupparsi la funzione, potrà recuperare l’uso del linguaggio.
2.6Lettura e scrittura
Il pensiero si esprime non solo mediante le espressioni verbali, ma anche attraverso la scrittura, ed è sempre più evidente che, scrivendo, vengono migliorate le prestazioni cognitive
e anche quelle emotive; infatti, in un esperimento di psicoimmunologia, disciplina che mette in relazione i contenuti mentali con le risposte del sistema immunitario, venne chiesto
a venticinque studenti di scrivere per quattro giorni, per venti minuti al giorno, a proposito di esperienze traumatiche che avevano vissuto: i soggetti mostrarono un miglioramento
della risposta immunitaria, cosa che invece non si verificò in soggetti di controllo che dovevano scrivere di cose superficiali.
La scrittura è una forma di memoria esterna all’individuo, e consente di trasmettere un
numero pressoché infinito di conoscenze e di informazioni. Complementare alla scrittura è
la lettura, che è il processo che consente di comprendere lo scritto. Le due competenze si integrano tra loro ma richiedono abilità motorie, visive e di comprensione del linguaggio differenti, e coinvolgono regioni cerebrali diverse: infatti una lesione cerebrale corrispondente
ad esempio ad un evento ischemico potrebbe compromettere alcune delle abilità richieste
ma non altre, e ancora, si potrebbe imparare a leggere ma non a scrivere, così come accadeva
alle ragazze di certe regioni (così racconta Goethe nel suo Viaggio in Italia), cui la scrittura
era proibita; e inoltre la leggibilità della grafia è determinata dalla motricità fine della mano,
con tutte le difficoltà che ne derivano per i mancini, per cui è dominante l’emisfero destro.
Tutti gli esseri umani possiedono dei sistemi di scrittura, anche se questi sono molto differenti tra loro. Nel mondo occidentale viene utilizzato l’alfabeto latino, in cui ad ogni segno corrisponde un suono, e la lettura corre da sinistra a destra e dall’alto verso il basso;
non così in Cina e Giappone, dove si utilizzano ideogrammi, che sono caratteri grafici che
rappresentano una parola o un concetto e la lettura è da destra a sinistra; i sistemi di scrittura arabo ed ebraico, invece, si basano solo sulle consonanti. Inoltre, mentre in italiano e
in tedesco è diretta la corrispondenza tra fonema e grafema (dove il grafema è il segno e
il fonema è il suono che vi corrisponde), per altre lingue, come ad esempio l’inglese, è necessario memorizzare con precisione la grafia corrispondente ad ogni parola, cosa che rende più complesso l’apprendimento della scrittura e della lettura, per cui nelle scuole degli
Stati Uniti sono frequenti le gare di spelling, sillabazione di parole, proprio per questa difficile corrispondenza. Cosa che, quando viene rappresentata in un film, risulta ovviamente incomprensibile agli spettatori italiani, per i quali sillabare una parola è compito relativamente semplice.
C’è un linguaggio, quello della matematica, che essendo nato per convenzioni condivise dopo
l’adozione della numerazione araba, è compreso in tutto il mondo, poiché i suoi significati sono legati all’identico concetto condiviso in ogni paese: questa particolarità ha fatto immaginare a molti uomini di scienza che il linguaggio matematico avrebbe permesso una comunicazione priva di conflitti.
Nel processo di lettura e scrittura si possono distinguere due aspetti; uno più propriamente tecnico (o strumentale) e un aspetto testuale, che corrispondono ad abilità differenti, che
«maturano» in tempi diversi.
La competenza tecnica corrisponde alle abilità che permettono la trasposizione e il riconoscimento grafici (per esempio, l’ortografia), e richiede competenze che divengono gradualmente più fini.
L’abilità testuale è invece la capacità di produrre e/o comprendere testi con un significato,
e impiega competenze di tipo cognitivo e metacognitivo.
La scrittura e la lettura richiedono un percorso di apprendimento piuttosto lungo, che si articola in una serie di fasi, nelle quali il bambino sviluppa abilità sempre più perfezionate.
Secondo la psicologa britannica Uta Frith il bambino giunge al possesso delle regole linguistiche attraverso quattro stadi.
In questo modello di apprendimento della lettura si ipotizza che i bambini passino da una
totale ignoranza dei rapporti tra linguaggio orale e linguaggio scritto all’automatizzazione
dei processi di lettura secondo un andamento gerarchico, dove ogni stadio è premessa per
l’accesso allo stadio successivo.
Questi stadi sono:
— stadio logografico o ideografico: coincide con l’età prescolare ed è la fase in cui il bambino riconosce alcune parole in base alla presenza di elementi (forma, colore, lunghezza, forma fonologica, ecc.) che ha imparato a discriminare, ma ancora non ha conoscenze sulla struttura ortografica e fonologica della parola;
— stadio alfabetico: si presenta durante la prima scolarizzazione, quando il bambino apprende l’esistenza di una forma orale e una forma scritta della parola; è in grado di leggere anche parole che non conosce e impara a sillabare le parole che incontra riconoscendo l’esistenza dei fonemi;
— stadio ortografico: il bambino perfeziona il meccanismo di conversione grafema/fonema, e impara che la combinazione delle lettere nelle parole non è casuale e illimitata ma
è regolamentata dalle regole ortografiche e sintattiche della lingua;
— stadio lessicale: con l’automatizzazione della lettura e della scrittura, il bambino abbandona il meccanismo di conversione grafema/fonema, e legge le parole già note accedendo direttamente alla forma fonologica della parola.
Secondo questo modello, la completa acquisizione delle prime tre fasi renderebbe possibile
il raggiungimento della quarta, che permette al bambino di leggere o scrivere le parole conosciute senza bisogno di operare la conversione grafema-fonema.
2.7 I disturbi del linguaggio
La dislessia è un deficit dell’apprendimento che ha presumibilmente origine neurobiologica, ed è caratterizzata dalla difficoltà di lettura e di scrittura, in particolare nell’ortografia.
Dobbiamo però distinguere tra la dislessia acquisita, che è conseguenza di un danno cerebrale che può coinvolgere diverse abilità (per esempio non essere più in grado di leggere, ma avere ancora la capacità di scrivere, oppure non comprendere il significato delle
parole) a seconda delle aree danneggiate, e la dislessia evolutiva, che si manifesta in età
scolare, la cui conseguenza principale è un possibile ritardo dell’apprendimento scolastico, ma che può avere diversi aspetti. Per esempio può essere presente una difficoltà nella
discriminazione di grafemi simili per forma ma diversamente orientati nello spazio, come
le lettere «p» e «b», oppure «d» e «q»; oppure nella discriminazione di grafemi che presentano somiglianze, come «m» con «n», «c» con «e»; oppure nella discriminazione di grafemi
che corrispondono a fonemi con somiglianze percettivo-uditive; o ancora difficoltà di decodifica sequenziale, perché invece di procedere con lo sguardo in direzione sinistra-de-
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
367
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
368
stra e dall’alto in basso, come richiede la lettura nel nostro sistema occidentale, se ne inverte il senso; infine, si possono invertire le sillabe, leggendo per esempio «li» al posto di «il».
I bambini dislessici hanno difficoltà ad imparare l’alfabeto, le tabelline o altre sequenze come
i giorni della settimana o i mesi.
Spesso alla dislessia, per le stesse ragioni, si associano disgrafia (disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di segni alfabetici e numerici), disortografia (difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto) e discalculia (fatica nello svolgere calcoli aritmetici, per la difficoltà a interpretare correttamente la
posizione dei numeri).
Le conseguenze di questo disturbo non sono solamente di ordine culturale e di apprendimento; spesso comportano oltre al disagio psichico facilmente comprensibile, l’emarginazione e l’esclusione sociale.
3. L’intelligenza
Nel 1904 il Ministero della Pubblica Istruzione francese incaricò una commissione di studiare dei metodi per l’educazione dei bambini delle scuole di Parigi che presentavano uno
sviluppo intellettivo inferiore alle attese: si pensava che se fosse stato possibile accoglierli
in scuole speciali, quei bambini, incapaci di seguire il normale percorso di studi, avrebbero
potuto raggiungere risultati migliori. Di questa commissione faceva parte anche lo psicologo Alfred Binet (1857-1911), che sarebbe divenuto noto come inventore del primo test
di intelligenza.
Per individuare il livello medio di intelligenza, Binet e i suoi collaboratori trascorsero un
gran numero di ore tra i bambini delle scuole, osservando e sottoponendo loro dei quesiti
di vario tipo. Dalle loro risposte, Binet e il suo assistente Simon, elaborarono la prima scala
metrica. La scala era composta da una serie di trenta problemi, che si proponevano di offrire una valutazione di alcuni aspetti dell’intelligenza, come la capacità di comprensione,
di ragionamento logico e di giudizio. I problemi erano stati scelti in modo da ridurre al minimo la ripetizione di nozioni apprese a scuola.
Binet introdusse il concetto di età mentale, che corrisponde alla capacità di rispondere
correttamente alla metà dei quesiti risolti normalmente dai bambini di una data età (l’intelligenza corrisponde ai quattro anni se il bambino supera almeno la metà dei test preparati per quell’età).
Per definire il livello d’intelligenza viene utilizzato un indicatore chiamato Quoziente di intelligenza (QI); tale indice viene calcolato, per un determinato individuo, in base ai risultati
di un insieme di prove (item) che compongono i cosiddetti test d’intelligenza. Il valore viene
ottenuto dividendo l’età mentale (l’età in cui la media delle persone della stessa età cronologica riesce ordinariamente a superare un determinato gruppo di problemi) con l’età reale del soggetto in esame, moltiplicato per 100 e arrotondato all’intero.
Un bambino di 6 anni che risponda esattamente almeno alla metà dei quesiti preparati per
soggetti di 8 anni, avrà un quoziente d’intelligenza pari a: QI = 8/6x100 = 133.
Ovviamente questi prime valutazioni andavano bene solo per i bambini, perciò furono sostituite da test elaborati per gli adulti, per i quali non ha senso parlare di età mentale. Da
un punto di vista statistico, se un test d’intelligenza è stato ben tarato, e cioè testato su un
gran numero di prove applicate a un campione sufficientemente ampio di popolazione, darà
questi seguenti risultati:
— il 25% della popolazione si trova al di sotto di 90 (il 21,5% ha un QI compreso tra 90 e
70, il 3,5% si colloca al livello inferiore a 70);
— il 50% della popolazione presenta un QI compreso tra 90 e 110;
— il 25% della popolazione si trova al disopra di 110 (il 21,5% di individui va da 110 a 130,
il 3% da 130 a 140 e solo lo 0,5% supera un punteggio di 140).
La misura del QI effettuata tramite gli usuali test di intelligenza è riferita alle tradizionali capacità logico-matematiche, verbali e spaziali, ma questo tipo di misurazione ha validità solo
se il soggetto appartiene alla stessa popolazione dei soggetti su cui il test è stato standardizzato; inoltre, valutando solo alcuni aspetti delle capacità mentali, tali test possono produrre risultati ingannevoli sia dal punto di vista predittivo che dell’apprendimento scolastico.
L’intelligenza basata sulla pura razionalità costituisce soltanto un aspetto delle più generali capacità che permettono all’uomo di misurarsi con la vita di tutti i giorni e di risolvere i
problemi che essa presenta.
Su un piano neurofisiologico, i recenti studi del neuro scienziato portoghese Antonio Damasio dimostrano come la capacità di scegliere la soluzione migliore non derivi da una attenta disamina razionale dei pro e dei contro relativi alle diverse alternative possibili; infatti, le facoltà razionali si appoggiano all’apparato emotivo, perché le emozioni ben regolate
che si dispiegano in corrispondenza di un evento che richieda una decisione derivano dalla
memorizzazione dell’insieme di sensazioni ed emozioni che corrispondono alle soluzioni
che si erano rivelate più efficaci, permettendo una decisione rapida e adeguata.
3.1 Le forme dell’intelligenza
Da un’idea iniziale di intelligenza come competenza riconducibile a un unico fattore razionale si è passati gradualmente a una concezione più ampia, che riconosce la presenza di diverse componenti. Negli ultimi anni ha acquisito progressivamente grande importanza l’intelligenza emotiva, che corrisponde alla capacità di percepire e di conseguenza utilizzare al
meglio le proprie emozioni e comprendere ciò che provano gli altri.
Il costrutto di intelligenza emotiva è stato elaborato tra il 1989 e il 1990 dagli psicologi
Peter Salovey e John Mayer, che la definirono originariamente come «la capacità di monitorare le proprie e le altrui emozioni, di differenziarle e di usare tale informazione per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni», e più recentemente come «la capacità di pensare sui sentimenti».
3.2 Le intelligenze multiple di Gardner
Howard Gardner ha elaborato una teoria dell’intelligenza, detta delle intelligenze multiple; nel delineare questa teoria, Howard Gardner descrisse nel 1983 due forme di intelligenza personale: l’intelligenza intrapersonale, come capacità di comprendere la propria
vita affettiva, e l’intelligenza interpersonale, come capacità di comprendere gli stati d’animo, le intenzioni e i desideri altrui.
Gardner considerava queste due forme di intelligenza come abilità biologicamente fondate
e intimamente intrecciate. Queste abilità fondamentali dell’intelligenza personale sono centrali nel costrutto di intelligenza emotiva, che comprende la percezione e la considerazione
dei comportamenti emotivi non-verbali, incluse le sensazioni corporee evocate dall’attivazione emozionale, le espressioni facciali, il tono della voce e la gestualità esibita dagli altri.
Dopo aver effettuato indagini sull’intelligenza dei bambini e su adulti colpiti da ictus, Gardner
concluse che esiste un numero variabile di facoltà relativamente indipendenti tra loro, e
identificò almeno sette differenti tipologie di intelligenza:
1. intelligenza logico-matematica, implicata nel confronto e nella valutazione di oggetti
concreti o astratti, nell’individuare relazioni e principi;
2. intelligenza linguistica, che si esprime nell’uso del linguaggio e delle parole, nella padronanza dei termini linguistici e nella capacità di adattarli alla natura del compito;
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
369
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
3. intelligenza spaziale, usata per percepire e rappresentare gli oggetti visivi, rielaborandoli mentalmente anche in loro assenza;
4. intelligenza musicale, che si rivela nella composizione e nell’analisi di brani musicali e
nella capacità di discriminare con precisione altezza dei suoni, timbri e ritmi;
5. intelligenza cinestetica, che consiste nel controllo e nel coordinamento dei movimenti del corpo e nella manipolazione degli oggetti per fini funzionali o espressivi;
6. intelligenza interpersonale, ovvero l’abilità di interpretare le emozioni, le motivazioni e gli stati d’animo degli altri;
7. intelligenza intrapersonale, espressa nel comprendere le proprie emozioni e incanalarle in forme socialmente accettabili.
A questi tipi di intelligenza, Gardner ha aggiunto successivamente l’intelligenza naturalistica, relativa al riconoscimento e alla classificazione di oggetti naturali; egli ipotizza inoltre l’esistenza di una nona forma di intelligenza, l’intelligenza esistenziale, che riguarderebbe la capacità di riflettere sulle questioni fondamentali concernenti l’esistenza e, più in
generale, nell’attitudine al ragionamento astratto per categorie concettuali universali.
La teoria delle intelligenze multiple prevede che i diversi tipi di intelligenza siano presenti in tutti gli esseri umani, e che la differenza tra le relative caratteristiche intellettive e prestazioni vada ricercata unicamente nelle rispettive combinazioni dei vari fattori.
4. Lo sviluppo affettivo
370
È necessario risalire al primo anno di vita del bambino, per cogliere le tappe e i tratti decisivi dello sviluppo affettivo: assume particolare rilevanza, fin dall’inizio, la qualità del rapporto madrebambino, come hanno evidenziato i numerosi studi della psicologia contemporanea sui primi
anni di vita del bambino. Il senso di sicurezza, necessità psicologica fondamentale per il processo di sviluppo affettivo e sociale, si costruisce in un clima di serenità e in presenza di atteggiamenti di disponibilità a soddisfare i bisogni del bambino, in primo luogo quello di essere amato.
Fino all’età di due o tre anni le manifestazioni emotive sono predominanti e intense e si evolvono sia con l’avanzare del processo di maturazione intellettuale, sia con le rassicurazioni esterne.
La conquista dell’autonomia motoria (intorno ai 15 mesi), con il conseguente avanzare del
processo di adattamento al mondo esterno, segna una tappa importantissima non solo per
l’ampliarsi delle possibilità di esplorazione della realtà circostante, ma anche per l’allargamento delle relazioni con altri membri della famiglia, tra cui — in primo luogo — il padre,
che comincia a diventare per il bambino fonte di sicurezza e di ammirazione, soprattutto se
ne avverte la presenza nell’attività di gioco.
Intorno ai 2-3 anni il bambino mostra atteggiamenti di grande curiosità (l’età dei «perché»),
bisogno di autoaffermazione (io) e momenti di aggressività: solo con la guida, né troppo rigida né eccessivamente permissiva dei genitori, il piccolo imparerà ad affrontare situazioni
nuove e stimolanti, sperimenterà il successo, ma anche l’insuccesso, senza subire frustrazioni insostenibili, comincerà a canalizzare gli atteggiamenti di violenza o collera verso gli
altri, scaricando le tensioni in attività sostitutive.
Con l’ingresso nella scuola dell’infanzia, all’età di 3 anni, il bambino affronta una nuova realtà, nuove relazioni e sperimenta il primo distacco dalla madre e dalla famiglia: in questa fase,
oltre all’incalzare dei mille «perché» con cui il bambino non vuole soddisfare solo esigenze
intellettive, ma anche bisogni affettivi di amicizia e di sicurezza, comincia a emergere quella
problematica definita conflitto edipico che gradualmente egli risolve (nell’alternanza di sentimenti di amore-odio verso il genitore dello stesso sesso, vissuto come rivale, nella conquista del genitore del sesso opposto) attraverso l’identificazione con il modello di riferimento
(la madre per la femminuccia, il padre per il maschietto), purché questi sia rassicurante, positivo, gratificante.
In questo stadio di sviluppo affettivo è, altresì, determinante una buona identificazione con l’insegnante che agevola sia la conquista dell’identità e dell’autonomia, sia quella della competenza.
Con l’inizio della scuola primaria la vita affettiva del fanciullo assume via via caratteri più
sfumati, sia per l’instaurarsi di modalità di autocontrollo, sia per l’evolversi dell’egocentrismo a favore di una maggiore obiettività e razionalità e di una più sviluppata capacità di entrare in relazione con gli altri.
Nel processo di identificazione, avviato in precedenza nella famiglia e nella scuola dell'infanzia, si inseriscono più modelli di identificazione, con conseguenti problemi a cui, solo con
gli atteggiamenti di intesa degli insegnanti è possibile ovviare: è necessario, infatti, non solo
garantire l’unità del progetto formativo, ma — sulla base della comune conoscenza dei tratti di personalità del gruppo/classe e del singolo alunno — assumere comportamenti e atteggiamenti coerenti, creare un’atmosfera di positiva considerazione, offrire gratificazioni
e fiducia, proporre valori sociali di tipo democratico (rifuggendo sempre da atteggiamenti
di autoritarismo e permissivismo).
La vita affettiva nell’età della preadolescenza e, poi, dell’adolescenza, assume sempre più
carattere di stabilità, sia per l’affermarsi della volontà, sia per la forte valorizzazione dell’io,
sia per l’emergere del pensiero ipotetico-deduttivo.
5. Il processo di socializzazione
Quando inizia la sua esperienza scolastica, il bambino ha già cumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, morali e sociali . Il patrimonio
di valori e di esperienze si costruisce e si arricchisce grazie a quel processo di socializzazione mediante il quale l’individuo entra in contatto con l’ambiente circostante e, attraverso
condotte di adattamento continuo, sviluppa comportamenti sociali e morali, oltre che affettivi e cognitivi. Fino ai due anni di età assumono grande rilevanza, anche per questo aspetto, la qualità del rapporto madre-bambino, la relazione con il padre e quello con i fratelli e
con i nonni presenti nel nucleo familiare. La famiglia, in primo luogo, assolve al compito di
iniziazione alla vita sociale, avviando gradualmente il bambino alla scoperta di sé, alla introiezione di valori, all’autonomia.
Un fattore molto importante per una socializzazione positiva è dato dalle cure materne, non
tanto in termini di durata, quanto di «qualità», cioè in termini di capacità di infondere sicurezza in modo equilibrato, senza eccedere in atteggiamenti iperprotettivi o di rifiuto più o
meno inconscio. A causa del lavoro extradomestico della madre, inoltre, e della conseguente trasformazione dei ruoli materno e paterno nella società contemporanea si è rafforzato
quello del padre che è maggiormente coinvolto nei problemi della casa ed è più disponibile a prendersi cura dei figli.
L’eventuale nascita, poi, di altri figli può rendere più complesse le relazioni all’interno della famiglia, se la naturale gelosia e rivalità non si affrontano con adeguate premure e attenzioni da parte dei genitori.
Intorno ai 2-3 anni il bambino sente un bisogno di compagnia e ricerca i coetanei, seppure per scambi comunicativi approssimativi, a causa dell’egocentrismo: la frequenza della scuola dell’infanzia diventa, quindi, essenziale per favorire l’avvio alla socializzazione,
consentendo al bambino di sperimentare dapprima forme di cooperazione nei piccoli gruppi che — se pure di breve durata — lo aiutano a superare con gradualità conflitti e tensioni,
facendo leva sia sull’attività di gioco, sia sulla presenza mediatrice degli insegnanti. Il dover
risolvere situazioni di conflitto con gli altri, porta il bambino ad assumere comportamenti
via via più adeguati a norme che gli provengono dagli adulti: con l’imitazione, infatti, egli incomincia ad accettare le regole, la sua però è ancora una morale eteronoma basata sull’obbedienza e non ancora sull’indipendenza dal modello-adulto.
C o n o s c e n z e f o n da m e n ta l i
d e ll a p s i c o l o g i a d e ll ’ e t à
e v o l u t i va
C4
371
P a r t e II - L a s c u o l a p r i m a r i a
Sezione prima
Libro I
Teoria
372
Un’esperienza prescolastica fondata su significative relazioni emotivo-affettive, stimolanti sul versante cognitivo, agevolerà senz’altro il passaggio alla scuola primaria, soprattutto se i genitori e gli insegnanti delle due scuole sapranno impostare rapporti di reciproca fiducia e di collaborazione.
Nell’età in cui i bambini frequentano la scuola primaria, continua quel processo di identificazione con altri modelli (gli insegnanti) che, se positivi, favoriscono comportamenti di autocontrollo e motivazione ad apprendere.
Condizionamenti socio-economici negativi, esperienze poco stimolanti (in famiglia e nell’ambiente) sul piano relazionale, la stessa scuola — con l’eventuale adozione di metodi di tipo
passivo o con atteggiamenti autoritari da parte degli insegnanti — possono ostacolare il processo di socializzazione ed essere, perciò, causa di quelle diversità che potrebbero sfociare,
poi, in vere e proprie forme di disadattamento, cioè di disequilibrio rispetto all’ambiente
esterno o, peggio ancora, in vere e proprie diseguaglianze sul piano sociale e civile, se non si
interviene precocemente, con strategie personalizzate, di arricchimento e di compensazione.
5.1La funzione della scuola nel processo di socializzazione
La scuola ha tra i suoi fini quello di educare alla società, La formazione del futuro cittadino è un processo che inizia già nel primo ciclo. «È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di ap­prendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di coope­razione
e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo
di un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi
che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile» (Indicazioni nazionali) .
Lo sviluppo della dimensione sociale della personalità presuppone uno stretto rapporto tra
individuo e società, che si instaura fin dai primi mesi di vita, attraverso le relazioni primarie
all’interno della famiglia e, successivamente, con altri adulti e coetanei nella scuola: la relazionalità significativa è alla base di uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della personalità, da quello affettivo, a quello cognitivo, a quello morale, a quello fisico. Il processo
di identificazione è strettamente connesso a quello di socializzazione ed entrambi vengono
favoriti da modelli comportamentali «autorevoli», da esperienze affettive positive, da condizioni economiche e sociali stimolanti. Il benessere psico-fisico è condizione per uno sviluppo armonico che riguardi sia il corpo, sia il rapporto con gli altri e con l’ambiente esterno: educare alla salute significa, pertanto, condurre l’allievo alla stima di sé e al rispetto degli altri, assumendo responsabilità personali e sociali, per sentirsi costruttivamente inserito nella società di cui la scuola è importante laboratorio formativo.