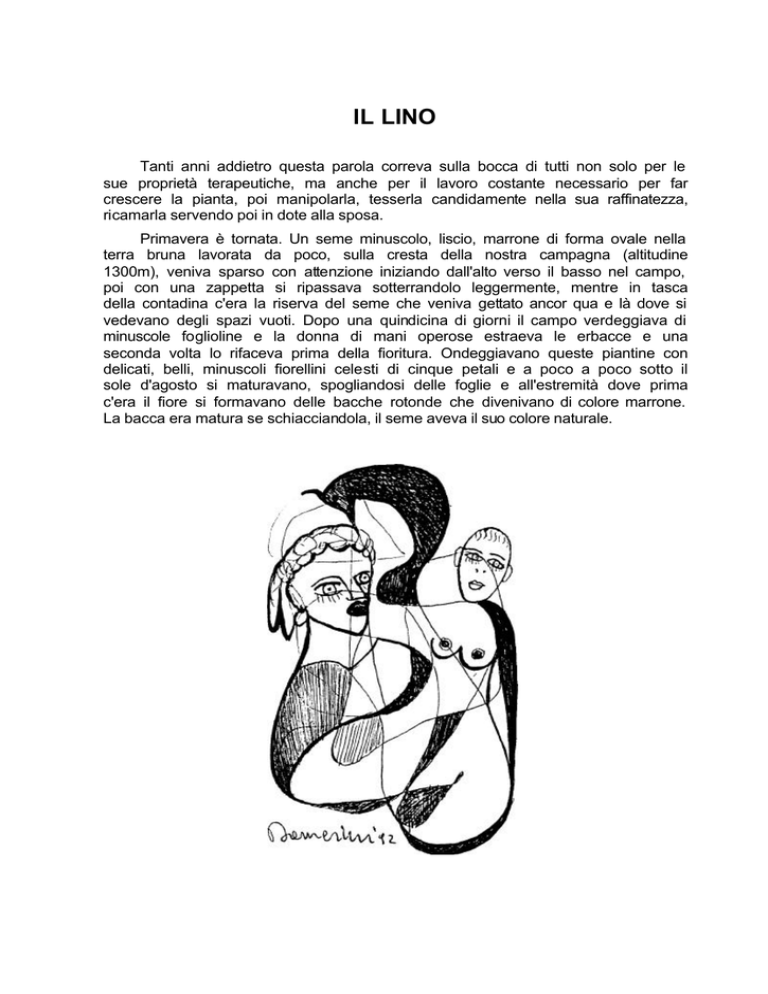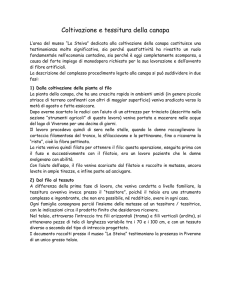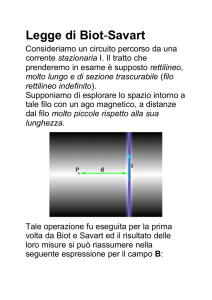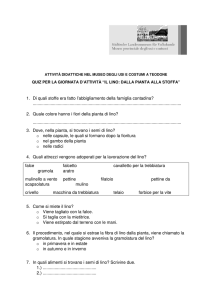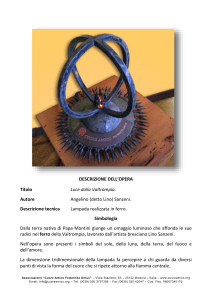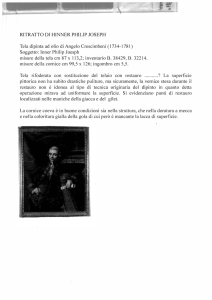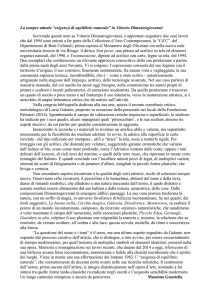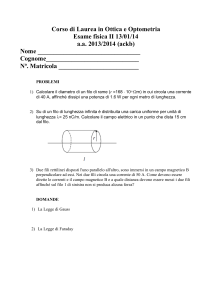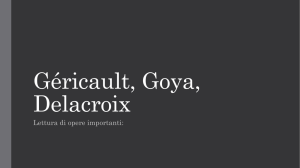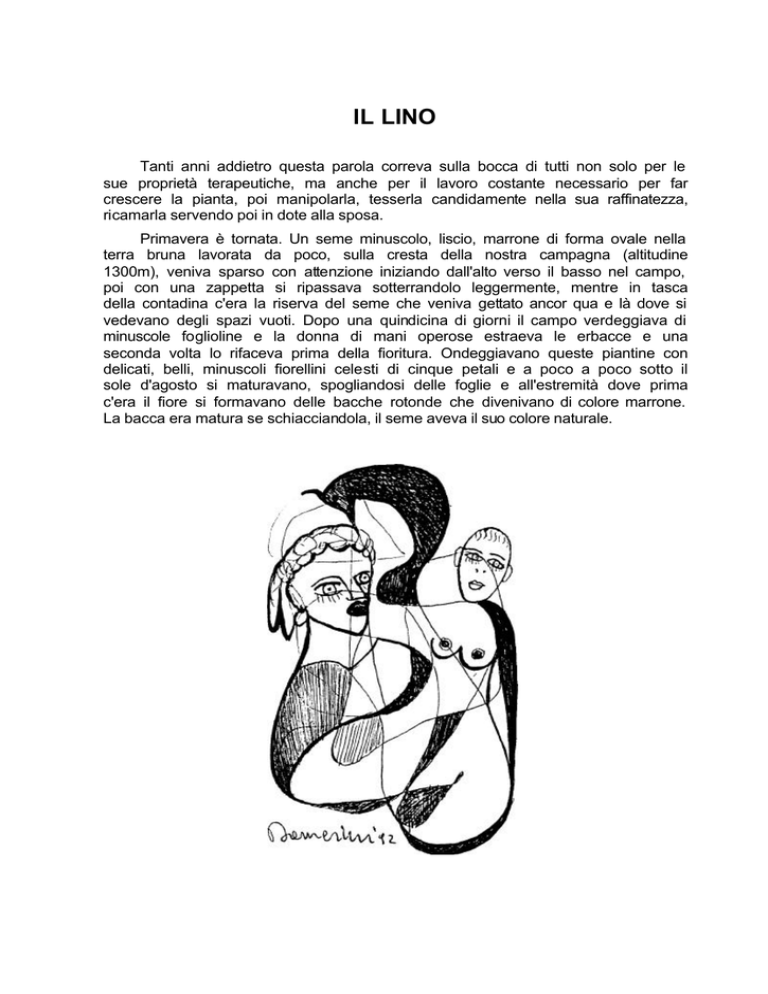
IL LINO
Tanti anni addietro questa parola correva sulla bocca di tutti non solo per le
sue proprietà terapeutiche, ma anche per il lavoro costante necessario per far
crescere la pianta, poi manipolarla, tesserla candidamente nella sua raffinatezza,
ricamarla servendo poi in dote alla sposa.
Primavera è tornata. Un seme minuscolo, liscio, marrone di forma ovale nella
terra bruna lavorata da poco, sulla cresta della nostra campagna (altitudine
1300m), veniva sparso con attenzione iniziando dall'alto verso il basso nel campo,
poi con una zappetta si ripassava sotterrandolo leggermente, mentre in tasca
della contadina c'era la riserva del seme che veniva gettato ancor qua e là dove si
vedevano degli spazi vuoti. Dopo una quindicina di giorni il campo verdeggiava di
minuscole foglioline e la donna di mani operose estraeva le erbacce e una
seconda volta lo rifaceva prima della fioritura. Ondeggiavano queste piantine con
delicati, belli, minuscoli fiorellini celesti di cinque petali e a poco a poco sotto il
sole d'agosto si maturavano, spogliandosi delle foglie e all'estremità dove prima
c'era il fiore si formavano delle bacche rotonde che divenivano di colore marrone.
La bacca era matura se schiacciandola, il seme aveva il suo colore naturale.
La raccolta: veniva strappata la pianta con la radice e si facevano dei mazzetti i
quali venivano legati dalle stesse piantine. Terminata questa fase di raccolta si
portavano nel
fienile e sulle stanghe del "pnizu", si adagiavano i mazzetti a cavalcioni uno
accanto all'altro con le bacche all'ingiù, cosicché la pianta terminava di asciugarsi e
maturarsi. Venivano poi tolte e messe sopra ad un grosso ceppo di legna, e con un
attrezzo fatto apposta per questo mestiere, si battevano le bacche per privarle del
seme. Fatta la sfasciatura dei prati in un posto un po' pianeggiante, veniva steso il
lino a ragnatela formando un bel quadrato ed ad ogni angolo si incrociavano delle
piantine annodando come segno di Croce, come simbolo di protezione delle
calamità. Le buone rugiade e il sole insieme alle piogge autunnali facevano macerare
le piante e si raccoglievano quando, strofinando, si staccava la paglia dallo stelo.
In paese più o meno si potevano contare dieci campi di lino, cioè dieci
produttori, perciò le donne da buone comari si mettevano d'accordo, anche perché
l'unione fa la forza, e nelle
giornate prescelte prima della neve, tutte o quasi, con il loro arnese detto
"gramula" e il fascio del lino si recavano dov'era la fornace. Questa era una buca
scavata apposta dalle dimensioni di 1 m di profondità, 1,5 m di lunghezza e 1m di larghezza dentro la quale si faceva il fuoco affinché venisse un buon braciere: sopra si
poneva una grata fatta di legno e su questa si mettevano le manciate di ilno. La
donna scelta per questo lavoro doveva essere agile e maneggiare con prontezza
girando e rigirando, perché una minima scintilla sarebbe bastata per appiccare fuoco
e mandare in fumo tutto il lavoro. Così facendo si asciugava e, ancora caldo,
passava dalla prima donna e via a tutta la fila, finché per ultimo doveva diventare più
o meno come una grossa treccia sciolta bionda. In quel frastuono di gramule che
risuonava dalle forti e laboriose braccia, si lenivano le fatiche con risate, barzellette e
canzonette.
Calata la sera, si rincasava per riprendere l'indomani se questo giorno non era
bastato. Poi veniva usato anche il "garzin". Si poteva usarlo anche in casa in fondo ai
grandi
corridoi oppure, meglio ancora, nel cortile ai tiepidi raggi di sole. Una manciata
dopo l'altra, si tirava attraverso i chiodi del garzin per separare il lino e la stoppa. Il
lino è la parte migliore della pianta, mentre la stoppa è più grezza. Con tanta
pazienza il lino era pronto per filare; la filatura durava tutto l'inverno a seconda della
quantità. Si avvolgeva sulla rocca un attrezzo a forma di cono fatto apposta e poi per
ore ed ore a pedalare il corletto facendo crescere il filo sul fuso, si bagnavano le dita
con la saliva, pollice e indice, e si tirava torcigliando per uguagliare il filo. La
canzonetta della filatrice:
"Tutti quanti filan lana, sol che io filo lin,
tutti quanti si smarida sol che iò sto S. Martin.
Sette dì a filar un fuso sette pan a far saliva,
perché tutti quanti si smarida sol che là sto S. Martin".
Dal fuso si passava all'arcolaio, detto "didaspal" in matasse abbastanza grandi
uguali. Ora si procedeva alla cottura del filo. Le cosiddette "scivere" si potevano
trovare in affitto qua e là per qualche giorno: si trattava di un grosso forno a pietre,
meglio mattoni con sopra una grande caldaia. In fondo alla caldaia si ponevano due
bastoni incrociati perché il filo non tocchi il fondo, poi un altro bastone grosso nel
mezzo, attorno a questo si adagiavano le matasse, uno strato di filo, uno strato di
cenere possibilmente d'abete e così via; si aggiungeva poi acqua abbondantemente
e si accendeva il fuoco facendo bollire per almeno quattro ore; quindi lasciare riposare per tutta la notte e anche di più. Diverse erano allora le fontane in paese,
quindi ci si recava nella più vicina con un grande mastello di legno; si riempiva
d'acqua che correva lungo la "salera" (gronda di legno) legata al "curnon" (getto) e
poi con la "breia da lavà" (asse) si passavano ad una ad una le matasse facendo
uscire tutta la cenere. Ore ed ore in quell'acqua gelida ed ogni tanto per scaldare le
mani le si sbatteva ai fianchi con energia, oppure si mettevano un po' di tempo sotto
le ascelle. Come se non bastasse la ruvidità faceva sanguinare i polsi della
lavandaia.
A Casamazzagno per la precisione viveva un sig. Festini Tela Antonio che
possedeva un grande telaio e che dedicò tutta la sua vita ordendo e tramando
metraggi di tela e per chiunque lo faceva con passione. Dopo aver "disdodu" le
matasse e fatto gomitoli si portava da lui con un pezzo di sapone e farina bianca da
pane che gli occorreva per fare la "bodme" (amido) facendo correre i fuselli e tirare
uniforme la tela. Il costo era onesto in più si lasciavano le frange della tela che poi
annodate si lavora dell'altra.
Dal rotolo di tela si tagliava, più che altro lenzuola, poi di nuovo cucite con un
punto detto piede di gallina perché non si disfi e agli angoli una grossa asola. Poi
veniva nuovamente lavata, insaponata e stesa sul prato; nelle asole s'infilavano dei
bastoncini perché rimanesse ben distesa per diversi giorni, finché diventava
sufficentemente candida. Tutto questo era il lavoro per possedere alcune paia di
lenzuola; fortunata era la sposa che possedeva queste lenzuola.
Ecco perché questa tela di fibra naturale e di grande durata è così preziosa e
adoperata da diverse generazioni. Per questo ora è molto ricercata ed apprezzata.
ottobre 1990