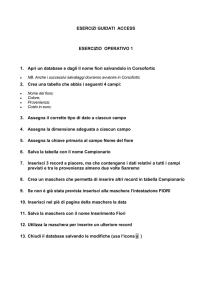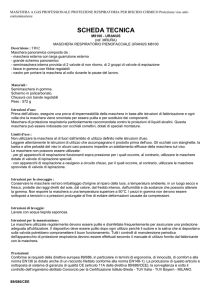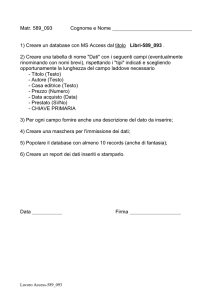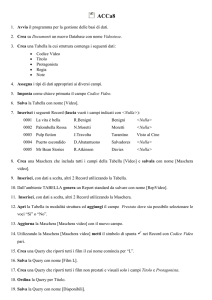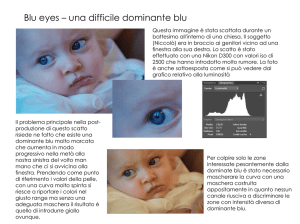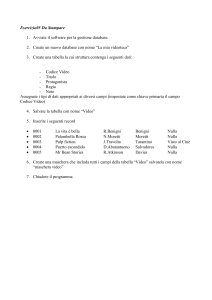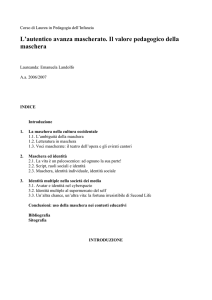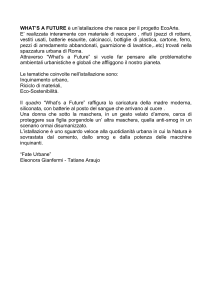Post-fazione
Attraverso la maschera.
Rappresentazione e riconoscimento
di Roberta Sassatelli
Se è vero, come scriveva già Hobbes nel Leviatano, che non c'è alcuna regola comune di ciò
che è buono o cattivo che sia derivata dalla natura degli oggetti stessi, è altrettanto vero, che spesso
sentiamo di esistere quando ci misuriamo con gli oggetti e la resistenza che essi ci offrono,
prendendo distanza dal loro essere cose, o usandoli come mezzi convenzionali e ben riconoscibili
per comunicare con gli altri. L’essere umano sembra trovarsi nella condizione del Cavaliere
Inesistente di Calvino, Agilulfo, che per sentirsi vivo ha sempre bisogno di fronteggiare le cose,
perché solo in piena luce, con colori vividi e contorni definiti, queste si offrono a lui come un muro
contro cui infrangere la propria volontà, e come uno schermo attraverso cui fare emergere un
barlume di certezza della propria coscienza. E quale oggetto esemplifica meglio di una maschera
una simile necessità di fissare, attraverso il continuo incontro/scontro con la cultura materiale
convenzionalizzata, il proprio essere soggetto? La maschera è un oggetto culturale primordiale ed
essenziale che svolge un fondamentale ruolo di mediazione tra persona e ruolo, tra esperienze
intime e rappresentazione pubblica, tra identità individuale identità collettiva. Come ci ricorda
Pizzorno, le culture umane hanno sempre costruito maschere, oggetti rituali che funzionavano come
ponti verso il sacro, che permettevano di incarnare una identità pubblica collettivamente
riconoscibile, consentendo così di alludere ad una identità privata profonda e mai pienamente
comunicabile. Nel suo Saggio sulla maschera, un piccolo classico degli anni cinquanta, Pizzorno
ripercorre la tradizione antropologica per arrivare a considerare come i meccanismi di
rappresentazione e riconoscimento facilitati dalle maschere nelle società tradizionali si sono
trasformati nelle nostre società. Anche se il soggetto moderno può giocare a travestirsi, per lui la
maschera è diventata essenzialmente un oggetto artistico, che rientra nel dominio dell’estetica e
della fantasia, non indossa più maschere rituali che fondano, alludendo ad una cosmologia
essenziale, l’ordine sociale. Eppure la metafora della maschera ci aiuta ancora, e molto, a
comprendere i meccanismi di costruzione dell’identità, la dialettica del nascondere e rivelare, e con
essa le ambivalenze della soggettività moderna.
Nella società moderna il soggetto, scrive Pizzorno, deve rappresentare se stesso come
funzione dell’espressione di una identità profonda, deve creare le proprie maschere e renderle
riconoscibili: rappresentazione e riconoscimento non poggiano più su un terreno saldo e ritualmente
condiviso, si fondano sulla capacità del soggetto di “esprimere l’essere identico a se stesso”.
Come per Foucault, la modernità è per Pizzorno un fenomeno ambivalente: "non libera l'uomo dal suo
proprio essere, bensì lo obbliga al compito di produrre se stesso" (Foucault 1984, 42).
Pizzorno ci chiede quindi di pensare alla maschera senza partire dalla pregiudiziale del
soggetto che intenzionalmente si maschera per un pubblico come avviene nel teatro, ma mettendo a
fuoco la rete di relazioni che si stabiliscono attraverso la maschera, tra il soggetto e il suo pubblico,
tra le maschere e il soggetto. Relazioni e riconoscimento sono co-costitutivi: le dinamiche del
riconoscimento non alludono ad una “identificazione psicologica” - un “credere” o “non credere”
all’identità che si assume indossando una maschera o accettando un ruolo - ma ad una performance
sociale, situata in contesti precisi. In questa linea, la metafora della maschera consente di concepire
l’identità non come un “sentimento soggettivo bensì [come] un’attribuzione da parte di altri,
un’operazione di riconoscimento” (Pizzorno 2007, 92). La dialettica tra identificazione e
disidentificazione, tra presenza e assenza che Pizzorno (1993; 2007) porrà alle fondamenta delle
forme sociali del riconoscimento nelle sue opere maggiori è già chiaramente delineata: “la maschera
nasconde e rivela allo stesso tempo” così come “il nascondere non è che un momento in funzione
dell’apparire come del rivelare”. E il farsi riconoscere e riconoscersi è anche e soprattutto un modo
di comunicare con gli altri costruendo, per sé e per gli altri, una identità che a sua volta,
circolarmente, appare come condizione della comunicazione. Nel saggio sulla maschera come nei
suoi lavori più recenti si sottolinea dunque la centralità del riconoscimento e il suo essere un fatto
sociale e pubblico: ancora oggi esso è un processo mediante il quale le persone vengono
denominate o collocate in categorie predefinite usando una pletora di segnali tanto eterogenei
quanto condivisi, dai distintivi ai titoli professionali, ed è nel continuo gioco di reinterpretazione di
questi segnali che via via viene a fissarsi l’ordine sociale (Pizzorno 2007, cap. 7). Sin dal suo primo
prendere forma, il suo pensiero si allinea così a quelle posizioni “attributive” che affondano le
proprie radici in Wright Mills e Kenneth Burke e che ritroviamo nel post-strutturalismo
foucaultiano e nell’etnometodologia (Sciolla 2000), e si distanzia dalle teorie “intenzionaliste” alla
Davidson o alla Elster (Cella 2007).
In effetti, ciò che interessa a Pizzorno è soprattutto il rapporto tra razionalità e ricezione, e non
quello tra razionalità ed intenzionalità: reinterpretando un celebre esempio weberiano, l’attore che
in nome di qualche valore persegue scopi terreni del cui impossibile conseguimento è consapevole,
non continua a presentare tali scopi come validi per ingannare gli altri e “sotto la maschera”
perseguire uno scopo diverso; il suo agire, quantunque vano in termini di scopi esterni, trova
giustificazione in sé stesso, nel suo essere “fatto insieme con altri”: il fine non è quindi sotto la
maschera, ma appunto nella possibilità di “riconoscersi mutuamente con altre persone” usando gli
appigli identitari offerti da forme simboliche condivise come le maschere (2007: 157 e ss.)
L’identità insomma non è un espediente, un mezzo per raggiungere uno scopo, e neppure un fine o
un bene da massimizzare – e qui Pizzorno entra in rotta di collisione con le posizioni neoutilitariste, le quali inevitabilmente lavorano con una visione pre-costituita e normativa del soggetto
e con una nozione sradicata e non processuale dell’azione sociale (cfr. Pizzorno 1986 e 2007, cap.
1). L’identità è la sostanza e il prodotto dell’azione sociale. La metafora della maschera si allontana
dalla metafora del teatro utilizzata da Goffman. Il soggetto drammaturgico goffmaniano “esiste già
come persona”, invece “in ogni movimento della maschera, ogni volta si ricrea l’identità di una
persona” (2005, 76 e 79). La maschera è, per Pizzorno un modo per mettere a fuoco l’idea che,
come direbbe Garfinkel (2000), l’identità è una “continua, concertata, realizzazione sociale” e non
un gioco di gestione delle impressioni. E’ un processo di apprendimento, di negoziazione della realtà:
impariamo ad essere ciò che siamo, e più che interpretare una parte, utilizziamo ogni possibile
occasione – ogni possibile maschera - per capire in che modo è opportuno, giusto, naturale che una
persona come noi si comporti.
L’approccio di Pizzorno all’identità è marcatamente non individualista - e del resto egli ha
chiarito che sono i fondamenti della ricezione culturale, e non le intenzioni dell’individuo, a
determinare il significato dell’azione sociale, e in quanto tali sono essi gli oggetti propri della
spiegazione sociologica (Pizzorno 1986 e 2007, cap. 2, sez. 1). Se Pizzorno mette a fuoco il
rapporto tra razionalità/ragioni dell’agire e ricezione, cosa potrà dirci del rapporto tra intenzionalità
e ragioni dell’agire? Si apre qui la questione dell’autenticità del soggetto e della sua sincerità.
Pizzorno chiude il saggio sulla maschera scrivendo che “ogni gesto o parola o smorfia” del soggetto
moderno “sono funzione di una verità da interpretare”, riportando quindi il rapporto tra
intenzionalità e ragioni dell’agire alla ricezione. La maschera è metafora di quei riferimenti durevoli
che consentono all’osservatore di attribuire un’identità. E se le azioni dei soggetti non tornano con
le maschere ad essi attribuite, occorrerà “modellare altre maschere” o “frugare nel magazzino di
maschere” (Pizzorno 2007, 94), lavorando su un repertorio di riferimenti durevoli, che pian piano
verranno aggiustati e reinterpretati per re-identificare l’attore e risaldare l’ordine sociale. Il soggetto
che fruga e reinterpreta è dunque il punto cieco dell’analisi sociale, attingibile solo come modello
culturale di soggettività, come menlischer Typus, spinto a costruire una verità su se stesso, in nome
dell’autenticità, e magari mediante un “processo di ricostruzione mitizzante, che è fatto in modo da
alimentare la nostra stima di noi stessi” (Pizzorno 2005, 77) e attento a preservare la propria
coerenza, immaginandosi un “io futuro” che sopravvive alle proprie scelte contingenti (Pizzorno
2007, 96 ss.).
Nelle società moderne, scrive Pizzorno, l’essere umano è “mitizzato” come un oggetto
sacro, ma resta anche incarnato e “sulla terra”, portando su di sé questa contraddizione e costretto a
scioglierla mediante la costituzione visibile di una “coscienza di sé”: “la comunicazione con gli altri
apparirà quindi sotto la guisa dell’espressione di sé” per sostenere la quale “internamente” l’essere
umano dovrà costruire una “identità a se stesso”, una continuità biografica che sia identificabile
come autentica e personale. Ecco che la metafora della maschera ci dice qualcosa di importante
anche della costruzione delle identità biografiche:
“all’inizio la maschera la trovi in famiglia. Tu credevi che nessuno avesse la maschera.
Poi ti accorgi che gli altri se la mettono. Ne sei osservatore e attore. Cerchi di capire
cosa c’è dietro a quella che portano gli altri, e insieme cerchi di capire quale sia quella
che meglio serve a te per proteggerti dagli altri. E te la levi e te la rimetti. E quando sei
adolescente, e sei incerto tu stesso su cosa ci sia dietro al tuo cercare maschere da
indossare, e sei incerto su cosa ci sia veramente che faccia conto di nascondere, cerchi
la maschera più irsuta e apotropaica possibile, oppure la più festosa e cerimonialmente
ingannatrice. Tieni gli altri a distanza, mentre ti guardi un po’ alla volta crescer dentro
la maschera, che solo in parte ti costruisci, ma che poi, volente o nolente, a un certo
punto, ti vedrai costretto a indossare … (Pizzorno 2005, 74)
E così, col passare degli anni ciascun soggetto si troverà a negoziare con le proprie maschere,
ritagliandosi spazi sempre più piccoli di movimento in funzione della densità e dello spessore dei
riconoscimenti ricevuti:
Poi la possibilità della maschera matura in lui perché vede che gli altri gliene
riconoscono una, e per lui accettare quel riconoscimento sembra la cosa più ovvia,
meno faticosa, e finirà per indossare quella figura nata dal riconoscimento degli altri,
come maschera che ha scelto lui. Ma la tratta ancora un po’ come maschera. Cioè come
qualcosa dietro la quale si immagina di conservare un luogo ‘non rivelato’, da usare per
eventuali strategie di occultamento. E probabilmente nella vecchiaia cesserà anche
questa immaginabile comunicazione interna alla coscienza, e tutto sarà maschera, muta
per gli altri, silenzio ripetuto e apatico per se stessi” (Pizzorno 2005, 75).
Il frequente richiamo al ‘nascondimento’ nelle pagine di Pizzorno allude certo alla costruzione
cerimoniale del sé mediate la distanza dal ruolo: dagli spiragli lasciati dalla maschera, dai
movimenti del soggetto che mai potrà essere tutt’uno con essa, emerge un sé che pare tanto sacro
quanto inafferrabile (Goffman 1988). Ma c’è di più. Il “nascondimento” è tale anche per se stessi, in
quanto incomunicabile, inesprimibile se non attraverso l’incompletezza dell’identificazione o reidentificazione sociale: il sé profondo è allora divenuto un riferimento mitico, che nuovamente potrà
realizzarsi attraverso pratiche socialmente condivise nell’arte come nella psichiatria. Conoscitore di
quello che chiama il “teatro del riconoscimento” di Pirandello, Pizzorno avrebbe potuto chiudere il
saggio sulla maschera con I giganti della montagna: "Non ho mai fatto altro in vita mia! Senza
volerlo, Contessa. Tutte quelle verità che la coscienza rifiuta. Le faccio venir fuori dal segreto dei
sensi, o a seconda, le più spaventose, dalle caverne dell'istinto. Ne inventai tante al paese, che me ne
dovetti scappare, perseguitato dagli scandali. Mi provo ora qua a dissolverle in fantasmi, in
evanescenze. Ombre che passano. Con questi miei amici m'ingegno di sfumare sotto diffusi chiarori
anche la realtà di fuori, versando, come in fiocchi di nubi colorate, l'anima, dentro la notte che
sogna".
Riferimenti Bibliografici
Cella, G.P. (2007) “Pizzorno, il linguaggio dello stile” in “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4,
pp.719-28.
Foucault, M. (1984) What is Enlightenment, in P. Rabinow, (a cura di) The Foucault Reader, Penguin,
London.
Garfinkel, H. (2000) Agnese, Armando, Roma [orig. 1967].
Goffman, E. (1988) Il rituale dell’interazione, il Mulino, Bologna, [orig.1967].
Pizzorno, A. (1986) Sul confronto intertemporale delle utilità, in “Stato e mercato”, 16, pp. 3-25.
Pizzorno, A. (1993) Le radici della politica assoluta e altri saggi, Feltrinelli, Milano.
Pizzorno, A. (2007) Il velo della diversità, Feltrinelli, Milano.
Pizzorno, A (2005) La maschera e l’identità. Conversazione con A. Pizzorno (a cura di R.
Sassatelli) in “Studi Culturali”, 1, pp. 69-84; ristampato in Pizzorno (2007).
Sciolla, L. (2000) Riconoscimento e teorie dell’identità in D. della Porta, et als. (a cura di)
Indentità, riconoscimento, scambio, Laterza, Roma, pp. 5-29.