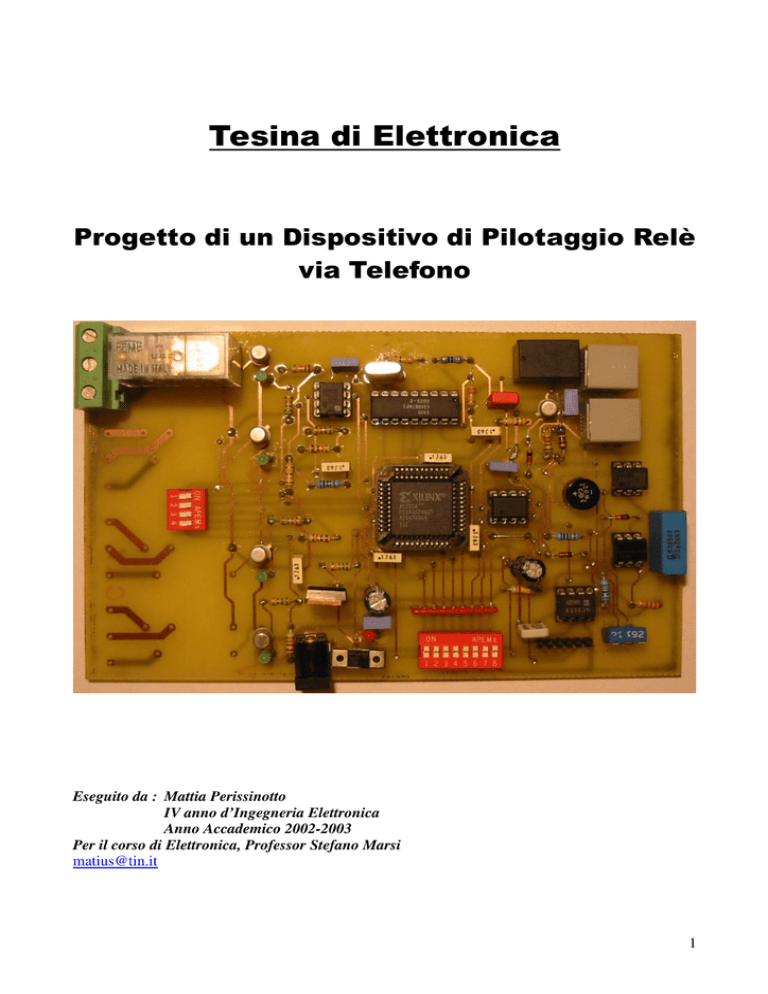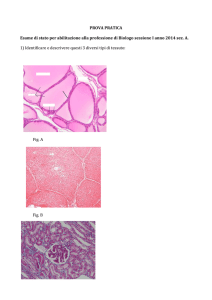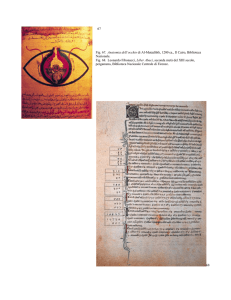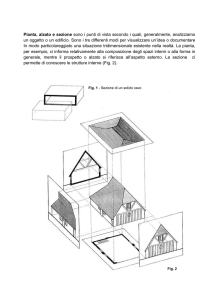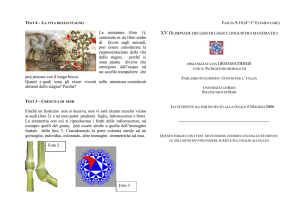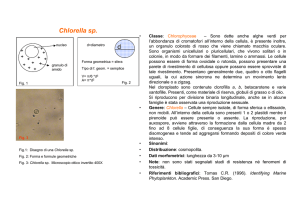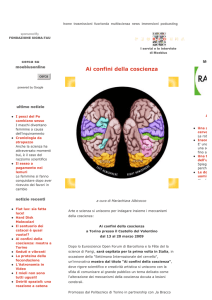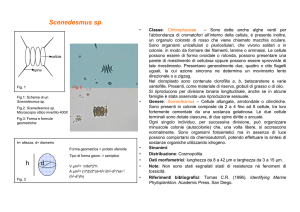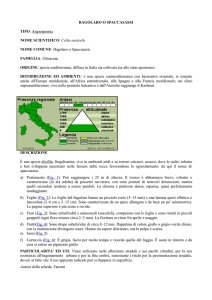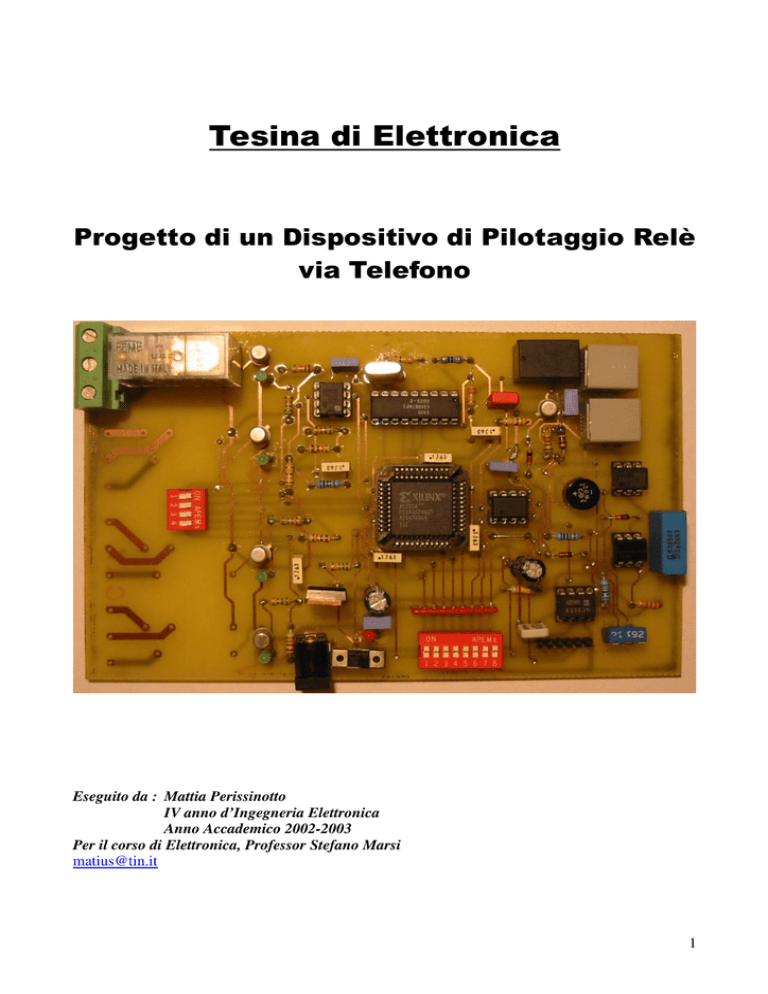
Eseguito da : Mattia Perissinotto
IV anno d’Ingegneria Elettronica
Anno Accademico 2002-2003
Per il corso di Elettronica, Professor Stefano Marsi
[email protected]
1
!
# $
% &
' (
)
0
1
"
(
(
*
*
*
+
,
&
. 2
3 4 ( !
.
&- ./
!
4
!
&- ./
5
!
# ( !
/
.
5
$
!
!
"
!
!
!
!
2
&6 37 3 8 9
/ (-: ( 8 ;:
S
8
8
' =)
<
0==> %=
0
% =?
8
"
!
!
3
∗#
∗) ∗'
@ %
@ ' @ #
"
3
<
Figura 1 - Schema di funzionamento del dispositovo -
3
1.1 Descrizione
&!
"
&
)
"
A
&
(
-
&
"
"
"
∗
'> B (
5
)
5
#
)
!
5
5
#
/
5"
5
8 5
/
!
9
5
A
8
(
!
&
'C B
4
% .
/
5
(Queste informazioni sono riportate dalla dispensa messa a disposizione su internet dal CEDI,
CEntro Didattico di Ingegneria dell’Univesità di Parma)
La rete telefonica trasferisce segnali elettrici analogici che rappresentano la voce. La
trasformazione della voce in segnale elettrico avviene negli apparati d'utente (i comuni
telefoni). La rete comprende nodi intermedi e linee trasmissive. I nodi sono detti centrali o
autocommutatori o commutatori. La connessione d'utente che collega il telefono a una
centrale è una linea formata da due fili di rame, di diametro circa 0,6 mm e lunghezza
dell'ordine di qualche km, chiamata doppino. Sul doppino è presente un unico circuito
analogico. Sulle linee che collegano le centrali fra loro sono presenti dei circuiti chiamati
circuiti di giunzione o semplicemente giunzioni.
Fig.2 – Schema elettrico (semplificato) di un apparecchio telefonico –
L'apparecchio telefonico comprende un microfono e un ricevitore, messi in serie su un circuito
elettrico (ossia il doppino) in cui circola corrente continua. Il microfono è un resistore la cui
resistenza varia in funzione della pressione che su di esso esercitano le onde sonore emesse
da chi parla. Il ricevitore svolge la funzione inversa del microfono: una tensione variabile
applicata ai suoi morsetti provoca l'emissione di un'onda sonora.
In figura 2 l'apparecchio è rappresentato a riposo: in questo stato il microtelefono è appeso a
un gancio, il contatto pilotato dal gancio è interrotto e il circuito elettrico è aperto. Il telefono è
alimentato dalla centrale attraverso la linea. La centrale è un generatore di tensione (esistono
centrali a 60V, altre a 48V). Quando l'utente solleva il microtelefono (sgancia) il contatto del
gancio provoca la chiusura del circuito elettrico in cui comincia a circolare una corrente
continua di intensità da 20 a 60 mA, variabile in funzione della resistenza della linea.
5
Il familiare servizio telefonico di base funziona secondo il seguente modello di chiamata, che
prevede tre fasi successive:
1. Fase di formazione (call setup). Uno dei due utenti (il chiamante) sgancia e
comunica alla rete il numero dell'altro utente (il chiamato), quando il chiamato
risponde viene stabilita una connessione fra i due utenti. La chiamata passa in
2. Fase di conversazione. I due utenti possono scambiarsi informazioni (tipicamente
voce) in modo bidirezionale a loro piacimento.
3. Fase di svincolo. Quando uno dei due utenti riaggancia la connessione è persa.
Riferendoci alla Figura 2, si tenga presente che in centrale è presente in serie sul doppino
(non rappresentato in figura) un relè da 1000 ohm. Quando l'utente sgancia comincia a
circolare corrente continua, il relè viene eccitato e la rete riconosce che l'utente chiede
servizio.
Oltre ad annunciare la propria presenza alla rete, l'utente deve dire chi vuole chiamare. Per fare
questo trasmette alla rete una sequenza di cifre decimali che formano il numero del chiamato.
Questa operazione si chiama selezione.
La selezione multifrequenza, di tipo più moderno, si basa sull'invio di toni. I toni sono suoni
puri (monofrequenza) che la centrale manda all'utente per mandargli delle informazioni. Nel
caso di selezione multifrequenza, detta Dual Tone Multi Frequency (DTMF), anche l'utente
manda dei toni alla centrale per codificare le cifre di selezione. Ogni cifra corrisponde a una
coppia di toni emessi contemporaneamente. Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti
nel modo di selezione a toni ("tone"), usano questo tipo di selezione. Essa è riconosciuta
dalle moderne centrali elettroniche, che comunque sono in grado di riconoscere anche la
selezione a impulsi dando così accesso agli apparecchi di vecchio tipo.
In Figura 3 è riassunto l'uso delle principali frequenze di segnalazione sul doppino d'utente. I
toni inviati dalla rete (parte superiore della figura) sono emessi a cadenze discontinue in
modo da provocare i noti effetti (il tuu, tuu, ... del tono di occupato, ad esempio) e sono usati
con qualsiasi tipo di selezione. I toni DTMF (parte inferiore) sono emessi dal telefono; ad
esempio il numero "15" del caso precedente corrisponde alla coppia di frequenze 697/1209
emessa finché si tiene premuto il tasto "1", seguita dalla coppia 770/1336 emessa finché si
preme il tasto "5".
Fig. 3 – Frequenze dei segnali telefonici –
6
Oltre ai toni che sono inviati al chiamante la rete usa, per "allertare" il chiamato (ossia per
avvisarlo che c'è una chiamata in arrivo), la corrente di chiamata. Questa corrente, alternata a
25 Hz, immessa dalla centrale sulla linea provoca l'oscillazione della suoneria che vibra alla
medesima frequenza; l’ampiezza che si misura è di circa 70V[…].
'
3.1 Il “Cervello” del circuito: La CPLD
&- ./ A&
, -
.
/
B" D
5
!
!
5
;6 / .
!
E
!
F
=
.
5
!
A
B"
Fig. 4 – Schema semplificato del funzionamento di una CPLD -
.
G
H
E
7
&
&- ./
+ &? 0'1
.
!
5
5 + &? 0'1
0'1==#0- &))& "
+ &? 0'1 "
=#0 "
+
, 7
? 0I I
G
'1
#0
- &)) "
))
&"
A-
.
&
8
5
A
&!
I
&
B
C I J &B
'1
>II
!
!
-
&
5
!
5
!
/
!
5
&- ./
5
/
8
3.2 Lo squillo telefonico
/
!
5
!
5
.
"
Fig. 5 – Riduzione di tensione dello squillo telefonico –
&#C
/ C
)C I
K%0
%06
#I L
=
;
(
#I ;
/ >
0;
F
!
!
&- ./
!M
)
!
!
#0
"
)
+ %0
5
#0I
5
+ #0
>
>
%%
!
=
=
9
D
A
F
F
.7 000
> B"
5
5
!
H
A8
B
A:
B
Fig. 6 – Timer 555 usato come divisore di frequenza –
5
!
A8 K 4 $
#N'
!
A8 6 KB
AD B
%N' ;
7
> =B
!
5
10
/
!
5
'
O
8
A(
:
A3
B
&- ./ B
Fig. 7 – Divisione degli impulsi dello squillo telefonico –
.
&- ./
"
Fig. 8 – Configurazione del timer per lo squillo –
11
&
)C I $
) %0
A
#I L
B
!
!
-
5
!
"
Fig. 9 – LM555: Capacità e resistenza in funzione del tempo –
(
5
&% P % % $ K# P #7
&# 5
I # $
#0
5
'
3.3 I “bip” di Risposta
!
3
3
#
H
&- ./
1%0 6
&
H
8
!
5
(
&- ./
5
F
.
5
!
!
5
12
3
&- ./
.
5
#I L
"
Fig. 10 – Configurazione del transistor per l’emissione dei “bip” –
13
3.4 La decodifica dei Toni DTMF
. &
A&7 : (
!
7
/
/ 87 $ K
&7 > > C I
B
=
)
B
/ 87 $ A
5
"
!
5
/ 87 $ (
A
!
B
D #=D )
"
Fig. 11 – Tabella di decodifica –
14
8
!
&7 : (
5
!
5
!
"
Fig. 12 – Timing dell’inegrato CM8870 –
.
)
!
( /
D
!
/ 87 $ 5
&F
A
B
!
!
D #=D )
!
!
/ 87 $
( /
.
D #=D )
( /
D
=
!
&- ./
D #=D )
F
H
15
-
F
!
!
"
Linea
Telefonica
Fig. 13 – Configurazione integrato CM8870 -
7
5
!
5
F
3.5 Risposta e Svincolo
3
!
&- ./
-
&- ./
5
-
5
0;
D > A
!M
);
&- ./
34-
.
);
I c = βI b
!
5
!
1I I : !
5
' =B
5
&- ./
% %%%%
'I 3
"
30 * 10 −3 = 150 *
&- ./
4
Rb
"
Rb = 2 K
16
3.6 Il clock interno
H
&- ./
.7 000
&
!
"
Fig. 14 – Configurazione Timer LM555 per la generazione di “bip” -
H
F
1%0 6
.
5
"
"
&# P I # $ K3 P # > L
K< P #I L
"
6
P I 1? 'AK3 Q K<B&#
.
P I 1? 'K<&#
5
K3
#I
!
K<
17
3.7 Il codice di sicurezza
!
:
5
=
.
*
!
>
>
!
&- ./
*
!
;
A
)
I
?B
D
(
&- ./
3.8 Il dispositivo di sicurezza
-
!
5
!
!
&- ./
!
5
.
=
.
&- ./
O
.7 000
!
!
5
"
.
#7
#0
P K R &#
&#
#I I $
K
18
3.9 Il pilotaggio dei relè
-
5
7
&- ./
!M
5
!
&- ./
5
*
);
!
5
% %%%%
'I
;
5
%L A
.
5
' 0B
3.10 L’alimentazione
-
5
.7 C > I 0
I 03
0;
!
!
0;
)C
!
)I ;
(
5
-
5
?;
.
0I I
G
%0I
35
!
3
5
"
-
"
A
5
5
) .
≈# ' S
≈I ) S
≈I % S
B"
"
+ &? 0'1
.
&- ./
!
- T
* * * ,
3
,
,
,
H
D
=
/
S
5
-
= !
5
19
4.1 Interfaccia Project Navigator
.
Fig. 15 – Interfaccia del Project Navigator -
20
/
-
5
9 &(
.
!
5
"
Fig. 16 – Interfaccia del programma ECS -
21
.
!
!
!
*
!
!
5
!
&- ./
!
&- ./
3
N:
- T
-
H
-
5
!
4.2 Dettaglio della logica di circuito
D
!
&
5
&- ./
5
!
&- ./
"
Fig. 17 - Schematico principale -
22
.
O
D # D % D ' D )"&
( 8/ "& H
K
"
3#==3) " )
3#
<#=
<#=<) " (
)
( 9 & K9 " .
&.: &L " & H
)
3
6 : ./
F
/ 87 $
&7 > > C I
&7 > > C I
*
!
*
!
=
1%0 6
6 : ./ " .
< <: - " :
.#==K9 .) " K9 .#
/
"
!
5
5
!
K
=
(8/
"
8
!
Fig. 18 - Visione interna del blocco call -
23
( /
D )
(
#==
D #
8K 9
Fig. 19 - Interno del blocco pass -
5
=
A
%
B
G
24
.
8K 9
)
!
(
#%')I >
∗
#
>
3
5
/
: L 3&&9
2
/
2
Fig. 23 - Blocco abilita -
25
5
=
$8&
Fig. 24 - Blocco relay -
/
5
A
B
26
.
6 : ./
!
8K 9
"
Fig. 20 - Linea HOLD tra il blocco call e bibop -
1%0 6
>
!
D
>
Fig. 21 - Parte superiore del blocco bibop -
27
.
8&
F
6
1%0 6
%6
8& 5
'#%
3 /
F
8&
Fig. 22 - Parte inferiore del blocco bibop -
D
6 : ./ 8 K 9
=
(8/
< <: -
3
&#=
&#=&)
2
/ #=
#=/ )
< <: 5
A
B
28
( 9 & K9
&.K
A
=
2B
'>B5
A
&- ./
&
!
5
/ >
>
0 .
5
*
5
:
":
&
:
F
5
. 2
!
29
5.1 Lo schematico in Orcad Capture
*
5
- &<
!
!
. 2
!
5
5
"
Fig. 25 – Interfaccia del programma Orcad Capture -
30
.
"
2
%
'
*
.
!
'
"
&- ./
N:
!
!
<
-
H
!
5
5
*
. 2
5.2 Orcad Layout
&
5
5
5
A/ 9 $ 3 .8 8 &6 B (
&
!
:
A
!
( 5
5
5
B
F
G
!
!M
31
3
2
G
!
"
Fig. 26 – Disposizione dei componenti –
-
5
2
&- ./
5
=
!
H
32
-
!
A#
P I I %0
B"
•
#>
!
&- ./ "
Fig. 27 – Ingrandimento di alcune piste adiacenti la CPLD –
•
•
•
'I
>I
;
'0
5
33
3
!
#'0
2
5
"
Fig. 28 – Layers TOP e BOTTOM -
3
N9
K
7
5
5
!
2
8: -
<: 8 8 : 7
!
&
!
K
9 &:
. 2
2
-
5
L
:
/
34
-
%0I
*
/
"
&
D
-
%#
1
%
I I #%W
I #C W
I #0W
# )#)>
X
#I ;
I 0J
.7 C > I 0
9 000
&7 > > C I
&- ./ + &? 0'1
:
3
) %0
%
%
#
#
'
#
#
#
%
I I>W
I I>W
I '0W
I 1'W
I )? W
% 1'W
' 'I W
I ##W
I )1W
.
.
)
#
I %'W
I #0W
0
I C 1W
#
%
I 0C W
# #C W
#
)
#
# 1%W
%?IW
I 0C W
B1
B>
B #>
%
'
#
I %'W
I %C W
I 1> W
#I + #1
#
' )> W
K
&
&
U S
9
8
0V
/
/
-
;
K
8
&
&
<Y 8 % %%%%
3
8
K 5 8
K 5
:
X
X
X
-
<
-
=: $ $
A8
A8
A8
5
%0W
A
B
5
35
Datasheet
• &- ./ = + &? 0'1 "
• 8
http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/9536.pdf
4 9 000 " http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/NE_SA_SE555_C_2.pdf
• $
http://www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N25-M.pdf
4 ) %0 "
•
/ 87 $ K
•
K
http://www.calmicro.com/products/data/pdf/cm8870.pdf
4 &7 > > C I "
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf
4 .C > I 0 "
Siti Internet
•
www.xilinx.com
=(
•
, 7
!
=
www.cadence.com
= (
•
+
*
!
:
&
:
. 2
4
www.cedi.unipr.it/links/Corsi/telematica/Materiale/dispense/Telefonia/PSTN.html
=/
!
&
/
-
=
36
3
3=( !
.
=
37
38
39
40
Elenco Componenti Schematico
&#
&% &' &) &1 &C &> &#I
&0 &#%
&1
&##
&#'
&#1
&#C
&
&
&
&
&
&
&
&
9
9
-
K#
K% K'
K%0 KC
K%#
K) K#1 K#C K#> K#?
K%I K%% K%' K%)
K1
K0
K?
K%1
K#%
K'%
K'#
K''
<
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
/ 1
/ C / >
/ #I
/
/
-
#
' 1 %I
)
C
>
%# %%
''I
I #
#I
%%
#I I
I I#
)C
)C I
+>
#I L
#I I L
#I L
#I L
01I
#> L
#>L
'I I L
#7
%CL
> %I L
0 1L
1I I
#0L
;
# )#)>
#I ;
I 03
X
.7 C > I 0
9 000
&7 > > C I
+ &? 0'1
&- ./
:
3
) %0
/ # / % / ' / )
/ 0
.
.
;
K
D ) D 0 D 1 D C D >
8
Y#
Y' Y)
Y- 1
Y - #I Y - %I Y - 'I Y - )I
&
&
&
&
.( #
K9 .# K9 .% K9 .' K9 .)
K 5 8
K 5
(S #
(S %
(S )
(*
(*
<Y 8
% %%%%
3
8
Y8 3
%%I ;
:
=: $ $
!+ )
!+ >
41