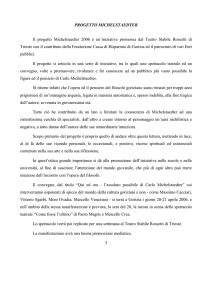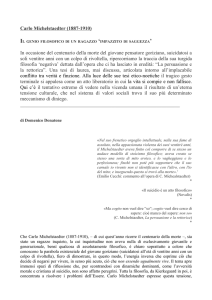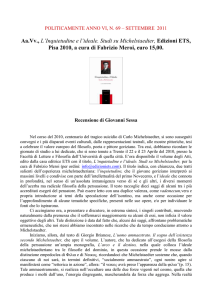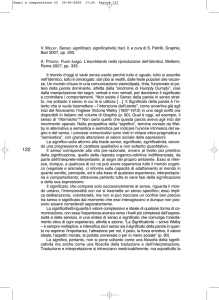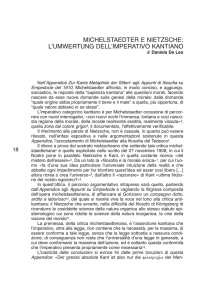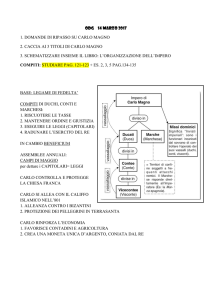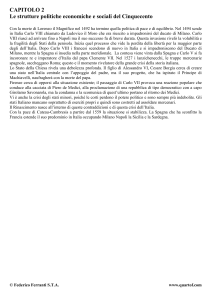Ricerche
Un’altra società
Carlo Michelstaedter
e la cultura contemporanea
a cura di Sergio Campailla
Marsilio
indice
7 La persuasione e la menzogna
di Sergio Campailla
20 Il percorso universitario di Carlo Michelstaedter dall’archivio
dell’Istituto di Studi Superiori
di Valerio Cappozzo
32 Insonnia e dolore in Carlo Michelstaedter
di Arnaldo Colasanti
39 «Dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra».
Sull’«Epistolario» di Carlo Michelstaedter
di Simona Costa
53 Michelstaedter personaggio
di Paola Culicelli
67 Michelstaedter postmoderno.
Il concetto di scienza in Carlo Michelstaedter e Richard Rorty
di Yvonne Hütter
© 2012 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia
Prima edizione: ??? 2012
ISBN 978-88-317-???
www.marsilioeditori.it
Realizzazione editoriale: Valeria Bové
76 Il Romanzo mancato di Michelstaedter
di Filippo La Porta
81 Il Fondo Carlo Michelstaedter. Appunti documentari e bibliografici
di Marco Menato
95 L’opera in versi di Michelstaedter e la poesia del primo Novecento
di Maria Carla Papini
106 La repubblica teoretica.
La variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
di Rosalia Peluso
127 Il sasso del San Valentin
di Fabio Pierangeli
LA PERSUASIONE E LA MENZOGNA
di Sergio Campailla
144 Michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
di Antonio Pieretti
162 Michelstaedter, d’Annunzio e il mondo della vita
di Roberto Salsano
188Carlo Michelstaedter e l’Istria
di Donatella Schürzel
205 Testimonianza
di Christian B.M. Berlakovits Cominciamo dal cuore.
Che cos’è la persuasione? È la parola-chiave, magica, per entrare nel pensiero
e nell’opera di Michelstaedter.
Ma come si può sintetizzarne il significato? Infatti, oltre che magica, è anche
una parola polisensa, ai limiti dell’ambiguità. Si può rispondere in vari modi, tuttavia insoddisfacenti.
Più agevole illustrarne la genesi storica. Sul piano basso, La persuasione e la
rettorica è un lavoro d’obbligo, sia pure estremo, che segue ad altre esercitazioni accademiche. All’autore, studente presso l’Istituto di Studi Superiori a Firenze,
viene assegnata una tesi su I concetti di persuasione e rettorica in Platone e in Aristotele. Nei precedenti lavori di impostazione scolastica Michelstaedter si era impegnato in uno studio su Lessing e Baretti, di taglio comparatistico; quindi in una
ricerca su Il coro nella teoria e in alcune sue forme originali in Italia, dove la tragedia greca è il sacro, da cui nasce il fiume che deve guadagnarsi la via tra le asperità del terreno. Nella tesi di laurea, quindi, Michelstaedter riprenderà e coniugherà il carattere binario e la materia greca, attraverso due suoi sommi rappresentanti. Ma stranamente è proprio dal più ostico, dal meno congeniale di questi impegni universitari, da L’orazione “Pro Q. Ligario” tradotta da Brunetto Latini che scaturisce la scintilla. Ne informa lo stesso Michelstaedter in una lettera al padre del
31 maggio 1908:
Il semplice studio d’analisi d’una traduzione di Brunetto Latini d’un’orazione di Cicerone m’impigliò nella questione del testo che Br. Latini poteva aver avuto sott’occhio;
dovetti occuparmi della storia dei manoscritti di Cicerone, ed esaminare quanti ho potuto trovare qui anteriori a Br. Lat. per confrontarli colla sua trad. Poi studiai pure i mano7
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
scritti fiorentini della traduzione per correggere in parte l’edizione. Non sono lavori fatti
per me. Ma ora ne sono quasi fuori e il materiale raccolto mi servirà non solo per il breve lavoro che presenterò Martedì a Mazzoni ma quel che più importa per il lavoro obbligatorio di latino. – L’unica cosa che mi interessò sono le osservazioni che ho potuto fare
sull’eloquenza e sulla “persuasione” in genere. Forse interesseranno anche te.
Sarà bene notare che è la stessa lettera in cui Carlo informa, con un resoconto di drammaticità coperta, dei suoi intervenuti guai di salute, cioè della sua incipiente malattia 1. Qui, nel tentativo di sottrarla al generico, la persuasione è virgolettata; mentre la rettorica si chiama ancora eloquenza. Ma è il primo spiraglio,
confessato. Né dobbiamo dimenticare, per l’economia del discorso che svolgerò,
il destinatario di questa comunicazione, che è il padre. È probabile che l’assegnazione sia stata, nella sostanza, una scelta. Michelstaedter è affascinato dal mondo
greco, Girolamo Vitelli è un professore che riscuote la sua stima, un ellenista di
fama internazionale. L’argomento della tesi è, sulla frontiera, di materia e competenza linguistica greca e tuttavia di spessore filosofico.
Non è una tesi sui concetti di persuasione e rettorica in Platone, ma in Platone
e in Aristotele: il che conferisce dinamismo alla riflessione e identifica i termini di
riferimento. Ovviamente, il confronto, la triangolazione più che implicita è con la
modernità, di cui è sentinella il giovane autore. Da questo momento, e più di prima, L’apologia di Socrate, il Fedone, Il Sofista, il Parmenide, il Fedro, La Repubblica,
e soprattutto il Gorgia, e sull’altro versante la Retorica e la Poetica, estremizzando
e accentuando la divaricazione, il primo Platone e l’ultimo Aristotele, saranno i
livres de chevet e il pane quotidiano dello studente Michelstaedter, si insinueranno nel suo sonno e costituiranno il suo alimento.
Siccome siamo già alla fine di maggio del 1908, i margini, senza che nemmeno
l’interessato lo sappia, sono già strettissimi. Michelstaedter si è posto, è stato costretto a porsi, dei paletti, ma inevitabilmente, con una spinta crescente e irresistibile, per scavalcarli. Senza quella compressione non ci sarebbe stata, con quell’intensità e accelerazione, quella liberazione.
Ancora due sottolineature, a ribadire l’eccezionalità del documento: Michelstaedter si augura che le sue osservazioni possano interessare il padre; che è esattamente l’opposto dell’esclusione, e della contrapposizione, che determineranno.
Inoltre, commenta con sollievo: «Ma ora ne sono quasi fuori». Michelstaedter ha
premura di chiamarsi fuori. È nella sua natura, e per l’avvenire lo farà nella maniera più clamorosa.
Dunque, la persuasione, tenuto conto della fonte platonica, è la divina πειϑώ. Il
verbo in questione è πείϑω. Nella forma media, πείϑομαι: persuado/ mi persuado.
E chi è persuaso, crede. In inglese oggi suonerebbe come: to believe. E chi crede,
ha la fede o, almeno, una fede. Si può allora dire che la persuasione è una varian-
te “laica” della fede? Ma a questo punto, non abbiamo compiuto un gran passo
avanti. Infatti, il persuaso crede, sì, ma in che cosa?
Tentiamo un diverso approccio.
La persuasione, se vogliamo cercare di definirla, è autenticità, un’autenticità realizzata nel presente, senza rinvii. Non è una rincorsa, ma una consistenza.
È il peso che non pende e dipende. Il che, a partire dal celebre incipit dell’opera maggiore, lascia trasparire la sua contraddizione, insanabile. Ma già entriamo
nel campo delle metafore. Un’altra metafora: è il cristallo, luminoso e intatto. La
fiamma, che brucia. Ma non può bruciare in eterno. La persuasione si realizza nel
tempo e nella storia: è il presente, che si ferma. L’infinito nel presente. Il rabbino Benedetto Carucci Minervi mi suggerisce un’altra soluzione: è il Tempo dello
Shabbat, fuori del tempo storico. Una condizione perfetta, che ripristina la creazione del mondo, il suo miracolo. Ci può essere anche questo nella memoria genetica di Michelstaedter, ma tutto si risolve in un processo di riappartenenza, l’opposto dell’assimilazione? I segnali criptati, criptati anche per l’autore, alludono a
questo? Non stiamo forzando, per trovare la quadratura del cerchio? Occorrerà
calcolare l’influenza del pensiero buddhista, proprio nell’ultimo biennio.
Di sicuro, per quanto possiamo sofisticare il discorso, non sono le parole o gli
argomenti che ci mettono in mano le chiavi di ingresso in una condizione altra. La
gioia, teorizzata alla fine della prima parte della Persuasione, è uno stato di felicità che ha come fondamento la coscienza del dolore e assomiglia piuttosto a un orgasmo mistico. Più agevole per l’uomo della modernità, come in una famosa poesia di Montale, dire ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. La prima riga della Persuasione ribadisce questo: «So che voglio e non ho cosa io voglia». È l’alterità che chiarisce l’identità. L’Assoluto esiste in assenza. La persuasione non è corsa
da omnibus: non è per tutti, e non è nemmeno una corsa. È uno stato individuale.
Un sogno; e quando si sogna, si sogna da soli. Ognuno è il primo e l’ultimo, ripete Michelstaedter, con san Giovanni.
È la rettorica a essere nella storia ed è per viam negationis che si restaura la comunicazione. La persuasione è l’antitesi della rettorica. Il titolo dell’opera potrebbe essere, più correttamente: La persuasione o la rettorica. Giovanni Gentile nella
sua recensione giudicò che la parte dedicata alla persuasione fosse debole sul piano filosofico. Dal suo punto di vista, aveva ragione. Ma il suo punto di vista era
quello dell’idealismo gentiliano. Si capisce tuttavia come, per queste ragioni interne, la critica della retorica, nella sua molteplicità di manifestazioni, risulti più
battente, riconoscibile, convincente.
Non esistono formule e ricette preconfezionate. Michelstaedter ha ammonito:
i cristiani avessero fatto più pesci, si sarebbero salvati davvero. Nessuno può appellarsi al modello di un precursore e limitarsi a imitarlo, perché si duo idem faciunt, non est idem. Il persuaso ha nella sua mano la sua vita e non la fa dipende-
8
9
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
re da alcuno e da niente. I profeti aprono una strada originale e i seguaci prolificano e degenerano nel nome di chi tradiscono.
Ma le difficoltà non diminuiscono spostando l’attenzione dal concetto filosofico di persuasione all’olimpo dei persuasi. La prefazione alla tesi ha un rilievo esemplare, scolpisce una tavola di valori. Conferma il principio oppositivo: i
presocratici e Socrate da una parte, Aristotele dall’altra; Cristo e la fabbrica della Chiesa. Ma i personaggi invocati sono di incerta compatibilità: come stanno insieme Parmenide ed Eraclito, che si ispirano a principi opposti? Stupisce nel catalogo la presenza di Petrarca, accanto a Leopardi. Inoltre, come in ogni catalogo,
può sollevare obiezioni non solo chi vi è compreso, ma anche chi ne rimane escluso. Proprio dalla postazione di Michelstaedter, Tolstoj, per la sua opera, per l’apostolato della sua vita e per quello che storicamente ha rappresentato, non avrebbe diritto di farne parte?
Falliti tutti i tentativi, constatate e confermate le difficoltà, bisogna prenderne
atto: la persuasione non è definibile. È indefinibile, come Dio.
Michelstaedter reagisce con la cultura del suo tempo, con la cultura che ha respirato all’interno della sua famiglia. La sua parabola si svolge dentro un conflitto
tra generazioni di eccezionale asprezza, che miete vittime come un’epidemia nella
società austro-ungarica, di cui si respira il crollo imminente. In quest’occasione,
intendo circoscrivere il problema e sviluppare, su una pista nuova, un confronto
diretto del figlio con il padre.
Intanto, chi era Alberto Michelstädter? Riassumendo, un professionista stimato, dapprima agente di cambio in zona di frontiera e poi direttore del­­l’agenzia goriziana delle Assicurazioni Generali. Appartiene alla prima ondata della generazione che è uscita dal ghetto e, con il matrimonio, si sistema nella casa borghese di
piazza Grande, vetrina di rappresentanza e centrale snodo della città. Ha nel suo
Dna la memoria del nonno e del bisnonno rabbini celebri e lui stesso ha una buona conoscenza dell’ebraico. Carlo, quando è toccato da un sussulto di interesse
per questa genealogia, punta sulla mediazione linguistica del genitore, che ha tradotto a sua volta testi biblici e che gli mette a disposizione la sua competenza. Alberto è un ebreo in fase di progressiva assimilazione, molto attivo, di umore bonario, persino simpatico, con il debole per la letteratura e per la versificazione. Autodidatta, svelto in aritmetica e nei calcoli, ha una preparazione eclettica, che gli
piace sfoggiare. È diventato un notabile cittadino, influente nelle istituzioni, specie in quelle di tendenza irredentista, con il gusto per le cariche. Non a caso, un
suo ritratto a olio, a firma di Milesi, è conservato nel comune di Gorizia, nella galleria dei Sindaci della città. Non perde una ricorrenza né privata né pubblica. È in
prima fila per promuovere le celebrazioni di Ascoli, vanto insieme della comunità
ebraica, di quella scientifica e di quella italiana; e quando è il momento di accogliere a Gorizia gli ospiti illustri: per esempio, Luigi Federzoni, giornalista e lette-
rato, campione del movimento nazionalista, e più tardi, negli anni venti, con benemerenze fasciste e persino presidente del Senato del Regno, d’Annunzio, Sem Benelli. È anche un conferenziere apprezzato, con una bibliografia senza pretese ma
in lodevole crescita. Di particolare risonanza Per Giosuè Carducci, il discorso tenuto al Gabinetto di Lettura di Gorizia il 31 maggio 1901 e, come estratto dal «Corriere Friulano» del 1° giugno, spedito dalla direzione del Gabinetto stesso al «bardo d’Italia», il quale fece l’onore di rispondere e di ringraziare. In un fuoco d’artificio di dichiarazioni retoriche, un motivo di successo personale. Ma chi voglia
studiare il carduccianesimo delle prime poesie di Carlo, dovrà mettere nel conto anche questa infatuazione, che fu di un’epoca e che contraddistinse Alberto.
Il quale, dopo aver tenuto le sue conferenze, le pubblica. Le legge dove trova un uditorio disponibile, ovviamente non le risparmia ai familiari. In occasione
dei grandi eventi, nozze e partenze storiche, non fa mancare il suo monito severo,
il suo ricordo affettuoso, con dedica a stampa. Non perde un colpo.
Ecco la sequela degli interventi, a documentare la sua attitudine mentale e la
sua strategia di comportamento, distribuiti equamente sui quattro figli.
Inaugura la serie un opuscolo dal titolo Un’oretta di divagazioni, dedicato alla
figlia, Elda, che si sposa con Silvio Morpurgo. È del 1902, ma recupera una conferenza, tenuta a Trieste e a Gorizia nel marzo e nell’aprile dell’anno precedente,
che vuol essere una riflessione a ruota libera – cita espressamente La carrozza di
De Amicis – su cultura e società nel trapasso tra un secolo e l’altro, con una presa di posizione contro il relativismo dilagante.
Il secondo turno spetta a Gino, che si unisce in matrimonio con Amalia Dalumi. La coppia parte per New York: Alberto rispolvera allora una conferenza già
letta nel 1893 al Gabinetto di Lettura di Gorizia e riciclata successivamente in un
paio di occasioni. Adesso la dà alle stampe, nell’anno 1905, per celebrare il lieto e triste evento: è l’opuscolo, pubblicato dalla tipografia Paternolli, con il titolo Un amico dell’uomo (Il letto), un centone di freddure sul “quadrupede” amico
dell’uomo, che non è il cane ma il letto appunto, ignaro di eventuali implicazioni
maliziose sul tema e sfortunato per l’esito di quel matrimonio e di quella partenza. Basti selezionare questa perla: nella prefazione in versi l’autore divulga senza
discrezione che ad attrarre Gino, prima che «il fascino gentile» della sposa, sono
stati «l’ingegno virile / e le doti del cuore e il culto del dovere, / l’animo franco e
retto e il solido sapere». Con questo messaggio augurale inizia il viaggio di nozze… Mentre la conferenza termina con un incredibile invito agli uditori, verosimilmente entusiasti: «Insomma, signori miei… andiamo a letto!».
In quello stesso anno 1905 la performance di Alberto appare particolarmente
notevole. Gino infatti va via, lascia definitivamente l’Isonzo per l’Hudson River,
ma tocca anche a Carlo distaccarsi da Gorizia e dalla famiglia, non per un matrimonio, è ancora troppo giovane, ha appena diciotto anni, e non si sposerà mai:
10
11
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
va invece a Firenze, per realizzare il suo sogno artistico e per studiare. Scatta allora il cosiddetto Sermone paterno, su cui ho richiamato l’attenzione già nel 1974
in A ferri corti con la vita e su cui, quindi, nonostante riguardi da vicino proprio
il filosofo, non mi dilungo. Siamo prima della tempesta; e l’autorità patriarcale vi
si esprime, senza resistenze, esercitando una forte pressione sul figlio, che sta abbandonando il nido.
Nel 1913, infine, ormai dopo la tragica morte di entrambi i figli maschi, Alberto festeggia la figlia Paula, che si sposa con Fritz Winteler, recuperando una conferenza del 1909 letta al Gabinetto di Lettura cittadino nel centenario della nascita del poeta Giuseppe Giusti, patriota risorgimentale, valorizzato come «un grande umorista». Ne ricava un opuscolo, presso la locale tipografia Paternolli, corredato di un disegno di Giusti abbozzato da Carlo e di una prefazione con versi a rima baciata, in cui rievocando la duplice sventura rinnova gli epiteti di “Antigone”
e “Cordelia” alla figlia che lo ha amorevolmente sorretto in quelle terribili prove.
Come si vede, questa produzione corre parallela a un’esperienza straziante,
che riguarda la sfera privata e che merita il massimo di rispetto, oggi come ieri.
Alberto Michelstädter ci mette la sua umanità e buona volontà e viene punito dalla sorte in maniera crudelissima e imprevedibile. Su un altro piano, la letteratura
entra nella vita, nel tentativo di renderla solenne e memorabile. Una lezione interiorizzata da Carlo, il quale scriverà lettere importanti in occasione dei compleanni delle persone care, ma riducendo il dato convenzionale e rovesciando in maniera sconveniente quell’abitudine, come nel caso limite dei versi Alla sorella Paula
per il natalizio di lei e del suicidio il 17 ottobre, giorno del natalizio della madre.
Ma esaminati questi materiali innocui, che potrebbero interessare gli eruditi
locali, balza all’occhio un rapporto, e un’antinomia, che getta una luce diversa su
questi stessi documenti, aprendo un interrogativo allarmante di carattere generale.
Tra questi testi ce n’è uno che si distingue dagli altri e che risulta sorprendente per più aspetti; un testo che per giunta è abbastanza remoto. Infatti, la conferenza, tenuta presso il Gabinetto di Minerva di Trieste, risale al 13 aprile 1894, e
viene data alle stampe presso la tipografia di Domenico Del Bianco di Udine prima nei fascicoli di ottobre e novembre di «Pagine friulane», e poi in opuscolo separato nel 1895. Porta regolarmente una dedica, che merita evidenza:
Chi è Ada? Se piacevano alla defunta, vuol dire che ha fatto in tempo a fargliele ascoltare, durante la conferenza o almeno nel testo scritto precedente la
stampa. Ada, difatti, questa donna dal nome triadico e perfettamente palindromo, è morta nel 1895. È la figlia di Girolamo Luzzatto Coen e di Carolina Sabbadini, la giornalista direttrice del «Corriere Friulano»: è suicida, per via di veleno, la battistrada in un sentiero angoscioso che si affollerà negli anni successivi.
È quindi una parente. Nata, per l’esattezza, il 19 settembre 1870 e morta per autosoppressione, il 9 maggio 1895. A quella data aveva ventiquattro anni. Alberto
quarantacinque. Carlo di lì a pochi giorni ne compiva otto. Troppo giovane per
una presa di coscienza, comunque incalcolabile.
Il testo tuttavia rimane lì, è antecedente rispetto a tutti gli altri che ho sopra
menzionato; inaugura, da lontano, una catena di lutti. La menzogna è, a mio giudizio, senza dubbio l’opera d’occasione più significativa del dilettante Alberto Michelstädter. Sia pure prolissa, d’intrattenimento, eclettica, gonfia di citazioni, ma
impegnativa, riflette una visione del mondo e dei problemi, contiene una filosofia
empirica e una pedagogia. Se Carlo, a suo tempo, non l’ha ascoltata o non l’ha letta, ne ha subito le conseguenze, nell’indottrinamento o almeno nel vissuto.
Se ne conservano due copie nel Fondo Carlo Michelstaedter della Biblioteca
Civica di Gorizia. Una con dedica autografa a Enrico Maionica, l’altra a Gilberto
Senigaglia, in date successive del novembre 1895. L’autore fa circolare la sua creatura letteraria, che spera gli procurerà reputazione e consenso.
L’argomento della menzogna è una freccia acuminata, che cerca il suo bersaglio. È noto il paradosso del mentitore, attribuito dalla tradizione a Epimenide di Creta, il quale avrebbe dichiarato: «Tutti i cretesi sono bugiardi»: affermazione contraddittoria da cui però non si viene fuori, perché lo stesso Epimenide,
in quanto cretese, non si può sapere se abbia detto per una volta la verità, invalidando la tesi generale; o se ha mentito, abbia detto allora la verità, invalidando di
nuovo la tesi generale. Accontentiamoci di questa premessa, che può avere sviluppi sofisticati, per dare un’idea delle insidie del terreno in cui ci inoltriamo.
Alberto Michelstädter non cita Epimenide, bensì il filosofo Stratone di Lampsaco, il quale conversando sotto gli archi del ginnasio di Corinto avrebbe chiesto agli allievi chi dovesse considerarsi l’uomo più virtuoso del mondo; al che un
discepolo gli avrebbe risposto: «Colui che non ha mai mentito». Replica di Stratone: «Allora quest’uomo abita nel cielo della pura Idea e non sulla terra, – perché
sulla terra nostra non esiste un uomo che non abbia mentito mai». Da qui prende le mosse Alberto, che condisce immediatamente l’aneddoto con una facezia: si
confessa infatti dolente di non poter risparmiare gli uditori presenti. Come dire:
siete tutti bugiardi. Anzi, siamo tutti bugiardi.
Provocazione con tono fatuo che si premura di riassorbire. Secondo lui, la verità è l’ideale dell’anima; l’uomo tende alla verità a cui si atterrebbe permanen-
ada
alla tua memoria
incancellabile
cara e dolorosa
consacro
queste pagine
che ti piacevano
12
13
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
do nella condizione naturale. Questo tuttavia non succede, perché in realtà è un
animale sociale e il rapporto sociale impone l’uso della menzogna per legge di sopravvivenza. «Dal conflitto d’interessi fra uomo e uomo è sorta la necessità di creare una regola, da questa è nato il vivere sociale, la società: la grande menzogna».
Sembrerebbe il preambolo di una contestazione globale: Alberto prima dichiara che siamo tutti bugiardi, poi che la società si basa sulle fondamenta della menzogna. È una denuncia alla Ibsen? Vengono in mente I pilastri della società del
drammaturgo scandinavo. I conferenzieri non si aspettavano tanto. Il bonario Alberto Michelstädter, di professione assicuratore, darà fuoco alle polveri? Come si
rimedia per salvare la faccia e riportare il tutto nei binari di un gioco mondano?
Difatti il conferenziere sfoggia il suo repertorio pieno di citazioni, che rivelano un
bagaglio culturale superiore alla media, e di vaghezze letterarie, del tipo «vanni»
invece di ali, «speme» invece di speranza, «augelli» piuttosto che uccelli. In un
battibaleno, si assiste a un capovolgimento felice della situazione: è, sì, tutto fondato e dominato dalla menzogna, ma «se guardiamo il fenomeno non preoccupati
dal punto di vista del vero e del falso, vi scorgiamo tutt’altra cosa. Allora seguiamo ammirati la marcia trionfale della civiltà».
Insomma, falso allarme, tutto bene. Non è che Alberto non veda le crepe
dell’edificio sociale, ma scopre che vanno considerate in maniera diversa e positiva. Addirittura, un popolo più è civile, più è capace di mentire. Gli australiani
sono poco inclini alla menzogna e hanno infatti un’intelligenza meno sviluppata. Al contrario i neozelandesi sono falsissimi e intelligenti. Forse si riferisce agli
aborigeni. Ma la conseguenza sarà che il popolo più sviluppato è imbattibile nella strategia dell’inganno. A questo punto si invoca Satana maestro di malizie conoscitive, e la sua lista di cantori a vario titolo, da Dante a Milton, da Goethe giù
sino a Rapisardi.
Il discorso di Alberto entra in un terreno dove è difficile non evocare la figura
di Carlo. Esiste una dimensione pedagogica del problema. L’educazione del fanciullo viene curata non spingendolo a esternare sentimenti e valutazioni con sincerità, ma a costruirsi una personalità basata su un’abile e sistematica finzione. Per
le bimbe è ancor peggio: il codice delle belle maniere richiede per il sesso femminile una scuola di addestramento speciale alle «civili dissimulazioni». Il bambino,
insomma, cresce facendosi una ragione della necessità di non poter perseguire i
suoi ideali e sostenere le sue convinzioni e un poco alla volta le sacrifica sull’altare dell’interesse e del profitto.
Tra quei bambini c’è anche Carlo Michelstaedter, che – vale la pena di ripeterlo – a questa data ha soltanto otto anni e che ascolta la lezione di ipocrisia, se
non nella sala della conferenza, in casa. Il figlio impara al contrario la lezione del
padre, si sforza di metabolizzare quell’insegnamento, ma non ci riesce. La sua parabola culturale, morale e intellettuale è destinata ad accentuare la divaricazio-
ne. Nel 1905 scrive una pagina sul tema in cui, con intransigenza, definisce l’ipocrisia come menzogna della menzogna 2. Nessun compromesso. Alla fine, sputerà la perfida sorba. Il suo sarà un rifiuto tra i più clamorosi, l’impegno estremo
a non rinunciare a valori che appaiono non negoziabili, una smentita dei precetti paterni.
Alberto è abbastanza onesto per riconoscere la tela degli inganni su cui è edificata l’esistenza quotidiana, ma è abbastanza pratico per adeguarsi e saltare il
fosso. Il passaggio, senza con ciò indulgere a facili anticipazioni e tenuto conto
dell’empiria dei concetti elaborati in queste pagine, è da una generica persuasione a una retorica funzionale, positiva, fatale. La sua dimostrazione è analitica, panoramica sui vari settori della società, dal giornalismo alla pubblicità, al diritto,
alla diplomazia. Non gli manca un’intuizione umoristica: «Immaginatevi una società ove fosse imposta per norma assoluta la verità: quanti odi, quante antipatie
vi scoppierebbero allo scambio delle più insignificanti parole». Esattamente l’intuizione su cui il regista Tom Shadyac nel 1997 ha girato il film Liar Liar, interpretato da Jim Carrey: un bugiardissimo avvocato per ventiquattro ore non riesce più a mentire, inconveniente che determina vari disastri: ma è l’effetto di un
desiderio del figlio, che si avvera. Il comportamento dell’adulto ha una ricaduta
sulla sensibilità del figlio, che cerca una soluzione al problema almeno nell’ordine del desiderio.
Così fan tutti e tutte. «La rettorica», è Alberto a scriverlo, non ancora Carlo,
«cangia nome alle cose». Esiste una verità ufficiale, che si discosta dalla “verità vera”. L’oratore è talmente preso dalla sua tesi che trova conferme ovunque, persino
nella pace imparziale del cimitero. L’elogio funebre, l’epitaffio pietoso che mistifica le qualità del defunto, non è questa l’ultima concessione all’ipocrisia? Alberto va oltre, incauto: «La morte stessa non è più un fenomeno esclusivamente naturale, ma c’è la morte procurata ad arte che le fa purtroppo una grande concorrenza: la tremenda piaga del suicidio. – La menzogna ci perseguita dovunque!».
Il suicidio come menzogna. Dovrebbe mordersi la lingua, non per presentimento
delle sventure che si abbatteranno su di lui, ma per la disgrazia recente di Ada, a
cui l’operetta è pur formalmente dedicata. Sembra una variante del paradosso di
Epimenide di Creta: sta dicendo la verità, per eccesso di zelo, o sta pronunciando un’ulteriore menzogna?
Alberto ci ha riflettuto sopra e la sua rassegna mira a essere completa: non dimentica nessuna delle risorse della finzione, nessuna delle occasioni di svelamento: la maschera, il carnevale, l’alcol, il vino… «La verità spaventa veramente, perché rappresenta il dolore». Se si vuole vivere, e vivere il meno peggio possibile, bisogna mentire. Arriviamo a un passo inquietante di questa perorazione: «L’uomo
che sente in sé l’irresistibile spinta verso la verità e che respinge da sé ogni idea
che tenda ad illuderlo, non solo ha nel suo interno una sorgente d’inevitabile in-
14
15
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
felicità, ma riceve dall’esterno continue acute punture che lo fanno sanguinare. È
il grande spostato del mondo». E più avanti: «Questo intransigente apostolo del
vero se vuole il senso della realtà applicato rigorosamente a tutto e la sua vita regolata dai suoi convincimenti soltanto, senza riguardo alla corrente da cui è rimorchiato, è il più puro degli idealisti. Non ci può essere infatti una concezione
più ideale di quella d’un uomo che viva soltanto del proprio pensiero, che possa
emanciparsi da tutte le convenienze della società che lo circonda». Alberto è un
profeta a rovescio. Devo di nuovo ridargli la parola: «Sappiamo che l’uomo non è
fatto così; ed uno che volesse plasmarsi, sia pure in nome del vero, una natura così
assoluta, cadrebbe nel falso. Quelli che non sanno conciliare le due cose: la libertà del proprio pensiero e la vita non eccezionale, hanno una filosofia morbosa».
Questa è una fonte certa di infelicità. Alberto se ne preoccupa, si preoccupa
per i suoi figli. «Ai nostri figli, infatti, quante cose insegniamo di cui l’esperienza
e lo studio ci dimostrarono la vacuità e la nullità? E perché? – perché non vogliamo crearli eccezioni, non vogliamo che si trovino isolati in mezzo al mondo in cui
vivranno; vogliamo anzitutto la loro felicità, e – in omaggio a questa nostra santa e legittima aspirazione – facciamo una transazione col complesso delle idee che
crediamo non vere, o con parte di esso».
Mi pare impressionante: l’assunto del padre e, nel medio termine, la risposta del figlio, ammalato di assoluto, come chi soffre di insonnia conosce il sonno;
del figlio che, piuttosto, come Paolino della novelletta, non vuole crescere allora;
che si dispone a fare una tesi su Platone e Aristotele, ma poi non andrà a giocare.
L’antidoto è credere, illudersi, mentire. Alberto assembla una bella schiera
di facitori di inganni e la spedisce in Paradiso per meriti acquisiti nei confronti
dell’umanità: in cima ovviamente Ulisse, ma poi, senza guardar per il sottile, Richelieu, Mazzarino, Machiavelli. Celebrata persino la volpe, simbolo dell’astuzia,
in tutte le letterature, da Esopo a La Fontaine, a Casti, a Goethe; e celebrata la figura del bugiardo, nella forma anche del tartufismo alla Molière, tutto compreso. Alberto, con eclettico ondeggiamento, eleva un inno al relativismo: «Il mondo
oscilla fra una verità relativa e una relativa menzogna; da queste contrarie correnti nasce l’equilibrio e da questo, la possibilità del vivere sociale». E dopo una concessione incongrua ai martiri della verità, conclude, dopo sessanta pagine, con Jean Paul Richter: «Supporre che possa contenersi il concetto universale della verità nella mente dell’uomo, equivale a dar vita alla più grande menzogna».
Evidente che per l’autore menzogna ha in prevalenza un significato morbido,
di bugia bianca, di espediente ipocrita, non di raggiro e, peggio, di trama criminosa; evidente anche che caccia nello stesso sacco, per debolezza dell’impianto,
per compiacere il suo pubblico, cose che non stanno insieme. Ma a dispetto dei limiti evidenti, questa piccola monografia sulla menzogna conserva una sua anomalia e un suo specifico. Non ha la profondità né il tormento gesuitico di Della dis-
simulazione onesta di Torquato Accetto, un testo seicentesco che non poteva conoscere, perché lo riesumò Benedetto Croce nella Storia dell’età barocca anticipata sulla «Critica» negli anni dal 1924 e nell’edizione moderna in volume del 1928.
Ma già questo appartenere a un genere controcorrente dà al profilo del suo autore
una piega inattesa, se non un lato oscuro. È come se Alberto Michelstädter accennasse a un’altra strada, che non percorre, e che anzi esorcizza. In maniera inefficace. Non sarà lui a raccogliere quella tentazione. Ma non ha voluto intonare l’elogio
della menzogna. Si è esposto, ma, come osserva con involontario umorismo Torquato Accetto, che se ne intendeva, chi indossasse la maschera sempre, sarebbe,
per la curiosità suscitata, più noto di chiunque altro. Mentre degli eccellenti dissimulatori, che ci sono stati e che ci saranno, non si ha notizia alcuna.
Il problema della menzogna è legato a quello dell’identità. Secondo Benedetto Carucci Viterbi, Alberto mentisce perché ha perduto l’identità, perché sta cercando l’assimilazione. È così? Rimane il fatto che, nel generale clima perbenistico
e farisaico, le dichiarazioni di Alberto hanno smosso le acque, sono state sentite
anche come una provocazione, si sono prestate a una reazione strumentale. Nella stampa locale, tra Gorizia, Trieste e la sponda slava, accanto ai commenti favorevoli si sono levate le voci di dissenso, politico, ideo­­logico, antisemita, eco anche
di preoccupazioni da Vienna.
Fra tutte propongo questo stralcio da una nota uscita su «Il Rinnovamento» il
5 maggio 1894. Titolo: Come gli ebrei fanno l’apoteosi della menzogna:
16
L’ottima Reichspost di Vienna del 1 corr. publicò un articolo intitolato: Ebraica impudenza, in cui s’occupa della conferenza tenuta recentemente a Trieste dall’ebreo Michlstädter – banchiere e a tempo perso poeta, letterato e giornalista – sul tema: la menzogna…
Se un parroco predica contro il dominio ebraico, ecco che la stampa giudaica e semiti e filosemiti levano un baccano di inferno e chiedono provvedimenti al governo perché
proibisca tali prediche, ma se all’opposto invece un ebreo ardisce proclamare la menzogna come cosa indispensabile e necessaria ai popoli e la innalza ai più eccelsi onori, non
si strepita, ma si tollerano simili attentati alla società e si considera come cosa naturale
l’apoteosi a cui innalza simili attentati la stampa giudaica.
Da rilevare che la polemica del «Rinnovamento» si richiama a un articolo
della «Reichspost» viennese, che a sua volta cita di seconda mano il «Piccolo»
di Trieste, accusato di fare da cassa di risonanza di queste teorie corruttrici. Ed
è chiaro che l’interesse conoscitivo sul tema della menzogna si inquina in chiave di stereotipo antiebraico nel contrasto tra establishment governativo ed élite filoitaliana. Anche in anni successivi, Alberto sarà chiamato in ballo dagli ambienti conservativi cattolici come ispiratore di una lobby dentro il «Piccolo», ac17
sergio campailla
la persuasione e la menzogna
cusa che respingerà con sdegno dalle colonne del «Corriere di Gorizia» di Carolina Luzzatto Coen. Sono le avvisaglie di un sospetto destinato, sotto il fascismo, a degenerare.
Accenno qui a queste polemiche sia perché sono inedite nella letteratura su
Carlo, ma soprattutto perché danno il senso di come la figura di Alberto abbia
conosciuto una sua notorietà nel territorio, assumendo un ruolo di simbolo. Con
una semplificazione, è percepito come l’autore di un testo sulla menzogna, e come
autore ebreo di questo piccolo misfatto culturale.
E Carlo? L’epistolario ci racconta il legame di affetti, che si evolvono da una
prima fase di forte intensità e che, un poco alla volta e rapidamente, si deteriorano. Presuppongo i passaggi fondamentali di questa ricostruzione epistolare. Il figlio rende conto al padre, con puntuale ossequio ma con sempre maggiore impazienza, in un desiderio di emancipazione e in un quadro edipico di conflitto. Nello scritto Περὶ ϰοινωνίας ϰαὶ πολυμαϑίας, paragona gli uomini a chi in un guscio di
noce si trovasse ad affrontare il mare in tempesta: farà di certo una brutta fine e
non ci sarà dunque da rattristarsi troppo quando un’onda più forte si rovesciasse
a chiudere «il triste gioco». Ma si è trovato un rimedio alla fragilità dell’esistenza.
«Gli uomini», commenta duro Carlo, «hanno creato le “Assicurazioni”». E queste
Assicurazioni assomigliano moltissimo alle Assicurazioni Generali, in cui lavora
il padre; e che da quegli inizi di Novecento diventeranno sempre più potenti nella società contemporanea. Così nella Persuasione e la rettorica l’uomo nella botte
di ferro è assicurato contro tutto: infortuni, malattie e morte. Ma, in una dialettica di complicità, quell’assicurato è anche, ambiguamente, un assicuratore. Quella
satira è, nel suo esito ultimo, una protesta contro il padre.
Non è però la comunicazione della pagina, esplicita, quella che svela l’entità drammatica dell’ambivalenza. Per andare a fondo, dobbiamo aprirci alla confidenza di un altro linguaggio, quello figurativo. Carlo ci ha lasciato numerosi
schizzi del genitore, ma due caricature sconfinano, con la forza del messaggio onirico. Il primo: il Padre-Sfinge, un acquerello in cui la sagoma di Alberto si staglia
come una sfinge su un basamento, in uno scenario con piramidi e palmizi. Una
straordinaria figurazione del complesso edipico, teorizzato da un Freud estraneo
a Carlo. Il secondo, Assunzione, è un altro acquerello: Alberto assurge in cielo, in
odore di santità, accolto dal biblico Jahvè. Ma nel volo scopre scandalose gambe
tornite da donna, con scarpe femminili. L’irriverenza qui è illimitata, nei termini
di un vero e proprio smascheramento.
I titoli dei due acquerelli e le identificazioni del personaggio sono miei e risalgono già al tempo di A ferri corti con la vita. Le domande che ne conseguono sono inquietanti.
Mi è già capitato di citare il trattatello Della dissimulazione onesta, opera a suo
modo geniale di un napoletano dell’Italia sotto la dominazione spagnola. Ci ritor-
no adesso. Nel capitolo tredicesimo, intitolato Della dissimulazione che appartiene
alla pietà, Torquato Accetto si mostra convinto che il vino fu trovato dopo il diluvio e sostiene con gusto d’iperbole che non occorreva minor quantità d’acqua per
temperarlo e neutralizzarne le insidie. Porta a questo proposito l’esempio di Noè
che, ubriaco, restò nudo. Due figli, impietositi da quella miseria, lo coprirono, volgendo il viso all’indietro. Ma un terzo, «già alienato da ogni legge di umanità»,
schernisce «ignudo colui che l’avea vestito delle proprie carni». Prosegue, con accenti da sacra rappresentazione: «Oh quanti son al mondo che imitano questa
mostruosa ingratitudine, facendo materia da ridere chi loro doverebber esser oggetto d’amore e di reverenza!». Così suona la deprecazione di Torquato Accetto,
il quale cita a contrasto l’esempio di Giuseppe nei confronti dei suoi fratelli, il tema ebraico e biblico su cui Thomas Mann costruirà un’imponente tela narrativa.
A diversi strati di profondità, il duello inconscio tra padre e figlio, su ciò che è
persuasione, su ciò che è menzogna. Alberto alla fine di Un’oretta di divagazioni,
nel 1902, con un’autoironia non esente da narcisismo sul pericolo di vaniloqui, citava Amleto: «Parole, parole, parole». Risponde, gli risponde, Carlo nell’epigrafe
alle Appendici critiche: «Con le parole guerra alle parole».
Un rapporto che scava nel profondo di entrambi e, da un certo momento in
poi, da quel terribile 17 ottobre 1910, un’eredità rovesciata, del figlio nei confronti del padre. Il quale, in qualche modo, dovrà gestire una quota di rimorso e giustificare, di fronte a sé e agli altri, il suo successo e la sua stessa sopravvivenza allo strazio dei figli; e nella sua immagine pubblica verrà percepito dalla collettività benpensante, prima che si alzi fulgida la stella di Carlo, come una figura positiva, un Giobbe, e sia pure un Giobbe umorista. Esemplare l’aneddoto sulla sua
morte, a quasi ottant’anni, registrato da Augusto Riccio di Solbrito che ne scrisse
una memoria per necrologio. Alberto ormai allo stremo chiedeva di continuo che
ora fosse alla consorte devota, che ogni volta lo accontentava. Al che lui osservò
ridendo, e furono le sue ultime parole: «Ma tu mi dai il tempo col contagocce».
Un contrasto crudele, e umanissimo, nel simbolismo della morte.
Giovane che sotto le apparenze della verità snida la menzogna anche nei luoghi ritenuti inviolabili, con un rifiuto tra i più radicali alla vigilia della prima guerra mondiale, Carlo Michelstaedter ci appare oggi come il testimone e l’interprete del disagio di una civiltà.
1
Si veda su questo delicatissimo punto, un vero tabù mai affrontato prima, il mio Il segreto di Nadia B.
La musa di Michelstaedter tra scandalo e tragedia, Venezia, Marsilio, 2010.
2
Cfr. C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010, p. 38.
18
19
note al testo
il percorso universitario di carlo michelstaedter
Il percorso universitario di Carlo Michelstaedter
dall’archivio dell’Istituto di Studi Superiori
di Valerio Cappozzo
È difficile scegliere se fare Matematica a Vienna o Lettere a Firenze. Rimanere in Austria oppure trasferirsi in Italia è una questione che condiziona la persona
e il carattere, particolarmente negli anni della formazione universitaria. Carlo Michelstaedter si era appena maturato all’illustre liceo cittadino, lo Staatsgymnasium, dove ebbe modo di approfondire la letteratura italiana attraverso un percorso storico e filologico articolato. Fece temi comparativi su Dante e Brunetto Latini; Il Rinascimento e l’età del Leopardi; Achille e Ulisse attraverso l’opera omerica
e dantesca; e anche temi dal titolo: Potenza della parola, in cui si chiedeva un’analisi personale basata sui principali concetti della filosofia greca e tedesca 1.
A casa Michelstaedter la cultura letteraria italiana assumeva un ruolo domestico, costituiva un linguaggio comune in particolare tra Carlo e il padre, Alberto. Anche la madre Emma era una lettrice assidua di romanzi francesi e tedeschi e condivideva con i figli questa passione. La lettura e lo studio erano soggetto di lunghi
discorsi e scambi epistolari con la sorella Paula e con i primi amici goriziani Enrico Mreule e Nino Paternolli. Discutere di letteratura, filosofia, teologia, faceva parte del suo rapporto con le persone che gli erano care e con le quali aveva condiviso
gli anni della formazione scolastica e, dal novembre del 1905, quella universitaria.
La scelta difficile che si poneva dopo la maturità cade su Firenze e Carlo si
trasferisce per formarsi nella città dell’arte medievale e rinascimentale, simulacro
del passaggio dall’epoca comunale alla corte medicea. Grazie all’amicizia del padre con il professor Guido Mazzoni, viene indirizzato verso l’iscrizione al Regio
Istituto di Studi Superiori. Pur se con un’iniziale reticenza, l’idea di potersi immergere tra i modelli dell’arte su cui fare esercitazioni pittoriche e la «possibilità
d’ottenere un permesso» per entrare nei musei, lo convinsero ad accettare: «Per
me potete immaginarvi che l’iscrizione regolare è una gran bella cosa, perché mi
20
da’ per diritto tutte quelle cose che io desidero, come il passo libero alle gallerie
e l’uso a casa dei libri di tutte le biblioteche» 2.
Dal novembre del 1905 Carlo Michelstaedter segue i corsi al «Regio Istituto
di Studi Superiori pratici, e di perfezionamento» a Firenze, in piazza San Marco,
sede dell’odierno Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze che nascerà nel
1923 dalla trasformazione dell’istituto. La ricchezza delle materie offerte e l’alto valore dei professori facevano dell’Istituto di Studi Superiori una scuola molto
ambita per i suoi principi riformatori e innovatori, com’era stato lo Studio Fiorentino dalla fondazione al Cinquecento 3.
Lo Studio Fiorentino venne istituito con la bolla pontificia In supremae dignitatis speculo, emessa da papa Clemente vi ad Avignone nel 1343. Nel 1364 Carlo vi lo promuove a università, «ad sacri splendore Imperii […] erigere dignaremur» 4. Questa istituzione rappresenta per Firenze l’origine della ricerca scientifica in ambito accademico. Nel Rinascimento fiorentino si comincia a sentire l’esigenza di affiancare alla ricerca teorica la sperimentazione pratica nei laboratori,
nei gabinetti d’analisi e nelle biblioteche. Uscendo dalle aule i lavori dello Studio
si espansero fuori dai confini della lezione cattedratica.
La Toscana volse il pensiero alla necessità di questi studi d’applicazione dalle scienze all’arte; e distinse i pratici dai così detti teorici, e volle per questi conferita la laurea,
per quelli la matricola di libero esercizio: il Regno italico deve farne la base delle generali leggi sull’istruzione pubblica 5.
Con decreto del governo toscano lo Studio Fiorentino diventa «Istituto di Studi Superiori pratici, e di perfezionamento», il 22 dicembre 1859. Il decreto è firmato da Bettino Ricasoli, presidente del Consiglio dei ministri, e da Cosimo Ridolfi, ministro dell’Istruzione. L’istituto nasce distinto in tre sezioni: «Studi legali, di Filosofia e Filologia», «Medicina e Chirurgia», «Scienze naturali». L’aspirazione dei fondatori è quella di «mantenere in Firenze un tipo di scuola superiore
che, per non essere chiusa entro gli schemi canonici della Università, rispondesse veramente ai bisogni di un progresso in atto: una scuola rinnovatrice in un momento rivoluzionario» 6.
Nel 1866 divenne preside Pasquale Villari, che contribuì in maniera determinante allo sviluppo dell’istituto. Con «una grande simpatia per le riforme più utili indicate dal progresso de’ tempi» 7, volle adattare la sezione di materie umanistiche a favore degli studi filologici e, con l’esclusione del settore giuridico, la sezione di «Studi Legali, di Filosofia e Filologia» divenne la «Facoltà di Lettere e Filosofia» 8. In questa scuola Michelstaedter intraprende il suo percorso universitario
che lo porterà alla scrittura di La persuasione e la rettorica.
La parte della sua biografia relativa agli anni fiorentini non era sinora precisa
21
valerio cappozzo
il percorso universitario di carlo michelstaedter
a causa della carenza di documentazione. Nel catalogo della mostra Far di se stesso fiamma Sergio Campailla ha pubblicato di recente il registro degli esami sostenuti da Michelstaedter 9. Un materiale importante che comincia finalmente a mettere luce sulla carriera universitaria del giovane goriziano. Dal giugno del 2006,
grazie all’aiuto della dottoressa Paola Navone, ho visionato gli archivi dell’Istituto di Studi Superiori relativi agli anni 1905-1910, nella sala consultazione Rari
della Biblioteca umanistica della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Firenze.
I documenti sono raccolti nella serie degli «Affari risoluti», composta di buste cartacee legate in cartone e costola in pergamena che raccolgono la documentazione prodotta e ricevuta dalla «Sezione di Studi legali, filosofici e filologici».
Contengono inoltre i «Verbali delle adunanze», le copie dei «Verbali del Consiglio della facoltà di Lettere e Filosofia» con il carteggio relativo; i «Registri degli iscritti», «Orario e programmi delle lezioni», le «Sessioni di esami regolari e
straordinarie», le «Istanze d’ammissione agli esami» e le «Carriere scolastiche degli studenti» 10.
Attraverso la sterminata quantità di fogli che formano questo archivio si può
risalire al primo giorno, sabato 4 novembre del 1905, quando si inaugurò il primo
anno accademico di Michelstaedter. A quella data l’assetto dell’istituto comprendeva l’insegnamento di 37 materie per 211 studenti suddivisi in 106 iscritti regolari al corso di laurea, 3 di complemento, 58 uditori, 2 di paleografia, 4 di corsi
orientali e 38 di perfezionamento 11.
Iscritto a Letteratura italiana, latina e greca, Lingua latina e greca, Storia antica e Storia moderna, fa subito amicizia con i due colleghi che gli resteranno uniti
sino alla fine e che si proporranno di prolungarne il ricordo anche dopo la morte, facendosi editori delle sue opere: Vladimiro Arangio-Ruiz e Gaetano Chiavacci. Con loro conosce Aldo Oberdorfer, Giannotto Bastianelli, Antonio Giachetti,
Emilio Cecchi, Scipio Slataper, Jolanda de Blasi, Giuseppe De Robertis, Eugenio
Treves, solo per segnalare i nomi più celebri.
Per il corso di laurea Michelstaedter ha sostenuto 25 esami complessivi, lo
scritto di latino e quattro materie libere: Storia moderna con due annualità, Pedagogia e Lingua tedesca. Ha biennalizzato Storia antica con Achille Coen; Storia
moderna, la prima annualità con Coen e la seconda con Carlo Cipolla. Ha triennalizzato Letteratura italiana con Guido Mazzoni, Letteratura latina con Felice
Ramorino e Letteratura greca con Girolamo Vitelli, il relatore della tesi 12.
Di seguito si presentano i programmi dei corsi seguiti da Michelstaedter. Sono
disposti in ordire cronologico secondo la data del giorno di discussione dell’esame, con tutte le informazioni rinvenute tra cui la cattedra, il professore incaricato o il supplente, il programma del corso, il nominativo degli studenti, il numero degli iscritti, la data e il voto degli esami sostenuti e note aggiuntive qualora ci
siano dati rilevanti. A conclusione di ogni anno accademico si trascrivono le lettere autografe mandate alla segreteria dell’istituto trovate tra i protocolli della corrispondenza in arrivo.
22
23
programmi dei corsi, aa 1905-1906, i anno
Letteratura italiana, prof. Guido Mazzoni.
«Programma del corso: i. Storia letteraria. La letteratura italiana nella seconda metà del secolo xviii (in continuazione al corso dell’anno precedente). ii. Lettura: Il Purgatorio di Dante. iii. Esercitazioni: Avviamento allo studio critico delle lettere italiane. Alcune delle principali relazioni tra la letteratura italiana e le
altre moderne».
Corso seguito con Vladimiro Arangio-Ruiz, Giovanni Bastianelli, Gaetano
Chiavacci, Aldo Oberdorfer. 123 iscritti.
Esame sostenuto il 19 giugno 1906 con il voto di 29/30.
Per il terzo modulo di questo corso, nel maggio del 1906, Michelstaedter consegnerà la tesina comparativa su Lessing e Baretti 13.
Geografia, prof. Olinto Marinelli.
Manca il programma del corso
Corso seguito con Oberdorfer e Giachetti. 51 iscritti.
Esame sostenuto il 22 giugno 1906 con il voto di 27/30.
Lingua latina, prof. Ermenegildo Pistelli.
«Programma del corso: A) Metrica della Commedia. Interpretazione d’una
commedia di Terenzio (Adelphoe). B) Interpretazione del secondo libro delle Satire di Orazio».
70 iscritti.
Esame sostenuto il 29 giugno 1906 con il voto di 30/30.
Lingua greca, prof. Ermenegildo Pistelli.
«Programma del corso: A) Dialetto omerico. Interpretazione di alcuni libri
dell’Iliade. B) Interpretazione di alcune Vite di Plutarco».
Corso seguito con Arangio-Ruiz, Bastianelli, Chiavacci e Giachetti. 81 iscritti.
Esame sostenuto il 29 giugno 1906 con il voto di 28/30.
Grammatica comparata delle lingue classiche e neolatine, professor Ernesto
Giacomo Parodi.
Manca il programma del corso
valerio cappozzo
Corso seguito con Bastianelli e Chiavacci. 44 iscritti.
Esame sostenuto il 30 giugno 1906 con il voto di 29/30.
Storia moderna, prof. Pasquale Villari, prof. Achille Coen, supplente.
«Programma del corso di Villari: i. Considerazioni generali sulla storia e sul
metodo. ii. Si condurrà a termine il corso cominciato nel 1903-1904 e continuato
nel 1904-1905. 1. Storia fiorentina dagli Ordinamenti di giustizia sino alla morte
di Arrigo vii. 2. Fondazione dell’Impero di Carlo Magno».
Programma del corso corretto da Coen, diventato effettivo: «i. Storia della Toscana, e particolarmente dello Stato fiorentino, durante il regno di Cosimo
i dei Medici (continuazione del corso dell’anno 1904-1905). ii. Metodologia e bibliografia storica».
Corso seguito con il solo Arangio-Ruiz. 91 iscritti.
Esame sostenuto il 22 ottobre 1906 con il voto di 27/30.
Letteratura latina, prof. Felice Ramorino.
«Programma del corso: A) storia letteraria del v e vi secolo dell’era volgare,
dal 430 a Gregorio Magno. B) lettura di autori: a) Lucrezio, lib. v. b) Tacito, Annali xv. c) Esercitazioni di stile e lingua latina».
Corso seguito con Antonio Francesco Giachetti (soprannominato «Giacchettucci»). 105 iscritti.
Esame sostenuto il 6 novembre 1906 con il voto di 30/30.
Letteratura Greca, prof. Girolamo Vitelli.
«Programma del corso: La tragedia di Sofocle. Interpretazione dell’Antigone.
I giovani saranno invitati alla lettura delle altre sei tragedie» 14.
Corso seguito con Bastianelli e Giachetti. 92 iscritti.
Esame sostenuto il 19 novembre 1906 con il voto di 29/30.
Storia Antica, prof. Pasquale Villari, prof. Achille Coen supplente.
«Programma del corso: i. Storia interna di Roma dal tribunato di Tiberio Sempronio Gracco alla uccisione di C. Giulio Cesare. ii. Storia della caduta dell’Impero romano d’Occidente (continuazione del corso dell’anno 1904-1905). Conferenze Cronologia storica, particolarmente greca e romana».
47 iscritti.
Esame sostenuto il 28 giugno del 1907 con il voto di 30/30.
il percorso universitario di carlo michelstaedter
Corso seguito con Bastianelli, Chiavacci, Oberdorfer. 36 iscritti.
Esame sostenuto il 22 luglio 1907 con il voto di 28/30.
Firenze, 6 giugno 1906
Ill.mo Signor Preside
Della facoltà di Filosofia e lettere
Il sottoscritto chiede d’esser ammesso nella sessione di Giugno ai seguenti esami:
Letteratura italiana, Storia comparata delle lingue classiche e neolatine, Letteratura
latina, Lingua latina e greca, Geografia.
Carlo Michelstädter 15
Firenze, ottobre 1906 16
Spettabile segreteria
Il sottoscritto chiede d’essere ammesso per la sessione d’ottobre ai seguenti esami:
Letteratura latina, Letteratura greca, Storia moderna.
Carlo Michelstädter
programmi dei corsi, aa 1906-1907, ii anno
Lingua tedesca, prof. Carlo Fasola.
Manca il programma del corso
Il 29 aprile 1907 sostiene l’esame da non frequentante con il voto di 30/30.
Filosofia teoretica, prof. Felice Tocco, prof. Francesco De Sarlo supplente.
«Programma del corso: Il sottoscritto insegnerà la storia della filosofia moderna a cominciare da G. Hegel, e nelle conferenze leggerà i testi del Ritter-Preller
sulla sofistica e su Socrate. Parte generale. Introduzione allo studio della filosofia. – Parte generale. La percezione interiore e la conoscenza di sé».
Esame sostenuto il 26 giugno 1907 con il voto di 28/30.
Lingue e Letterature neo-latine, prof. Pio Rajna.
«Programma del corso: La lingua e la letteratura latina del medioevo. Continuazione del corso di lingua e letteratura provenzale».
Letteratura italiana (ii annualità), prof. Guido Mazzoni.
«Programma del corso: i. Storia letteraria. La letteratura italiana nella prima
metà del secolo xix (in continuazione al corso dell’anno precedente). ii. Esercitazioni: Avviamento allo studio critico delle lettere italiane. Manzoni e la critica
romantica».
Esame sostenuto l’8 luglio 1907 con il voto di 27/30. Il coro nella teoria e in al-
24
25
valerio cappozzo
il percorso universitario di carlo michelstaedter
cune sue forme originali in Italia come tesina per il corso e lavoro conclusivo del
biennio.
renze. Illustrazione di testi epigrafici latini e greci di speciale importanza storica».
Corso seguito con Arangio-Ruiz, Bastianelli, Chiavacci.
Esame sostenuto il 4 luglio del 1908 con il voto di 28/30.
Letteratura greca (ii annualità), prof. Girolamo Vitelli.
«Programma del corso: La tragedia di Euripide. Interpretazione dell’Elettra. I
giovani saranno invitati alla lettura di altre tragedie Euripidee (Alcestide, Medea,
Ecuba, le due Ifigenie, Oreste, Elena). Interpretazione della Costituzione di Atene
di Aristotele».
Corso seguito con Arangio-Ruiz, Chiavacci, Jolanda de Blasi.
Esame sostenuto il 13 novembre 1907 con il voto di 30/30.
Letteratura latina (ii annualità), prof. Ermenegildo Pistelli, incaricato.
«Programma del corso: A) interpretazione dell’arte poetica di Orazio. B) La
tragedia di Seneca: lingua, grammatica, metrica. Interpretazione della Fedra e
delle Troiane».
Esame sostenuto il 29 novembre 1907 con il voto di 28/30.
Lingua latina, prof. Ermenegildo Pistelli, incaricato.
«Programma del corso: 1) Lettura dei frammenti delle tragedie di Marco Pacuvio e di Lucio Accio. 2) Esercizi di versione in latino e di composizione latina.
3) Storia letteraria: le opere di prosa dei secoli v e vi dell’era volgare».
Corso seguito con gli studenti di primo anno Emilio Cecchi, Eugenio Treves.
Esame scritto sostenuto il 30 novembre 1907 con il voto di 27/30.
Lingua greca, prof. Ermenegildo Pistelli, incaricato.
«Programma del corso: I dialetti greci. Interpretazione di iscrizioni (ed. Solmsen, Lipsia 1905), di frammenti dei lirici e d’un libro di Erodoto».
Corso seguito con Cecchi e Treves.
Esame scritto sostenuto il 30 novembre 1907 con il voto di 24/30.
Storia moderna, prof. Carlo Cipolla.
«Programma del corso: Delle riforme in Italia nel secolo xviii e particolarmente delle riforme in Toscana».
Esame sostenuto il 2 maggio 1908 con il voto di 26/30.
Archeologia, prof. Luigi A. Milani.
«Programma del corso: 1) Propedeutica archeologica. 2) Arte e religione degli Etruschi (continuazione dell’anno precedente). 3) La plastica greca arcaica. 4)
Esercitazioni archeologiche sui principali tipi e rappresentanze degli Dei ed eroi».
Esame sostenuto il 19 novembre 1908 con il voto di 25/30.
Firenze 21 marzo 1907
Ill.mo Signor Preside
Della facoltà di Filosofia e lettere
del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze
Lo studente di secondo anno Carlo Michelstädter, essendo stato durante la scorsa sessione autunnale sovraccarico di esami e di lavoro, e dovendo d’altra parte in quest’anno
compiere il numero di esami prescritto per presentare la tesina di licenza biennale, desidererebbe di non avere materie arretrate nella prossima sessione di giugno e fa perciò domanda a questa facoltà di essere inscritto all’esame di Storia Antica per la imminente sessione straordinaria, fiducioso che gli si vorrà concedere quest’agevolezza.
Carlo Michelstädter
Dopo aver sostenuto questi esami, il 16 dicembre del 1907 Michelstaedter sostenne l’esame di Licenza biennale, con voto di 30 e lode.
programmi dei corsi, aa 1907-1908, iii anno
Nota: I programmi dei corsi sono scritti su fogli autografi non definitivi e senza registri, per cui è difficile ricostruire anche con chi frequentasse i corsi. Senza
dubbio alla maggior parte delle lezioni erano presenti i colleghi già citati.
Storia antica, prof. Achille Coen.
«Programma del corso: 1) La politica religiosa del governo imperiale romanobizantino, particolarmente rispetto al Paganesimo, da Costantino a Giustiniano. 2)
Storia interna di Roma dal tribunato di Tiberio Sempronio Gracco alla uccisione
di Caio Giulio Cesare. (Continuazione del corso dell’anno antecedente). 3) Confe-
Storia moderna, prof. Carlo Cipolla.
«Programma del corso: Proseguendo il corso iniziato nel passato anno, si parlerà di alcune forze accentratrici che agirono durante l’età medievale e di alcune
forze decentratrici che agirono durante l’età medievale facendo sentire la loro efficacia nelle organizzazioni politiche ed amministrative in Italia».
Esame sostenuto il 2 maggio 1908 con il voto di 26/30. Corso seguito in aggiunta a quello dell’anno precedente.
26
27
valerio cappozzo
il percorso universitario di carlo michelstaedter
Letteratura italiana (iii annualità), prof. Guido Mazzoni.
Manca il programma del corso
Esame sostenuto il 17 giugno 1908 con il voto di 28/30. Per questo esame preparò la tesina L’orazione “Pro Q. Ligario” tradotta da Brunetto Latini 17.
Esame mai sostenuto, materia facoltativa avendo già frequentato Lingua greca e latina.
Storia della filosofia, prof. Felice Tocco.
Manca il programma del corso
Esame sostenuto il 23 giugno 1908 con il voto di 27/30.
Storia antica, prof. Achille Coen.
«Programma del corso: 1) La politica religiosa del governo imperiale romano-bizantino, particolarmente rispetto al Paganesimo, da Costantino a Giustiniano. (continuazione del corso dell’anno antecedente). 2) Storia interna di Roma dal
tribunato di T Sempronio Gracco alla uccisione di C. Giulio Cesare (continuazione). 3) Conferenze. Le magistrature romane durante la repubblica (continuazione
e fine del corso dell’anno antecedente). 4) Le magistrature romane durante l’impero da Augusto a Diocleziano».
Esame sostenuto il 4 luglio 1908 con il voto di 28/30. Corso seguito in aggiunta a quello dell’anno precedente.
Pedagogia, prof. Felice Tocco.
Manca il programma del corso
Esame sostenuto il 9 luglio 1908 con il voto di 27/30.
Letteratura greca, prof. G. Vitelli.
«Programma del corso: Interpretazione dell’Odissea e di Pindaro. Di alcune
questioni omeriche».
Esame sostenuto il 10 novembre 1908 con il voto di 30/30.
Letteratura latina, prof. Ramorino.
«Programma del corso: 1) La cultura pagana quale si rispecchia negli scrittori cristiani. 2) Lettura dei libri vi, vii, viii delle Confessioni di S. Agostino. Lettura di alcuni poemetti dell’Appendice virgiliana. 3) Esercizi di lingua e stile».
Esame sostenuto scritto e orale il 7 dicembre 1908 con i voti rispettivamente di 27/30 e 29/30.
Paleografia classica, prof. Rastagno.
«Programma del corso: 1) Codici greci: nozioni generali. 2) Codici latini classici: del loro uso e scopo filologico. 3) Esercizi speciali di lettura e traduzione da
scritture greche più difficili, comprese quelle dei papiri».
28
Firenze – 18 febbraio 1908
Illustrissimo Preside della Facoltà di Filosofia e Lettere
Il sottoscritto chiede che gli venga esibito il suo attestato di licenza liceale – (dopo
fatta da questa la voluta copia legale per l’archivio) – che gli necessita per ragioni di servizio militare; e gli sia certificato ch’egli è regolarmente iscritto al terz’anno di lettere di
quest’inclita Facoltà e ne frequenta regolarmente le lezioni.–
Carlo Michelstädter
scuola di magistero, perfezionamento, aa 1908-1909, i anno
Nel semestre primaverile di questo anno accademico Michelstaedter seguì
delle lezioni non per il corso di laurea, ma per il i anno della scuola di Magistero, valevole anche per il perfezionamento. Probabilmente era intenzionato a completare l’intero ciclo offerto dall’istituto per avere l’abilitazione all’insegnamento, com’era effettivamente nei suoi propositi: «tra tre anni sarò professore a Gorizia o a Trieste» 18.
Corsi che segue per la scuola di Magistero nell’anno accademico 1907-1908
Letteratura Italiana, prof. Guido Mazzoni.
Manca il programma del corso
Esame non sostenuto.
Grammatica latina e greca, prof. Ermenegildo Pistelli.
Manca il programma del corso
Esame non sostenuto.
Corsi che segue per la Scuola di Magistero nell’anno accademico 1908-1909
Propedeutica storica, prof. Villari.
Manca il programma del corso
Esame sostenuto il 22 luglio 1909 con voto di 21/30.
Geografia, prof. Olinto Marinelli.
Manca il programma del corso
Esame non sostenuto.
29
valerio cappozzo
il percorso universitario di carlo michelstaedter
Lingua latina, prof. Ermenegildo Pistelli.
«Programma del corso: Virgilio, del tradurre Virgilio. Eneide. Leggenda di
Enea. Eneide i, 1-33; 150-222; 223-304; 306 ss.».
Esame non sostenuto.
le ideati in Firenze e di quelli ammessi dall’onorevole Commissione del Senato rispetto alla proposta del senatore Matteucci, in «Lo Sperimentale», ix, 1862, pp. 193-222, citazione a p. 202.
6
Garin, L’Istituto di Studi Superiori, cit., p. 37.
7
Così la recensione al Discorso inaugurale alle lezioni dell’Istituto di studi superiori in Firenze, del prof.
Preside Pasquale Villari, Gazzettino bibliografico, in «Rivista Contemporanea Nazionale Italiana», xvii, lvi,
1869, p. 118.
8
«Ad esso si accorse da ogni parte d’Europa. Pareva che fosse divenuto la scuola del mondo». P. Villari, Storia, politica e istruzione, Milano, Hoepli, 1914, p. 423.
9
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, catalogo della mostra a cura di S. Campailla (Gorizia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 17 ottobre 2010-27 febbraio 2011), Venezia, Marsilio, 2010, pp.
98-99. A p. 100 è pubblicata la lettera M della «Rubrica degli studenti iscritti».
10
Durante il trasloco dell’archivio dell’istituto dalla sede del Rettorato in piazza San Marco, una parte è andata nel pozzo librario della facoltà di Lettere e filosofia e l’altra all’Archivio di deposito di via delle
Gore; ne è stato fatto un inventario che comprende anche una parte dei documenti relativi alle carriere degli studenti che, al 2006, stavano momentaneamente presso le segreterie della facoltà in via San Gallo in attesa di essere ordinati. Cfr. Archivio storico dell’Università degli studi di Firenze (1860-1960), Guida inventario, a cura di F. Capetta, S. Piccolo, Firenze, Firenze University Press, 2004.
11
Lista delle cattedre al 1905: Letteratura italiana, proff. Guido Mazzoni, Guglielmo Volpi; Letteratura latina, prof. Felice Ramorino; Letteratura greca, prof. Girolamo Vitelli; Lingua latina, Lingua greca,
prof. Ermenegildo Pistelli; Storia moderna, proff. Achille Coen, Pasquale Villari, Gioacchino Volpe; Storia antica, prof. Achille Coen; Geografia, prof. Olinto Marinelli; Grammatica comparata delle lingue classiche e neo-latine (per errore c’è scritto Storia comparata), prof. Ernesto Giacomo Parodi; Lingue e letterature neo-latine, proff. Pio Rajna, Mario Schiff; Filosofia teoretica, Filosofia morale, Psicologia sperimentale, prof. Francesco De Sarlo; Storia della filosofia, prof. Felice Tocco; Archeologia, prof. Adriano Dilani; Paleografia latina, Paleografia diplomatica, Bibliografia Storica, prof. Luigi Schiapparelli; Paleografia classica, prof. Enrico Ristagno; Istituzioni medioevali, prof. Alberto del Vecchio; Antropologia, prof. Paolo Mantegazza; Biologia elementare, prof. Gilberto Rossi; Lingua tedesca, Letteratura tedesca, prof. Carlo Fasola;
Sanscrito, prof. Paolo Emilio Pavolini; Ebraico, prof. Francesco Scerbo; Arabo, prof. Fausto Lasino; Lingue
semitiche comparate, prof. Peretz Hirsch Chajes; Storia e geografia dell’Asia orientale, prof. Carlo Puini; Paleografia Classica, prof. Enrico Ristagno; Meteorologia, prof. Carlo Marafoni; Economia politica, prof. Jean
de Johannis; Biologia elementare, prof. Gilberto Rossi; Morfologia terrestre, prof. Olinto Marinelli; Astronomia sferica, prof. Antonio Loperfido; Cartografia, prof. Attilio Mori; Lingue scientifiche, prof. Fausto Lasino. Altre cattedre come Paleontologia, Assiologia, Storia dell’arte, Dottrina archivistica e Cronologia del
Medio Evo non furono assegnate.
12
Il Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia prevedeva: «Materie obbligatorie per Filologia classica Filologia moderna, Storia e Geografia: Letteratura italiana, Letteratura latina, Letteratura greca, Filosofia teoretica o Storia della filosofia. Materie specifiche per Filologia classica: Grammatica greca e latina
oppure Paleografia ed epigrafia greca e latina; Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine oppure
Sanscrito; Storia antica, Archeologia. 21 esami annuali complessivi su 12 materie più quattro materie libere più la prova scritta di Latino».
13
Le tesine scritte per i corsi universitari sono in: Scritti scolastici, a cura di S. Campailla, Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1976.
14
Aiace, Edipo re, Elettra, Filottete, Trachinie, Edipo a Colono.
15
Si noti la grafia del nome con la dieresi sulla a e non l’uso contemporaneo con ae.
16
Manca la data precisa.
17
Cfr. Scritti scolastici, cit., pp. 171-200.
18
Lettera al padre in data 27 maggio 1907.
19
Discorso del professor Pasquale Villari, 18 novembre 1899, in Fondazione Villari, Firenze, Tipografia di G. Barbèra, 1900, p. 47. Discorso tenuto in occasione del festeggiamento per i quarant’anni di insegnamento.
Lingua greca, prof. E. Pistelli.
«Programma del corso: Lettura della Poetica di Aristotele – Demostene, le Filippiche. Aristotele la metrica e la poetica viste nell’insieme della sua filosofia. La
catarsi pathematon. Poetica cap. vi».
Esame non sostenuto.
L’anno accademico 1909-1910 sarà dedicato soprattutto alla stesura della tesi
di laurea affrontata dopo questo impegnativo corso di studi che, tornando ora alla luce, mostra bene la complessità e la serietà dell’Istituto di Studi Superiori. Qui
Carlo Michelstaedter raggiunse sì un apice intellettuale, ma al prezzo di un naufragio senza ritorno.
Pochi anni prima fu proprio il preside Pasquale Villari ad ammonire profeticamente: «voi tutti avete le mille volte sentito parlare di giovani che non studiano, che pensano solo a fare indebite vacanze. Ma io affermo, e sono certo che i
miei colleghi non smentiranno, che noi abbiamo piuttosto faticato a persuadere i
nostri discepoli a non studiar troppo, con danno non di rado della loro salute» 19.
note al testo
1
Per i documenti relativi alla carriera scolastica di Michelstaedter allo Staatsgymnasium si veda C.L.
Bozzi, Carlo Michelstaedter studente ginnasiale, in «Studi goriziani», xl, luglio-dicembre 1966, pp. 3-13.
2
Lettera alla famiglia del 9 novembre 1905. L’epistolario di Carlo Michelstaedter, scritto con rigore
confessionale, è estremamente significativo per la ricostruzione biografica. Ora in un’edizione aggiornata a
cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010.
3
Per una storia approfondita dello Studio Fiorentino dalle origini alla fondazione dell’Università degli
Studi di Firenze si veda: E. Garin, L’Istituto di Studi Superiori di Firenze (cento anni dopo), in La cultura italiana tra 800 e 900, Bari, Laterza, 1962, pp. 29-66; C. Ceccuti, Alle origini dell’Università fiorentina: l’Istituto di Studi Superiori, in «Rassegna Storica Toscana», xxii, 1977, pp. 177-203; G. Spadolini, Genesi dell’università fiorentina negli anni di Ricasoli e di Capponi tracciata da un professore con trentacinque anni di insegnamento (1985), in La Firenze di Gino Capponi fra restaurazione e romanticismo, gli anni dell’“Antologia”, Firenze, Edizioni della Cassa di Risparmio di Firenze, 1985, pp. 323-330; S. Rogari, Cultura e istruzione superiore a Firenze dall’unità alla grande guerra, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1991; M. Moretti, Carlo Cipolla, Pasquale Villari e l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento, Verona, Accademia di Scienze e Lettere di Verona, 1994, pp. 33-81; Istituzioni culturali in
Toscana dalle loro origini alla fine del Novecento, atti del ciclo di conferenze, a cura di F. Adorno, M. Bossi, A. Volpi (Firenze, Gabinetto G.P. Vieusseux, gennaio-marzo 1995), Firenze, Edizioni Polistampa, 2000.
4
Statuti dell’Università e Studio Fiorentino, a cura di C. Morelli, vii, Firenze, tipi di M. Cellini e c.,
1881, p. 139 (in data 2 gennaio 1364).
5
C. Ridolfi, R. Lambruschini, M. Bufalini, Confronto ragionato d’alcuni ordinamenti di pubbliche scuo-
30
31
insonnia e dolore in carlo michelstaedter
Io lo so che non è vero, ma come non crederci. Carlo, almeno una volta, sarebbe potuto andare al duomo e scorgere in alto l’Allegoria della Gloria celeste, il
sogno di Giulio Quaglio. E se ci fosse stato, avrebbe capito che la Gorizia gotica
è una città barocca (il “barocchetto goriziano»), che vuol dire un’arte inebriante
di rovine, la gloria di uno stile che incenerisce lentamente il proprio delirio senza, tuttavia, consumarlo. Quel sogno a noi è stato tolto dalle bombe della grande
guerra; e senza un acquerello o qualche triste foto non ne sapremmo più niente.
Ma Carlo no: lui, ragazzo, la vide; avrebbe potuto vederla. Il barocco goriziano è
fisicità, è ingombro, ma anche perdita dei sensi. La letteralità della luce di Quaglio si dà come una materia o meglio come la gravità della materia; una specie di
carne gonfia, a tratti senile e pelosa, quasi appiccicata sui corpi sino alla morsa
della finzione, come se quella materia fosse fissata dalla pittura nella maestosità
di un sospeso cedimento.
Era, sarebbe dovuta essere, un’allegoria che fa dell’aria, sotto l’affresco, un
vuoto letterale, cioè una corposa presenza invisibile. In questo senso, tutto all’opposto del capolavoro di Andrea Pozzo nella chiesa romana di San­­t’Ignazio: qui
il cielo multiforme abbraccia e stringe gli occhi del popolo in un azzurro rosso e
giallo che porta in alto, verso il Signore; lì, a Gorizia, nella chiesa di Sant’Ilario e
Taziano, il cielo sta invece per rovinare a terra ed è gonfio di una leggerezza chiusa, chiede a tutti di difendersi così come si può, nell’esistenza, con la preghiera.
«Svegliati completamente!» annota un santo del vecchio secolo, Ludwig Wittgenstein nel Diario 1936-1937 (i Movimenti del pensiero). E allora, se lo fai, «capisci di non valere nulla; e con ciò cessa per te la gioia per questo mondo. E non può
nemmeno ritornare, se tu rimani sveglio». Muore la gioia, muore il dolore. Ma
quel risveglio è lo stesso dei cristiani? Il risveglio che invoca l’Allegoria della Glo-
ria celeste è quello o è altro? Carlo, se fosse andato un giorno in duomo, avrebbe
capito. Non svegliarti completamente: la pittura te lo dice. Il barocchetto goriziano (nato da una Controriforma che manda lassù contro i «lupi riformati» gruppi
di francescani, suore e la compagnia di Gesù per insegnare l’ortodossia a un popolo confuso), domandava, infatti, altro. Certo, «svegliati»; il mondo sta per finire: la terra è diventata, come questo mondo di dubbi e dolori, un luogo pericoloso. «Svegliati», non c’è altro da fare. Ma fino a un certo punto: fermati prima – invoca la pittura – di quell’assurdo avverbio wittgensteiniano («completamente»),
ovvero di ciò che spazza via il dolore e la gioia e li rende futili, persino dementi,
come se non ci fosse nient’altro (alcuna altra «plaga», avrebbe detto un poeta di
quegli anni), né morte né più esistenza, da abitare.
È questo il punto. Se Carlo fosse andato un giorno con il padre sotto la volta del duomo e avesse visto quello che a noi è oggi precluso, avrebbe sì capito la
gravità della materia, la luce che piove a basso, il peso della cenere; ma avrebbe compreso che l’allegoria del cristianesimo domanda un passo, un salto, nulla di più, quello del piccolo Zaccheo sull’albero, ma senza per questo superare la
soglia, senza bruciare le navi e le corde tirate delle tende. L’affresco del maestro
Quaglio invocava preghiera: pazienza, misericordia; in pieno diritto e dovere ogni
fatto dell’esistenza; un piede dentro e un piede fuori dalla vita, l’ascolto e l’amore intelligente verso le nostre profonde incapacità, verso il nostro delirio di esseri – nient’altro.
«Svegliati», però mai completamente: incenerisci diligentemente il tuo delirio senza mai decidere di consumarlo. Abbiamo bisogno che il sonno ci accarezzi ancora un po’ in mezzo al risveglio dell’anima: abbiamo bisogno che l’illusione della vita resti nella luce della rivelazione, perché a noi non è concesso niente, né davvero sapienza, né intangibile fede, quanto solo la fiducia a una promessa che ci è stata fatta e che non capiamo, hodie mecum eris in paradiso, e possiamo
appena mormorare di sera con le labbra stanche. Svegliati; non aver paura che le
palpebre siano ancore chiuse. Solo Dio, recita il santo Corano (39, 42), «chiama a
sé […] le anime che non muoiono, durante il sonno». Il dono più grande che possiamo avere non è effetto dell’interpretazione, ma è piuttosto la rappacificazione
con noi stessi, con la stessa creazione. Abbiamo bisogno di fiducia e di pazienza:
di un tempo della preghiera in cui scorra il tempo della vita, senza che l’intensità,
gli occhi sbarrati, la visione completa e mostruosa, accadano in noi, giacché quella conoscenza sarebbe solo accecamento e non ciò di cui abbiamo bisogno. Appunto, far finire in noi il più grande peccato contro Dio: l’esistere, il senso di colpa contro noi stessi; ciò che ci opprime e non ci fa pregare.
Ma forse Carlo quella pittura in alto non la vide; era troppo preso a fare le caricature dell’umanità lungo le navate. Non ci sarà mai andato con suo padre al
duomo. Peccato. La pittura gli avrebbe detto che pensare è un atto di gratitudi-
32
33
Insonnia e dolore in Carlo Michelstaedter
di Arnaldo Colasanti
arnaldo colasanti
insonnia e dolore in carlo michelstaedter
ne; che il grumo e la gravità delle illusioni vanno accolte e sbriciolate lentamente
nel loro cedimento in noi stessi, senza mai, però, che ci si colpevolizzi, e fino alla
distruzione, solo per punirle. Perché non comprese? Quel povero ragazzo dolce
e intelligente se ne andò triste per la città dei morti, sigillato dalla “lettera” di un
desiderio di epistrophé. O come dice il grande James Hillman in Il suicidio e l’anima: «il suicidio offre l’immersione e una possibilità di rigenerazione attraverso il
lato oscuro di Dio. Vuole confrontarsi con l’ultima, o la peggiore, verità di Dio, la
Sua negatività nascosta». Così il risveglio rimase una completa insonnia. La solitudine di un ragazzo a cui è permessa appena l’agonia, l’assenza di sonno e di sogni. Una furia contro se stessi.
Carlo divenne filosofo: almeno un laureando. La sua famosa tesi fu il racconto
di un peso, descrisse la trappola di un’urgenza che nemmeno fa più male giacché,
ormai, è necessaria. Necessità, appunto. Sottilmente (con un imprevisto retrogusto aristotelico che Carlo avrebbe abiurato) quella servitù è mancanza di libertà
e insieme assenza di destino. Se vogliamo, una fuoriuscita di Carlo dal romanticismo (nonostante le letture evidenti e, in fondo, canoniche lasciate sulla scrivania: Schopenhauer, i tragici, l’antistoricismo) e allora, un ritorno indelebile come,
al tempo stesso implacabile, al pensiero di Empedocle e Parmenide. Eppure, se
non ci fosse il barocco o il barocchetto di casa, capiremmo solo in parte Carlo Michelstaedter. Se non tentassimo di ritrovare l’orizzonte, forse l’origine della prosa
e del pensiero di Carlo in quel pensiero domestico (e la filigrana della scrittura lo
denuncia: i racconti mitologici, l’aerostato, la sovrabbondanza di similitudini e di
metafore; la lingua greca che entra e sfalda, come intaglio sulla pietra, quale una
larva, il panneggio denso della scrittura e gli apologhi di una materia visiva e visionaria quagliesca, cioè appiccicata quanto una seconda pelle al suono del ragionamento: le parabole aspre sul mondo e sull’uomo bambino mortificato dal mondo), se non ci affidassimo alla lingua di Carlo, potremmo rischiare di capire poco
e oltre i limiti, fino a fraintendere.
Domando: mettere, malgré tout, la forza di La persuasione e la rettorica in quello squilibrio fra una tesi di laurea scritta con il sangue e il carsico discorso presocratico (uno scalino, un cancello, lo squilibrio patologico cancellato da un’esistenza a termine), non rischia di liquidare la sua filosofia in una tragicità del disamore – dico in un errore nudo e indifferente che solo la generale Krisis di inizio Novecento (un semplice pitiatismo da manuale) saprebbe giustificare e spiegare, ridimensionandone, in definitiva, la forza? Siamo sicuri che Carlo fu semplicemente un laureando novecentesco, dico un filosofo di inizio secolo? Il suo suicidio è
quello stesso dell’Europa? Come non accettarlo, visto che le condizioni storiche e
geografiche per dirlo ci sono tutte. Eppure, è possibile pensare un’altra via: almeno sussurrarla come complementare alla vulgata.
Il libro di Michelstaedter, nella sua inguaribile e selvaggia bellezza, è e resta
un libro barocco, ma ai limiti del cattolicesimo goriziano. È infatti un libro “autobiografico” che reputa la necessità, prima che un processo logico, il peso di una
realtà fisica deflagrata – un dato, insomma, gravitazionale (inerte quanto più invasivo) della materia. Attenzione, questa non è la via del pensiero esistenziale, del
disagio e della “disperazione” esistenzialista. Sì, «un peso pende ad un gancio»;
la volontà di ogni uomo è la fame verso il basso, è una vis discensiva: «ognuno gira intorno al suo perno, che non è suo». Carlo non esce da questa frana. Tuttavia
la frana non è effetto o scoperta ma è causa, è il corpo della voce: «il peso non
può mai essere persuaso». Il filosofo, il ragazzo di La persuasione e la rettorica, non
sanno molto di più; e, in un certo senso, quella loro lingua adolescente fa propria
la diversità da tutto e da se stessa («il suo agire è un esser passivo»), perché la voce «non sa ciò che vuole».
Una parola, dunque, cieca e abbandonata. Va detto: una filosofia perdutamente oscurata dalla sua stessa materia di ombra. Con un corollario impressionante
che proviene da Eraclito e trafigge la psicologia di Carlo: «L’uomo nella notte accende una luce a se stesso» fino a deflagrare in un lampo nero. La lingua, dunque,
è chiusa; possiede un che di perentorio. Più che la ricerca, in questa tesi di laurea, colpisce l’oppressione, l’assenza di aria, quel dover sentire «nel deserto», senza chiedere, senza osare di più, e appena invocare: «abituarsi a una parola è come prendere un vizio». La prosa di Michelstaed­­ter è una caverna dove anche le
stalattiti o i più preziosi diamanti sono neri e accecanti. È un percorso concavo, è
l’armadio dove si entra e ci si chiude, offesi nell’immaginazione, quando eravamo
bambini; è forse un presepe di favole senza, però, mai una fine o un inizio, perché lì, su quei fogli non c’è cielo stellato, sebbene l’azzurro di questa lingua densa
e scura possegga la tela semplice di un addobbo domestico – la candelina di gesso in un cassetto.
La voce di La persuasione e la rettorica nasce da un’invenzione autobiografica e adolescenziale: nega la dialettica in favore del racconto e della messa in scena barocca. Ma poi non sa mai come diventare un romanzo: le figure, i suoi centri nevralgici, dico le parabole, le ellissi e le metafore (la quercia potata e l’uomo
nella società; Platone, malinconico e assorto mentre il traditore sull’aerostato svita la solitudine iperuranica; le citazioni, poi, “aggiustate” per il proprio discorso,
la geometria e certo improvviso furor agendi di tassonomie naturalistiche) risultano, insomma, un controromanzo – molto altro e di più di un romanzo abortito,
perché sulla pagina esplodono spari sordi nel vuoto. Ecco: ciascuno di questi spari nega l’altro e insieme tutti gli altri, come se ognuno fosse lo stesso e fosse il ripetuto, illuso, battito di un pendolo irreale.
Cos’è accaduto? Dove e quale fu l’errore, se fu mai errore, di Carlo Michelstaedter? Ora, potremmo sbagliare molto, moltissimo: e sarebbe come disonorare la
vita e la morte di quel ragazzo. E sarebbe terribile: perché io amo Carlo e la sua
34
35
arnaldo colasanti
insonnia e dolore in carlo michelstaedter
ombra, il destino amaro di una giovinezza eterna. Ma devo insistere. Se pensassimo che il suo libro si inceppò in un rigore tragico che era, in fondo, solo l’impossibilità di “far filosofia”, dichiareremmo il falso: l’affaire Michelstaedter resterebbe un fatto esotico ed eroico del pensiero italiano, un semplice caso umano. Va invece sottolineata l’origine da cui siamo partiti: l’invenzione adolescenziale (la vera materia del rigore di Carlo), se sente impossibile la dialettica, è perché fa sua
un’azione dell’anima, cioè un modus, il preludio del barocchetto grinzoso, in cui,
appunto, la lingua stessa andrebbe a vivere quello che Carlo chiama il «valore individuale», cioè la radicalità del senso e del significato. Insisto: Michelstaedter
esistenzialmente proviene da Quaglio, dalla rovina inerziale lassù nel soffitto del
duomo. E questo, anche se mai avesse alzato il capo. È importante che nella Persuasione e la rettorica vada raschiato via qualsiasi retrogusto di titanismo postromantico, qualsiasi scetticismo novecentesco. L’idea che l’esperienza dialogica (un
tratto imprescindibile della scrittura di Carlo) sia una vera e propria insubordinazione del dire alla verità logica dell’“asserzione” è un’idea, è una figura che appartiene al barocco, alla creatività prima che alla metafisica: riconduce in una logica
dell’anima e dentro alla filigrana dei grandi pensatori moralisti classici, per i quali sarebbe del tutto consona e pertinente quella certezza del «valore individuale»
creduta da Carlo. Ovvero: che il “detto” venga sempre «tenuto unito ad un’infinità di non detto in un’unità di senso».
No, Carlo non è l’indifferente, il disperato, nemmeno il filosofo depresso. La
sua stessa adolescenzialità (di parola, di gusto, di pensiero) non è un limite, bensì una condizione di espressività – quel modus che continuo a chiamare il “barocchetto goriziano” di Carlo, volendo sottolineare una specie di conservatorismo
dell’identità a cui appartiene la lingua di Michelstaedter e in cui il ruolo della rovina (l’infinità di non detti) implica sempre e ancora quello della gravità, cioè un
«sentire nel deserto»: il peso individuale della forma (l’unità del senso). È questo, per me, il vero punto di snodo. Provo a dirlo in maniera schematica e forse
metaforica. Il rigore, il limite di una morale imprigionata nello svegliarsi completamente, avrebbe dovuto aprirsi al vuoto del barocco romano, in cui la presenza
del sonno e della veglia resta la forma, se vogliamo sonnambolica, de l’esprit de finesse come de l’essai.
In altre parole, il cerchio labirintico della «verità individuale», invece di restare aperto finisce per chiudersi. La retorica e la persuasione restano il battente di una campana muta nella notte: un isolamento. Il pozzo e il pendolo: la fissità di una decisione mancata perché pensata e non, al contrario, promessa. Carlo,
da cattivo studente, non argomenta la sua tesi; ma da grande filosofo greco la lascia in un’illustrazione nevrotica, chiusa e segregata come se la prima cosa impossibile fossero proprio la controversia o la contraddizione. Ma esiste, domando, un
pensiero senza aporie? E il pensiero, prima che essere esclusione del dubbio (in
tal caso, un’arresa all’impossibilità di pensare), non è davvero la lotta, la negazione della paura che si ha del dubbio?
Maurice Blondel, in uno squisito testo “minore”, Le principe élémentaire d’une
logique de la vie morale del 1900, annota un bivio illuminante: «È perché spontaneamente ci crediamo capaci di modificare le cose, che acquistiamo l’idea che esse
potrebbero essere diverse [autres]». Carlo è prima di questa via, anche se, scongiurando, ci dice di esserne oltre. Non si crede capace di modificare le cose: difetta di
stupore. La retorica e la persuasione non possiedono spontaneità e quindi “temperamento” platonico: stanno comunque al di qua del bivio come imprigionate.
Se nella parabola di Carlo il vecchio Platone, in aerostato, vede che le nuove creature, cioè le idee, «erano tutte chiuse nella leggerezza»; e se il traditore, il
giovane miope Aristotele, s’affaccenda intorno alla valvola per «prendere un po’
dell’aria che è qui attorno e metterla nella leggerezza», così che l’istante dell’esistenza precipita con la sua nuova ma identica segregazione, ciò è perché la persuasione non si è fatta rovina e la «verità individuale» dimentica come poter essere «anima» – una storia infinita, l’attesa, l’immaginazione e, allora, l’ora della spiritualità e l’incontro con le cose “altre, altri” e diverse. È come se, alla fine, Carlo
avesse trovato il bandolo per uscire dal labirinto ma non sapesse più come entrarvi, come conoscerlo, perché egli stesso si vede mostruosamente nel Minotauro, così
come quando «uno si volge a guardare il proprio profilo nell’ombra, lo distrugge».
La stessa «negazione della molteplicità» vagheggiata da Michelstaedter non è più
uno schema, un ordine parmenideo: insomma, un atto di coraggio conoscitivo. Tale negazione sembra piuttosto il momento più drammatico (l’espressionismo astratto di La persuasione e la rettorica) dell’autobiografismo filosofico di Carlo: nasce,
quella negazione della molteplicità, come un assedio; come il volto offeso di chi è
stato tradito dalla realtà che ora, mostrandosi per quello che è (la sua gloria: la sua
pura illusione), rivela tuttavia senza tregua, senza alcuna pietà, il proprio sarcasmo.
È troppo: chi avrebbe resistito? Non so se qualcuno ci abbia mai pensato, ma
la morte del ragazzo è molto simile a quella di Didone, mentre Enea dolce e illusivo parte per la sua gloria. Didone entra nella morte ma non sa uscire dalla vita.
Il suicidio non è un’esperienza letterale di conversione: è la letteralità di chi non si
dà pace ma è costretto a rinnegare la propria «verità individuale», quell’unica verità che, unita «ad una infinità di non detto in un’unità di senso», è veramente il
sonno e la veglia della realtà, il suo amore nei confronti dell’io. La filosofia, invece
di dialogare, sta muta, si distacca dalla sua profondità: non tollera (e chi potrebbe?) il disamore del sarcasmo. E allora del barocco (dei suoi tanti soggetti disseminati che si cercano e si intrecciano par coeur) si nega proprio il principio nutritivo: l’analogia, il pensiero allegorico, i colori, la possibilità di raccontare un labirinto dell’anima, in cui promessa e realtà scorrano quale il medesimo e insieme il
duplice fiume della nostra possibile conoscenza.
36
37
arnaldo colasanti
Carlo non sognò più, cadde nell’insonnia. Morì a ventitré anni, con un colpo
di rivoltella, a causa di una tesi di laurea. Noi lo amiamo. Dalla distanza di questa
vita ormai già vicina alla vecchiaia e abituati alla mediazione, al compromesso, alla paura, percepiamo il brivido invidiabile di quella canna sulla tempia, in cui percepire finalmente qualcosa di pulito e di reale. Eppure che orrore. Cosa chiediamo alla filosofia se non salvarci da noi stessi? Cosa desideriamo dalla conoscenza,
se non vivere la speranza? E lo sappiamo bene: la speranza non è sperare ciò che
si spera e, in qualche misura, ciò che si conosce. La speranza vera è assoluta, radicale, insensata, oscura: quale e quanto una promessa mantenuta. Il peso del mondo tocca la rovina, cioè la vera profondità della mia anima. Ripenso a Hillman e
con devozione: «Ovunque si sia esperito un mistero, là sorge una casa di Dio».
Eppure altro avrebbe potuto parlargli. Se fosse andato ad Aquileia: se avesse voluto abbandonare, almeno per un giorno, le caricature dell’umanità. Eppure
era lì vicina. Poi la Madonna col Bambino e i Santi di Gianantonio Guardi sarebbe venuta più tardi al Palazzo Attems di Gorizia, ma intanto era lì in quei giorni, splendida e sontuosa, nella città antica dello spirito. È il trionfo della verticalità e della caduta. Quasi nulla è frontale – nemmeno la Vergine. Dall’alto la luce
precipita con la sua capacità di infilarsi dentro la vita, in uno sfolgorio che attraversa i panni cardinalizi, oltre e lungo le barbe, le aureole, le perle dei rosari, gli
stemmi sovrumani della santità. Fortissima, e non più di maniera, la discesa verso un basamento che è anche (secondo il modello tizianesco) un baratro, una cesura, il sepolcro aperto. Ma questo precipitare serve solo per stringere, attorno ai
fili d’oro lasciati in aria, il trucco e il vero dei colori e dei chiaroscuri, l’esistenza
che vive e che insieme sogna se stessa, come dentro a un pizzicato brillante rammemore, in questa pala del 1749, la grande musica di Porpora, il suo Orlando, la
pittura italiana barocca, Sebastiano Ricci e la cura febbricitante della nuova realtà settecentesca. Antonio Morassi, un maestro per gli studi sui Guardi, parlò di
un impressionismo en plein air, sottolineando il clamore e la forza naturale che,
in questi termini, appartiene profondamente alla scuola francese e non certo, al
di là dello storicismo, agli accenni naturalistici dell’illuminismo. È vero. Se l’avesse vista, quella pala del Belvedere di Aquileia, Carlo avrebbe forse capito che i colori sono pensieri e che quest’ultimi sono le forme della vita, che vanno riconsegnati alla vita, alla musica segreta e sfinita della grazia. Avrebbe. Ma non fu così.
Carlo restò chiuso in casa e volle trovare il suo dio laddove Dio lo avrebbe, lo stava perdutamente accogliendo. Il mistero filosofico davanti a cui pur ci inchiniamo, ci lascia dispiaciuti e sofferenti: perché quel viso di ragazzo quieto, resta qui
un volto terribile – un orrore. Chiede rispetto ma anche solo silenzio: un infinito
stanco silenzio. Li ha entrambi, li ha conquistati tutti nel dolore e nell’insonnia.
Per quanto, avrebbe dovuto, avrebbe potuto allontanare da sé, addormentandosi
in un meriggio dell’esistenza.
L’epistolario di Carlo Michelstaedter, quasi tutto giocato sul versante della «lettera familiare», è di straordinaria ricchezza intellettuale e autobiografica, con tutti gli ingredienti di un romanzo di formazione, a iniziare, pressoché ad apertura di
scenario, dalla partenza il 22 ottobre 1905 del giovane diciottenne dalla casa paterna verso Firenze. Di qui, l’esplorazione di una nuova città in una nazione “altra”,
la ricerca di un’ancora indeterminata vocazione intellettuale, tra matematica, pittura e studi filosofico-letterari, le iniziazioni sentimentali, le nuove, ma rastremate
amicizie (Aldo Oberdorfer, Gaetano Chiavacci, Vladimiro Arangio-Ruiz), comunque fuori dai confini del pur vivace circuito delle riviste d’epoca; le serate teatrali
(Gor’kij, Dreyer, Pinero, Praga, Bracco, d’Annunzio, Maeterlinck, Benelli); i contraddetti rapporti sociali, mediati dall’ambiente goriziano (come la famiglia Della Pergola); il trauma di un doppio suicidio, l’identificazione dei “propri” autori.
Un percorso a tappe che, sul piano intellettuale, vede l’acceso «corpo a corpo» con
d’Annunzio, in un serrato confronto etico-ideologico che ha, non a caso, il proprio
clou nel pieno della crisi dell’anno 1907; l’emergere, tra gli altri, dei nomi di Foscolo, Leopardi, Carducci con il definitivo imporsi della parola di Leopardi; l’entusiasmo sociale per l’Hugo dei Miserabili la cui lettura condividere a distanza, in
emotiva sintonia, con l’amata sorella Paula, sulla scia di un interesse sociale che ci
condurrà fino al Discorso al popolo del novembre 1909; il rafforzarsi dell’influenza di Schopenhauer, già caro all’amico goriziano Rico (Enrico Mreule) come poi
ad Arangio-Ruiz, probabile interlocutore anche per i testi nietzschiani; la scoperta nel 1908 di Ibsen accostato a Sofocle per il suo sconvolgente potere di penetrazione 1, ma altrove anche all’amato Tolstoj. Ibsen e Tolstoj: potenti demistificatori della società e delle sue menzogne, se «entrambi presero pel petto questa società soffocata dalle menzogne e le gridarono in faccia: verità! verità!» 2. E ancora, la
38
39
«Dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra».
Sull’«Epistolario» di Carlo Michelstaedter
di Simona Costa
simona costa
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
lettura del Vangelo quale testo «tanto superiore alle filosofie e alla scienza moderne», e accanto alla figura del Cristo, quella di Buddha, a formare una costellazione che, ormai all’altezza del 1909, trova ulteriori stelle polari nel «divino Platone»,
meritevole «d’essere amato tanto quanto Leopardi», e nel Beethoven che fa «spasimare di gioia e di sofferenza», mediato dal pianoforte di Giannotto Bastianelli 3.
«Non tradire Beethoven», sembra sia stata la sua unica raccomandazione all’amico
musicologo, al momento di lasciare definitivamente Firenze per il ritorno a Gorizia alla fine del giugno 1909 4. Poi, l’ultimo giro di vite: le sofferte lettere agli amici; la soffitta-ritrovo di Nino Paternolli, con la recuperata frequentazione dei compagni già di scuola, Rico e Nino, i personaggi del Dialogo della salute; il rapporto,
testimoniato dalle poesie, con Argia Cassini, anche lei mediatrice, fino all’ultima
sera, di Beethoven; il confronto con Rico che, partito di nascosto per l’Argentina,
ha saputo spezzare con l’azione «l’inerzia nemica delle cose» e la penosa immobilità dell’essere 5; i colloqui finali con il cugino Emilio (tolstojano prototipo, si sa, di
«quanti giovani ancora non abbiano messo il loro Dio nella loro carriera») e con
una madre dalle improvvide recriminazioni. L’ultimo atto ancora in scena sarà dato dall’invio, il 5 ottobre 1910, all’egregio signor Gelati, segretario dell’Istituto di
Studi Superiori di Firenze, della sua tesi di laurea, affaticato punto fermo di una
tormentata formazione intellettuale avvertita in tutta la sua portata antiaccademica. «Tanto poi per quei professori è tutto buono; per loro è come arabo, non hanno
via e criteri per dire se va bene o male», aveva scritto a Paula ancora da Firenze il 6
giugno 1909, ripromettendosi di gettar loro negli occhi tutta la polvere necessaria.
I cinque anni ricoperti da questa fitta scrittura epistolare tracciano dunque
una parabola di forte intensità emotiva e intellettuale, in uno stile di grande tenuta, teso, ortisianamente, a fare della propria vita romanzo. Firenze è «la città tanto desiderata» cui si richiede di apportare la serenità di spirito: una città i cui monumenti, il duomo, piazza Signoria, Santa Croce, paiono subito creare all’aspirante artista una “sindrome di Stendhal”: «Com’è bella Firenze […] è un po’ troppo in una volta, mi sento come soffocato». Alla bellezza dei monumenti, al cumulo di storia che si riversa dal recupero di tante citazioni dantesche e dalle case fitte di iscrizioni relative a eventi e personaggi, si accompagna l’ammirazione per la
lingua, avviata già in treno di fronte ad alcuni toscani («io avevo vergogna di parlare con la mia fetida pronuncia») e ribadita nel soggiorno quotidiano: «Qui c’è
molto bella gente. / E come parlano, dio che musica. Mi fa l’effetto che ognuno
abbia un tesoro in bocca e non lo sappia» 6. Un entusiasmo però destinato a spegnersi rapidamente, se in data 17 gennaio 1906 troviamo un atto d’accusa contro
l’onnipresente «spirito di piccineria borghese» redatto in questi termini: «Poveri
fiorentini come sono caduti in basso […] non hanno niente dell’atticismo antico,
sono piccini, gretti in tutto, limitati d’ingegno, senza sentimento né per l’arte né
per alcun’altra cosa, egoisti e soprattutto falsi, hanno una certa diligenza ottusa,
una laboriosità da formica che urtano i nervi. Non è rimasto loro che quello spirito mordace maligno come lo descrisse Mazzoni nella figura di Stenterello». Un
giudizio ribadito, a quasi due anni di distanza, in una lettera del 12 ottobre 1907,
dove sotto un tempo affatto incolore (e pioggia continua, vento, freddo, nebbia,
cielo grigio e gementi civette costelleranno tutte le lettere fiorentine) si muove un
popolo che, privo di qualsiasi «piccola manifestazione straordinaria o politica, o
commerciale, o mondana, e nemmeno militare che attragga», «fa proprio l’impressione d’un formicaio colla differenza che ha un ronzio fastidioso da zanzara».
«Morte alla borghesia», la «fetida borghesia», è il grido che si alza da queste
lettere che mettono alla gogna gli «antipatici grassi borghesi, volgari e stupidi», il
«loro modo ristretto e piccino di considerar la vita» e dichiarano di infischiarsene «dei loro gretti concetti, dei loro riguardi, delle loro convenienze […] del loro
ordine, delle loro cure» (30 novembre 1906). Anche se, ad autoriduttivo corollario, Carlo non solo scriverà: «se non sono un borghese ciò non vuol dire che debba esser un artista» (2 febbraio 1907), ma più volte avanzerà per se stesso l’igienica
istanza all’ordine, all’inizio in via compensatoria al suo distacco familiare: «ho regolato tutta la mia vita qui perfettamente, tutte le cose sono in un ordine incredibile, di cui non mi sarei mai reputato capace» (9 novembre 1905). L’ordine diventa
apotropaico verso una giovanile, rischiosa sregolatezza vitale, magari banalmente
individuata nel fascino di un ballo e di una successiva gita notturna sul viale dei
colli con la luna piena: «Arrivai a casa alle sei e mezza della mattina e avendo quasi l’impressione d’aver giunto il colmo della sregolatezza, cominciai dal mettere
in ordine tutte le mie cose che da un mese soffrivano un indicibile disordine» (11
marzo 1906). Scriverà al padre in un momento cruciale: «Sono felice di venirmene a casa, perché non ne posso più, proprio non ne posso più […] di questa vita disordinata» e la data non è casuale, ovvero il 1° luglio 1907. In un poscritto a Paula,
in data 25 marzo 1908, affermerà: «io devo pur diventare una persona in ordine».
La resa di interni è una delle direzioni in cui più si esercita la scrittura di Carlo: esemplari la descrizione, in data 17 gennaio 1906, del salotto della sua locataria
Argia, capolavoro del minuto ordine che caratterizza le case fiorentine e, come ha
notato già Campailla, la lettera relativa alla zia Irene e alla sua casa di Vicenza (910 febbraio 1908). Cuscini, uncinetti e ricami, fiori secchi e finti, campane di vetro,
soprammobili in quantità e chincaglierie varie affollano il salotto fiorentino, ma si
rincorrono anche nelle fredde e polverose stanze vicentine, gremite di mobili antichi, porte a muro nascoste dalla carta da parati, vecchie foto di famiglia, specchi
incrinati, cornici aggiustate, pendole che battono tra loro in disaccordo, tele di ragno, soprammobili, cuscini e ricami, animali di stoffa dagli occhi di vetro; e poi
un cane lento e decrepito, due canine viziate, un pappagallo centenario. Lo sguardo distaccato e ironico del giovane registra tutto impietosamente tra malinconico e
divertito, dicendosi ormai sulla strada di «intendere quella certa bellezza che ade-
40
41
simona costa
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
risce a questo benessere fatto di pienezza di cuscini e di tappeti, di sofà, di bijoux».
Ma non c’è solo la visita alla zia, promossa dalla famiglia a porre una qualche
ipoteca affettiva sulla futura eredità: «in fondo sono stato incredibilmente porco
– non c’è scampo», commenterà Carlo, a missione compiuta (19 febbraio). Il salotto borghese, quadro caro al teatro d’epoca quanto al corrosivo Gozzano e al
più spietato Pirandello, è uno degli scenari privilegiati dalla scrittura epistolare
di Carlo, pur in una schizofrenica scissione fra l’incontaminabile interno della casa di piazza Grande 4 e tutti gli altri, allegramente aggredibili per virtù di ironia. È il caso della famiglia di Cesare Della Pergola, in via dei Renai, imparentata con i Della Pergola goriziani: Carlo vi è invitato rigorosamente al sabato, giorno di riunione dell’intero parentado, da cui per l’appunto lui rifugge: «ed io proprio al Sabato non ci voglio più andare perché mi urta i nervi tutta quella gridante accozzaglia di zie cugine cognate e che so io» (14 gennaio 1906). O, ancora, i
ritratti dell’intera famiglia Alfandery, conosciuta tramite i Bolaffio e individuata
nei suoi singoli componenti con l’attenzione fisiognomica del caricaturista, volto
a conchiudere che «tutta la famiglia gode d’un grado d’intelligenza allegramente basso» (6 febbraio 1906).
Verrà anche via via aumentando la distanza avvertita con il mondo accademico, guardato subito, già ai primi di novembre 1905, con un qualche annoiato distacco: Pio Rajna, di cui segue la prima lezione, è simpatico per fisionomia e modo di fare, ma è tuttavia «prolisso da morire». Così, in data 11 gennaio 1907, dando notizia di uno sciopero di lavoranti parrucchieri, Carlo vi aggiungerà un ironico e irriverente corollario: «Parecchi professori fanno sciopero perché hanno perduta la moglie. C’è una vera epidemia fra le mogli dei prof. – E sfido io a resistere ai discorsi pesanti che faranno loro sul talamo. Finiranno per morir tutte». Nel
febbraio 1908, dopo un soggiorno goriziano, aspettando un imprecisato professore nell’aula universitaria, scriverà ai fami­­liari di non ritrovarsi più «qui dentro fra
questi muri sudici e questa gente pallida e semi-incretinita» e di sentirsi nauseato
dal profluvio di erudizione verso cui nutre «quel disprezzo amaro che l’ateo dubitante porta a chi è felice nella sua fede» (19 febbraio). Sempre più il giudizio si farà
caustico sui docenti dell’istituto, e su Mazzoni, in particolare, cui giungerà a dare dell’«istrione» (3 novembre 1907) e che fortemente avverserà (con conseguenti
preoccupazioni paterne) per la candidatura a ufficiale commemoratore di Carducci: a lui anteporrà d’Annunzio e poi Pascarella, in una sollevazione di massa siglata da un «solennissimo pugno» dello stesso Carlo a uno dei caporioni della fazione avversa. A salvarsi, resteranno Pasquale Villari, che ai festeggiamenti dei suoi
ottant’anni si erge ancora «poderoso nella piena energia della sua intelligenza» di
fronte agli insulsi e banali elogi dei colleghi accademici (sempre nella lettera del 3
novembre 1907), e Girolamo Vitelli, l’unico, dice Carlo, «che stimo fra questi professori, l’unico che potrà farmi del bene – non molto – intellettualmente» (29 feb-
braio 1908). Possibile antidoto è dato dall’attività fisica: la scherma («oggi ho preso la prima lezione di scherma […] ho passato un’ora che mi ha rigenerato», scrive
il 20 febbraio 1908) e le tante animose passeggiate anche notturne e lunari, canali
alternativi all’incanalarsi di quell’ἐνέργεια che deve condurre ἐς ἀργίαν.
C’è certamente, da parte di Carlo, una forte coscienza letteraria dell’uso epistolare, sulla scia, fors’anche, di quel Cicerone, classico maestro di “lettere familiari”, impostate sulla ricerca di un sermo humilis e di una varietas tonale che coniugasse scherzo e serietà. E Carlo si dimostra particolarmente attento non solo
alla funzione comunicativa della lettera, ma anche alla varietà di registri implicita nel genere. Rivolgendosi, al solito, all’intera famiglia (9 novembre 1905), dopo
aver chiamato direttamente in causa la «mammerella benedetta» in disperata ricerca del caffè sottrattogli dal regime draconiano di Paula, così si indirizza alla
sorella: «Ma tu Paula sei proprio immemorabile [sic] nelle tue lettere […] anche
da un punto di vista generale come lavoro letterario le lettere che mi scrivi sono
proprio belle. Scrivi con spirito con comunicativa, mi fai ridere o esser triste a volontà e soprattutto dipingi l’ambiente così bene che mi par di stare con voi quando leggo le tue paginette e ho sempre dispiacere che finiscano e le rileggo 2, 3 volte». E particolare appare anche la scrittura di Amalia, la moglie del fratello: «Che
simpatica! Come è ben scritta! Ha una grazia speciale diversa per es. dalle lettere
che scrivi tu mamma. Non so cosa sia, ma mi piace molto» (26 marzo 1906). Così ai primi di settembre 1909, rispondendo a un nuovo amico, Marino Caliterna,
scrive: «In generale la tua lettera è così viva e parlata che mi pareva d’averti vicino. È questo il più bel piacere che può dare una lettera. Anche la lettera della Maria alla Paula è tanto simpatica; par di sentirla parlare» 7.
In un’atmosfera culturale ben sollecita alle scritture dell’io, Michelstaed­­ter
non poteva certo ignorare il potenziale patrimonio letterario formato da quei fogli apparentemente volanti. La pubblicazione a sua insaputa sul «Corriere Friulano», diretto dalla zia Carolina Luzzatto, della lettera inviata ai familiari sui funerali di Carducci, gli causerà uno scatto di indignazione per la violazione della confidenza privata. Anche se non mancherà un ridimensionamento (forse non troppo) ironico: «infine gli epistolari dei grandi si pubblicano dopo la morte», che fa
pendant con l’altrettanto ironica profezia di un’università fiorentina che quando
sarà, fra secoli, «un gran morto», si vergognerà di averlo eventualmente cacciato 8.
Il segreto epistolare, avallato dall’autorevole precedente ciceroniano, sarà rivendicato a più riprese da Carlo, come nelle lettere a Paula, talora siglate da indicazioni di «privato!»: «Tu continua a dirmi tutto quello che ti passa per la mente […]
ed io ti risponderò come ora facendo sì che nessuno lo legga»; «ti proibisco assolutamente di mostrar questa lettera a chiunque altro specialmente per quanto riguarda me» 9. Fino a dichiararsi dispiaciuto, molto dispiaciuto che una sua lettera
sia stata letta ai Morpurgo, per cui occorrerà, nel futuro, a stornare tale indiscre-
42
43
simona costa
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
zione, seminare le proprie lettere di «“stronzi” inevitabili anche nella lettura ad
alta voce» 10. Alla mamma, in data 16 ottobre 1908, scriverà: «ti prego di bruciare
subito questa lettera appena letta e di non farla vedere a nessuno», richiamando
a noi lettori l’eco di una voce apocalittica e di più espressionistico registro, quella
di un Campana che affermerà le sue lettere esser fatte per essere bruciate. E la testamentaria lettera alla madre si chiuderà, appunto, sulla esecrata volgarità di far
vedere le lettere ad altri.
Che si trattasse di un ben preciso genere letterario, erano in tanti a suggerirglielo e non solo il suo Cicerone, ma anche il Carducci delle Lettere a Lydia da lui
lette, nonché quel Baretti su cui preparava per Mazzoni la tesina di primo anno
(tema: Lessing e Baretti) e di cui cita proprio le lettere 11. Per non parlare di uno
Jacopo Ortis, scoperto e letto quasi tutto d’un fiato in una giornata trascorsa in
biblioteca con l’intento di ingoiarsi un volumone sull’arte pisana (5 luglio 1906).
Ma si potrebbe anche aggiungere il nome di Amiel, il cui Journal intime, testo allora in voga e molto frequentato anche da un d’Annunzio, Carlo cita all’amico Rico in una lettera del 13 giugno 1909.
La potenzialità di lettura diaristica di questo epistolario è infatti implicita nella sua stessa forma. Già la lettera avviata subito dopo la partenza del treno, sin
dalla prima stazione dopo Gorizia (Rubbia) e scandita per tappe successive (Gradisca, Sagrado-Ronchi, Monfalcone ecc.), dà infatti l’avvio a una scrittura di genere spurio: una contaminazione tra lettera e diario che Carlo protrarrà nelle sue
lettere fiorentine iniziate, sospese e riprese in momenti diversi della giornata o addirittura in una lunga sequela di giorni successivi: «Non so se ti sei accorta che ho
lasciato e poi ripreso la lettera più volte. Ora che scrivo siamo già Lunedì, – tempo misto – umore costante», scrive per esempio a Paula il 12 aprile 1908. Piccolo espediente utile, sì, al contenimento delle spese postali, ben in linea con quelle
direttive di risparmio impartitegli che costelleranno queste righe anche di minuti
rendiconti finanziari e apriranno la lunga querelle sull’esonero dalle tasse universitarie, avvertita subito da Carlo come non ammissibile e poco dignitosa e conclusa su un diniego avallato dalle non certo indigenti condizioni familiari. Ma l’apertura della lettera alla forma diaristica risponde anche all’intento, più o meno sotterraneo, di ripercorrere la quotidianità restituendola nel suo fluire al destinatario
assente. Se il viaggio, come scriverà già subito in una lettera del 27 ottobre, comporta la perdita della continuità del proprio “io”, sentimento per cui Marco Cerruti ha richiamato il Bergson dell’Introduction à la métaphisique del 1903 12, la lettera è allora strumento di un possibile recupero, svincolandosi dalla contingenza postale e offrendosi quale foglio bianco su cui nel corso della giornata fermare
le “chiacchiere” con l’assente. «Tu però dovresti scrivermi sempre quando ti viene un’idea in testa, senza attendere l’ora di posta; allora noi continueremmo così
per lettera le nostre lunghe chiacchierate», scrive alla mamma il 23 ottobre 1905.
Se la lontananza, pur razionalmente definita «salutare ginnastica del cuore»
(2 novembre 1905), è ripetutamente vissuta come un «incubo» 13, la lettera ne è il
solo, sostanziale compenso: di qui la richiesta ossessivamente insistita di scrivergli: «Scrivetemi scrivetemi» è l’appello spasmodicamente iterato e vergato fin sui
margini o su ogni foglio delle lettere (6 febbraio 1906). Fino a suggerire un organigramma della reciproca corrispondenza, organizzata su giorni fissi: domenica
e mercoledì scrivono i familiari; martedì e venerdì risponde Carlo con lettere che
giungerebbero mercoledì e sabato a mezzogiorno, dunque in tempo per mantenere attivo il circolo virtuoso (1° febbraio 1906). E se le lettere latitano, non resta
che un conforto: l’amata, amatissima cioccolata, ottimo antidoto all’umor malinconico e i cui effetti benefici scandiscono questo epistolario come già quello di altro scrittore uso alle malinconie, tal Vittorio Alfieri. Cioccolata e dolci, che fanno
di Carlo un ottimo conoscitore delle pasticcerie fiorentine, cui portare magari un
domani in pellegrinaggio le amate Emma e Paula, madre e sorella. E insieme, altro potente antidepressivo, il sole: quel sole più volte invocato e festosamente salutato a ogni apparizione; quel «sole rosso» che i familiari non possono non aver
notato, unico conforto al momento di lasciare Gorizia.
Comunicare per via epistolare implicherà anzitutto l’indicazione del luogo della scrittura, del posto da cui si scrive, degli oggetti, delle persone e del­­l’ambiente
che circonda lo scrivente: l’amico che gli siede accanto aspettando di studiare insieme, la padrona di casa che attende per la cena. E non si potrà trascurare quanto lui vede e sente al momento della scrittura: vede, i paesaggi che si aprono alzando gli occhi alla finestra di fronte; sente, i rumori che giungono dall’esterno
e si riversano nella stanza. Un Carlo, parrebbe, affine a quel molto amato Giacomo con cui la sorella Paula, in un gioco a tre sui nomi, aveva probabilmente inteso confonderlo, scherzosamente indirizzandogli la posta a «Giacomo Michelstaedter, Via Carlo Antonini» invece che a «Carlo Michelstaedter, Via Antonio Giacomini», come si legge nella risposta di Carlo del 22 marzo 1908. Tutta la scrittura di Leopardi, a cominciare dalle riaffiorate pagine diaristiche sul «primo amore», testimonia infatti una compensazione per cui vista e udito immettono di prepotenza in una stanza l’esterno, così eludendo l’isolamento fisico della scrittura.
La distanza tra chi scrive e chi leggerà può essere dunque abolita con la trasposizione di una scena che annulla la lontananza spaziale: chi legge si trova immesso
nell’atmosfera dello scrivente, per cui non si limita a seguirne i pensieri, ma lo vede vivere nel suo ambiente. La teatralizzazione del proprio quotidiano traspone il
destinatario sulla scena della scrittura: «l’ambiente è come tu mamma l’immagini:
le imposte chiuse, il lume acceso, tutto molto calmo e simpatico», esordisce nella notte fra il 6 e il 7 novembre 1906; «io scrivo qui al lume della lucerna nel mio
posto solito come tu mi vedi», scriverà a Rico (Enrico Mreule) alle sette di sera del
28 novembre 1909, da Gorizia. La piena consapevolezza del ruolo teatrale impres-
44
45
simona costa
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
so alla scrittura epistolare è chiarito dallo stesso Carlo: «Una tua lettera è come
un’alzata di sipario che mi lascia intravvedere uno squarcio della vostra vita, mi fa
vivere con voi per pochi momenti», scrive alla madre la sera del 7 dicembre 1905.
Molto attento anche il gusto del ritratto che fa pendant alla vocazione del disegnatore, del caricaturista e del pittore, in una compenetrazione fra parola e immagine che vede protrarsi il ritratto per parole nello schizzo abbozzato sulla medesima pagina, nella ricerca di “visualità” perseguita da questa scrittura. Ne abbiamo un esempio nell’espressionistica descrizione della sua prima affittuaria, la
signora Viola Fortini, a cui deve comunicare la sua scelta di andare altrove: «me
la vedevo già precipitarsi addosso movendo le mani come un mulino col muso appuntito come una lancia e con un torrente infinito irresistibile di parole schiaccianti». O ancora la signora Reiss che in piena via Calzaiuoli, sotto una pioggia
torrenziale e lampi e tuoni e fulmini, «sgambetta e saltella tutta grondante, rialzate le gonnelle fino al ginocchio», o la signora Marinaz che, fra le lacrime incerte
tra le ciglia, discende dalla carrozza con «il cappotto sollevato dall’emozione» 14.
La lettera è per Carlo trasposizione scenica di tipi, personaggi, situazioni, da rendere in tutto il loro dinamismo. Ce lo dimostra a pieno la lunga lettera della notte fra il 6 e il 7 novembre 1906, iniziata dopo un esame di latino dal felice esito e
continuata, fino alle tre e mezzo di notte, al ritorno dalla rappresentazione della
Figlia di Jorio. Una lettera che dichiara la sovreccitazione della giornata e che, oltre a una prima recensione a caldo della tragedia dannunziana, dispiega a pieno
meccanismi tutti scenici: dal diretto coinvolgimento del pubblico fuori scena – «ti
ricordi mamma? continua tu se ti ricordi, io sono stanco di parlare» –, all’uso della didascalia – «ho tutta la gola arsa e bevo un bicchier d’acqua… (si versa dell’acqua e beve) ora si può continuare» –, fino a quella vera e propria sceneggiata relativa alla signora Reiss che, in cerca di una stanza per il «suo disgraziato rampollo», interviene direttamente nel narrato epistolare con ampi brani di discorso diretto, tutto rigorosamente dialettale 15.
Una teatralizzazione accentuata dal fatto che le lettere familiari di Carlo hanno spesso come destinatari non un solo membro, ma l’intera famiglia: all’interno di un “voi” cumulativo, vengono via via a stagliarsi, uscendo a uno a uno dal
gruppo, i singoli personaggi che si fanno incontro allo scrivente con le loro abitudini quotidiane, nella confidenza di un’intimità che, come nel caso paterno, collide con l’impostata immagine pubblica: «penso che tu, mamma, se sei più triste
mangerai più caffè! che peccato»; «penso sempre a papà che scende dal letto colle
piante dei piedi disuguali e tutto reumatizzato o raffreddato»; «Che cocolo papà
(non arrabbiarti) con quei stivali imbottiti e colla tosse e dire che quando guardo
la tua fotografia (l’unica che abbia di tutta la famiglia) mi vieni incontro così austero e indignato e sostenuto» 16. E ancora, a inizio febbraio 1906, «Che cocolo che
doveva esser papà coi saltuzzi e le piroette». Varrà ricordare che la sopracitata fo-
tografia era compresa, non a caso, in quel Sermone paterno redatto dal provvido
genitore – un possibile alter ego di Monaldo Leopardi, ha ben detto Campailla –,
a edificazione del figlio in partenza per la tentacolare Firenze. Tutto quello scorcio del 1905 ha l’immediatezza visiva di scene familiari entro la cui cornice lo scrivente sente di aver lasciato un suo possibile doppio a cui occorra ricongiungersi al
più presto: «è una gioia che non ho mai provato, dio mio tornare a casa, dormire
sul mio canapè, veder la mamma in poltrona col fazzoletto sugli occhi e papà dormente rumorosamente sul canapè, e la Elda e Silvio seduti di fronte a me e poter
parlare con te fino alle 2 di notte […] e mangiare i nostri cibi e vedere il castello e
tutte quelle linee alle quali l’occhio era usato, e la mia stanza», scrive a «Paccicina
mia benedetta» (Paula), la mattina dell’8 dicembre 1905. Scrivendo ancora a Paula, stavolta da Gorizia nell’estate 1906, ecco consegnarle la scena familiare entro
cui si compie la scrittura: «Il Marietto col capo in terra in pergolo grida: “Lidia,
Lidia, Teresina! Vien, vien!”. Gli altri fanno commenti, la mamma in piedi impietrita dalla fiacca, con la carta in mano, e con gli occhiali, socchiude gli occhi e tace, il sole poggia i suoi raggi sulle cose, e par che le sfondi e io ne sento il peso».
In un discorso corale, si dipinge un nucleo familiare compatto e solidamente
riunito, un microcosmo che ci appare pericolosamente autosufficiente nonché autoreferenziale. Così Carlo chiosa le proprie lacrime all’arrivo delle lettere familiari, in data 14 gennaio 1906: «Le vostre righe mi sciolsero in copioso pianto (dio
che imbecille, direbbe qualunque che non fosse della nostra famiglia)». Ma ancor più significativa la lettera a Gaetano Chiavacci del 26 febbraio 1909 in cui si
dà notizia dell’improvvisa e accidentale morte del fratello a New York (un suicidio anche questo, come hanno recentemente comprovato le ricerche di Campailla): «sai anche come siamo noi in famiglia uniti quasi in un unico punto caldo […]
Penso alla nostra casa chiusa per solito agli indifferenti, raccolta, gelosa della sua
intimità – e invasa ora da tutta la volgarità perché una forza indipendente da noi
ha aperto la porta. E tutti i corvi vengono all’odore della morte; tutti si precipitano perché siamo colpiti, indeboliti; il nostro dolore, la parte più intima di noi
esposta in strada, profanata dagli occhi curiosi e dalla simpatia della sensiblerie
dei deboli». Una casa-bunker si profila quale ultimo potenziale rifugio tra «mandrie di degenerati e disonesti» e fra le «bucce di tutti i mandarini guasti» aperti e
puzzolenti. «Quando siamo insieme soli – ritroviamo un po’ di calore e si riforma
l’ambiente chiuso, isolato dal resto, e che pare riacquisti valore in sé», scrive alla famiglia il 30 marzo 1909 da una Firenze che non è più nulla per lui, tanto che
preferirebbe sentir parlare slavo che toscano.
Ma la riunione di tutti i familiari «in un unico punto caldo» è precaria contingenza, se, come si legge sempre nella lettera a Chiavacci, per il padre la morte di Gino è solo «il primo squarcio dell’illusione», come più o meno per gli altri; per Carlo è «paglia sul fuoco». Su toni epico-tragici, ne nasce una drammatiz-
46
47
simona costa
zazione del dettato epistolare, bilanciato sulla tensione di due poli destinati sempre più a confliggere: gli interlocutori familiari da una parte, relegati nella loro ormai inaccessibile “incomprensione” (e Incompreso di Montgomery era stato un libro transizionale tra Carlo e la madre); dall’altra la solitudine di una voce che da
una nostalgica lontananza solo spaziale approda a un’irreversibile estraneità. Preannunci non erano mancati, e corposi, a cominciare dalla lettera di chiusura del
1906 a Paula, in cui ribatte alle rimostranze della sorella su un suo presunto allontanamento affettivo e rivendica il diritto alla propria tristezza, priva di alcuna
«vera ragione palpabile», ma viva nella sofferenza di non saper dominare né cose,
né persone, né idee, né passioni. La sua mancanza di equilibrio morale e intellettuale, il suo vivere «quasi in un sogno dove tutto è incompleto ed oscuro» lo convincono sempre più di non essere che un «degenerato». Dove si potrebbe avvertire l’eco di quella «degenerazione» divulgata, nel dibattito culturale dell’Europa di fine secolo, da un filosofo ungherese di origine ebraica, Max Nordau, autore di titoli molto consentanei a Michelstaedter: dalle Menzogne convenzionali della nostra civiltà (1883) a Degenerazione (Entartung, 1892) apparso anche in Italia,
in tempestiva traduzione, tra il 1893 e il 1894, con una lunga dedica a Lombroso 17.
La lettera a Paula continuerà, infatti, ascrivendo questa malattia non al singolo ma
all’intera epoca, così testimoniando i legami con «certa tormentata cultura mitteleuropea del tempo», come con quell’Otto Weininger morto suicida nel 1903 18 :
«ci troviamo appunto», dice Carlo a Paula, «in un’epoca di transazione della so- transizione?
cietà quando tutti i legami sembrano sciogliersi, e l’ingranaggio degli interessi si
disperde, e le vie dell’esistenza non sono più nettamente tracciate in ogni ambiente verso un punto culminante, ma tutte si confondono, e scompaiono, e sta all’iniziativa individuale crearsi fra il chaos universale la via luminosa. Così nell’arte come nella vita pratica» (9 dicembre 1906).
«Quando tutti i legami sembrano sciogliersi»: una frase premonitrice, parrebbe, della crisi messa in moto dal suicidio di Nadia, di cui la sofferenza, come ci
dicono le lettere, si intensificherà con il passar del tempo. L’intreccio tra le due figure femminili di Nadia e di Jolanda, aspramente rinfacciatogli dai familiari tutti, ha la sua intrinseca ragione nel proseguimento di un colloquio avvertito come
necessitante percorso di autoindividuazione. La lettera testamentaria lasciatagli
da Nadia (e rivelataci ora da Campailla nell’intrigante Segreto di Nadia B. 19) apre
a un impegno ormai inderogabile con se stesso denunciato nelle lettere a Jolanda.
La lettera del 25 aprile 1907, davvero stravagante come epistola amorosa, in cui
le cita ampiamente Max Stirner, «il triste filosofo dell’anarchia», afferma l’istanza primaria a una libertà ottenuta, prima che dal materiale annientamento nella
morte, dallo scioglimento di ogni legame affettivo: «io la libertà la voglio, e la saprò raggiungere… o soccomberò», grida Carlo, usando un verbo che, anche nei
ricordi di lettura di Campailla, gli sarebbe stato imprestato da Nadia. «Non retro48
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
cederò nemmeno di fronte all’affetto della mamma», ribadisce in un’ulteriore lettera a Jolanda, quasi presagendo il tragico finale 20. Anche se proprio alla madre,
nelle righe di quella lettera che avrebbe voluto destinata alle fiamme, dichiarava
l’affetto materno come l’unico per il figlio «che non tange la sua libertà nella vita»,
almeno «fino al punto in cui giunge a rinunciare alla vita» (16 ottobre 1908). La
lotta, dice ancora a Jolanda, è nel non salire sull’orrido treno che dovrebbe portarlo «nel mondo borghesemente, trionfalmente cretino» (25 aprile 1907): a sostenerlo sono una voce morente che incita piuttosto a «soccombere» e un’altra (della stessa Jolanda), più giovanilmente fiduciosa che incita a perseverare e vincere.
Stirner e d’Annunzio, il d’Annunzio del Più che l’amore non a caso citato a breve distanza in una lettera ai familiari (14 giugno 1907), sovraintendono a questo
brevissimo e quanto mai inusuale epistolario amoroso con Jolanda. «Voglio e potrò foggiarmi la vita come opera d’arte», scrive a Jolanda sempre il 25 aprile, ma
a lei soprattutto chiede di amarlo «oltre la vita, oltre i confini umani», «al di sopra della vita e della speranza», riu­­scendo a essere felice nell’infelicità: quella zona dell’«oltre» in cui Maria si univa a Corrado Brando, usi entrambi, su un’eco dal
Rimbaud di Une saison en enfer, a cantare nei supplizi, come amerà dire di sé anche Arangio-Ruiz 21. Nella recensione di Carlo al Più che l’amore apparsa nel 1908
sul «Corriere Friulano», tornerà, oltre al passo di Stirner e la conseguente alternativa tra la «via luminosa» indicata a Paula e il «soccombere» di Nadia, il grande
tema della libertà perseguita tramite la rottura di ogni legame, già messo a fuoco
nella lettera del 12 gennaio 1907, scritta al ritorno dal teatro. Unico nucleo drammaticamente vivo e altamente lirico della tragedia è infatti per Michelstaedter la
rappresentazione dell’uomo «chiamato agli ideali più alti, che consacra a questi
tutto se stesso e si strappa da ogni affetto umano per la tema, per l’angoscia di trovarvi il legame che menomi la sua individualità sola e tesa come un arco verso il
destino» 22. E gli affetti, non a caso, coincidono anche per Corrado Brando con le
«dolci rimembranze della giovinezza lontana passata in comunanza di sogni e di
vita» e con uno scenario familiare di cose delicate e fresche, animate da una «creatura musicale», Maria Vesta 23. Quella Maria che, nella casa condivisa con il fratello Virginio e sfondo di un idillio domestico, suona per gli amici diffondendo
«il silenzio del mondo quando parla Beethoven» 24. Il tutto esattamente duplicato nella scrittura epistolare dello stesso Carlo, dove Argia Cassini si prospetterà a
sua volta, nella lettera dell’agosto 1908 a Gaetano Chiavacci, quale «creatura musicale», mentre nel salotto familiare di Gorizia, come scrive ancora a Chiavacci, lo
«spirito fluttua deliziosamente in un mare di cose buone e dolci», per cui, «non
meno deliziosamente però», lo scrivente si sente «di giorno in giorno incretinire»
e progressivamente imborghesire (22 dicembre 1907).
La distonia con il proprio nucleo familiare, pur tempestivamente rassicurato,
dopo Nadia e Jolanda, nei fatti e nelle parole, è ormai segnata: «voi non m’avete
49
simona costa
«dal punto di contatto» alle «sfere dell’ombra». sull’«epistolario»
seguito in questo mese, che io ho vissuto tanto, e poi vi siete meravigliati dei risultati dello svolgimento […]. Io mi sono completato, non mi sono cambiato. – Certo però è stato fatale che in quel periodo non abbiamo vissuto insieme. E perciò
ci siamo trovati stonati», scriverà a Paula il 4 giugno 1907. E la malinconica lettera al padre del 27 giugno, che ribatte con tristezza ai suoi incessanti rimproveri di
essere moralmente guastato dai principi moderni, è già, a ben vedere, preannuncio della lettera alla madre del 10 settembre 1910.
Non sorprende dunque che il definitivo ritorno a casa, per la stesura della tesi, conceda un’illusa pacificazione per il solo lasso di tempo coperto dal viaggio di
ritorno, quando vede «le Alpi illuminate dai primi raggi del sole, e […] in un paesello a pochi chilometri da Gorizia […] le operaie friulane, coi piedi nudi e i capelli biondi, e […] il profilo del S. Valentin, e […] l’Isonzo». È la lettera da Gorizia a Gaetano Chiavacci del 29 giugno 1909, in cui rende l’angosciata radiografia
di uno spaesamento ormai insinuatosi anche nell’ultimo illusorio rifugio: «Ti scrivo dal mio tavolo, accanto sono tutti i miei libri, sul sofà dorme papà, fumo il tabacco che mi piace, vedo i rondoni […] attorno al castello… ma non sono contento affatto – peggio che a Firenze perché non ho più dove desiderarmi. Concludo
che è peggio il ritorno che la partenza; questa è una morte semplice, quella una
doppia morte». Se il 1905 si chiudeva con l’allegra registrazione dei fischi dei treni
e l’esclamazione «che bella cosa il ritorno!», l’ultimo periodo a Gorizia testimonia, attraverso le lettere agli amici, una più pervicace distanza, incolmabile stavolta perché consumata non più sotto lo schermo giustificatorio dell’assenza. Il lungo
dialogo epistolare con i familiari finisce così per stagliarsi quale strumento di sopravvivenza di una comunione sentimentale e di intenti illusoria: ancor viva sotto l’alibi della lontananza; decaduta con il fisico rientro in quel salotto borghese.
L’esuberanza vitale dell’impetuoso nuotatore, del ragazzo fidanzato a una bicicletta e appassionato del ballo («per me il ballo è un piacere fisico, una voluttà insuperabile») 25, la ricerca di salute nella vita attiva e nell’immedesimazione con la
natura, l’inquieto richiamo ibseniano del mare come il pacificante, tolstojano vagheggiamento della vita campestre non soccorrono più. E ancora, il nietzschiano
anelito ascensionale verso le montagne che costerà più tardi (1923) la vita all’amico Nino, la volontà di essere un falco e non una cornacchia, pur nella consapevolezza che «in fondo in fondo tanto vale una cornacchia che un falco» se entrambi «vivono e mangiano per morire» 26 : tutto infine si blocca all’ultimo bivio tra la
via luminosa e il soccombere.
È ormai tempo che il colloquio si faccia tutto generazionale, si allarghi a un
“noi” di condivisa sofferenza, giocata sull’amato contrasto luce/ombra: «noi viviamo oscuri, mal delineati, confusi, doppiamente infelici; gli altri vivono una vita luminosa anche nel dolore», scrive a Gaetano Chiavacci il 29 giugno 1909, dando della loro condizione di «forzati alla stessa catena» la caustica connotazione di
«parodia di calvario». Dall’interno ormai della casa paterna, il dialogo resta solo con gli amici, con cui era stato possibile condividere, persino in levità, la problematica ideologica del suicidio, magari sdrammatizzata in unione al gioco della
morra, come con Chiavacci («Certo è che gli unici bei ricordi di questo periodo
sono quelli della nostra convivenza – dalla mora ai propositi di suicidio», da Gorizia, 11 luglio 1908), o allusa in una simpatetica rilettura dello spagnolo Ramòn
de Campoamor con la sua Lo que se piensa al morir, come con Enrico Mreule (14
aprile 1909). Con funzione apotropaica verso il proprio «pensiero dominante» si
dissuade gli amici da un comune proposito: sia Chiavacci («Colui che per fuggire una pena pensa alla morte non ne misura la profondità tanto come non ha saputo misurar la profondità della vita», gli scrive il 29 novembre 1909), sia quel
Rico a cui si sottrae prudenzialmente la pistola al momento della partenza per il
Sud America. L’abisso più volte rasentato e stornato da una residua spinta vitale o
da un tempestivo gesto o parola materni (come dicono le lettere a Rico e alla madre del 29 giugno e del 10 settembre 1910) si aprirà complice la pistola sequestrata all’amico. La lettera da Pirano del 2-3 settembre al cugino Emilio, che sentiva
con orgoglio di aver formato, era tutta declinata nello spirito del già dannunziano
«navigare necesse est, non vivere», additando il porto non «dove gli uomini fanno
i porti a riparo della loro trepida vita», ma nella «libera vita del mare dove ognuno s’apre da sé la via ed è in porto sicuro là dove gli altri periscono». Quel mare
omericamente «color del vino» da navigare a vela, con tutta la tela spiegata, raccogliendo il vento della sera nell’infiammato tramonto della costa istriana, come
si racconta da Gorizia a Gaetano Chiavacci (4 agosto 1908).
Si sciolgono le vele e, insieme, si sciolgono gli ultimi legami. «Dal punto di
contatto rientreremo l’un per l’altro nelle sfere dell’ombra», aveva scritto, in una
suggestione figurale da Orfeo ed Euridice, al momento in cui stava nascendo una
simpatia con Fulvia Cassini: lui, come scriveva alla sorella, sempre timoroso di
una sua presunta insensibilità amorosa («Dubito d’aver mai amato, dubito di poter mai amare», 11 febbraio 1906) e di sentirsi vivere “fuori dalle passioni” («Mi
accorgo sempre più con orrore che sono condannato a restar per sempre fuori dalla vita grande intensa passionale», a Gaetano Chiavacci, 4 agosto 1908). «Solo una
reazione mi resta ora: d’andarmene, di distruggere questo corpo che vuol vivere»,
aveva scritto già il 2 settembre 1909 a Rico. Qualcosa di molto simile l’Ettore Schmitz del suo primo romanzo aveva attribuito al suo protagonista, Alfonso Nitti,
così siglando la sua vicenda: «Non sapeva amare e non godere: nelle migliori circostanze aveva sofferto più che altri nelle più dolorose […]. Quella era la rinunzia
che egli aveva sognato. Bisognava distruggere quell’organismo che non conosceva pace; vivo avrebbe continuato a trascinarlo nella lotta perché era fatto a quello
scopo». Solo che a differenza di Alfonso Nitti, stretto seguace di Schopenhauer
con un occhio a Darwin, per Carlo Michelstaedter non si tratta di alcuna rinun-
50
51
simona costa
zia, perché, come sappiamo, «la vita si misura dall’intensità e non dalla durata» e,
soprattutto, «chi si attacca alla vita è già giudicato».
note al testo
1
Cfr. la lettera dell’8 aprile 1908 alla madre in C. Michelstaedter, Epistolario, a cura di S. Campailla,
Milano, Adelphi, 1983, p. 308. Le citazioni sono da questa edizione, ma è ora uscita una nuova edizione riveduta e ampliata dell’Epistolario, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010.
2
Si veda l’articolo dedicato da Carlo allo scrittore russo sul «Corriere Friulano» del 18 settembre 1908,
in Id., Opere, a cura di G. Chiavacci, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 650-654.
3
Per la lettura del Vangelo cfr. la lettera alla famiglia del 27 maggio 1909; per Leopardi e Platone,
quella del 14 aprile 1909 a Enrico Mreule e per Beethoven quella a Paula del 30 maggio 1909 (Epistolario,
pp. 381, 363, 383).
4
Cfr. S. Campailla, A ferri corti con la vita, Gorizia, Comune di Gorizia, 1974, p. 105.
5
Si veda la lettera a Enrico Mreule di data incerta, oscillante fra dicembre 1909 e gennaio 1910, in Epistolario, p. 425.
6
Si vedano, tra fine ottobre e primi novembre 1905, le lettere del viaggio e dell’arrivo a Firenze con la
registrazione delle prime impressioni, ivi, pp. 20-55.
7
Per un’ulteriore riflessione sull’immediatezza comunicativa della scrittura epistolare si veda anche la
lettera del 2 febbraio 1907, ivi, p. 180: «E le lettere che m’accompagnate […] mancano del vero piacere che
dà la lettera con l’elemento personale di chi legge, con la coscienza che ci dà che quello scrivendo pensava
a noi, si rivolgeva a noi».
8
Si vedano le lettere del 4 marzo 1907 e del 30 marzo 1909, ivi, pp. 189, 357.
9
Cfr. una lettera senza data, ascritta ipoteticamente da Campailla al novembre 1905, ivi, p. 64 e quella di fine gennaio 1906, ivi, pp. 92-93.
10
Lettera del 19 novembre 1906, ivi, p. 148.
11
Per Carducci cfr. la lettera del 22 dicembre 1907, ivi, p. 266 e per Baretti quelle del 6 dicembre 1905,
del 19 febbraio 1906 e del 20 marzo 1906, ivi, pp. 70, 105, 114.
12
M. Cerruti, Carlo Michelstaedter, Milano, Mursia, 1987, p. 11.
13
Cfr. le lettere del 24 ottobre 1905 e del 13 gennaio 1906, in Epistolario, pp. 18, 81.
14
Per questi ritratti, cfr. le lettere del 14 gennaio 1906, del 6-7 novembre 1906 e del 9 gennaio 1907,
ivi, pp. 83, 144, 161.
15
Si veda anche, per una scrittura epistolare tendente alla sceneggiatura, la lettera del 16 febbraio 1908,
ivi, p. 283: «Intanto accendiamo il lume – chiudiamo la finestra – tiriamo la tende – bene: così almeno s’è
cambiata la luce e il colore e questo è qualche cosa».
16
Cfr. le lettere del 23 ottobre 1905 e del 31 ottobre e 1° novembre 1905, ivi, pp. 14, 45-47.
17
Max Nordau era tra l’altro autore ben presente anche alla poetica di quel Pirandello di cui Carlo,
sappiamo dalle lettere, apprezzava le novelle, inviate anche al fratello Gino.
18
Cfr. Cerruti, Carlo Michelstaedter, cit., p. 25.
19
S. Campailla, Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e tragedia, Venezia, Marsilio, 2010.
20
La lettera, senza data, è collocabile, secondo un’indicazione dei familiari, verso fine aprile 1907: Epistolario, p. 205.
21
Cfr. Campailla, A ferri corti con la vita, cit., p. 40.
22
Cfr. la recensione al Più che l’amore sul «Corriere Friulano» del 6 maggio 1908, in Michelstaed­­ter,
Opere, cit., p. 648.
23
Ivi, pp. 648-649.
24
G. d’Annunzio, Più che l’amore, in Id., Tragedie, sogni e misteri, i, Milano, Mondadori, 19648, p. 1156.
25
Cfr. la lettera del 6 febbraio 1906, in Epistolario, p. 98.
26
Si veda la lettera alla famiglia del 30 marzo 1909, ivi, p. 355. Per la contrapposizione falchi/cornacchie, si veda anche la lettera a Enrico Mreule, da Firenze, del 14 aprile 1909, ivi, p. 360.
52
Michelstaedter personaggio
di Paola Culicelli
Michelstaedter è un cercatore di verità. Intenta la scalata all’alto, all’assoluto, con un profondo sentimento della vertigine. I luoghi ricorrenti, nella sua geografia di scrittore, continuamente in bilico tra vette e abissi, sono la montagna
e il mare.
Ha un occhio, e una voce, che denunciano la nudità del re, che smascherano
la menzogna, una vocazione dissacrante alla caricatura. Segnatamente, la prolusione di Sergio Campailla a questo convegno ha avuto come titolo La persuasione e la menzogna.
È un giovane incendiario l’enfant prodige goriziano, che non è mai voluto diventare pompiere, un adolescente, dal latino adolescor, ossia “crescere”, che per
scelta si è rifiutato di invecchiare: un forever young a prezzo della vita, un Peter
Pan maledetto, ma anche un «precocemente maturo». Possiamo immaginarlo come Paolino, protagonista del racconto omonimo inserito nella recente Melodia
del giovane divino. Già nel nome, il personaggio porta scritto il suo destino. Viene da paulus, che vuol dire piccolo, inoltre a ribadire il suo status di giovanissimo
concorre il diminutivo. Paolino è il ragazzo che rinuncia a diventare uomo. È così bravo, così diligente, educato, rispettoso, che sembra un uomo, «è come un uomo» 1 scrive Michelstaedter più e più volte. Attraverso quel sembra e quel «come»
si precisa però una differenza: Paolino non è un uomo e non lo sarà mai. Ha come amica del cuore una gallina dal bianco piumaggio – una bianca pollastra, direbbe Saba – e, quando scopre quale destino le abbiano riservato la madre e la
cuoca, si ribella. Si oppone alla catena alimentare, alla violenza trofica che sta alla base della società, alla legge del pesce grande che mangia il pesce piccolo. Tuttavia, alla sua infantile disubbidienza, la madre obietta le ragioni dell’adulto, che
ormai ha accettato il compromesso sociale, scendendo a patti con la vita, e lo rim53
paola culicelli
michelstaedter personaggio
provera duramente: «Paolino va’ di là, questi son capricci da bambini e non da
uomini» 2. A queste parole, Paolino risponde laconico, con un nodo in gola, trattenendo le lacrime: «ma io non voglio – essere un uomo – allora» 3. In quell’«allora» c’è il gran rifiuto di Michelstaedter. Con quella risposta lapidaria, il giovane protagonista, come lo scrittore, viene a ferri corti con la vita 4, incapace di accomodamenti e vie di mezzo.
Una variante di Paolino è Amicizia per un cane, che si rifà a un episodio significativo della biografia di Michelstaedter, a un’altra rivolta adolescenziale. Dopo
aver infatti salvato dalla strada un cane randagio, Carlo fu sorpreso dai genitori mentre gli faceva la toletta nella loro vasca da bagno e, per di più, lo strofinava
con la spugna del padre. Sempre più evidenti si fanno i sintomi della sua insofferenza. Dietro l’amore per gli animali, si sa, si profila non di rado l’ombra della misantropia. Inoltre, il fatto che il testo originale sia in greco è un altro indizio. La
comunicazione con gli uomini del suo tempo è interdetta, non c’è alcuna possibilità di scambio. Così come nella Persuasione e la rettorica, in cui fa continuamente ricorso al greco antico, parlando di Socrate e dei filosofi ellenici come se fossero loro i suoi interlocutori, suoi contemporanei nonostante i secoli, il giovane Michelstaedter si professa inattuale: «Io lo so che parlo perché parlo ma che non persuaderò nessuno» 5. Tutto ciò che si accinge a dire è stato già detto ma non può fare altrimenti, come è «necessario che se uno ha addentato una perfida sorba la risputi» 6. Coloro che lo hanno preceduto sulla via della persuasione, Leopardi, Petrarca, Beethoven, Socrate, Cristo, hanno rivelato agli uomini, ancor prima di lui,
quelle stesse verità amare, eppure l’umanità ha proseguito indifferente sulla sua
strada, come se quelle parole non fossero mai state dette.
«La via della persuasione non è corsa da “omnibus”», spiega, «non ha segni,
indicazioni che si possano comunicare, studiare, ripetere. Ma ognuno ha in sé il
bisogno di trovarla» 7. C’è in lui una ricerca, seppure frustrata, del divino: «L’assoluto», spiega, «non l’ho mai conosciuto, ma lo conosco così come chi soffre d’insonnia conosce il sonno, come chi guarda l’oscurità conosce la luce» 8.
Parlare di Michelstaedter richiede perciò una conversione: bisogna fare i conti con la sua istanza di verità e di autenticità.
Rifacendomi alla metafora dei falchi e delle cornacchie, cara allo scrittore goriziano, mi sento di affermare che, per poter parlare di lui, è necessario spingersi
laddove l’aria è più rarefatta, laddove osano i falchi: occorre mettersi in gioco, accettare la sfida: la vetta o l’abisso. Il falco è il persuaso che vola libero, mentre la
cornacchia è chiusa nella gabbia della retorica, al sicuro.
Un’altra società. Carlo Michelstaedter e la cultura contemporanea: questo il titolo del convegno. In questi due giorni di lavori, si è tentato di proporre un’altra società, mettendo al bando la retorica.
Il rischio paradossale, ne eravamo tutti consapevoli, era quello di ricordare, a
cento anni dalla morte, il filosofo della persuasione, violando la sua memoria con
la armi della sua nemica mortale: la rettorica. E il paradosso, con uno scrittore come Michelstaedter, bussa continuamente alle porte. La persuasione e la rettorica,
che rappresenta il suo capolavoro postumo, il suo testamento d’artista sconosciuto, è infatti la tesi di laurea mancata di chi ha affermato che l’università è il tempio della retorica, eppure oggi, nelle accademie, a partire dalla sua tesi rinnegata, si moltiplicano in quantità industriale le tesi di laurea 9. Dalla persuasione alla retorica, come insegna Michelstaedter, il passo è breve, brevissimo. Prendendo
in prestito le sue stesse parole, in modo analogo, sul vangelo di Cristo hanno edificato la Chiesa. Bisogna perciò dare atto al suo più grande studioso, Sergio Campailla, di non aver mai voluto concedere, per principio, una tesi di laurea su di lui.
Partiamo dal titolo. Perché Michelstaedter personaggio? Parliamo di uno scrittore postumo. La data ante quem, ineluttabile, è quella del 17 ottobre 1910. Michelstaedter non ha pubblicato nulla se non alcune caricature, in un giornale goliardico redatto da studenti universitari fiorentini, dal titolo «Gaudeamus Igitur»,
e degli articoli d’occasione sul «Corriere Friulano», complice la zia Carolina Luzzatto Coen.
È uno studente oscuro alla vigilia della dissertazione della tesi di laurea, che
pure non discuterà mai. Il suo è un laboratorio privato, ingombro di una messe
di carte inedite, nel quale la vocazione alla scrittura rasenta la grafomania. Quelli che oggi vengono considerati i suoi capolavori, La persuasione e la rettorica, I figli del mare e Il dialogo della salute, sono serrati in un cassetto, inediti, quasi sepolti, minacciati dal silenzio.
L’epistolario registra una serie di fallimenti, di tentativi abortiti. Nelle lettere ai familiari, Michelstaedter scrive delle sue richieste di collaborazione, presso
giornali e riviste fiorentine, andate in fumo, così come delle sue candidature a traduttore, prima dal francese e poi dal tedesco, quest’ultima documentata in una
lettera a Benedetto Croce, finora inedita, nella quale si offre di tradurre Schopenhauer 10. In una significativa lettera al padre, invece, lamenta che l’università, ancora una volta, ha rifiutato la sua richiesta di esonero dalle tasse, profetizzando
che, a distanza di secoli, la sua grandezza conoscerà il giusto risarcimento: «La risposta giusta sarebbe – se non mi danno la dispensa – d’andarmene senza pagare
un soldo e senza prender la laurea: – così fra secoli quando io sarò un grande morto resterà all’università di Firenze la vergogna d’avermi cacciato. Peccato che debbano passare i “secoli”. Intanto vado all’istituto, e alle biblioteche come un mortale qualunque» 11. Sono parole che fanno tremare le vene e i polsi. Da visionario,
si proietta in un futuro remoto, di là della sua morte. È già arrivato al punto di
non ritorno. Scrive Campailla: «Michelstaedter si isola dal mondo, radicalizza la
sua passione e le sue scelte, vive da asceta chiuso come all’interno di un faro, imposta con se stesso un inesauribile monologo drammatico» 12.
54
55
paola culicelli
michelstaedter personaggio
Come un faro, Michelstaedter rimane al buio della sua stessa luce. Chiuso in
quella sua ombra di scrittore inedito e sconosciuto, avvolto dalle brume, richiama alla memoria un aforisma di Nietzsche, in base al quale il saggio, al pari di
una fiamma che brucia, è chiaro agli altri ma oscuro a se stesso, accecato dalla sua
stessa luce, come il suo amato Beethoven, che può comporre melodie straordinarie sordo alla sua stessa musica. Una coincidenza degli opposti, dunque. Michelstaedter ne era consapevole.
Nel pensiero intorno alla Libertà scrive: «Questa tua ragione vuol conoscere sé
stessa e in sé ogni cosa, per cui quando a te apparirà la meta vedrai con chiari occhi
che la meta di te sei tu stesso e come è il principio così è la fine, e la tua forza conflagrerà in fiamma luminosa nella perpetua serena immobilità del tuo spirito» 13.
Si tratta di un’autocombustione. È un eccesso di luce a contraddistinguerlo.
«La lampada si spegne per mancanza d’olio», appunta su una delle sue pagine
tormentate, «io mi spensi per traboccante sovrabbondanza» 14. Non a caso il mito di Prometeo è ben presente a Michelstaedter, sia laddove ritrae il titano a icona del persuaso, sia nell’epistolario, dove scorre sottotraccia come un fiume carsico: sempre il furto del fuoco porta con sé una maledizione. Quella di Carlo è una
luce apollinea, accecante e oscura, solare e notturna, è la luce di Febo Apollo, dio
luminoso, e di Apollo Lykos, dio lupo della notte.
L’autoritratto del maggio 1910 è esemplificativo. Il volto sembra emergere
dall’ombra, avvolto da un’aureola di luce. L’ovale è per metà al buio, per metà rischiarato, proprio a significare la dialettica di ascendenza giovannea tra luce e tenebra. In basso una scritta in greco recita: «L’uomo nell’oscurità accende una luce a se stesso» 15.
È una febbre la sua, un fuoco. È significativo che l’amico Mreule lo abbia definito un «Buddha moderno». La sorella Paula, invece, ricorda come Michelstaedter, negli ultimi tempi, vivesse da asceta nella sua casa di Gorizia, nutrendosi di
latte, dormendo sul pavimento, rifiutando l’affetto dei cari. «Meglio l’odio», sentenzia oscuro nei suoi scritti, «che l’affetto della famiglia» 16.
«E sotto avverso ciel – luce più chiara» 17 è appuntato sul retro del suo ultimo dipinto, cui lavorò nei suoi ultimi giorni di vita, probabilmente con l’intenzione di donarlo alla madre nel giorno del suo compleanno, proprio quel 17 ottobre.
L’attenzione al cielo e agli astri è ossessiva. Su un taccuino si può notare la meticolosa osservazione di un’eclissi solare in tutte le sue fasi 18. Nel 1910, invece, il
passaggio della cometa di Halley, con la sua coda suggestiva, quasi lo strega, portandolo a riflettere in modo enigmatico sul fatto che pochi nella loro vita abbiano
la ventura di vederla due volte. In quello stesso anno si toglierà la vita.
Lo sguardo intento alla volta celeste rivela la sua fame d’assoluto.
È opportuno tornare a parlare dello scritto Περὶ χυνοϕιλίας, ossia Amicizia per
un cane, che di seguito riportiamo tradotto:
Da fame e da sete costretto venne il cane nero alla casa degli uomini. Temeva, sì, costoro, ma non aveva l’animo di fuggire; perché era bramoso di cibo. E vide il saggio il nero cane, come tremante e affamato fosse ridotto all’estremo, ed ebbe pietà di lui. Accolse
il cane in casa e gli diede da mangiare e da bere, e gli volle bene, in quanto riconobbe in
lui se stesso vivente, e gioì della gioia del cane, e si rallegrò del ristorarsi del cane. – Non
si accorse che in ciò amava la propria stessa vita.
Ma sopraggiunsero i padroni di casa, i genitori del saggio, e si adirarono fortemente
con lui, sembrando loro che avesse agito da ragazzo, e cacciarono via con grande clamore e viva forza il cane, mendico.
S’indignò di questo il saggio, vedendoli così egoisti, ma nulla disse; perché riconobbe il suo proprio attaccamento alla vita, e che ciecamente aveva collocato il suo amore su
di un niente, e che niente era egli stesso.
E s’indignò contro se stesso e contro il suo stesso sdegno, e la sua intensità di vita e
la sua richiesta del bene lo fecero tremare, come l’attaccamento alla vita faceva tremare il
cane. Ed ebbe timore della Notte, madre delle Eumenidi e punitrice dei ciechi e dei veggenti, e desiderò la morte.
Ma nuovamente e nel dolore e nell’attività, e nell’amore del bene e nella morte riconobbe l’attaccamento alla vita. La pace invece non ha a che fare con queste cose.
Cucù cantaba la rana.
Cucù debajo del rio.
Poiché tutto è niente 19.
56
57
Il «nero cane», con l’aggettivo preposto al sostantivo, ha ormai trasceso il dato reale, non ha più niente a che fare con l’animale randagio ospitato nella propria casa, piuttosto è un’allegoria della mente, una fiera dantesca; rappresenta la
voracità, la fame, in senso metafisico, di chi desidera ciò che non ha, l’eros nell’accezione socratica, figlio di Poros e Penia, e dunque il mero attaccamento alla vita. Chi ha paura di morire, chi teme la morte, secondo Michelstaedter, è già morto. Il «nero cane» simboleggia la sua stessa paura della morte, un demone che lo
bracca. L’animale, nel suo istinto vitale, è dominato dalla filopsichia, l’amore per
la vita che accende agli uomini sempre nuovi piaceri per ingannarli e distoglierli
da quel sordo, «misurato dolore che stilla sotto a tutte le cose» 20. Suggestiva l’immagine della Notte punitrice dei ciechi e dei veggenti, che Michelstaedter immagina di esorcizzare accarezzando l’idea della morte.
L’intero apologo è pervaso di un afflato evangelico. Per alcuni versi l’indignazione dei genitori nei confronti del saggio, accusato di essersi comportato in modo capriccioso, alla stregua di un ragazzo, ricorda l’episodio dell’allontanamento di Gesù da Maria e Giuseppe, che poi lo ritrovano nel tempio a discorrere di
questioni teologiche con i sommi sacerdoti. La stessa dicotomia saggio-ragazzo è
significativa. Il ragazzo saggio è il «precocemente maturo», incarna l’intensità di
Cristo in opposizione alla durata di Matusalemme: «La vita si misura dall’inten-
paola culicelli
michelstaedter personaggio
sità e non dalla durata – l’intensità è in ogni presente: la durata sia essa anche infinita non è meno vuota se non è che un susseguirsi di presenti vuoti. Cristo è vissuto più che Matusalemme, un insetto effimero vive più che un albero secolare» 21.
In quel 17 ottobre 1910, dunque, Michelstaedter si dà la morte, cieco e veggente.
La stessa mancanza di titoli nelle sue opere è emblematica, vuol dire rimanere
nel cerchio del proprio silenzio, nella solitudine della propria caverna, come scrive Nietzsche a proposito di Schopenhauer. L’assenza del titolo è un ponte franato
nella comunicazione con l’altro.
I suoi scritti, tutti inediti, sono serrati nelle cassapanche ottocentesche.
Scrittore postumo, abbiamo detto. Era necessario, prima di tutto, che qualcuno lo raccontasse, che lo strappasse a quel buio, a quell’oscurità che lo circondava. C’era bisogno di uno scrittore.
Mi viene in mente una novella di Turgenev, compresa in Memorie di un cacciatore, intitolata I cantori. L’io narrante, il cacciatore appunto, trova ristoro in una
locanda nel villaggio di Kolotòvka, dove si sta svolgendo una gara di canto tra due
contendenti. Il primo, un appaltatore di Zizdra, è un uomo corpulento e massiccio, sicuro di sé e della vittoria. La sua voce è stentorea, prepotente, e si conquista subito la benevolenza del pubblico. È un artigiano della parola e rappresenta lo scrittore affermato, inserito nel canone. Il suo rivale è Jaska Turok, un giovane gracile e insicuro, poco più che ventenne, sul quale nessuno si sentirebbe di
scommettere. Quando tuttavia la sua voce si leva è come se si compisse un miracolo: una magia si trasmette a chi l’ascolta. Come l’albatros di Baudelaire, quando
cammina in mezzo agli altri uomini, è impacciato e ridicolo ma, allorché si libra
in volo, è maestoso: è il «principe dell’azzurro». Contro tutte le aspettative, dunque, è il secondo a vincere il premio in palio, un ottavo di birra, ed è il suo stesso
sfidante, l’appaltatore di Zizdra, a riconoscerne la superiorità.
Perché noi potessimo sentire la voce dello sconosciuto Jaska Turok, era indispensabile che Turgenev, nei panni del cacciatore, entrasse in quella locanda remota della steppa russa. Analogamente, perché noi potessimo scoprire Michelstaedter, c’era bisogno di un narratore. Se infatti possiamo paragonare l’autore goriziano all’ignoto cantore, ossia Jaska Turok, è vero che Sergio Campailla, suo massimo studioso, può essere accostato all’io narrante, cacciatore nel senso di cercatore, ossia der suchende. Campailla rappresenta, in un certo senso, lo scrittore,
Turgenev stesso.
Era il 4 marzo 1973. La locanda remota nella steppa russa era la casa al civico
36 di via Cadorna. Cito dal Segreto di Nadia B.:
[…]
Era una data importante e, tutti e tre, sembravamo partecipare a un rito esoterico. Basti pensare che quel giorno prescelto, il 4 marzo, era di domenica, quando cioè la biblioteca era chiusa! Questo per evitare il più possibile pubblicità e sguardi indiscreti. Una discrezione che sarebbe servita anche al mio non facile lavoro di riordino e catalogazione
nella saletta riservatami, una specie di cella monastica.
[…]
Quel 4 marzo avvenne dunque l’ingresso nella casa di via Cadorna 36, dove erano custodite le carte, all’angolo con via Diaz.
[…]
Lì erano state conservate le carte, gli schizzi, i dipinti di Carlo, come altrettante reliquie.
La prima cosa che mi colpì furono le cassapanche ottocentesche, scolpite, di qualche
valore. Una di esse, nel tinello, era lo scrigno che custodiva il tesoro, la maggior parte del
lascito, organizzato in grosse cartelle. Ma dei manoscritti erano stipati anche dentro un
armadio in camera da letto.
[…]
Eravamo intimiditi. Per lo meno, così mi sentivo io. Era come se Carlo fosse morto allora, e non sessantatré anni prima; come se in quel lungo periodo, per l’artificio amoroso
della custode, il tempo si fosse fermato.
Quelle pagine trasmettevano l’eco di una voce, raccontavano una passione solitaria,
inarrestabile e vana. Chi poteva immaginare che le carte fossero così numerose, che l’attività di un giovanissimo fosse stata così frenetica? Quella calligrafia, vigorosa e personale, mi divenne immediatamente familiare. Una febbre aveva ispirato il suo autore… Cercavo di orientarmi. Era il mio compito. Sarebbe stata la mia responsabilità. Esaminai in
sequenza la varie sezioni. Sfogliavo qua e là.
Trovai una carta che portava questa indicazione, evidentemente della famiglia: Ultimo foglio scritto da Carlo. Mi fece una grande impressione: era macchiato del suo sangue. La prova crudele ed estrema della sua espiazione, dell’identificazione tra sangue e
scrittura 22.
4 marzo 1973: questa la data definitiva fissata per la consegna delle carte di Carlo Michelstaedter alla Biblioteca Civica di Gorizia.
Nasce qui A ferri corti con la vita, biografia di Michelstaedter pubblicata nel
1974 da Campailla. È il racconto della vita di un grande postumo, come un romanzo, una leggenda d’artista, o meglio Il ritratto dell’artista da giovane. In esso
Michelstaedter veste i panni dello scrittore inedito che, raccontato per la prima
volta, diviene a sua volta personaggio. Ha inizio in questo modo una lunga fedeltà, un sodalizio tra scrittori, seppure a distanza. Proprio questa mattina, presiedendo la sessione dei lavori, Campailla ha definito la biografia «la cellula segreta della storia».
Il riferimento a Joyce, e in particolare a The portrait of the artist as a young
man, non è casuale. Come è risaputo, lo scrittore dublinese impartiva lezioni di inglese a Svevo e, insieme a Montale, ha contribuito a renderlo noto al grande pubblico. Il loro incontro, tuttavia, è consistito in uno scambio reciproco. Svevo, dal
58
59
paola culicelli
michelstaedter personaggio
canto suo, ha infatti ispirato a Joyce il personaggio di Leopold Bloom nell’Ulysses, nel quale l’archetipo dell’eroe omerico si contamina con la figura dell’ebreo
errante, in una prospettiva di ulissismo giudaico. Allo stesso modo, Campailla ha
contribuito al revival internazionale di Michelstaed­­ter e quest’ultimo, a sua volta,
ha bussato alla porta di Campailla scrittore chiedendo udienza al pari di un personaggio, ispirandolo nel suo percorso di scrittura.
Gli scrittori, si sa, sono cannibali: si nutrono dei loro simili, di altri scrittori. E
a volte un incontro, così, per caso, può avere gli effetti di una coincidenza astrale.
Abbiamo detto dell’assenza di titoli negli autografi di Michelstaedter. Occorre qui ricordare come i nomi delle caricature e dei dipinti, così come degli scritti, si debbano a Campailla: quasi una scrittura a quattro mani. Per orientarsi nel
labirinto privato del goriziano, sigillato ermeticamente, gli strumenti del critico
erano insufficienti.
Non ci sembra superfluo rammentare che, accingendosi a consultare le carte
di Michelstaedter, Campailla si sentì dire, da un ordinario dell’università di Genova, che non vi avrebbe trovato nulla di scientificamente fruibile.
Per trovare una chiave di lettura, fare luce nei percorsi carsici di quella scrittura, piuttosto che una bussola, e i consueti strumenti del critico e del filologo,
erano necessari la sensibilità da rabdomante di uno scopritore di talenti e il fiuto di uno scrittore.
Tanta parte della suggestione che esercita la leggenda d’artista di Michelstaedter oggi, a cento anni dalla morte, si deve a chi l’ha raccontata.
Come ci viene rivelato nel Segreto di Nadia B., il nipote di Michelstaedter, Carlo Winteler, gravato dalla condanna dell’omonimia, quasi un doppio dello zio materno, è diventato Oscar Sinai in Domani domani 23, romanzo di Campailla percorso sottotraccia dal fil rouge della cultura ebraica. Oscar, quasi un anagramma
di Carlo, se non fosse per la esse al posto della elle, laddove la esse è l’iniziale del
nome dello scrittore: Sergio.
Basterà considerarne la scena iniziale e quella finale, che si richiamano a distanza, speculari. In apertura, infatti, compare la figura di un vagabondo, giunto
a piedi da Ostia a piazza di Spagna, che nel suo delirio profetico ripete la parola
ebraica «Abba» 24, che significa padre. Tale personaggio, nella sua erranza, è alla
ricerca del Padre, con l’iniziale maiuscola. È scalzo, sporco, quasi una personificazione dell’ebreo errante: la sua è una quest esistenziale che pesa come una condanna. L’ultima scena, invece, ha come scenario piazza San Pietro: di piazza in
piazza. L’occasione è quella dell’elezione del nuovo papa. Figura centrale, stavolta,
è l’ebreo Oscar Sinai, che cerca di comunicare in tutte le lingue con la folla che lo
circonda senza però riuscire a farsi capire da nessuno. È una scena babelica, nella quale l’ebreo è immagine del diverso, di chi è irrimediabilmente altro. L’accostamento a Michelstaedter, e al suo plurilinguismo, è immediato. Sappiamo, però,
che anche il nipote, Carlo Winteler, segnato da un bisogno segreto di emulazione,
scriveva lettere lunghissime ed erudite, nelle quali si esprimeva in diverse lingue.
Addirittura, in occasione della nascita del primo figlio maschio di Campailla, inviò un assegno intestato al nascituro nientemeno che in greco antico.
Entrambi i personaggi, il vagabondo e Oscar Sinai, sono a loro modo cercatori
di assoluto, proprio come Michelstaedter, e come lui sono condannati a non trovare mai ciò che cercano. Sono simili al folle nietzschiano della Gaia scienza, che
ricerca Dio in pieno giorno brandendo una lampada. L’esperienza che lo scrittore
fa dell’assoluto è quella della sua assenza: una coscienza dolorosa, per viam negationis. Nella prefazione a La Melodia del giovane divino, intitolata Alla ricerca del
tesoro che non c’è, la tensione di Michelstaedter verso l’assoluto viene paragonata in modo icastico da Campailla alla Creazione di Michelangelo: è quella distanza infinitesimale, e infinita, tra l’indice di Adamo e l’indice del creatore. L’uomo,
dunque, si protende verso Dio, verso l’assoluto, senza però mai riuscire a sfiorarlo.
La ricerca della verità da parte di Michelstaedter si rivela in realtà uno smascheramento della menzogna. Lo scrittore goriziano in effetti denuncia che il sancta sanctorum è vuoto, che non c’è nulla oltre il velo. La verità è che non c’è nessun assoluto, non c’è nessun tesoro.
Carlo è un ebreo che non frequenta la sinagoga e che si è allontanato dalla religione dei padri. Come tuttavia osserva Einstein, un ebreo che ha abbandonato
la propria fede è come una lumaca senza guscio: rimane pur sempre una lumaca.
Più in profondità affondano in lui le radici ebraiche, più abissale si fa il suo sentimento della perdita, più urgente la ricerca del suo tesoro perduto, un tesoro che
in realtà non c’è. Quello ebraico, in fondo, è il popolo della terra promessa, una
terra che è continua aspirazione: utopia nel senso di luogo felice e, insieme, luogo che non c’è. Quella di Michelstaedter è una terra promessa perduta. Alla fine
la sua Atlantide sarà rappresentata dal mare, regno alternativo e antitetico rispetto alla terra, e la sua inappartenenza, la sua diversità, saranno simboleggiate dalla
sua condizione di figlio del mare.
Molti si sono domandati come sia nato il sodalizio tra Michelstaedter e Campailla. Per rispondere prendo in prestito le parole dello stesso Campailla, sebbene la sua sia una risposta evasiva:
60
61
In questi anni mi sono abituato a sentirmi rivolgere una domanda: attraverso quale
strada sono arrivato a “scoprire” Michelstaedter, all’incontro con Slataper, Svevo e gli altri, a respirare insomma l’aria pungente, tra Bora e Carso, di quella fron­­tiera? Quale lo
scatto primo da cui è germinato il tenace interesse? Non pochi hanno accompagnato la
domanda con l’ipotesi che a Trieste, o nella zona, fossi nato. Avrei dovuto rispondere di
no, che ero nato a Genova. Ma esitavo, perché istintivamente mi rendevo conto che con
una simile risposta avrei non tanto fornito un elemento per chiudere la questione, quan-
paola culicelli
michelstaedter personaggio
to per depistare l’interlocutore. Infatti, anagraficamente, sono nato a Genova, ma padre e
madre sono siciliani. In casa, da bambino le mie orecchie erano avvezze non già al dialetto triestino, musicale e ciarliero, né a quello genovese, rude e rauco, ma a quello siciliano,
concitato e teatrale. Io stesso ho vissuto dagli undici ai quattordici anni in Sicilia: tre anni
tra i più delicati per qualsiasi formazione, e forse decisivi per la mia. Precisare tutto questo sarebbe stato­­ – bisogna convenire – un po’ lunghetto, ed inutile: curioso che, scrivendo un libro su Verga, nessuno mi abbia chiesto se fossi nativo della provincia di Catania o
– poniamo – di quella di Ragusa (e questa volta ci avrebbe azzeccato). […]
Quale, dunque, la strada che mi ha condotto dall’isola di Sicilia alla frontiera giuliana? In questa sede, non posso che rassegnarmi ad una risposta allusiva ed ellittica. Sì, anche la Sicilia è un coacervo di popoli e di civiltà, ha una sua tradizione nutrita di sincretismo. E poi c’è il percorso dal Sud al Nord, che sembra sia una sorta di itinerario obbligato per ogni intellettuale siciliano. Per restare in argomento, mi sono trovato a pensare,
a volte, che il siciliano è un po’ come l’ebreo (magari, come l’ebreo povero). E un siciliano trapiantato a Genova, non più siciliano e non più ligure, dominato dalle ambivalenze del sentimento e della razza, non è allora un ebreo poverissimo, orfano e randagio 25?
Sarebbe interessante rintracciare la presenza di Michelstaedter personaggio
nella narrativa di Sergio Campailla, ma in questa sede ci limiteremo ad alcuni
cenni.
Una stagione in Sicilia 26, romanzo d’esordio, è un Bildungsroman ma anche
un ritratto dell’artista da giovane, proprio come A ferri corti con la vita. Racconta
un’emigrazione di ritorno, da nord a sud, ossia da Genova, terra d’approdo, in Sicilia, isola archetipica delle origini. Protagonista è il giovane Antonio, che guarda caso è il nome rimosso dello scrittore, per esteso Sergio Antonio Campailla, la
cui iniziazione passa attraverso la scoperta della violenza e della sessualità. Il ragazzo, nel suo rito di passaggio all’età adulta, si trova costretto a scegliere tra realtà e fuga, denuncia e omertà. Imperante il simbolismo del fuoco, vero e proprio elemento battesimale che in Sicilia non può che ricollegarsi all’Etna e al mito di Empedocle.
Il paradiso terrestre 27 già nel titolo è riconducibile a Michelstaedter. Era il paradiso terrestre rappresenta infatti l’incipit e il titolo – quest’ultimo scelto da Campailla – di un racconto dello scrittore goriziano. Di nuovo, abbiamo un’emigrazione di ritorno. Il protagonista, Vanni Corvaia, da Genova approda in Sicilia, alla
ricerca delle sue origini. È un architetto che sembra aver ricusato la sua professione e si definisce un archeologo dilettante. Nella scena finale del romanzo lo troviamo a vagare nei labirinti sotterranei di Agrigento con una lampada, nel tentativo di scoprire la verità sulla mafia dell’acqua. È un cercatore di verità, come Michelstaedter e, fatalmente, è destinato a perdersi in quei sotterranei. Alla fine si
scopre che l’altra faccia del paradiso terrestre è l’inferno, per il siciliano così come per l’ebreo, e il paradiso non può che essere perduto.
Per quanto riguarda Voglia di volare 28, raccolta di narrazioni brevi, in prevalenza nel solco dell’ebraismo, citiamo il racconto Dialogo con l’angelo, nel quale il
desiderio e l’ansia del volo nascondono la segreta paura di cadere. C’è l’attrazione vertiginosa per l’alto controbilanciata da un oscuro magnetismo esercitato invece dalla caduta.
In Romanzo americano, altra raccolta di racconti, l’emigrazione è verso gli Stati
Uniti. Subito il primo, Like life, si apre all’insegna del nomadismo e dell’erranza:
«Cammelliere nel deserto. Oppure, viaggiatore nel Caucaso, dove si vive a lungo.
O esploratore nei ghiacciai della Groenlandia. Non avrebbe mai pensato, invece, di fare il lustrascarpe a New York. Proprio, lo sciuscià!» 29. Il destino dell’emigrante è simile a quello dell’ebreo condannato a errare: è quello dell’homo viator.
La divina truffa, romanzo del 2008 30, è incentrato sulla figura di Alessandro
conte di Cagliostro, mago, alchimista, medico, profeta, capo della massoneria di
rito egiziano. L’intreccio procede a ritroso, contraddistinto da una tecnica narrativa inedita. Ciò fa sì che, una dopo l’altra, cadano tutte le maschere dell’impostore
Cagliostro. Addirittura è accusato di essere ebreo, per le sue ricchezze, ma alla fine si scopre che il suo vero nome è Giuseppe Balsamo, e che è nato in un quartiere
malfamato di Palermo. Di nuovo, l’ebreo e il siciliano. È il romanzo di una truffa,
che fa riflettere su ogni forma di impostura e di menzogna, compresa quella religiosa, non a caso la truffa è detta divina, quando invece, di consuetudine, è diabolica. Ancora una volta, il dilemma è tra persuasione/verità e rettorica/menzogna. È un percorso di demistificazione che, per molti versi, presenta consonanze
interessantissime con il pensiero di Michelstaedter intitolato La filosofia domanda
il valore delle cose. Nel suo significato etimologico, la filosofia è amore del sapere
e dunque ricerca della verità. Lo scrittore goriziano ironizza sui «cercatori di assoluto, quindi anche su se stesso, che non si preoccupano di verificare “se l’assoluto c’è dentro o no”» 31, e fa il caso di una truffatrice internazionale, la Humbert,
«che parlava dei suoi milioni mostrando una cassa che nessuno osava aprire» 32.
Le consonanze con Cagliostro, divino truffatore, sono suggestive. Campailla arriva a trasformare la valigia chiusa, che serra il tesoro, nel sancta sanctorum, vaso
di Pandora vuoto che all’interno contiene la sola speranza, o fede che dir si voglia, degli uomini: «Credi! Credi! Questo è il segreto. E il sogno si realizzerà» 33.
Da ultimo Il segreto di Nadia B., per molti versi speculare rispetto al saggio A
ferri corti con la vita, anch’esso come un romanzo. Insieme, chiudono un percorso
circolare. La protagonista, Nadia Baraden, è un doppio di Michelstaedter. I loro
destini di giovani brillanti, luminosi, si sono incrociati, per poi spegnersi a breve
distanza l’uno dall’altro, come due comete. Persuasa al femminile, donna, ebrea,
russa, anarchica, colta, anzi coltissima, anche Nadia è morta suicida, tuttavia la
sua vicenda, fino alle recenti rivelazioni di Campailla, è rimasta obliata. Come
Carlo, anche lei è un personaggio che ha chiesto udienza per raccontare la sua sto-
62
63
paola culicelli
michelstaedter personaggio
ria: «Sua caratteristica è una vicenda tutta al femminile. La protagonista era come
un fantasma, che visitava la mia mente e che perorava il suo diritto all’ascolto, in
definitiva all’esistenza. Finché ho capito che era un personaggio in cerca d’autore.
E che io dovevo, dopo trentasette anni, essere quell’autore» 34.
E chi, se non uno scrittore, può essere abitato da personaggi?
Basterà leggere le ultime righe del Segreto di Nadia B. per scoprire Michelstaedter non più scrittore ma personaggio:
suo Ariel e il suo Calibano. Congedandosi dal nostro dipartimento di Italianistica, però, non intende certamente spezzare la sua bacchetta, né tantomeno infrangere i suoi incanti. Una scelta degna di Michelstaedter, la sua. Non ci resta che attenderci nuove storie, nuovi personaggi, nuovi romanzi:
Rimasto solo, impugna la pistola. Quella stessa arma che aveva sottratto per cautela all’amico Mreule. Il teorico della non violenza la riafferma, concentrandola su se stesso. Il contatto freddo della canna gli promette verità definitive, o almeno l’oblio. Forse ha
l’impressione di raggiungere, in una prova di fedeltà, quanti prima di lui si erano incamminati senza ritorno su territori vergini, alla ricerca di una catarsi impossibile: la famiglia
degli autoesclusi, i discepoli involontari di Egesia, Nadia e Gino. Nadia si era sparata alla bocca. Gino alla tempia destra.
Preme il grilletto, contro la tempia destra, come il fratello. Secondo il quotidiano locale, i colpi sono addirittura due. Crolla dal letto, a terra. L’agonia è orribile.
Il violinista oscuro, da tempo, nella luce del buio, eseguiva le variazioni della sua musica maledetta 35.
Ecco il gran rifiuto: Michelstaedter come Paolino, il suo personaggio. Qui, però, il personaggio è lui: è Carlo. Il romanzo è Il segreto di Nadia B., lo scrittore è
Sergio Campailla.
Come può uno scrittore, ci chiediamo, diventare personaggio? Quali le strade che lo conducono nell’officina di un altro scrittore? La domanda è lecita, scontata, la risposta invece non lo è mai. È il caso o il destino, comunque una coincidenza astrale, a far incontrare due scrittori. Racconta Campailla di aver letto I figli
del mare al tempo dei suoi studi universitari. Alla lettura, che dovette certo suggestionarlo, seguì un sogno: una donna che si tuffava in mare dicendogli: «Carlo ti
aspetta». Sarà stata quell’epifania onirica? Oppure l’ingresso nella casa di via Cadorna? O, ancora, saranno state le pagine autografe macchiate del sangue di Michelstaedter a vincolarlo, a suggellare il patto?
Sappiamo che con questo convegno dedicato a Michelstaedter si chiude la carriera universitaria di Sergio Campailla. È il 24 novembre, il giorno del suo sessantacinquesimo compleanno. Il convegno tenutosi a Gorizia, gemello e dioscuro di
questo, si è aperto invece il 17 ottobre, genetliaco della madre di Carlo e centenario della morte dello scrittore. Le date, è ovvio, in qualche modo sono evocative,
rispondono a un disegno.
Viene in mente l’immagine di Prospero nella Tempesta di Shakespeare. Come
il mago nella sua isola incantata, anche Campailla scrittore trasforma coloro che
fanno ingresso nel suo immaginario in personaggi. Come Prospero, anche lui ha il
64
Ora i miei incanti son tutti spezzati,
e quella forza che ho è mia soltanto
e assai debole. Ora senza dubbio
potete confinarmi qua
o farmi andare a Napoli. Non vogliate,
giacché ho riavuto il mio ducato
e perdonato al traditore, che io resti ad abitare,
in grazia del vostro magico potere, questa isola;
ma liberatemi da ogni inceppo
con l’aiuto delle vostre valide mani.
Un gentil vostro soffio deve gonfiar le mie vele,
altrimenti fallisce il mio scopo
che era quello di divertire. Ora non ho
spiriti a cui comandare, né arte da far incantesimi,
e la mia fine sarà disperata
a meno che non sia soccorso da una preghiera
che sia così commovente da vincere
la stessa divina misericordia e liberare da ogni peccato.
E come voi vorreste esser perdonati di ogni colpa,
fate che io sia affrancato dalla vostra indulgenza.
note al testo
1
C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla,
Milano, Adelphi, 2010, pp. 155, 156, 157.
2
Ibid., p. 159.
3
Ibid., p. 160.
4
Cfr. S. Campailla, A ferri corti con la vita, Gorizia, Comune di Gorizia, 1974.
5
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1982, p. 35.
6
Ibid.
7
Ibid., p. 104.
8
Ibid., p. 96.
9
Cfr. S. Campailla, Alla ricerca del tesoro che non c’è, in Michelstaedter, La melodia del giovane divino,
cit., p. 15: «La persuasione e la rettorica è una tesi di laurea mancata, che fa esplodere le contraddizioni del
sistema e che, alla fine, produce una montagna di tesi di laurea».
10
Cfr. C. Michelstaedter, Epistolario, Milano, Adelphi, 2010.
11
Ivi, p. ??.
12
Campailla, Alla ricerca del tesoro che non c’è, cit., p. 14.
13
Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., p. 59.
14
Cfr. Id., Poesie, a cura di S. Campailla, Bologna, Patron, 1973, illustrazione a p. 70; cfr. anche Id.,
65
paola culicelli
Opera grafica e pittorica, a cura di S. Campailla, Gorizia, Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei,
1975, p. 138.
15
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, catalogo della mostra a cura di S. Campailla (Gorizia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 17 ottobre 2010-27 febbraio 2011), Venezia, Marsilio, 2010, p. 161.
16
Id., La melodia del giovane divino, cit., p. 91.
17
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, cit., p. 177.
18
Cfr. ibid., p. 79.
19
Ibid., p. 162.
20
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 57.
21
Id., La melodia del giovane divino, cit., p. 127.
22
S. Campailla, Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e tragedia, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 16-25.
23
Id., Domani domani, Milano, Rusconi, 1992.
24
Ibid., p. 7.
25
Id., Due paginette quasi prefatorie, in Scrittori giuliani, Bologna, Patron, 1980, pp. 6-8.
26
Id., Una stagione in Sicilia, Foggia, Edizioni Bastogi, 1981.
27
Id., Il paradiso terrestre, Milano, Rusconi, 1988.
28
Id., Voglia di volare, Milano, Rusconi, 1990.
29
Id., Romanzo americano, Milano, Rusconi, 1994, p. 7.
30
Id., La divina truffa, Milano, Bompiani, 2008.
31
Id., Alla ricerca del tesoro che non c’è, cit., p. 25.
32
Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., p. 98.
33
S. Campailla, La divina truffa, cit., p. 257.
34
Id., Il segreto di Nadia B., cit., p. 10.
35
Ibid., p. 236.
66
Michelstaedter postmoderno: Il concetto di scienza
in Carlo Michelstaedter e Richard Rorty
di Yvonne Hütter
A cent’anni dalla scomparsa di Carlo Michelstaedter cercherò di sondare la
sua attualità e i punti d’incontro tra il pensiero michelstaedteriano e la filosofia
contemporanea. La domanda “Con chi parlerebbe Michelstaedter oggi?” non è
affatto superflua, visto che il filosofo, che a suo tempo fu poco recepito, potrebbe, secondo me, trovare molti interlocutori nel paesaggio filosofico attuale e forse addirittura adesso più che mai. Ciò che ancora cent’anni fa pare avergli impedito un successo più largo – si pensi solo alla valutazione di Gentile che criticò il
pensiero michelstaedteriano in quanto privo di sistema e metodo – ora potrebbe
perfino essere il suo punto di forza. Non avere un approccio metodologico ed evitare di diventare sistemico è anzi la conditio sine qua non della filosofia postmoderna, poststrutturalistica, pragmatistica (comunque si vogliano chiamare queste correnti) 1.
Date le grandi similitudini delle loro fonti, non ci sarebbe neanche da stupirsi.
Per il pensiero postmoderno bisogna citare prima di tutto la filosofia dell’esistenza (soprattutto Heidegger) e Nietzsche. Michelstaedter a sua volta recepì Nietzsche 2 e anticipò certe posizioni di Heidegger 3. Sia Heidegger che Nietzsche vengono inoltre associati ai presocratici e alla tradizione mistica – come anche Michelstaedter 4.
Nietzsche, Michelstaedter, Heidegger e, come mostrerò in seguito, Richard
Rorty, sembrano appartenere allo stesso filone della storia delle idee. Credo in
più che guardare Michelstaedter sotto l’ottica del pensiero postmoderno possa
essere estremamente produttivo. Non solo si trovano somiglianze con il pensiero
di Rorty, ma anche Derrida e Foucault mostrano similitudini con il filosofo goriziano. Quando ho cominciato a preparare questa relazione volevo mettere in luce molti più punti e molti più nomi – impresa che si è ovviamente ben presto di67
yvonne hütter
il concetto di scienza in carlo michelstaedter e richard rorty
mostrata irrealizzabile. Mi sono resa conto di dovermi limitare a un solo nome e
non solo a un solo nome, ma anche a un solo concetto nel pensiero dei due filosofi 5. Un concetto grazie al quale si riescono a illuminare le grandi somiglianze tra
Carlo Michelstaedter e Richard Rorty. Questo concetto, a mio avviso, è il concetto di scienza, cioè l’immagine di scienza che Michelstaedter e Rorty dipingono.
Bisogna però dire subito, che, anche se i loro pensieri condividono, come si vedrà, alcune strutture importanti, emergerà alla fine soprattutto la loro differenza.
Guarderò il concetto di scienza in Michelstaedter e Rorty sotto tre ottiche diverse: prima sotto quella epistemologica, poi sotto quella sociologica e infine sotto l’ottica etica.
bolezza dell’uomo ed ha dato ferma costituzione per tutti i secoli avvenire alla rettorica del
sapere. Nella infinita somma delle cose che non vedono, gli scienziati portano, con la tenacia dell’esperimento, la breve luce della loro lanterna cieca via via a ricavare dalla contemporaneità o dal susseguirsi d’una data serie di relazioni una presunzione di causalità:
un’ipotesi modesta, che diventi teoria o legge. Legge di chi? […] [E] a che? (PeR 83 ss.)
Entrambi, Michelstaedter e Rorty, smantellano grandi parti delle categorie
con le quali la scienza si autodefinisce tale: decostruiscono in modo meticoloso
la metodica, la facoltà conoscitiva, la pretesa d’oggettività, e il concetto di verità.
Tutti e due sono inoltre convinti che la scienza non possa aiutare a descrivere cos’è la vita.
La critica di Michelstaedter si potrebbe riassumere nella frase: solo il persuaso, solo chi è (nel senso più strettamente ontologico della parola), può sapere.
Acquistare sapere nel mondo della rettorica invece è impossibile. In più: l’istituzionalizzazione di “scienza” come motore per acquisire sapere e conoscienza
impedisce all’individuo di diventare sapiente perché non gli sa portare mezzi per
giungere al sapere ma solo distrazioni. Michelstaedter:
A rendere più intensa questa ottusa vita autonoma dei sensi la scienza moltiplica la
loro potenza con ingeniosi apparati – Ma questa intensificazione non è che la ripetizione della stessa vicinanza, il render più vasta la stessa unica determinazione. (PeR 80 ss.)
la vera funzione organica della società è l’officina dei valori assoluti, la fornitrice dei “luoghi speciali” e “comuni”: la scienza. Che con l’“oggettività” che implica la rinuncia totale dell’individualità, prende i valori dei sensi, o i dati statistici dei bisogni materiali come ultimi valori, e fornisce alla società col suggello della saggezza assoluta ciò che per
la sua vita le è utile: macchine, e teorie d’ogni genere e per ogni uso – d’acciaio, di carta, di parole 6.
La scienza aiuta così ad aumentare la violenza della rettorica. Non cerca mai
sostanza, ovvero la vita, ma solo ciò che serve per continuare a cercare ancora anche in futuro.
Nella degenerazione della persona sapiente per la ricerca del sapere, la scienza colla sua materia inesauribile e il suo metodo fatto di vicinanza di piccoli scopi finiti – colla sua posizione conoscitiva che esperimenta oggettivamente e ripete sempre la stessa minima reazione dell’organismo, che non solo non esige, ma non tollera la persona intera –
colla sua necessità della specializzazione – ha calato le radici nel più profondo della de-
68
Michelstaedter dubita dei valori empirici sui quali si basa la scienza sperimentale: «Qual è il sapore del pane? Quello del primo pezzo che mangio quando ho
fame o quello che mangio dopo quando mi son saziato?» (PeR 76). “Esperienza”
o “dati sensoriali” per Michelstaedter non possono essere fondamento di sapere e
anche gli strumenti scientifici non possono colmare questa lacuna:
Gli scienziati, secondo Michelstaedter, controbattono: «“Ma noi non guardiamo le cose con l’occhio della fame o della sete; noi le guardiamo oggettivamente”»
(PeR 77). Ed egli risponde: «Eppure se “oggettività” vuol dire “oggettività”, veder
oggettivamente non ha senso perché deve aver un soggetto o l’estrema coscienza
di chi è uno colle cose, ha in sé tutte le cose: ἓν συνεχές, il persuaso: il dio» (PeR
77). Non porta alla conoscienza cercare la verità al di fuori di se stessi perché «nel
punto che uno si volge a guardar il proprio profilo nell’ombra, lo distrugge. Così
l’uomo per volgersi al sapere, che è la persona, la coscienza attuale dell’onesta volontà della persuasione, distrugge questa per sempre» (PeR 63). Più tardi scrive:
C’è un esperimento [e aggiungerei: un esperimento solo], che uno scienziato che voglia l’oggettività può fare: si metta in un pericolo mortale e, invece di perder la testa per
l’infinita paura, abbia il coraggio di non aver paura fino all’ultimo: allora taglierà la vita
nel grosso e s’affermerà finito in quell’infinito dove gli altri sono straziati dalla paura, e conoscerà che cos’è la vita. (PeR 81)
Per dirla con la famosa massima: bisogna «venir a ferri corti con la vita» (PeR
82). Solo il persuaso saprà: «Chi è tutt’uno col suo soggetto [e allora lì la distinzione tra soggetto e oggetto non esiste più] e parla perché questa è la sua vita, vedrà in ogni cosa tutto e a proposito d’ogni cosa dirà sempre lo stesso» (App. iv,
PeR 227).
La posizione di Rorty, invece, si potrebbe riassumere in: “sapere”, “conoscienza” persino “verità” sono categorie inutili.
69
yvonne hütter
Anche lui mette in dubbio le virtù fondamentali delle scienze naturali:
Nella nostra cultura le nozioni di “scienza”, “razionalità”, “oggettività” e “verità” sono interdipendenti. Si pensa che la scienza fornisca la verità “solida”, “oggettiva”: la verità come corrispondenza alla realtà, la sola specie di verità degna di tale nome. Gli umanisti – filosofi, teologi, storici, critici letterari – devono preoccuparsi di essere “scientifici”, devono chiedersi se sono autorizzati a ritenere che le loro conclusioni […] siano degne del termine “vero”. Tendiamo ad identificare “verità oggettiva” con “uso della ragione” e crediamo, perciò, che le scienze naturali siano paradigmi di razionalità. Crediamo,
inoltre, che la razionalità sia questione di adeguamento a procedure prestabilite, di conformità ad un metodo 7.
E in un altro articolo aggiunge: anche di «una speciale relazione con la real­­tà»
(PhPi 61). Rorty ribatte: «È caratteristico di una cultura secolarizzata, nella quale lo scienziato prende il posto del prete, preoccuparsi dello “stato conoscitivo” e
dell’“oggettività”. Oggi lo scienziato viene considerato il tramite tra l’umanità e
qualcosa che la trascende» (PhPi 47).
Veramente però, secondo Rorty, non esiste questa “speciale relazione con la
realtà” e non si potrà mai sapere se esiste qualcosa che ci trascende – se sia Dio
o una scoperta scientifica che trova le strutture “sotto sotto” la nostra esistenza.
Ciò che “scopre” la scienza era sempre, come direbbe Michelstaedter, «già presente nelle premesse» 8 (App. iv, PeR 229). Però il concetto trascendente di “verità” è caro alla scienza, perché
Per loro [gli scienziati (i realisti)] non è sufficiente, per esempio, spiegare il successo
della tecnologia basato sulla credenza nelle particelle elementari mediante l’esistenza di
queste ultime. Essi riconoscono, infatti, che questo tipo di spiegazione è banale, poiché si
limita a dire che noi descriviamo le nostre azioni coronate da successo come le descriviamo perché sosteniamo le teorie che sosteniamo. Tale spiegazione del successo attuale esibisce la stessa vacuità che rincontriamo nelle spiegazioni che i nostri antenati fornivano
dei successi passati: Perché siamo in grado di predire così bene le eclissi? Perché l’Amagesto di Tolomeo è una rappresentazione accurata dei cieli. Perché l’Islam ha un successo
così spettacolare? Perché questo è il volere di Allah. Perché un terzo del mondo è comunista? Perché la storia è veramente storia di lotte di classe. (PhPi 71)
In più: i metodi presuntuosamente logici e perciò presuntuosamente “scientifici” non si trovano solo nelle scienze naturali:
quasi tutti […] danno per scontato che possiamo trovare qualcosa come un “principio inferenziale” che può essere chiamato “abduttivo” e che è maggiormente prevalente nella
scienza moderna di quanto lo sia, diciamo, nella teologia omerica o nella filosofia trascendentale. La mia personale congettura, strettamente amatoriale, è che qualunque “princi-
70
il concetto di scienza in carlo michelstaedter e richard rorty
pio inferenziale” che è “centrale per la spiegazione scientifica” si rivelerà centrale per praticamente ogni altra area della cultura. In particolare, postulare cose invisibili per spiegare cose visibili non sembra maggiormente peculiare a quelle attività che sono normalmente chiamate “scienza” di quanto lo non lo sia il modus ponens. (PhPi 70)
Secondo Rorty, e in questo si basa su (e cita in seguito) Davidson, l’uomo non
può mai mettersi in una posizione di fronte al mondo che si potrebbe poi definire
“vera”: «“Nulla […], nessuna cosa rende veri enunciati e teorie: né l’esperienza, né
le irritazioni superficiali, né il mondo possono rendere un enunciato vero”» (PhPi
66). Rorty specifica: «Il quadro wittgensteineriano della relazione tra linguaggio
e mondo è praticamente identico a quello di Davidson. Entrambi vorrebbero che
noi concepissimo la relazione come meramente causale, e non anche rappresentazionale» (PhPi 78). Perciò Rorty suggerisce di lasciar cadere il concetto “rappresentazionale” (e con questo anche il concetto di verità) e di parlare invece piuttosto di “credenza”, specificando:
una credenza al modo di Pierce: una regola per l’azione piuttosto che una specie di immagine costituita da sostanza mentale; vale a dire consideriamo le credenze degli strumenti
per fronteggiare la realtà, specificazioni del modo in cui agire in risposta a certe contingenze, e non delle rappresentazioni della realtà. Secondo questa concezione non dobbiamo più preoccuparci, per esempio, della domanda “la fisica corrisponde alla struttura del
mondo come è o semplicemente alla struttura del mondo come ci appare?” perché non si
pensa più che la fisica corrisponda a qualcosa. (PhPi 160 ss.)
Sia Rorty che Michelstaedter guardano il “mostro scienza” anche sotto un’ottica sociologica.
“Verità” e “sapere” come concetti servono nel mondo della rettorica di Michelstaedter non a trovare veramente essi stessi (cioè verità o sapere), ma a uno
scopo ben preciso: a distrarre l’uomo dalla sua stessa non-esistenza.
Michelstaedter scrive che ogni tanto nel sonno o durante il giorno ricordandosi di sogni, l’uomo si trova «senza nome e senza cognome, senza consorte e senza parenti, senza cose da fare, senza vestiti, solo, nudo con gli occhi aperti a guardare l’oscurità» ( PeR 23 ss.). In quei momenti l’uomo si rende conto di non essere e dice a se stesso: «non sei niente, e non puoi niente» (PeR 24). L’uomo in quei
momenti si angoscia e
Come il bambino nell’oscurità grida per farsi un segno della propria persona […] così gli uomini, che nella solitudine del loro animo vuoto si sentono mancare […] cerca[no]
ognuno la mano del compagno e dic[…][ono]: “io sono, tu sei, noi siamo”, perché l’altro
gli faccia da specchio e gli dica: “tu sei, io sono, noi siamo”. (PeR 58)
71
yvonne hütter
il concetto di scienza in carlo michelstaedter e richard rorty
Questo è però solo il primo passo, perché in seguito «L’uomo si ferma e dice: io so» (PeR 54).
63). I seguaci di Kuhn però sanno: la «demarcazione tra razionale e irrazionale»
(PhPi 63) è definita sociologicamente.
I progressi scientifici, come sappiamo da Kuhn, non si svolgono lungo un asse
temporale lineare 13, in cui un teorema si basa sempre su quello precedente, ne è
anzi addirittura l’evoluzione e così ci porta a mano a mano sempre più vicino alla verità, ma i progressi scientifici si svolgono grazie a rivoluzioni – e, parliamoci chiaro, non rivoluzioni scientifiche ma rivoluzioni sociali dentro il corpo della
scienza. Secondo Kuhn l’industria degli istituti scientifici funziona, come da Michelstaedter, a base di μίμεσις! Un gruppo di scienziati seguirà, per non perdere la
faccia, per non perdere la carriera o per non doversi ammettere di aver perso troppo tempo con una teoria che non funziona, sempre lo stesso paradigma. Solo alcuni soggetti rivoluzionari sono capaci di capovolgere i paradigmi e condurre su
una nuova strada – che diventerà nel seguito il nuovo paradigma da seguire e così via. Tutt’altro che “razionale”, “metodico o “oggettivo”‚ allora.
Infatti la scienza, secondo Rorty, non ha il diritto esclusivo sulla parola “razionale”:
[M]a quando egli dice “io so”, “dice agli altri che egli è vivo” per aver dagli altri alcunché che per la sua affermazione vitale non gli è dato. Egli si vuol “costituire una persona” con l’affermazione della persona assoluta che egli non ha: è l’inadeguata affermazione d’individualità: la rettorica. (PeR 57)
Per Michelstaedter non vale il cartesiano «cogitamus ergo sumus» (PeR 60)
perché «cogito non vuol dire “so”; cogito vuol dire cerco di sapere: cioè manco del
sapere: non so» (PeR 60). Solo colui che è persuaso, e allora è, può sapere. Non
«cogito ergo sum» allora, ma «sum ergo scio»! Ma all’uomo basta l’apparenza di
esistenza che gli dà la “rettorica” e per coltivare il nuovo metodo di ingannarsi riguardo alla propria non-esistenza, si creano istituzioni come la “scienza”. «[N]
ascono “le questioni”, nascono i “problemi” 9, dove ognuno possa dir “la sua” – la
quale (poiché se uno la gira di qua, ben può un altro girarla di là) in qualunque
modo entri nel coro, sarà sempre “buona anch’essa”» 10 (App. iv, PeR 228).
Il problema della scienza non è però solo che non potrà mai aiutare a giungere alla verità, che per Michelstaedter non è mai altro che la persona stessa, cioè
il persuaso, ma il problema della scienza è anche che gli è necessario, che «ci sia
sempre richiesta. Altrimenti gli uomini che sanno per chi saprebbero? Che cosa sarebbe un infermiere se non ci fossero gli ammalati? […] Ma gli ammalati si
creano» (PeR 59). Difficile oggigiorno non sentire l’eco di Michel Foucault che ha
smascherato la pervertita fame di potere del “sapere” una volta reso autonomo 11.
Alcuni – anche dentro le righe della scienza – si rendono conto che c’è qualcosa che non va, ma qui scatta un altro meccanismo che ci impedirà sempre di essere sapienti: la vanità. Perché «per non esser detti ἀπαίδευτοι, ἂπειροι, νεανιϰοί, bisogna tacere» (App. ii, PeR 220). In più i corpi della scienza, i ϰοινωνίαι intellettuali,
scientifici e allora malvagi, hanno un rigido codice d’ammissione che si basa sulla μίμεσις. Nel mondo della rettorica c’è
In realtà è disponibile un diverso senso di “razionale”, secondo il quale la parola significa qualcosa di simile a “sensato” o a “ragionevole” invece che a “metodico”. Essa designa un insieme di virtù morali: tolleranza, rispetto per le opinioni del nostro prossimo,
disponibilità ad ascoltare, fiducia nella persuasione piuttosto che nella forza. (PhPi 49)
Nel seguito bisogna anche revisionare il concetto di “verità” e bisogna concepire «la verità come ciò che ci è utile credere» (PhPi 31).
Questo porta Michelstaedter nelle vicinanze di Thomas Kuhn 12 e con questo
nelle vicinanze di Rorty, che si basa esplicitamente su di lui. Secondo Rorty, gli
scienziati «adottano di norma una nozione forte, criteriale di razionalità, una nozione che fa consistere la razionalità nella conformità a principi espliciti» (PhPi
Sia Michelstaedter che Rorty, il primo più in modo indiretto, vedono allora il
primato nella prassi, non nelle teorie. Né la scienza né i derivati della scienza portano vantaggi o progresso nella vita umana. Non si capisce come tecnologie possano mai diventare fonte di maggior felicità per un largo numero di persone. In
più la parola “progresso” indica qualcosa che aumenta sempre di più con il passare del tempo – cosa per Michelstaedter inconcepibile, perché «Colui che è per
sé stesso […] non ha bisogno d’altra cosa che sia per lui […] nel futuro, ma possiede tutto in sé» (PeR 9).
Rorty chiede: «Che cos’hanno di tanto speciale la previsione e il controllo?»
(PhPi 76). Importante sarebbe piuttosto aumentare la felicità del maggior numero
possibile di persone, e per questo non serve “verità”, ma flessibilità intellettuale.
«Un’utopia democratica sarebbe una comunità in cui la tolleranza e la curiosità, e
non l’aspirare verità, sarebbero le prime virtù intellettuali» (PhPii 104).
Qui si trova la differenza (e in realtà bisognerebbe dire una delle tante diffe-
72
73
bisogno che ognuno s’adatti alla sufficienza di quell’astrazione di vita che egli [Platone] a
ognuno ha macchinato. Ognuno deve μιμεῖσϑαι τὰ αὑτῷ προσήϰοντα εὐϑὺς ἐϰ μαιδός (395c),
e deve imitare dunque, imparare a ripetere gli atti oscuri che vede compiere agli altri.
(App. ii, PeR 151)
yvonne hütter
il concetto di scienza in carlo michelstaedter e richard rorty
renze) fondamentale tra Rorty e Michelstaedter. Per Michelstaedter la verità non
è inutile, la verità è anzi l’unica cosa che ci può salvare – bisogna però specificare:
non le presupposte verità scientifiche, ma la verità del persuaso, dell’essere. Come
si svolge però in Michelstaedter questo salto all’essere? Seguendo un’unica massima. Solo quella può aiutare a «togliere […] dalle radici» (PeR 41) la violenza del
mondo della rettorica: «tutto dare e niente chiedere: questo è il dovere – dove sono
i doveri e i diritti io non so» 14 (PeR 42). Agire in modo etico allora: «tutto dare e
niente chiedere» – solo quello ci farà persuasi. E con la persuasione nello stesso
momento essenti, sapienti e buoni.
Si potrebbe riassumere: per Rorty ha importanza solo l’etica, per Michelstaedter solo l’essere, che però si rivela essere etica anch’esso.
Le affinità del pensiero michelstaedteriano con quello rortyano sono grandi
anche se, alla fine, sono sicuramente in prevalenza le differenze insormontabili:
Michelstaedter è ontologo e crede profondamente in un’unica verità, che è il persuaso – cosa inaffrontabile per Rorty e la maggior parte dei pragmatisti. Però, mi
sembra che in punti cruciali e, soprattutto, nei punti che di solito vanno elencati come “le debolezze” di Michelstaedter, cioè di essere privo di metodo e sistema, ci siano grandi concordanze con le correnti postmoderne: chi ha metodo e
chi cerca di installare un sistema è diventato sospetto.
7
R. Rorty, Objectivity, Relativism and Truth, Philosophical Papers, i, New York, Cambridge University Press, 1991; trad. it. di M. Marraffa, Id., Scritti filosofici, a cura di A.G. Gargani, ii, Roma-Bari, Laterza,
1994, p. 47 (d’ora in poi farò riferimento a questa edizione citandola, direttamente nel testo, come PhPi).
8
In toto: «Così di fronte a ogni problema essi [gli scienziati] si pongono in modo da poter apparir
trionfanti, non per cercare il valor più pieno possibile dei concetti, ma premettendo di questi quel qualsiasi
contenuto che premetta l’apparenza d’un’elegante soluzione. Ma la soluzione è già nelle premesse, e queste
necessariamente arbitrarie» (App. iv, PeR, 228 ss.).
9
Nel Dialogo della salute aggiunge: «nascono anche le ϰοινωνίαι “intellettuali”» (C. Michelstaedter, Il
dialogo della salute e altri dialoghi, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1988, p. 56).
10
Bisogna non illudersi mai: quando Michelstaedter e anche Rorty parlano di scienza, questo include
sempre anche la filosofia (e allora la loro stessa attività) e tutte le discipline che si basano sul “teo­­retizzare”:
«la macchina che muove i concetti: l’attività filosofica» (PeR 61). Rorty proclama addirittura: «io credo che
tutti noi [con “noi” si riferisce a tutti i filosofi e teoretici – allora anche a tutti noi che facciamo questo “mestiere”] […] dovremmo provare a fare in modo di non avere più lavoro»; R. Rorty, Essays on Heidegger and
Others, Philosophical Papers, ii, New York, Cambridge University Press, 1991; trad. it. di B. Agnese, Id., Scritti filosofici, a cura di A.G. Gargani, ii, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 119 (d’ora in poi farò riferimento a questa edizione citandola, direttamente nel testo, come PhPii).
11
Cfr. per esempio M. Foucault, Qu’est-ce que la critique? (Critique et Aufklärung), in «Bulletin de la
Société Française de Philosophie», 84, 2, 1990, pp. 35-63. Come anche nel caso di Rorty, alla fine di un’accurata analisi dell’analogia, si vedrebbero più le differenze che le convergenze tra Michelstaedter e Foucault. Ho tentato un primo, breve, avvicinamento in Hütter, «Zu sein, eine Aufgabe», cit., note 84, 99, 364.
12
Cfr. Th. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, seconda edizione ampliata, Chicago-London,
University of Chicago Press, 19702.
13
Come invece suggeriscono anche gli scienziati secondo Michelstaedter: «Sappiamo oggi una parte, domani ne sappiamo un’altra, tutti i giorni della nostra vita ne sappiamo sempre delle altre. Così acquisto io sapienza per la mia parte, così ogni altro figlio dell’uomo per sua parte ne acquisti ogni giorno della
sua vita sotto il cielo, e il retaggio della nostra sapienza tramandiamo ai nostri posteri perché altra ne acquistino e sempre via s’accresca di sempre nuove verità e si costituisca il corpo della scienza umana» (PeR 75).
14
Michelstaedter specifica e modifica questa massima poi nelle pagine seguenti: cfr. PeR 42-44.
note al testo
1
Non intendo allargarmi sull’esattezza o inesattezza del termine “postmoderno”, “poststrutturalistico” (o piuttosto “neostrutturalistico”?) ecc., non perché non credo sia necessario trovare una definizione accurata (tutto il contrario), ma perché mi riferisco in questo contesto a molti pensatori estremamente diversi tra loro e perciò mi sembra utile limitarmi al minimo comune denominatore. Ho scelto dunque, come risulta evidente anche dal titolo, generalmente “postmoderno” (invece, per esempio, di “pragmatistico”), perché la vaghezza di questo termine, che grazie all’inflazionistico uso e abuso di scrittori, giornalisti, filosofi, architetti ecc. ha perso praticamente ogni significato, mi permette di interpretarlo con una certa libertà.
2
Anche se non sempre in modo confermativo: cfr. per esempio tra gli altri: D. De Leo, Michelstaed­­
ter e Nietzsche: l’Umwertung dell’Imperativo Kantiano, in «Segni e Comprensione», xix, 56, 2005, pp. 18-33;
L.A. Manfreda, Tempo e Redenzione. Linguaggio etico e forme di esperienza da Nietzsche a Simone Weil, Milano, Jaca Book, 2001.
3
Cfr. per esempio tra gli altri il famoso articolo di Ranke, Das Denken Carlo Michelstaedters, Ein Beitrag zur italienischen Existenzphilosophie, in «Zeitschrift für philosophische Forschung», 15, 1961, pp. 101123.
4
Cfr. G. Carchia, Linguaggio e mistica in Carlo Michelstaedter, in «Rivista di estetica», xxi, 9, 1981, pp.
126-132; M. Cacciari, Interpretazione di Michelstaedter, in «Rivista di estetica», xxvi, 22, 1986, pp. 21-36; Y.
Hütter, «Zu sein, eine Aufgabe». Andreas Maier und die Philosophien von Meister Eckhardt und Carlo Michelstaedter, Bielefeld, Aisthesis, 2011.
5
Questo articolo spera però di dare inizio a una più vasta ricerca sulle convergenze del pensiero di Michelstaedter con quello postmoderno.
6
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a cura di S. Campailla, Milano,
Adelphi, 1995, p. 125 (d’ora in poi farò riferimento a questa edizione della Persuasione e delle sue appendici
citandole, direttamente nel testo, come PeR).
74
75
il romanzo mancato di michelstaedter
A proposito della conversione vorrei rivolgermi a un grande storico del pensiero antico, Pierre Hadot (fondamentale per l’ultimo Foucault), il quale in Esercizi spirituali, scritto alla fine degli anni settanta, ci invita a considerare la filosofia
greco-romana non come insegnamento di una teoria astratta ma come arte di vivere, esercizio spirituale che impegna tutta l’esistenza. La conversione si svela così
come il passaggio dalla vita inautentica, rosa dalle preoccupazioni, alla vita autentica, «dove l’uomo raggiunge la visione esatta del mondo» o, se preferite, un progresso verso uno stato trascendente. Ecco, accostandosi a Michelstaedter si viene
subito in contatto con una idea diversa (antica e orientale) della filosofia, intesa come stile di vita e trasformazione di sé e non come erudizione parassitaria (l’unica
attività degli intellettuali, scrive in Sapienza e felicità, è di ipernutrire l’intelletto,
di «raccogliere, collegare, serbare teorie e opinioni altrui», o anche di fare sistemi
all’infinito, come Croce). Ora, prosegue Hadot, per chi ha quella «visione delle
cose come sono» la vita quotidiana dovrà apparire come «uno stato di follia, d’in-
coscienza, d’ignoranza della realtà». Di qui un conflitto tra il filosofo e i costumi della vita quotidiana, «la visione convenzionale delle cose su cui poggia la società umana». Un conflitto mai interamente risolvibile e a cui correnti filosofiche
diverse hanno dato risposte diverse: i cinici la rottura totale, gli scettici l’accettazione delle convenzioni sociali, gli epicurei ricreando tra loro una vita quotidiana
conforme all’ideale della saggezza, i platonici e gli stoici cercando di «vivere filosoficamente la vita quotidiana». Così come queste diverse scuole hanno prescritto gli esercizi pratici e le terapie adatte a conseguire quello stato di saggezza (meditazione, controllo di sé, ascolto, contemplazione della natura, sforzo di volontà,
assimilazione di buone abitudini morali, adesione a certe regole di vita, attenzione
sul momento presente ecc., tutte pratiche che ritroveremo poi negli ambienti monastici sotto il cristianesimo). E qui Hadot nota come la meditazione greco-romana, diversamente da quella buddhista e induista, «non è legata a un atteggiamento
corporeo», ma è di tipo razionale e immaginativo, consiste soprattutto in tecniche
retoriche e dialettiche di persuasione. Insisto sul conflitto drammatico (e non veramente componibile) tra filosofia e vita quotidiana perché Michelstaedter è precipitato quasi privo di difese (e di tecniche di meditazione) dentro tale conflitto,
optando per una rottura totale al modo dei cinici, ma senza più la loro illusione di
autosufficienza. Hadot ci ricorda che per il Socrate del Fedone filosofare è esercitarsi a morire, ma qui si tratta del «morire alla propria individualità, alle proprie
passioni, per vedere le cose nella prospettiva dell’universalità e dell’oggettivazione». Per Michelstaedter, che prendeva la filosofia seriamente, secondo l’accezione
antica, il morire alla propria individualità significò morire tout court. L’ideale plotiniano dello scolpire la propria statua – e cioè togliere tutto il superfluo, giungere
all’essenziale –, perseguito con inflessibilità eroica può avere conseguenze distruttive: a forza di togliere non resta più nulla… Non porta alla sapienza e alla perfezione umana, né a un cambiamento radicale di prospettiva, ma alla fine di ogni
prospettiva. Il sogno di perdere peso, di sospendere la legge di gravità – così simile al desiderio che qualche decennio dopo espresse Simone Weil, un’altra mistica
innamorata della grecità, di decrearsi ed eliminare la pesanteur – implicava la sparizione. Come se a quel punto l’istante vissuto, che ricapitola la totalità del cosmo
e l’intera eternità, chiedesse la propria stessa fine. Anche rileggendo La persuasione e la rettorica in anni recenti, continuo a pensare che quel testo sia quasi inaccessibile per l’umanità contemporanea (sempre più immersa nella Rettorica, in una
cultura che tutto riduce a blanda citazione e ornamento, che depotenzia ogni messaggio eversivo in mero consumo e in chiacchiera infinita: pensate che in un post
scriptum del febbraio 1908 dichiara di annoiarsi nell’aula universitaria «fra tutte
queste chiacchiere del pubblico studentesco» in attesa del professore) e, al tempo
stesso, attualissimo, ma solo se troverà lettori in grado di meritarlo, capaci cioè di
quella conversione, e di vedere ogni presente come l’ultimo.
76
77
Il Romanzo mancato di Michelstaedter
di Filippo La Porta
Quando lessi per la prima volta Carlo Michelstaedter negli anni dell’università, più o meno alla stessa età in cui lui si tolse la vita, non ero per niente certo di
capirlo davvero. Capivo però che quel libro rivolgeva a me, al lettore, una richiesta radicale, ineludibile: niente meno che una “conversione”, un cambiamento totale. Inoltre: ragionando sulla sua veloce meteora pensai che se Michelstaedter
fosse riuscito a scrivere un romanzo forse avrebbe potuto “salvarsi”. Provo ora a
svolgere la mia riflessione su questi due aspetti diversi, anche se tra loro collegati.
conversioni possibili
filippo la porta
il romanzo mancato di michelstaedter
l’aerostato del romanzo: un genere letterario salvifico?
traccia di humour. È vero: alcune lettere contengono momenti di spossante gioia
vitale (si pensi all’innamoramento per Iolanda, che fa vedere in tutte le cose «un
ritmo di gioia»), di allegria scanzonata («La Paula sta elaborando la bella massa
dei suoi capelli… c’è un bel sole, siamo tutti di buon umore»), o anche di malinconia intenerita (a Firenze la nostalgia dell’ambiente domestico goriziano), ma il
giovane Michelstaedter, come ogni adolescente, aveva scarso umorismo e ancor
meno autoironia. Il suo stesso estremismo tragico-eroico glielo vietava, quell’immaginarsi alle prese con compiti grandiosi e sfide ineluttabili, al di qua della “linea d’ombra” della maturità che nel romanzo breve di Conrad intitolato alla linea
d’ombra (pubblicato appena sette anni dopo la morte di Michelstaedter, nel 1917)
coincideva con l’accettazione del limite (la bonaccia) e della propria impotenza
(noto per inciso che Michelstaedter e Conrad, sospesi tra due lingue, tra due culture, amavano entrambi il mare e le barche a vela…). Dunque, solo in questo senso il romanzo come genere – peraltro inviso alla letteratura italiana di quegli anni – avrebbe potuto riportare Michelstaedter dalle translucide altezze alpine alla
prosaicità della terra, simile all’aerostato di Aristotele cui accenna nella Persuasione e la rettorica, e dunque “salvarlo” ( lui però con ogni evidenza non voleva essere “salvato”, poiché dal suo punto di vista ciò significava rientrare nella Rettorica).
Ovviamente le ragioni che portano una persona al suicidio sono imperscrutabili (e aggiungo che un elementare pudore dovrebbe vietarci perfino di indagarle). Nel caso di Michelstaedter vorrei però collegare, con tutte le cautele dovute, il
suo gesto estremo a una questione culturale e di genere letterario, anche se è stata
occasionata da esperienze e fatti contingenti su cui preferisco sorvolare. Soltanto
in quest’ottica allora diventa possibile, e non impudico, chiederci se quel gesto si
sarebbe potuto evitare. Ho prima citato Hadot, secondo il quale la storia del pensiero ellenistico si configura come una topica storica, uno studio sull’evoluzione
dei topoi, dei vari modelli succedutisi nel tempo. E si tratta perlopiù – sottolinea –
di una topica degli aforismi. Ora Michelstaedter, che pensa in greco, usa uno stile saggistico di tipo aforistico, scrive frammenti, lettere, commenti filosofici, recensioni, poe­­sie (oltre a qualche racconto-apologo). Testi inclassificabili, come ha
osservato Sergio Campailla, sempre al confine tra discipline diverse, in transito
tra un genere e l’altro. Nelle prime pagine dei suoi Saggi italiani Fortini ci mostra
attraverso l’analisi di un biglietto a un amico (a Enrico Mreule) come la saggistica di Michelstaedter abbia un carattere lirico, di poemetto in prosa. E infatti Michelstaedter non scrive romanzi. Il romanzo presuppone la virtù della pazienza e
poi un’attitudine a tradurre le idee in personaggi. Il saggismo di Michelstaed­­ter
si fonda sull’impazienza e ci propone a ogni momento un personaggio unico, magnetico e straziante: l’autore stesso. Inoltre: fra tutti il romanzo è il genere, storicamente inventato dalla borghesia, che aiuta gli individui ad adattarsi alle regole e convenzioni sociali attraverso nuovi paradigmi. Dunque: il luogo del compromesso, della coesistenza di pulsioni e forze psichiche opposte (su questi temi
rinvio alle riflessioni teoriche di Franco Moretti, per quanto riguarda romanzo e
adattamento, e di Francesco Orlando per quanto riguarda le implicazioni psicanalitiche). La legge del romanzo consiste nell’et-et e non nell’aut-aut, nella continuità epica dell’esistenza (appunto: l’epopea della borghesia) e non nella discontinuità di una rivelazione oracolare, nella durata e non nell’intensificazione. La letteratura tutta intera è il campo del ritorno del rimosso (o del represso), e nel caso di Michelstaedter il rimosso è anzitutto il trauma originario, la verità inconfessabile sull’esistenza che i presocratici o l’Ecclesiaste enunciarono per primi e che
lui ripete quasi ossessivamente. Ma vorrei notare come questo rimosso “torna” in
modi diversi secondo il genere. Nello spazio contratto del racconto quasi non fa
in tempo a risolversi (e diventa il perturbante), mentre nei tempi lunghi e nelle laboriose, pazienti architetture del romanzo il rimosso ha come l’agio di accomodarsi: si disinnesca e diventa così assai meno minaccioso. Il romanzo è secondo le
parole di Milan Kundera (L’arte del romanzo) un genere che nasce dall’humour,
da una saggezza intrisa di ironia. Ma nell’opera di Michelstaedter c’è pochissima
78
la vita sdoppiata
Come poi si evince dalle sue lettere ad amici e familiari, amava lo sport, il ballo, le donne (poteva corteggiarne sette alla volta!), le intimità che durano un giro di valzer… Non aveva affatto un temperamento saturnino o penitenziale, non
indulgeva all’autocompatimento. Attratto da una vitalità effimera, eccitata, sentiva però che lo portava lontano dalla Persuasione (si veda il rapporto contraddittorio con d’Annunzio: era affascinato dalla sua opulenza espressiva e disgustato
dall’immoralismo di orecchiante di filosofia, senza peraltro scorgere il nesso tra le
due cose, e cioè l’essere compiutamente il Vate, quello che Benjamin una volta definì l’«uomo ammobiliato», che riempie il vuoto con orpelli e ciarpame luccicante). Nel pensiero era un asceta e un mistico, tutto teso a possedere la vita nel presente della Persuasione, a farla coincidere con il pensiero. Ora, chi intende possedere pienamente la vita – che è inafferrabile – è destinato a perderla. Il Persuaso è
colui che riconosce «il muto e oscuro dolorare di tutte le cose», che rinuncia stoicamente a ogni falso possesso, e perfino a quelle consolazioni e troppo umane illusioni che leopardianamente ci servono per vivere. Così scrive nell’agosto del 1908:
«Mi pare che ogni piccola cosa della vita mi sfugga…». È come se una parte anche
rilevante della sua esistenza – che è poi la dimensione più reale, delle abitudini e
delle piccole cose, degli affetti intimi e dei piaceri del corpo, la «felicità reale» di
79
filippo la porta
tutte le «consuete situazioni» di cui parla a Paula nella primavera del 1908, insomma la «calda vita» – non riuscisse a trovare veramente espressione e cittadinanza
nel suo stile. Ne restava al di qua. E si tratta della vita quotidiana, costituzionalmente impura, e anzi per parafrasare lo stesso Michelstaedter in una lettera a Rico,
sempre “sdoppiata”, e cioè sia fredda che ardente, sia banale che sublime, impastata di Persuasione e di Rettorica, di autentico e inautentico, di verità e menzogna
(tanto che Fortini volle così correggere l’Adorno perentorio dei Minima moralia:
non si dà vita vera se non nella falsa). E come risulta proprio da ogni pagina, fittissima di realtà e affollata di voci, di quel Tolstoj romanziere da lui tanto ammirato, alieno dalla bella pagina molto italiana e dal realismo fotografico dei francesi.
IL FONDO CARLO MICHELSTAEDTER.
APPUNTI DOCUMENTARI E BIBLIOGRAFICI
di Marco Menato
un’omissione significativa
Campailla, nel Segreto di Nadia B. – originale reportage in forma di noir sulla
biografia di Michelstaedter –, ricostruisce attraverso alcune lettere l’amore impossibile dello scrittore per Nadia Baraden, bellissima artista russa, anarchica e mitomane, «pericolosa come una cometa». Apprendiamo anche che Carlo aveva contratsifilide o fre- to una sifilide per la sua intensa frequentazione di bordelli, della quale si vergognava. Il punto non è condannarlo moralisticamente, ma capire come mai un’esperienza
quentazione?
del genere (che diventa coazione quasi quotidiana, come per Pasolini la necessità di
avere un orgasmo ogni sera con un “ragazzo di vita”) non trovi alcun posto nella filosofia di Michelstaedter, non riesca cioè neppure a essere nominata entro quello stile alto, poetico-aforistico, che lui si è scelto… La sua opera abbagliante, il suo struggente poema in prosa (Emilio Cecchi) ci parla di molte cose tra il cielo e la terra, tra
la persuasione e la rettorica, ma omette, forse perché privo di una lingua romanzesca, proprio la relazione fondamentale con Nadia e il demone indomabile dell’eros.
S. Campailla, Il segreto di Nadia B., Venezia, Marsilio, 2010.
E. Cecchi, Saggi e viaggi, Milano, Mondadori, 1995.
F. Fortini, Saggi italiani, Bari, De Donato, 1974.
M. Kundera, L’arte del romanzo, Milano, Adelphi, 1988.
P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Torino, Einaudi, 2005.
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a cura di S. Campailla, Milano,
Adelphi, 1995.
C. Michelstaedter, Epistolario, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1983.
F. Moretti, Segni e stili del moderno, Torino, Einaudi, 1997.
F. Orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, Torino, Einaudi, 1987.
S. Weil, Quaderni, a cura di G. Gaeta, 4 voll., Milano, Adelphi, 1882-1993.
Ora, dopo aver letto Il segreto di Nadia B., saggio-romanzo di Sergio Campailla 1, sappiamo come sono andate più prosasticamente le cose, e cioè come le carte e i pochi libri di Michelstaedter siano passati da una cassapanca nell’appartamento di Paula Michelstaedter (1885-1972) in via Cadorna 36 alla Biblioteca. L’ultima residenza della famiglia Michelstaedter è infatti villa Elda, dapprima abitata
da Elda, sorella di Paula, sposata con il medico Silvio Morpurgo (l’ingresso per i
pazienti era invece da largo Culiat); dopo la deportazione ad Auschwitz quella casa rimase a Paula che si era salvata perché all’epoca risiedeva in Svizzera sposata
con Fritz Winteler, cittadino svizzero 2. La villetta, su due piani, è ora totalmente
occupata dagli uffici di Informest, ma il nome – non so se per caso o per scelta –
è rimasto sulle colonne del cancello: «In quel palazzetto Paula, a differenza della
sorella una volta, occupava appena un appartamento che presentava un tono dimesso ma decoroso, quale poteva essere la dimora di una persona molto anziana,
che vi viveva da sola, in compagnia dei ricordi» 3.
Tre personaggi sono dipinti con passione e garbo in quel capitolo: il figlio di
Paula, e quindi il nipote di Carlo Michelstaedter, l’ingegner Carlo Winteler (19141981), il ventisettenne Sergio Campailla, professore universitario e curatore testamentario del fondo, e Guido Manzini (1921-1975), direttore della Biblioteca statale, «un uomo sobrio ed equilibrato, forse con una punta di scetticismo»: gli incontri si susseguivano serrati da settimane, per il fatto che sia Winteler sia Campailla venivano apposta a Gorizia, il primo da Padova e il secondo da Genova, per
chiudere questa “benedetta” consegna.
Nell’archivio della Biblioteca si legge tutto il peregrinare un po’ burocratico e
un po’ perplesso di queste carte fino a quando domenica 4 marzo 1973, con un taxi, il trasporto è cosa fatta. Ma non ne sa niente nessuno, la consegna deve rima-
80
81
bibliografia
marco menato
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
nere un segreto (l’inventariazione amministrativa avverrà appena un anno dopo).
Guido Manzini, pur alle soglie della pensione (nonostante sia poco più che cinquantenne), si preoccupa subito di come tutto quel ricco materiale (appunti, lettere, fotografie, disegni, quadri e i sette libri rimasti della biblioteca personale di
Carlo) potesse essere valorizzato, di qui la scelta di destinarlo alla Biblioteca Civica e quindi al Comune di Gorizia e non alla Biblioteca statale come per altri versi poteva parere più logico: «fu lui a mettermi in contatto con il gruppo dirigente
dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia, nel quale presto
annoverai tanti amici. Istituto sotto la cui egida iniziai la promozione dell’immagine e l’edizione delle opere di Michelstaedter, prima che Luciano Foà e Roberto
Calasso, all’inizio degli anni ottanta, in pieno revival mitteleuropeo, mi offrissero
di continuare sotto il marchio prestigioso dell’Adelphi» 4.
Poco più avanti è raccontata con meticolosa precisione la distruzione di due
lettere appunto di Nadia Baraden («un cognome che io mi sforzavo di non scordare, perché mai più avrei voluto chiederlo a Winteler») e della vii Appendice critica alla Persuasione, «la sconfessione delle prime sei, legate invece all’occasione
accademica»; dei documenti distrutti («L’ingegnere stracciò le due lettere. Nessuno poteva giudicare che fossero importanti», stessa sorte toccò poco dopo all’Appendice) Campailla si sforza di dare porzioni di testo, così come è rimasto raccolto nella sua mente: quel capitolo è ora l’unica prova filologica dell’esistenza (e soprattutto del profondo significato) di quelle carte che sarebbero state perdute una
seconda volta, se Campailla non avesse deciso di raccontare la verità, a distanza
di quarant’anni, perché «le cose rimosse sono le più importanti, le sole di cui valga la pena di parlare» 5.
Sergio Campailla aveva cominciato a frequentare villa Elda più di un anno
prima, mosso dalla lettura di alcune liriche di Michelstaedter su un’antologia raccolta da Luciano Anceschi; quelle liriche avevano fatto scattare in lui (ha scritto nel Segreto di Nadia B.) la voglia di approfondire la conoscenza di quel nome:
per un professore avvezzo alla ricerca non fu difficile mettere assieme la scarsa bibliografia allora esistente e decidere di venire a Gorizia 6. Non mancarono, e sono
raccontate con gustosa perfidia, le definizioni negative messe lì apposta quasi per
impedire di andare avanti: «Non c’è nulla di scientificamente fruibile» sentenzia
un professore titolato al giovane Campailla; queste parole avrebbero tarpato le ali
a chiunque, invece passano e non lasciano traccia sulla voglia che Campailla ha
di andare fino in fondo, anzi forse costituiscono una sferzata e una scommessa.
Sindaco di Gorizia era Pasquale De Simone, una figura alta di uomo di cultura a tutto tondo, presidente dell’istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei
(Icm) era il senatore Michele Martina: queste due istituzioni ebbero quindi gioco
facile, in virtù dei solidi rapporti di stima e di aperta collaborazione, nel garantire alle carte Michelstaedter una nuova vita: il Comune si assunse subito il compi-
to di incaricare Campailla del riordino di quello che di lì a poco fu tecnicamente
denominato «Fondo Carlo Michelstaedter» e l’Icm di avviare la pubblicazione –
prevista in 5 volumi – dell’opera omnia di Michelstaedter. Dal riordino del fondo
venne fuori la prima biografia di Michelstaedter, suggestivamente intitolata A ferri corti con la vita, pubblicata dal Comune nel settembre 1974 7, in occasione del
nono convegno culturale mitteleuropeo, dedicato a La filosofia nella Mitteleuropa 8, nel quale fu ovviamente riservata una sezione a Michelstaedter sia con le relazioni di Carlo Arata, Quirino Principe e dello stesso Campailla, sia con la mostra Testimonianza per Carlo Michelstaedter 9.
Nel medesimo anno Campailla pubblica presso Patron l’edizione filologicamente rivista delle Poesie 10, l’anno prima era stata la volta della monografia Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter 11, dove in appendice vengono editi gli appunti biografici stesi dalla sorella Paula, che contenevano sotto energiche cancellature la storia che Campailla avrebbe raccontato, dopo trentasette anni, con vivacità romanzesca e notevole sagacia documentaria nel Segreto di Nadia B. 12.
L’istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei aveva iniziato nel 1975 a pubblicare l’opera omnia, a partire dall’Opera grafica e pittorica; l’anno dopo erano
usciti gli Scritti scolastici, sempre per le cure di Campailla. La prosecuzione della pubblicazione, per dare maggiore risalto e consentire una diffusione adeguata (a oggi secondo il Servizio bibliotecario nazionale solo otto biblioteche possiedono gli Scritti scolastici e addirittura due l’Opera grafica!), passò all’editore Adelphi, che nel 1982 pubblicò La persuasione e la rettorica, nel 1983 l’Epistolario, nel
1987 le Poesie, nel 1988 il Dialogo della salute e altri dialoghi e nel 1995 una nuova
edizione della Persuasione con le Appendici critiche: le opere ebbero numerose ristampe e furono edite in due collane, una economica, la “Piccola Biblioteca Adelphi”, e una di pregio, riservata alle “Opere di Carlo Michelstaedter”.
Il convegno Icm del 1974 ebbe il merito di dare notizia dell’esistenza del fondo Michelstaedter e quindi di dare il via a una lunghissima serie di indagini, ricerche, approfondimenti da parte degli studiosi, visto che in un’unica sede, la Biblioteca statale, erano state concentrate e le carte autografe e tutti i saggi e gli articoli prodotti dall’analisi di quelle carte (quello che è definito il “Fondo vivo”):
era una situazione per il mondo degli studi assai favorevole, che non ha molti altri equivalenti nell’ambito della letteratura (soprattutto se si considera la giovanissima età dell’autore e il fatto che due guerre mondiali e la persecuzione nazista si
sono accanite su quello che era rimasto e che la sorella Paula aveva in seguito tenacemente mantenuto unito).
Invece il centenario della nascita, 1987, non vide altrettanto interesse, soprattutto da parte di Comune e Icm. Il vuoto fu colmato dalla Provincia di Gorizia,
allora retta da Silvio Cumpeta, con un grande convegno internazionale, Michelstaedter. Il coraggio dell’impossibile (1°-3 ottobre 1987), curato da Elvio Guagnini
82
83
marco menato
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
dell’università di Trieste e con la partecipazione di una ventina di studiosi, tra i
quali Alberto Asor Rosa, Marco Cerruti, Claudio Magris, Massimo Cacciari, Michel David (Campailla non vi partecipò). Gli atti si trascinarono da una presidenza all’altra, fino a quando, nel 2002, il presidente della Provincia Giorgio Brandolin incaricò Silvio Cumpeta di raccogliere i contributi ancora disponibili (Asor
Rosa per esempio preferì non rivedere il testo e quindi non autorizzare la stampa)
e di procedere, finalmente, alla pubblicazione che, con la collaborazione di Angela Michelis (solo per motivi di età non aveva partecipato al convegno, autrice di
un’importante bibliografia finale, della quale si parlerà più sotto), avvenne con il
titolo piuttosto anonimo Eredità di Carlo Michelstaedter 13.
Sempre in quel 1987 la Biblioteca statale isontina compare per la prima volta
ufficialmente nell’ambito degli studi su Michelstaedter, con la pubblicazione dei
Dialoghi intorno a Michelstaedter, curati da Sergio Campailla (che vi pubblica 19
Lettere a Carlo, a completamento dell’Epistolario adelfiano del 1983, scritte da parenti e amici, e conservate nel Fondo Michelstaedter), con nove contributi di studiosi che (tranne Alberto Cavaglion) 14 non avevano partecipato al convegno della Provincia. Il volume non fa cenno in alcun luogo alla ricorrenza ed esce con
una veste tipografica austera e senza anno di stampa: l’unico appiglio cronologico è la premessa di Otello Silvestri, direttore della Biblioteca statale, datata «luglio 1987».
E arriviamo al centenario della morte: una ricorrenza che sia Sergio Campailla sia l’istituto per gli Incontri culturali mitteleuropei hanno preparato per tempo e scelto quasi per ripartire da quel lontano e magico marzo 1973, ripartire per
fare il punto della situazione, per dare forza a un dialogo che, se non si era mai
interrotto, con il tempo e con le vicende della vita si era di molto allentato e allontanato dagli schemi usuali. A questa importante ricorrenza la Biblioteca statale isontina – che invero all’inizio e nel centenario della nascita era rimasta piuttosto da parte – ha voluto partecipare e dare il proprio contributo: le carte Michelstaedter appartengono al Comune di Gorizia, ma sono conservate fin dall’origine
nella Biblioteca statale, la quale con gli anni ha visto crescere il numero degli studiosi che di persona e per lettera hanno continuamente attinto al Fondo, sia per
la parte autografa (che negli anni è stata sottoposta prima a microfilmatura e poi
a digitalizzazione) sia per la parte su Michelstaedter, ricca di contributi anche minimi, ma che possono rivelarsi interessanti.
«Il centenario della morte del filosofo goriziano», scrive Marco Grusovin,
presidente dell’Icm, «è senz’altro una preziosa opportunità non solo per tornare
a riflettere sul suo messaggio, per rivisitarne l’opera e il valore a distanza di tanti anni in un contesto socio-culturale completamente mutato, ma per riprendere
con le sue tesi e con la sua esigenza di autenticità un dialogo che fu soprattutto di
un ambiente, di una storia e di un territorio, senza i quali evidentemente non si
spiegherebbe proprio quel caso» 15. Con tale spirito, l’Icm si è candidato a collegare insieme e soprattutto a comunicare tutte le iniziative goriziane dedicate a Michelstaedter: una sorta di cabina di regia, vista la pluralità delle istituzioni coinvolte (Provincia, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e Biblioteca statale) e l’interesse dimostrato dalla città per un suo così illustre concittadino.
Non serve, in questa sede, passare in rassegna tutte le manifestazioni e le pubblicazioni che hanno avuto a oggetto Michelstaedter: due pieghevoli editi da Icm
e distribuiti in migliaia di copie e il sito www.michelstaedter.it allestito dalla Biblioteca statale (nel 2010 gli accessi sono stati 325.406) danno al riguardo sufficienti notizie e conservano la memoria dei fatti.
È utile invece ricordare i momenti più importanti e corali: la grande mostra
aperta nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia il 17 ottobre (il
giorno del suicidio), Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, curata da Sergio
Campailla 16 ; i due convegni internazionali organizzati scientificamente da Campailla 17; la mostra Le carte del Fondo Carlo Michelstaedter (2-9 ottobre), curata da
Antonella Gallarotti e Marco Menato, nella galleria d’arte “Mario Di Iorio” della Biblioteca Statale Isontina 18 ; la collocazione a opera del Comune, il 3 novembre, della statua ad altezza naturale (sulla base della nota fotografia del 1907 che
lo ritrae nel giardino di Boboli) nello slargo che da via Rastello sale al castello.
Dal lato editoriale registro due nuove edizioni di scritti michelstaedteriani curati da Sergio Campailla: La melodia del giovane divino, nella “Piccola biblioteca
Adelphi 602”, luglio 19 ; risale invece a settembre la nuova edizione riveduta e ampliata dell’Epistolario nella collana “Opere di Carlo Michelstaed­­ter” di Adelphi 20,
il già ricordato saggio (ma scritto con il piglio del romanziere, quale Campailla è
diventato negli anni) Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e
tragedia 21, in settembre per i tipi di Marsilio, editore pure del catalogo della mostra goriziana 22, un catalogo che si legge d’un fiato come un romanzo (forse anche per la magnifica carta e stampa delle prestigiose Grafiche Antiga di Crocetta
del Montello): non a caso in questi due ultimi testi l’apparato bibliografico, delizia dei bibliotecari, è ridotto volutamente al minimo.
Un’altra delizia, ma per il piccolo pubblico dei bibliofili: l’edizione di I figli del
mare, con testi di Sergio Campailla (Il tuffo) e di Antonella Gallarotti (Il Fondo
Carlo Michelstaedter della Biblioteca Statale Isontina): si tratta di un libro d’artista
pubblicato a Trieste dallo Studio Bibliografico Simone Volpato, in 60 copie numerate, composto da 8 carte e 3 fotografie analogiche di Roberto Kusterle stampate su carta baritata virata (in 3 versioni tutte conservate nel Fondo, soggetto A
dall’esemplare 1 al 20, soggetto B dal 21 al 40, soggetto C dal 41 al 60), patrocinio di Icm, Biblioteca statale isontina, Librerie Tarantola di Udine e Minerva di
Trieste 23.
Nel 2010, quasi a suggellare l’importanza della riflessione filosofica di Carlo, è
84
85
marco menato
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
uscito il 74° volume del Dizionario Biografico degli Italiani che comprende alle pagine 273-277 la voce Michelstaedter, Carlo Raimondo scritta da Alessandro Arbo 24
(nella sezione bibliografica è dato rilievo al Fondo).
Considerato che molto è stato edito sia da Campailla che da altri studiosi, la
Biblioteca è ora in grado di pubblicare il catalogo scientifico dei manoscritti di
Michelstaedter insieme all’inventario dell’archivio personale di Paula, disperso
all’interno della sezione ix del Fondo 25.
Fino a oggi la descrizione (e quindi la conoscenza) dei manoscritti di Michelstaedter è affidata solo all’inventario topografico del Fondo, uno strumento abbastanza sommario che prelude sempre all’esame se non carta per carta, certamente
fascicolo per fascicolo, condotto per ovvi motivi di conservazione su riproduzioni fotostatiche e/o digitalizzate (queste ultime effettuate nel 2000 e nel 2002). Fa
eccezione a questa situazione la parte grafica e pittorica del fondo analiticamente
riprodotta e commentata nei seguenti cataloghi:
iv.l), pp. 313-315, schede 438-449; Album M (fcm iv.m), pp. 316-335, schede 450-499;
Album N (fcm iv.n), pp. 337-347, schede 500-549; Taccuino O (fcm iv.o), pp. 348355, schede 550-579; Taccuino P (fcm iv.p), pp. 355-358, schede 580-596; Taccuino
Q (fcm iv.q), pp. 359-369, schede 597-641; Taccuino R (fcm iv.r), pp. 369-373, schede 642-661; Quadri (fcm v.1-46), pp. 373-418, schede 662-730; Disegni su fogli manoscritti, pp. 418-428, schede 731-772; Disegni su libri, p. 428, scheda 773; Proprietà privata e riproduzioni da originali perduti, pp. 429-448, schede 774-801.
Il catalogo intende registrare tutta la produzione grafica e pittorica di Michelstaedter,
anche quella minore (si vedano per esempio le aggiunte pubblicate nel 2011), rinvenuta sui manoscritti e su un libro; il catalogo di Campailla mira invece a una presentazione storico-critica della figura di Michelstaedter pittore.
–– Carlo Michelstaedter, Album G, Monfalcone, Edizioni della Laguna, 1992, 20,5 ×
12,5 cm. 30 cc. n.n., nota introduttiva di Otello Silvestri, colophon: «Di questo volumetto, copia anastatica dell’Album G disegnato da Carlo Michelstaedter e conservato presso la Biblioteca Civica di Gorizia, sono stati impressi cinquecento esemplari numerati da 1 a 500»; cfr. L’immagine irraggiungibile, cit., pp. 251-271, l’originale è
in fcm iv.g, inv. 37.198.
–– Antonella Gallarotti, L’oscurità luminosa invade la stanza. Dialoghi con Carlo Michelstaedter dopo il 17 ottobre 1910, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2011, 55
pp., a conclusione del saggio da p. 40 a p. 52 sono pubblicati in b/n ulteriori 20 schizzi rinvenuti su mss di Michelstaedter non disponibili all’atto del catalogo L’immagine
irraggiungibile. Il quaderno, autografo di Paula, con i testi di sedute spiritiche, è conservato nel Fondo (ix.m.5).
–– Carlo Michelstaedter, Opera grafica e pittorica, a cura di Sergio Campailla, Gorizia,
Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1975, xxx-142 pp. + indice delle tavole, 141 tavv. in b/n e a colori, allegato un foglietto azzurro Introduzione firmato da
Sergio Campailla, Opere di Carlo Michelstaedter, 5, nell’indice numerico delle tavole è specificato che «Tutti i titoli sono a cura dell’editore, il quale nei pochi casi in cui
ha potuto, ha utilizzato indicazioni a margine di Michelstaed­­ter», non è registrata la
collocazione e il numero di inventario dei singoli pezzi, ma si tratta di una selezione
del materiale conservato nelle sezioni iv e v; in copertina è riprodotto a colori l’Autoritratto su fondo fiamma che all’epoca era conservato da Francesco Verzegnassi (per
la storia del quadro vedi il catalogo della mostra Carlo Michelstaedter, far di se stesso
fiamma, cit., p. 152);
–– Carlo Michelstaedter, L’immagine irraggiungibile. Dipinti e disegni di Carlo Michelstaedter, catalogo generale delle opere a cura di Antonella Gallarotti, saggio introduttivo di Daniela Bini, Monfalcone, Edizioni della Laguna, 1992, 453 pp., ill. a colori nei saggi e in b/n nelle 801 schede, pp. 15-52: L’autenticità del segno, di Daniela Bini, segue fino a p. 64 il testo originale inglese The authenticity of drawing, pp. 81-96:
L’immagine irraggiungibile. Dipinti e disegni di Carlo Michelstaedter, di Antonella Gallarotti, la schedatura inizia a p. 98 e rispecchia l’ordinamento del Fondo Michelstaedter; sono descritti anche disegni di proprietà privata o andati perduti; senza indici;
catalogo della mostra presso il Castello di Gorizia dal 10 maggio al 22 giugno 1992.
Più analiticamente: Album A (fcm iv.a), pp. 99-125, schede 1-45; Album B (fcm
iv.b), pp. 127-143, schede 46-74; Album C (fcm iv.c), pp. 144-185, schede 75-229; Album D (fcm iv.d), pp. 185-205, schede 230-263; Album E (fcm iv.e), pp. 206-233,
schede 264-297; Album F (fcm iv.f), pp. 234-250, schede 298-325; Album G (fcm
iv.g), pp. 251-271, schede 326-352; Album H (fcm iv.h), pp. 272-282, schede 353369; Album I (fcm iv.i), pp. 283-295, schede 370-386; Album J (fcm iv.j), pp. 296301, schede 387-415; Album K (fcm iv.k), pp. 302-311, schede 416-437; Album L (fcm
86
Il Fondo Michelstaedter, il cui delicato ordinamento delle carte manoscritte
per volontà del donatore non poteva che essere affidato a Campailla, fu inventariato, come «Dono Winteler», sul quinto registro cronologico d’entrata della Biblioteca Civica di Gorizia nei mesi di aprile, maggio e luglio 1974 (numeri 35.884909, 35.942-951, 36.027-036) e nel dicembre 1975 (numeri 37.101-37.213) in modo
sommario, rimandando in un paio di casi a generici «inventari a parte»; invece la
serie dei numeri 35.922-934 (aprile 1974) corrisponde a 13 monografie di Chiavacci, Capitini, Cerruti e Hasselquist degli anni cinquanta e sessanta, donate a Paula, e che ovviamente non sono state inserite nel Fondo. Il materiale bibliografico
conservato nel Fondo è presente nei cataloghi a schede, generale e speciale, della Biblioteca; dal 1998 le nuove acquisizioni sono registrate solo nell’opac del Servizio bibliotecario nazionale, mentre la parte precedente, in attesa di una ricatalogazione, è stata riversata nella sezione intitolata Bibliografia Michelstaedteriana
del sito web della Biblioteca statale isontina (pagina Patrimonio librario / Fondo
Michelstaedter).
Il Fondo si presenta oggi suddiviso in 12 sezioni (le ultime sono state aperte
negli anni ottanta), nelle quali sono collocati circa 1700 documenti di vario tipo.
87
marco menato
Nelle prime 6 sezioni, il fondo “storico”, sono conservati i mss, i disegni e i
quadri di Michelstaedter, ma non tutto il materiale che era presso Paula (e che
per questo motivo deve essere definito “storico”) è stato collocato in queste sezioni, per esempio fotografie originali sono in ix/g, lettere indirizzate a Paula in ix/i
e, come già detto, il quaderno con le sedute spiritiche in ix/m, dattiloscritti di studiosi in ix/d, e, f; le altre 6 sezioni costituiscono invece il fondo “vivo”, costantemente alimentato con nuovi studi e documenti, ma da questo punto di vista sembra che non si sia considerato abbastanza il fiorire anche di una produzione bibliografica minore, a volte minima e occasionale (tesi, recensioni, citazioni, articoli su quotidiani e riviste di carattere non scientifico, inviti ecc.) collegata, e allo
specializzarsi degli studi su Michelstaed­­ter, ma soprattutto alla nascita del “mito”;
forse una divisione più netta fra produzione bibliografica e solamente documentaria, nella quale comprendere il cosiddetto materiale non librario, avrebbe contribuito a rendere il fondo più “leggibile” dal punto di vista bibliografico, oltre che
più gestibile dal punto di vista biblioteconomico (le numerose fotocopie porranno presto problemi conservativi e di descrizione).
Le sezioni quarta e quinta, le uniche che presentano una certa compattezza, sono state già integralmente descritte nei citati cataloghi di Campailla e Gallarotti.
Per le sezioni settima e ottava (e per alcune partizioni della nona) valgono,
fino al 1975, il Quaderno bibliografico su Carlo Michelstaedter (53 pp.) di Sergio
Campailla, prefazione di Cesare Federico Goffis, edito dall’università di Genova nel 1976, organizzato in Edizioni delle opere (30 titoli descritti con ampio commento) e Bibliografia della critica (in ordine cronologico dal 1910 al 1976, 244 titoli, compresi anche articoli su quotidiani e tesi di laurea) e fino al 2003 le bibliografie pubblicate da Angela Michelis, condotte sul posseduto del Fondo:
–– in appendice agli atti del convegno Eredità di Carlo Michelstaedter, Udine, Forum,
2002, pp. 257-279, circa 600 titoli, suddivisi nei capitoli: 1. Edizioni degli scritti di Michelstaedter (in ordine cronologico, 30 titoli), 2. Scritti su Carlo Michelstaedter (in ordine alfabetico, iniziando purtroppo con l’inutile sigla aa.vv.!), 3. Bibliografia, in ordine cronologico, delle pubblicazioni di o su Carlo Michelstaedter in inglese, tedesco, francese, spagnolo, 4. Mostre allestite con opere di Carlo Michelstaedter (in ordine cronologico). È la migliore bibliografia esistente, anche se sarebbe stata opportuna o una
maggiore selezione o una suddivisione più articolata (specie per gli articoli su quotidiani e per le citazioni);
–– Carlo Michelstaedter, Sfugge la vita. Taccuini e appunti, a cura e con saggio introduttivo di Angela Michelis, trascrizione dei testi dai manoscritti e note di Rinaldo Allais,
postfazione di Marco Cerruti, Torino, Nino Aragno, 2004, lxv-293 pp., ill., Passages,
pp. 237-288: Rassegna bibliografica in ordine cronologico. 1. Edizioni degli scritti di Michelstaedter (46 titoli), 2. Scritti su Carlo Michelstaedter (circa 750 titoli), ambedue le
88
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
bibliografie contengono anche indicazioni di tesi di laurea e di articoli sulla stampa
quotidiana presenti nel Fondo; i nomi degli autori sono puntati.
Il piano di classificazione è stato pubblicato da Antonella Gallarotti, Le carte
del Fondo Carlo Michelstaedter. Appunti per una storia, Gorizia, Biblioteca Statale
Isontina, 2010, pp. 19-27 (con bibliografia specifica); all’interno delle sezioni, particolarmente nel fondo vivo, l’ordinamento è cronologico, cioè per anno di stampa, che spesso corrisponde anche all’anno di acquisizione:
i. Epistolario (ordinato secondo destinatario e quindi per data, in fine la corrispondenza ricevuta da Carlo).
ii. Scritti scolastici.
iii. Scritti poetici, letterari, filosofici, vari (qui sono conservati i mss della Persuasione,
inv. 35.945, 35.947/8).
iv. Opera grafica e pittorica. Album e taccuini.
v. Opera grafica e pittorica. Quadri e disegni (da questa sezione sono stati estratti la
maggior parte dei 21 quadri esposti dal 1998 nella Sinagoga di Gorizia).
vi. Opere a stampa possedute da Michelstaedter (7 volumi, inv. 37.142-147, al n. 37.144
corrispondono in realtà 2 edizioni legate in 1 volume).
vii. Edizioni delle opere di Carlo Michelstaedter (comprese 3 serie di bozze di stampa –
inv. 37.149, 37.150, 41.043 – corrette da V. Arangio-Ruiz e mai edite, le traduzioni, le
edizioni successive alla prima e in qualche caso anche le semplici ristampe, alla fine
del 2010 erano conservati 70 volumi).
viii.Pubblicazioni su Carlo Michelstaedter (è la sezione forse più utile dal punto di vista
scientifico, alla fine del 2010 erano conservati 263 tra volumi e opuscoli, in prevalenza estratti; comprende anche 77 tesi per le quali non è stata riservata una apposita
sottosezione; cfr. Antonella Gallarotti, Tesi e tesine su Carlo Michelstaed­­ter disponibili per la consultazione presso il “Fondo Carlo Michelstaedter” e on line, in Carlo Michelstaedter: l’essere come azione, a cura di Erasmo Silvio Storace, Milano, Albo Versorio, 2007, pp. 93-112).
ix. Articoli, saggi, fotografie e materiale archivistico.
Il materiale, specie nelle prime sottosezioni, proviene dall’archivio personale di Paula, che purtroppo non è stato tenuto unito (per questo l’auspicata pubblicazione del
catalogo dei manoscritti di Michelstaedter prevede anche la ricomposizione dell’archivio di Paula). È l’unica sezione che ha ricevuto un’ulteriore, e non sempre giustificata, suddivisione dalla lettera A alla lettera Z. Richiederebbe un totale rifacimento, dato che alcune sezioni non sono state più alimentate e in altre è presente documentazione fotocopiata (anche quando l’originale è posseduto dalla Biblioteca) solo
per comodità di consultazione.
a. Bustina in pelle con una ciocca di capelli di Carlo (foto in Le carte del Fondo,
cit., p. 25).
b. Articoli apparsi soprattutto su quotidiani, la maggior parte in fotocopia.
c. Estratti da riviste scientifiche (compresi alcuni dattiloscritti di Chiavacci).
89
marco menato
d. Articoli su quotidiani e testi dattiloscritti (di provenienza Paula).
e. Interventi dattiloscritti (i primi 17 numeri di provenienza Paula) e 4 testi teatrali inediti.
f. Trascrizione dattiloscritta di 3 articoli apparsi su quotidiani non posseduti dalla Biblioteca.
g. 10 fotografie d’epoca, compreso il ritratto fotografico (inv. 37.113) – in cornice
d’epoca – dello Studio Rossi di Genova; album (inv. 61.577) con 24 fotografie risalenti agli anni 1908-1909 (alcune di queste in riproduzione sono state esposte nella mostra Intorno a Carlo); album a fogli mobili (di fattura non originale,
inv. 37.210) con 24 fotografie d’epoca, 4 riproduzioni fotografiche moderne, 12
riproduzioni da opere a stampa. Tutte le fotografie antiche provengono dall’archivio di Paula.
h. Riproduzioni fotografiche moderne di quadri, disegni e delle fotografie collocate in G, eseguite dai fotografi goriziani Mazucco, Assirelli, Bumbaca (positivi e negativi).
i. 38 lettere e cartoline (1931-1971) indirizzate a Paula da parte di studiosi, compreso Emilio Michelstaedter.
j. Miscellanea di documenti biografici e critici (i primi pezzi di provenienza Paula).
k. Scritti e disegni di Michelstaedter apparsi su periodici (28 titoli a stampa, in fotocopia da esemplari in possesso della Biblioteca).
l. Postille trascritte da Paula a opere lette da Michelstaedter e andate perdute (cfr.
Antonella Gallarotti, Postille di Michelstaedter su volumi perduti, in Ha-Tikva.
La Speranza attraverso l’ebraismo goriziano, Monfalcone, Edizioni della Laguna,
1991, pp. 102-104).
m. Documenti biografici provenienti dall’archivio di Paula e curiosità (inviti, programmi, cartoline ecc.).
n. Articoli biografici e critici apparsi su periodici (i primi numeri sono di provenienza Paula).
o. Articoli critici apparsi su riviste scientifiche o in volume (438 pezzi soprattutto in fotocopia).
p. Fotocopie dei registri dello Staatsgymnasium relativi all’esame di maturità (gli
originali sono nell’Archivio di Stato di Gorizia).
q. Estratti da riviste.
r. Numeri di riviste con articoli dedicati a Michelstaedter.
s. Riproduzioni fotostatiche di fotografie ritraenti Michelstaedter e familiari.
t. Articoli su riviste dedicati al tema della Mitteleuropa e dell’ebraismo (8 titoli, fotocopie da esemplari in possesso della Biblioteca).
u. Riproduzioni fotostatiche, totali o parziali, di libri fuori commercio con saggi dedicati a Michelstaedter (prevalentemente da esemplari non posseduti dalla Biblioteca).
v. Convegno del 1987 Michelstaedter, il coraggio dell’impossibile, programma, invito, ampia rassegna stampa e 18 relazioni dattiloscritte. Gli atti sono usciti nel
90
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
2002 presso l’Editore Forum, ma non con tutte le relazioni.
w. Articoli, soprattutto della stampa locale, e pagine di siti web con citazioni di Michelstaedter.
y. Articoli ritenuti genericamente di interesse per lo studio di Michelstaedter (fotocopie da esemplari in possesso della Biblioteca).
z. Opere di Alberto Michelstaedter (29 titoli a stampa, in fotocopia da esemplari in
possesso della Biblioteca).
x. Registrazioni audio di conferenze e di trasmissioni radiofoniche (6 pezzi), insieme
alla dodicesima si tratta di sezioni poco rappresentative.
xi. Manifesti e locandine relativi a convegni e mostre tenuti dal 1974 prevalentemente a
Gorizia (24 pezzi, alcuni in cornice).
xii. Registrazioni su vari supporti (videocassette, floppy disk, CdRom, 33 pezzi).
intorno a carlo: postilla a una mostra
Giovedì 20 gennaio 2011 in un’ala dello spazio espositivo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia è stata inaugurata, con brevi discorsi, la mostra Intorno a Carlo, idealmente collegata a Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma,
curata da Sergio Campailla e aperta da domenica 17 ottobre 2010 nel medesimo
spazio espositivo. La mostra a sua volta è suddivisa in tre piccole sezioni: Itti e Senia. Frammenti di una storia d’amore (la più interessante, sulla quale mi soffermerò), Da un album fotografico. La famiglia di Giovanni Luzzatto tra America ed Europa e I luoghi di un filosofo. Itinerari di Carlo Michelstaedter.
Gli eredi di Argia Cassini (1887-1944), la Senia di Michelstaedter, hanno messo a disposizione alcuni scritti e disegni autografi di Michelstaedter ancora conservati gelosamente tra le carte di famiglia e ritrovati per l’appassionata insistenza
di Antonella Gallarotti, responsabile delle raccolte manoscritte (nelle quali è confluito il Fondo Michelstaedter) della Biblioteca statale isontina.
Si tratta di 12 disegni (in realtà 13 perché un foglio è disegnato sia sul recto
che sul verso), databili tra il 1903 e il 1910. I soggetti sono tipici di Michelstaedter
e quindi ci sono alcuni studi, ritratti femminili e maschili (alcuni non identificati), scene di vita studentesca (La corsa alla stazione, Da Monfalcone a Duino) tecnicamente somiglianti alla Processione di ombre, ma di valenza artistica e simbolica inferiore 26, che splendidamente riprodotta in grande formato accoglie il visitatore della mostra Far di se stesso fiamma. Sono di forte impatto due autoritratti,
che erano ritenuti perduti, e i ritratti del padre (incompiuto, sul verso di un foglio
recante un modesto acquerello e lapis, datato 15 maggio 1908, siglato C.M., con
i versi dannunziani «E se i tuoi occhi…», ritrae un uomo in abiti da antico romano con una capigliatura nera) e dell’amico Nino Paternolli (siglato CM, sul ver-
91
marco menato
il fondo carlo michelstaedter. appunti documentari e bibliografici
so «Paternolli 1903»). Gli autoritratti (fino a oggi noti solo attraverso vecchie riproduzioni fotografiche) sono L’uomo nella notte accende una luce a se stesso, che
per testimonianza della sorella Paula è l’ultimo autoritratto eseguito da Carlo nel
maggio 1910 in occasione proprio del compleanno di Paula 27 e l’Autoritratto tenebroso 28 siglato in basso con la formula algebrica dell’iperbole, eseguito con lapis,
matite acquerellate e acquerello, pubblicato nell’invito (quest’ultima mostra non
ha un proprio catalogo, ma è accompagnata da un elegante pieghevole con un testo essenziale e da quattro cartoline che riproducono questo autoritratto, la Scenetta in tre tempi, il viaggio verso San Mauro dei Michelstaedter e l’Isonzo in una
fotografia del 1911 di proprietà della famiglia Luzzatto Guerrini).
Dal lato epistolare le presenze sono forse meno significative e comunque confermano quanto era già noto nel rapporto tormentato Carlo-Argia. Spicca un mezzo foglio con un pensiero per Argia, firmato «Carlo M.» e datato «Gorizia 7 febbraio 1908», stilisticamente molto bello, ma che non sembra concedere un futuro
a quel rapporto (lo trascrivo integralmente): «Alla “creatura musicale” per-/ché
canti, e suoni, e viva la / sua vita, un augurio, un salu-/to, nel vento, da chi dopo
la / sosta obliosa riprende il / lungo e solitario errare»; sul recto, ai lati, sono incollate tre piccole fotografie: di Argia al piano (molto simile a quella nel catalogo
Marsilio 29), di Carlo (formato tessera) e dell’autoritratto L’uomo nella notte; il piccolo carteggio comprende inoltre una cartolina postale (Gorizia, 2 agosto 1909) e
una lettera (Gorizia, 4 agosto 1909) delle sorelle Argia e Fulvia a Carlo, una cartolina postale non viaggiata (ma stampata nel 1910) della Società nazionale Dante Alighieri con la citazione manoscritta in greco, autografa di Carlo, di due versi
dell’Antigone di Sofocle e infine una cartolina postale con i saluti di Emma, madre di Carlo, ad Argia (Venezia, 26 aprile 1919), un legame forse tenuto in vita per
amore del figlio perduto.
A una prima superficiale analisi risulta sicuramente più interessante la traduzione parziale della Persuasione (solo la prima parte, 61 carte dattiloscritte in inchiostro blu su fogli di carta velina) che potrebbe essere opera della stessa Argia
che tuttavia, per motivi che ora ci sfuggono, si nasconde sotto l’anonima sigla N.N.:
Die Überzeugung und die Rhetorik. (Aus dem Italienischen ubersetzt von N.N.).
Certo queste nuove carte, tra l’altro molto ben conservate, non aggiungono
nulla di nuovo, né dal lato biografico né da quello artistico-letterario, ma dicono invece molto sul fascino e sulla presenza di Carlo ancora fra di noi: sono carte freschissime, che sembrano uscite da poco dalla penna e dalla parola di Carlo.
Qualche dubbio rimane: sono state sempre presso Argia (alcune, come le lettere,
sono evidentemente a lei collegate, ma i disegni?) oppure dopo la tragica morte di
Carlo sono state richieste indietro dalla famiglia e in seguito rimesse in circolo da
Paula, con l’intendimento di mantenere e alimentare il ricordo del fratello? C’è
dell’altro materiale in mani private, consegnato dalla sorella sempre con la volon-
tà di far conoscere Carlo, soprattutto disegni? L’interrogativo non è pleonastico,
e credo che un po’ di verità ci sia: prima che sia troppo tardi sarebbe opportuno
che tutto questo materiale venisse almeno depositato (se non lo si vuole donare)
nel Fondo Michelstaedter della Biblioteca statale isontina.
L’altra sezione che riveste un certo interesse per la biografia di Michelstaedter, almeno indirettamente, sono i due album della famiglia Luzzatto (conservati presso la famiglia Luzzatto Guerrini di Gorizia) che testimoniano chiaramente l’agiatezza di vita raggiunta da Giovanni Luzzatto (1852-1938), zio materno di Carlo, importatore in America (con negozio a New York dal 1882, nel quale
aveva lavorato Gino, fratello di Carlo) del made in Italy gastronomico: fra le decine di foto scattate nel periodo 1906-1925, che meriterebbero un approfondimento anche dal lato della storia del costume e del turismo, vale la pena citare in questa sede quella che ritrae in un giardino non identificato Emma e Alberto, genitori di Carlo, nel 1925 30.
L’ultima sezione della mostra Intorno a Carlo è una passeggiata fotografica nei
luoghi frequentati da Carlo e citati nel suo epistolario (ovviamente con eccezione
di Gorizia), fatta con una serie di 56 cartoline illustrate estratte dalla collezione
del fotografo goriziano Jurko Lapanja, insieme a 13 fotografie originali degli anni 1908-1909 (presenti in un piccolo album, poco conosciuto, del Fondo Michelstaedter, collocato in fcm ix.g/c, inv. 61.577) che ritraggono Carlo, le sorelle Elda e Paula e la mamma in gita nei dintorni di Gorizia: tempi felici e spensierati
che, nonostante la catena di morte che di lì a pochi anni avvolgerà tutta la famiglia, è bene ricordare.
92
note al testo
1
S. Campailla, Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e tragedia, ii, Le carte segrete, Venezia, Marsilio, 2010.
2
Nel medesimo capitolo Campailla pubblica interessanti notizie sui Winteler.
3
Ibid., p. 23.
4
Ibid.
5
Ibid., p. 38.
6
Per l’esattezza bibliografica doveva trattarsi di Lirica del Novecento. Antologia di poesia italiana, a cura
di L. Anceschi, S. Antonielli, Firenze, Vallecchi, 1961, pp. 103-106; l’antologia, che riporta due liriche di Michelstaedter, I figli del mare, edita senza titolo, e A Senia, non è posseduta né dalla Biblioteca né dal Fondo.
7
S. Campailla, A ferri corti con la vita, Gorizia, Comune di Gorizia, 1974 (141 pagine, ristampata, proprio per il successo, nel marzo 1981).
8
La filosofia nella Mitteleuropa, atti del convegno internazionale (Gorizia, Palazzo Attems, 28 settembre-1° ottobre 1974), Gorizia, Icm, 1981, pp. 241-280.
9
Testimonianza per Carlo Michelstaedter, Palazzo Attems, 28 settembre-20 ottobre 1974: disponibile
l’opuscolo di sole 6 carte non numerate, con l’elenco del materiale esposto.
10
C. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Bologna, Patron, 1974 (122 pagine, illustrazioni
tratte dai disegni di Michelstaedter).
93
marco menato
S. Campailla, Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, pp. 147-164.
Id., Il segreto di Nadia B., cit., in particolare p. 222.
Eredità di Carlo Michelstaedter, atti del convegno internazionale Michelstaedter. Il coraggio dell’impossibile, a cura di E. Guagnini (Gorizia, 1°-3 ottobre 1987), a cura di S. Cumpeta, A. Michelis, Udine, Forum, 2002 (279 pagine).
14
Dialoghi intorno a Michelstaedter, a cura di S. Campailla, Gorizia-Roma, Biblioteca Statale IsontinaIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato, [1988?] (184 pagine).
15
M. Grusovin, Il centenario di Carlo Michelstaedter, in «Kadmos. L’informatore mitteleuropeo», 51,
2009, p. 2.
16
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, catalogo della mostra a cura di S. Campailla (Gorizia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 17 ottobre 2010-27 febbraio 2011), Venezia, Marsilio, 2010(195
pagine completamente illustrate).
17
La via della persuasione, Gorizia, 18-19 ottobre 2010, con l’intervento di quattordici studiosi e con il
contributo di Icm, e Un’altra società: Carlo Michelstaedter e la cultura contemporanea, Roma, 23-24 novembre 2010, con l’intervento di sedici studiosi e con il contributo dell’Università di Roma Tre e della Provincia di Roma.
18
A. Gallarotti, Le carte del Fondo Carlo Michelstaedter. Appunti per una storia, Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, 2010 (48 pagine); M. Menato, Le celebrazioni per il centenario della morte di Carlo Michelstaedter (Gorizia 1910-2010). Appunti per una documentazione, in «Accademie e biblioteche d’Italia», n.s., v,
3-4, 2010, pp. 41-45.
19
C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla,
Milano, Adelphi, 2010 (241 pagine).
20
Id., Epistolario, a cura di S. Campailla, nuova edizione riveduta e ampliata, Milano, Adelphi, 2010
(xx-489 pagine).
21
Campailla, Il segreto di Nadia B., cit. (238 pagine).
22
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, cit.
23
C. Michelstaedter, I figli del mare, Trieste, Simone Volpato Studio Bibliografico, 2010.
24
A. Arbo, a.v. Michelstaedter, Carlo Raimondo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto
della Enciclopedia italiana, lxxiv, 2010, pp. 273-277.
25
Il primo volume del catalogo, a cura di Simone Volpato, è stato pubblicato dalla casa editrice Olschki nel 2007 (“Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia 112”) e comprende i manoscritti della Biblioteca Statale e della Biblioteca Civica, con esclusione del Fondo Michelstaedter e delle pergamene
Della Bona.
26
Cfr. Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, cit., pp. 54-55.
27
È il n. 172 del percorso espositivo; ibid., p. 161.
28
Ibid., p. 156.
29
Ibid., p. 171, n. 187.
30
Sulla famiglia Luzzatto si può leggere l’ampio articolo di Stefano Cosma, I Luzzatto medici e avvocati della comunità ebraica goriziana, in «Il Piccolo», edizione di Gorizia e Monfalcone, 4 febbraio 2011, p. 24.
11
12
13
94
L’opera in versi di Michelstaedter
e la poesia del primo Novecento
di Maria Carla Papini
«Dopo i secoli d’oblio ieri ha echeggiato tra noi la generosa voce di Giovan
Battista Pergolesi. Non il faticoso lavoro di [chi] compone dispone ordina per
aver fatto, ma l’ultimo canto d’una giovane vita che […] non spera più nel futuro,
e tutta ardendo della propria fiamma, dà tutta sé stessa in un punto – così che chi
la senta vedrà sempre davanti a sé, quasi concreta e tangibile, l’imagine della passione che, svincolata dalle cose del più e del meno, dell’oggi e del domani, abbraccia via via tutte le cose nel suo amore ed in questo viventi le ricrea» 1: nelle parole
con cui Michelstaedter recensisce il 29 aprile 1910 l’esecuzione, sotto la direzione
del maestro Seghizzi, dello Stabat Mater di Pergolesi, appaiono profilarsi chiaramente non solo gli elementi portanti della sua poetica e la riflessione teorica che li
sottende, ma anche la stretta connessione che collega prassi filosofica, letteraria ed
ermeneutica come momenti distinti e pur tra loro interattivi di un discorso che se,
infatti, dalla lettura e dalla conseguente speculazione filosofica prende senz’altro
avvio, trova nell’elaborazione artistica e poetica il senso e l’esito della sua ricerca.
Così, nonostante Giacomo Debenedetti affermi che per quanto Michelstaedter «sia anche autore di poemi […] bisognerà senz’altro rinunziare a farne un
poe­­ta […] là dove non sembra neppure che egli cerchi la poesia» 2, nonostante che
il nome e la fortuna critica di Michelstaedter siano comunque e prevalentemente
legati alla stesura di La persuasione e la rettorica, crediamo di dover condividere
l’«indiscrezione» che «autorizza» 3 Sergio Campailla – che della sua opera è insigne studioso e massimo divulgatore – ed esaminarne quindi la produzione poetica non come esperienza secondaria e/o marginale ma, appunto, come fine precipuo di una riflessione filosofica di cui la prassi poetica, in specie, e l’opera d’arte,
in generale, appare, insieme, risultante e termine ultimo della ricerca.
Non a caso, dunque, nelle parole con cui si celebra l’opera di Pergolesi sem95
maria carla papini
l’opera in versi di michelstaedter e la poesia del primo novecento
brano riecheggiare quelle che, in chiusura della Persuasione, tracciano schopenhauerianamente il profilo e il compito di chi facendo «di sé stesso fiamma […]
giunga a consistere nell’ultimo presente» e in ciò «persuaso» trovi «nella persuasione la pace» 4 e, insieme a esse, quelle che significativamente e conseguentemente concludono la poesia composta a Pirano nell’agosto 1910: «vana è la pena e vana la speranza, / tutta è la vita arida e deserta, / finché in un punto si raccolga in
porto, / di sé stessa in un punto faccia fiamma» 5.
Nella musica, nel «canto» di Pergolesi, infatti, Michelstaedter sembra individuare la suprema realizzazione di quell’arte che – come Rico afferma nel Dialogo
della salute – «arride al forte che l’ama al sole della sua libera vita, sicuro che essa
a lui darà ciò che a nessun altro può dare» 6. Un’arte che Schopenhauer aveva appunto identificato con l’«opera del genio» 7, di colui che affrancandosi dalla «servitù» che comunemente lega la facoltà conoscitiva alla volontà di «conservazione
della specie», «ne spezzi il giogo, e […] stia a sé come un semplice, chiaro specchio del mondo» 8. Un’arte che si sottrae così a ogni funzione utilitaristica e subalterna per esplicare appieno una facoltà conoscitiva altrimenti sempre e inevitabilmente soggetta al vincolo dell’umana, quotidiana e pertanto vacua quanto labile necessità. Un’arte che – secondo la definizione schopenhaueriana che pare appunto ribadirsi nelle parole di Michelstaedter – «è […] la sola cosa essenziale del
mondo, la vera sostanza dei suoi fenomeni, a nessun mutamento soggetta e quindi
in ogni tempo con pari verità conosciuta». Un’arte che «riproduce le eterne idee
afferrate mediante pura contemplazione» e la cui «unica origine è la conoscenza
delle idee», l’«unico fine la comunicazione di questa conoscenza» 9. L’arte dunque
e il canto, la poesia – nella specificità della sua attuazione nella prassi poetica michelstaedteriana – come principio e fine di una conoscenza di cui essa è l’unico
ma anche, inevitabilmente e sempre, imperfetto tramite di espressione e proprio
in quanto non può opporre alla perfezione dell’essere che la informa e che in essa si rivela, altro che la consapevolezza della sua perdita, la nostalgia, il dolore che
nel suo canto si innalza, nella sua parola si imprime, nel suo segno si ribadisce nel
limite di un vuoto che non può essere colmato.
Così, nelle parole con cui Michelstaedter definisce la musica di Pergolesi, in
quella stessa musica, sembra insistere ciò che Nietzsche aveva definito come l’Urschmerz in Herzen des Ureinen 10, il dolore originario nel cuore dell’uno primordiale, e che, nella scrittura del Campana del Quaderno si sarebbe espresso poi
nel grido, «cri loin de l’humaine douleur», che «diviene musique énervante et caline», «armonia» che evoca e riecheggia le «risonanze del tutto» 11. L’umana originaria interezza, così come è narrata nelle pagine del Simposio platonico, l’Eden
primigenio, la completa e appagata compiutezza che, nel racconto di Michelstaedter, caratterizza ciò che Era il paradiso terrestre 12, è quanto nel canto, nella poesia, nell’arte appunto può ancora rivelarsi nel dolore che in essa si manifesta, nei
termini che, evocandone l’assenza, ne fanno l’oggetto, pur irrecuperabile, della
propria strenua quanto inappagabile aspirazione. Un paradiso terrestre che già si
era rappresentato, e in tutta la sua irrevocabile preclusione, nei versi che, nell’ultima poesia di Sergio Corazzini, ne avevano amaramente dichiarato l’illusorietà
del recupero – «Assaporammo tutta la notte / i meravigliosi grappoli. / Bevemmo
l’acqua d’oro, / e l’alba ci trovò seduti / sull’orlo della fontana / nella vigna non
più d’oro» 13 – individuando proprio nel desiderio, nell’effetto stesso della sua attuazione, la causa prima e determinante del suo scacco, dell’inappagamento implicito e connaturato alla sua stessa formulazione: «O dolce mio amore, / confessa al viandante / che non abbiamo saputo morire / negandoci il frutto saporoso /
e l’acqua d’oro, come la luna» 14. Nella Morte di Tantalo corazziniana è la volontà di un piacere effimero e perciò sempre insoddisfatto a mostrare insieme l’inanità dell’esistenza e la sua identificazione con un desiderio che solo se rimosso e
negato, con la vita stessa, potrebbe, nella morte, essere esaudito. Nei versi di Corazzini è dunque proprio nella riproposizione del desiderio che la vita, l’esistenza
stessa, appare come una condanna cui è interdetta ogni speranza di salvezza nella morte: «E aggiungi che non morremo più / e che andremo per la vita / errando
per sempre» 15. Analogamente, nella poesia di Michelstaedter, il «dolore cieco» 16
che Schopenhauer, e Leopardi con lui, dichiara «essenziale alla vita», principio e
causa della vita stessa 17, quel dolore che tanto più è percepito quanto più se ne individua la ragione nell’esistenza 18, il dolore che è, in sé, il segno, quasi la rivelazione del mistero che si cela dietro l’illusorietà di ogni aspetto e forma di vita, e
che nei volti di Itti e Senia, nella profondità dei loro occhi, resiste oltre la miseria,
la fatica e l’ansia che ne accomuna la sorte a quella di ogni mortale – «Sulle pallide facce il timore / delle piccole cose umane / e le tante speranze vane / e l’ansia che stringe il core. // Ma nel fondo dell’occhio nero / pur viveva il lontano dolore / e parlava la voce del mistero / per l’ignoto lontano amore» 19 – quel dolore
appare mistificato, eluso, misconosciuto nel «dolore che vide / la stessa vanità di
sé stesso» 20, «l’oscuro dolore» 21, quello che si crede derivato dall’insoddisfazione
del piacere – «Chi lo cerca non lo trova, / chi lo trova non lo sa» 22 – dall’insaziabilità di un desiderio mai appagato: «Ahi, quanto pur m’illuse la mortal / mia vista che di fuor ci finge certo / quanto ci manca sol perché ci manca» 23. Così, come afferma Schopenhauer, «infaticabilmente andiamo di desiderio in desiderio, e
sebbene ogni soddisfazione raggiunta, per quanto ci promettesse, tuttavia non ci
appaga, anzi il più sovente non tarda a mostrarci come un mortificante errore, non
vediamo, ciò malgrado, che attingiamo con la botte delle Danaidi, e invece corriamo incontro a desiderii sempre nuovi» 24. L’errore, intrinseco alla formulazione di ogni umano desiderio, dichiara tutta la sua inanità negli accenti espressionistici della Scena comica finale di Corazzini, nei versi che paiono anticipare temi e
luoghi della Prosa fetida campaniana, e in cui, appunto «nell’ombra della porta /
96
97
maria carla papini
l’opera in versi di michelstaedter e la poesia del primo novecento
d’un postribolo» l’«ultimo Desiderio traballando / […] / […] fa / la serenata alla
Disperazione» 25. Quell’errore che, riconosciuto tale, culmina nell’ultimo Corazzini nella sarcastica messa al “bando” 26 di ogni idea e, con essa, della poesia stessa che ne proclama il rifiuto; l’errore che inutilmente rinnova l’empito di una ricerca e di una speranza inesaudibile e che, per il poeta romano, sembra trovare,
appunto, realizzazione solo nel «sentiero della mor­­te» 27, insistentemente appare
reiterarsi, nei versi di Michelstaedter, nei termini di un linguaggio, di una poesia
che ne evidenziano l’esito vanificante nella labilità formale, nell’insistente quanto
insensata trasformazione, nell’inarrestabile dissoluzione di una realtà che sfugge
ai limiti stessi della loro definizione: «Ed ogni cosa / sembra che debba / nell’ombra densa dileguare e quasi / nebbia bianchiccia perdersi e morire / […] / Così
l’anima mia si discolora / e si dissolve indefinitamente» 28, «Così nel giorno grigio
si continua / ogni cosa che nasce moritura, / […] // Ed ancor io così perennemente / e vivo e mi tramuto e mi dissolvo / e mentre assisto al mio dissolvimento / ad
ogni istante soffro la mia morte» 29.
Nel passaggio dallo sfumato impressionismo del­­l’immagine in cui «l’indifferente tramutar del tutto» 30 sembra eludere i limiti di ogni definizione, alla scandita, perentoria nitidezza formale dell’evocazione di una natura che si «aneddotizza» 31 parcellizzandosi nei termini realisticamente concreti della sua apparenza – «ed il sole racconta a forti tratti / le coste cui il mare rode ai piedi / ed i verdi vigneti su coronano» 32 –, al quasi ossessivo, cadenzato riproporsi di un evento
nella cui ripetizione pare faticosamente esaurirsi il senso di ogni esistenza e di
ogni vita – «ritrova il vento l’onda affaticata, / e la mia chiglia solca il vecchio solco» 33, «Onda per onda batte sullo scoglio / – passan le vele bianche all’orizzonte» 34 – alla limpida percezione, al di là di ogni visibile parvenza, del «mistero
eterno d’ogni cosa / costretta a divenire senza posa / nell’infinito» 35, e quindi
all’ostinata, ferma determinazione di un intento che alla vana illusorietà del tutto
contrappone l’intera, irripetibile unità di una verità sempre attesa, perseguita e,
peraltro, indicibile e solo percepibile, appunto, nel «dolore» che ne esprime l’assenza, nella parola, nel linguaggio che ne ripete il vuoto dell’incolmabile mancanza, prende forma e si evolve la dialettica intrinseca al discorso poetico michelstaed­
­teriano. Discorso che, nelle sue più mature proposizioni, ormai al di là di ogni primitivo influsso dannunziano o carducciano, si sostanzia, talvolta ricalcandone letteralmente l’assunto, sia della speculazione filosofica schopenhaueriana sia di
quanto di essa già appare nei versi e nel pensiero di Giacomo Leopardi. E se, nel
più disteso e narrativo andamento del poemetto, esso si riveste di accenti e temi
mediati dalla letteratura scandinava, trova tuttavia proprio nella contrapposizione dialettica che ne connota la proposizione, nella dialogicità che, platonicamente, ne informa il processo evolutivo, la cifra della propria autonoma autenticità. È
infatti appunto nei termini contrapposti di una dialettica in cui al «dolore muto e
cieco di tutte le cose» 36 si oppone «la parola eloquente» di chi «parlando la voce
del proprio dolore» 37 ne esprime la tensione e ne condivide l’attesa, che il discorso filosofico e poetico di Michelstaedter sembra coinvolgere, in primis, la valenza
stessa, la potenzialità semantica di un linguaggio e, in esso, di una parola sperimentata e volta a volta assunta a esempio e a sfida della sua stessa implicita contraddizione. Così nel tessuto, nel testo, di una poesia in cui la scrittura, il linguaggio intreccia, con il filo stesso delle sue parole, «Vita, morte, / la vita nella morte;
/ morte, vita, / la morte nella vita» 38 – come lo stesso Michelstaedter rileva fin dal
secondo capitolo di La persuasione – la «trama nota (finita) dell’individualità illusoria che il piacere illumina, non è fitta così che l’oscurità dell’ignoto (infinito)
non trasparisca» 39 e si renda percepibile proprio nella «voce» pur «indistinta» di
quel «sordo e continuo dolore» che, mentre ne celebra la mancanza, ne ribadisce,
evocandola, la pur indicibile presenza. Analogamente al vuoto che sostanzia ogni
nome e, dunque, ogni parola, vincolandola alla transitorietà contingente della cosa che, volta a volta, significa 40, alla costretta limitazione del suo stesso significato, pur si contrappone lo stretto nesso che collegando l’uno all’altro termine ne
elude la parzialità semantica nell’esaustività del senso implicito al flusso stesso del
linguaggio, alla sua ininterrotta tensione 41. Finito e infinito, vita e morte, piacere
e dolore, illusione e verità, essere e nulla appaio­­no quindi i termini e i temi sempre dialetticamente contrapposti di un percorso e di un discorso poetico che, non
a caso, assume – e teoricamente giustifica 42 – la reiterazione dell’avversativa «ma»
a elemento portante del suo stesso procedere: «Ma nel cielo e nel piano, ma
nell’aria, / ma nello sguardo della tua compagna / […] / ma nel tuo corpo, ma per
la tua bocca / canta ciò che non sai: la primavera. // […] / Ma solo e miserabile mi
struggo / lontano e solo, anco s’a te vicino» 43, «sta sotto il cielo sulla buona terra
/ questo ch’io chiamo “io”, ma ch’io non sono. / No, non son questo corpo, queste membra / prostrate qui fra l’erbe sulla terra, / […] / Io son solo, lontano, io son
diverso – / […] / Ma ora qui che aspetto, e la mia vita / perché non vive, perché
non avviene?» 44. È infatti appunto nei termini della contraddizione intrinseca alla struttura dialogica del testo michelstaedteriano che sembra ribadirsi la fermezza dell’intento che, alla base della stessa ricerca poetica, trova in essa riscontro
nella negazione che oppone alla convenzionalità del comune assunto e di ogni,
per quanto rassicurante, percezione della realtà, la perentorietà del proprio individuale rifiuto e con esso l’istanza della propria autonoma irrinunciabile ricerca.
Così se i nomi che per consuetudine si attribuiscono alle cose, le parole che ne definiscono il significato, tessono – nei termini reiterati, nelle «frasi prescritte» 45
dell’umana comunicazione – una trama che cela, sotto il velo della sua stessa illusoria apparenza, «l’oscurità pur minacciosa» 46 del vuoto 47, del mistero cui esse
pervicacemente fanno da «schermo» 48, se, come più di un decennio dopo nei versi montaliani di Forse un mattino andando in un’aria di vetro, anche in quelli di Mi-
98
99
maria carla papini
l’opera in versi di michelstaedter e la poesia del primo novecento
chelstaedter, quel «vuoto» si rende, appunto, percepibile «oltre il vetro […] / che
le consuete immagini riflette» 49, il «segreto» 50 della sua rivelazione non è, come
nel componimento di Montale, taciuto, ma anzi dichiarato esplicitamente come fine e scopo precipuo della stessa ricerca poetica, come «dono» da perseguire e
quindi condividere: «Lasciami andare, Paula, nella notte / a crearmi la luce da me
stesso, / lasciami andar oltre il deserto, al mare / perch’io ti porti il dono luminoso» 51. E se Paula, nella poesia a lei dedicata, riveste dunque il ruolo che sarà poi,
nel componimento del 9 settembre 1910, di Senia proprio in quanto interlocutrice privilegiata, destinataria del «dono» della narrazione, della parola poetica –
«Le cose ch’io vidi nel fondo del mare, / i baratri oscuri, le luci lontane / e grovigli d’alghe e creature strane, / Senia, a te sola lo voglio narrare» 52 –, risulta poi significativo che, in entrambi i casi – come anche, e ancor più esplicitamente, nei
versi dei Figli del mare –, sia, «oltre il deserto», il mare, appunto, il luogo, l’ambito, in cui cercare e trovare infine lo scopo, il frutto della propria ricerca e, con esso, in esso, la pace, il recupero della primigenia e, finalmente, indivisibile unità
originaria: «Dalla pace del mare lontano / dalle verdi trasparenze dell’onde / dalle lucenti grotte profonde / dal silenzio senza richiami – / Itti e Senia si risvegliaro / dei mortali a vivere la morte» 53. Quello stesso mare che – «patria» 54 perduta
e, dunque, meta rimpianta e ambita lungo il viaggio di Itti e Senia «per le vie che
la siepe rinserra» 55, «nelle tristi dimore dell’uomo» 56 – sarebbe poi stato preso da
De Chirico, nel saggio del 1919 Sull’arte metafisica, a esempio del mistero che la
sua superficie rivela 57. Quel mare in cui Montale avrebbe individuato, nei versi di
Mediterraneo, appunto «la patria sognata» da chi «esiliato» 58 attende di «ritornare» nel suo «circolo» 59, quel mare cui l’invocazione poetica si rivolge, nel secondo movimento del poemetto montaliano del 1924, con un attacco – «Antico, sono ubriacato dalla voce» 60 – in cui, pur nella diversa attribuzione dell’appellativo
iniziale, sembra singolarmente riecheggiare quello del componimento di Michelstaedter, «Amico – mi circonda il vasto mare» 61, nei cui versi «il cielo ed il mare»
che fondono «all’orizzonte» «lor vita infinitamente» 62, paiono, nella loro illimitata vastità, essere assunti a immagine di una «pienezza» dell’«essere» 63 cui, antiteticamente, si contrappone la misura, i «confini» 64 del paesaggio e del tempo umano: «E giù: alle coste in seno accende il sole / bianchi paesi intorno ai campanili
/ e giù nel mare bianche vele erranti / alla ventura» 65. E se anche, poi, quei confini sembreranno inevitabilmente frapporsi – come la «siepe» leopardiana – alla
percezione dell’infinito cui si oppongono – «e senza fine / nuovi confini sotto
nuove stelle / fingere all’occhio fisso all’orizzonte, / dove per tramontar pur sorga
il sole» 66 – se nei versi di Michelstaedter, come, molti anni dopo, in quelli della
Canzone ungarettiana, la realtà apparirà pur sempre prevalere nella reiterata, per
quanto ingannevole, insistenza della sua metamorfica proposizione – «Onda per
onda batte sullo scoglio / […] / monta rimonta, or dolce or tempestosa / l’agitata
marea senza riposo» 67 –, se lo scacco sembrerà allora inevitabile, inutile il viaggio
e irraggiungibile la meta – «E se l’albero gema, se la scotta / a spezzarsi si tenda,
e nella vela / ingolfandosi il vento il mio naviglio / minacci di sommergere, pur
sempre / alla stessa distanza io mi ritrovo / dalla punta agognata» 68 –, se «anche
il mare» finirà quindi per apparire «un deserto senza vita, / arido triste fermo affaticato» 69, «Morto […] anche lui» 70, come, a più di quarant’anni di distanza, nel
Finale della Terra Promessa ungarettiana, pur tuttavia la mira poetica – così come
poi anche nella Canzone di Ungaretti 71 – non si distoglie dalla sua meta e a essa
pervicacemente guarda come all’unico possibile esito, al senso e al fine della sua
ricerca: «Vedo il mar senza confini / senza sponde faticate / vedo l’onde illuminate / che carena non varcò. / Vedo il sole che non cala / lento e stanco a sera in mare / ma la luce sfolgorare / vedo sopra il vasto mar. / Senia, il porto non è la terra
/ dove a ogni brivido del mare / corre pavido a riparare / la stanca vita il pescator.
/ Senia, il porto è la furia del mare, / è la furia del nembo più forte, / quando libera ride la morte / a chi libero la sfidò» 72.
Nel 1950, nel suo Secondo discorso su Leopardi, Ungaretti rileva che nel­l’idillio
leopardiano, l’evocazione dell’infinito non può paradossalmente procedere che
tramite «rappresentazione del finito» 73, e dunque «per espedienti approssimativi» 74, laddove «idea e sentimento dell’infinito non possono aversi che da cose finite, da cose del passato, da cose morte, dal nulla» e l’infinito altro non è, nella riflessione leopardiana, come poi in quella, da essa mediata, di Ungaretti, che
«un’illusione, originata dalla potenza evocativa, dalla potenza incantatoria della
parola» 75. Nel «segreto […] inviolabile» 76 della parola o – come già nei versi michelstaedteriani – nel «mistero» 77 della sua origine, nella «fiamma» che ne sostanzia la forma 78 – appare dunque individuabile il senso di un discorso e di un
percorso poetico che, nei termini della sua stessa evoluzione, e pur nel suo apparente consenso alla forme metriche e stilistiche tradizionali, si apre tuttavia ai temi e ai modi della sperimentazione poetica novecentesca, precorrendone anzi –
quasi per intuizione e nella riflessione teorica che ne sottende l’espressione – gli
esiti. Ché se, infatti, nei versi campaniani del Tempo miserabile consumi, la lezione
baudelairiana – «O Morte o morte vecchio capitano» 79 – riecheggia nell’espressionismo dissacrante di un’invocazione in cui sembra, comunque, ribadirsi tutta la fermezza dell’intento michelstaedteriano – «No, la morte non è abbandono
/ disse Itti con voce più forte / ma è il coraggio della morte / onde la luce sorgerà» 80 –, se il viaggio, e il viaggio per mare, è, nella poesia di Campana, come in
quella di Michelstaedter, metafora ricorrente di una ricerca che, in entrambi, sembra parimenti aspirare – nel silenzio e nel mistero della morte, e dunque nel superamento di ogni limite o determinazione formale – a uno stesso «porto» di libertà
e «di pace» 81 – «Pieno di canti soffocati. Agogno / La nebbia ed il silenzio in un
gran porto, / […] / O quando quando in un mattino ardente / L’anima mia si sve-
100
101
maria carla papini
l’opera in versi di michelstaedter e la poesia del primo novecento
glierà nel sole / Nel sole eterno, libera e fremente» 82 –, la tensione orfica che ispira
il dettato dei due poeti e che, fin dal 1910, aveva trovato esplicita espressione nei
versi A Senia 83 di Michelstaed­­ter, torna quindi a riproporsi, e nel volgere di pochi
anni, nelle poesie del Porto Sepolto ungarettiano e quindi nei temi stessi dell’Allegria. Allegria di naufragi in cui il rimando, ma anche lo scarto, dalla tradizione leopardiana appare evidente, fino appunto dal titolo, ma in cui la valenza metaforica del naufragio vale, proprio come nei versi michelstaedteriani – «mi parve dolce cosa naufragare» 84 –, a rilevare il processo dialettico di un percorso poetico
che nel rapporto tra parola e silenzio, essere e nulla individua l’ambito e il senso
della sua stessa significazione. E se certo lo iato strutturale che distingue le Poesie
di Michelstaedter dalla prima raccolta di Ungaretti potrebbe perfino aprioristicamente escludere ogni possibilità di confronto, e se la sperimentazione ungarettiana si spinge, nelle poesie dell’Allegria, a soluzioni che appaiono senz’altro estranee alla prassi poetica di Michelstaedter, è purtuttavia innegabile l’affinità tematica che li accomuna in un percorso – poetico e metapoetico insieme – di cui la
lezione leopardiana è matrice determinante ma anche soglia oltre cui procedere
nella ricerca del senso di un linguaggio e di una parola poetica che, singolarmente, in Ungaretti sembra prendere avvio proprio là dove in Michelstaedter si interrompe, nello stesso «abisso» da cui per Ungaretti si sprigiona la «limpida meraviglia» 85 della parola, nel «silenzio» da cui quella parola, per Ungaretti, deriva e in
cui, viceversa, e per sfuggirne il limite della contaminazione, tace la voce e la poesia di Michelstaed­­ter: «Non Argia ma Senia io t’ho chiamata, / per non sostar nel
facile riposo, / e la lingua la fiamma consacrata / con le parole non contaminò» 86.
1
C. Michelstaedter, Lo «Stabat Mater» di Pergolesi, in La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti,
critiche, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010, p. 214.
2
G. Debenedetti, Saggi critici. Prima serie, Milano, il Saggiatore, 1969, p. 66.
3
Cfr. S. Campailla, Introduzione. Il terzo regno, in C. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1987, p. 12: «Michelstaedter ci mette in una posizione imbarazzante. Non ha chiesto dei giudici di poesia, e nemmeno dei lettori; e li rifiuterebbe. È la nostra indiscrezione che ci autorizza».
4
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1982, p. 89.
5
Id., «Onda per onda batte sullo scoglio», in Poesie, cit., p. 74. Cfr. in proposito Id., La persuasione e la
rettorica, cit., pp. 70-71: «I bisogni, le necessità della vita, non sono per lui necessità, poiché non è necessario
che sia continuata la vita che, bisognosa di tutto, si rivela non esser vita. Egli non può prender la persona di
questi bisogni come sufficiente, se appunto essi non curano che il futuro […] non c’è pane per lui, non c’è
acqua, non c’è letto, non c’è famiglia, non c’è patria, non c’è dio – egli è solo nel deserto, e deve crear tutto
da sé […]. Poiché quelli che il bisogno gli addita, quelli sono il suo stesso bisogno […] quelli non li potrà mai
avere, […] poiché egli rincorrerebbe la propria ombra. / No, egli deve permanere […] seppur vuole ch’essi gli siano nel presente, che siano suoi veramente», e cfr. quindi A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione (1819, 1844), t. ii, Roma-Bari, Laterza, 1984, pp. 256-257: «Mentre la scienza, tenendo
dietro all’incessante e instabile flusso di cause ed effetti […] ad ogni mèta raggiunta viene di nuovo sospinta sempre più lontano e non mai può trovare un termine vero, né un pieno appagamento, […] l’arte all’op-
posto è sempre alla sua mèta. Imperocché ella strappa l’oggetto della sua contemplazione fuori dal corrente flusso del mondo e lo tiene isolato davanti a sé. E quest’oggetto singolo […] diviene per lei un rappresentante del tutto, un equivalente del molteplice infinito nello spazio e nel tempo: a questo singolo ella s’arresta: ella ferma la ruota del tempo: svaniscono per lei le relazioni: soltanto l’essenziale, l’idea, è suo oggetto».
6
C. Michelstaedter, Il dialogo della salute e altri dialoghi, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi,
1988, p. 58.
7
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 256.
8
Ibid., p. 218.
9
Ibid., p. 256.
10
F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, in Werke in Zwei Bänden, i, München, Carl Hanser Verlag,
1967, p. 37 e si veda anche la trad. italiana di La nascita della tragedia in Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di G. Colli, M. Montinari, v. iii, t. i, Milano, Adelphi, 1972, p. 49: «il simbolismo cosmico della musica
[…] si riferisce simbolicamente alla contraddizione e al dolore originari nel cuore dell’uno primordiale».
11
D. Campana, Storie ii, in Id., Canti Orfici e altri scritti, a cura di E. Falqui, Firenze, Vallecchi, 1966,
p. 334.
12
Cfr. C. Michelstaedter, Era il paradiso terrestre, in Id., La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010, p. 151: «C’era una volta un paese fortunato, dove
la terra produceva alle braccia volonterose i suoi doni più abbondanti della stessa speranza, dove gli uomini
erano forti e laboriosi, le donne sane e fiduciose, dove l’aria era mite, l’acqua esuberante, gli animali robusti
e domestici. Era il paradiso terrestre».
13
S. Corazzini, La morte di Tantalo, in Id., Poesie edite e inedite, a cura di S. Jacomuzzi, Torino, Einaudi, 1968, p. 159.
14
Ibid.
15
Ibid., p. 160.
16
C. Michelstaedter, «Che ti valse la forte speranza», in Id., Poesie, cit., p. 50.
17
Cfr. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 420: «il più delle volte vogliamo sottrarci alla conoscenza […] che il dolore è essenziale alla vita, e quindi non dal di fuori flui­sce in noi:
bensì ciascuno ne porta nel suo proprio interno l’inesauribile sorgente» e cfr. anche ibid., p. 410: «Ciascuno
ritroverà facilmente nella vita dell’animale le stesse condizioni, soltanto più deboli, espresse in gradi diversi; e, guardando anche la sofferente animalità, avrà di che convincersi abbastanza che sostanzialmente ogni
vita è dolore». Appare perfino ovvio ricordare in proposito i versi conclusivi del leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: «Forse in qual forma, in quale / Stato che sia, dentro covile o cuna, / È funesto a chi nasce il dì natale».
18
Cfr. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 410: «Nella stessa misura dunque, onde la conoscenza perviene alla chiarezza, e la conscienza si eleva, cresce anche il tormento, che raggiunge perciò il suo massimo grado nell’uomo; e anche qui tanto più, quanto più l’uomo distintamente conosce ed è più intelligente. Quegli, in cui vive il genio, soffre più di tutti».
19
C. Michelstaedter, [I figli del mare], in Id., Poesie, cit., p. 80.
20
Id., «Che ti valse la forte speranza», cit., p. 50.
21
Id., [A Senia], ibid., p. 88.
22
Id., «È il piacere un dio pudico», ibid., p. 77 e cfr. in proposito Id., Il dialogo della salute, cit., p. 46:
«Già dunque quando si parla comunemente “dei piaceri” come di posizioni determinate che danno piacere,
siamo ormai nella posizione ammalata: e andiamo a cercare il piacere per sé, a sfruttare la nostra posizione
verso una cosa per avere un sapore che in quanto lo andiamo a cercare non lo abbiamo più».
23
Ibid., pp. 59-60 e cfr. anche in proposito p. 72: «E il dio gioisce della privazione che la paura impone
e della rovina che l’odio produce, e li fa battere nella perpetua inimicizia con vicendevole danno, e li assoggetta all’inimicizia delle altre cose della natura, e infine del tutto li travolge. E poiché essi via pur sempre si
riilludono, ogni limitazione del proprio creduto possesso […] tutto trascende la loro realtà come la stessa morte e fa loro soffrire nella vita il dolore della morte».
24
Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 420.
25
S. Corazzini, Scena comica finale, in Id., Libro per la sera della domenica, in Id., Poesie edite e inedite, cit., p. 151.
26
Id., Bando, ibid., p. 152.
27
Ibid., p. 155.
28
C. Michelstaedter, «Cade la pioggia triste senza posa», in Id., Poesie, cit., p. 44.
102
103
note al testo
maria carla papini
Id., Aprile, ibid., p. 65.
Ibid., p. 66.
Id., «Amico – mi circonda il vasto mare», ibid., p. 52.
32
Ibid.
33
Ibid., p. 73.
34
Ibid.
35
Ibid., p. 52.
36
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 85.
37
Ibid., p. 86.
38
Id., Il canto delle crisalidi, in Id., Poesie, cit., p. 54 e cfr. anche «Ognuno vede quanto l’altro falla»,
ibid., p. 75: «Ché tale è la sua sorte: / col suo filo sperar vita tramare / e con la speme giungere alla morte».
39
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 55.
40
Cfr. la prosa I nomi, in Id., La melodia del giovane divino, cit., pp. 65 ss.
41
Cfr. Id., La persuasione e la rettorica, cit., pp. 87-88: «In ogni punto nell’attualità della sua affermazione c’è la vicinanza delle cose più lontane. […] Perciò ogni sua parola è luminosa perché, con profondità di
nessi l’una alle altre legandosi, crea la presenza di ciò che è lontano».
42
Cfr. Id., Delle particelle avversative, in Id., La melodia del giovane divino, cit., pp. 121 ss.
43
Id., Aprile, cit., p. 64.
44
Id., Risveglio, ibid., pp. 69-70.
45
Cfr. Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 165: «Così fa l’uomo nella società: il segno convenuto egli
lo trova nella tastiera preparata come una nota sul piano. E i segni convenuti si congiungono in modi convenuti, in complessi fatti. Sul piano egli suona non la sua melodia – ma le frasi prescritte dagli altri».
46
Id., [Alla sorella Paula], in Id., Poesie, cit., p. 72.
47
Cfr. Id., Nostalgia, ibid., p. 60: «vuoto il presente, vuoto nel futuro / senza confini ogni presente».
48
Cfr. Id., [Alla sorella Paula], cit., p. 72: «cit. dal ?????», «E baci e doni e la mensa imbandita, / dolci
parole in copia e dolci cose, / liete promesse e guardi fiduciosi / faccian chiara la stanza famigliare / facciano schermo alla notte paurosa…» e cfr. in proposito Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 101: «Il sistema
dei nomi tappezza di specchi la stanza della miseria individuale, pei quali mille volte e sempre avanti infinitamente la stessa luce delle stesse cose in infiniti modi è riflessa».
49
Ibid., p. 72.
50
Cfr. E. Montale, «Forse un mattino andando in un’aria di vetro», in Id., Ossi di seppia, in Id., L’opera
in versi, a cura di R. Bettarini, G. Contini, Torino, Einaudi, 1980, p. 40: «ed io me n’andrò zitto / tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto».
51
Michelstaedter, [Alla sorella Paula], cit., p. 72 e cfr. in proposito la lettera a Nino Paternolli datata
Gorizia 11 agosto 1910 in Id., Epistolario, a cura di S. Campailla, nuova edizione riveduta e ampliata, Milano, Adelphi, 2010, p. 469: «Quanto deserto c’è ancora perché io giunga al mare!».
52
Id., [A Senia], cit., p. 85.
53
Id., [I figli del mare], cit., p. 79.
54
Cfr. ibid., p. 80: «E la vasta voce del mare / al loro cuore soffocato / lontane suscitava ignote voci, /
altra patria altra casa un altro altare / un’altra pace nel lontano mare».
55
Ibid.
56
Ibid., p. 81.
57
Cfr. G. De Chirico, Sull’arte metafisica, in «Valori Plastici», 4-5, 1919, in Il meccanismo del pensiero.
Critica, polemica, autobiografia 1911-1943, a cura di M. Fagiolo, Torino, Einaudi, 1985, pp. 86-87: «L’opera
d’arte metafisica è quanto all’aspetto serena; dà però l’impressione che qualcosa di nuovo debba accadere
in quella stessa serenità e che altri segni, oltre quelli già palesi, debbano subentrare sul quadrato della tela.
Tale è il sintomo rivelatore della profondità abitata. Così la superficie piatta d’un oceano perfettamente calmo ci inquieta non tanto per l’idea della distanza chilometrica che sta tra noi e il suo fondo quanto per tutto lo sconosciuto che si cela in quel fondo».
58
E. Montale, Mediterraneo, in Id., Ossi di seppia, cit., p. 54. Montale, recensendo su «Pegaso», i, 8,
agosto 1929, i Saggi critici. Serie prima, di G. Debenedetti, fa riferimento al saggio, ivi contenuto, su Michelstaedter (cfr. E. Montale, Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, t. i, Milano, Mondadori,
1996, p. 371); un ulteriore riferimento allo scrittore goriziano è presente nella recensione a L’homme révolté di A. Camus, pubblicata con il titolo L’uomo in rivolta sul «Corriere della Sera» del 9 febbraio 1952: cfr.
Montale, Il secondo mestiere, cit., p. 1337: «Il saggio trattava essenzialmente del suicidio, considerato come
29
30
31
104
l’opera in versi di michelstaedter e la poesia del primo novecento
l’unico vero problema della filosofia. Tema non nuovo, già svolto, e con che rigore, dal Michelstaedter, che
arrivò fino in fondo alle sue conseguenze e si dette la morte volontariamente»; il nome di Michelstaedter
è quindi accomunato da Montale a quelli di alcuni esponenti del gruppo vociano nel necrologio pubblicato sul «Corriere della Sera» il 2 novembre 1957 con il titolo Clemente Rebora si è spento a Domodossola: cfr.
Montale, Il secondo mestiere, t. ii, cit., p. 2090.
59
Ibid., p. 59.
60
Ibid., p. 52.
61
Michelstaedter, «Amico – mi circonda il vasto mare», cit., p. 52.
62
Ibid.
63
Ibid., p. 53.
64
Id., «Onda per onda batte sullo scoglio», cit., p. 74.
65
Id., «Amico – mi circonda il vasto mare», cit., p. 52.
66
Id., «Onda per onda batte sullo scoglio», cit., p. 74.
67
Ibid., p. 73.
68
Id., [A Senia], cit., p. 90.
69
Id., «Onda per onda batte sullo scoglio», cit., p. 73.
70
G. Ungaretti, Finale, in Id., La Terra Promessa, in Id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura e con un
saggio introduttivo di C. Ossola, Milano, Mondadori, 2009, p. 294.
71
Cfr. Id., Canzone, in Id., La Terra Promessa, cit., p. 282: «Non distrarrò da lei mai l’occhio fisso».
72
Michelstaedter, [I figli del mare], cit., pp. 81-82 e cfr. in proposito la lettera a Emilio Michelstaed­­ter,
datata [Pirano] 2-3 settembre 1910, in Epistolario, cit., p. 472: «Il porto non è dove gli uomini fanno i porti
cfr. cit. in Pierangeli a riparo della loro trepida vita; il porto per chi vuole seriamente la vita è la furia del mare perché egli possa
regger diritto e sicuro la nave verso la meta».
e Pieretti
73
G. Ungaretti, Secondo discorso su Leopardi, in Id., Vita d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di M. Diacono, L. Rebay, Milano, Mondadori, 1974, p. 472.
74
Cfr. ibid., p. 484: «Il Leopardi sente che c’è un segreto, ma è inviolabile, e solo può concepirsi e esprimersi per espedienti approssimativi: “Non solo” annoterà nello Zibaldone il 4 gennaio 1821 “la facoltà conoscitiva, o quella di amare, ma neanche l’immaginativa è capace dell’infinito, o di concepire infinitamente, ma solo dell’indefinito, e di concepire indefinitamente”».
75
Ibid., p. 469.
76
Ibid., p. 484.
77
Michelstaedter, [I figli del mare], cit., p. 81.
78
Cfr. Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 99: «con parole significano quanto non sanno e di cui
hanno bisogno per lenire il dolore – o rendersi insensibili al dolore: ogni parola contiene il mistero – e in
queste s’affidano, di parole essi tramano così un nuovo velo tacitamente convenuto all’oscurità».
79
Cfr. D. Campana, Il tempo miserabile consumi, in Id., Quaderno, in Id., Canti Orfici e altri scritti, cit.,
p. 160: «O Morte o morte vecchio capitano / Ischeletrito stendi le falcate / Braccia e portami in stretta disperata / Verso le stelle».
80
Michelstaedter, [I figli del mare], cit., p. 83.
81
Id., [A Senia], cit., p. 88 e cfr. ibid., p. 86: «perché possiamo un giorno fiammeggiar / liberi e uniti al porto della pace».
82
D. Campana, Poesia facile, in Id., Quaderno, cit., p. 176. Si noti inoltre come i versi campaniani sembrino preludere a quelli della Preghiera ungarettiana: «Quando mi desterò / dal barbaglio della promiscuità / in una limpida e attonita sfera // Quando il mio peso mi sarà leggero // Il naufragio concedimi Signore / di quel giovane giorno al primo grido» (cfr. G. Ungaretti, L’Allegria, in Id., Vita d’un uomo. Tutte le poesie, cit., p. 135.
83
Cfr. Michelstaedter, [A Senia], cit., p. 86: «E l’occhio stanco e ardente la tenèbra / pur mira densa e
inesorata quale / si chiuse innanzi all’antico cantore / che a Euridice si volse ed Euridice / nella notte infernale risospinse» e cfr. quindi Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 106: «Egli cerca quello che già non è
più nel punto che lo cerca. Euridice che gli dei infernali concessero ad Orfeo, era il fiore del suo canto, del
suo animo sicuro. Quando egli nell’aspra via e oscura verso la vita, si volse, vinto dalla trepida cura, già Euridice non era più».
84
Id., [A Senia], cit., p. 89.
85
G. Ungaretti, Commiato, in L’Allegria, cit., p. 96.
86
Id., [A Senia], cit., p. 93.
105
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
Dalla distanza di un secolo guardiamo oggi a Carlo Michelstaedter. Un secolo
breve e denso che egli non ha vissuto ma che ha precorso a vario titolo e secondo
modi talvolta eccentrici. Per circa sessant’anni, infatti, la fatale categoria dell’anticipazione ha fatto di Michelstaedter il precursore di movimenti e correnti del Novecento. Una distorsione ermeneutica talvolta in buona fede – penso ai casi di Gaetano Chiavacci e Vladimiro Arangio-Ruiz –, alimentata dal nobile proposito di
rendere il loro «grande amico» digeribile dalla cultura italiana, acclimatabile in
una tradizione in cui aveva cercato con ostinazione di entrare e da cui era rifuggito con desolazione e disincanto. Gli amici ed editori di Carlo erano al contempo dioscuri dell’attualismo. Arangio-Ruiz fu vicedirettore della Normale di Pisa
in anni in cui direttore della scuola era Giovanni Gentile. Chiavacci si laureò in
filosofia con Gentile nel 1921 e fu condirettore del «Giornale critico della filosofia italiana»; sulla rivista gentiliana pubblicò nel 1924 il suo primo contributo critico su Michelstaedter, con buone probabilità rifiutato l’anno prima da Benedetto Croce per la sua «Critica» 1. Entrambi furono docenti all’università di Firenze
(Arangio-Ruiz vi insegnò Storia della filosofia e Chiavacci Filosofia teoretica), vale a dire nell’istituzione che era stata teatro del loro incontro con l’amico prematuramente e tragicamente scomparso. A sgombrare il campo se non da tutti, almeno dai più insidiosi fraintendimenti nonché da alcune mitologie, provvede, da
ormai circa un quarantennio, la cura editoriale delle principali opere michelstaedteriane di Sergio Campailla.
Ma, con la distanza del secolo che ormai ci separa da lui, si può dichiarare
chiuso il “caso” Michelstaedter, vale a dire superata la condizione di eccezionalità
che ha fatto di lui un’anomalia della nostra cultura? Molte componenti della sua
formazione, a partire dal retroterra ebraico, tenderebbero a farlo escludere. «Ci
sono degli uomini che sono dei mostri, che si sono liberati del tutto dal loro tempo e dagli altri tempi e fanno la disperazione degli storici» 2 : sono le parole di Michelstaedter a favore degli uomini che riescono postumi, che sfuggono dai criteri compilativi perché appartengono a una storia dell’acerbo (ha notato Pietro Piovani) che come tale non è storicizzabile 3. E sono queste alcune delle categorie interpretative (l’inattualità, l’essere postumo, l’acerbo), aperte e incomplete quanto si vuole, ma inclini a tollerare il peso dell’eccezionalità senza cedere a contraffatte normalizzazioni.
Michelstaedter ha fatto e fa la disperazione degli storici. Fa però la gioia di
chi nella sua incompiuta opera cerca più di un criterio storiografico: partono infatti dalle sue pagine fermenti che si irradiano per tutto il Novecento. Per questo motivo la relazione che lega questa compiuta e tragica esistenza al suo tempo
e alla cultura contemporanea ancora rimane la questione più avvincente di tutta
la critica michelstaedteriana. Un aspetto della questione riguarda il recupero tipicamente novecentesco della filosofia antica, qui investigato con particolare riferimento a Platone, la cui presenza nella pagina michelstaedteriana dà vita da un lato a un platonismo estetico e per certi versi estetizzante, dall’altro a un antiplatonismo teoretico. La presenza di Platone nell’opera di Michelstaedter è «ambigua
e lacerante» 4 : il pensatore antico è da un lato infatti l’apportatore di salus, dall’altro è l’iniziatore della condizione speculativa, della vita teoretica che divide l’interezza della persuasione; il testimone di una vita dell’assoluto e nell’assoluto e il
padre della «repubblica razionale» che si apre alla storia.
La lettura michelstaedteriana di Platone è una pagina integrale del Novecento filosofico. Un secolo che è stato, come il nostro autore, insieme platonico e antiplatonico: Michelstaedter appartiene alla genia di coloro che si sono sentiti platonici – dal momento che per loro il platonismo è principalmente una Stimmung –
in un tempo che platonico non è. Il suo secolo si apre infatti con il tragico annuncio nietzschiano della morte del platonismo e non rinuncia, già a partire da Nietzsche, alla ricerca di un valore assoluto e al ristabilimento di nuove “filosofie del
valore” che soppianteranno, con gesto tipicamente platonico, princìpi ormai desueti. Il platonismo michelstaedteriano è con tutta evidenza percorso da nuance
nietzschiane – penso in particolare alla valenza del Platone educatore della gioventù. Eppure una distanza siderale lo separa da Nietzsche quando pronuncia,
per esempio, un diverso giudizio su Socrate, del quale difende la tenacia del valore interamente razionale, e quando è costretto a rovesciarsi suo malgrado nell’antiplatonismo, in nome di un ideale che a partire dal tardo Platone, sedotto dalla
contingenza, vede vacillare 5.
Nel disegno antiplatonico di Michelstaedter ricorrono alcune affinità con il
modello heideggeriano che ha fatto del platonismo una «figura archetipica della
metafisica», costretto a registrare una svolta interna all’essere e una storia diver-
106
107
La repubblica teoretica.
La variante michelstaedteriana
dell’antiplatonismo contemporaneo
di Rosalia Peluso
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
sa della verità nel destino del disvelamento 6. Anche il Platone michelstaedteriano
è a suo modo una figura epocale, tragicamente arrendevole alla malattia del tempo e all’ansia di accasare il relativo nei templi dell’assoluto. Però, come ha scritto Goethe, le affinità diventano interessanti quando producono separazioni: e anche nel caso del confronto con Heidegger, del quale troppo spesso e talvolta in
modo scorretto Michelstaedter è stato salutato come anticipatore, vanno segnalate le differenze che meglio rendono l’originalità della voce del nostro autore.
Certamente entrambi condividono un’impostazione filosofica antintellettualistica centrata in particolare sulla nascita della modernità e sulla frattura di soggettivo e oggettivo: ed è singolare che ritorni nei due pensatori l’accostamento in chiave metastorica di cartesianesimo e platonismo. A differenza di Heidegger, tuttavia, nel quale è dominante una tendenza antifilosofica e antimetafisica, il platonismo michelstaedteriano decade quando abbandona la pratica dell’esercizio di
morte al mondo che era la filosofia socratica, eraclitea e parmenidea: testimonianze del verbo persuaso che, scrive Michelstaedter, da Platone e non da altri ha potuto apprendere 7.
Prima, però, di entrare nel vivo della questione, è necessario fare un passo indietro e scoprire le ragioni di fondo che hanno condotto il nostro giovane autore
a maturare la sua variante dell’antiplatonismo contemporaneo.
e la rettorica: la più letta tesi di laurea d’ogni tempo, è stato opportunamente notato, ma anche il più antiaccademico tra i lavori per l’accademia.
La presenza di Platone, che pure agirà sui motivi dell’antiaccademismo michelstaedteriano, è particolarmente significativa nel carteggio tra Carlo e l’amico
Enrico “Rico” Mreule, il quale ha occupato, tra tutti coloro che hanno accompagnato Michelstaedter nella sua breve esistenza, un posto di riguardo. Ne dà conferma per esempio il ruolo di protagonista che Mreule si vede assegnato nel Dialogo della salute, oppure il riconoscimento di Carlo quando gli scrive, in greco, parafrasando e risemantizzando la celebre definizione della διάνοια che si legge nel
Teeteto e nel Sofista di Platone: «il dialogo dell’anima mia è dialogo con se stessa e con te» 11. Se Rico è l’altro del silenzioso soliloquio michelstaedteriano, Platone si avvia a essere tra i due, nella lontananza, il termine medio dei loro scambi epistolari 12.
Rico era partito, alla fine del 1909, per l’«altro mare», cioè per il regno della persuasione e perciò appariva ebbro della «semplice e libera vita» che a Carlo sembrava invece mancare 13. All’amico lontano, scrivendogli per l’ultima volta, Michelstaedter confessa che, ormai «malato nell’anima e impigrito nel corpo»,
non spera più di poter dar sfogo alla voce che egli aveva creduto di poter far risuonare con entusiasmo e di essersi ridotto a «scrivere senza convinzione parole
vuote tanto per poter presentare carta scritta». Mentre Carlo sprofonda nella disperazione che nasce dalla parola atrofizzata, le parole di Rico «si son fatte azione!»: così, con amarezza, logorato nel corpo e nello spirito, si congeda dall’amico nel giugno 1910 14.
L’Epistolario, tuttavia, ci restituisce due importanti documenti datati 14 aprile e 13 giugno 1909 che testimoniano un interesse costante per Platone, oltre che
una consolidata pratica dialogica su temi platonici e non solo. La filosofia era sempre stata al centro dei conversari tra Rico e Carlo, fin dagli anni dello Staatsgymnasium e in seguito durante i momenti di rifugio nella soffitta dell’altro componente del trio michelstaedteriano, Nino Paternolli 15. Nell’aprile del 1909 l’episodio dell’«amicizia per un cane» 16 narrato in greco da Carlo e tradotto in latino da
Mreule fornisce lo spunto per una meditazione intorno all’intendimento platonico della “teoria”. Michelstaedter tira in ballo il celebre giudizio dell’anima nuda
del Gorgia platonico (523e), dove vien detto che solo il «nudo contempla il nudo»
(γυμνὸς γυμνὸν ϑεωρεῖ), e il luogo della Repubblica (486a) dove si parla della «visione di tutto il tempo, di tutto l’essere» (ϑεωρία παντὸς χρόνου, πάσης οὐσίας).
La presenza di Platone in Michelstaedter può essere indagata a diversi livelli,
il primo dei quali è costituito dalle testimonianze epistolari, il secondo dalla tesi di laurea e dal suo corredo critico. Dall’Epistolario si apprende che Michelstaedter comincia lo studio sistematico di Platone nel 1907, quando decide di chiedere a Girolamo Vitelli, docente di Letteratura greca all’Istituto di Studi Superiori
di Firenze, una tesi sui concetti di persuasione e rettorica in Platone e Aristotele 8.
L’anno del suo incontro “accademico” con Platone è un anno, scrive alla sorella
Paula, pieno «di lavorio e di svolgimento interno» che gli ha portato, tra immense crudeltà, «un contributo di vita forte, di vita intensamente vissuta» 9. Nell’aprile di quell’anno si era tolta la vita Nadia Baraden, evento del quale Carlo si sente
in qualche modo responsabile e che accelera la ricerca già in atto di un equilibrio
di forze allora mancante 10.
Mentre compone i suoi studi d’occasione (le tre tesine degli Scritti scolastici)
cresce in Michelstaedter un disagio per il lavoro compilatorio che avrà ricadute
anche di natura organica. Gli impegni obbligati dalla formazione universitaria si
collocano all’origine dell’antiaccademismo michelstaedteriano che, mentre in un
primo tempo si era espresso, con spirito goliardico e leggero, nei “tipi” delle sue
caricature, ora, con il conforto di una più matura coscienza, reclama serie ragioni
teoretiche di fondo, quelle stesse che stanno per prendere corpo nella Persuasione
108
Per lui – Platone, scrive Michelstaedter – il conoscere filosofico è sempre un ϑεωρεῖν τι
della γυμνὴ ψυχή; la filosofia è παντὸς ϑεωρία. – Aristotele usa ϑεωρεῖν assoluto: philosophieren!! speculare ins Blaue hinein, oppure ϑεωρεῖν ὐπέρ τινός, è lo studio, il lavoro speculativo su qualche cosa; la ϑεωρία diventa ὐπέρ τινός anch’essa. – Non ti pare che basti questo
per definire la differenza fra il maestro e il suo miserabile scolaro 17?
109
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
Teoria è in Platone “vista” e “spettacolo”, manifesta l’anima autenticamente filosofica e a essa inerisce come sua più intima natura. La corrispondenza del simile al simile (il nudo che vede e giudica un altro nudo), il dialogo dell’anima con
se stessa, sono tutte immagini dell’unità e dell’identità dell’antica persuasione,
non ancora dimidiata dalla moderna frattura di soggetto e oggetto: una modernità, sottolinea Michelstaedter, che nascerebbe retroattivamente con il rettorico
Aristotele. L’opera aristotelica dà infatti sistemazione all’ideale della vita teoretica già inaugurato dal tardo Platone e che qualifica il sommo grado dell’esistenza,
quello che non ha altro scopo se non trascorrere il tempo in una fittizia dimensione oltretemporale separata dalle cose e, proprio in virtù di questa separazione,
creduta il luogo idoneo dove poter riflettere sulle realtà mondane con oggettività.
Nella lettera del 13 giugno dello stesso anno Carlo torna al «divino Platone
[che] merita d’essere amato tanto quanto Leopardi» 18 : accostamento che non piace però a Rico perché – scrive nella sua risposta – «Platone ha cercato molto bene,
ma non ha trovato» 19. Nel frattempo aggiunge una lunga nota sul significato del τί
ἐστιν che convince pienamente Carlo, il quale gli risponde:
di associazione per scopi particolari e di comunità umana nel senso più ampio del
termine (la città), tiene impegnato Michelstaedter negli ultimi mesi di vita e di lavoro. La platonica invenzione del macrocosmo e la contestuale fondazione della
πόλις, descritte con brio e ironia nell’Esempio storico della Persuasione ed esaminate nel dettaglio e con rigore nella ii Appendice critica, tengono a battesimo ogni
derivata ϰοινωνία ϰαϰῶν: costituiscono per meglio dire quella repubblica dei princìpi, repubblica perciò teoretica che funge da archetipo a ogni umano consorzio.
Non è un semplice caso, allora, dettato dall’opportunità accademica, che per tutto il 1909 a occupare un posto fisso e di riguardo sulla scrivania michelstaedteriana sia Platone, colui che obtorto collo verrà a ricoprire un ruolo di primo piano
nei toni e nei modi della polemica di Michelstaedter contro l’accademia, contro
la società ma, più in generale, contro una visione dell’essere che, a partire dal tardo Platone, da dialoghi come il Parmenide e il Sofista, diviene un “essere-con”: essere in-relazione, molteplice, dimidiato, frazionato, smembrato, squartato 23. Scrivendo la sua tesi di laurea, leggendo Platone, Michelstaedter si trova dinanzi le viscere dell’essere e la radiografia del proprio tempo.
In tutti i dialoghi Platone domanda τί ἐστι questa cosa? o τί ἐστι quest’altra? E «questa o quest’altra cosa», sia la virtù, sia il coraggio, sia l’amicizia ecc. in fondo non è che
l’assoluto, l’ἀγαϑόν. È come se chiedesse «in quale delle cose conosciute è questo ἀγαϑόν».
Il τί dovrebbe esser sempre l’indicazione di limiti fra le cose conosciute, la determinazione, la definizione. E questa è per me la meraviglia quando leggo Platone, di veder la sicurezza con cui ogni volta, da qualunque parte prenda la vita, domanda sempre τὸ ὄν e nega sempre la vita come un μὴ ὄν. È come se chiedesse τί ἐστι τὸ ὄν; = τί ἐστι; (assolutamente) = ἐστι τί 20 ;
Per ammissione dello stesso Michelstaedter e come ben testimoniano le due
lettere a Mreule appena esaminate, la stesura della tesi costituisce l’occasione per
aprire squarci sul volto nascosto e obliato della verità. Non basta però questa consapevolezza per evitare che, nella ricaduta nel quotidiano, Carlo si percepisca al
massimo come «“uno studente che fa la tesi”» 21. Proprio la tesi diverrà allora il
luogo in cui le figure del platonismo e dell’antiplatonismo sosterranno la critica
ontologica, antropologica e sociologica del suo giovane autore.
Un tragico disincanto è intanto sceso negli occhi e nel cuore del ventiduenne Michelstaedter 22 : seppur limitato a quel ruolo di studente che gli stava tanto
stretto, con le parole “inopportune” e “sconvenienti” – ma per noi fin troppo mature e postume – del suo elaborato finale, dall’osservatorio “mittelitaliano” della
sua Gorizia trova la condizione d’animo ideale per enucleare la propria critica alle «comunelle di malvagi» di cui si era fatto un’idea chiarissima durante gli anni
della sua formazione fiorentina. La critica della ϰοινωνία, nella duplice accezione
110
La persuasione e la rettorica non può però essere ridotta al rango di mero atto
di accusa contro la filosofia platonica. Nelle pagine del principale scritto michelstaedteriano si possono individuare due distinti livelli di lettura perché, a un atteggiamento più indulgente nei confronti del Platone che si ammala di contingenza e di relativo, tiene dietro invece l’apparato critico in cui è combattuta la «lotta contro Platone» che Nietzsche aveva già dichiarato qualche anno addietro 24.
Stupisce ogni volta aprire quest’opera che la critica ci presenta come un elaborato sui concetti persuasione e rettorica in Platone e Aristotele e notare in prima
battuta, assieme alla maturità del risultato, l’ingombrante assenza dei due “soggetti”. Eppure, senza Platone e Aristotele, senza una loro conoscenza seria e rigorosa, le pagine sulla persuasione e soprattutto sulla rettorica non sarebbero state
scritte o forse non sarebbero state così vibranti, lucide e nietzschianamente “inattuali” 25.
Platone non è tra i protagonisti della persuasione: il suo nome non compare
infatti nell’essenziale elenco degli eroi persuasi della Prefazione alla tesi. È piuttosto un personaggio della drammaturgia michelstaedteriana, con quel suo incedere tormentato di grande tragico della filosofia, costretto suo malgrado a registrare tra le pieghe dei suoi discorsi un mutamento di determinazione dell’essere di
cui sembra ignorare la portata epocale e di cui non rimane traccia che ai margini
dei suoi testi. La dialettica di velamento e schiudimento che sembra caratterizzare il destino complessivo del platonismo – come noterà Heidegger – corrisponde
a un’occulta presenza di Platone nel tessuto concettuale della Persuasione, che al111
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
terna richiami teorici più o meno espliciti a originali e inedite rielaborazioni del
linguaggio platonico 26.
Il nome di Platone compare per la prima volta nel capitolo iniziale della tesi
michelstaedteriana dove, con brevi e asciutti tratti, si disegna la figura della persuasione: «eternità raccolta e ’ntera» (Petrarca), «tutto unico indiviso» (Parmenide) e infine «anima nuda nelle Isole dei beati», evidente rinvio al mito del giudizio delle anime dei morti narrato nel Gorgia (523a-524a) 27. Seguono più avanti un breve rimando al Fedro (255d) 28 e soprattutto tre citazioni tratte dall’Apologia (29a 29, 22d 30, 36c-d 31).
L’Apologia e il Gorgia sono senza dubbio gli scritti platonici più vicini a Michelstaedter; in particolare il Gorgia, e la sua persuasa figura della γυμνὴ ψυχή.
Non è un caso che il richiamo a quest’immagine si trovi incastonato tra i Vangeli di Luca e Matteo, quasi si trattasse di una laica «lieta parola della salute» 32. Il
dialogo platonico costituisce la letteratura primaria per un tesista che ha il compito di scrivere una dissertazione su persuasione e rettorica in Platone e Aristotele. L’inserimento dell’“anima nuda” nel catalogo dei sommi exempla della persuasione dimostra però un interesse per il dialogo che travalica l’occasione meramente accademica. In questa idea Michelstaedter trova infatti accarezzata l’ansia
e la ricerca d’assoluto che sorregge il Platone apostolico – degno di occupare un
posto accanto a Socrate e a Cristo 33 – e lo aiuta a elevarsi al di sopra della contingenza e della storia.
Tramandato con il sottotitolo περὶ ῥητοριϰῆς, il Gorgia è in prima istanza un
dialogo sulla rettorica che, in prospettiva del lavoro scolastico, interessa a Michelstaedter per la distinzione tra due concezioni di persuasione e rettorica. Esiste una pratica persuasione che è cosa diversa dalla «verità persuasiva» di Parmenide e degli altri dicitori di verità, i parresiasti che, come Socrate, non temono di
incontrare il fastidio della moltitudine (454e) 34. Ma esiste anche una possibilità
di appello per la rettorica, per la parola autentica che ripete il contenuto molesto,
inopportuno e sconveniente della persuasione. Opera di retorica sulla retorica, il
Gorgia è oltretutto un’anticipazione della buona novella che di lì a poco si sarebbe
diffusa per il mondo: prende infatti a cuore il senso della vita umana e ne discute
a tutto campo, chiamando a testimoni il terreno, con la sua concretezza etico-politica, e l’ultraterreno, con la sua simbologia mitica, e portando in primo piano il
tema che maggiormente dovrebbe qualificarla in entrambi i destini, la giustizia. Il
pieno possesso della giustizia corrisponde a ciò che nell’opera platonica è descritto come un atto di denudamento: occorre svestirsi, come le anime del mito, liberarsi del velo della vita. Platone chiede, nel Gorgia (523d) e nel Fedone (66a), di liberarsi, «in un parola, di tutto il corpo».
La polemica socratico-platonica contro la rettorica, usurpatrice del vero significato della giustizia tanto da trasporla sul terreno di scontro dei tribunali o del-
le assemblee politiche, segna la distanza dallo spirito del tempo (sofistico o borghese che sia) e corrisponde, per Michelstaedter, a una contesa epocale che deve trasferirsi dal piano della storia a quello della metastoria: solo qui trova realizzazione la giustizia non viziata da coordinate umane. Il gioco di parole tedesche
Recht/gerecht (Alle haben Recht – niemand ist gerecht), spesso ripetuto negli scritti michelstaedteriani, sta a indicare che la mancanza di possesso del valore assoluto (il Recht) esclude la «persona della giustizia», la possibilità di essere giusti
(gerecht) 35. La dimensione iperbolica della giustizia nel mondo rende pertanto le
proposizioni fondamentali dell’etica socratica inadeguate per il gusto inquieto e
per la richiesta disperata d’assoluto del giovane Michelstaedter. Ammonisce Socrate: è preferibile liberare se stessi anziché gli altri, subire ma non commettere
ingiustizia, essere in disaccordo e in contraddizione con il mondo piuttosto che
con se stessi 36. Ma questi principi appaiono al giovane e irrequieto pensatore relativi a un’etica da «uomo concettuale», da «homunculus» 37, un insieme di massime
del provvisorio, valevoli fintantoché dura la condizione provvisoria della vita 38.
L’ultimo tema platonico tratto dal Gorgia ricorre in una delle tesine di supporto alla Persuasione: è «l’analogia del corpo», ovvero «il prediletto punto d’appoggio della dialettica socratica» e di quella michelstaedteriana. Illumina il testo
l’analogia, stabilita nel Cratilo (400b-d) e ribadita proprio nel Gorgia (493a), tra
σῶμα e σῆμα, che arriva nel mezzo della contesa tra Socrate e Callicle, cioè durante il confronto tra due distinte concezioni di vita: la prima, informata al criterio
della giustizia e della filosofia, la seconda a quello della rettorica e dell’antifilosofia. L’asciuttezza della salute e l’incontinenza del caradrio 39. Socrate ripete a questo punto l’etimologia già stabilita nel Cratilo che ispira il suo “punto d’appoggio”
dialettico 40. Il corpo è sì la tomba dell’anima ma è anche il suo segno, il mezzo attraverso il quale l’anima può esprimere ciò che intende significare. L’analogia con
il corpo e il suo potere di significazione rappresentano il punto archimedico della dialettica socratica e si accordano con il principio prediletto di Michelstaedter,
quell’analogico portare a vedere le cose lontane come vicine che, massimamente
utilizzato da Platone, troverà nella sua opera tarda un diverso destino:
112
113
la vita elementare egli [Socrate] chiama naturalmente σῶμα (corpo), e la totalità della persona ψυχή (anima); se anche egli abbia a così chiare note affermata l’insufficienza dell’uomo e con tanta amarezza parlato della giustizia di Radamante, il giudice dell’anima ignuda che giudica le anime ignude; se anche a ognuno debba esser chiaro che egli dà valore
alla salute dei bisogni elementari solo come analogia al bisogno di persuasione; – pure è certo che da questo punto è incominciata la rettorica nella filosofia di Platone 41.
Il momento culminate della presenza di Platone nella Persuasione è documentato dall’Esempio storico, che è caricatura in prosa della filosofia dei massimi si-
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
stemi, tentativo di demitizzazione della rettorica filosofica, infine apologo, favola
costruita sul modello del mito platonico. Ciascuna parte dell’Esempio corrisponde alla divisione in paragrafi della ii Appendice critica, che si intitola appunto Note
alla triste istoria narrata in quelle pagine: l’abbandono della vita socratica, il macrocosmo, il riflesso del sole, la decadenza e il discepolo, che sono i cinque momenti essenziali di una parabola filosofica destinata a segnare per sempre il destino della filosofia.
In questa suggestiva allegoria Michelstaedter descrive una metafisica della
leggerezza, centrata sul viaggio mentale di Platone e dei suoi discepoli verso la
trascendenza. Il processo spirituale segna la nascita della “repubblica teoretica”,
che indica innanzitutto il macrocosmo platonico, insieme invisibile «luogo del
pensiero» 42 e visibilissima πολιτεία; e, secondariamente, l’atteggiamento teoretico platonico e aristotelico, traviamento dell’autentica via filosofica, che è invece la
via della persuasione di ascendenza parmenidea, eraclitea e socratica. La ϑεωρία
nasce dal contrasto tra il visibile e l’invisibile, essendo “vista” e “spettacolo”, come ha già notato Michelstaedter, e sinonimo di vita contemplativa, cioè dell’esistenza che si ritrae in un non-luogo dove il valore della fenomenicità è sospeso.
Questo contrasto, simbolo della lotta intestina fra teoria e politica, fra la volontà di essere inappariscente e la necessità di apparire sulla scena del mondo, è ben
espresso dalla definizione michelstaedteriana «repubblica razionale» 43 che introduce la critica al grande μηχάνημα platonico: macchina da guerra, meccanismo e
infine espediente, perché tutte queste cose è infatti il travestimento dell’aerostato che partecipa di leggerezza, di assoluto, ciò che ha peso e che patisce il relativo e l’accidentale.
Il pensiero teoretico nasce dall’escogitazione, dall’ingegnosità, dalla macchinazione che soppianta la «disperata devozione» 44 di Socrate per la libertà. È una
tecnica che consente di librarsi in volo senza abbandonare il corpo e la vita: corrisponde dunque a quel filosofare vivendo nel mondo come morti, che immaginava Platone nel Fedone (64a) 45. Raggiungere l’alto significa conquistare l’idea, autentica leggerezza, «punto di appoggio e slancio» 46, che concede a chi la conquista, cioè alle anime filosofiche, la «magnificenza e la visione – ϑεωρία – della totalità del tempo e dell’essere» 47.
Se attraverso l’allegoria parla il Platone michelstaedteriano, Aristotele, Ulisse
filosofico, dopo aver acquisito «una conoscenza minuziosa di tutti gli ingegni» 48,
contamina la leggerezza con le cose terrestri: esige dal maestro dialoghi compenetrati di «spirito aristotelico» che «di platonico non hanno più che le frasi fatte
del platonismo» 49. Prendono forma il Parmenide, il Sofista e il Politico. Michelstaedter saluta in Aristotele l’iniziatore di un sistema che «ancora vive fra noi, se pur
sotto nuove vesti»: e qui ha in mente probabilmente la scienza moderna e il mito positivistico dell’oggettività. L’inizio antico che ancora perdura nei tempi mo-
derni ha la sua chiave di volta nella mutazione della ϑεωρία in un ϑεωρεῖν ὐπὲρ πάσης οὐσίας, un operoso «teorizzar sulle cose» 50, speculazione, riflessione sull’essere.
Un tempo la ϑεωρία era come una finestra sull’essere che apriva squarci su «cose tanto più interessanti – amaramente interessanti» (com’è scritto in una lettera a Chiavacci 51), cioè sulla «deficienza dell’infinita varietà delle cose nell’infinito
tempo», e si faceva coscienza di questo deficĕre. Quella medesima visione si trova
in seguito soggiogata dall’istinto filopsichico e tramutata in una fabbrica di valori assoluti: la natura filosofica ha perduto ogni slancio e si è chiusa nella dogmatica costruzione e legittimazione del sistema 52. L’unica teoria filosofica, che è vista
sul tempo e sull’essere, si è spezzettata in molteplici ϑεωρίαι, in tante indagini particolari quante sono le partizioni del­­l’essere che si è a sua volta pluralizzato (questo è secondo Michelstaedter l’esito ontologico del Sofista).
L’ultimo riconoscimento al Platone d’un tempo è contenuto in questo passo:
114
115
Platone almeno usa ϑεωρεῖν sempre coll’oggetto diretto e ϑεωρία col genitivo; ma quando del ϑεωρεῖν uno si fa la vita, esso è attività sufficiente per sé stessa: assorbe in sé l’oggetto, diventa pregnante, e s’usa senza oggetto, o con l’oggetto indiretto 53.
Nel commento a questa affermazione Michelstaedter cita in nota alcune opere aristoteliche: la Politica (Γ ix, 1280b28) dove «ϑεωρέω [è] usato assolutamente»; quasi sempre è impiegato però «col περί», per esempio nella Metafisica (A iii,
983b33) e nelle Confutazioni sofistiche (xi, 172b6). Si afferma in questo modo il lavoro spirituale incardinato in quello che Michelstaedter definisce il «punto teoretico» 54, criterio per un sapere dimidiato e fallace cui già Platone ha dato inizio: è
la «vista vicina», «realismo ingenuo» che pretende di portare nella vicinanza le
cose lontane, ricorrendo a facili analogie quando il lontano si rivela davvero irraggiungibile 55. Questo criterio sorregge del resto le due grandi analogie della Repubblica, quella tra l’anima e la città e quella tra il sole e il bene, ed è indice di un
sapere che si afferma mediante un mutamento del ϑεωρεῖν: si rende necessaria una
torsione interna all’atteggiamento contemplativo che specula, riflette, teorizza
sulle cose. Occorre, in ultima istanza, l’uso «senza oggetto» o «con oggetto indiretto», dal momento che l’oggetto è stato già tutto assorbito nell’atto del contemplare. Il pensiero stesso è diventato pregno di vita ma nel senso, tutto dispregiativo, che ha prosciugato ogni vita e si è tramutato in un’attività autoreferenziale.
La vita contemplativa segna l’avvento di una frattura che manda il vivere e il
pensare lungo strade differenti. La critica a questa decisiva variazione storica che
agisce sulla futura filosofia occidentale non si arena però tra le secche di un’arida
contestazione antifilosofica. Al contrario, la visione della filosofia ridotta a «macchina che muove i concetti» 56, tramutata in un’industriosa e affaccendata occupazione, è il primo passo che consente a Michelstaedter di scorgere in lontananza,
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
quasi come una terra promessa, il ritorno a un’originaria purezza filosofica scevra
di tutti i dualismi (io e mondo, anima e corpo, soggetto e oggetto) che, fondandosi sulla superiorità della teoria, hanno l’obiettivo di separare la vita dal pensiero.
tre dialoghi registrano per Michelstaedter il momento in cui Platone viene a ferri corti con i maestri della persuasione, con Socrate e soprattutto con Parmenide,
con la sua integra e compatta visione dell’essere, «tutto unico indiviso» che abbiamo visto inaugurare la Persuasione. Platone è ormai lontano dal socratico uomo autarchico che non «fa il proprio dovere» a servizio della società, dall’Apologia che intima a chi è saggio di non temere la morte, e dal giudizio giusto del Gorgia, che esige un nudo dinanzi a un nudo. Egli si esercita, anche se soltanto per un
senile divertimento, non più a morire al mondo ma nella pratica delle distinzioni
e delle riunificazioni, nel­­l’agonistica dialettica che si spinge addirittura a sospendere la validità delle tesi sull’esistenza dell’uno e sulla non-esistenza del molteplice; si diverte, con l’infantile sussiego del giovane che crede di mettere in scacco i
più saggi vecchi con un semplice motto di spirito, a postulare un ipotetico parricidio per godere, seppur in forma relativa, di quel po’ d’aria irrazionale che penetra nella compattezza razionale dell’essere parmenideo.
Non stupisce allora se il Platone di Michelstaedter si trovi a un certo punto
rappresentato come l’annoiato re che, non sapendo più in che cosa consista l’essenza della propria regalità, la trasferisce in un fantoccio reale per poterla meglio
apprezzare 61.
Le Appendici critiche si aprono con un grido di battaglia: «con le parole guerra alle parole» 57. Dell’indulgenza e della levigatezza che dominavano le allegorie
dell’Esempio storico è rimasto ben poco. Con le armi spietate e feroci della filologia Michelstaedter raccoglie l’invito nietzschiano e dichiara guerra a Platone e al
platonismo. Si pone cioè sul versante della nietzschiana “filosofia dell’avvenire”
che ha il compito di sbarazzarsi delle imposture dei valori fintamente assoluti. E
diventa, con il suo gesto da guerriero dello spirito, cantore della modernità che
esige non a caso proprio l’iniziazione alle ragioni dell’antiplatonismo.
Michelstaedter struttura la sua polemica intorno a due questioni principali.
Svolge innanzitutto un’analisi dei principi della filosofia platonica per dimostrare come, attraverso i tardi dialoghi dialettici, si verifichi la «morte della filosofia
di Platone» 58. Questo evento è scandito in modo particolare attraverso tre tappe:
la morte dell’uno e il trionfo del molteplice (Parmenide); la morte del non-essere
e la conseguente affermazione logica e ontologica della differenza (Sofista); morte
infine del sistema filosofico e nascita della sapienza politica (Politico). A quest’ultima tappa si connette un altro tema centrale dell’antiplatonismo michelstaedteriano: la fondazione della πόλις, che diviene l’archetipo di ogni comunità umana
(Repubblica).
La questione veramente dirimente che segna come una frattura la filosofia platonica è l’assorbimento – dice Michelstaedter – del «veleno di quella infame piccola parola: ϰατά» 59 e «la tanto desiata facoltà della συμπλοϰή» 60 : la relazione e la
sintesi dialettica mandano a morire il messaggio puro della precedente speculazione platonica che era, come si è visto, un esercizio di morte al mondo e alle sue
possibilità di relazione e correlazione. Non vincolata dall’uno, che nel frattempo è andato a morire nel regno del molteplice che si chiama storia (costante e fatale tentazione dell’uomo Platone), la “piccola infame parola” concede all’essere
la possibilità di entrare in relazione con tutto (non-essere compreso). Dopo tante sottili distinzioni che aprono lacerazioni nella viva carne dell’essere stesso, ecco intervenire la sintesi a cucire arbitrariamente e in modo artificioso le differenze poste dal travaglio dialettico.
Gli esercizi aporetici del Parmenide, le diairesi del Sofista, le dicotomie del Politico sono ben altro che giochi: descrivono invece la “decadenza” di Platone e,
con lui, del pensiero greco. Da questi testi in poi il molteplice e la differenza irrompono nella filosofia, che, messa alle strette, può difendersene, cioè renderne
conto, soltanto lanciandosi in rappresentazioni dialettiche che sfiorano l’eristica. I
116
Così – scrive Michelstaedter – egli [Platone] non toglie τὸ ὄν dall’esistenza correlativa,
ché con quello se ne andrebbe la σοϕία; ma elimina per sempre l’espressione τὸ μὴ ὄν dal
campo della filosofia: facendovi entrare le stesse cose che col μὴ ὄν erano significate, sotto il nome più dignitoso di ἔτερον. Costituito questo ἔτερον a idea, è attribuita tacitamente
sostanza assoluta (cioè diritto d’esser detto) all’irrazionale. E per questo πόρος nei templi
sereni dell’assoluto si diffonde la nebbia delle mutazioni correlative. – Dai giochi atletici
del Parmenide τὰ πολλά esce nel Sofista colla palma vittoriosa: τὸ ἔν è morto per sempre e
con lui il postulato dell’onestà filosofica 62.
La morte della filosofia a mezzo della scienza politica trova il definitivo completamento nel macrocosmo platonico, cioè nella città della filosofia industriosa
e delle anime incamiciate rettoricamente, individui non più integri ma «policefali» 63. La πόλις di Platone diviene l’archetipo di ogni comunità perché riproduce
il meccanismo istitutivo nascosto al fondo di ogni umano consorzio 64. La platonica ϰοινωνία ϰαϰῶν nasce infatti quando il presupposto ineluttabile del “bisogna
vivere”, del δεῖ ζῆν, che è «principio della deficienza», trasvalutazione ragionevole
delle irrazionali necessità del vivere la «qualunque vita», incontra un fondamento razionale: è istituita così l’«organizzazione di necessità irrazionali», la «repubblica razionale» che non è altro se non il parto sensibilissimo dell’istinto di vita 65.
Gli ingranaggi della società subiscono, al pari di ogni organismo vivente, una
fondazione irrazionale che si insinua anche nei più reconditi meccanismi. L’ulti117
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
mo cimento antiplatonico di Michelstaedter ha per tema infatti lo smascheramento dell’illusione della giustizia terrena, che costituisce l’ultima resa di conti con il
Platone d’un tempo e con il Gorgia in special modo che così bene aveva postulato
la separazione di giustizia e mondo. La città giusta crea chiaramente «l’apparenza
della giustizia» 66 e la pone nel criterio del πράττειν ἑϰάστου τὰ ἑαυτοῦ (Repubblica,
433d), nello svolgimento del proprio oscuro ufficio al servizio del bene comune.
Il valore assoluto d’una volta, la giustizia fuori del tempo, è divenuto un criterio
della funzionalità e dell’efficienza del μηχάνημα. La nascita dello stato platonico
potrebbe pur originarsi dalla nobile intenzione di concedere ospitalità alle “anime nude”, ai filosofi che, perseverando nei loro esercizi di morte, si fingono in vita morti al mondo, ma a conti fatti si rivela tutt’altro. Le vie della negazione della
vita indicate nel Gorgia sono ormai superate e così «la Repubblica può parlare – al
massimo – d’una giustizia di banditi» 67.
la rivelazione. Chissà che l’arrogante etichetta di «buon proletario della filosofia»
che un irriverente “studente” affibbierà al maestro della moderna filosofia tedesca non sia l’implicita risposta al troppo severo giudizio kantiano che condannava
in anticipo anche le future suggestioni poetanti di un certo pensiero contemporaneo, alle quali fu sensibile lo stesso Michelstaedter 69.
È tuttavia Friedrich Nietzsche a rinfocolare l’antiplatonismo michelstaed­­
teriano. Nell’opera nietzschiana, infatti, il tema del Kampf gegen Plato, la lotta a
Platone e al platonismo, anche nella variante del cristianesimo, definito «platonismo per il “popolo”», serpeggia come un motivo dominante e una mania 70. Il platonismo è una malattia spirituale dell’Occidente cui Nietzsche dichiara guerra:
corrisponde al vizio del dogmatismo, ossia alla tendenza a non lasciar danzare in
libertà la verità per chiuderla in una rappresentazione dogmatica (Idea, Dio, Bene ecc.). Il platonismo è una maschera, l’errore più sublime e sofisticato elaborato dalla cultura europea.
Fiondarsi nei motivi teoretici che hanno segnato la genesi dell’antiplatonismo
michelstaedteriano ha comportato la sospensione del confronto tra questa variante e altre proposte antiplatoniche contemporanee. È il caso ora, in conclusione,
di tornare all’andamento comparativo del discorso per far emergere l’originalità della voce di Michelstaedter pur assiso tra gli antiplatonici del Novecento. Si è
già fatto cenno ai nomi di Nietzsche e di Heidegger, autori che più di altri si avvicinano alla proposta michelstaedteriana. Vale la pena però, anche se in maniera fugace, richiamare il modello kantiano che costituisce in qualche modo il crocevia dove lo spirito moderno incontra l’eredità platonica. Si è accennato prima a
un dato: la modernità esige il battesimo dell’antiplatonismo. Non è un caso che sia
proprio questo principio a trovarsi al centro della polemica antiplatonica di Kant.
Nello scritto del 1796 Di un tono di distinzione assunto di recente in filosofia
Kant definisce Platone il «padre di ogni Schwärmerei», archetipo cioè della mistica esaltazione, di quella filosofia dell’intuizione che egli vedeva ritornare in tempi recenti, in particolare nel periodo storico che segnò la fine delle belle illusioni
dell’Aufklärung, del rischiaramento delle menti, e del regno illuminato di Federico ii di Prussia 68. Quando la filosofia si sottomette all’inclinazione schwärmerisch
si fa pensiero oracolare e sentimentalistico, chiuso in una ricerca più estetica, poetica, piuttosto che logica e prosaica. Mette in scacco definitivo la ragione che si alimenta, invece che di folgoranti e improvvise intuizioni, del faticoso e lungo lavoro
del concetto e dell’onere di rendere partecipe chiunque, non una ristretta cerchia
di iniziati, delle conquiste della conoscenza. Il tono “di distinzione”, “da signori”
che serpeggia sempre nella filosofia corrisponde alla pretesa snobistica di chi trova ripugnante imparare e criticare e preferisce passare per le scorciatoie dell’intuizione intellettuale, abbandonare la ragione per farsi rapire dal sentimento o dal-
La mia filosofia – scrive Nietzsche in un celebre frammento del 1870-1871 – è un platonismo alla rovescia: quanto più lontano ci si mantiene da ciò che veramente è, tanto più
pura, bella e buona è la vita. La vita nell’apparenza come scopo 71.
118
A differenza di quel che si è visto in Michelstaedter, il rapporto che lega Socrate a Platone è qui completamente rovesciato: non si parla infatti di tradimento
platonico ma di traviamento socratico del «figlio più bello dell’antichità» 72. Non
è più Platone ad abbandonare la via socratica; è al contrario Socrate a corrompere il rampollo dei tempi antichi e a metterlo sulla strada delle astrazioni razionali dimentiche di vita. Il mondo greco dell’età socratica, già corrotto nei suoi fondamenti spirituali, doveva scegliere tra la rovina oppure deviare con Socrate verso l’“assurdamente razionale”. Scelse, inutile dirlo, quest’ultima strada, il cammino della ragione, e abbandonò la via dei sensi.
Socrate fu un equivoco; tutta la morale del miglioramento, anche quella cristiana, fu un
equivoco… La più viva luce del giorno, la razionalità ad ogni costo, la vita luminosa, fredda, cauta, cosciente, senza istinto, in contrapposizione agli istinti, fu essa stessa soltanto
una malattia, un’altra malattia – e non fu assolutamente un ritorno alla «virtù», alla «salute», alla «felicità»… Dover combattere gli istinti – questa è la formula della décadence 73.
Nel disegno nietzschiano Platone si vede assegnato un ruolo che risulterà centrale anche nella lettura heideggeriana. Quello cioè di iniziatore della metafisica,
colui che ha separato il “mondo vero” dal “mondo apparente”. Occorre attendere
la venuta di Zarathustra, il mezzogiorno dello spirito, l’ora in cui le ombre, se non
svaniscono, sono più corte, e le menzogne si dissolvono. L’anti Platone, che è pu119
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
re l’anti Cristo, non si limita a rovesciare il platonismo e a dichiarare la superiorità delle apparenze, cioè dei sensi, sulle idee. Il suo compito performativo è procedere alla trasvalutazione di tutti i valori, unica operazione che consente di sbarazzarsi di ogni fittizia separazione 74.
Il tema già nietzschiano del platonismo quale origine della metafisica acquisisce una superiore profondità teoretica nella meditazione di Martin Heidegger:
non a caso egli ha elaborato il platonismo come figura teoretica, chiave di volta per intendere la nascita e lo sviluppo della filosofia, all’interno di un serrato
confronto con Nietzsche. Heidegger ha più volte intonato il canto del cigno della
metafisica occidentale e ha prospettato un nuovo, altro inizio del pensiero corrispondente a una rinnovata stagione dell’ontologia: l’architrave che sorregge questo progetto filosofico si chiarisce soprattutto nell’Aus-einander-setzung, ossia nel
dialogo reciproco che esclude le mezze misure, tra i due pensatori tedeschi e che
prenderà forma nelle lezioni e nelle trattazioni di Heidegger lungo un intero decennio, dal 1936 al 1946, e che saranno poi raccolte nell’omonima opera in due
volumi del 1961 75.
Anche Heidegger, come gran parte di coloro che si sono cimentati con Platone, ha chiara coscienza della linea di demarcazione tra le dottrine del filosofo antico e le sue rielaborazioni, ossia i numerosi platonismi che si sono succeduti nel
corso della storia. Per esigenze di sintesi, è possibile affermare che il cosiddetto
primo Heidegger, antecedente alla Kehre degli anni trenta, benché provenga da
una tradizione filosofica dominata quasi esclusivamente da Aristotele, sia un attento e scrupoloso lettore di Platone; il secondo Heidegger, successivo alla “svolta”, si serve del platonismo per esprimere figurativamente l’essenza e l’apogeo della metafisica: «ogni metafisica unitamente al suo antagonista, il positivismo, parla la lingua di Platone» 76. A un primo produttivo incontro con il pensatore antico tiene dietro l’elaborazione di un’immagine, diremmo pure di una visione del
mondo, che racchiude in un unico colpo d’occhio le vistose differenze di una benché unitaria tradizione culturale e spirituale. Heidegger si serve infatti del platonismo come di una figura epocale, concettuale e metastorica, molto criticata dai
suoi avversari, e nella quale l’autore stesso lascia confluire molto più di ciò che sarebbe da far ricadere sotto una banale formuletta storiografica: il platonismo definisce per il filosofo tedesco la metafisica antica e quella moderna, la scienza e la
tecnica, il razionalismo e il soggettivismo, per non dire lo stesso aristotelismo (in
particolare per l’accostamento troppo disinibito che si produce nella sua opera tra
l’εἷδος aristotelico e l’ἰδέα platonica) 77.
La questione veramente dirimente dell’antiplatonismo heideggeriano si legge in uno degli scritti fondamentali della sua querelle antimetafisica: La dottrina platonica della verità, testo maturato negli anni trenta, al tempo del confronto
con Nietzsche, ma apparso nel dopoguerra assieme alla Lettera sull’«umanismo»,
perché – commenta Heidegger – «l’inizio della metafisica nel pensiero di Platone
è nello stesso tempo l’inizio dell’“umanismo”» 78. Il motivo centrale del platonismo risiede nel processo che sottopone la verità dell’essere al giogo dell’idea platonica, inaugurando una diversa concezione della verità greca. Quest’ultima non
è più ἀλήϑεια, apertura dell’essere, schiudersi della natura e fioritura della vita,
in una parola disvelamento, ma ὀρϑότης, correttezza dell’enunciato, formula eminentemente logica che troverà rispondenza nella fortunata variante latina di adaequatio intellectus et rei e in seguito nella modernità. Il movimento che determina
questa svolta assieme logica e ontologica è secondo Heidegger registrato nel cosiddetto mito della caverna che si legge nel vii libro della Repubblica di Platone:
120
non c’è dubbio che questo «mito» contenga la «dottrina» platonica della verità. Infatti
esso si fonda sul processo non detto attraverso cui l’ἰδέα diviene padrona del­­l’ἀλήϑεια. Il
«mito» dà un’immagine di ciò che Platone dice dell’ἰδέα τοῦ ἀγαϑοῦ […] «essa stessa è sovrana perché consente la disvelatezza (a ciò che si mostra) e nello stesso tempo l’apprensione (di ciò che è svelato)». L’ἀλήϑεια cade sotto il giogo dell’ἰδέα. Quando Platone dice,
a proposito dell’ἰδέα, che essa è la sovrana che consente il disvelamento, egli rinvia a qualcosa di non detto, e cioè che d’ora in poi l’essenza della verità non si dispiega più come essenza della disvelatezza […] ma si trasferisce nell’essenza dell’ἰδέα. L’essenza della verità
abbandona il tratto fondamentale della disvelatezza 79.
La vera profonda affinità che si può registrare tra Heidegger e Michelstaedter
consiste nell’individuazione della dimensione epocale del platonismo, nel suo ergersi cioè a momento storico culminante che ha inaugurato una nuova visione del
mondo e una diversa e quasi irreversibile comprensione della vita e del pensiero. Per questo motivo non stupisce l’accostamento che ho richiamato all’inizio tra
platonismo e modernità, nella specifica figura del cartesianesimo. In particolare,
il primo capitolo della seconda parte della Persuasione, dedicato alla costituzione
rettorica del sapere, e che si conclude con il già commentato Esempio storico, contiene infatti una rilettura e una decostruzione del principio del soggettivismo cartesiano. Per Michelstaedter «cogito non vuol dire “so”» ma «cerco di sapere: cioè
manco del sapere: non so» 80.
L’afflato speculativo comune a due pensatori nel complesso molto distanti tra
loro non deve indurci a vagheggiare anticipazioni che farebbero torto a entrambi. Come notava Eugenio Garin in una delle sue “cronache di filosofia italiana”,
ciò che rende originale e autentica la voce di Michelstaedter, rispetto alle fanfare
retoriche antiaccademiche e antifilosofiche del suo tempo, è la radicata tendenza
verso un genuino filosofare che l’ha condotto, in definitiva, a lidi più vitali e “salutari” rispetto alle tante nichilistiche derive che segnerebbero in maniera irreparabile il destino dell’Occidente. Conclude così Garin la sua “cronaca”:
121
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
tutto era paradossale nel messaggio che Michelstaedter consegnava al manoscritto di una
tesi di laurea presso l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, nel 1910. […] Eppure giova
tornare a quelle pagine ove una sensibilità squisita dava voce a motivi così presenti e operanti in questo secolo, che forse non a caso si aprì sul grido della morte di Dio e l’annuncio delle aurore che ancora non hanno brillato 81.
1
Cfr. E. Giammattei, La Biblioteca e il Dragone. Croce, Gentile e la letteratura, Napoli, Editoriale Scientifica, 2001, p. 107.
2
C. Michelstaedter, Scritti vari, in Opere, a cura di G. Chiavacci, Firenze, Sansoni, 1958, p. 810, nota 114 (ora anche in Id., Sfugge la vita. Taccuini e appunti, a cura di A. Michelis, Torino, Nino Aragno, 2004,
p. 146).
3
Cfr. M. Cacciari, Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Milano, Adelphi, 1980; S.
Campailla, Un autore postumo, introduzione a C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1995, pp. ix-xvii (d’ora in avanti Persuasione); P. Piovani,
Michelstaedter: filosofia e persuasione, a cura di F. Tessitore, in «Nuova antologia», 2141, 1982, pp. 209-220.
4
In questi termini si esprimeva Sergio Campailla, da me interrogato sull’identità del Platone di Michelstaedter, in un colloquio che abbiamo avuto qualche anno fa: R. Peluso, Michelstaedter e il dottor Freud.
Conversazione con Sergio Campailla, in «Riscontri», 1, 2004, pp. 27-43, in particolare p. 38. Sulla dimensione “estetica” del platonismo rimando al saggio di G. Lukács, Platonismo, poesia e le forme: Rudolf Kassner
(1908), contenuto nel suo celebre L’anima e le forme (1910), trad. it. di S. Bologna, con uno scritto di F. Fortini, Milano, Se, 2002, pp. 39-51, e a quello di M. Cacciari, Metafisica della gioventù, che chiude l’edizione italiana curata da G. Caramore del lukácsiano Diario (1910-1911), Milano, Adelphi, 20012, pp. 69-148. Mi sono occupata nello specifico di questi temi nel mio volume, di recente pubblicazione, L’identico e i molteplici. Meditazioni michelstaedteriane, Napoli, Loffredo, 2011.
5
Cfr. Persuasione, ii Appendice critica, p. 143, e F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, ovvero come fare filosofia col martello (1888), a cura di G. Brianese, C. Zuin, Bologna, Zanichelli, 1996.
6
Cfr. F. Volpi, Platonismo e aristotelismo come figure archetipiche della metafisica di Heidegger, in Heidegger in discussione, a cura di F. Bianco, Milano, Franco Angeli, 1992, pp. 242-273. Sulla complessiva lettura
heideggeriana di Platone rinvio al mio volume Logica dell’altro. Heidegger e Platone, Napoli, Giannini, 2008.
7
Cfr. Persuasione, ii Appendice critica, pp. 164-165.
8
«Ieri sera tardi ho dato l’esame di greco che è andato nel modo migliore. È stato l’unico 30 della sessione (su 33 esaminandi). Per me era questione vitale che andasse bene perché il professore è quello a cui
presenterò la tesi» (Id., Epistolario, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1983, p. 262).
9
Ibid., p. 226.
10
Cfr. il recente lavoro di S. Campailla, Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e
tragedia, Venezia, Marsilio, 2010.
11
Michelstaedter, Epistolario, cit., p. 393 (13 giugno 1909).
12
Le Lettere a Carlo di Mreule sono state pubblicate da S. Campailla nel volume da lui curato Dialoghi
intorno a Michelstaedter, Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988,
pp. 7-34, in particolare pp. 23-28.
13
Cfr. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 19945, p. 81; Id., Epistolario,
cit., p. 446 (a Emilio Michelstaedter, 2-3 settembre 1910). Mreule trascorse circa tredici anni, dal 1909 al
1922, in Argentina a fare il gaucho. La sua storia è stata ricostruita da Claudio Magris nel romanzo Un altro mare, Milano, Garzanti, 19982. Di Magris si veda pure Il mio romanzo “goriziano”, in «Studi goriziani»,
2, 1991, pp. 27-37.
14
Michelstaedter, Epistolario, cit., pp. 441-442 (29 giugno 1910).
15
Nella biografia michelstaedteriana A ferri corti con la vita, Gorizia, Comune di Gorizia, 1974, Campailla ha fatto notare che fu Mreule a far conoscere a Michelstaedter il pensiero di Schopenhauer e in generale a determinare in lui un «primissimo risveglio alla filosofia» (p. 20), seguendo su questo punto le osservazioni di Paula Michelstaedter Winteler nei suoi Appunti per una biografia di Carlo Michelstaedter, pubblicati da Campailla in appendice al suo Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, pp.
145-164, in particolare p. 152 (il testo reca la data del 1939).
16
C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla,
Milano, Adelphi, 2010, pp. 161-162 (già in Id., Scritti vari, cit., pp. 684-685, nota 21).
17
Id., Epistolario, cit., p. 362 (14 aprile 1909). In principio della lettera Aristotele era stato definito «miserabile Zaunkönig [scricciolo]» (p. 359).
18
Ibid., p. 363 (14 aprile 1909).
19
Mreule, Lettere a Carlo, cit., p. 26.
20
Michelstaedter, Epistolario, cit., p. 396 (13 giugno 1909).
21
Ibid., p. 367 (a Paula, 5 maggio 1909).
22
Sintomatica è questa risposta data a Nino Paternolli, studente a Vienna, che gli aveva chiesto informazioni o un contatto diretto con qualche editore italiano: «Ho vissuto 4 anni a Firenze, che è uno dei centri
librari d’Italia, mi misi ripetute volte a disposizione di editori del posto, di editori d’altre città, feci loro proposte precise dopo aver scritto agli editori e agli autori esteri; offrii i miei servizi agli organizzatori di vaste
pubblicazioni di cose tradotte (professori o letterati essi stessi). Tutto m’andò infruttuoso – m’ebbi risposte
nei stretti limiti della cortesia, vaghe o negative. E intesi che dappertutto bisogna esser in qualche modo raccomandati o dalla fama di scrittore o dalla protezione di chi per le aderenze o per la carica, o il censo, o i fatti
compiuti abbia voce a esser ascoltato. – Acquistare l’un modo o l’altro di raccomandazione per “proposito” è
una cosa che io non ho saputo fare – né ora sono progredito in quell’arte» (ibid., pp. 435-436, 21 marzo 1910).
23
Le lettere a Chiavacci (13 febbraio) e alla famiglia (8-10 maggio), assieme a quelle già citate a Mreule, testimoniano un’assidua lettura di Platone.
24
F. Nietzsche, Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell’avvenire (1885), trad. it. di F.
Masini, con una nota introduttiva di G. Colli, Milano, Adelphi, 1999, p. 4.
25
Il capitolo della presenza di Platone in Michelstaedter ha cominciato a prendere forma negli ultimi anni. Si deve soprattutto agli studi di Massimo Cacciari la nascita di un interesse per la figura del platonismo michelstaedteriano disseminato in molti suoi scritti. Mi limito a citare La lotta “su” Platone. Michelstaedter e Nietzsche, in Eredità di Carlo Michelstaedter, atti del convegno internazionale Michelstaedter. Il coraggio dell’impossibile, a cura di E. Guagnini (Gorizia, 1°-3 ottobre 1987), a cura di S. Cumpeta, A. Michelis, Udine, Forum, 2002, pp. 93-105. Segnalo inoltre il saggio di D. Micheletti, Platone a partire da Michelstaedter, alla fine del volume michelstaedteriano da lui curato, L’anima ignuda nell’isola dei beati. Scritti su Platone, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, pp. 145-206.
26
Bisogna partire innanzitutto dalla riconcettualizzazione michelstaedteriana del lessico platonico.
Tutta l’opera di Michelstaedter è percorsa da un concetto-cardine che indica il principio costitutivo di ogni
vita, inorganica e organica che sia: è la ϕιλοψυχία, la brama di vita, l’«amore alla vita, viltà» traduce Michelstaedter, che si trova impiegata da Platone nell’Apologia (37c), nelle Leggi (944e) e nel Gorgia (512e). Cfr.
Persuasione, p. 17: qui il termine è citato per la prima volta ma ricorre spesso nella Persuasione, nel Dialogo
della salute e negli appunti degli Scritti vari o della Melodia del giovane divino. In alcuni luoghi Michelstaedter, per esempio nella Persuasione, pp. 95, 102, utilizza l’espressione ϰοινωϕελῶς ϕιλοψυχεῖν (attaccarsi alla vita in modo socialmente utile). Anche l’adulazione richiamata nelle ultime pagine, la ϰολαϰεία, è l’unica
122
123
Son parole che sigillano idealmente un intervento che ha inteso, pur attraverso un richiamo all’antico, parlare di Michelstaedter al presente. Dinanzi al suo
tempo egli non si è fatto funesto cantore del nulla né sterile levatrice dell’avvenire, nemmeno ha preteso di curare, al pari di tanti improvvisati taumaturghi di allora, la «malattia dell’epoca» che pure aveva diagnosticato. Con finissima sensibilità è giunto più in profondità, sino a scorgere che il male, in fin dei conti, è nei
fatti, nelle cose che si ammalano a causa dell’«accidente mortale» che le vede nascere 82. Non da altri che da Platone, per sua esplicita ammissione, era stato spinto
ad affacciarsi su questo spettacolo cosmico, a contemplare la terrificante magnificenza dell’essere e del tempo.
note al testo
rosalia peluso
la variante michelstaedteriana dell’antiplatonismo contemporaneo
finalità cui mira la retorica sofistica secondo il Socrate del Gorgia (cfr. 463b ss., 501c-503a; Persuasione, pp.
122-131. Il termine si trova impiegato anche nel Simposio, nella Repubblica e nelle Leggi). Di ascendenza platonica è pure l’espressione ἄβιος βίος, letteralmente “vita che non è vita”, utilizzata nella Persuasione in chiave positiva (p. 12), e che potrebbe essere il riadattamento di un passo dell’Apologia (38a) dove Socrate dice
che «una vita non esaminata non è degna di essere vissuta» (βίος οὐ βιωτός; ἀβίωτος è tra l’altro l’equivalente
di ἄβιος: cfr. Menesseno, Repubblica, Leggi), e dove ha quel significato dispregiativo che ricorre in altri luoghi
michelstaedteriani (soprattutto nelle Appendici critiche). Chiare rielaborazioni di termini platonici sono infine due espressioni ricorrenti nella delineazione della rettorica: ϰαλλωπίσματα ὄρϕνης (ornamenti dell’oscurità, Persuasione, p. 58) e ϰοινωνία ϰαϰῶν («comunella di malvagi», ibid., pp. 88 ss. e 124): ϰαλλώπισμα si trova
infatti nel Gorgia (492c) e nel Fedone (64d) e, in forma aggettivale, nel Cratilo (414c e 426d) e nella Repubblica (572c); Michelstaedter modella su questo termine anche il suo neologismo «callopismatismo»; la ϰοινωνία
potrebbe essere un richiamo a quella ϰοινωνία τῶν γενῶν del Sofista (257a) che, analizzato assieme al Parmenide, segnerebbe secondo Michelstaedter la morte dell’uno e l’avvento del molteplice nella filosofia (cfr. Persuasione, ii Appendice critica, p. 181).
27
Ibid., pp. 9-10. Un altro riferimento alla γυμνὴ ψυχή si incontra nel Cratilo (403b).
28
Persuasione, p. 27.
29
Ibid., p. 33.
30
Ibid., p. 95.
31
Ibid., p. 127.
32
Id., La melodia del giovane divino, cit., p. 116 (già in Id., Scritti vari, cit., p. 706, nota 38).
33
Cfr. ibid, p. 865, nota 130; ora anche in Id., L’anima ignuda nell’isola dei beati, cit., p. 63.
34
Sulla verità persuasiva cfr. Id., Parmenide ed Eraclito. Empedocle. Appunti di filosofia, a cura di A. Cariolato, E. Fongaro, Milano, Se, 2003, p. 37.
35
Persuasione, p. 39; cfr. anche Id., La melodia del giovane divino, cit., pp. 89-90 (già in Id., Scritti vari, cit., pp. 740-741, nota 69).
36
Cfr. Platone, Gorgia, trad. it. di G. Reale, in Tutti gli scritti, Milano, Bompiani, 2000: «l’essere liberato dal male maggiore è bene maggiore che il liberare gli altri» (458a). Sulla preferenza etica di Socrate per
il subire ingiustizia anziché essere ingiusti numerose sono le testimonianze: «il più grande dei mali è il fare
ingiustizia – Questo è il male più grande? Non è più grande il ricevere ingiustizia? – Niente affatto! – Allora
tu preferiresti ricevere ingiustizia piuttosto che farla? – Io non preferirei né l’una né l’altra cosa; ma, se fosse necessario o fare o ricevere ingiustizia, sceglierei piuttosto il ricevere che non il fare ingiustizia» (469bc); «nessuno teme il morire per se stesso, a meno che non sia un uomo del tutto insensato e vile, ma è da temere il commettere ingiustizia. Infatti, l’estremo di tutti i mali è l’andare all’Ade con l’anima carica di molte ingiustizie»(522e); «bisogna guardarsi dal commettere ingiustizia più che dal riceverla, che l’uomo deve
preoccuparsi non di apparire buono ma di esserlo veramente, e in privato e in pubblico» (527b). Celebre infine la massima della coerenza: «assai meglio sarebbe che fosse scordata e stonata la mia lira, e che stonato
fosse il coro da me istruito e che la maggior parte degli uomini non fosse d’accordo con me e dicesse il contrario di ciò che dico io, piuttosto che fossi io, che pure sono uno solo, in disaccordo e in contraddizione con
me stesso» (482b-c). L’espressione “proposizione fondamentale dell’etica” si ricava dall’analisi dei passi platonici in Alcune questioni di filosofia morale (1965-1966) di Hannah Arendt, raccolte nel volume Responsabilità e giudizio, a cura di J. Kohn, trad. it. di D. Tarizzo, Torino, Einuadi, 2004, pp. 41-126.
37
Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., p. 42 (già in Id., Scritti vari, cit., p. 639, nota 6).
38
Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., p. 42 (già in Id., Scritti vari, cit., p. 639, nota 6).
39
Platone, Gorgia, 494b: l’immagine del caradrio deve aver colpito molto Michelstaedter, tanto da ricordarla in una delle lettere a Mreule (Michelstaedter, Epistolario, cit., p. 397, 13 giugno 1909) e in Persuasione, ii Appendice critica, p. 154.
40
Il corpo, il σῶμα, «alcuni lo chiamano σῆμα [tomba], dell’anima, come se essa vi si trovasse sepolta
nella vita presente. E poiché, d’altro canto, attraverso questo l’anima σημαίνει [significa] ciò che σημαίνῃ [intende esprimere], anche per questo viene denominata correttamente σῆμα [segno]. Tuttavia, mi sembra che
questo nome sia stato assegnato soprattutto dai seguaci di Orfeo, dato che l’anima per essi sconta la pena
delle colpe che deve espiare, ed ha questo involucro, immagine di una prigione, affinché σῴζηται [si salvi].
Questo, pertanto, come suggerisce il nome stesso, è σῶμα [custodia, salvezza] dell’anima, finché essa non abbia pagato il suo debito. E non occorre mutare nemmeno una lettera» (Cratilo, 400c-d, trad. it. di M.L. Gatti, in Platone, Tutti gli scritti, cit.).
41
C. Michelstaedter, Il prediletto punto d’appoggio della dialettica socratica: l’analogia del corpo, in Id.,
La melodia del giovane divino, cit., pp. 106-107. Il testo ha avuto varie precedenti edizioni: mi limito a ricordare Id., Scritti vari, cit., pp. 875-881, nota 133, e Id., L’anima ignuda nell’isola dei beati, cit., pp. 29-34.
42
Platone, Repubblica, 508c.
43
Persuasione, ii Appendice critica, p. 144.
44
Ibid., p. 67. Disperata è anche la devozione michelstaedteriana per la leggerezza, congiunta a una fatale vertigine dell’alto, come quella dell’ibseniano costruttore Solness. Queste idee sono alla base di alcune mie giovanili «note su Michelstaedter»: Abitare la leggerezza, in «Atti dell’Accademia di Scienze Morali
e Politiche, Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti», cxiii, 2002, pp. 5-21.
45
«Tutti coloro che praticano la filosofia in modo retto rischiano che passi inosservato agli altri che la
loro autentica occupazione non è altra se non quella di morire e di essere morti» (trad. it. di G. Reale, in Platone, Tutti gli scritti, cit.).
46
Cfr. Id, Repubblica, 511b.
47
Ibid., 486a.
48
Persuasione, p. 70.
49
Ibid., p. 72.
50
Ibid., p. 73.
51
Id., Epistolario, cit., p. 350 (1° febbraio 1909).
52
Cfr. Persuasione, ii Appendice critica, pp. 173-174.
53
Ibid., p. 196.
54
Ibid., p. 208.
55
Ibid., p. 188.
56
Ibid., p. 61.
57
Ibid., p. 134.
58
Ibid., p. 193.
59
Ibid., p. 165.
60
Ibid., p. 175.
61
Cfr. ibid., pp. 169-170.
62
Ibid., p. 181.
63
Cfr. ibid., pp. 184-185.
64
Sulla funzione archetipica della città platonica cfr. anche A. Negri, Il lavoro e la città. Un saggio su
Carlo Michelstaedter, Roma, Edizioni Lavoro, 1996, pp. 47-55.
65
Persuasione, ii Appendice critica, pp. 144, 146, 153-154.
66
Ibid., p. 146.
67
Id., L’anima ignuda nell’isola dei beati, cit., p. 62 (già parziale in Scritti vari, cit., pp. 862-867, note
129-130).
68
I. Kant, Di un tono di distinzione assunto di recente in filosofia, in Id., Questioni di confine. Saggi polemici (1786-1800), a cura di F. Desideri, Genova, Marietti, 1990, pp. 53-69; la citazione si trova a p. 61. Lo
scritto kantiano era la risposta diretta al curatore della traduzione tedesca, apparsa l’anno precedente, delle Lettere di Platone, Johann Georg Schlosser, il quale, nelle note e nell’introduzione, aveva tirato in ballo la filosofia kantiana.
69
C. Michelstaedter, Περὶ ἐλευϑερίας (La libertà), in Id., La melodia del giovane divino, cit., pp. 57-64, in
particolare p. 63. Il testo, che fa parte degli Appunti per trattazioni sistematiche, era stato raccolto da Chiavacci negli Scritti vari, cit., pp. 662-667 (nota 14), nella prima sezione (Appunti - Note - Critiche letterarie - Dialoghi - Bozzetti) ed era indicato nell’indice conclusivo con il titolo Di fuori la vita rumoreggia.
70
Le opere nietzschiane in cui la polemica antiplatonica è centrale sono le già menzionate Al di là del
bene e del male del 1885, cit., pp. 3-5 (l’equazione cristianesimo-platonismo si legge qui), e Il crepuscolo degli
idoli del 1888, in particolare le prime parti di quest’ultimo scritto: Il problema di Socrate, La ragione nella filosofia e Come il “mondo vero” divenne finalmente favola, pp. 34-37, 50-75.
71
Id., Frammenti postumi 1869-1874, trad. it. di G. Colli, C. Colli Staude, i, Milano, Adelphi, 1989, 7
(156), p. 203.
72
Id., Al di là del bene e del male, cit., p. 4.
73
Id., Il crepuscolo degli idoli, cit., pp. 59, 61.
74
Cfr. ibid., pp. 73-75.
75
M. Heidegger, Nietzsche, ga xliii, nuova edizione italiana ampliata a cura di F. Volpi, Milano, Adelphi, 20003.
124
125
rosalia peluso
76
Id., La fine della filosofia e il compito del pensiero (1966), in Tempo e essere (1969), trad. it. di E. Mazzarella, Napoli, Guida, 19914, p. 181.
77
Si vedano per esempio le critiche di P. Friedlaender, «Alētheia». Una discussione con Martin Heidegger, in Platone. Eidos - Paideia - Dialogos, trad. it. di D. Faucci, Firenze, La Nuova Italia, 1979, pp. 291-303,
e S. Rosen, Du platonisme comme aristotélisme, in Contre Platon, ii. Le platonisme renversé, a cura di M. Dixsaut, Paris, Vrin, 1995, pp. 47-76.
78
M. Heidegger, La dottrina platonica della verità (1947), in Segnavia (1967), trad. it. a cura di F. Volpi,
Milano, Adelphi, 19944, pp. 159-192, in particolare p. 190; nello stesso volume si legge la Lettera sull’«umanismo», pp. 265-315.
79
Id., La dottrina platonica della verità, cit., pp. 184-185 (traduzione lievemente modificata).
80
Cfr. Persuasione, pp. 60-61. Per Heidegger si veda per esempio la conferenza del 1938 (poi confluita
in volume nel 1950) L’epoca dell’immagine del mondo, in Sentieri interrotti, trad. it. di P. Chiodi, Scandicci,
La Nuova Italia, 19842, pp. 71-101, in particolare pp. 84-99.
81
Cfr. E. Garin, Cronache di filosofia italiana 1900-1960, i, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 31-37, in particolare p. 37.
82
L’espressione «malattia dell’epoca» ricorre in una lettera a Paula (cfr. Michelstaedter, Epistolario,
cit., p. 158, 9 dicembre 1906); «accidente mortale della nascita» si legge invece in vari contesti: per esempio
nella Persuasione, pp. 82, 206, e, nella variante di nascita quale «caso mortale», in Id., Il dialogo della salute e altri dialoghi, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 19952, p. 72, e in Id., Scritti vari, cit., p. 747 (nota 80). Dei temi della malattia, della salute e della nascita mi sono ampiamente occupata nel mio già citato
volume L’identico e i molteplici.
Il sasso del San Valentin
di Fabio Pierangeli
Se Carlo Michelstaedter scrive La leggenda del San Valentin, su quelle pietraie, sul suo “sasso”, oltre alle note di Beethoven restano incise indelebili realtà della storia. La buia notte del 23 novembre 1943, insieme agli ebrei di Gorizia, i nazisti trascinano ad Auschwitz la madre e la sorella maggiore di Carlo, Elda. Una
pietra silente, il sasso del San Valentin, idealmente gemella alla pietra dell’Ungaretti combattente sul Carso, sinonimo di fratellanza, di lacerazione, di distruzione, pietra del San Michele, così vicina al Valentin, del Carso degli Slataper e degli Stuparich, di tanti soldati senza nome, diviene testimone oculare della strage
di trent’anni dopo, sotto gli occhi di Carlo, che osservano chissà da quale confine,
senza più confini: «Il sasso, usato dalla famiglia per anni come fermacarte, fu poi
portato via dai tedeschi nel novembre 1943» 1. Nessuno può più difendere quel
simbolo di libertà di fronte alla bestia-cornacchia assetata di sangue: «Mi pareva
di essere un falco che difendesse la purezza dei sassi e dell’aria sulla cima del S.
Valentin contro un volo di cornacchie».
Andiamo agli inizi del Novecento, sul San Valentin, per sapere di quel sasso,
con la didascalia di Sergio Campailla, accanto a una cartolina d’epoca (Fondo Mischou, Fondazione Cassa di Risparmio, Gorizia) che ritrae le “rovine”:
Oltre ai ruderi medievali sulla cima [del San Valentin], lungo la mulattiera che sale
da Gorizia, per Piuma-San Mauro, si incontrava un masso a due cuspidi, testa da cavallo
e cavaliera, che veniva chiamata la dona a caval e che contribuì a ispirare a Carlo la “leggenda” del monte. Poco lontano era una “casa” con “cucina”, ossia un anfratto di Roccia,
dove la comitiva faceva sosta. La sorella Paula, in occasione di un compleanno del fratello, che si trovava a Firenze, gli spedì il dono di un sasso del monte amato, senza imballaggio, con una semplice fascetta. Su una parte levigata, di un rosso cupo, Carlo vi incise le
prime note, in un’edizione per pianoforte, di una sinfonia di Beethoven 2.
126
127
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
Alla sacra intimità raggiunta da quel gruppo di amici nel luogo mitico del loro rifugio, il pensiero di Carlo ritorna nei mesi del “distacco”, quando Firenze gli
appare il contesto dell’accademia e della rettorica. A essa, con il livello cristallino
raggiunto sulla via della persuasione, il giovane oppone anche una dimensione di
energia fisica, colta frequentemente nelle ascese verso l’alto, siano i colli di Gorizia o quelli stessi intorno a Firenze, puntualmente descritte nell’Epistolario. “Figura”, vedremo, di un’altra dimensione, superiore perfino, a un certo punto, alle
parole di qualsivoglia filosofia “scritta”, vicine allo spirito della musica, come appunto dimostrato dal gesto simbolico di incidere sul “suo” sasso le note di Beethoven. La contemplazione potrebbe apparire forma della stessa persuasione, in
taluni momenti, dopo l’ascesa faticosa di un cammino corporale e mistico, non
escludendo un amaro, inquieto, rovescio della medaglia, descritto per esempio
nella poesia dal San Valentin Risveglio. Racconta Paula Michelstaedter:
metri di trincea e venticinquemila uomini contro i centomila italiani, il Sabotino
subisce tredici assalti e due irruzioni, senza centrare l’obiettivo. Dopo alterne vicende, con l’apertura di altri fronti, nell’agosto del 1916, con un’enorme sproporzione di forze, circa di dodici a uno per gli attaccanti, e nell’attacco alle trincee
centomila contro diciottomila, gli italiani conquistano Gorizia. La battaglia del
Sabotino viene ricordata per l’inaudita violenza, scatenata dalla determinazione
dei dalmati che non si arrendono, con una sanguinosa e feroce rissa tra le caverne e le voragini di terra di quel suolo friabile, che guadagnano al monte di Michelstaedter la sinistra fama di cima terribile e difficile da conquistare. Per alcune fonti, la crudeltà delle forze italiane è eccessiva nello snidare con il fuoco i nemici ormai in trappola. Fra le testimonianze di semplici soldati raccolte da Fabi,
Mario Rizzati riferisce di aver sentito di quella terribile guerra a corpo a corpo nel
San Valentin (la propaggine più vicina a Gorizia del Sabotino, come ora si chiama l’altura nel suo complesso), da un certo Slataper triestino: si tratta del fratello
dello scrittore, morto in quei giorni sul Podgora in una missione a cui aveva partecipato come volontario. Si tenga anche conto che molti goriziani dovettero rispondere alla chiamata alle armi dell’impero, e alcuni furono destinati a combattere una crudele guerra civile alle porte di Gorizia. Come è ben noto, l’anno seguente le sorti della guerra si capovolsero, con gli italiani impreparati all’assalto
austriaco a Caporetto: e, ironia della sorte, proprio a Caporetto, «si trovò a combattere un giovane ufficiale tedesco di nome Erwin Rommel, lo stesso che venticinque anni dopo – la notte tra l’8 e il 9 settembre del 1943 – guidò le truppe germaniche dal confine del Brennero verso l’Italia, catturando in pochi giorni centinaia di migliaia di soldati italiani» 5. Evento, quest’ultimo, nella sue tragiche conseguenze, appena due mesi dopo, portato a sconvolgere ulteriormente il destino
della famiglia Michelstaedter, come si è detto. Siamo dunque tornati al punto di
partenza, a quelle pietraie. Lì in cima, accanto alle rovine, Carlo invia la prima lettera di quello che sarà per lui un anno non vissuto fino alla fine 6.
In quel fazzoletto 7 di terra fuori dalla terra, in un tempo sospeso, dentro una
sensazione di vertigine per il rincorrersi di vicende vorticose, gonfia di energia,
si legge il destino di tre ragazzi. Sospensione dentro un distacco (la cima solitaria
ne è correlativo oggettivo privilegiato), sentimento primario nell’antropologia di
Carlo, in risvolti stratificati e complessi. “Distaccati” dal suolo delle convenzioni,
avvertono la vicinanza con la natura, in una specie di goliardica e laica Trasfigurazione 8, in cui però si adombra, in nuce, il tentativo di formazione di un falansterio ribelle alle regole imposte dalla comunità al di sotto, per cui si può leggere questa esperienza, in linea con il tema del convegno, come “figurazione” embrionale di «un’altra società», in quel luogo di consuetudine di una speciale amicizia, alle cui fondamenta si trovano il desiderio di una vita non conforme alle regole della rassegnazione 9. Scrive ancora Paula Michelstaedter:
Non fece alpinismo, ma conosceva bene i nostri monti attorno a Gorizia, e non ci andava per sport, in compagnia, ma per bisogno di movimento, per amore alla natura, per
ricerca della solitudine. In una delle ultime vacanze d’estate, passò alcuni giorni sulle Alpi Giulie, ci andò da solo, senza meta prefissa, senza carte, senza sacco di provviste, senza saper nemmeno quando sarebbe tornato. E si fermò alcuni giorni camminando molto,
passò tutto un giorno nella nebbia fitta, nutrendosi soltanto di latte che trovava nelle malghe dei pastori. E ritornò più dimagrito, ma con una faccia illuminata come chi ha vissuto intensamente d’una vita interiore 3.
Durante le cosiddette seconda e terza battaglia dell’Isonzo nel luglio fino al
novembre del 1915, il San Valentin, poi ribattezzato monte Sabotino, fu il teatro
dell’attacco italiano alle roccaforti austriache lì insediate, proseguito in direzione
di un altro luogo di villeggiatura ben conosciuto da Carlo: Tolmino. Da parte italiana si dovette aspettare, per il sopraggiungere dell’inverno, fino all’agosto successivo per sferrare l’attacco finale il cui obiettivo era proprio Gorizia, città fortificata e importante snodo ferroviario. Il monte Sabotino fu conquistato il 6 di
agosto 1916. Facile intuire cosa sarebbe rimasto dopo la cruenta battaglia a corpo
a corpo, di trincee nemiche ravvicinate, dei luoghi così cari a Carlo. Lo racconta,
tra gli altri, Lucio Fabi, nella sua ricostruzione delle vicende della grande guerra sui colli di Gorizia: «Assieme agli uomini, muore la natura. Con il susseguirsi delle operazioni, le granate incendiarie ed i proiettili dei grossi calibri cancellano il verde dei prati, dei frutteti, delle vigne, dei boschi. Le quote più battute sono gialle: il giallo dello zolfo, della polvere da sparo, della pietra inerte e sbriciolata» 4. Le pietre di Carlo, del suo San Valentin, dove resistono furiosamente i dalmati, con più di mille perdite, fino alla pausa delle operazioni belliche che riprendono con l’autunno, quando nella terza battaglia dell’Isonzo, contro sette chilo128
129
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
Ma il suo monte preferito era il San Valentin (quello che dopo la guerra si chiamò Sabotino). Ci andava spesso con i suoi due compagni di Gorizia, Mreule e Paternolli e anche solo, trattenendosi su tutta la giornata. Non era un’ascensione quella (il monte è soltanto di 600 metri) lo considerava come un rifugio dalla città. Lassù scrisse parecchie
delle sue ultime poesie: Risveglio, Giugno. Mi par ancora di vederlo ritornar a casa verso
mezzogiorno il 1 marzo del ’910. Era una giornata luminosa e ventosa; rientrò a casa coi
capelli arruffati, proprio come una folata di vento e si mise a scrivere di getto la poesia:
«Marzo ventoso…». La leggenda del San Valentin l’aveva scritta prima, nel 1908, e difatti
essa risente nello stile delle sue letture di allora, specialmente delle opere dannunziane,
non ha la spontaneità, quell’impronta viva e la forza della Bora, scritta nell’ultimo anno 10.
recita la targa, ispirata da Biagio Marin, del Cai di Gorizia, apposta sul masso del
Poldanovec dove Paternolli ha trovato la morte, durante un’escursione in compagnia del germanista Ervino Pocar 15. Affascinati dall’alto, nel bisogno impellente di scalare ogni cima o di scendere qualunque precipizio, ne muoiono entrambi
intenti, in modi diversi, alla salita, pieni di un’energia traboccante: «Quando facevamo fuoco e cucinavamo la carne ci domandavamo, come la facevi tu ed eravamo contenti, quando ci pareva di fare allo stesso modo. Così ci facciamo compagnia aspettandoti. Tuo Nino» 16. Sono in tre, simbolicamente, quando accolgono la presenza ben augurante di un passerotto di passaggio. Le parole di Carlo
sembrano soffuse di una strana, malinconica prefigurazione del futuro. «Siamo in
tre! un passero è sbucato tra i sassi – non so se sia per noi o pel fuoco! Dopo l’ultimo sacrificio a Giove – partiamo – che è già calata la sera – e ti salutiamo insieme al nostro monte e all’orizzonte che è suo. Addio Carlo» 17. Scherzosa e probabile allusione a una frase ripetuta più volte in situazioni simili, l’accenno al pasto e
al fuoco come sacrificio a Giove assume un significato simbolico, alla luce del destino futuro, quasi una violenta appropriazione di un territorio proibito, la violazione di un limite, pagata, per la legge della ὕβρις, a caro prezzo, con il loro di sacrificio, offerto agli dei voraci del cielo e della terra (sappiamo quanto Michelstaedter rifletta sul teatro tragico e sulla sua liturgia e come Eschilo e Sofocle figurino nella prima pagina della Persuasione e la rettorica come capaci di mostrare il
vero agli uomini). Si rammentino anche dei versi di quell’anno non finito, del settembre del 1910, nel vii movimento delle liriche [A Senia]:
Ora, all’inizio del 1910, sono solo in due sulla cima, il terzo amico è con loro
idealmente, accentuando l’evidenza dell’inevitabilità di un distacco sulla via della persuasione. Enrico Mreule, Rico del Dialogo della salute, è partito per l’Argentina 11, alla fine di novembre del 1909. Con il viaggio ha dato la svolta alla sua vita. Una delle soluzioni accarezzate da Carlo Michelstaedter per sottrarsi, nel concreto, alla morsa della Rettorica: a Pirano, pochi mesi dopo, vorrà rendersi esperto di cose marinare. I tre amici pronti a ogni altezza della montagna, non disdegnano la stessa profondità di esperienza in orizzontale, nel mare, vagheggiando
tra loro un’idea marinaresca «che speriamo non resterà idea; ma ci dimostrerà che
il mondo è più vasto per chi ne è capace», scrive Giovanni Paternolli a Carlo, da
Vienna, rispondendo alla lettera dell’amico dell’8 maggio del 1909 12. Nino parla
di un possibile godimento futuro citando l’Odissea, chiarisce di aver ben presenti
le difficoltà, ma confida nell’energia (parola, come sa il lettore di Michelstaedter,
centrale nel suo pensiero) dell’amico. Il filo sottile della vita era così teso «all’altezza vertiginosa di quelle cime», in questi ultimi mesi della vita di Carlo e del destino degli altri due compagni, «che avrebbe potuto spezzarsi al minimo scossone» 13. Anche Paternolli, in quella circostanza, aggiunge un saluto nella lettera indirizzata a Mreule: «Quando facevamo fuoco e cucinavamo la carne ci domandavamo, come la facevi tu ed eravamo contenti, quando ci pareva di fare allo stesso
modo. Così ci facciamo compagnia aspettandoti. Tuo Nino» 14.
L’idea ricorrente del fuoco, per mangiare e per scaldarsi, resta segno di un
privilegio del destino, vocazione all’abisso, coltivato attraverso l’ascetismo e il libero dispiegarsi di un’energia fisica a contatto con la natura, in un percorso ormai lontano dal modello dannunziano. Far di se stesso fiamma, sarà uno dei motti centrali di Carlo, posto in significativa rilevanza da Sergio Campailla come titolo complessivo della mostra di Gorizia. Un destino di morte segna la vita dei due
amici del San Valentin. Il distacco come privilegio e destinazione ultima. Carlo si
uccide il 17 ottobre di quello stesso anno, Nino morirà il 19 agosto nel 1923, sulle
montagne amate «sacrificando la giovane vita all’amore sublime dei monti», come
130
Fatto sono da me stesso diverso
che contra il fato mi dicevo forte,
perché ho esperta e ancor vivo ad ogni istante
nella tua indifferenza la mia morte.
Né più mi giova mendicare i giorni
Né chieder altro più dal dio nemico,
se non che faccia mia morte finita 18.
Il dio nemico, lo immagino con tre teste: la forza intangibile del destino, il soffocamento della società (il muro di Campailla), un demone interiore, capace di
far leva su una sensibilità acutissima. Le rovine, in realtà, non sono di un fantomatico castello, anche se vi assomigliavano molto, ma dell’eremo, appunto, di San
Valentin, luogo originario costruito per la contemplazione, in modalità, possiamo
immaginare, almeno nella purezza iniziale, vicine all’ascetismo. Per le oggettive difficoltà dell’altura sentite, con comprensibile paragone con il progresso civile e il benessere, troppo dure, gli eremiti si trasferirono “in basso”, in una dimora
131
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
più accessibile. Particolarmente toccante risalta il saluto a Rico, dove l’addio, usato senza forti connotazioni nel linguaggio epistolare dei ragazzi, si rafforza di un
senso struggente, in limine mortis, come la profezione del distacco perenne: «Ancora vicini alle rovine, nel tuo monte e guardando la tua collina. Addio Nino» 19.
Le rovine sono poi la stessa metafisica oggettivizzata di un distacco da assorbire,
quasi esorcizzare, una perpetuazione immutabile rispetto al tempo degli uomini,
sulla quale Carlo, lo ha sottolineato ancora una volta Campailla nella sua introduzione al catalogo della mostra goriziana per il centenario, si trova a ironizzare,
proprio con Enrico Mreule, in una lettera del 13 giugno del 1909:
zione di Gesù, davanti ai tre prediletti apostoli, si deve necessariamente aggiungere, per un ebreo, sia pur non osservante, almeno la tradizione del roveto ardente, delle tavole della Legge, delle ripetute ascensioni di Mosè per trovarsi a colloquio con il Dio. L’ascesa è comunque momento privilegiato per l’uomo religioso,
in analogia con il cammino ascetico.
D’altro punto di vista, la scelta di ricominciare da zero in un altro continente si può presentare come allontanamento in un altrove superficiale, nel facile, e
solo iniziale, godimento della novità assicurata dal cambiamento spaziale, senza
nessuna forma di conoscenza o di approfondimento. Si tratta di uno dei piaceri a
cui ci si attacca chiedendogli di costituire, coscientemente o no, una proroga alla morte, o una labile «distrazione». I due amici di Carlo ne discutono letterariamente nel Dialogo della salute, diventando personaggi emblematici ma rimanendo se stessi, con la chiara da persuaso di Mreule, il viaggiatore. Nella parte finale e culminante, dopo aver ben esaminato anche la vita del gaudente, colui che,
seguendo il motto di Lorenzo il Magnifico, si illude più di tutti, investendo sulla
cambiale della vita, Rico esplicitamente ricorda le passeggiate in montagna dove
il dialogo trovava, nel deambulare vagabondo, un momento e un luogo privilegiato. Diviene chiaro, dalle sue parole, che anche per l’itinerario “ascetico”, come in
ogni altra esperienza dell’esistenza, non conta il mezzo o l’esteriorità, bensì l’azione concreta di ogni singolo uomo nella circostanza in cui si trova immerso, dalla
più quotidiana all’idea di svolta più radicale legata, per esempio, a un’esplorazione in terre sconosciute. Si deve comunque «venire a ferri corti con la vita», ascoltando, dalla profondità dell’abisso, la voce inaudita:
Ho saputo una cosa che ti farà piacere e non posso non dirtela. A Messina c’erano
antichissimi templi greci. Nel terremoto fra le rovine di tutta la città sono rimasti in piedi infatti soltanto questi templi. Pensa, in tutti questi secoli da quando sono stati fabbricati, quante volte si sono visti crollar intorno tutte le case e morire tutti gli uomini negli
innumerevoli terremoti di quella regione. Mi fa pensare che non sono stati fabbricati 20.
Poco più avanti nell’Epistolario, il 16 febbraio del 1910 il giovane ricorda l’episodio, sottolineando la commozione di Nino (espressa anche nelle lettere dello
stesso a Mreule riportate nella bella biografia di Luca Matteusich) di aver ritrovato quella consuetudine del San Valentin, sia pur in assenza di Rico. Il tono si
fa immediatamente melanconico, rilevando la propria inadeguatezza rispetto alla coraggiosa scelta dell’amico, per cui il viaggio è persuasione, vivere ogni attimo nel presente, non appoggiandosi né al passato né al futuro. Non è il momento
di indugiare, scrive Carlo, ma di agire, eppure si trova immobile: «come quando
uno deve levarsi e sogna continuamente di essere levato e d’uscire e via via s’accorge di esser sempre a letto». La circostanza è penosissima, Carlo ha lavorato con
lena, per due settimane, alla tomba dell’amato fratello, morto in circostanze allora fatte credere misteriose o casuali e che Campailla, in Il segreto di Nadia B., ha
ormai documentato con certezza, riportando la notizia come apparsa sui giornali di New York: si trattava di suicidio 21. Il giovane giudica in una prospettiva, direi, definitiva, la possibilità del viaggio offerta dall’esempio dell’amico come azione del persuaso ben cosciente di aver intrapreso una via ardua e altamente dignitosa, non cercando il porto sicuro ma attraversando, nel presente, il mare tempestoso. Si tratta, in tale svolta, di ammaestrare la lacerazione del distacco e veicolarla verso l’ideale: passaggio obbligato nel cammino. Il San Valentin contiene i
caratteri di un territorio capace di connettere due elementi spesso contraddittori:
la persuasione e la contemplazione: a entrambi si arriva dopo un’ardua salita, che
il giovane ha costellato di preziosi elementi simbolici e oggettivi, altrettante tappe figurali di ascesa, carattere non di tutte le alture, come è ben chiarito dalla distinzione con l’adiacente monte Santo, “triste monte petroso” 22. Alla trasfigura132
Niente da aspettare
niente da temere
niente chiedere – e tutto dare
non andare
ma permanere. –
Non c’è premio – non c’è posa.
La vita è tutta una dura cosa 23.
L’etica del persuaso è, allora, letteralmente, trovarsi la via da sé, postulata la
metafora più ovvia e calzante: l’esistenza come viaggio verso una metà, nella quale ogni attimo deve aver valore per il suo presente.
Incamminarsi, si vedano le lettera a Mreule, risulta comunque doloroso. La
parola distacco, con i suoi sinonimi, è tra le più usate, nelle diverse gradazioni che
può assumere, negli appunti di Paula, più volte citati: distacco dal fratello Gino
che parte per New York, distacco dalla famiglia. «Ci andò con entusiasmo giovanile, assetato del bello in tutte le sue emanazioni. Pure il distacco da casa per la
133
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
prima volta gli fu doloroso». Sappiamo ancora dal romanzo di Sergio Campailla come Carlo Winteler avesse fatto cancellare dagli appunti della madre il brano
su Nadia Baraden, suicida nell’aprile del 1907: distacco feroce, le cui conseguenze
in termini di esortazione etica Carlo si porterà fino alla morte. Ancora sulla partenza di Mreule, Paula usa la medesima espressione con un carico di connotazione significativo: «Nell’ottobre di quell’anno partì il suo Mreule per l’America del
Sud e quel distacco lo scosse profondamente». Una sensibilità acuta avverte anche una breve separazione, dagli amici, quelli fiorentini e quelli goriziani a turno,
dolorosamente percepita alla stregua di un addio, di una mancanza, di un vuoto che la sua “filosofia”, d’altra parte, ammetteva, lo si è detto, quale elemento necessario. Dialettica lacerante, tra gli elementi più rilevanti della personalità di Michelstaedter, nella coerenza estrema di voler unire la prassi quotidiana all’ideale,
sull’esempio del Brand ibseniano.
L’esperienza matura di Carlo, documentata dall’Epistolario, inizia e procede
sotto il segno del distacco 24 per chiudersi in senso contrario e probabilmente analogo, nella famosa legge di coincidenza degli opposti: Carlo ha compreso la necessità ormai di seguire la propria strada a livello teoretico e si appresta a intraprenderla nella prassi, tentando titanicamente di unire l’ideale all’azione in modo coerente fino al particolare più infimo. Tale dialettica in costante climax crea,
nell’ambito lacerante del distacco, una caratteristica situazione aggrovigliata e ossimorica tra disadattamento a vivere fuori dal nucleo familiare e marcata prospettiva di autosufficienza, via via più necessaria, come testimonia uno dei documenti più alti dell’intera esperienza umana di quegli anni, la lettera alla madre del 10
settembre 1910. Vivere nell’attesa di ricevere e nell’ansia di esprimere, sintetizza
così, acutamente, Campailla la prima parte dell’epistolario, dominata dalle lettere ai familiari, di cui la primissima a Gino, il fratello maggiore, trasferito a New
York già nel 1893, data 1902. Dopo il suicidio di Nadia, avvenimento di fondamentale importanza, avvenuto a Firenze, mentre Carlo era tornato a Gorizia per
le vacanze pasquali, le lettere ai familiari diminuiscono, ma non quella dialettica,
legata a fattori interiori o alle figure degli amici, fiorentini, Chiavacci e ArangioRuiz, o goriziani, Nino e Rico. Si tratta, sempre e comunque, di una «corsa vertiginosa»: estrapolate dal contesto e trasportate a livello sintetico e descrittivo di
un’intera esperienza “fuori di casa”, le due espressioni sono indicative di una percezione esistenziale, del rapporto di osservazione del nuovo rispetto a una consuetudine che il mettersi in viaggio muove più urgentemente.
L’idea della corsa vertiginosa rende il senso di un pathos esasperato, di una ferita costantemente aperta, modalità visceralmente empatica di vivere ogni attimo
segnandolo nella mente, per poi essere capace di condividerlo con i familiari nelle lettere, ancora per molto, almeno fino al 1908, al centro della sua vita affettiva.
Le annate dell’Epistolario si aprono con questa evidenza, fin dall’inizio, come si è
visto. Rimandando l’analisi minuta di queste lettere, peraltro esaminate splendidamente nell’intervento di Simona Costa, ad altra occasione, per i necessari limiti di brevità di questo intervento, ci limitiamo a qualche esempio, dove incontriamo di nuovo il nostro sasso.
Il 1907 si apre con una partenza e con un distacco, proprio da Paula, che raggiunge a Vienna la sorella maggiore e il cognato Silvio Morpurgo: dopo un attacco sboccato, estroverso, condito da espressioni dialettali (probabile schermo al dispiacere per la lontananza), il tono si fa più decisamente melanconico descrivendo il grigiore del luogo topico del distacco,
134
quella stazione nordica, quel paesaggio all’intorno freddo, invernale, con qualche pallida,
sperduta traccia di sole che non riesciva a spiccar un’ombra sola, quel cielo incerto, indefinito, s’accompagnava così perfettamente col nostro senso di profonda malinconia, di irresistibile malinconia. Specialmente per me, mentre la dolorosa impressione della tua partenza s’unisce all’allegra prospettiva della mia partenza, a quel senso di nausea, di stanchezza, di noia, di spleen, di scoraggiamento, che deve seguire a qualche ora di piacere,
a 2 settimane di pace e di felicità spensierata. Firenze mi spaventa, la mia stanza fredda
mi terrorizza 25.
La lettera continua con la paura di non essere all’altezza dello sforzo mentale
richiesto dallo studio per arrivare a quella sospirata laurea, sentita già come impegno da onorare per la dedizione della famiglia. Così i tempi della Firenze come città in cui riversare la meraviglia del gran turista sono ormai lontani. «Mi fa
impressione che i giorni passati a Gorizia si siano vertiginosamente sprofondati
nel passato, che le circostanze che li informarono, non possano più ripetersi» 26.
La prima lettera del 1909 viene indirizzata a Gaetano Chiavacci, da Gorizia:
Carlo si sente dimezzato, con una parte di se stesso volata via. Distaccata, dimidiata. Soffre a una gamba, si sente ridicolo e menomato, possiamo immaginare che
avverta questa vicenda alla stregua di una punizione dovuta all’invidia degli dei
per le due settimane passate con Mreule intensamente, sulla via della perfezione,
con passeggiate, discese sulla neve, discorsi filosofici. Piccolezze rispetto alla tragedia consumatasi lontano ma orrendamente vicina: arriva la notizia della morte del fratello, ad aggiungersi drammaticamente a quella di Nadia, con una forza
devastante, tanto più che anche in questo caso si tratta di suicidio. Da Firenze, il
30 marzo, scrivendo alla famiglia da poco colpita da quel lutto, oppone, al distacco irreparabile, il desiderio di rifare le valigie, di tornarsene a Gorizia, per vivere
uniti quel dolore. La solitudine di Firenze, l’impegno dello studio non hanno più
senso, erano legati alla presenza di Gino, alle sue visite, alla sua testimonianza, sia
pur da lontano (e idealizzata). «Passassero almeno questi mesi», scrive il giovane,
intendendo quelli di impegno fiorentino e invocando la venuta in città delle ama135
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
te sorelle. Nei momenti in cui gli torna la voglia di lavorare e di impegnarsi, nella solita, scoperta oscillazione, tra dolore e necessità del distacco, Carlo dichiara
di lottare per la vita e per il sole «contro quell’aridità e quell’oscurità» della vita
universitaria, per i sassi puri del San Valentin. L’opposizione è chiara tra i falchi
e le cornacchie: i primi puntano verso l’alto, le seconde, svolazzando basse nella vita della rettorica, continueranno a sostare in quel luogo come in qualsiasi altro, vivacchiando e procurandosi il cibo necessario alla sopravvivenza. Vorrebbero arruolare Carlo e i suoi amici in questa vita insulsa, dominata dalla paura della
morte e dall’ansia per il futuro, mitigata solo dal possesso materiale. La laurea resta, indubbiamente per lui, il pedaggio da pagare alle cornacchie, l’entrata in quel
mondo a cui vorrebbe sottrarsi ma che intanto gliela «fa pagare» salata, non concedendogli la dilazione richiesta. In una comprensibile tristezza, il giovane si domanda quale sia, in fondo, la differenza tra le cornacchie e il falco se entrambi, alla fine, vivono per mangiare e vivono e mangiano per morire, «ma lasciatemi almeno per questi mesi l’illusione che valga realmente più un falco. Perché soltanto
così le cornacchie finiranno col dargli la cittadinanza fra loro – voglio dir la laurea» 27. Con la metafora si è tornati da dove eravamo partiti, ovvero quasi al termine della troppo breve esistenza di Carlo Michelstaedter, sulle tracce dei suoi itinerari e dei suoi luoghi, nei quali, con tutta evidenza, Pirano e il San Valentin sono i privilegiati scenari metaforici dell’aspirazione all’alto o alla navigazione con il
mare in tempesta. Con ironia, amara, nella medesima lettera del 30 marzo, si citano le rovine del Valentin: «lavoro per una rovina», rivelandone ancora il simbolismo, in quella intimità tra i giovani di cui si è detto, con evidentemente rilevanza
mitica. L’ambiguità della parola rovina, si ricordi l’accenno al terremoto di Messina, si rende qui arma efficace alla pungente autoironia del giovane, se si riflette in
linea con la convinzione di parlare al deserto, pur nella veste persuasa dei falchi:
nelle loro altezze, non fanno altro che girare intorno a un messaggio di civiltà ridotto a mura dilaniate dal tempo e comunque hanno bisogno della rettorica per
continuare a vivere, inevitabilmente simili alla cornacchia.
Alla prima comparsa di Mreule (a cui però confida di aver sempre parlato
«di nascosto», mentre apparentemente dialogava «con altri») nell’epistolario, il
14 aprile dello stesso anno, una quindicina di giorni dopo, la metafora si ripete,
nel racconto di una gita a Carnizza, dimostrazione che il San Valentin non è solo quella cima, ma diventa la cima, come luogo unico, per dirla con Pavese, anche
espressione di un linguaggio alternativo condiviso fino in fondo, nella diversità
delle scelte, dai tre amici: «Mi pareva di essere un falco che difendesse la purezza
dei sassi e dell’aria sulla cima del S. Valentin contro un volo di cornacchie» 28. Segue però, al dispiegamento di energia, il suo rovescio: ancora una volta si sta calpestando, forse, un’ombra di fumo, scrive in greco all’amico. La lettera è piena di
allusioni, di riverberi, di conflitti e labirinti, tra la decisione e l’inerzia, il vizio di
essere cornacchia a cui ci si vorrebbe sottrarre, atteggiamenti sintetizzati nell’inquietudine espressa dalla poesia spagnola di Ramón de Campoamor cara a Carlo.
Il volo del falco (si noti ancora l’espressione «come il Valentin» e «come da noi»),
riverbero di un’esperienza mistica, viene tarpato a causa di un episodio tanto banale quanto sicuramente da leggersi in chiave «fisica e metafisica», proprio quando i due termini si stavano conciliando nell’ascesa e grazie alla musica:
136
Un giorno sentii l’Eroica di Beethoven – eroica davvero – e il giorno seguente andai
fuori per la campagna, e sopra un monte “puro” ancora abitato dai falchi come il Valentin, con un sole chiaro e l’aria limpida come da noi; quando fui presso la cima cominciai
a correre per l’attrazione dell’alto e ad esultare dalla gioia; e scendendo presi la corsa attraverso i cespugli e i crepacci per il pendio molto ripido. – E lì mi storpiai mettendo un
piede in fallo e insistendoci per non perdere l’equilibrio 29.
Da falco a cicogna, il momento di entusiasmo è punito con la condanna a portare le stampelle, grave in un ragazzo di questa sensibilità e per il quale l’energia della fisicità rappresenta un culto anche morale. D’altronde la frusta del destino impone a Carlo la necessità di staccarsi da queste contingenze: scrivendo non
per nulla in greco all’amico, sintetizza i termini del distacco giunto a maturazione
nella Persuasione, intravisti nel necessario strapparsi di dosso ogni amore, sia pur
quello del bene: «solo l’anima nuda è libera».
Passano una ventina di giorni da quella lettera e, dopo un malinconico distacco alla stazione dalla sorella Paula che aveva trascorso qualche giorno a Firenze,
alla stessa, per lettera, esprime il desiderio di avere con sé, se può spedirgliela presto, «una pietra del S. Valentin, così ci farò l’ascensione ogni mattina. Ci si illude
di esser vivi, soltanto perché non siamo ancora morti» 30.
Il valore simbolico del sasso del Valentin accompagna dunque Carlo nella
complessità sentimentale e filosofica del distacco: necessario ascendere alla cime,
difendere la libertà dalle cornacchie, portare con sé qualcosa di perennemente legato alla terra da dove si proviene e da dove, con gli amici, si è inaugurata «l’altra
società», almeno per alcuni istanti sublimi di pienezza.
Il piede gonfio non parla, ribadirà alla sorella il 10 maggio, e il tema sarà al
centro di un gustoso dialogo delle Appendici critiche 31. La dolorosa infermità è
ancora accennata il 6 giugno, quando, arrivata la pietra, il cui valore è incommensurabile a tutti i marmi di Toscana, Carlo descrive minutamente lo stato del suo
piede, la penosa situazione di «cicogna», ma “annusa” con grande piacere la pietra del Valentin e chiede alla sorella se, andando in cima, avesse trovato «la nostra casa, con la tavola, i sedili, il camino» 32. La lettera di Paula ha lo slancio poetico e la libertà di quei monti agli occhi di Carlo. A Mreule, poco dopo, scrive di
137
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
sentirsi come Prometeo incatenato, reso schiavo da inutili cure e dai nervi malati
per immobilità. Finalmente (ma gran parte delle lettere da Firenze, in quella prima metà del 1909, ha sapore di distacco), tornato a Gorizia, il 29 giugno scrive a
Chiavacci di esser pieno di stupore nell’aver ritrovato i luoghi cari, ma di essere
già avvolto dalla melanconia. Per la prima volta, in modo esplicito, dichiara che è
meglio la partenza del ritorno, capovolgendo tutta la serie di impressioni dettate
nella prima parte dell’epistolario. Eppure, l’impressione avuta nello spuntare delle Alpi illuminate e del San Valentin, «inaspettatamente viva che ancora adesso
mi meraviglia» 33, non ha niente che ora le rassomigli. Sembra ormai che il falco
non si possa più adattare a vivere nel fango, in basso, tra il putridume dei cadaveri, dove svolazzano le cornacchie. Anche le letture, il Vangelo, il Qoelet, Brand, si
innalzano vistosamente ad altezze ineguagliabili e la frattura con la vita quotidiana si rende insopportabile. Quella del 2 settembre del 1909 a Rico è un’altra lettera fondamentale, di un esame di coscienza spietato, per il fallimento della ricerca
di un centro, senza la quale neanche l’amicizia è degna:
tesi come logica inevitabile dell’esistenza umana, ammirando chi ha avuto il coraggio di una svolta: l’annata si chiude e si riapre, già l’abbiamo considerato, sotto l’insegna del viaggio di Rico. La lettera del 28 novembre 1909, a cui Carlo appone anche l’indicazione temporale delle sette di sera, conserva un’aura d’infinito e di mistero, quasi si trattasse di un biglietto abbandonato dentro la bottiglia,
in viaggio verso quell’ignoto dove l’amico si stava orientando. Atmosfera fondata
da uno straniamento temporale, nel paragone tra un esserci pieno di dettagli futili, circondato da libri, ma avvertito come una soffocante prigione, e un altrove
vertiginoso dove Pola («mentre scrivo qui al lume della lucerna nel mio posto solito come tu mi vedi, – tu, io penso, sarai già all’altezza di Pola» 36) diviene il simbolo della lontananza, il crocicchio di uno spazio e di un tempo indefinito, senza
alcun confine, speranza e progetto allo stato puro di inizialità. Nei bordi di questi
confini, l’io cerca il tu dell’amico, con una confidenza amorevole particolarmente connotata. Mreule attua il suo piano in gran segreto e tocca a Carlo avvertire
il padre dell’amico del vero intento del suo viaggio fino a Trieste. Egli commenta, mettendo in risalto la mentalità comune e il coraggioso gesto dell’amico, che
aveva dolorosamente «sofferto nell’inerzia». Breve e intensa la lettera che chiude il 1909 (ma la data è incerta), e che idealmente possiamo riconnettere a quella dal Valentin, che leggiamo immediatamente dopo nell’edizione dell’Epistolario, ad aprire il 1910:
Ho riso di tutto e ho vissuto per sport. Ed ora che ho conosciuto cosa era la mia sicurezza ed ho preoccupato il futuro, che mi resta se non il riso maligno, e il dolore bruto per
la brutalità irriducibile della forza che mi tiene in vita? peggiore questo dolore che tutto
il dolore che ho provato quando vedevo per la prima volta. Solo una reazione avrei potuto avere – così pensavo nella mia speranza, solo una reazione mi resta ora: d’andarmene,
di distruggere questo corpo che vuol vivere 34.
La natura selvaggia del corpo, quella tensione energetica, la stessa però che
porta alla cima del San Valentin o alle interminabili gite sui colli fiorentini, alle
nuotate in solitaria di Pirano, lo attacca a una vita senza valore, finisce per essere
sport vuoto, nell’allusione evidente a una fisicità agonistica altrove strumento per
la lotta verso le altezze della purezza e della conquista di identità. In un’oscillazione toccante, ferita sempre aperta, tra ricerca d’affetto, in particolare nella famiglia, colpita dalla tragedia del fratello, Carlo scrive allo zio di cercare con dignità
di essere al proprio posto o di non stare in nessun posto più, accentuando ancora
una volta un sentimento di distacco, per la partenza di lui e per quella, ormai irreparabile, da Gino, il cui dolore era stato riaperto appunto dalla visita dello zio
da New York. Lo zio, andato con successo a far fortuna negli Stati Uniti, appare al nipote persona al di fuori delle volontà parziali, quei temperamenti speciali che si sentono affini a tutto. Carlo, in questa dolorosa immobilità, tesse le trame della sua opera maggiore; ne è una sintesi un’altra lettera di importanza capitale, a Chiavacci del 29 novembre: al rifiuto del suicidio come ipotesi conclusiva
oppone la via ardua della persuasione. «Tutto dare e niente chiedere» 35, non prima di aver sottolineato «il distacco definitivo» dall’amico dopo la chiusura della
138
Mentre tu in questo tempo hai agito così da vincere l’inerzia nemica delle cose, io sono ancor sempre così come m’hai lasciato diverso da me stesso. Così per quanto ho sentito di te e più desidero sentire, meno mi sento voce di parlarti. Addio Rico. Tuo Carlo 37.
Al giovane goriziano, in questi ultimi mesi, non sfugge di vivere il contrasto,
ben definito da Campailla, tra il cristallo della Persuasione e la Rettorica e il magma impuro dell’Epistolario 38. Prima di chiudere la tesi di laurea definitivamente,
si concede un benefico soggiorno a Pirano. La notte tra il 2 e il 3 settembre, Michelstaedter scrive al cugino Emilio una delle lettere più significative dell’intero
Epistolario, intonata all’energia, al superamento dello stallo del deserto (la casa
vuota delle parole inconsistenti) usando la metafora del mare, così presente nelle
liriche, in una superba descrizione della costa istriana. Da tempo Michelstaedter
non aveva potuto guardare al paesaggio con quella sua vocazione pittorica così ticfr. cit. in Papini
pica: «Il porto non è dove gli uomini fanno i porti al riparo della loro trepida vi- Pieretti
ta; il porto per chi vuole seriamente la vita è la furia del mare perché egli possa
regger dritto e sicuro la nave verso la meta» 39. La tenerezza verso il cugino, di cui
si è eletto, con l’impegno delle ripetizioni, a guida spirituale, trasforma in energia attiva, quella dei momenti astrali della Persuasione, le ansie angosciose di inadeguatezza alla sua stessa “filosofia”. Il mare lo ha rigenerato, è pronto per risali139
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
re le vette, come il falco, verso la purezza. Dopo esattamente una settimana, Carlo
risponde alla madre, in una lettera celebre, in cui stigmatizza, su un piano strettamente personale, il dovere del distacco. Con quella appena citata a Emilio, formano un dittico involontariamente testamentario, ai due capi opposti delle generazioni: esortazione al giovane, nella sicurezza della sua impronta caratteriale già
impostata a seguire la via luminosa, ferma volontà espressa alla madre di doversi distaccare definitivamente dalla famiglia, per affrontare quel vasto mare aperto in tempesta da solo, in ogni attimo, perché proprio in quell’attimo, in ogni attimo deve infiammarsi il momento della persuasione, il presente vivo per sé stesso, che niente può togliere – nemmeno la morte. A questi documenti, sull’identica linea del dovere di un distacco definitivo, consegnato alle persone più “care” al
mondo, si deve aggiungere quello poetico, dedicato a Paula:
elitico di Valdirose, in territorio sloveno, poco oltre il confine. Il cimitero è detto
in ebraico Beth Ha Chajim, cioè La Casa dei Viventi. Chiuso dal 1947, introduce
in un’atmosfera senza tempo. Le tombe sono rivolte a oriente, in direzione di Gerusalemme. Sotto due alti cipressi il cippo funerario con il nome “Carlo Michelstaedter” e la nuda annotazione “suicida/senza lapide”» 43.
Lasciami andare, Paula, nella notte
a crearmi la luce da me stesso,
lasciami andar oltre il deserto, al mare
perch’io ti porti il dono luminoso
[…]
molto più che non credi mi sei cara 40.
L’ultimo dipinto di Michelstaedter è un paesaggio 41, recante sul retro la scritta: «E sotto avverso Ciel – luce più chiara» 42. La dialettica contemplazione-azione, la lotta aspra contro la comunella dei malvagi, la sovrumana scelta del distacco ascetico della persuasione, si è spostata all’aperto e la forza della luce sembra
possedere la potenzialità di emergere fra le tenebre. Doveva essere un regalo di
compleanno alla madre: «Nell’oscurità della vita Carlo era pura luce che avrebbe
sconfitto il male della materia». Il dono non fu mai consegnato e come sappiamo,
nel giorno del compleanno della madre, il figlio si dà la morte. Decisione sintetizzata dagli ultimi due disegni, quelli della lampada fiorentina, nella copia definitiva della Persuasione e la rettorica e negli Indische Sprüche con l’espressione in greco così tradotta da Campailla: «La lampada si spegne per mancanza d’olio. Io mi
spensi per traboccante sovrabbondanza». Sovrabbondanza che è anche energia fisica non comune, ribelle, a tratti bizzarra e capricciosa. Il sasso del San Valentin,
regalato dalla “cara” Paula, per ammaestrare il distacco da lei e dai “suoi luoghi”,
e insieme simbolo di libertà da difendere, rimane testimonianza materiale di una
superiore genialità che seppe farsi profezia. «Il sasso usato dalla famiglia per anni
come fermacarte, fu poi portato via dai tedeschi nel novembre 1943». Sasso inciso
dalle note di tragedia, come da un’esperienza di luce irrepetibile. Pietra sei e pietra tornerai, sembra suggerire il catalogo della mostra di Gorizia, nella didascalia
di Sergio Campailla: «Tomba di Carlo Michelstaedter. Si trova nel cimitero isra140
note al testo
1
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, catalogo della mostra a cura di S. Campailla (Gorizia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, 17 ottobre 2010-27 febbraio 2011), Venezia, Marsilio, 2010, p. 49.
2
Ibid.
3
P. Michelstaedter Winteler, Appunti per un biografia di Carlo Michelstaedter, in S. Campailla, Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, p. 155.
4
L. Fabi, Sul Collio della Grande Guerra, Gorizia, Edizioni della Laguna, 1992, p. 33. Dello stesso autore la più ampia monografia Id., Gente di Trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull’Isonzo, Milano, Mursia, 1994.
5
L. Baratter, Dagli Altipiani a Caporetto, Luserna, Centro Documentazione Luserna Onlus, 2007, p.
164.
6
Sulla simbologia del monte in questione, sulle sue leggende raccontate da Michelstaedter e sulla consuetudine dei tre giovani, S. Campailla, La leggenda del San Valentin, in Scrittori giuliani, Bologna, Patron,
1980 e la bella biografia L. Matteusich, Nino Paternolli biografia, Gorizia, B&V editori, 1999, in particolare le lettere di Nino a Rico, sul Valentin e appena dopo la morte di Carlo sul significato di quella amicizia.
7
Sul tema dell’energia e della contemplazione, in particolare nelle liriche e in riferimento alle figure
femminili, si veda Antonello Perli, Oltre il deserto. Poetica e teorica di C.M., Ravenna, Giorgio Pozzi, 2009.
8
Sul tema si veda Le vie del mondo. Berlino, Budapest, Praga, Vienna e Trieste. Intellettuali ebrei e cultura europea dal 1880 al 1930, Milano, Electa, 1998, con il saggio di R. Callimani, Le vie del mondo ovvero
la storia i destini e le avventure di ebrei erranti. Più specificatamente per il nostro, esiste una vasta bibliografia critica sull’ebraismo. Ricordo almeno i lavori di Pieri, tra cui La differenza ebraica. Grecità, tradizione e
ripetizione in C.M. e in altri ebrei della modernità, Bologna, Pendragon, 2002, oltre ai vari riferimenti nei testi che si citeranno di Sergio Campailla.
9
Il tema dell’alto si intreccia a quello dell’agonismo, della sfida, della salute e della corporeità. M.A.
Raschini, Michelstaedter, Venezia, Marsilio, 2000, nella terza edizione di un volume apparso per la prima
volta nel 1966, vede Michelstaedter come profeta e testimone “minore” del nostro tempo, secondo la categoria che potrebbe adattarsi al pensiero di Nietzsche, dove il filosofo tedesco è protagonista e il goriziano,
appunto, il testimone, a partire da un’unità inscindibile tra pensiero “filosofico” e necessità di espressione
in poesia. Entrambi poi concordano nel profetizzare un evento di rinascita del tempo, in cui far saltare la
menzogna della società. A p. 13 «il michelstaedteriano bisogno di “scalare qualunque cima”, di “scendere in
qualunque precipizio” ha pieno riscontro con il nietzschiano possesso di una fatalità che, in quanto “voluta”, da dominatrice si rende dominabile e dominata». Del versante corporale parla, tra gli altri, M. Fortunato, Aporie della decisione, separatezza del soggetto e saggismo filosofico da Weininger e Michelstaedter ad Adorno, Verona, Guerini Scientifica, 1996: attraverso un frammento di Minima moralia di Adorno che sembra
stampato apposta per Michelstaedter, lo descrive come sempre il primo della classe in tutto, nella sua precoce maturità, avendo a dispetto ogni limacciosità, riflessione pigra o indugio. Tesse insomma per lui un elogio
della fluidità, nell’ambito di un’interessantissima aporia centrale a p. 67: «Così dal suo libro spira l’aere della morte, in singolarissimo contrasto con le pagine in cui Michelstaedter, il grande nuotatore che si era sempre preoccupato di conservarsi in una forma fisica inappuntabile e anche per questo veniva venerato da un
manipolo di amici fidatissimi come un semidio, tesse sperticati elogi della vita all’aria aperta in diretto, temerario contatto con gli elementi naturali».
10
Michelstaedter Winteler, Appunti per un biografia di Carlo Michelstaedter, cit., p. 155.
11
Sulla simbologia del mare e della spinta al viaggio interviene M. Cerruti, “Fra la miseria dei battuti
scogli”. Michelstaedter, settembre 1910, in «Revue d’études italiennes. Université de Provence», 2, 1998. La
141
fabio pierangeli
il sasso del san valentin
centralità della partenza di Mreule per la vita e le riflessioni di Carlo in quegli ultimi fervidi e tragici mesi
della composizione della tesi viene sottolineata con forza da F. Innella, Michelstaedter e la ricerca della permanenza, in E sotto avverso ciel luce più chiara. Michelstaedter tra nichilismo, Ebraismo e Cristianesimo, a cura di S. Sorrentino, A. Michelis, Troina, Città aperta, 2009, pp. 232 ss.
12
Si veda la lettera di Nino Paternolli a Carlo, prodotta da S. Campailla in Dialoghi intorno a Michelstaedter, a cura di S. Campailla, Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988, p. 29.
13
S. Campailla, A ferri corti con la vita, Gorizia, Comune di Gorizia, 1974, p. 135.
14
Matteusich, Nino Paternolli biografia, cit., pp. 56 ss.
15
Si veda, proprio attraverso le lettere e la testimonianza di Ervino Pocar e di Biagio Marin, le commosse pagine dedicate da Matteusich alle ultime giornate di Nino: la settimana del Cai il desiderio di tornare la domenica successiva ancora in montagna, perché si sentiva soffocare nella “bassura”. Ma tutto il volume è assai interessante per la ricostruzione, attraverso l’esistenza di Nino, dei tratti di assolutezza di tutta
una generazione, quella dei Michelstaedter, dei Mreule, dei Pocar, dei Marin.
16
Ho potuto consultare gli originali di queste lettere, con i frammenti autografi di Nino, grazie alla
gentile disponibilità di Antonella Gallarotti, che ringrazio.
17
C. Michelstaedter, Epistolario, nuova edizione riveduta e ampliata, a cura di S. Campailla, Milano,
Adelphi, 2010, p. 453.
18
Id., Poesie, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1987, p. 96.
19
In una lettera a Carlo dell’aprile del 1909, Rico, raccontando di come scendendo dal monte leggesse
Leopardi, afferma che sulle alture tutto diventa chiaro: il problema è discendere. Le lettere di Mreule a Michelstaedter sono pubblicate da Campailla in Dialoghi intorno a Michelstaedter, cit., da p. 25. Ci rimangono
dal viaggio solo brevi saluti, da Almeria, Spagna, 3 dicembre 1909 e da Neuquen, Argentina, di data incerta.
20
Michelstaedter, Epistolario, cit., p. 421. Si veda anche S. Campailla, Una giovinezza sempre, in Carlo
Michelstaedter, far di se stesso fiamma, cit., p. 12.
21
Campailla, ricostruendo la vita di Nadia Baraden, anche qui con incredibili rivelazioni e scoperte,
alzava il velo anche su questo episodio, scovando articoli di giornale che descrivevano inconfutabilmente gli
avvenimenti. Cfr. Id., Il segreto di Nadia B. La musa di Michelstaedter tra scandalo e tragedia, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 221 ss.
22
Cfr. il citato lavoro di Antonello Perli, pp. 40 ss.
23
C. Michelstaedter, Il dialogo della salute e altri dialoghi, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi,
1988, p. 85.
24
Si veda anche G. Taviani, Michelstaedter, Palermo, Palumbo, 2002 per cui, a p. 12, le prime pagine
del diario di Michelstaedter si presentano come un vero e proprio «plurilinguistico diario di viaggio, in cui,
con un certo rischio d’immaginazione, è possibile rintracciare un’embrionale concezione di poetica», insieme a una prima possibile collocazione intellettuale dentro il nascente Novecento.
25
Michelstaedter, Epistolario, cit., p. 172.
26
Ivi, p. 173.
27
Ivi, p. 375.
28
Ivi, p. 380.
29
Ivi, p. 381.
30
Ibid.
31
Si veda, su questo, l’intervento di M. Ficara, Carlo Michelstaedter. Dal deserto al mare, in Attorno a
questo mio corpo. Ritratti e autoritratti degli scrittori della letteratura italiana, Matelica, Hacca, 2010.
32
Ivi, p. 413.
33
Ivi, p. 424.
34
Ivi, p. 431.
35
Ivi, p. 444.
36
Ivi, p. 445.
37
Ivi, p. 450.
38
Campailla, Il segreto di Nadia B., cit., p. 233: «Il rapporto, sfuggente e da ribadire, è tra il cristallo e
il magma, tra l’assoluto della Persuasione e il vissuto impuro di quell’altra opera che è l’Epistolario, in un regime devastante di doloroso occultamento e di dualismo».
39
Ivi, p. 472.
40
Michelstaedter, Poesie, cit., p. 72.
41
Sul paesaggio utile il confronto con i brani del Taccuino del 7 agosto del 1905: cfr. A. Gallarotti,
L’immagine irraggiungibile, in C. Michelstaedter, L’immagine irraggiungibile. Dipinti e disegni di Carlo Michelstaedter, catalogo generale delle opere, a cura di A. Gallarotti, Monfalcone, Edizioni della Laguna,
1992, pp. 81 ss.
42
Carlo Michelstaedter, far di se stesso fiamma, cit., pp. 118-119.
43
Ibid., p. 181.
142
143
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
Complesso si presenta l’itinerario spirituale di Carlo Michelstaedter. Tale itinerario tuttavia sembra trovare il suo nucleo unificante in una profonda tensione
morale che ha come meta ultima la vita autentica. Questa prospettiva è quella che
contraddistingue l’uomo che ha scelto la persuasione e l’ha elevata a stile di riflessione e di comportamento.
Il persuaso per Michelstaedter altri non è che «colui che è per sé stesso (μένει)», cioè che possiede già tutto e che «non ha bisogno d’altra cosa che sia per lui
nel futuro» 1. Poiché vive esclusivamente delle proprie risorse, egli è autosufficiente e gode di un’assoluta autonomia. Non per questo, però, esclude ciò che è diverso da lui, contrario alla sua struttura, ma lo riconduce a sé, lo riporta dentro l’orizzonte del proprio essere. In quanto non lascia alcunché fuori di sé, il persuaso si
propone anche come un’unità che ricompone tutto in tutto. Egli, sostiene Michelstaedter, equivale al Soggetto assoluto, in cui è portata a compimento la possibilità di «crearsi da sé la vita» 2.
Nella sua specificità, dunque, l’uomo della persuasione incarna un’esistenza
che si ispira alla filosofia parmenidea: gli è costitutivo essere Uno, cioè compiuto e pienamente realizzato in se stesso. Non ammette perciò alcuna forma di alterità che gli resti ancora da conquistare e per cui debba impegnarsi. D’altra parte, osserva il goriziano, «se diciamo che è l’uno, esso deve aver tutto in sé (dev’esser αὐτάρϰες)», perché, «se non ha tutto in sé, manca di qualche cosa»; ma per lui
mancare di qualche cosa equivale a mancare di tutto, in quanto, se non è completo, non è ἑός, e «se non è ἑός è οὐδείς». E ancora: nel caso in cui sia privo di qualche cosa, egli potrà colmare questa lacuna successivamente; ma allora la cosa di
cui è attualmente privo è nel futuro e, viceversa, «il suo futuro è in questa cosa» 3.
Ciò significa che nel presente egli non è in se stesso, cioè non è né compiuto né
uno; anzi, in un certo senso, equivale a nulla, perché ciò che dovrebbe essere è
nella cosa di cui è privo.
Ma non solo; se il compimento fosse riposto nel futuro, gli sarebbe preclusa
la possibilità di stare fermo: egli dovrebbe muoversi e, al tempo stesso, dovrebbe
mutare continuamente il proprio aspetto. Tuttavia, se si ammette che egli possa
modificare la propria condizione «in questa relazione e in quella», si deve convenire anche che non ha tutto in sé e che manca di qualche cosa, giacché «se ha tutto in sé, non c’è spazio fuori di lui, e non ci sono cose in relazione alle quali egli
abbia a mutarsi» 4. Inoltre, in tale eventualità, egli non sarebbe più uno al presente, ma lo sarebbe solo in futuro, dal momento che, mancando di qualche cosa e
quindi essendo incompiuto, è costretto a muoversi e a sottostare a mutamenti. Solo che così egli cede il posto alle relazioni e, poiché gli subentra «la nebbia indifferente irrazionale della correlatività», perde la propria identità e, in qualche modo, sperimenta su se stesso il venir meno della propria vita 5.
Di tutt’altro genere è la condizione dell’uomo persuaso. Questi si comporta
come il falco durante il suo volo, perché «mantiene in ogni punto l’equilibrio della sua persona», senza disperdersi nelle relazioni, e rende attuale la parmenidea
vicinanza «di ciò che è lontano» 6. Nella persuasione, dunque, risiede per l’uomo
la possibilità di essere se stesso e di sottrarsi al rischio di dissolversi nel nulla. In
ciò che ha di più proprio, tale possibilità non si presenta per lui come un’opportunità qualsiasi, bensì come l’unica che può dare un’impronta specifica alla sua
esistenza.
In virtù di questa sua peculiarità, la persuasione interpella l’uomo e lo investe
nel profondo del suo essere: lo chiama a prendere coscienza della sua insufficienza e a compiere una scelta che comporta una svolta nel suo rapporto con il mondo, perché lo libera dalla schiavitù delle relazioni, gli permette di «impossessarsi
del presente» e di concentrare la propria vita su un attimo totalizzante che «niente può togliere» 7. D’altro canto, chi accoglie questo appello, osserva Michelstaedter, vive tutto concentrato in se stesso e la morte nulla gli toglie, perché «niente in lui chiede più di continuare»: egli vuole «il “possesso” presente» e rifiuta il
futuro 8. La morte, infatti, «non toglie che ciò che è nato», ossia quello che essa
«ha già preso dal dì che uno è nato» in quanto che, con la sua venuta al mondo,
egli «vive della paura della morte», perché così gli è dato «dalla nascita come necessario alla vita» 9.
Nella radicalità della decisione per l’attimo presente, che è «vivo per se stesso», ma che comprende anche «quello che io faccio, […] quello che io sono nella
mia opera d’ogni giorno» 10, il persuaso crea contemporaneamente la propria vita e quella del mondo in cui desidera vivere. Non per questo, però, essi sono rassicuranti per lui, perché sono privi delle leggi, dei valori e delle convenzioni che
costituiscono la sicurezza fittizia della nostra vita inautentica. D’altra parte, il per-
144
145
Michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
di Antonio Pieretti
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
suaso non ne sente la necessità, perché vive totalmente immerso nell’istante presente e non chiede assolutamente altro. In ogni caso, il “qui e ora” a cui si dedica si contrappone al frenetico e vuoto divenire che caratterizza l’agire quotidiano,
perché possiede la pienezza di ciò che è autosufficiente e non necessita di nulla.
La condizione offerta dalla persuasione, però, non è accessibile a tutti: può essere conseguita soltanto da chi è disposto a farne oggetto di scelta e a impegnarsi
per essa, sottraendosi a ogni genere di relazione. A questa opzione, che è unica e
irripetibile perché concerne il presente, è connessa la possibilità di vivere in modo autentico, in quanto equivale a un atto di libertà che dà un nuovo orientamento all’esistenza, restituendole il senso che la rende degna di essere vissuta.
Ma da quali relazioni l’uomo deve svincolarsi per realizzare se stesso, per essere all’altezza della propria natura? La risposta di Michelstaedter non dà adito a
dubbi: deve liberarsi della rettorica che altro non è che il volto falso e ingannevole della vita. Questa, nella sua essenza, è volontà di vivere, cioè rinvio al futuro,
alla maniera della volontà schopenhaueriana. Come tale, la vita è contrassegnata
intrinsecamente da un’insufficienza, da una mancanza che la spinge oltre se stessa. La volontà, infatti, è intrisa di un’incolmabile «deficienza – per la quale ogni
cosa che vive, muore ogni attimo continuando» 11.
Per dare conto della natura particolare che contraddistingue la volontà Michelstaedter ricorre all’immagine del peso che pende da un gancio. Per il fatto
che pende, esso «soffre che non può scendere: non può uscire dal gancio, poiché quant’è peso pende e quanto pende dipende» 12. Liberato dal gancio, il peso può riprendere la discesa verso il basso, ma, quale che sia il punto a cui si arresta, ne avrà sempre di nuovi da raggiungere, che sono posti al di sotto di quello
precedente. Così la tendenza del peso a scendere non sarà mai soddisfatta in modo compiuto, anche perché, qualora «non mancasse più di niente – ma fosse finito, perfetto: possedesse sé stesso, esso avrebbe finito d’esistere» 13. D’altro canto,
la vita del peso è tutta e sola nella possibilità di procedere verso il basso, di assumere sempre nuove posizioni; ma, contemporaneamente, se esso potesse «possedere l’infinito scendere dell’infinito futuro – in quel punto non sarebbe più quello che è: un peso». Ne consegue in modo evidente che «il peso non può mai esser persuaso» 14.
Poiché la volontà è insufficienza, la vita sfugge irrimediabilmente a se stessa in
ogni istante. In essa chi vuole e ciò che è voluto, quale che sia, «saranno sempre
due, e ognuno solo e diverso di fronte all’altro» 15. La dualità implica la differenza, la quale, poiché è incolmabile, comporta l’impossibilità di un possesso stabile
e definitivo. Per la vita, perciò, aspirare a possedersi equivale a non essere mai se
stessa in forma compiuta. Peraltro, se essa si possedesse effettivamente e nulla le
mancasse, cesserebbe di essere volontà di vivere e perciò di essere vita.
Per Michelstaedter, dunque, la vita dell’uomo si dibatte nell’attesa di un esi-
to che è sempre di là da venire. Essa non conosce appagamento in nessuna condizione che è in grado di raggiungere: la voce del bisogno riecheggia in ogni forma che assume e la sollecita sempre a proiettarsi oltre se stessa. Come pure, non ci
sono soste nell’incessante ricerca di sé e nell’inesauribile inseguimento della propria essenza cui la vita è esposta. Vivere, che in sé è volontà che vuole se stessa, di
fatto è sempre e solo volontà insoddisfatta e possesso mancato. D’altra parte, se la
vita si possedesse già nel presente e di niente avesse bisogno, non avrebbe nulla
d’aspettarsi dal futuro: perciò non continuerebbe, ma cesserebbe d’essere, «ché
tanto è vita, quanto si continua» 16.
Va altresì tenuto presente, secondo Michelstaedter, che la soddisfazione della
volontà, anche nell’eventualità in cui sia effettivamente possibile, può riguardare
soltanto un bisogno particolare, ma non ogni bisogno. In questo caso, il complesso delle determinazioni che consentono all’organismo umano di continuare a vivere, benché vi sia coinvolto in tutta la sua articolazione, tuttavia è soddisfatto solo per un aspetto. Ebbene, la soddisfazione di una particolare deficienza non annulla né rende inoperose le altre, ma anzi le attiva, perché è correlata a esse; pertanto dà modo all’organismo di «deficere ancora» 17, cioè di continuare a sentirsi
privo di qualche cosa. A sua volta, ciò che gli manca, proprio perché ne ha bisogno, gli appare esterno e contraddistinto da una propria oggettività. Così, in qualche modo, l’organismo si sente sempre consegnato a ciò che gli manca e l’uomo, a
sua volta, poiché aspira ad appropriarsene, finisce per dargli importanza e per attribuirgli un valore.
Ciò che induce l’individuo a dare l’assenso alle realtà immediate, secondo Michelstaedter, è il dio della ϕιλοψυχία, che altro non è che l’amore per la vita, ossia
ciò che la spinge a soddisfare i suoi bisogni:
146
147
Nella nebbia indifferente delle cose il dio fa brillare la cosa che all’organismo è utile;
e l’organismo vi contende come in quella avesse a saziar tutta la sua fame, come quella gli
dovesse dar tutta la vita: l’assoluta persuasione 18.
Ma poiché è anche un dio sapiente, il dio della ϕιλοψυχία «spegne la luce quando l’abuso toglierebbe l’uso» 19 e ne accende un’altra dalla quale l’uomo crede di
poter ottenere la felicità assoluta. La sua ingannevole opera non si arresta a questo punto, ma prosegue ancora; infatti questo dio onnipotente fa brillare sempre
di continuo nuove luci, lusingando con il piacere. Con questa operazione scompone l’unico vero bene, rappresentato dalla persuasione, in una quantità innumerevole di beni particolari, di cui fa avvertire il bisogno.
È dunque il piacere a fare da guida all’uomo nell’individuazione delle determinazioni adatte a soddisfare la sua volontà di vivere. Per questo ogni cosa che
predilige ha per lui un «dolce sapore»; infatti «la sente sua perché utile alla sua
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
continuazione». Non solo, ma da ciascuna di esse, poiché si afferma con la sua potenza, egli «ritrae sempre l’adulazione “tu sei”», cosicché «volta per volta nell’attualità della sua affermazione egli si sente superiore all’attimo presente e alla relazione che all’attimo appartiene» 20. Ma, così adulandolo, il dio della ϕιλοψυχία
«si prende gioco di lui» 21.
Nell’inseguire il soddisfacimento momentaneo dei suoi bisogni, l’uomo spera di pervenire al possesso di se stesso e delle cose. Di fatto, invece, egli riesce a
ottenere soltanto il miraggio del possesso che non comporta nessuna identificazione effettiva tra chi possiede e ciò che è posseduto. La vita così si risolve per lui
inevitabilmente in una ricerca continua di quello che essa non ha, in una proiezione costante verso il futuro. Ma, poiché «ciò che ha bisogno di qualche cosa per
essere non è» 22, allora la vita di per sé non è. E infatti Michelstaedter la definisce
«una cosa inadeguata (un errore implicito di logica perché è in quanto non è)» 23.
Se la vita fosse, consisterebbe in un punto, cioè «sarebbe una, immobile, uniforme». Però in tal caso non sarebbe più volontà di vivere e dunque tensione oltre se stessa, esposizione al fluire del tempo. Invece, poiché «la necessità della fuga nel tempo implica la necessità della dilatazione nello spazio», cioè «la perpetua mutazione», di qui scaturisce «l’infinita varietà delle cose» 24 in cui la vita ripiega per essere. Non per questo, però, essa realizza se stessa, bensì sprofonda nella finzione, perché, afferma Michelstaedter, nel momento in cui il necessario «è
l’immediato tratto davanti agli occhi», allora «irresistibile fiorisce la rettorica» 25.
Il vivere in maniera rettorica è un vivere guardando avanti e riponendo la possibilità di raggiungere la propria realizzazione in ciò che non si ha. L’uomo che
vi si adegua perciò «altro non è che volontà di se stesso nel futuro» 26. Questa propensione opera in lui in modo da assorbirlo completamente; egli infatti, scrive Michelstaedter, è «tanto occupato dal futuro» che «sfugge a sé stesso in ogni presente» 27.
Per ottenere ciò di cui è privo, l’uomo della rettorica si allontana dalla coscienza di se stesso, dalla propria identità di io, e si immerge nell’infinita correlazione con le cose, facendo sì che tutto, compreso se stesso, acquisti rilevanza da
questo modo di essere. Così, «le sue cose che lo attorniano e aspettano il suo futuro, sono l’unica realtà assoluta indiscutibile» 28. Ed egli, da parte sua, «non dice:
“questo è per me”, ma “questo è”; non dice: “questo mi piace”, ma “è buono”» 29.
Di conseguenza nell’uomo della rettorica nasce la persuasione di essere una cosa
sola con il mondo e di avere raggiunto l’auspicata identità di uno-tutto. Ma, afferma Michelstaedter, si tratta di una persuasione illusoria perché la realtà che vi è
coinvolta – tanto dell’io quanto del mondo – non è che il «contenuto d’ogni mio
piacere: è la “mia coscienza”, è l’“illusione” della mia “individualità”» 30 e quindi
il riflesso dei bisogni che la volontà di vivere esige di soddisfare. È perciò una realtà semplicemente fittizia, perché è costituita dalle correlazioni in virtù delle qua-
li le cose ricevono la vita dall’uomo e l’uomo dalle cose, senza però che né le cose
né l’uomo abbiano una consistenza propria.
Ingannevole è dunque la vita che si ispira alla rettorica, in quanto persegue il
proprio fine attraverso l’assolutizzazione delle cose. Un fine così raggiunto, infatti, è adeguato soltanto al tipo di vita «che essa si finge» 31, cioè a una vita ridotta a
«cosa fra le cose», in balia dei bisogni e schiava «del più del meno, del prima del
dopo, del se del forse» 32.
D’altro canto l’unificazione con le cose ottenuta mediante la rettorica equivale per l’uomo alla realizzazione di se stesso con la mediazione del divenire; perciò per lui è possibile solo nello sviluppo del tempo e, più precisamente, nella dimensione nel futuro. Data questa sua peculiarità, però, tale unificazione non può
rappresentare per l’uomo il suo compimento, perché di per sé si risolve in un processo sempre aperto e mai giunto a conclusione. Egli non può derivare la propria
«individualità» autentica dal futuro, in quanto questo corrisponde a ciò che non
è ancora e quindi a ciò che non può dare l’essere, dal momento che ne è privo.
Poiché «la stessa cosa è il mio vivere e il mondo che vivo» 33, se il vivere, in
quanto volontà che si dispiega nel tempo, è mancanza di essere, allora tale è anche il mondo. Da quest’ultimo, perciò, l’uomo della rettorica può ricavare soltanto la conferma della sua costitutiva nullità. Così si esprime Michelstaed­­ter nei
suoi confronti:
148
149
Niente, niente, niente, non sei niente, so che non sei niente, so che qui t’affidi ed io ti
distruggerò sotto il piede il terreno, so quello che riprometti a te stesso e non ti sarà mantenuto, come tu hai sempre promesso e mai tenuto, non hai mai tenuto – perché non sei
niente, e non puoi niente, io so che non puoi niente, niente, niente 34.
Inoltre, poiché ha lo sguardo proteso in avanti, all’uomo sfugge il possesso
di se stesso, come pure la padronanza della propria esistenza. Per questo, finché
egli opera in modo conforme alla rettorica, non giunge mai alla persuasione, che
è possesso attuale di sé.
L’uomo della rettorica, in verità, «sa quanto vuole» 35 e pertanto è consapevole di ciò che gli è necessario per realizzare pienamente se stesso. Tuttavia, mentre
dichiara di perseguire questo intento, egli di fatto rincorre le cose. Così presume
di essere autosufficiente, invece non si trova mai in questa condizione, perché essa è riposta nel futuro, cioè in un tempo che non è e che deve sempre accadere.
Ciò che l’uomo vuole è la pienezza della vita; però, siccome la ricerca al di fuori di
quello che è, cioè nelle cose, egli s’allontana da se stesso. «Gli sfugge la padronanza della propria vita», afferma Michelstaedter, perché la potenza che può esercitare sulle cose «in ogni punto è limitata alla limitata previsione» 36. In tal modo l’uomo della rettorica dà prova di non sapere ciò che veramente vuole.
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
Per mostrare che non è assorbito interamente nella relazione con le cose, l’uomo talora fa leva sulla conoscenza. Rivendicando la totale indipendenza dell’attività del pensiero, egli attribuisce un valore assoluto sia a tale attività sia all’immagine della realtà che essa è in grado di assicurargli. Infatti «si ferma e dice: io
so» 37. Ma, rileva Michelstaedter, questa non è che «“inadeguata” affermazione
dell’inadeguata individualità» 38 ; pertanto, riporre la garanzia di sapere nell’atto
di pensare, nel cogito, equivale ad ammettere di non possedere il sapere, perché
l’atto di pensare riflette sempre una mancanza, una deficienza che solo in futuro
potrà essere eliminata 39.
Dal momento poi che «pensare vuol dire agitare concetti», che appunto per
mezzo di questa attività «devono divenire conoscenza» 40, ne segue che l’io penso nel presente è vuoto. Scrive infatti Michelstaedter: «La cura del futuro dove io
fingo il mio scopo mi toglie tutto il mio essere» 41. Anche la fiducia nel valore assoluto della conoscenza perciò è mera illusione: non garantisce all’uomo né il sapere né il possesso definitivo di se stesso 42. Anzi, esaminata nelle sue implicazioni,
essa ne rivela l’assoluta inconsistenza ontologica e lo restituisce alla sua condizione di essere in divenire e quindi di non essere.
Nel mettersi «nella posizione conoscitiva», inoltre, l’uomo dà luogo a un dualismo che gli preclude la possibilità di raggiungere l’auspicata unificazione di tutto in tutto. Da un lato, infatti, si trova a vivere immerso nella correlatività con le
cose e a esaurire la propria identità nel rapporto con esse; da un altro, si adopera,
mediante la conoscenza, per proporsi come l’uno-tutto, come il «Soggetto assoluto». Ma, in tal modo, produce in se stesso uno sdoppiamento:
possibilità della sua realizzazione nel futuro, allora viene meno in lui ogni illusione. Per attenuare gli effetti laceranti di questa inquietante scoperta, l’uomo dispone ancora di una risorsa cui appigliarsi, quella offerta dalla scienza. Questa può
rispondere a tale funzione perché consente a chi la pratica di svolgere un’attività
che, «fingendo piccoli scopi conseguibili via via in un vicino futuro», gli dà l’illusione «di camminare» pur stando fermo 46. Ma la scienza, con la sua aspirazione
a cogliere oggettivamente la real­­tà, richiede un soggetto che vi si impegni, dando
così di nuovo prova della sua costitutiva insufficienza e della sua dipendenza da
altro da sé. A ciò si aggiunge che l’oggetto stesso perseguito dallo scienziato non
è che un’illusione, perché «non v’è altra realtà che la realtà del Soggetto» 47. Perciò, secondo Michelstaedter, vedere oggettivamente, come pretende la scienza, «o
non ha senso perché deve aver un soggetto o è l’estrema coscienza di chi è uno colle cose, ha in sé tutte le cose: ἓν συνεχές, il persuaso: il dio» 48.
A volte però accade che «la trama dell’illusione s’affina, si disorganizza, si
squarcia». Allora, osserva il goriziano, «gli uomini, fatti impotenti, si sentono in
balia di ciò che è fuori della loro potenza, di ciò che non sanno: temono senza saper di che temano» 49. In questo caso, non è più la morte a far loro paura, altrimenti continuerebbero a volere, ma la deficienza di essere che scoprono al fondo della loro vita. Poiché «vivono per vivere: per non morire», per essi la vita «non è che
paura della morte. Essi vivono per salvar ciò che è dato loro col nascimento, come
se essi stessi fossero nati con persuasione e stesse in loro arbitrio la morte» 50. Perciò la loro vita, che si fonda sulla certezza della morte, si alimenta della sua paura
e si risolve nello sforzo di tenerla lontano e di procrastinarla nel tempo. Ma quando l’uomo si trova a voler fuggire la morte senza poter ricorrere più alla via consueta offerta dall’illusione, allora prende coscienza della propria inconsistenza e
si sente «sperso in balia dell’ignoto» 51. In tal caso, la volontà di vivere, «interrotta
la voce del piacere che le dice tu sei – sente solo il sordo mormorio del dolore fatto
d’istinto che dice: tu non sei, mentre pur sempre essa chiede la vita» 52.
Questo dolore non proviene dall’esterno, ma dall’interno stesso dell’uomo, a
causa del fatto che egli non è mai in maniera compiuta e definitiva. Data la sua origine, esso può essere occultato, ma non aggirato o soppresso. In ciò che lo caratterizza infatti il dolore comporta un’alternativa che non ammette vie di fuga: l’uomo può rifiutarlo o accettarlo, ma non può restare indifferente nei suoi confronti.
Dinanzi al dolore si dà per lui la possibilità di vivere alla maniera della rettorica o
alla maniera della persuasione. Se si uniforma alla rettorica, egli si adopera incessantemente per infittire la trama delle sue illusioni, allo scopo di non far emergere l’inconsistenza del suo essere e di tacitare il dolore; se invece si ispira alla persuasione, squarcia il velo delle illusioni e trova nel dolore la via per raggiungere la
pienezza della propria vita.
Egli non è più uno ma sono due: c’è un corpo, o una materia, o un fenomeno, o non
so cosa, e c’è un’anima, o una forma, o un’idea. E mentre il corpo vive nel basso mondo
della materia, nel tempo, nello spazio, nella necessità: schiavo; l’anima vive libera nell’assoluto 43.
Questa duplicazione, in virtù della quale l’uomo si dispone a vivere su due
piani distinti, anche se l’uno accanto all’altro, quello della vita e quello del sapere,
costituisce per lui il terreno su cui germoglia la rettorica. Infatti, coloro che vi si
adeguano, poiché non possono fare in modo che il mondo di ciascuno sia il mondo di tutti, «fingono parole che contengano il mondo assoluto, e di parole nutrono la loro noia»: con le parole «essi significano quanto non sanno e di cui hanno
bisogno per lenire il loro dolore» 44.
Finché è impegnato a soddisfare i bisogni e a condurre la vita nell’alter­­nanza
di «rimorso, malinconia e noia, ira, dolore, paura, gioia “troppo” for­­te» 45, l’uomo
si illude di essere, perché questi sentimenti gli consentono di mascherare la paura della morte. Quando però si rende conto che di fatto non è, perché ripone la
150
151
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
Chi vuole fortemente la sua vita – scrive Michelstaedter – non s’accontenta, temendo di
soffrire, a quel vano piacere che gli faccia schermo al dolore, perché questo continui sotto
cieco, muto, inafferrabile; ma anzi, la persona di questo dolore prende e sopportando λύπης
ἀντίρροπον ἄχθος (Soph., Elettra), s’afferma là dove gli altri sono annientati dal mistero 53.
ser padrone e non schiavo nella sua casa» 59. Chiunque voglia imboccare la via che
è offerta dalla persuasione e nella quale è riposta la possibilità di sottrarsi alla dispersione e di raggiungere la salvezza, è tenuto a prendere su di sé la responsabilità
della propria vita, con la conseguenza di dover rispondere a essa e di essa, perché
non troverà nulla di già fatto e nessuno che lo faccia al suo posto. Così «nel nulla chiedere» egli sperimenta la vertigine della propria libertà e della propria solitudine, nonché dei doveri cui deve attenersi per guadagnarsi «in pace la vita» 60.
Se la rettorica è continua violenza dell’uomo nei confronti del suo simile per
soddisfare i propri desideri, per appagare la sua sete di possesso, invece la persuasione, in quanto rifiuto della cieca volontà di perseverare nella vita, ne rimuove la
causa, ne sopprime la possibilità. Per questo Michelstaedter afferma che la persuasione è l’unico modo di essere che toglie la violenza alla radice, estirpandola.
Nella disponibilità a «tutto dare e niente chiedere» 61 è riposto il senso di una vita che a essa si ispira.
La persuasione, peraltro, non si risolve in un semplice stato psicologico, ma
comporta anche un’attività pratica che consiste nel «far beneficio», atto «che ha
in sé la sua ragione di essere, la causa insieme ed il fine, poiché nulla chiede, nulla aspetta, né da alcuna cosa dipende» 62. Infatti, in ciò che lo caratterizza, il «far
beneficio» «non è dare o fare agli altri quello che essi credono di volere», perché
questo in realtà è «subire», ovvero «lasciare che gli altri prendano» 63, ma è dare «perché l’altro “abbia”» 64. Come pure, esso non è dare agli uomini appoggio
alla loro paura, ma è togliere tale paura, ovvero non «dar loro la vita illusoria e i
mezzi a che sempre ancora la chiedano, bensì dar loro la vita ora, qui, tutta, perché non chiedano» 65.
Il «far beneficio» è un atto d’amore; infatti, è proprio di chi ha e dà quello che
ha, vale a dire se stesso, e non quello di cui fa uso. Costui sa che il bene consiste
nel possedere pienamente la propria vita e, forte di questa consapevolezza, si adopera a vantaggio degli altri perché, liberandosi dal terrore per il dolore, acquistino coraggio e pervengano anch’essi allo stesso risultato. In qualche modo, afferma Michelstaedter, «dare è fare l’impossibile: dare è avere» 66. Questo, del resto, è
il precetto a cui si ispira il persuaso in quanto rinuncia ai propri bisogni e dà tutto per avere tutto, si comporta cioè in modo da «avere nel possesso del mondo il
possesso di sé stesso» o, meglio ancora, da «esser uno egli e il mondo» 67.
Paradossalmente, dunque, l’uomo è chiamato al dovere di dare a partire dalla sua costitutiva insufficienza, giacché solo attraverso questa disposizione può far
tacere i propri bisogni e, «facendo la propria vita sempre più ricca di negazioni»,
crea se stesso e il mondo 68. Infatti, sperimentando fino in fondo il dolore che gli
deriva da questa condizione, egli si libera della tirannia del tempo e giunge ad affermare la sua vera individualità.
Questa scelta, peraltro, benché sia vissuta dal persuaso nella sua singolarità ir-
Egli ha infatti il coraggio di strappare la trama delle «dolci e care cose» che inducono a guardare in avanti per ottenere il possesso attuale di se stesso.
Questa condizione, per essere raggiunta, richiede all’uomo l’obbligo di colmare nel presente la sua costitutiva incompiutezza. Comporta cioè per lui la disponibilità a vivere integralmente nel qui e ora, ossia a «vedere ogni presente come l’ultimo, come se fosse certa dopo la morte» 54. Di conseguenza esige dall’uomo che
prenda coscienza di sé, che rinunci ai propri bisogni, che si liberi dell’urgenza di
soddisfarli, anche perché il loro appagamento è solo momentaneo, in quanto essi
risorgono sempre e si rinnovano di continuo, stimolando in lui il desiderio di cercare di assecondarli nel futuro. I bisogni costituiscono per l’uomo l’unico antidoto che egli può opporre alla ricorrente insorgenza della paura della morte. Pertanto essi rappresentano l’espediente più efficace a cui può affidarsi per continuare a
vivere, giacché riflettono la sua volontà di guardare oltre se stesso e di non temere la morte: infatti, «chi teme la morte è già morto» 55.
Del resto,
quando questa volontà d’essere è forte così da non aspettare dal futuro, da non accontentarsi della speranza, da voler tutto in un punto; allora le illusioni e le forme che accontentano gli altri manifestano la loro nullità; allora le condizioni che accontentano la fiducia
dei più manifestano la loro contingenza; allora le forme della vita manifestano la necessità della loro relatività; e in questa l’uomo forte sente tutta la mancanza di libertà e di vita e tutto il peso del dolore 56.
Non deve meravigliare se la scelta a favore della vita persuasa impone una rottura così radicale nei confronti del mondo dei bisogni, perché quanto più l’uomo
li asseconda, tanto più essi lo attraggono, costringendolo a uscire da sé e a rincorrere la propria ombra. Invece chi si eleva al livello della coscienza e assume su di
sé il peso della propria insufficienza, come fa il persuaso, ha il coraggio di stare
«con gli occhi aperti a guardare l’oscurità» 57. Questo però comporta che per lui
«non c’è pane […], non c’è acqua, non c’è letto, non c’è famiglia, non c’è patria,
non c’è dio – egli è solo nel deserto e deve crear tutto da sé» 58.
Quella della persuasione è una scelta assoluta che non ammette fasi di transizione o momenti intermedi. Per essa «ognuno è il primo e l’ultimo», cioè unico:
egli «non trova niente che sia fatto prima di lui, né gli giova confidar che sarà fatto dopo di lui, […] deve creare sé e il mondo, che prima di lui non esiste: deve es152
153
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
ripetibile, tuttavia non lo porta a isolarsi dal mondo. Nel momento in cui egli soffre, vive un’esperienza universale che condivide con tutti gli uomini. Per questo
Michelstaedter può dire che il dolore avrà, per chi se ne sarà fatto carico, «la parola eloquente e la vista lontana» 69.
La via per giungere alla persuasione è aperta a tutti, ma non è per tutti la stessa. Ciascuno cioè è chiamato a trovare la sua, quella che si addice alla sua indole. Del resto, ognuno è diverso dall’altro nel modo di essere persuaso e quindi
non può contare sul suo aiuto laddove è in gioco il senso del suo essere al mondo e la possibilità di realizzare la propria identità personale. In questa opportunità assoluta ciascuno è coinvolto nella sua individualità e come tale egli deve rispondere. «Ognuno deve nuovamente aprirsi da sé la via, poiché ognuno è solo
e non può sperar aiuto che da sé» 70. Siccome poi la via della persuasione «non è
corsa da “omnibus”», cioè «non ha segni, indicazioni che si possano comunicare, studiare, ripetere» 71, ognuno deve trovarla da solo. Chiunque la voglia seguire ne ha l’indice nel dolore prodotto dalla sua condizione e in null’altro; da parte sua, infatti, «non ha che questa indicazione: non adattarti alla sufficienza di ciò
che t’è dato» 72. Oltre che nuova e imprevista, essa è una via che deve essere sempre inventata. Di conseguenza chi decide di percorrerla «deve far cammino dove non c’è strada» 73.
Come non prevede la possibilità di disporre di un itinerario precostituito, la
via della persuasione non ammette neppure soste. Chiunque si fermi a guardare indietro dopo averla intrapresa, si comporta come se la persuasione fosse una
condizione che esiste indipendentemente da chi vi si impegna. Ma così egli rende
nullo il percorso compiuto ed è costretto a iniziare daccapo. D’altra parte, fermarsi non è che un residuo della ϕιλοψυχία, che reclama continue gratificazioni dagli altri, non riuscendo a procurarsele da se stessa. Scrive infatti Michelstaedter:
«L’uomo nella via della persuasione mantiene in ogni punto l’equilibrio della sua
persona; egli non si dibatte, non ha incertezze, stanchezze» 74.
Questo si deve al fatto che il persuaso, a differenza dell’uomo della rettorica,
non cerca di evitare il dolore, ma piuttosto ne ha coscienza e lo accoglie. Peraltro, nel decidersi a «far beneficio», egli prende posizione nei confronti della propria insufficienza e, anziché tentare di aggirarla e di porvi un rimedio provvisorio,
preferisce rinunciare a ogni forma di illusione, riconoscendone l’intrascendibilità.
È per questo che l’uomo della persuasione si assume la responsabilità dell’«amaro» che è riposto in ogni piacere e lo vive nella sua radicalità. E, siccome «questo dolore accomuna tutte le cose, in lui vivono le cose non come correlativo di
poche relazioni, ma con vastità e profondità di relazioni» 75. Nella sua accettazione perciò è riposta per lui la possibilità di realizzare l’unità con il tutto cui aspira.
Michelstaedter fa rilevare che «finché l’uomo vive, egli è qui – e là è il mondo» 76 ; pertanto, finché l’uomo è in vita, è in preda alla volontà di vivere e non rie-
sce a colmare la distanza che lo separa da se stesso e dal mondo. Impegnato a soddisfare i propri bisogni, egli concepisce le cose esclusivamente in funzione di questo intento e perciò ne fa una realtà da dominare, anziché una realtà con cui identificarsi. «Dà e chiede, entra nel giro delle relazioni», per cui «è sempre lui qui e là
il mondo diverso da lui» 77. Solo nella morte l’uomo può realizzare l’unificazione
con se stesso e con il mondo, non già però nella sua invocazione e quindi nella sua
attesa, ma nell’istante stesso di morire. Nell’invocazione della morte è la debolezza umana a parlare, la quale chiede per pietà uno schermo al dolore, allo scopo di
continuare «nella vita che non è vita», nella falsità della rettorica. Nella morte è
invece la vita stessa a imporsi e a farsi valere, perché accetta il dolore e «lo vive in
ogni punto» 78. È per questo che al persuaso, cioè all’uomo che ha la vita nel presente, «la morte nulla toglie» 79.
Nella presenza inaggirabile della morte, dunque, risiede per l’uomo la possibilità di attingere il senso autentico della vita. Solo di fronte alla sua certezza, cioè,
egli può cogliere il suo volto più genuino. Nell’intrascendibilità con cui si presenta, per cui gli preclude la possibilità di guardare al futuro e gli impone di arrestarsi al presente, la morte richiede all’uomo una decisione improcrastinabile e
definitiva 80. È per questo che chi l’accoglie, cioè il persuaso, è l’incarnazione della volontà di essere-avere tutto nel presente: ne è l’espressione più compiuta. Infatti, così dice di se stesso:
154
155
Io rifiuto il futuro e voglio il “possesso” presente – non voglio questa determinazione o quella ma voglio la cosa “in sé”, la cosa che abbia valore assoluto, voglio possederla
identificandomi in lei, voglio possedere la mia volontà; possedere me stesso – voglio “essere” (esser “liberamente”) 81.
Ebbene, nello scegliere la morte e quindi l’esperienza che gli permette di attingere la propria essenza, l’uomo può colmare la differenza che lo separa da se
stesso e realizzare l’unificazione con il mondo. Questa pienezza, in virtù della
quale non ha più nulla da chiedere, è la sua stessa «salute», cioè la condizione in
cui egli realizza il possesso presente della propria vita. Solo quando «non vorrai
avrai quello che vuoi, poiché quello che tu vuoi è l’essere assoluto, e tutta la tua
volontà non è che contingenza: non è in sé» 82.
Quella del persuaso è la condizione privilegiata di chi, giunto all’apice della
propria “consistenza”, riesce a permanervi e a resistere alla suggestione dell’esistenza illusoria. È l’uomo sufficiente a se stesso che, in quanto si è liberato della sudditanza dei bisogni, trionfa sulla paura della morte e sul futuro. È colui che
non si ritrae di fronte al continuo e incessante dolore che ne tormenta l’esistenza,
ma lo accoglie disposto a sostenerlo per tutto il tempo in cui dura la sua volontà
di vivere. D’altro canto, afferma Michelstaedter,
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
solo quando non chiederai più la conoscenza conoscerai, poiché il tuo chiedere ottenebra
la tua vita: fintanto che il tuo corpo sarà, esso getterà l’ombra sulle cose, così che tu non
potrai vedere; quando tu non sarai, non avrai la possibilità di vedere. Quando non pretenderai più la libertà sarai libero, perché questa stessa pretesa è un legame. Quando non
avrai più facoltà d’aver piacere sarai assolutamente felice 83.
come infinitamente l’iperbole si avvicina all’asintoto, così infinitamente l’uomo che vivendo voglia la sua vita si avvicina alla linea retta della giustizia; e come per piccola che sia
la distanza d’un punto dell’iperbole dall’asintoto, infinitamente deve prolungarsi la curva per giungere al contatto, così per poco che l’uomo vivendo chieda come giusto per sé,
infinito gli resta il dovere verso la giustizia. Il diritto di vivere non si paga con un lavoro
finito, ma con un’infinita attività 93.
In effetti, una volta che non è più soggetto alla volontà di vivere, per cui non
avverte più la necessità di chiedere, l’uomo viene a ferri corti con la propria vita e
non prova più dolore. Allora giunge a “consistere” nell’ultimo presente, nel quale «ogni suo attimo è un secolo della vita degli altri […] ed avrà nella persuasione la pace» 84.
Il possesso ricercato dal persuaso, cioè dall’«individuo che ha in sé la ragione», in realtà è impossibile. «Iperbolica è la via della persuasione» 85 e «la volontà
forte riconosce che non è tanto quanto “vuole” essere» 86. Per questo la conquista
di se stesso resta per l’uomo sempre al di là degli sforzi che compie per riuscire a
ottenerla. Tutto ciò che egli può conseguire appartiene all’ordine della rettorica,
perché «il possibile è ciò che è dato», vale a dire «i bisogni, le necessità del continuare, quello che è della limitata potenza volta al continuare, quello che è della paura della morte, – quello che è la morte nella vita, la nebbia indifferente delle cose che sono e non sono» 87.
L’assoluto, che è la meta finale della persuasione, «non è che la negazione di
tutte le forme della volontà dell’assoluto» 88. Per raggiungerlo perciò l’uomo deve far tacere in se stesso la volontà di vivere, scendere nell’abisso della propria insufficienza e raccogliersi nell’attimo presente. Ma questa condizione può essere
da lui soddisfatta solo mediante l’atto di volontà con il quale persegue la pienezza della propria vita. Questo significa che, per ottenere l’unificazione di se stesso con il mondo, egli è chiamato ad assumersi il coraggio dell’impossibile, perché
solo allora risplende «la luce che rompe la nebbia davanti a cui cadono il terrore
della morte e il presente divien vita» 89.
D’altra parte, per l’uomo che «vive con la fede nell’assoluto» e persegue «l’individualità grande» 90, «non c’è cosa fatta, non c’è via preparata, non c’è modo o lavoro finito» per il quale egli possa giungere alla pienezza della vita. Questa, infatti,
«è proprio nel crear tutto da sé, nel non adattarsi a nessuna via: la lingua non c’è
ma devi crearla, devi crear il modo, devi crear ogni cosa: per aver tua la tua vita» 91.
Ma come iperbolica è la via della persuasione, altrettanto lo è la meta cui essa
dovrebbe condurre, cioè il crearsi da sé la propria vita. Colui che la persegue è tenuto a realizzare in se stesso la volontà di vita nella sua forma più alta, cioè nella
coscienza che non arriva mai a possedersi e quindi a raggiungere l’assoluto in cui
consiste la sua vera essenza, perché quando è «in condizione di farlo, cessa d’essere coscienza» 92. Del resto,
156
Ebbene, trattandosi di un compito infinito, richiede un impegno altrettanto
infinito, ma che l’uomo può ripromettersi di soddisfare soltanto con la volontà di
vivere. Il crearsi da sé la vita è dunque per lui la meta ideale alla quale egli coraggiosamente aspira, sospinto dal desiderio di possedere se stesso, ma che gli è impossibile da raggiungere, perché richiede la morte che è «negazione del desiderio, del bisogno: della volontà» 94. Tuttavia, non si tratta di una meta che l’uomo
si è imposto da sé con la forza della propria volontà, ma che ha una consistenza
sua propria, perché coincide con l’assoluto che è pienezza di essere, «sommo bene» 95. Scrive Michelstaedter:
Il porto non è dove gli uomini fanno i porti al riparo della loro trepida vita: il porto cfr. cit. in Pierangel
per chi vuole seriamente la vita è la furia del mare, perché egli possa regger diritta e si- e Papini
cura la nave verso la meta 96.
Ma se è nel presente eterno e immutabile che il persuaso iperbolicamente attua se stesso, cioè si impossessa di sé e del mondo e realizza l’uno-tutto parmenideo, allora non è nella vita ascetica, ma in quella eroica attivamente operante che
egli trova il suo compimento. E di silenzio è segnata la via che conduce a questa
meta, perché la vita autentica dell’uomo consiste nel far tacere la volontà di vivere, nel rinunciare ai bisogni e nel non temere più la morte. Allora infatti, afferma Michelstaedter,
anche l’ultimo compagno serio s’annulla: il “dolore”. Il dolore che è stato il fondamento
sicuro in ogni istante della vita, quello che ho sempre ritrovato al di sotto d’ogni vana illusione, che io sentivo come l’essenza della mia vita, come la forza che mi faceva crescere
e fiorire, anch’esso s’annulla, poiché anche la sua ragione d’essere altro non era che il voler essere – insoddisfatto 97.
Del resto la vita, in ciò che ha di più proprio, «è l’attualità di ciò che non è attuale, la sussistenza di ciò che non sussiste» 98. E tale è la vita del persuaso, cioè
di colui che non vive più di relazioni, ma solo di se stesso, in quanto ha unificato i diversi e ha ristabilito in sé l’unità del tutto. Solo per lui infatti vale l’ammonimento di Michelstaedter:
157
antonio pieretti
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
Pace avrai se non la chiederai per perdurare – che allora non la chiederai più ma ti
annullerai nella pace. E non sarà la tua pace ma sarà “Pace”, perché la tua persona non ci
sarà più a esser turbata 99.
note al testo
Ma questa condizione, come si è detto, è impossibile da raggiungere; ha perciò il significato di una meta ideale che risponde a un’istanza morale. Nel perseguirla peraltro la vita si libera dei bisogni e conosce la morte, che ne è la negazione. Non è comunque mediante il suicidio che essa può ricercare il proprio riscatto e la propria emancipazione da ogni forma di dipendenza. Chi vi ricorre, secondo Michelstaedter, si serve di un gesto che gli permette di non accorgersi di morire e di «preparare tutto prima», ma con il quale egli «inganna se stesso», anziché
il proprio destino. Infatti la morte volontaria, di fronte alla domanda che la chiama in causa, non risponde «con una realtà “libera” dal bisogno» o «con una coscienza non più sottomessa al tempo, ma con l’incoscienza» 100.
Essa inoltre non garantisce la felicità che sembra promettere. Il suicida, in
quanto concepisce la felicità «come assenza di bisogno», attribuisce alla morte la
capacità di soddisfare questa condizione, perché è «la coscienza del­­l’assenza dei
bisogni» e la «felicità senza “coscienza” non esiste» 101. Ma di fatto egli «concede
alla morte ciò che è contrario al suo concetto – la coscienza» e «parla di una “felicità” senza contenuto, cioè che ha contenuto solo in rapporto ai bisogni insoddisfatti della sua vita» 102.
L’atteggiamento del suicida, peraltro, non è quello del pessimista, che nasce dalla «conoscenza del non-valore» e si traduce nell’indifferenza, ma quello
dell’ottimista, che scaturisce dalla «fede in un valore (la felicità nella morte) sconosciuto, per solo stimolo del suo bisogno presente» 103. Infatti, se agisce alla luce di questa fede o sotto la pressione di determinate insoddisfazioni, «egli passerà
dalla vita alla morte senza saper ciò che voleva nella vita veramente, e senza sapere che cos’è la morte rispetto a questa sua volontà – come uno che per fuggire alla minaccia delle fiere entrasse nel covo della tigre». Se invece ci rifletterà sopra e
farà conoscenza con la morte cercandola «nei suoi posti caratteristici (fame, precipizi, fuoco) che il corpo conosce, egli arriverà presto a capire che il non-valore
non gli vale la speranza del valore» 104.
Rifiutata dunque la falsa soluzione del suicidio, all’uomo non resta che la via
della persuasione. In ogni attimo egli deve scegliere l’impossibile, cioè vedere
l’esito del suo cammino come lontano e, insieme, come vicino, ovvero viverlo nel
presente. In questa modalità di essere, in virtù della quale egli è sempre se stesso
senza mai esserlo in forma compiuta e definitiva, è riposta per lui la possibilità di
attingere il proprio essere e di realizzare quella fermezza che «è una via vertiginosa agli altri che sono nella corrente». Per Michelstaedter, «questo è il lampo che
rompe la nebbia» 105, altrimenti «la vita è tutta una dura cosa» 106.
158
1
C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a cura di S. Campailla, Milano,
Adelphi, 1995, p. 9.
2
Ibid.
3
Ibid., ii Appendice, p. 164.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid., p. 48.
7
1958
Id., Epistolario, in Id., Opere, a cura di G. Chiavacci, Firenze, Sansoni, 1958, p. 618.
8
Id., Scritti vari, ivi, p. 817.
9
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 33.
10
Id., Epistolario, cit., p. 618.
11
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 11.
12
Ibid., p. 7.
13
Ibid., p. 8.
14
Ibid., pp. 7-8.
15
Ibid., p. 9.
16
Ibid., p. 8. Campailla, infatti, scrive: «Come il peso non può sottrarsi a quella forza attrattiva che lo
determina in quanto peso, allo stesso modo l’uomo del futuro attende ciò che non sa o non può trovare nel
presente» (S. Campailla, Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, p. 24).
17
Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 16.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Ibid., p. 18.
21
Ibid., p. 21.
22
Id., Scritti vari, cit., p. 814.
23
Ibid., p. 730.
24
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 11.
25
Ibid., p. 83.
26
Ibid., p. 20.
27
Ibid., p. 9.
28
Ibid., p. 18.
29
Ibid.
30
Id., Scritti vari, cit., p. 759.
31
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 19.
32
Ibid., p. 54.
33
Ibid., p. 20.
34
Ibid., p. 24.
35
Ibid., p. 20.
36
Ibid.
37
Ibid., p. 54.
38
Id., Scritti vari, cit., p. 731.
39
Cfr. Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 60.
40
Ibid., p. 61.
41
Ibid.
42
«Il valore della conoscenza, scrive Michelstaedter, è soltanto negativo» (Id., Scritti vari, cit., p. 829).
43
Id., La persuasione e la rettorica, cit., pp. 54-55.
44
Ibid., p. 58.
45
Ibid., p. 25.
46
Ibid., p. 82.
47
Ibid., i Appendice, p. 138.
48
Ibid., p. 77.
49
Ibid., p. 22.
159
antonio pieretti
Ibid., p. 33.
Ibid., p. 25.
52
Ibid., p. 27.
53
Ibid., pp. 34-35.
54
Ibid., p. 33.
55
Ibid.
56
Id., Scritti vari, cit., pp. 828-829.
57
Id., La persuasione e la rettorica, cit., pp. 23-24.
58
Ibid., p. 34.
59
Ibid., p. 36.
60
Ibid., p. 37.
61
Ibid., p. 42.
62
Id., Scritti vari, cit., p. 764.
63
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 42.
64
Id., Scritti vari, cit., p. 734.
65
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 43.
66
Ibid.
67
Ibid., p. 44.
68
Ibid., p. 45.
69
Ibid., p. 46.
70
Ibid., p. 62.
71
Ibid.
72
Ibid.
73
Ibid., p. 36.
74
Ibid., p. 47.
75
Ibid.
76
Ibid., p. 43.
77
Ibid.
78
Ibid., p. 47. Scrive Michelstaedter: «L’uomo non “chiede la morte” ma “muore”; e in ciò egli vive, poiché non chiede di essere ma è» (Id., Il dialogo della salute, in Id., Opere, cit., p. 362).
79
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 33.
80
Emblematici a tale proposito sono alcuni versi di I figli del mare: il coraggio della morte è «il coraggio di sopportare / tutto il peso del dolore, / il coraggio di navigare / verso il nostro libero mare, / il coraggio di non sostare / nella cura dell’avvenire, / il coraggio di non languire / per godere le cose care» (Id., Poesie, in Id., Opere, cit., p. 398).
81
Id., Scritti vari, cit., p. 817.
82
Ibid., p. 781.
83
Ibid., pp. 781-782.
84
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 49.
85
Ibid., p. 40.
86
Id., Scritti vari, cit., p. 840.
87
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 43.
88
Id., Scritti vari, cit., p. 809.
89
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 43.
90
Id., Scritti vari, cit., p. 752.
91
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 61.
92
Id., Scritti vari, cit., p. 779.
93
Id., La persuasione e la rettorica, cit., pp. 40-41.
94
Id., Scritti vari, cit., p. 759.
95
Ibid., p. 816.
96
Id., Epistolario, cit., p. 616.
97
Id., Scritti vari, cit., p. 779.
98
Ibid., p. 783.
99
Ibid., p. 784.
100
Id., Il dialogo della salute, cit., p. 357.
michelstaedter e il coraggio dell’impossibile
Ibid., p. 359.
Ibid.
Ibid., p. 360.
104
Ibid.
105
Ibid., p. 366.
106
Ibid., p. 365.
50
101
51
102
160
103
161
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
In Carlo Michelstaedter pensiero e scrittura si richiamano reciprocamente, a
fronte degli svolgimenti culturali e artistici contemporanei, sul piano d’una presenza vitale sempre attiva. Entro la stratificazione filosofica e lette­­raria del primo
Novecento, il goriziano svela analogie ma soprattutto distinzioni rispetto all’universo ideologico e artistico dominante nella società contemporanea impegnando
personali attitudini di ragione e sentimento, intelligenza e poesia. Quando individua nel vivere, paragonato a un peso destinato a pendere, un intrinseco contrasto con la persuasione, la quale tuttavia, supremo anelito della vita, non può non
confrontarsi con la vita stessa, propone una formula di rilievo teoretico attraverso
una performance linguistica e immaginativa di marcato valore espressivo. In questa similitudine, allusività a un’esperienza di vita e trasparenza di visione si intrecciano per osmosi: lo stesso periodare dal marchio tendenzialmente prolettico mima l’avanti a cui è attratto il pendere, mentre la ripetizione di parole e frasi propizia un ritmo serrato di sequenza discorsiva e figurativa fino alla sigla austera «La
sua vita è questa mancanza della sua vita» che riecheggia la sintesi poetica e filosofica di «la vita nella morte» e «la morte nella vita» del Canto delle crisalidi. Le
volute sintattiche e immaginative, modulate sulla proiezione d’una temporalità la
cui distentio è scandita dall’intentio di verticalizzazioni psicologiche, si assimilano
ai meandri profondi dell’interiorità vitalmente intensa. C’è un mordente di prospettiva drammatica e visionaria che si lascia indietro certo stile rinvenibile nella
prosa di un Bergson immaginativo e raziocinante quando indugia anch’egli sulle
similitudini (e un’immagine di peso che cade simboleggia, in L’évolution créatrice,
ciò che è materiale, contrastata però da un opposto impulso vitale che tenderebbe a correggere verso l’alto la direzione al basso 1), ma al confronto di Michelstaedter meno disponibile a così marcate tensioni di pathos e di senso tragico. Pecu-
liare l’originalità prospettica di un osservatore che nel continuum in cui il peso si
abbandona è portato a individuare non tanto il compenso di un collegamento vitale che ricompatti, attraverso l’evolversi di un élan vital, fasi distinte del soggetto,
quanto il tragico di un’intentio puntata sull’illusorietà del desiderio e l’immanenza della morte. Si vede chiaramente come la forma del significante di questo linguaggio metaforico che introduce al centro vivo di pensiero e sentimento del trattato michelstaedteriano sia collegata alla materia e alla forma d’un significato non
astratto, il quale innerva il pensiero in una dialettica reale, lontana da ogni retorica, ed evocata con una tale calcolata incidenza espressiva da suscitare la domanda se non vi si rispecchi l’esito di una poetica intesa quale unità del mondo teoretico, etico ed estetico dell’autore.
Gli interessi primari di Michelstaedter sembrano riguardare non propriamente la poesia quanto la filosofia, ambito identificativo per eccellenza d’un affermarsi dell’autocoscienza individuale che perfora in profondità la superficie fenomenica del mondo. Ma in talune epoche storiche la filosofia sembra tendere in modo
particolare a umanizzarsi o avvicinarsi al mondo. Il mondo della vita, privilegiato dalle concezioni primonovecentesche come nuovo orizzonte del pensiero antipositivistico, è l’orizzonte delle cose vicine e lontane che circonda ogni esperienza
e dunque anche quella poetica e letteraria, un mondo della vita la considerazione del quale, eludendo il leitmotiv delle estetiche idealistiche sistematiche, riscatta il ruolo fenomenologico delle poe­­tiche valorizzando la fecondità di una commutazione intrinseca tra ideale e prassi artistica. Commutazione che in d’Annunzio rischia di sfaldarsi quando l’autore coltiva un “poetico” nel cui spessore il momento estetico diventa troppo esclusivo. Diversamente, nel segno dell’organicità,
le poesie di Michelstaedter rappresentano una variante, pur dotata di orientamenti specifici, dell’iter sia filosofico che umano tracciato in La persuasione e la rettorica, mentre quest’opera appare il versante teoretico di una profonda convinzione alimentata da quella biografia del profondo che, riflessa dall’epistolario, trova
referenti nella determinatezza d’un pensiero così come nella trasparenza simbolica dell’immagine. Proprio questa salda convergenza di pensiero, vita e poesia 2
segna un distacco da d’Annunzio non solamente sul piano di una poetica letteraria, ma nell’ambito di un cliché di disposizioni culturali e filosofiche che facciano
dell’unità non riduttiva dell’io, criterio discriminante dell’universalità e profondità dell’esperienza, una forza attiva di concentrazione vitale.
L’unità di pensiero, vita e poesia, giudicata da Michelstaedter contrassegno
forte della personalità di Tolstoj, si manifesta, in lui uomo, pensatore, poe­­ta, come negazione di profili d’esperienza votati al carattere pretestuoso di motivazioni
intellettuali e artistiche, carattere non assente, invece, in d’Annunzio, allorché la
sua produzione è collegata a una strategia di rapporto strumentale, quindi utilitario, con il pubblico, e alla variabilità di relazioni che ne conseguono. Difficile stu-
162
163
Michelstaedter, d’Annunzio e il mondo della vita
di Roberto Salsano
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
pirsi, dunque, che l’interesse per d’Annunzio, da Michelstaedter manifestato precocemente, si sia bilanciato, già nel caso della critica a Il piacere, con l’impossibilità d’un apprezzamento totale. Proprio una varietà di rilievi caratterizzanti singolarmente individuati (si tratterebbe di un testo all’altezza dei più celebrati romanzi dal punto di vista dell’«interessamento»; «grande» per la forma ma «nullo» per quanto concerne la «coerenza dei caratteri», la «mancanza degli elementi naturali» e la «vacuità dell’idea»; «infame», da ultimo, nei riguardi morali e sociali 3) doveva celare una mancanza di saldezza unitaria, una possibilità di slittamenti e spostamenti di valore all’interno dell’opera, qualche spunto di analogia,
nel profondo, con le ambagi valoriali e discorsive debordanti da un centro di profondità etica e conoscitiva proprie di procedimenti retorici (retorico per eccellenza, per Michelstaedter, sarà il declinare, da parte di Platone, attraverso una svolta del suo discorso filosofico, l’etica socratica in senso formalistico e intellettualistico). Si tratta d’una sensibilità critica ribadita quando, più in là nel tempo, presentando poeti giudicati di valore più basso rispetto ad altri, fra i quali d’Annunzio e Wilde, Michelstaedter, contrapponendoli ai grandi della cultura contemporanea, insisterà su una mancanza di visione profonda e unitaria. Ma particolarmente indicativa rimane la giovanile critica a Il piacere, poiché, in zona ancora aurorale della personale formazione, un estremismo di posizioni contrastanti, onde si va da giudizi quali «libro eccezionale, meraviglioso, eccentrico nuovo, unico quasi» alla denuncia di «una irritazione dei sensi o una nausea invincibile» 4,
denota un rapporto con l’autore vitalmente caldo e umorale e tuttavia tale che già
vi si inserisce una demarcazione riflessiva la quale trascende il mero impressionismo estetico, mentre una presa di posizione netta nella gradazione del giudizio
tendente verso un acme di negatività esibito dal predicato «infame» è la soglia di
successivi percorsi intellettuali e morali che fisseranno più consapevolmente la distanza da d’Annunzio.
Uno scarto fondamentale del maturo Michelstaedter da d’Annunzio si inscrive nei modi con cui egli guarda al mondo della vita in rapporto al coevo paradigma di crisi della ragione. Se d’Annunzio interpreta, seguendo suoi specifici indirizzi, una tensione irrazionalistica di stampo decadente, il tema della realtà concreta dell’esistere attraversa, presso Michelstaedter, il filtro di una razionalità, pur
scissa dall’ideale scientista, tutt’altro che menomata, ma radicale, al punto da evitare approcci all’esaltazione della vita privi di giustificazione etica e critica. Una
ragione assai attenta al reale, del resto, collabora a proiettare il modello di un
mondo della vita da un piano ontologico sul piano di una critica alla società storicamente e politicamente determinata, sì da alimentare una contestazione della
violenza irrazionale, individuale e sociale, oltre che ogni abbandono edonistico
alla ϕιλοψυχία. Ancora avendo di mira oscillazioni tra razionalismo e vitalismo si
potrebbe osservare che l’unificazione del molteplice, riflettentesi in quel collega-
re, proprio del goriziano, cose lontane a cose vicine in cui consiste, spazialmente
figurata, una dinamica della ricerca di verità, è tipologicamente assimilabile alla
forma astratta del procedere intellettuale, e tuttavia quell’unificazione presso Michelstaedter stesso converge strettamente, fino a identificarsi in essa, con l’unità e
presenza alta del momento vitale che la attualizza in una coincidenza tra universale e individuale, espunta ogni falsa sufficienza. D’altra parte è chiaro come, pur
stornata ogni pura intellettualità del conoscere, il principio razionale di verità sia
anima della persuasione michelstaedteriana, dal momento che, se il tema filosofico di critica del principium individuationis di appannaggio socratico, discusso da
Nietzsche nella Nascita della tragedia dallo spirito della musica, potrebbe convergere con la Weltanschauung irrazionalistica dannunziana, non può convergere con la
posizione di Michelstaedter nella misura in cui questa esprime proprio verso Socrate il più alto apprezzamento.
Certamente, nella misura in cui il “tragico” appartenga alle categorie del­­
l’irrazionale piuttosto che della razionalità del mondo, l’irrazionale si affaccia
nella Weltanschauung dell’autore della Persuasione. Un “tragico” come ingrediente destinale dell’esistenza autentica, non attenuato da nessuna giustificazione metafisica o storicistica (se non da identificare, da confrontare, eventualmente, con
un tragico che già in certo Hebbel appartiene all’essenza della vita al di fuori di
un senso, idealisticamente inteso, del tragico stesso 5), in una divergenza dalla tradizione idealistica e razionalistica, è avvertito da Michelstaedter in uno scritto
sull’azione tragica e la catarsi 6. Tuttavia, in certe valutazioni della forma-dramma egli mostra di non rinnegare il recupero di certa razionalità strutturale ed etica che proviene dal classicismo o, meglio, da un’esperienza, rivisitata, della classicità. Se, come Michelstaedter ritiene, nella tragedia il tragico in quanto tale appare inseparabile da una vita che sia veramente se stessa, e tende, come a una meta irraggiungibile, alla purezza e trasparenza assolute dell’agire scenico attraverso l’articolarsi del suo scontro con forze opposte, risultano imprescindibili sia la
conflittualità dell’azione stessa come forma intrinseca del dramma sia la riflessione (o significazione immanente) sullo scacco messa in luce, se non dal coro, dalla catarsi, due componenti, conflitto e riflessione, del modello classico della tragedia. Quando Michelstaedter, nella recensione a Più che l’amore del 1908, afferma
che d’Annunzio non sa «rappresentare le due parti in contrasto vitale tra loro» 7,
sottolineando la parola «vitale» proietta il motivo della vitalità (spazio fenomenologico, se vogliamo, di intenzioni, all’interno dell’esperienza) sulla trama dialettica, radicata nel dialogo, del conflitto tragico. Si manifesta qui l’assunzione d’un
modello recepibile tra cultura classica da un lato, poetica contemporanea dall’altro, filtrato dalle istanze soggettivistiche d’una moderna attenzione al mondo della vita e dai postulati, antintellettualistici e dunque antiretorici, dell’ideologia michelstaedteriana. La critica, espressa nella stessa recensione, circa la lungaggine
164
165
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
discorsiva delle battute dannunziane, ove riecheggia l’opposizione a una discorsività macrologica il cui modello è osteggiato dalla dialettica socratica nell’opzione
d’una brevitas quale riflesso di una razionalità fondata sul contraddittorio di persone reali, contro la mistificazione del linguaggio ridondante, riconferma un carattere classicistico, e antiretorico in quanto vitale e insieme riflessivo, della struttura drammaturgica vagheggiata da Michelstaedter. Si aggiunga che certi giudizi su d’Annunzio, ma anche alcuni altri su Ibsen, rifiutano un quid non calato nel
contrasto drammatico e rimasto nell’aura del soggettivo, con una sottesa negazione di quello che Peter Szondi appellerà «teatro epico» contrapposto al dramma
di derivazione rinascimentale proprio soffermandosi, fra autori del primo Novecento, sul teatro di Ibsen, drammaturgo giudicato, dallo stesso Szondi, «di transizione». Inoltre, se consideriamo l’esito lirico e monologico più che dialogico che
tante battute del personaggio dannunziano realizzano esprimendo una foga tutta
e solo incentrata nell’enunciazione del proprio stato, non possiamo non convenire che colga nel segno una critica strutturale di incompiuta oggettivazione drammatica, conciliabile, teoricamente e metodologicamente, con punti di vista esplicati dallo studioso ungherese. Ed è significativo che appaia convergente con una
concezione della forma dramatis legata a simili punti di vista basati su nozioni di
rapporti differenziali fra dramma e genere epico la critica a Quando noi morti
ci svegliamo, dove Michelstaedter individua un’angolazione che potremmo chiamare “epica” quando nota che «la metà delle scene e – anche più – ha solo valore espositivo» 8, com’è significativa l’osservazione, contenuta nell’intervento del
1908, che esistono linee drammatiche in Più che l’amore trascurate da d’Annunzio
e non assimilabili all’antefatto ma all’azione vissuta, quindi al dominio del presente che elude ogni raccontare (il dramma «Non è fatto a racconti […] non è costituito d’antefatti» 9) , anche in questo giudizio vigendo la concezione che il dramma va interpretato in base al suo reagire o meno all’attrazione diegetica e quindi epica. Infine, a conferma di come un modello teorico alla Szondi possa risultare congeniale alla sensibilità critica di Michelstaedter, al suo recupero del classico nell’orizzonte di istanze attuali, si pensi a quanto la preminenza data, nello statuto strutturale szondiano della scrittura drammaturgica, al presente dell’azione,
possa andare all’unisono, non senza impliciti correlativi risvolti di accentuata intensificazione di un modello di vita, con la concezione di quel tempo attuale che
si insedia al centro della dimensione esistenziale autentica dell’uomo “persuaso”,
e ciò senza inficiare il valore della socialità. Socialità profonda dell’essere individuale che in un Corrado Brando concepito michelstaedterianamente come eroe
autentico salvaguarderebbe, pur apparentemente contrastata dal negativo tragico
della rottura dei legami affettivi, una sfera positiva di moralità alla quale rimane, al contrario, estraneo il personaggio concepito da d’Annunzio, tanto manifestamente ostile, per programma e convinzione, a ogni criterio di «bontà» (termi-
ne chiave, declinato altrove come «amore», dell’individualismo etico di Michelstaedter 10, esplicitamente oggetto di rifiuto da parte di Corrado Brando – diversamente dal d’Annunzio paradisiaco ove la bontà predomina anche se rimane, invero, soprattutto motivo letterario) e così esposto, nonostante i lati pur nobili e,
direbbe il goriziano, persuasivi, del proprio volenteroso agire abolente la retorica
delle complicazioni intellettuali (la perentorietà dell’«atto» viene da lui marcatamente evocata), ad atteggiamenti in cui emerge “la bestia” del proprio io accanto alla cupidigia e alla violenza, al risarcimento fantastico e alla memoria privata
del borghese scontento.
Nella dialettica generale tra esperienza tragica della défaillance e forma del
dramma rientra, come cogliamo in due recensioni michelstaedteriane a Più che
l’amore, del 1907 e del 1908, un contrasto particolare, tra progetto dell’eroe, da
una parte, vincoli familiari e affettivi dall’altra parte. Ma non lievi differenze separano i due interventi. Nella più giovanile recensione alligna appena una perplessità intorno alla realizzazione drammatica del conflitto quando si nota che le
creature normali non oppongono una loro alternativa credibile al protagonista,
la determinazione eroica del quale viene invece giudicata senza sostanziali riserve. È nella più tarda recensione che, diversamente, il superomismo solipsistico
della creatura dannunziana è chiaramente avvertito come limite e la rappresentazione di Più che l’amore è fermamente criticata perché da quel limite indebolita, imputata di una diminuita significazione etico-sociale ed estetica. Mancherebbe insomma, all’azione di Corrado Brando, pur indirizzata a una positiva contestazione antiborghese annessa alla determinazione individualistica del gesto, una
completa valenza conflittuale nei confronti dell’ambiente, l’individualità rimanendo astratta e chiusa in sé, mentre avrebbe bisogno di quello scambio tra io e
altri che, risaltando allorché «ogni individualità che vive a sé stessa, vive perciò
appunto alla totalità degli uomini» 11, si fa garante, possiamo chiosare, del superamento di ogni individualismo autocontemplato nella propria sufficienza e ricadente, dunque, nella persuasione dell’individualità illusoria. Ma non solo si profila, in Più che l’amore, secondo l’aggiornata chiarificazione critica michelstaedteriana della seconda recensione, un’opposizione a un determinato contesto sociale
insidiata da prospettive autoreferenziali e narcisistiche dell’io, un vitalismo, potremmo dire, inibito a far emergere, per deficienza di dialettica con l’alterità, il
barlume, in termini alternativi, di un’altra società, di un’altra morale. Al di sotto
di questa sminuita opposizione Michelstaedter ne scopre un’altra, a rafforzamento della manchevolezza strutturale, l’assenza, cioè, di un contrasto tra l’io eroico e
i propri stessi affetti familiari, fondamento di una non superficiale dinamica psicologica sollecitata da antitesi multiple, nella cornice di un «dramma intimo». Il
quadro ritratto è di una lucidità prospettica calzante, anche se ci si può chiedere
se queste ultime integrazioni psicologiche e socialmente rappresentative ipotizza-
166
167
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
te dal goriziano non spostino la visuale verso un’interiorità dell’io e un ritratto di
ambiente tali da suscitare l’intrusione di aree tematiche esterne all’assoluta autoreferenzialità del dramma classicistico, basato essenzialmente, come vuole Szondi, sul dialogo, eventualità che risiede in quella natura di “dramma intimo” di
Corrado Brando che, per eccesso di privata interiorizzazione, lo potrebbe inevitabilmente isolare e che, in effetti, nella componente più frammentistica del saggio recensorio michelstaedteriano, si lega a una lettura puntata sulla scelta antologica dei passi, sfiorando il metodo di “poesia e non poesia”. E ancora, passando
a un altro testo critico teatrale di Michelstaedter, ci chiediamo: non avviene qualche spostamento oltre l’organicità della forma-dramma nella critica a Piccoli borghesi di Gorki, ove il tema sociale della pièce è collocato su uno spaccato di realtà ambientale fissato con propri connotati identitari fino a indurre, per certi tratti,
l’idea di una drammaticità mimetica («Nei Piccoli borghesi Massimo Gorki scolpisce con tratti magistrali la società russa…» 12) fondata, al di là della forma assoluta del dialogo interpersonale, su un riporto di un’immagine storico-sociale di
contrasti fra classi preesistente al testo? Una risposta congrua a siffatte domande
direbbe che l’aderenza di Michelstaedter all’attualità drammatica impedisce o limita simili derive. Le sue virate prospettiche verso i “contenuti” rappresentativi
si assorbono, così, in una disposizione critico-interpretativa a valorizzare la configurazione di una forma drammatica che immedesimi nel linguaggio attuale interiorità e conflitto (tanto sottratti a un’oggettività e organicità drammatica dalle, definite con polemica, «belle frasi» di cui solo sarebbe capace Corrado Brando), disposizione favorita proprio dalle défaillance dannunziane acutamente individuate a tal riguardo e sostenuta, fra l’altro, dal principio antiretorico che predilige l’organico alla parzialità o unilateralità strutturali, come lucidamente risalta dalla considerazione tracciata in margine al ruolo ricoperto dall’eroe e dall’ambiente in Più che l’amore: «Ha ridotto l’uno e l’altro a espressioni rettoriche, prive
di contenuto rappresentativo e di dimostrazione dialettica» 13. E con ciò ritorniamo alla centralità di una tematica filosofica, estetica e psicologica generale che gli
approcci a d’Annunzio del giovane Michelstaedter hanno il merito di interiorizzare sul crinale di uno stacco tra le prime manifestazioni giovanili e l’ultimo periodo biografico, il più intenso, drammatico e, quanto al valore degli esiti raggiunti,
il più storicamente duraturo.
L’esperienza critica esercitata sul dramma, applicandosi alla richiesta di qualcosa di più che l’amore, svela la presenza non episodica ma ritornante e dialettica
di d’Annunzio nella stratificazione della cultura e della poetica di Michelstaedter.
Lo attestano non solo il maturarsi graduale di diversi atteggiamenti nei confronti
del poeta quasi questi abbia avuto un ruolo maieutico nel personale evolversi ideologico del goriziano, ma anche il fatto che il motivo avventato dal comparativo
«più che l’amore» (un comparativo ritornante nel commento michelstaedteriano:
«Pure a me sembra […] che c’è, che c’è qualcosa di più, qualcosa di vero e di toccante all’infuori dell’apologia della morale eroica» 14, a conferma, dato questo accenno di critica “mimetica”, della profonda suggestione operata in lui dal soggetto tragico dannunziano) interesserà sul piano tematico l’estrema poesia michelstaedteriana, evocatrice, in I figli del mare, di un rapporto tra Itti e Senia che deve superarsi inquadrandosi in una superiore richiesta di conquista del vero, della
persuasione e dei suoi connotati liberatori. In uno scritto intorno al coraggio, non
molto posteriore alla seconda recensione di Più che l’amore, ancora opera la prospettiva morale che richiede un’eccedenza, questa volta qualcosa di più che un risultato meramente estetico, alla forma di un gesto. Non vi è citato d’Annunzio, ma
non potrebbe escludersi un implicito sottinteso di motivi dannunziani quando è
detto, senza soggiacere a un estetismo riduttivo: «Ma dove sta la ragione della bellezza d’un gesto? Evidentemente in un raggio più forte in cui meglio si rivela una
personalità» 15. Resta che l’interesse critico per Più che l’amore proietta sull’immaginario e sulla riflessione in fieri michelstaedteriani la figura di un “di più” come
tendenza esperienziale inscrivibile nel nietzschiano “ponte” verso il sovrumano
(stigmatizzandosi però il dannunzianesimo deteriore, la caricatura in cui può scivolare lo stesso nietzschianesimo dannunziano come insinua la frizzante osservazione su un Corrado Brando intento a magnificare una «sua diligente occupazione giornaliera di superare se stesso!» 16) o nel verticalismo etico della scelta kierkegaardiana in sintonia con certo Ibsen, e tuttavia quell’interesse critico manifesta anche una disponibilità soggettiva tanto viscerale all’intensità vitale, intellettuale ed etica da far prevedere certe condizioni naturali in cui l’io possa spegnersi per un “di più” o sovrappiù di ardore attraverso una crisi implosiva di energie
psichiche destinata allo scacco oltre che della dialettica storica, dello stesso volontarismo titanico. In siffatto sfondo va segnalata anche l’eventuale insorgenza
del lato “umano, troppo umano” che si insinua nel profilo biografico di Carlo assai esposto al drammatico “divenire” d’una coscienza e che affiora particolarmente immediato in una lettera a Gaetano Chiavacci del 4 agosto 1908 dove si confessano momenti di crisi: la dispersione dell’io, la debolezza della lotta per l’ideale,
fin certo «sufficiente socratismo» 17 nel quale sembra affondare l’intelligenza spogliata del più attivo fervore agonistico. Anche se nella stessa lettera si contrappone allo stato depressivo la tenuta di un carattere agonistico che vagheggia l’ipotesi
di una riacquistata energia mediante modi di vitalità fisica: «A me non resterebbe
altro che la vita fisica violenta» 18, riesumabili, a certi livelli, entro i valori del sistema etico e filosofico ove la vita è posta in primo piano. Questo scivolare nella generica fisicità mostra i caratteri irriducibili d’una pianta uomo istintivamente attiva, pronta ad assimilare, eventualmente, aspetti dell’individualismo dannunziano
(si pensi all’esaltazione di corporeità, per esempio, spirante dalla rappresentazione del vigoroso nuotatore assimilato a un «bianco cefalo» nella prima edizione del
168
169
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
Canto novo, così vicina, per spirito e immaginazione, a certi tratti di quello che
può essere un profilo giovanile michelstaedteriano), destinata però, in questi casi, a non occupare gli alti gradi della gerarchia assiologica che convengono al modello della persuasione. Infatti, da una parte la sensualità, espressione dell’io corporeo, componente dell’individualismo dannunziano, riacquista presso Michelstaedter dignità rappresentando un antidoto a ogni «vita autonoma dei sensi» 19,
può rientrare dunque nel sistema antiretorico, dall’altra parte un altro “senso”, il
«senso della responsabilità» 20, porta, sempre in Michelstaedter, la cifra di un diverso, più alto e decisivo, criterio di distinzione.
Quanto, infine, il motivo del rapporto tra individuo e società dominante, in
Più che l’amore, in un orizzonte di ambivalenze semantiche e ideologiche, doveva intrigare profondamente Michelstaedter è confermato da alcune espressioni
verbali che, a nostro avviso, non gli sarebbero dispiaciute anche se, supponiamo,
avrebbero dovuto bilanciarsi con una prospettiva di fondo più consona all’ideale
suo proprio per un’identificazione piena in esse. Si pensi, oltre alla ripetuta affermazione di una volontà tesa a foggiare virilmente sé medesimo nell’ideale di un
uomo che «possegga sé», alle parole rivolte da Corrado a Virginio: «T’è vietata la
grande avventura. Tu hai il tuo compito prefisso, la tua persona circoscritta. L’ordine riposa su te, su la tua costanza infallibile. Tu sei un artefice della vita arginata» 21. L’immagine dell’argine rende bene la connessione precostituita di un insieme di vincoli adibiti alla cura pubblica dei bisogni con la conseguente limitazione e alienazione dello sviluppo dell’integrità umana. Una vita che ben si può dire “amministrata” dà luogo, in Michelstaedter, a quella «comunella dei malvagi»
che è modello ontologico di retorica sociale ma anche controfigura storica della
contemporanea società burocratica. E certo, in questa società, l’individualità eroica non potrebbe coincidere non solo con l’individualismo borghese, ma neppure con il carattere aristocratico classista di esaltata affermazione di sé a cui indulge il prototipo umano che si è venuto affermando negli svolgimenti della poetica
dannunziana quando collega, si veda Le Vergini delle rocce, superomismo e aristocrazia secondo un carattere da Nietzsche ascritto alla morale di padroni contro
schiavi, poiché in siffatta affermazione, alludente a un velleitario diritto del più
forte una cui lontana antecedenza potrebbe trovarsi nella morale di Callicle contrastata, nel Gorgia platonico, da Socrate, si rifletterebbe, ancora, il limite ontologico e politico di una naufragata persuasione, il risvolto retorico di un’individualità parziale data per intera.
La città moderna, burocratizzata e sotto il freno degli sbirri travestibili da Eumenidi in Più che l’amore, è amministrata o “arginata”, ma è anche caotica o degradata, ed è dunque qualcosa di conturbante per la Weltanschauung degli scrittori affacciati a un mondo irrimediabilmente trasformato. Ma se in d’Annunzio
perfino l’aspetto delle «città terribili» che il tramonto della classicità e l’invasio-
ne del moderno hanno favorito possono rientrare nell’esperienza estetico-letteraria, e qualcosa di analogo ritroviamo anche in alcuni versi di Michelstaedter delle prime poesie, si veda la crudezza realistica (d’una reazione polemica il cui tono
possiamo trovare anche in certo Carducci) di: «M’erutta in faccia con fetor di vino / un popolano dondolando l’anca» 22, presso Pirandello la scena della contemporanea degradazione urbana potrà rivestire le forme di un mondo entrato nel caos e nell’impersonalità senza alcun risarcimento estetico, come nello spaccato cittadino avvistato da una vittima di questa distruzione di vita autentica, Serafino
Gubbio, impassibile spettatore degli enigmi di una società tecnologica collaudata a un ritmo frenetico ma piegata al nonsenso. Quello sguardo dell’operatore cinematografico nelle prime pagine dei Quaderni, appuntato sullo spettacolo di cittadini automi pienamente integrati nel disegno di una divisione delle parti imposta da un sistema che esalta, straniando il soggetto sociale, funzioni e relazioni irrigidite o, diremmo con il goriziano, le correlatività interne alla macchina associativa, potrebbe essere lo sguardo di un Michelstaedter a patto di non restare puramente contemplativo e di evidenziare il senso paralizzante dell’aridità contemporanea attraverso lo svolgimento teoretico di una sofferta, articolata denuncia.
A questo punto si può ipotizzare una tendenziale ossimoricità rappresentativa propria dello stereotipo vitalistico deducibile dalla lezione michelstaed­­teriana.
Si ravvisa, voglio dire, una dialettica di rovesciamento interna al vitalismo stesso nella misura in cui siffatta categoria (del vitalismo) da una parte è in grado di
postulare prospettive di carattere ontologico in segno positivo, dall’altra di far risaltare, ma in negativo, ciò che, nutrito di ragioni spiccatamente storico-sociali,
all’effettiva vitalità si oppone. Un vitalismo insomma che, mentre si delinea, delinea anche la negazione di sé medesimo. Se il vitalismo indica un nodo di orizzonti esistenziali, culturali e poetici primonovecenteschi, proprio discernendolo, attraverso la mediazione, originale, di Michelstaedter, non dentro facies parziali o
schematiche, ma nella dialettica fenomenologia della sua significazione, si può avvertire con acuta (o comunque esaustiva) veemenza come, all’interno di un quadro di riferimento all’essere in generale, una condizione particolare dell’uomo
contemporaneo appaia esposta al ribaltamento della vitalità stessa sotto una crisi
epocale dell’Erlebnis. Un interesse valutativo diretto all’uomo tecnologico dell’oggi nella sua condizione sia vitale che sociale sollecita il goriziano a prendere posizione contro la scienza, non esattamente seguendo una teorizzazione del mondo
della vita la quale, nei modi di certe argomentazioni husserliane, evocherà un’universalità alternativa all’“universale” rappresentato dalla tradizione delle scienze
europee ma, pur situandosi in taluni casi non lungi da quelle future argomentazioni, per un’assai netta polemica di Michelstaedter verso il mito moderno positivistico dell’oggettività e per un penetrante sguardo fissato non sugli oggetti naturalistici del mondo ma su un insieme di «correlazioni» sospinte, nella prospettiva
170
171
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
di una riduzione che assimili un procedimento, tendenziale, di epoché, a cedere il
posto dei particolarismi a un’ampia quintessenziale visione dell’universale tramite il medium comunque, non solo riduttivo, ma pieno in corpo e spirito, di un’integra e totale esperienza soggettiva. D’altra parte, a distinguere profili e portata
dei due linguaggi teoretici, se l’oggettivismo logico-scientifico sarà bersaglio d’un
discorso critico husserliano sistematico e consequenziario contro postulati e metodi della scienza tradizionale, l’oggettività connessa con la scienza è stigmatizzata da Michelstaedter facendo leva soprattutto su profili critico-sociali ed etico-esistenziali nonché antropologici bilanciati tra ragione e morale, incunaboli politici e individuazione della sensibilità, con evidenza sintetica di linguaggio e pathos
aforistico e sempre nel cuore, irriducibile, di una vagheggiata intensificazione vitale. Egli attribuisce i motivi di una vitalità sminuita al predominio scientifico verificando il potere percettivo dell’uomo nel moderno orizzonte civile con uno spirito d’osservazione umanamente risentito e intellettualmente critico-pragmatico.
Scrive, intorno all’esperienza, rivolgendosi agli scienziati: «Ed è pur curioso di saper questa esperienza che cosa sia» 23. Né la tecnica che della scienza moderna è
il vettore operativo acuisce la sensibilità dell’uomo a parere di Michelstaedter che
riciclando ascendenze di testi sacri in un malizioso collage di arcaico e moderno conclude così un suo pensiero: «Degli scienziati moderni direbbe Isaia: “hanno microscopi e non vedono, hanno microfoni e non sentono”» 24. Evidentemente
non è ammessa indulgenza verso la scienza intesa come una branca della divisione del lavoro in cui, oltre ad affermarsi il determinismo del metodo sperimentale,
si parcellizza l’autenticità esperienziale del soggetto, né si intravede apprezzamento della condizione per cui un accresciuto sentimento della potenza individuale
attraverso le macchine favorirebbe certe pulsioni d’un prometeismo nietzschiano.
Quest’ultimo, che pur mostra sue tracce nella prefazione dannunziana a Più che
l’amore, sarebbe adeguabile al futurismo quando esalta un uomo moltiplicante la
propria efficienza. Ma tra l’autore della Persuasione e i futuristi c’è, dai fondamenti, un’irrisolvibile incompatibilità. Soprattutto lo iato tra l’uomo artificiale e la coscienza, ove può esercitarsi il pensiero negativo michelstaedteriano su certi aspetti della modernità, è annullato dall’unidimensionale totalità della visione meccanicistica di Marinetti e compagni.
Quanto al dualismo tra esperienza posticcia, puramente intellettuale, astratta, ed esperienza di un mondo della vita come fonte di autenticità, è un dualismo
che, sul piano dello svolgimento letterario tra Ottocento e Novecento, interessa
un percorso ermeneutico ispirato, all’interno di un tracciato vario di autori e poetiche, a due punti di vista altamente rappresentativi, ma fra loro per tanti aspetti divergenti, quelli di Pirandello e d’Annunzio: una visione esposta al relativismo
della verità, da un lato, una prospettiva tendenzialmente mitizzante, dall’altro lato, l’una sottolineante lo scotto che si paga, di quel dualismo tra artificio e veri-
tà, in termini di disagio storico-sociale ed esistenziale, l’altra proponente un’immagine di recupero personale e storico dell’integrità attraverso il ricorso all’ideale e alla poesia o a una volontà narcisistica di potenza. Certamente tra d’Annunzio e Pirandello da una parte, Michelstaedter dall’altra, si apre uno iato incolmabile riguardo alla possibilità dell’impegno intellettuale, culturale, artistico, di farsi discorso rivolto a una sfera di ricezione pubblica stimolata da nuovi modi di divulgazione e comunicazione. Se il riferimento più o meno esplicito a un uditorio
esterno al discorso contraddistingue un aspetto della scrittura pirandelliana, così fortemente intessuta di spiriti argomentativi, e della personalità dannunziana,
così disponibile ai fenomeni della ricezione, ed è comunque componente, questo riferimento, del modello discorsivo, o in generale culturale, basato sull’argomentazione nell’esaltazione del quale (sulla scia di Perelman che sottolinea il ruolo, proprio, dell’«uditorio») si orienta una rinascita retorica nel Novecento, la debolezza di un rapporto con gli ascoltatori della parola (cioè del discorso) attestata dall’inizio della prefazione alla sua tesi di laurea da Michelstaedter quando dice che «parla per parlare», convinto che non persuaderà nessuno, è conferma di
un’originarietà antiretorica dello scritto michelstaedteriano distante tanto da un
d’Annunzio che da un Pirandello. Ciò non toglie che relazioni e contrapposizioni
più articolate, fra i tre, siano, eventualmente, rintracciabili.
Michelstaedter e Pirandello sono, lo ripetiamo, ben diversi tra loro per le opposte mete a cui guardano: la necessaria riaffermazione unitaria della persona,
nell’un caso, l’inevitabile scomposizione relativistica del reale e della coscienza,
nell’altro caso. Tuttavia, se l’approfondimento teoretico e di esperienza, nonché
poetico, del problema dell’identità vitale può interessarli, come effettivamente li
interessa, un accostamento reciproco li può riguardare per ciò che concerne proprio la profondità di percezione dell’attuale crisi dell’Erlebnis. D’altra parte la distinzione di Pirandello dal più esteriore vitalismo dannunziano è parallela, per
certi aspetti e mutatis mutandis, alla distinzione tra Michelstaedter e d’Annunzio, prospettandosi così, in effetti, la possibilità d’un gioco incrociato di confronti fra i tre autori, fatta salva l’incommensurabile originalità delle rispettive individuali posizioni.
Con grande acutezza il goriziano, analizzando il rapporto tra soggetto e vita,
denuncia l’impasse che si viene a stabilire allorché vita e pensiero della vita costituiscano diversità separate. E qui può entrare Pirandello, con il rilievo storico di
una direzione alternativa rispetto a un orizzonte di pensiero e di predisposizioni della poetica e dell’arte in cui d’Annunzio è impegnato a esprimere la propria
esaltazione del vivente. Pirandello distingue il vivere dal «sentirsi vivere» ove il
sentirsi vivere, per quanto non identico al pensiero astratto, non ha certo la potenza originaria del vivere e tanto più si distingue dal vivere quando si identifica
nel «vedersi vivere», con un’oggettivazione di prospettiva che deroga a un esau-
172
173
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
stivo statuto di “vissuto”. L’agrigentino nel definire il «sentirsi vivere» contrappone l’albero, per il quale la realtà è la propria stessa esperienza, all’uomo che avverte il sentimento della distinzione: «noi non siamo come l’albero che vive e non si
sente» 25. Michelstaedter scrive in ii Appendice, precisando la distinzione tra vita
umana e vita naturale degli animali: «Finché uno vive: egli è qui e là è il mondo:
due e non uno» 26 e arriva perfino a inscrivere in uno spettro di autenticità la vita
dell’animale, superiore a quella di un uomo il quale sacrifica l’immediatezza vitale: «Egli è meno vivo di qualunque animale» 27, escluso com’è dall’illusoria ma,
entro certi parametri, assoluta persuasione dell’istinto bruto e privo di uno stato
di “salute” come si osserva sia in La persuasione e la rettorica sia nel dialogo proprio alla salute dedicato. Quando poi, sempre nel confronto tra uomini e animali,
Pirandello, in Quaderni di Serafino Gubbio operatore (i, 3), delimitando l’emergere di una soggettività umana camuffata ma irriducibile attraverso certe parole di
Simone Pau: «Il monte è monte, perché io dico: Quello è un monte. Il che significa: Io sono il monte», parole singolarmente analoghe a una definizione di Michelstaedter che, riferendosi all’uomo, scrive: «Per la sua illusione egli dice che “è”
quello che “è per lui”» 28, aggiunge, a proposito di questo fenomeno, che si tratta di un «superfluo», con la designazione di “superfluo” viene a indicare una sovrapposizione vana su una realtà più sostanziale, una ridondanza, dunque, e la ridondanza è uno specifico indicatore retorico. Ma è proprio Michelstaedter che,
con sottigliezza, coglie la sovrapposizione tra chi sa perché vive e chi dice io so, e
quest’ultimo atto ritiene una deriva retorica. Egli tuttavia, diversamente da Pirandello, non abbandonato allo scetticismo, anzi eroico sostenitore della ricerca del
vero, ha chiara l’idea d’una necessaria conciliazione tra vita e verità nella sfera di
una tensione a un ambito razionale ed etico di autenticità e quindi di virtù (ciò
che Platone andrebbe via via smarrendo), senza nascondersi l’arditezza dell’alta
persuasione fino al punto che essa può rivestire, come si deduce da un luogo della Persuasione, il ruolo di un “impossibile” razionale («il coraggio dell’impossibile è la luce che rompe la nebbia, davanti a cui cadono i terrori della morte e il presente divien vita» 29). Il primo Pirandello, meno legato alla metafisica di marca tilgheriana e più attento alla fenomenologia storica del contrasto tra vita e forma e
ai meccanismi menzogneri delle convenzioni, in anni del primo Novecento vicini a Michelstaedter, compresi nella cronologia della sua breve parabola biografica (L’umorismo è del 1908, Il fu Mattia Pascal esce nel 1904), parte prioritariamente da una potenza di oggettiva osservazione erede dell’impostazione naturalistica
(certo da posizioni iniziali più distanti dalle michelstaedteriane) e ritrova con maturata angolazione universalizzante del punto di vista empirico, dentro il quadro
sociale che gli si presenta, quelli che Michelstaedter designa ornamenti dell’oscurità i quali occultano la nudità dell’anima 30, un’oscurità ove ogni uomo, nel capitolo xiii del Fu Mattia Pascal, è visto portare un lumicino nel tentativo, patetico,
di diradare il buio, in sintonia con un metaforismo michelstaedteriano, spesso ritornante, legato al contrasto tra buio e luce (d’altra parte, al di là della semantica
simbolica della luce, ma sempre in un simbolismo legato al “visivo”, nel citato capitolo pirandelliano ogni uomo si figura un mondo illusorio «secondo il vetro che
ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di vetri colorati», mentre in Michelstaedter – vi, ii Appendice – le illusorie relazioni con il mondo dei vari soggetti appaiono «come i vetri colorati in un caleidoscopio»). Ma sia consentito, una volta richiamata la metafora del buio, rievocare anche quella della nebbia, parola chiave nell’opera michelstaedteriana, atta a delineare l’imperscrutabile dell’esistente, una nebbia collocabile accanto all’omologa con la quale si intitola
un capitolo del Fu Mattia Pascal incentrato sulla perplessità del protagonista, prototipo dell’uomo moderno, di fronte agli enigmi della scena e della vita.
Da nebbia e oscurità è circondato l’uomo nuovo della società moderna che,
sottomesso alla tecnica, perde vitalità sia nella diagnosi michelstaedteriana sia
nell’immaginario pirandelliano. Un esito estremo della perdita di vita nel mondo
delle macchine non esclude l’ipotesi di un silenzio totale. È ciò che traspare dal
significativo accenno: «Prima di giungere al regno del silenzio ogni parola sarà
un callopisma orfnes» 31, a fronte del quale si potrebbe menzionare la sorte del pirandelliano Serafino Gubbio operatore che, a contatto con il degradante mondo
tecnologico, finisce ammutolito fisicamente, ma non senza che nel suo destino di
mutismo traluca un significato socialmente simbolico 32.
Ma l’orizzonte comune da cui i due autori si staccano individualizzando la
propria personalità è ancora più particolarmente definibile dai termini della problematica sul contrasto tra finzione e apparenza. Nel mondo pirandelliano scetticamente orientato, se si intravede una verità fondata la si intravede come situazione limite, mai effettiva, adombrata dalla dialettica del tentato denudamento della maschera. Segno di una nostalgia dell’assoluto che, non essendo razionalizzato e vagando in un idealismo abbastanza posticcio, può definirsi come rischio di
un’ideologia approssimativa e, in definitiva, retorica (confluente nel cosiddetto pirandellismo legato a una fase cronologicamente avanzata dello scrittore) a confronto della concreta capacità critica d’una prospettiva culturale e sociale ben determinata è, proprio, la maschera nuda. Michelstaedter, nutrito di cultura platonica e segnatamente suggestionato dal Gorgia, accenna, a suo modo, all’anima nuda
e, quando in uno scritto del 1908 33 bersaglia le «finzioni dello spirito» e la «libertà» come «ultima finzione del nostro egoismo», usa termini che nel lessico coincidono con le cosiddette finzioni dell’anima di Giovanni Marchesini che hanno
suggestionato Pirandello, ma in un contesto particolare, passando dal nominare
la «crescente finzione sociale» (combattuta dall’individuo eroico) al nominare la
«finzione dello spirito di conservazione» dell’individualismo nietzschiano, a segno di come certo virtuale pirandellismo si mescoli a certo dannunzianesimo cri-
174
175
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
ticato, tuttavia, in termini parodici. Si rilevi, inoltre, come il senso vivo delle finzioni indotte dalle convenzioni sociali porti il goriziano all’immaginazione grottesca o espressionistica distorcente le linee dell’idillio realistico, ciò che è attestato dalla sua opera grafica ma anche da qualche eccentricità d’invenzione della sua prosa filosofica quando, per esempio, si manifesta un grottesco tipicamente pirandelliano nella favola del re annoiato che costruisce un fantoccio di se stesso delegando l’unicità del proprio ruolo alla parzialità del doppio (ii Appendice,
cap. iii). Ma un indizio forse più sottile e implicito nelle maglie stesse della teoresi michelstaedteriana potrebbe alludere a un virtuale sviluppo della visualizzazione del comportamento umano in direzione della fenomenologia immaginaria e drammatica del doppio, nodo centrale della costituzione dell’io pirandelliano in personaggio. Non penso, in questo caso, all’esplicita manifestazione della
maschera sociale che troviamo nel borghese gaudente sicuro come «in una botte di ferro», il quale testualmente afferma: «Quando indosso l’uniforme vesto anche un’altra persona» 34, ma a qualcosa di meno eclatante e pur sottilmente rivelatore, all’affacciarsi, dalle pagine del goriziano, nei punti decisivi in cui viene delineato lo strutturarsi dell’atto retorico, di un simulacro chiamato «persona», dove l’appellare appunto persona la soggettività limitata dei bisogni e delle correlatività che sostituisce l’autentico e integrale soggetto apre, in nuce, a una visione di
sdoppiamento dell’io.
In effetti, molteplici tendenze dei due autori, pur radicandosi in specifici non
omologabili contesti, sembrano convergere nel fuoco di uno spirito critico e polemico verso certi modelli sociali e culturali: se Michelstaedter fa del­­l’obiettivo di
rifiuto del conformismo il centro della propria speculazione antiretorica, Pirandello, nonostante infirmi, sul piano epistemologico, il modello umano e filosofico di una verità ultima, condanna a tutto campo sia la retorica letteraria, quella
che fa della parola un artificio magari brillante e prezioso ma vano e menzognero, consumando contro d’Annunzio una polemica esemplare, sia la retorica degli
intellettuali intravista come qualcosa estranea alla vita, attestando ciò la sentenza,
sapida umoristica, che un concetto, privo del contenuto, è come un guscio d’uovo (Sei personaggi in cerca d’autore, atto i), ove si potrebbe quasi vedere analogia
con l’immagine di quell’assoluto soffiato nell’aerostato mediante il quale Platone nell’«esempio storico» michelstaedteriano si libra verso il cielo scontando una
per così dire insostenibile leggerezza dell’essere, sia la retorica scientifica in una
singolare somiglianza con il goriziano quando in passi della Persuasione induce a
guardarsi intorno per verificare la verità della scienza e, come avviene in Uno nessuno e centomila, spiando perfino fisionomie umane variabili a seconda dei diversi giudizi, sia, infine, a collante del tutto, la retorica sociale, quella della commedia nella quale si atteggia l’esistenza quotidiana.
Arriva, Pirandello, a collegare retorica sociale con retorica linguistica, e un
esempio eclatante potrebbe applicarsi proprio a quella demistificazione della realtà sostanziale del nome in quanto tale, demistificazione vivacemente avviata da
Michelstaedter nella polemica contro la ragione sufficiente dei nomi, che risalta
come non mai nei suoi derivati ironici dal graffiante titolo Il piacere dell’onestà,
dove si trova, fra l’altro, nella centralità, pur rovesciata, della tipologia dell’onesto, un motivo forte dell’assiologia michelstaedteriana. Una cosa è significativa: il
rapporto tra nome e cosa, la vita del linguaggio, i giochi che ne problematizzano
le valenze ontologiche, conoscitive, dialogiche, diventano oggetto discriminante
d’una riflessione che, mentre si compendia in d’Annunzio nell’esaltazione totale
della parola poetica, trova Michelstaedter e Pirandello proiettati su un punto di
vista che articola e dialettizza le componenti del giudizio. Se nel pensiero di Michelstaedter è individuato con nettezza il rischio di parola come menzogna quando assume la valenza di quel sapere la realtà che è diverso dal viverla, se vivace è
la critica al carattere di schematizzazione dei discorsi che prende la filosofia nel
passaggio da Platone ad Aristotele al posto del rapporto intrinsecamente dialogico che la dialettica esige, certe indagini, sviluppate ulteriormente in Appendici critiche, non eludono il campo dell’analisi linguistica testuale condotta fino a strutture nuclea­­ri quali i modi di connessione sintattica, o l’uso dei tempi o, con attenzione al dettaglio, certi intercalari e formule del discorso, tuttavia sempre alla verifica di quel difetto di comprensività vitale in cui la parola precipita quando non
dice la cosa ma la dizione della cosa. Pirandello, da parte sua, alieno da ogni retorica schematizzante, critica la divaricazione tra cose e parole che però vede affermarsi sia nella precarietà della comunicazione sociale rappresentata da gran parte del suo stesso teatro sia nell’aulica tradizione specifica del linguaggio letterario. Certamente la parola apprezzata da Michelstaedter misura tutta la sua distanza da ogni estetismo nel quale d’Annunzio possa immergerne il potenziale evocativo esclamando per esempio, in uno spirito di adorazione e di ritualità, «o Poeta, divina è la Parola». Il goriziano avverte, senza cadere nell’estetismo dell’ineffabile, tutta l’inadeguatezza che l’espressione verbale può svelare a fronte del vissuto, del vissuto stesso rappresentato da un tema poetizzabile come il sentimento
amoroso: «la “storia” che non soffre le parole / ma vuol esser vissuta» 35 e arriva,
sul filo di una drammaticità ben più intensa di quella accessibile alla letterarietà
dannunziana ma anche al modulo logico-patetico della discorsività pirandelliana,
a quella straordinaria designazione di una parola «sanguinante» che fa intravedere un parallelo tra mondo verbale, da una parte, mondo della vita inteso come lotta a tal punto «a ferri corti con la vita» che «quanto uno vuol camminar sulle sue
gambe, tanto deve sanguinar le sue parole» 36, dall’altra parte.
La parola, che in i Appendice non scopre quel lustro di trascendenza teologica che certo côté ebraico attribuisce al linguaggio, da Rosenzweig a Benjamin, ma
appare collegata con l’individualità illusoria inscritta nei modi della «significazio-
176
177
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
ne sufficiente», occupa, nello sguardo complessivo di Michelstaed­­ter, uno spazio
di stretta contiguità tra filosofia e vita. Quanto poi a un più largo giro di pertinenze al tema del linguaggio, si può dire che l’attenzione dell’autore, intenta a individuare il ruolo di dinamiche intenzionali volitive nel fuoco delle quali si media
l’individualità illusoria, traguarda il potenziale semantico, etico, conoscitivo della
parola e della frase in rapporto alla verità o alla retorica, non solo in termini filosofici. Si fa luce anche, in La persuasione e la rettorica, un interesse a manifestazioni tendenzialmente stilistiche del discorso collocate entro un contesto di tensione
vitalistica. È in ballo un’immagine di vitalità, anzi di gradazioni di vitalità, quando in i Appendice, evocando la svolta della filosofia platonica verso l’astrazione retorica, Michelstaedter rileva come quella deriva teoretica è contrassegnata da una
certa voce, ovverosia intonazione esistenziale, non priva di risvolti psicologici, fra
i quali entra in questione perfino un sentimento gioioso o stanco riflesso nella forma discorsiva: «Già dal Fedro la dialettica propria non vive più e l’esposizione di
Platone è un’“apologetica”. Ma è sempre la voce d’una persona che ha qualche cosa da dire, che ha gioia viva nel dire. In questi ultimi dialoghi si manifesta la persona stanca che si tormenta di fronte a una nebbia di problemi ch’essa non domina più, e che deve pur via coi propri mezzi risolvere come che sia, perché questa è
ormai la posizione che ha preso» 37. Analogamente, sempre a proposito della svolta platonica, viene indicata una sequenza speculativa con un proprio ritmo interno, cioè una musicalità, qualità funzionale per sua natura al linguaggio poetico e
anche alla liberazione di pulsioni vitali, mediante il paragone di una melodia che
si disperde, e sempre nell’evento modulativo di una voce, di un segno concreto,
insomma, di manifestazione vitale: «Come una melodia che attraverso le elaborazioni e per il moltiplicarsi degli ornamenti e degli accompagnamenti abbia già
perduto la forza della sua primitiva purezza, che infine anche le note fondamentali
rompe negli accordi imperfetti […] Platone contamina le stesse note fondamentali a emetter le quali soltanto egli aveva levato la voce: e il suo sistema liquescit» 38.
Né si trascuri a conferma che una certa prospettiva sullo stile occupa un posto
nelle argomentazioni di Michelstaedter in rapporto allo stesso plesso di sensibilità e riflessività afferenti all’essenza della vita, l’affascinante notazione su una giocosità come fiore della serietà, là dove alla fatica dell’esposizione di certi tardi dialoghi platonici viene contrapposta una leggerezza insieme giocosa e seria, propria
dei primi dialoghi di Platone, corrispettiva del più sensibile ritmo vitale di quelle
prime esperienze dialettiche. Scrive Michelstaed­­ter: «Molti restano in dubbio se
il turbine logico del Parmenide sia giuoco o serietà. Ma non è né giuoco né serietà:
è fatica. Quando Platone era serio, allora giocava: è un giuoco il Simposio, un giuoco il Fedro, sono giuochi tutti i suoi primi dialoghi, dove la sua vita gli è davanti
concreta in persone ch’egli finge e fa vivere giocosamente davanti a noi» 39. E, più
avanti: «Il giuoco è il fiore della serietà. Cercare il giuoco per il giuoco è vana co-
sa, come di chi cercasse l’onda senza aver l’acqua» 40, definizione generale in cui
sembrerebbe accennarsi un incunabolo di poetica orientata a quell’ibridismo tra
comico e tragico, o umorismo, verso il quale tendeva la coscienza critico-letteraria
della modernità otto-novecentesca dagli scapigliati a Pirandello e che meno potrebbe ritrovarsi nella strategia retorico-letteraria di un d’Annunzio ma che non
porta in Michelstaedter a esiti degni di nota se non nella transvalutazione di quei
blandi accenni in espressionismo e grottesco o in tendenze satiriche, quest’ultime
per esempio in brani ove mette alla berlina la presunzione di chi conferisce al sapere astratto dalla vita la consistenza di un sapere assoluto, come nello scatto ironico: «Ma gli uomini non hanno più bisogno d’esser persuasi, poiché da quando
sono nati, qualunque cosa facciano o dicano, hanno già il privilegio d’un’anima
immortale che li accompagna dalle braccia della balia» 41 replicato dalla conclusione stessa, ironizzante, della Persuasione: «Ma gli uomini temo che siano sì bene incamminati, che non verrà loro mai il capriccio di uscir della tranquilla e serena minore età» 42. Ma si citi anche, a questo proposito, l’esclamazione: «O vanità cinta di querce!» 43, dove (insieme all’eco di un riferimento all’ibseniana Anatra selvatica che troviamo anche nella lettera alla famiglia 8-10 maggio 1909 44) fluisce un’ironia amara sintetica e metaforica, tale che si può ricordare, pur fuori di
ogni accertabile mediazione, il sapido verso di Umberto Saba: «Quante rose a nascondere un abisso!».
La personalità e la scrittura filosofica e letteraria di Michelstaedter non aprono, in verità, all’umorismo se per umorismo intendiamo solo un alleggerimento
della tensione psichica. Si ricollega, invece, come sopra accennato, a un umorismo
in chiave grottesca e satirica al di fuori del predominio meramente ludico buona parte della sua opera, per esempio alcuni passi della Persuasione e significativi documenti dell’opera grafica. La più superficiale vena comica è ben difficile da
propiziarsi, troppo distinta risultando una fondamentale coscienza tragica della
condizione umana anche in contesti dove affiorano virtualità di rappresentazione non depressive, come quando perfino l’immagine luminosa del sole, lontana
da certa solarità trionfante di d’Annunzio, talvolta identificata in un «sole avaro»
quasi antitesi del sole che in Canto Novo genera vita e gioia, è attraversata dallo
spirito del dolore universale: «Sente nel sol la voce dolorosa / dell’universo» 45. E
tuttavia non certo ingessato, disponibile anche all’ironia, se ironica è l’anima di
un criticismo che pone in discussione luoghi comuni e può rivestirsi di una serietà
tutta particolare, passibile magari di un’ironia come «circonlocuzione della serietà», secondo una definizione dell’ironia di Vladimir Jankélévitch 46, appare questo mondo sentimentale e immaginativo, dunque virtualmente dischiuso alla mobilità psicologica e intellettuale. Nei Figli del mare lo sguardo al mondo della vita
nella sua totalità unitaria e pur diversificata, tra vicende di esistenze e di morte, di
mondanità e di ascesi, di delusione e di riscatto, permette al goriziano una varie-
178
179
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
tà di moduli prospettici e una mobilità di toni espressivi il cui substrato è una disponibilità di sguardo in linea, proprio per la fluidità degli stati e dei punti di vista, con una disposizione anche letteraria alle variazioni. Si va da un ritmo cantilenante del refrain a ripiegamenti del linguaggio quasi prosastici ove si innerva l’autocoscienza intellettuale in parziale analogia con la struttura sintattica che nella
Ginestra leopardiana salda, attingendo il limite sinfonico, visione filosofica e pathos interiore, anche se nelle forme di una visualità riesumante tratti di un Leopardi meno spettacolarmente agonistico, prossimo alla quintessenza allegorica, e
nelle forme di un precario accostamento a quell’accensione estrema e a quel prospettivismo marcato che possono alimentare la disponibilità al verso di d’Annunzio rispecchiata nella dinamica di una metrica nata dalla musica e a essa ascrivibile ma non votata a contrappunti di profondità interiore e simbolica paragonabili a quelli michelstaedteriani nel tenore intenso e drammatico dei Figli del mare.
In questa alta poesia il vicino e il lontano, topoi d’una spazialità che presso
l’Heidegger di Essere e tempo potrà riguardare il «disallontanamento» e l’«orientamento» quali modi dell’«esserci», si alternano nelle spire di un canto che tende
a ritornare su se stesso e sui capisaldi del proprio etimo concettuale e sentimentale, riconfermando l’originaria scansione sulla quale si innesta una prospettiva che
fissa il lontano nell’“oltre” e lo riconfigura 47, ritornando, nel vicino (si veda certa
sequenzialità circolare di immagini tra terra e mare), sempre dentro una tesa attualità vitale. Tutto ciò si pone abbastanza fuori dallo spirito evasivo ed esotico
nel quale un certo d’Annunzio concepisce la distanza e, pur se rivisto nella luce
dell’allargato orizzonte visivo ed esperienziale promosso dalla modernità, rimane fuori, anche, da tendenze proprie del vitalismo modernista futurista. Pensiamo alla contrazione spaziale che l’immaginazione marinettiana vagheggia quando nella figura dell’analogia ritrova l’amore che lega le cose lontane («L’analogia
non è altro che l’amore profondo che collega le cose distanti» 48) in un’esaltazione, si direbbe, della più segreta e allargata correlatività (come quella da Michelstaedter adombrata nell’esempio dell’atomo di cloro in cerca, a distanza, dell’atomo di idrogeno), ma senza quel tendere al lontano che sia garante di un più ampio possesso di realtà al persuaso, a colui il quale nel raggiungimento d’una visione universale impegni la propria vita non limitata e non episodica. Vita non limitata e non episodica propria dell’uomo persuaso estraneo all’attivismo frenetico del mondo contemporaneo ma anche, sempre verificandone la valenza sul piano della dialettica tra “vicino” e “lontano”, estraneo all’impasse teorica del Platone scivolante verso la retorica, come si vede in i Appendice: «Ma Platone […] non
può dare vicine le cose lontane, ma le cose vicine dice e le chiama lontane – perché
[…] conservino il nome di cose lontane: di sapienza assoluta» 49.
Ma il d’Annunzio che entra più decisamente e ostentatamente in un mondo
di vita è rappresentato da Maia, poema di lode alla vita esaltante una disposizio-
ne di spirito coincidente con la sensibilità di Michelstaedter fervida già nei primi tempi giovanili quando scriveva, a proposito d’una poesia sul canto del gallo, «viva la vita». Nelle Laudi Michelstaedter poteva fra l’altro ritrovare un d’Annunzio confrontabile con il d’Annunzio di Più che l’amore e coinvolto in una situazione ritenuta come altamente evocativa di tutta la poe­­tica dannunziana, secondo quanto testimonia la lettera del 12 gennaio 1907 dove, in riferimento proprio a Più che l’amore, si legge: «Quindi la situazione è corrispondente esattamente a quelle del d’Annunzio stesso di fronte alla sua famiglia nelle Laudi quando
prende quasi commiato da lei, corrispondente a tutta l’Attività sua poetica e pratica» 50 ; al che potremmo aggiungere che in Maia compare anche un’affermazione vigorosa di contare sul proprio io come ingresso in una sfera d’esistenza qualitativamente superiore, secondo uno spirito analogo a quello vigente nell’immaginaria conquista eroica d’uno spazio marino che in Michelstaedter poeta attingerà, con maggiore coerenza e profondità morale, tutto un correlato simbolico. Nella lettera Michelstaed­­ter esprime, nonostante l’affermazione che il dramma è «un
gioiello, una cosa splendida per concetto ed immagini» 51, critiche alla composizione dannunziana, segno di una disposizione valutativa sviluppata con maggiore
ampiezza e discernimento nella recensione alla pièce del 1908 che, collegata alla
testimonianza epistolare, tanto più appare, nella responsabilità del giudizio, sottratta alla mera occasionalità dell’evento, coinvolta in una maturazione autonoma
di giudizio. Quanto alle Laudi, la missiva non attesta altri rilievi oltre quelli sopra
citati, ma non sarebbe certo assurdo ritenere che anche riguardo ai versi di Laus
vitae come riguardo a Più che l’amore Michelstaedter avrà potuto oscillare tra suggestione estetica e individuazione critica di ciò che rimaneva distante dai nuclei
più profondi, etici, filosofici e poetici, della sua propria tensione vitale.
La Laus vitae, esempio emblematico di vitalismo trionfante, scostata da quei
tratti di malinconia che, nell’ottica di Michelstaedter, accompagnano una coscienza della vanità dell’illusione per lo smarrimento d’un punto vitale collocato tra coscienza e atto, ben rappresenta la condizione dell’io esposto a un mondo
che, apparendo sotto le forme dell’infinita diversità degli oggetti evoca la trama
illimitata delle occorrenze pullulanti nello spazio sociale ragionando intorno alle
quali Michelstaedter indaga sulle possibili diversioni della volontà dallo stato di
persuasione verso i termini della ϕιλοψυχία. Il rischio d’un quid retorico in senso
michelstaedteriano rinvenibile nella Weltanschauung che è al fondo dell’esordio,
il luogo più esplicitamente laudativo all’interno del poema, potrebbe forse collocarsi tra ideologia e scrittura (o tematica e letteratura), cioè tra l’elogio indirizzato da d’Annunzio alla «diversità» o pluralità dell’esperienza, che è elogio, è facile
osservare, di un concetto, e la proiezione immaginosa, pur da d’Annunzio realizzata, di quel concetto, in una serie di plurimi singoli aspetti del mondo, puntualmente evocati con uno stile, al limite, di pura elencazione, ciascuno più denso di
180
181
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
vita reale a confronto con l’enunciata astratta e disperdente «diversità» (si ricordi il «sapore» concreto del cibo, esempio, per Michelstaedter, nella sua determinatezza, d’una, pur a suo modo, autenticità), e tuttavia ciascuno, nell’insieme della tendenziale mise in serie, “correlativo”, seguendo una metodologia teo­­retica di
Michelstaedter, a piaceri che si attendono dal futuro e che frantumano l’esistenza nei bisogni da soddisfare, distornanti un intimo dialogo con se stesso attraverso il quale la realtà molteplice si riconduca all’unità dell’io. D’altronde troppo vivo risulta, in d’Annunzio, un autocompiacimento della mutazione del sentimento
e dell’immaginazione (tanto più illecito, si potrebbe considerare alla luce delle riflessioni michelstaedteriane consegnate allo scritto, sopraccitato, La libertà, quanto più eventualmente ammantato dalla baldanza che procura la presunzione di
falsa universalità implicita in una sensazione assoluta, in realtà limitata e parziale, di “vita selvaggia”) a paragone di chi, come il poeta della persuasione, in Amico mi circonda il vasto mare, contempera un desiderio espansivo con un analogo
o più forte desiderio di totalità coesa chiedendo: «la vita che mi dia pace sicura /
nella pienezza dell’essere» 52.
Che si imponga, presso il d’Annunzio della Laus, sul terreno di spazi immaginativi equorei ed aerei pur affini a quelli che possiamo ritrovare in Michelstaedter
poeta, una tendenziale dispersività dell’io, lo conferma il limite immaginativo tra
presente e passato e tra presente e futuro varcato con troppo abbandono di sé, come nella facilità di «persuasi sonni» ove annega, in effetti, con singolare rovesciamento, la coscienza persuasa. Lo conferma, ancora, la chiusa di Maia che si può
leggere quasi come in assonanza con un altro simile ma pur differente passo del
goriziano, entrambi ruotanti intorno alla dignità ed essenza della vita. D’Annunzio recita la formula: «è necessario navigare, non è necessario vivere»; in ii Appendice della Persuasione è scritto: «impossessarsi del bene della propria anima, essere uguali a sé stessi (esser persuasi) è necessario, vivere non è necessario» 53, ove è
facile constatare come nel primo termine dell’antitesi michelstaedteriana il sostituto del verbo navigare figurante nel primo termine dell’antitesi dannunziana sia
impostato secondo un significato che esalta la potenza unificante dell’autodominio e dell’autoidentificazione. Si riaffaccia allora, come in palinsesto e a conferma
dunque di una presenza dannunziana nelle sepolte tracce dello stato sentimentale
di Michelstaedter, ma in termini del tutto riplasmati, il motivo, topico nella cultura occidentale, dell’ulisside e del viaggio nonché quello del mare che ne è la cornice fin dai tempi dello stereotipo omerico e fa parte dell’esperienza vissuta oltre
che del mondo delle reminiscenze letterarie 54 e di una loro mediazione, fra l’altro,
nella metafora dell’ulisside prospettata da d’Annunzio riguardo a Corrado Brando e a se stesso nella lettera a Vincenzo Morello preposta a Più che l’amore. Sono motivi aventi per sfondo storico, dal quale si stacca l’originalità di Michelstaedter, una tensione morale e una spinta attivistica che presso la cultura primono-
vecentesca di estrazione vociana trovava condizioni favorevoli per attecchire, motivi di avventura e di paesaggio adattati da d’Annunzio non solo in Maia ma, in
Intermezzo, al tracciato d’una vita edonistica tutta personale nella metafora della «Nave bella» conducente il poeta verso una vita agognata fuori dalla propria
«terra feconda», in tutt’altro ordine di senso rispetto a quella metaforica «fragile
nave» 55 del goriziano poeta navigante, come appare in una lirica a Senia, fra tante difficoltà, verso una meta rescissa da ogni preoccupazione del contingente, fatto salvo, sempre nei termini di un’analoga metaforizzazione, il desiderio michelstaedteriano di una nave non dannunzianamente bella ma “grande” come alternativa a una fragile imbarcazione: «Alla fragile imbarcazione in mezzo all’uragano, la grande nave è un porto sicuro» 56.
Michelstaedter, che poteva trovare in una citazione di Schopenhauer da parte del Nietzsche della Nascita della tragedia l’immagine metaforica di un mare illimitato e tempestoso di fronte al quale, nella sua barca, si difende l’uomo che trova serenità dal proprio giudizio 57, Michelstaedter che era in grado di discriminare con una nettezza sconosciuta a d’Annunzio tra evasione e impegno, introietta
nel dramma di Itti e Senia i simboli del mare contrapposti alla terrena trama delle
«dolci e care cose» scartando ogni tentazione di romanesque. Un quoziente simbolico dell’affidarsi all’ampio mare è pur nel dannunziano finale di Maia che include
il rimprovero: «L’amico / Divenuto sei della terra?» 58, ma la componente troppo
ariosamente avventurosa di questo epilogo è distante dall’aura tragica di un scelta
etica definitiva che domina in Michelstaedter. Spostarsi alla conquista di uno spazio oltre ogni limite era anche dell’imagerie di Marinetti, la cui preistoria poetica
è da annoverare nella nietzschiana fantasia della «conquista delle stelle», ma il futurismo, preannunciato da quelle origini, può tradire una sotterranea paura della morte da esorcizzare proprio nell’attivismo spasmodico, perché una volontà di
presenza, cioè di presente, dal carattere ossessivo, può velare, sull’interfaccia d’un
mondo della vita esibito come totalità, la condizione contingente della ϕιλοψυχία.
Nell’invito di Itti a intraprendere la via del mare quella che era l’eroicità di Corrado Brando si complica, fino a superare ogni esaltazione estetica del­­
l’ardimento che pur Michelstaedter ammirò e che brilla in tratti della stessa lirica, per il recupero d’una dimensione del sacro, inclusa, oltre che nella simbologia di Itti, in un’impressione di cacciata dal paradiso terrestre: i «figli» del mare
sembrano esiliati da un mondo di trasparenze e di levità divina per una condanna, dagli echi biblici, al lavoro, che li riduce ad aver posto «fra i mortali ricurvi
alla terra» 59, perché «stretti alle bisogna della terra / si curvarono a faticare» 60.
Idealità, sacralità del mistero, destino dell’esistere, sospingono Michel­staed­­
ter verso mete altre da ogni richiamo di mondo effimero e, trasgredendo la visuale in superficie, verso le sfere dell’alto o del basso. È a lato dei fantasmi della profondità e del sublime che si affianca un mondo della vita riportato all’essenza di
182
183
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
una sua non tranquillizzante durezza (la vita è dura, come si dice nella Persuasione). Risulta dunque ipotizzabile che una tendenziale verve di poetica della leggerezza in sintonia e d’altra parte non in completa omologazione con il Nietzsche di
Zaratustra o la scrittura di d’Annunzio o certe manifestazioni del futurismo negli assecondamenti d’una poe­­sia alata, la quale pur combacerebbe con la mediazione immaginativa di un concetto michelstaedteriano di persuasione, assimilandosi quest’ultima al volo non della cornacchia ma del corvo, non possa non essere il risvolto dialettico di un immaginario della pesantezza, di quel peso che definisce la condizione esistenziale fissata dal goriziano, una pesanteur a cui si oppone l’etereo della luce o della lampada, figura dell’esistenza fervida e tuttavia precaria. La musica, il trasporto per la quale è vivissimo in Michelstaedter, è il corrispettivo più pertinente di una poetica dannunziana della trasfigurazione del tema letterario in tensione espressiva intenta a escludere dal segno verbale una semantica realisticamente grezza, appesantita sul significato. E tuttavia, più ancora
che in d’Annunzio, presso Michelstaedter l’alternanza tra reale e ideale, basso e
alto, comporta un’esaustività integrale di compresenza dialettica dei termini. Come possiamo constatare quanto netta sia, in Michelstaedter, la critica della vanità
retorica della parola che non affonda nella realtà, così difficilmente potremmo attribuirgli la sentenza dannunziana proclamante, a esaltazione del ritmo e del suono della poesia, la sentenza che dice, con assolutezza di un’estetica onnicomprensiva, «il verso è tutto», senza quelle specificazioni di una totalità, attraversante lo
stesso ritmo poetico, che rispecchi il profondo drammatico della vita in senso individuale e insieme universale.
Alla musica delle parole tende il d’Annunzio di Laus vitae, fra tecnicismo metrico e rapimento ritmico, ma che la sua suggestiva tensione musicale non sia quella, propriamente, alla quale è intonato il pathos vitale michelstaedteriano, si evince da sintomatici rilievi testuali. Nell’encomio dell’opera posto verso la fine di
Maia, il poeta che, riferendosi all’autore dell’inno, dice: «operò con puro fervore, / quasi fosse questa l’estrema / opera di sé morituro» 61, esalta uno stato di raggiunta felicità trasferita dall’ispirazione alle parole concepite come «potenza… e
splendore dei suoni» 62, tessere d’una melodia in cui il tutto si rispecchia, una pagana divina melodia. La melodia del «giovane divino», quella a cui può sentirsi
trasportato Michelstaedter nel nome di Pergolesi, è diversa. La musica che affascina Michelstaedter è fusa dall’imo con un senso universale del dolore quasi l’intensità con la quale ha fatto proprio Beethoven (certo attraverso una consapevolezza, profondità e originalità di partecipazione diverse dalla plateale esaltazione di
un Corrado Brando che dice di avere appreso da Beethoven furore e turbine) abbia lasciato tracce di incompatibilità irresolubile con quel vitalismo dannunziano
per cui fin dagli archetipi della sua manifestazione in Laus vitae contenuti nell’alcaica xi del Canto Novo si proclamava il bando da ogni dolore: «Lungi da l’ani-
ma / nostra il dolore, veste cinerea» in una visione distante, sotto l’impulso di un
“apollineo” abbastanza estraneo al “dionisiaco”, dalla concezione che il goriziano può avere di un dolore che sottostà alla gioia stessa, un dolore che «stillante in
ogni attimo della vita nessuno lo conosce, ma lo dice gioia» 63. Demonica se non
divina vuol essere anche la melodia del dannunziano lodatore della vita, ma già
immiserita perché traguardata dal punto di vista dell’insegnamento e quindi della tradizione: «Il Dèmone dai mille nomi, / il vagabondo Orgiaste, / il Dio circolare, il Maestro / delle visioni, l’Amico / dei suoni, Colui che conduce / la melodia
del Tutto, / m’insegnò quest’arte nascosta» 64. Se questa melodia ha qualcosa di divino, la sua essenza non esclude il tono aulico d’una rievocata tradizione, d’un insegnamento ancora operante. È vero che d’Annunzio, nelle vesti di Stelio Effrena di Il fuoco, si accosta alla celebrazione di un carattere originariamente vitale
del linguaggio poetico che può rientrare, sia pur nell’ambito di un esaltato estetismo, e a parte il debito espresso alla tradizione autoctona della stirpe, nella sfera
di un vitalismo e antitradizionalismo, quindi antiretoricismo di fondo: «La più alta visione non ha alcun valore se non è manifestata e condensata in forme viventi
[…]. Io non verso la mia sostanza in impronte ereditate […]. Io non debbo e non
voglio obbedire se non al mio istinto e al genio della mia stirpe» 65. Ma l’inno alla vita offre almeno uno squarcio di un diverso ordine di istanze nella delineazione della poetica. Esso guarda a un procedimento essenzialmente tecnico di scelta di parole legate, sì, viene detto, alle profondità della vita: «Io vi trassi con mano / casta e robusta dal gorgo / della prima origine» 66, ma in realtà non tanto assorbite dal sentimento assoluto della propria origine quanto avvalorate dal lavoro, espressamente dichiarato, della conversione ovvero dell’adattamento: «Converse io v’ho nuovamente / in sostanza umana, in viva / polpa, in carne della mia
carne» 67 e programmaticamente esposte a un fine che contrappone al presente un
futuro illusorio: «Io dal vostro cozzo faville / sprigionai, baleni d’amore / che illuminarono l’ombra / del Futuro pregna di mondi» 68. Michelstaedter, librandosi
anch’egli in un aere più puro e alto rispetto alla routine quotidiana tramite l’ascolto e l’interpretazione della musica di Pergolesi, alle soglie della morte, morituro
egli stesso per decreto della sorte come simile a un morituro immagina, d’Annunzio, il cantore dell’inno («operò con puro fervore, / quasi fosse questa l’estrema /
opera di sé morituro» 69), attinge una melodia divina nel raggiungimento di un assoluto che è il presente di una rigenerante coscienza della verità, di un’intuizione
la quale, priva di sbocchi che affondino in un surrettizio meraviglioso e però sicura di un “tragico” da riscattare umanamente, ha alle spalle non la tradizione retorico-letteraria ma l’esperienza d’una persona pronta a contrastare, da uomo intero e consapevole, gli inganni del vivere, a lottare, dunque, non tanto, come nel più
esteticamente fascinoso impeto giovanile, «col ferro in pugno verso l’ideale» 70,
ma, spietatamente e senza illusioni, scostato il velo di Maia, a ferri corti con la vita.
184
185
roberto salsano
michelstaedter, d’annunzio e il mondo della vita
note al testo
Ibid., p. 60.
Id., Epistolario, cit., p. 394.
Id., Poesie, cit., p. 52.
46
Vladimir Jankélévitch, L’ironia, Genova, Il Nuovo Melangolo, 2003, p. 65.
47
La mobilità di posizioni e di ribaltamenti fra lontano e vicino, densa di significato simbolico, occupa un ruolo spiccato nell’argomentazione filosofica michelstaedteriana. Così, una «vicinanza delle cose lontane» è adombrata dal fatto che «La vicinanza s’intensifica soltanto per la presenza delle determinazioni future, che nel presente ogni volta procura la vicinanza futura» (Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 81).
48
F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Milano, Mondadori, 1968, p. 42.
49
Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 176.
50
Id., Epistolario, cit., p. 178.
51
Ibid.
52
Id., Poesie, cit., p. 53.
53
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 150.
54
Scrive Campailla: «Ma al di là di ogni influenza letteraria, fortissima fu in Michelstaedter l’esperienza diretta del mare»; cfr. Campailla, Pensiero e poesia, cit., p. 81.
55
Michelstaedter, Poesie, cit., p. 89.
56
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 47.
57
F. Nietzsche, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, a cura di V. Vivarelli, Torino, Einaudi, 2009, pp. 28-29.
58
G. d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, ii, Milano, Mondadori, 1964, p. 342.
59
Michelstaedter, Poesie, cit., p. 79.
60
Ibid., p. 80.
61
D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., p. 323.
62
Ibid., p. 325.
63
Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 24.
64
D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., p. 324.
65
D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., p. 324.
66
Id., Versi d’amore e di gloria, cit., p. 326.
67
Ibid., pp. 326-327.
68
Ibid., p. 326.
69
Ibid., p. 323.
70
Michelstaedter, Poesie, cit., p. 41.
H. Bergson, L’evoluzione creatrice, a cura di F. Polidori, Milano, Raffaello Cortina, 2002, p. 202.
Di «un’unità di misura comune» tra l’uomo e il pensatore parla Sergio Campailla. Cfr. S. Campailla,
Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, p. 18.
3
C. Michelstaedter, La melodia del giovane divino. Pensieri, racconti, critiche, a cura di S. Campailla,
Milano, Adelphi, 2010, p. 173.
4
Ibid., p. 172.
5
Sul tragico in Hebbel cfr. P. Szondi, Saggio sul tragico, Torino, Einaudi, 1961, pp. 49-54.
6
Scrive Michelstaedter: «Ma c’è il tragico, il drammatico nella vita. La vita è sempre tale ogni qualvolta
l’uomo vive e vuol vivere la sua vita»; Michelstaedter, La melodia del giovane divino, cit., p. 51.
7
Ibid., p. 198.
8
Ibid., p. 185.
9
Ibid., p. 202.
10
Si veda, in particolare, lo scritto al quale Campailla ha dato come titolo Il coraggio, ibid., pp. 48-50.
11
Ibid., p. 196.
12
Ibid., p. 174.
13
Ibid., p. 197.
14
Ibid., p. 200.
15
Ibid., p. 48.
16
Ibid., p. 197.
17
Id., Epistolario, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 2010, p. 351.
18
Ibid.
19
Id., La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1995,
p. 80.
20
Ibid., p. 108.
21
G. d’Annunzio, Tragedie, sogni e misteri, i, Milano, Mondadori, 1964, p. 1223.
22
C. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 1987, pp. 44-45.
23
Id., La persuasione e la rettorica, cit., pp. 75-76.
24
Ibid., p. 81.
25
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, in Id., Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia, i, Milano, Mondadori, 1975, p. 484.
26
Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, cit., p. 181.
27
Ibid., p. 65.
28
Ibid., p. 56.
29
Ibid., p. 43.
30
Leggi: «anima nuda, ancora una volta rivestita degli ornamenti dell’oscurità, vaneggia inconsapevolmente», ibid., p. 189.
31
Ibid., p. 119.
32
Parla Luigi Squarzina di «qualche intrinseca e finora credo non vista affinità fra l’opera di un ventitreenne (1910) grecista e filosofo e poeta Goriziano e quella del quarantottenne (1915) scrittore siciliano» in L. Squarzina, “Ciascuno a suo modo” di Pirandello e il teatro totale delle avanguardie, Roma, Bulzoni, 1987, p. 113.
33
Cfr. lo scritto intitolato da Campailla La libertà, in Michelstaedter, La melodia del giovane divino,
cit., pp. 57-64.
34
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 90.
35
Id., Poesie, cit., p. 91.
36
Id., La persuasione e la rettorica, cit., p. 116.
37
Ibid., pp. 193-194.
38
Ibid., p. 189.
39
Ibid., p. 194.
40
Ibid.
41
Ibid., pp. 55-56.
42
Ibid., p. 131.
1
2
186
43
44
45
187
carlo michelstaedter e l’istria
gico di cui faceva parte – era un modello della eterogeneità e della contraddittorietà di
tutta la civiltà moderna, priva di un fondamento centrale e d’una unità di valori 1.
Gli scrittori che hanno vissuto a fondo la sua eterogeneità, la sua molteplicità di elementi irriducibili a risolversi in un’unità, hanno capito che Trieste – come l’impero asbur-
Del resto, come sostiene anche Elvio Guagnini, la cosiddetta “triestinità”, come ogni definizione di un’identità culturale, è certamente una categoria «indifferenziata e indebita», che viene proiettata oltre i termini storici e culturali di momenti ed elementi distinti.
Tale concetto di Mitteleuropa, dunque, ha fatto di Trieste una stazione sismografica dei terremoti spirituali che si apprestavano a sconvolgere il mondo. Questo fenomeno era particolarmente evidente nella città giuliana per cui, mentre nel
resto d’Italia gli ambiti culturali erano prevalentemente sensibili agli influssi francesi, qui si sentivano chiaramente i modi della cultura tedesca (austriaca e non
germanica) che si estendeva non solo alla letteratura, ma all’abito di vita originario, sovrapponendovisi, a volte.
All’antica Tergeste si può senza dubbio accostare Gorizia che, seppure in misura minore e meno evidente rispetto alla prima, vive in quegli anni momenti culturali piuttosto intensi, spesso orbitanti intorno a giornali o riviste («Corriere di
Gorizia», «Corriere Friulano»).
Piuttosto importanti vi furono le istituzioni educative, come lo Staatsgymnasium frequentato da Carlo Michelstaedter, e considerevole l’attività vitale della comunità ebraica che qui, come altrove in tutta l’area giuliana, ha portato un influsso di malinconia e “pessimismo” uniti sempre ad acuta intelligenza, che qualunque studioso o scrittore, per esempio Paolo Santarcangeli di Fiume, riconosce. In
questo ambiente così in fermento si evidenzieranno nomi che, come quello di Michelstaedter, chiuderanno troppo presto la loro stagione (per esempio Nino Paternolli) e altri che invece, come Biagio Marin ed Ervino Pocar, attraverseranno
con le loro esperienze e la loro attività buona parte del secolo scorso, giungendo
sino al secondo Novecento.
Spicca particolarmente oggi, dopo tempi decisamente bui e trascuranti, la figura di Carlo Michelstaedter costituita da connotati moderni, critici, nei confronti della società del suo tempo, della scienza, della cultura, del sapere. Figura fondamentale per la ricerca delle vie che l’uomo potrebbe percorrere per giungere a
una prima consapevolezza di sé e della propria vita. Dunque, le vie della persuasione, del coraggio della solitudine e del dolore, del «coraggio dell’impossibile».
Questo pensiero così forte ed estremo, solo in un ambito mitteleuropeo
avrebbe potuto collocarsi. Si tratta di quella Mitteleuropa che, sottolinea Sergio
Campailla, «ha cominciato a riscoprirsi come fatto omogeneo solo dopo la dissoluzione territoriale della monarchia asburgica» 2. E certamente è stato condizionante a Gorizia, come a Trieste, quel sostrato psicologico e culturale ebraico
sopraccitato, nel vettore comune della comunicazione che era sino ai primi del
188
189
Carlo Michelstaedter e l’Istria
di Donatella Schürzel
L’Adriatico e Trieste come crocevia di culture, come luogo di incontro e spesso purtroppo anche di scontro di popoli e genti, assume un’importanza specifica
per quello che è lo sviluppo della letteratura e in particolare per quella che è considerata la letteratura italiana di frontiera.
A tale proposito da diverso tempo, ormai, si assiste alla rinascita non solo nella regione Friuli-Venezia Giulia e in quelle confinanti europee, ma anche in un
raggio geografico più ampio, di tale letteratura o del concetto di “Mitteleuropa”,
da cui non si può prescindere, affrontando questo argomento, come fatto culturale che avvicina e riunifica tra di loro, sulla base di antichi legami, culture e lettere di paesi diversi per lingua, struttura giuridica e appartenenza politica, al punto da individuare dei denominatori comuni, un certo linguaggio comune e un comune stile del sentire.
A proposito del concetto di Mitteleuropa, questo significa mazzinianamente
dialogo fraterno di tutte le genti e sentimento di appartenenza a un comune destino.
Tale fenomeno è sicuramente evidente nella letteratura sviluppatasi sin dal
tardo Ottocento in poi a Trieste in particolare, e a Fiume e in Istria con aspetti e
connotati che travalicano i tempi.
Di Trieste va detto che sicuramente è stata ed è ricca di contrasti e di differenze culturali in genere, anche in riferimento al resto d’Italia, ma ha cercato e cerca
proprio in questi contrasti la sua identità e la sua italianità. Come dichiara Claudio Magris in Trieste:
donatella schürzel
carlo michelstaedter e l’istria
Novecento la lingua tedesca. Dopodiché, invece, si farà prepotentemente spazio
l’italiano fortemente voluto e cercato dallo stesso Michelstaedter, così tanto affine alla ricerca di Svevo e a quella quasi certosina di Slataper, quando fa riferimento alle sue tre anime e poi tiene sempre il vocabolario della lingua italiana a
portata di mano.
Scrive dell’ambiente goriziano nel 1916 Bruno Astori:
mazione e per origini “spirituali”, quando pensa, per esempio, alle «generazioni
di rabbini sulle spalle» che ha allo stesso modo del «vicino».
Gorizia, prima della guerra, si presentava con una regola di vita quieta e casalinga,
che sapeva di salotto e di chiesa, una regola di vita un po’ ritirata e un po’ fastosa, un po’
molle e un po’ beghina, che ricordava insieme l’età del Goldoni e di Maria Teresa, i grassi
predicatori roboanti e il belare di quella decrepita Accademia dei «Sonziaci» che era stata un illustre cenacolo goriziano nella settecentesca famiglia d’Arcadia 3.
E Marco Cerruti osserva che l’interesse e l’amore per autori come Carduc­­ci,
presenza molto importante nella prima giovinezza goriziana del nostro, De Amicis, Verdi, Fogazzaro, d’Annunzio evidenziano chiaramente una predisposizione
all’italianismo, allora sempre più impellente e favorito fortemente dal padre, figura in vista della media borghesia ebraica goriziana, uomo d’affari e di lettere vivacemente aperto e rivolto quasi a una sorta di apostolato politico, pure se poi il
ginnasio tedesco era il canale diretto di comunicazione con il mondo germanico
o, meglio, austriaco.
In tale contesto Carlo Michelstaedter, attratto dal mondo vociano fiorentino,
che percepiva echi dai grandi letterati sopraccitati e dai moderni crepuscolari, si
colloca secondo alcune interpretazioni tra i precursori dell’esistenzialismo. Ma
quanto ciò è effettivamente corrispondente alla realtà?
Per Michelstaedter il superamento del dolore deriva dalla determinazione a
trarre gioia dal peso della vita, per cui piuttosto che voler oltrepassare il dolore
stesso della vita, è necessario essere coattivi nel dolore.
Molto interessante a tale proposito è l’idea del suicidio che si configura come
una “défaillance”, una non controllata lacerazione di un sistema di pensiero che
non può contemplare quel gesto, secondo l’opinione espressa in uno scambio epistolare con Vladimiro Arangio-Ruiz da Umberto Saba, che ha conosciuto Michelstaedter a Firenze intorno al 1907.
Voglio parlarle del mio “vicino” Michelstaedter. L’ho conosciuto anch’io, nel­­l’epoca
circa, che l’ha conosciuto lei.
A quanto ricordo, eravamo allora tutti e due un poco “matti”, e non ci siamo piaciuti
a vicenda. Poi ho saputo che si è suicidato 5.
Ancora insiste Saba sulla sua tesi scrivendo al suo interlocutore e attribuendo
molti anni dopo un peso, quasi un’avversione al ruolo svolto nella vita e nell’opera del «vicino» dalla sorella Paula, pur sottolineando che non è sicuro:
Michelstaedter che aveva, oltre il resto, molti suicidi in famiglia, si è ucciso per una
ragione punto filosofica e molto (umanamente) pietosa; una ragione che egli stesso (ma
non ne sono del tutto certo) ignorava, e che mi è oggi perfettamente chiara, come chiunque abbia un po’ di pratica con l’inconscio e il suo linguaggio 6.
Nel ricordo che Saba comunica ad Arangio-Ruiz si coglie un chiaro dissentire
nei giorni della loro conoscenza tra sé e il giovane goriziano, per motivi probabilmente personali, pur essendo così vicini oltre che anagraficamente anche per for-
Tornando all’ambito dell’intensa e poliedrica attività filosofica e artistica
di Carlo Michelstaedter, oltre alle numerose opere prettamente filosofiche e di
espressione di un pensiero particolarmente complesso e profondo, si evidenziano le esternazioni nell’ambito pittorico, nel quale pure il giovane goriziano ha
dato prova di notevole maestria e la predisposizione a realizzare caricature e autoritratti fortemente incisivi e dalle caratteristiche stilistiche che, ponendosi tra
un realismo quasi fotografico e un guizzo espressionistico, sono estremamente preziose per comprendere o intuire diverse sfumature dell’animo del giovane artista.
Sul ruolo di questo lo stesso interessato aveva espresso, secondo un procedimento analogico, una visione piuttosto originale confrontandola con la figura classica del letterato nazionale dei suoi giorni. Riconosce il piano retribuito
dell’intellettuale che è concetto sicuramente odierno e ne individua l’importanza sociale, mentre crede realizzata nella sua opera una “distinzione” dal tutto.
Cercando però di indagare più l’animo che il pensiero specifico di Michelstaedter, fondamentali sono le Poesie, composte tra il 1905 e il 1910, e l’Epistolario, a cura di Sergio Campailla e pubblicato nella sua interezza, costitui­­ta da molti inediti, proprio in occasione del centenario della morte. Attraverso queste due
raccolte si evince un forte rapporto del goriziano con l’Istria, in particolare Pirano e la costa sino a punta Salvore. Luoghi questi dell’Istria che in realtà, all’epoca, erano considerati i naturali sbocchi al mare, insieme a Grado, spesso pure frequentata dalla famiglia, di villeggiatura quasi “ovvia” per chi, benestante, si trovasse a vivere in quella Venezia Giulia ancora asburgica politicamente e positiva-
190
191
Si diceva allora e forse lo si dice ancora oggi, che il suo suicidio avesse una connotazione “filosofica”. Nulla, si capisce, di più falso 4.
donatella schürzel
mente mitteleuropea però, che individuava soprattutto nell’Istria la sua espressione marinara più bella, oltre che fortemente ed evidentemente italiana per cultura, lingua e sentimento.
Nella raccolta poetica, in cui la gran parte dei testi sono momenti di sfogo
dell’animo, composti senza preparazione, il mare, prediletto e vissuto con grande passione dal giovane, che vagheggiava l’idea di darsi, dopo la laurea, alla vita
marinara, è cantato in tutte le sue più evidenti manifestazioni, dalla bonaccia alla tempesta, percependo nel suo eterno rombo la voce di quel tempo che nell’immensità degli spazi diventa, per esempio nella poesia Alla sorella Paula, l’immagine metaforica della richiesta incondizionata del poeta, che ugualmente si può ben
percepire anche nella poesia Onda per onda batte sullo scoglio:
Onda per onda batte sullo scoglio.
Passan le vele bianche all’orizzonte.
Monta rimonta or dolce or tempestosa
l’agitata marea senza riposo.
Ma onda e sole e vento e vele e scogli,
questa è la terra, quello l’orizzonte
del mar lontano, il mar senza confini.
Non è il libero mare senza sponde,
il mare dove l’onda non arriva,
il mare che da sé genera il vento,
manda la luce e in seno la riprende,
il mar che di sua vita mille vite
suscita e cresce in una sola vita.
carlo michelstaedter e l’istria
Ché senza posa come batte l’onde,
ché senza posa come vola il nembo,
sì la travaglia l’anima solitaria
a varcar nuove onde, e senza fine
nuovi confini sotto nuove stelle
fingere all’occhio fisso all’orizzonte,
dove per tramontar pur sorga il sole.
Al mio sole, al mio mar per queste strade
della terra o del mar mi volgo invano.
Vana è la pena, vana è la speranza.
Tutta è la vita arida e deserta,
finché in un punto si raccolga in porto,
di sé stessa in un punto faccia fiamma.
Pirano, agosto 1910 7.
Ahi, non c’è mare cui presso o lontano
varia sponda non gravi, e vario vento
non tolga dalla solitaria pace,
mare non è che non sia un dei mari.
Anche il mare è un deserto senza vita,
arido tristo fermo affaticato;
ed il giro dei giorni e delle lune,
il variar dei venti e delle coste,
il vario giogo sì lo lega e preme
– il mar che non è mare s’anche è mare.
Ritrova il vento l’onda affaticata,
e la mia chiglia solca il vecchio solco.
E se tra il vento e il mare la mia mano
regge il timone e dirizza la vela,
non è più la mia mano che la mano
di quel vento e quell’onda che non posa…
192
Qui il mare è quello di Pirano, dell’Istria, che rappresenta un rifugio prediletto dal giovane poeta goriziano, quasi un luogo di fuga, spesso, dove fondersi
completamente con la natura, quella del mare appunto, che gli permette di dare sfogo alla sua intensa vitalità e sensualità, ai suoi sentimenti più teneri, più remoti, più profondi e anche più cupi in determinati versi («vana è la pena, vana è
la speranza»).
Tutto ciò è espresso sempre con grande passione, con un desiderio particolarmente vibrante di rimanere ancora e ancora a Pirano, davanti a quello splendido
e calmo azzurro o su quel mare talvolta mosso a tempesta.
In questi versi tutti gli elementi della natura sono fortemente corrispondenti a
stimoli vitali, evidenziati attraverso le consonanze, le anafore («onda per onda»),
gli ossimori («dolce… tempestosa»), l’incalzante accelerare del ritmo («onda e sole e vento e vele e scogli»).
«Il mar senza confini, il libero mare» dell’Istria suscita però anche sensazioni inquietanti ed evidenzia la ricerca di miraggi impossibili, così lontano dal mare fonte di gioia e serenità di stupariciana memoria. Il mare, quindi, diventa mito,
cantato con ardore, il «mar che non è mare s’anche è mare».
E la necessità di finire, di tramontare per poter rinascere diventa impellente;
considerando, dunque, la data di composizione, questi versi potrebbero essere avvertiti come il segnale oscuro di qualcosa che, di lì a non molto, sarebbe avvenuto.
Infine, questo mare, con il «mio sole, […] per queste strade della terra o del
mar», è amato così appassionatamente da Michelstaedter, come tante volte testimoniato dallo stesso e dalla sorella Paula, tanto che, dopo la laurea pensava, come già detto, di non lavorare e di andarsene proprio a Pirano (più difficilmente a
Grado), diviene il porto in cui raccogliersi, cosicché la vita «arida e deserta, po193
donatella schürzel
tesse di se stessa in un punto» fare «fiamma». Fiamma talmente accesa da bruciare chi, nel suo totalizzante individualismo, ne avvampa, cosa che nient’altro è che
l’allegoria dell’amore spasmodico del poeta per la vita, che ne rimane sopraffatto.
In Amico – mi circonda il vasto mare, quest’ultimo è sempre più protagonista
quasi esclusivo.
Amico – mi circonda il vasto mare
con mille luci – io guardo all’orizzonte
dove il cielo ed il mare
lor vita fondon infinitamente.
Ma altrove la natura aneddotizza
la terra spiega le sue lunghe dita
ed il sole racconta a forti tratti
le coste cui il mare rode ai piedi
ed i verdi vigneti su coronano.
E giù: alle coste in seno accende il sole
bianchi paesi intorno ai campanili
e giù nel mare bianche vele erranti
alla ventura.
carlo michelstaedter e l’istria
Guardo e chiedo la vita
la vita della mia forza selvaggia
perch’io plasmi il mio mondo e perché il sole
di me possa narrar l’ombra e le luci –
la vita che mi dia pace sicura
nella pienezza dell’essere.
E gli occhi tremuli della colomba
vedranno nella gioia e nella pace
l’abisso della mia forza selvaggia –
e le onde varie della mia esistenza
l’agiteranno or lievi or tempestose
come l’onda del mar l’alga marina
che le tenaci aggrappa
radici nell’abisso e ride al sole. –
Pirano, agosto 1908 8.
Si tratta ancora del mare dell’Istria che, come del resto le montagne intorno
all’Isonzo, diviene per il poeta, negli ultimi due anni della sua esistenza, “luogo”
dove far prova della “persuasione” come libertà assoluta dell’io, come esperienza
in un certo senso estatica e in un altro come “avventura” di scomposizione della
persona dai limiti dei condizionamenti precostituiti della “qualunque vita”.
In questa poesia scritta a Pirano nel 1908, il rivolgersi per due volte al “generico” amico fa trapelare una voglia quasi di comunicare stati d’animo così intensi
e contrastanti e ancora carichi di un vitalismo che due anni dopo sarà molto più
sofferto, come in Onda per onda batte sullo scoglio. Qui il poeta brama la vita quasi in modo divorante, parla della sua “forza selvaggia” che è in antitesi e contrasta
espressivamente con la gioia e la pace della colomba.
L’immagine del mare dalle mille luci evoca il ricordo di quelli che anni dopo
saranno i versi di Umberto Saba in Ulisse («Il porto accende ad altri i suoi lumi»
in Dalmazia) per esprimere un dolore che non è solo personale, ma generalizzato
a tutti gli uomini, mentre qui Michelstaedter si sente come avvolto sensualmente dal mare che con il cielo, nella successiva immagine di tipo leopardiano, «lor
vita fondon infinitamente». Trapela, due versi dopo, una bella eco dell’Aurora
ῥοδοδάϰτυλος, dalle rosee dita, di omerica, poi saffiana e poi dannunziana memoria, a dimostrazione pure dell’approfondita e raffinata cultura del nostro poeta.
Dal verso 8 al 13 è tratteggiata, come in un quadro d’insieme impressionista o
dei nostri macchiaioli attraverso il contrasto dei colori, la tipica costa istriana con
i suoi paesi di pietra bianchissima, in cui spicca sempre un campanile veneto e la
vegetazione fitta e profumata di pini, cipressi, allori e mirti che arriva a pelo d’ac-
A me d’accanto, sullo stesso scoglio
sta la fanciulla e vibra come un’alga,
siccome un’alga all’onda varia e infida
philobatheía.
S’avviva al sole il bronzo dei capelli
ed i suoi occhi di colomba tremuli
guardano il mare e guardano la costa
illuminata.
Ma sotto il velo dell’aria serena
sente il mistero eterno d’ogni cosa
costretta a divenire senza posa
nell’infinito.
Sente nel sol la voce dolorosa
dell’universo, e l’abisso l’attira
l’agita con un brivido d’orrore
siccome l’onda suol l’alga marina
che le tenaci aggrappa
radici nell’abisso e ride al sole.
Amico io guardo ancora all’orizzonte
dove il cielo ed il mare
la vita fondon infinitamente.
194
195
donatella schürzel
carlo michelstaedter e l’istria
qua. Realmente così, ancor oggi in particolar modo in alcuni tratti del vagabondare michelstaedteriano, per esempio Salvore.
Ma si coglie pure, in questi versi, il sensualismo accentuato di tutti gli autori
giuliani, per esempio in questo sole che accende con una passione erotica i paesi
bianchi intorno ai campanili.
Nella seconda strofe il senso “panico” della natura – «Sta la fanciulla e vibra
come un’alga» – fa molto pensare all’effetto di personificazione della natura e di
antropomorfizzazione dell’elemento umano, che ancora una volta riporta a d’Annunzio.
Nella terza strofe, invece, è percepibile un senso di dolore dell’esistenza
umana, molto simile, stavolta, a quello di Saba – «Sente nel sol la voce dolorosa
dell’universo» –, ma tra questa e la quarta strofe si evidenzia nuovamente un’eco
leopardiana di La ginestra che affonda profondamente e tenacemente le sue radici nella terra e resiste così a qualunque avversità, simbolo della solidarietà umana,
quanto «le tenaci aggrappa radici nell’abisso» l’alga e però poi, con un desiderio
bramoso di vita, «ride al sole».
Nella splendida Per ora a bordo non è lavorare, definita dai critici una barcarola, anche la tecnica della composizione e lo stile risultano particolarmente attenti, curati e studiati.
La ripetizione nella prima, seconda e terza strofe del primo e dell’ultimo verso che chiude unitariamente la “melodia” cantata, crea un leitmotiv dell’intera
composizione.
Nella seconda strofe, l’immagine del sole calante non sul ma nel mare produce una sensazione di pace e serenità proveniente proprio da quell’idea di immersione nell’azzurro, come in un originario liquido amniotico, che è la stessa idea di
posizione distesa, orizzontale sull’acqua («riposa il riposo del mare») di memoria
fetale, rintracciabile pure in Claudio Magris. Quella stessa posizione orizzontale
di Magris che, nel romanzo Un altro mare, riscopre il rapporto di Michelstaedter
con Enrico Mreule, quando con emozione scoprirà in una casupola di punta Salvore un baule con oggetti che, forse, erano stati di Enrico.
Protagonista assoluto è sempre il mare per il quale, in questo caso, non si trova
un riferimento certo che si tratti di quello di Pirano o dell’Istria, ma che, per come viene descritto, è probabile lo sia, così come avviene in altre poesie, per esempio la iv scritta a Gorizia, in cui si rivolge appassionatamente ad Argia Cassini,
amica particolare e amata, facendo riferimento a luoghi frequentati nelle loro comuni vacanze a Pirano del 1908, 1909, 1910 e vissuti intensamente: «Alla punta
del golfo donde il mare s’apre libero e vasto senza fine»; il riferimento alla punta
che chiude il golfo al di fuori del quale spira forte il vento e la scogliera su cui il
mare s’infrange fanno certamente pensare all’Istria.
E non si può fare altro anche per il riferimento alla barca a vela che doveva
e sapeva controllare, atletico com’era, e per il veleggiare lungo la scogliosa costa.
Non potrebbe del resto essere questa una descrizione per il mare di Grado che si
sviluppa in laguna. «Il vento e l’onde intanto come un rottame verso la scogliera».
Andando a considerare le epistole, e analizzando quelle dei fatidici ultimi tre
anni (nelle precedenti non vi sono riferimenti espliciti o particolarmente significativi), già nella lettera a Gaetano Chiavacci dell’11 luglio 1908 si apre lo scenario
sul trascorrere del tempo, estivo, sulla costa istriana (nelle lettere delle estati precedenti la villeggiatura marina veniva trascorsa a Grado).
Ciò che immediatamente colpisce di queste righe fitte e numerose, è la precisione, si potrebbe dire diaristica, del giovane nel raccontare all’amico come trascorra la giornata nel reinserimento “tradizionale” in famiglia, se confrontato con
la vita libera e “d’artista” che conduceva a Firenze.
Si nota, inoltre, l’atteggiamento di iperattività rappresentato dai molteplici impegni elencati in via di ripresa, di chi ha fretta e brama di iniziare, con un desiderio bruciante di muoversi, di dare sfogo alla sua fisicità così dirompente. E a tutto ciò è da aggiungere il riferimento, che per ben due volte appare, alle signorine
che insieme con la sorella saranno con lui nelle circa due settimane da trascorrere sulla costa istriana. Le concise espressioni fanno intuire delle aspettative di tipo se non altro vitale e gioioso, che in quel mare incontaminato e per lui ancora
Per ora a bordo non è lavorare
che inerte pende la vela
e il vento tace sul mare
e il mar è a specchio del cielo.
Per ora – a bordo non è lavorare.
A sera il sole calerà nel mare
che senza nubi è il cielo
e giù ai confini del mare
l’orizzonte è senza velo.
A sera – il sole calerà nel mare.
Oggi sul ponte dolce riposare
che senza moto la nave
riposa il riposo del mare
e non si può camminare.
Oggi sul ponte dolce riposare.
Sola sul dorso del mare
nel mezzo del cerchio lontano
sta sotto il ciel meridiano
la nave a galleggiare 9.
196
197
donatella schürzel
carlo michelstaedter e l’istria
sconosciuto, più lontano, per esempio di Grado, dunque più “riservato”, si poteva pensare di soddisfare:
Io davo la scalata a tutte le barche a vela che vedevo rientrare in porto quand’ero in
acqua, conversavo coi pescatori, poi mi precipitavo a testa dai coraggi. – Quando uscivamo e dovevamo fare anche forza di remi li aiutavo a remare. –
A Gaetano Chiavacci
Gorizia, 11 Luglio 1908
[…]; Martedì 20 con mia sorella e le 2 solite signorine, al mare sulla costa istriana fino ai primi d’Agosto; […] 10.
Nella successiva lettera del 4 agosto, da Gorizia, sempre a Chiavacci, è profondamente mutato lo stato d’animo. La vivacità e la brama di far tante cose lascia spazio a un ripiegamento su se stesso, nel timore di rimanere escluso dalla vita passionale. Le descrizioni della sua interiorità vengono effettuate con paragoni
al mare, quello dell’Istria che ha appena scoperto e lasciato.
A Gaetano Chiavacci
Gorizia 4 Agosto 1908
[…] – ma navigare a vela, sulle nostre buone «brazzere» venete. – In questi 10 giorni
che ho passato sulla costa istriana, con quale struggimento le vedevo raccogliere il vento
alla sera con tutta la tela spigata e uscire bordeggiando sul mare infiammato dal sole che
tramontava; – e di notte il mare era seminato di piccoli punti luminosi. Dieci giorni di
sole e dieci notti senza luna; la notte nera con tutte le stelle: εὐϕρόνη, e la luce dell’oscurità diffusa sul mare che batteva gli scogli ritmicamente. E non si sentiva che la sua voce. –
10 giorni di libertà in compagnia di mia sorella e di due signorine. Di quelle 2 signorine di cui ti parlavo e ti dicevo che sono innamorato di tutte e due e anche della mamma
loro e della loro casa e del loro cane.
Eravamo noi quattro soli con le stesse tendenze, gli stessi gusti a goderci il mare e i
colli, a vibrare allo stesso modo a ogni impressione senza bisogno di comunicarcele. Io
non so se tu sai che cos’è la costa dell’Istria. – Io certo non lo sapevo. Io credevo che si
trattasse d’una specie di deserto di pietra con una miserevole vegetazione e un mare basso
e sudicio contaminato da acque dolci. Invece è tutta un altipiano fecondo, tagliato a picco
dal mare che lo rode violentemente ai piedi – come Marinelli insegna.
Quando uno lo percorre in alto, vede le prospettive delle punte che scendono in mare con la testa verde e la base rocciosa, una dietro l’altra, sempre più chiare e in mezzo le
insenature profonde e il mare scuro come un lago fra i monti, poi più lontano a Nord il
nostro litorale, il Carso e la linea delle lagune che si perde verso occidente, e più in fondo
la linea delle Alpi e davanti l’ampio mare sonante.
[…]. In mare non c’erano limiti alle nostre nuotate né di tempo né di spazio: eravamo celebri in tutto il paese; io solo ho fatto dei bei viaggetti per mare a nuoto. Si mangiava su una terrazza sul mare e dopo i pasti ballavamo come indemoniati. – In dieci giorni
c’eravamo acquistata la simpatia di tutti i Piranesi (già – non t’avevo detto ancora che abitavamo a Pirano) specialmente della gente di mare con cui parlavamo sempre al porto.
198
[…] – Anche un altro m’aveva offerto un ingaggio. E davvero io penso che sarebbe
per me la miglior cosa. –
Anche Pirano è una città deliziosa, tutta affollata su una lunga lingua di terra completamente veneta, – e le case hanno i piedi nell’acqua; al principio della punta più in alto
la chiesa che domina lontano su tutto il golfo, più in alto le fortificazioni fra il verde degli
ulivi. E gli abitanti sono tutti belli, donne uomini, giovani vecchi – un tipo delicato, intellettuale quasi – veramente veneto.
Le donne vanno tutte avvolte nel zendàl nero come a Venezia, con le belle capigliature pettinate in modo come le Fiorentine non sognano, e tutte senza cappello, borghesi e
popolane. – Evviva l’Istria, l’Istria verde 11!
Fondamentale e tra le più belle e significative questa lettera in cui la scoperta
dell’Istria è sorprendente. Nel pensare a quel mare solcato dalle «brazzere», tipiche imbarcazioni usate su tutta la costa dell’Adriatico, dall’Istria alla Dalmazia,
come ricordato pure nel recente romanzo di Lucio Toth La casa di calle San Zorzi,
il giovane rimembra romanticamente giorni bellissimi, intensi, ricchi di emozioni impreviste, ma anche volute e cercate, che l’ambiente naturale amplifica e rende indimenticabili.
La bellezza incontaminata dei luoghi, inaspettatamente per lui ameni, lussureggianti nella loro vegetazione, coltivati in modo simile alla Toscana, ricchi di colori che vanno dal rosso della terra al verde intenso degli alberi di vario genere e
delle pinete, al bianco brillante delle scogliere che irradiano del loro splendore le
belle e curate cittadine veneziane e si specchiano nell’azzurro limpido e puro di
quel mare, che diviene così familiare per il poeta, come se fosse il suo vero ambiente, quello primigenio, quello a cui si torna istintivamente e nel quale ci si sente fusi in un “unicum” ancestrale che dona forza, energia vitale, voglia di vivere e
di “essere” per se stessi e rispetto agli altri.
E gli altri vanno dalle fanciulle amate delicatamente e sensualmente in un modo che tutto coinvolge e tutto vuole (la madre, la casa, il cane), alla capacità di
comunicare con chiunque come i pescatori, con i quali individua un sottile trait
d’union tanto da esprimere apertamente il famoso desiderio di cui si è già parlato
di risolversi a vivere sempre lì, al mare, in Istria.
Emozionanti e intensi sono i notturni dolci che tanto portano alla mente le
descrizioni marine estasiate di Stuparich e la bellezza aspra e intima del Carso di
Slataper che si staglia sopra il mare che “ride”. Con tale atmosfera a fare da sfondo
alle sue scorribande giovanili, il poeta prova completamente il senso totale della
libertà e dell’energia, che nella prima parte della lettera non percepisce più in sé.
199
donatella schürzel
Individua, infine, cosa di non scarsa importanza considerati i tempi politici che si profilavano e i venti di italianità sempre più frequenti, la visibilissima
e incontestabile cultura veneta dell’Istria dalle barche alle case e vie della bella Pirano, ai suoi abitanti, al loro modo di abbigliarsi, all’aspetto fisico, al modo
di vivere che si evince essere molto libero e aperto al superamento delle barriere sociali, che era cosa piuttosto inconsueta a inizio secolo sia nel resto d’Italia
(come nella colta Firenze tirata in ballo in un confronto che volge a suo svantaggio, con un po’ di sottile soddisfazione, da parte del frequentatore dei più
importanti ritrovi culturali della città del giglio), sia nella mitteleuropea e austera Gorizia.
Tutto sfocia in un grido forte e vibrante di «Evviva l’Istria» che suona molto patriottico.
Ritornerà ancora, in questa lunga lettera che sembra un’intimissima confessione, dopo il rientro a Gorizia con uno stato d’animo grave, ai ricordi di momenti particolarmente effusivi come quelli sulla terrazza dell’albergo di Pirano,
in compagnia della fanciulla amata, che questa volta è Fulvia, mentre la bora increspava il mare, una vela era sbattuta tra le onde e un gabbiano passava a volo radente sull’acqua scura del mare, illuminato solo dai riflessi delle luci dell’albergo.
Il pensiero va anche a serate meno travagliate, in cui con la fanciulla passeggiava sulle rive, in silenzio, cercando di assaporare e di godere fino in fondo di
quanto la natura di quel luogo, con la sua immediatezza e purezza, poteva trasfondere in loro. In tale contesto è incredibilmente moderna la mentalità manifestata
dal protagonista degli eventi e dalla sua accompagnatrice, che non vogliono e non
sentono il bisogno delle convenzioni e di trasformare una naturale e libera condivisione di pensieri e fisicità in una regolare storia tradizionale.
Ora che è di nuovo in città, il giovane artista si sente svuotato e l’idea di ripartire per la montagna dove trovarsi con altre persone lo spaventa.
Nell’estensione di questa epistola è da rilevare pure l’alta qualità dello scritto,
lo stile vario e ricercato, l’uso ricco del lessico e un modo del periodare piuttosto
originale, che frequentemente infrange le norme tradizionali, con l’utilizzazione
personale dell’interpunzione che accosta alle immagini dei quadri d’insieme una
sorta di espressionismo letterario.
In una lettera dell’anno dopo all’amico Enrico Mreule viene sottolineata la
fraterna amicizia che li lega, quasi con un attaccamento morboso da parte di Carlo e che lo mette in condizione di esprimere le sue più profonde sensazioni condividendo l’interiorità più intima mentre vagheggia ancora una volta l’amata Pirano, pensando a un tipo di situazione e di esperienza purtroppo conclusa senza dubbio.
200
carlo michelstaedter e l’istria
A Enrico Mreule
[S.ta Lucia] Domenica, 22 [Agosto 1909]
[…]
Nell’oscurità della mia vita di questi giorni, che passa stilla a stilla interminabile, io
vivo la mia vita più intima con te. Sono nella tanto prevista situazione di ripensare a Pirano come a un passato definitivamente conchiuso. Penso alle nostre giornate e alle nostre
serate, e soprattutto penso alla tua costante abnegazione per me. […]
[…]
Il terzo giorno che tu eri a Pirano, Sabato, il giorno della loro partenza, mentre
l’Argia ed io eravamo in sala a suonare, la Paula e la Fulvia facevano il bagno allo stabilimento; tu e Nino eravate al largo con la barca. A pranzo la Fulvia vi chiese come
era andato il bagno e se tu avevi nuotato, e Nino rispose: eh, lo go butà in acqua e el
ga nodà 12. –
Viene così ricordata la villeggiatura realizzata dal gruppo di amici di cui faceva parte anche Nino Paternolli e questa volta pure Argia Cassini.
I giovani sono maturati da un anno all’altro e si coglie il tipo di divertimento goliardico e meno sognatore o sentimentale, come quello dell’anno precedente condiviso con Fulvia.
Frequente in questa lettera, a differenza di quelle a Chiavacci non di origini giuliane, come Michelstaedter e gli altri amici, l’uso di modi del dire dialettali (premettere al nome proprio delle persone l’articolo) e addirittura l’espressione
in dialetto usata da Paternolli per rispondere a una domanda di Fulvia. Ciò a significare la dimestichezza, la confidenza e la condivisione di modi del vivere comuni tra loro.
Nella lettera del 28 novembre dello stesso anno, scrive ancora da Gorizia
all’amico Enrico partito per la Patagonia e accompagnato al porto di Trieste
dall’altro amico, Paternolli.
Teatro dell’iniziale e lunga navigazione che li separerà per sempre è ancora
una volta il mare dell’Istria. Stavolta, però, il panorama è quello di Pola o forse
anche un po’ più a sud e l’ideale legame tra i due amici è costituito dai rossi tramonti che sprofondano dentro il mare e che poi rendono con la loro foschia successiva evanescente la figura di Mreule che si allontana definitivamente provocando grande dolore e lasciando un vuoto che non verrà colmato.
È ormai l’ultimo anno di vita di Michelstaedter, il 1910, e si tratta anche delle
sue ultime lettere. In quella della fine di giugno sempre al carissimo Enrico Mreule, oltre a manifestare la sua imperitura amicizia che va al di là del tempo e dello spazio (il fatto che l’amico sia in America non glielo fa sentire meno vicino e la
condivisione interiore è sempre la stessa), gli racconta gli ultimi eventi che lo riguardano e le difficoltà insorte nei rapporti con i genitori.
201
donatella schürzel
A Enrico Mreule
carlo michelstaedter e l’istria
Gorizia, 29 Giugno 1910
[…]
Ormai il mio tempo penoso volge alla fine; ¾ della tesi è stesa, e mi sento più rincuorato a far il resto – spero d’esser libero fra un mese e poi vado al mare – e non me ne allontanerò più, se non per i pochi giorni alla discussione della tesi in ottobre 13. –
Qui è dichiarato apertamente il proposito di ritirarsi a vivere al mare, a Pirano, non appena discussa la tesi di laurea e sembra quasi una fuga programmata, soprattutto quando parla di tempo penoso (che in tal caso sembrerebbe proprio essere riferito allo studio e al dover rendere conto in qualche modo alla famiglia), mentre cova l’idea di un ritorno definitivo a quell’unico ambiente ed elemento della natura che lo fa sentire libero e vivo, forse.
Poi nella lettera a Nino Paternolli dell’11 agosto da Gorizia, quando, piuttosto
in ritardo sui suoi progetti di andare a Pirano, in quanto non è stato bene, gli dice
che se aspetta ancora qualche giorno si potranno incontrare nella cittadina marinara dell’Istria, già si vede proiettato in quella che è la vita al mare, con la barca
a vela su cui si informa. Ma quanto è cambiato il suo animo rispetto alle vacanze precedenti! La frase di chiusura, infatti, che dovrebbe essere serena, preludendo alla villeggiatura, è al contrario tremendamente triste e oscura quando fa riferimento al deserto, cioè la solitudine e la mancanza di vita che lo separa dal suo
mare. E persino il saluto, espresso in quell’«Addio», è fortemente drammatico.
Della seguente lettera, scritta precisamente da Pirano, sempre a Paternolli, ciò
che emerge tranne l’informazione spicciola data all’amico, è la notizia sul suo stare bene insieme alle amiche Cassini e alla sorella Paula, unitamente ai saluti per
tutti, pure se estremamente laconica.
A Emilio Michelstaedter
[Pirano], 2-3 sett. 1910
[…]
In questa notte ch’io passo ultima nel porto della pace, mi sei così vicino, Emilio, che
non mi basta pensare a te e alla tua vita ma ho bisogno di parlarti a parole che tu possa
udire. La mia solitudine qui non è quella della vita a Gorizia che tu conosci – non è il deserto – la voce del mare non è qui per me la lontana voce sognata, che la passione fa vicina – ma è qui presente in tutta la sua forza e mi fa partecipe della sua vita. Le onde battono e ribattono sugli scogli della costa deserta che finisce a Salvore – accanto a me sicura nel piccolo porto abbandonato è la mia barca; io ti scrivo disteso sulla stuoia d’una
piccola capanna di pietra che un tempo deve aver servito di ricovero ai minatori che, ora
abbandonata da tutti, a me è riuscito ad aprire ed occupare come mia proprietà. La bora
che soffia ancora con uguale violenza m’ha impedito ieri sera di partire, […]. Così anche
domani sera partirò per Gorizia abbandonando questa vita che m’è stata un porto di pace. Domani si ricomincia a navigare – con tutti i venti 14.
Altamente significativa, infine, la lettera all’amato cugino Emilio, scritta da Pirano tra il 2 e il 3 settembre.
L’imminenza della partenza avvertita con un senso nefasto della solitudine
quando si tratta di quella di Gorizia, fa invece vivere quella del mare come qualcosa di salutare molto più della terra, con un’idea che già Slataper aveva manifestato a proposito degli artisti del Nord e specialmente di Ibsen, quando veniva a
cercare il mare in Italia.
In questo passaggio molto sentito Michelstaedter fa la sua scelta di vita davanti al mare come le sue creature preferite, Itti e Senia, piuttosto che alla scrivania del letterato.
La barca, essendo settembre, è ormai ancorata al sicuro nel piccolo porto e lo
scrittore, disteso sulla stuoia, che rammenta tanto Slataper disteso sulla terra del
Carso di cui condivide il respiro, ha occupato quella famosa piccola capanna in
pietra di pescatori, che riporta a quella citata da Magris a Salvore con riferimento a Enrico Mreule.
Il giovane artista sembra quasi contento che la bora della sera precedente abbia impedito a lui e alle sue compagne di partire, mettendolo in condizione di trascorrere una notte proprio a Salvore, dove attendere l’alba. La chiusa alla descrizione idilliaca è prefiguratrice del futuro prossimo in cui si vede “costretto” a riprendere a “navigare” non nei modi a lui graditi, lasciando l’unico luogo che gli
è stato «porto di pace», l’Istria. Tanto che nei saluti chiede al cugino di andarlo
a trovare al suo rientro a casa, ma non in compagnia, perché è come se avesse necessità di riacclimatarsi in città prima di riprendere la vita consueta.
Il ritorno a questo punto a Gorizia, all’Isonzo e ai circostanti luoghi giuliani
denota un superamento di Vienna, di ciò che la città rappresentava e l’approdo a
quel Centroeuropa con la sua cultura della crisi o, come sottolineano Ara e Magris, della crisi e della vita.
202
203
A Nino Paternolli
Pirano, 23.8.1910
Caro Nino
Grazie per la tua lettera e la tua cura. Non c’è niente da dire e niente da fare, quello che ho detto io lo so, lo sa Seppenhofer, quello che ho fatto domani al caso porterei a
compimento.
Seppenhofer non ha né da procedere contro alcuno né da scusarsi, ma da tenersi per
detto quanto io gli ho detto, quel giorno in Piazza Grande. –
Io sto bene, e le mie tre compagne e ti salutano.
Saluta tu i tuoi e Gorizia. Per la borsa provvederò e la terrò molto volentieri. Grazie.
Tuo Carlo
donatella schürzel
Ma, sapendo bene quanto è successo poco tempo dopo il suo rientro a Gorizia, si adatta particolarmente una riflessione di Biagio Marin che, nel Ricordo di
Carlo Michelstaedter, sostiene che quest’ultimo ha vissuto e amato la terra comune
a tutti nutrendo delle sue bellezze la sua anima di poeta, anche se pochi sono stati in grado di udire e comprendere la sua voce e la spirale vorticosa della sua tragedia. E per il poeta che voleva superare i limiti, secondo Marin, persino la sua
tomba è al di là dei nostri limiti.
Testimonianza
di Christian B.M. Berlakovits 1
Carlo, pur sapendo quanto fosse bella, non l’amava la vita. Non l’amava proprio per
quel suo continuo trasformarsi, per quel suo scorrere eterno, che non sapeva sosta. Noi si
scorreva beatamente ignari con lei, e non pensavamo a fermarci, a resistere, a considerare. La salute era per noi proprio nella nostra fame e la vita era così ricca di cibo, che anche la fame diventava fonte di piacere e di gioia. E grande intensa era la comunione tra
noi e la ricca natura, che ci fioriva intorno, che ci fioriva dentro in un’estate unica, che pareva dovesse durare in eterno 15.
note al testo
A. Ara, C. Magris, Trieste, Torino, Einaudi, 1987, p. 4.
S. Campailla, Pensiero e poesia di Carlo Michelstaedter, Bologna, Patron, 1973, p. 38.
3
B. Astori, Gorizia nella vita, nella storia, nella sua italianità, Milano, Treves, 1916.
4
V. Arangio-Ruiz, Carteggio Saba-Arangio Ruiz (1948), a cura di A. Pinchera, in «Il Bimestre», 14-15,
1971, pp. 20-23.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
C. Michelstaedter, Poesie, a cura di S. Campailla, Milano, Adelphi, 20057, pp. 73-74.
8
Ibid., pp. 52-53.
9
Ibid., p. 78.
10
Id., Epistolario, a cura di S. Campailla, nuova edizione riveduta e ampliata, Milano, Adelphi, 2010,
pp. 347-348.
11
Ivi, pp. 350-358.
12
Ivi, pp. 426-428.
13
Ivi, pp. 464-467.
14
Ivi, pp. 470-472.
15
B. Marin, Gorizia città mutilata, Gorizia, Comune di Gorizia, 1956, pp. 101-107.
1
2
«Chi teme la morte è già morto».
Una frase, un fulmine a ciel sereno, un duro colpo, una sentenza. Impietosa,
spietata, inappellabile.
L’aforisma ricorre nella tesi di laurea letterario-filosofica La persuasione e la
rettorica, opera con una connotazione singolare e personalissima, di Carlo Michelstaedter, goriziano di discendenza ebreo-tedesca, all’epoca ventitreenne. Non
un enunciato cautamente confortato da evidenze scientifiche, bensì un assioma
che postula un fatto, alla maniera in cui anche il libro nel quale appare è un “fatto”, come un fatto è la vita e lo sono le opinioni e le opere dell’autore stesso del libro e, ancora, lo sono le considerazioni e riflessioni che si sedimentarono nel momento storico e nel contesto geografico e intellettuale in cui Michelstaedter era
immerso. Fatto come lo furono le speculazioni in merito alla visione e percezione
della vita di un’intera generazione di poeti e pensatori della Mitteleuropa, che caratterizzarono i decenni a cavallo tra la fine del xix secolo e gli albori del xx, periodo bollato con la definizione ambivalente fin de siècle. Infine, fatto come tutto
l’ordine di valutazioni sulla sopravvivenza dello spazio intellettuale del tempo e
segnatamente nella sua materializzazione geografica, nell’assetto culturale e istituzionale dell’Austria. Un fatto che afferisce alla morte, alla vita e alla sopravvivenza o la vita oltre la vita, che riguarda in proiezioni diverse la tesi di laurea di Michelstaedter, la sua esistenza e opera e l’Austria. Questo nesso spiega forse un po’
anche perché io oggi, nella mia funzione di ambasciatore d’Austria e in qualche
modo quale esponente della vita oltre la vita, ho l’onore di porgere il mio saluto.
Ambasciatore d’Austria a Roma.
1
204
205
christian b.m. berlakovits
Carlo Michelstaedter era circondato e anche intimamente penetrato dalla
morte. La precipua fase storica, la sua terra, terra di confine, l’impero – la monarchia, la famiglia, la mentalità in cui si era innestata la sua esistenza strabordavano di morte. Non solo moriva tanta gente, la morte traspariva anche dalle aspettative. E chi guardava in faccia la realtà lo avvertiva inequivocabilmente: la morte avrebbe preso a imperversare anche di più. Lo si vedeva e percepiva. La morte aveva la strada spianata.
Nel decennio in cui nacque Michelstaedter l’apologo L’uomo folle di Friedrich
Nietzsche nella sua Gaia scienza annunciava la morte di Dio. Per le menti un po’
più avvedute i massacri e gli eccidi di massa delle guerre mondiali erano solo una
questione di tempo.
Nell’area geografico-intellettuale dell’Austria, che all’epoca più o meno era
ormai solo una realtà geografica, si prese sempre più a ignorare consapevolmente
la morte accettando la morte stessa. Quell’atteggiamento di difesa fu in ogni caso alla base del monito e della speranza di Karl Kraus di fronte a Gli ultimi giorni
dell’umanità, della melanconia ed empatia di Gustav Mahler rispetto al canto incessante di separazione e commiato che promana dalla terra, della stridente consonanza e dell’urlo del mondo di Leoš Janá©ek e del testamento spirituale di Carlo Michelstaedter. Queste menti insigni, seppure nei loro diversi approcci, volgevano tutte lo sguardo alla morte.
«Chi teme la morte è già morto». Paradossalmente, se capovolta la frase perde
mostruosamente d’intensità: dunque chi non teme la morte non è morto.
Invero chi anche solo comincia a non temere la morte, vive in modo diverso o
quanto meno rimane aperto a un prosieguo dell’esistenza in un’altra dimensione.
Questa fu la chance che si preservò l’impavido Michelstaedter. Ora, mutato, continua a vivere negli spunti di riflessione che ci ha offerto.
Carlo Michelstaedter con la sua vita e le sue opere non voleva dire altro che
questo. Tutti voi che siete alle prese con il convegno come artefici, organizzatori
o partecipanti, date una nuova chiave di lettura alla persuasione o convinzione di
Michelstaedter: quella di cercare, impavidi della morte, di superarla nella metamorfosi, ossia proiettandosi in una vita autentica.
E io, che ho avuto l’onore e la gioia di fare questa breve introduzione, ho buone ragioni per ringraziarvi, perché mi avete dato modo di richiamare alla mente un personaggio, nella cui vita, nel cui pensiero e nella cui opera si sono rispecchiati destino e fallimento ma anche grazia e riscatto. Il riflesso che promana può
essere solo la premessa per un quadro nuovo, più nitido, variopinto e bello. Prima di dipingerlo dobbiamo ponderare bene e guardare al progetto con il massimo rispetto e amore.
206
Stampato da
La Grafica & Stampa editrice s.r.l., Vicenza
per conto di Marsilio Editori® in Venezia
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate
nei limiti del 15% del volume dietro pagamento alla siae del compenso
previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale,
economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale
possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione
rilasciata da aidro (www.aidro.org).
edizione
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
anno
2012 2013 2014 2015 2016