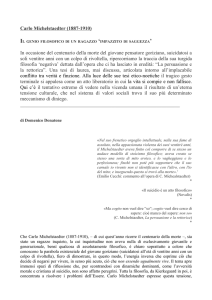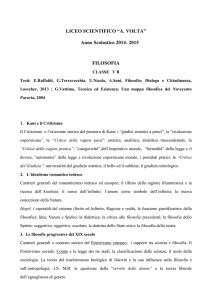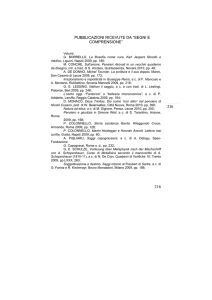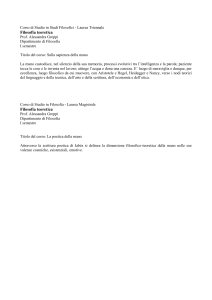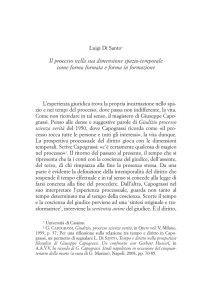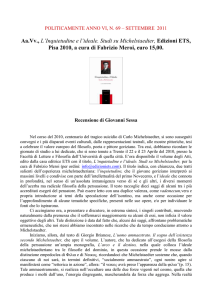Suggestioni utopiche sugli orizzonti della crisi
Fabio Corigliano*
Abstract
The article focuses on the contemporary crisis, which, besides being economic and financial is
primarily a crisis of thought. In this climate, which position is accorded to utopia? The analysis is
approached from the perspective of philosophy of law, through the reflections of Carlo Michelstaedter
and Giuseppe Capograssi, who have both expressed a way of thinking in which the struggle against the
crisis coincides with a critical exposition of the conditions of the crisis.
“e il mio maestro mi insegnò
com’è difficile trovare
l’alba dentro l’imbrunire”
(F. Battiato, Prospettiva Nevskij)
0. Criteri e orientamento
Riferirsi all’utopia in un momento di crisi come quello attuale potrebbe apparire
un’operazione tra le più felici; iniziativa certamente distensiva rassicurante
confortante, riuscirebbe persino, paradossalmente, a provocare un’apparente
metamorfosi dell’evento recessivo in poche mosse: dissimulazione della crisi,
travestimento della realtà, fuga verso l’esotismo di un non-luogo propizio per
eccellenza, uno Stato immaginario una società fuori dal tempo un luogo al di là del
luogo. Utopia, insomma, in quanto fuga dal luogo fatale, fuga dal tempo funesto. La
tensione all’irreale l’urgenza d’irrealtà posta in questi termini parrebbe nondimeno un
momento della degenerazione dell’esperienza in cui vive l’uomo d’oggi, il quale ha
talmente portato a compimento il suo assalto la sua offensiva alla realtà, al reale in
quanto res in quanto cosa, da contrapporgli come fosse un manufatto tangibile
l’irreale prodotto del pensiero, in una concezione del mondo e delle cose in cui
l’equazione parmenidea di essere e pensiero1 è surrogata da quella molto più
*
Queste schematiche riflessioni che seguono sono come degli appunti delle analisi preparatorie e
altresì delle istantanee per un lavoro più ampio sul tema della crisi che l’autore vorrebbe condurre nei
prossimi mesi: le scarne citazioni e l’apparato bibliografico così essenziale sono il segno non di una
superficiale noncuranza, ma piuttosto di uno sguardo che vorrebbe catturare più oggetti possibile con
ciò sacrificando in parte l’approfondimento teoretico ed in parte il necessario tributo bibliografico agli
autori già impegnati in suggestioni affini.
1
PARMENIDE, fr. 6, v. 1 e fr. 8, vv. 38-40. Si cita da H. DIELS-W. KRANZ, I Presocratici. Testimonianze e
frammenti (1903/1934-37), trad. it., I, Roma-Bari 1997, pp. 272 ss.
79
malleabile costituita da ente e pensiero2. L’urgenza d’irrealtà sarebbe quindi solo un
momento del corso con cui l’uomo moderno ha manipolato il mondo e lo ha stravolto,
sarebbe solo una fase di quel processo creativo col quale l’uomo ha eretto sé stesso in
quanto soggetto (subiectum) che conquista e domina il mondo con un metodo che
pone al sicuro l’ente3 e che proprio per questo motivo lo rassicura nella continuazione
della sua attività produttiva di cose e di mondi.
Allo stesso modo, parlare di utopia e in ciò fare riferimento alla contro-utopia,
all’utopia negativa, alla distopia o ancora alla (attuale) impossibilità di proiettare la
realtà in un immaginario universo utopistico, parrebbe decisamente un riprovevole
azzardo — e di primo acchito, giusta l’impostazione apparentemente eudaimonistica
di cui sopra le non-utopie sarebbero da inquadrare nella sezione terroristica ed
attentatoria della storia del mondo e dell’umanità.
Ma che cos’è quest’utopia?
L’argomento, come si vede, in entrambi i casi sopra schematicamente riferiti è
sempre il luogo il reale la cosa, ciò che si vede e che è presente allo sguardo:
insomma, il luogo-presente-allo-sguardo in quanto sguardo della cosa presente. Solo
un’analisi del luogo una riflessione concreta sul luogo acconsente così di
intraprendere la strada che conduce al suo superamento, dato che l’utopia è appunto,
per definizione, un superamento, l’attraversamento di un luogo concreto e reale,
dell’hic et nunc da cui proviene il pensiero. Un passaggio un transito da un territorio
ad un altro, da una regione all’altra.
Ecco appalesarsi in un istante, in una sola semplicissima parola, lo scarto tra
utopia e realtà. La parola è sempre il luogo, la localizzazione, la manifestazione
concreta tangibile palpabile, l’Erörterung4. E in questo caso il luogo da cui scappare
la parola dalla quale fuggire attraverso il sentiero che porta al non-luogo (utopia), è la
crisi, e quindi la realtà. L’allontanamento dalla crisi attraverso l’utopia è pertanto un
tonico per l’anima, un medicinale in grado di rendere meno sterile ogni esperienza
umana5.
Proprio per questo motivo, poichè il non-luogo misterioso e promettente,
rispetto al concreto luogo reale fatto di sofferenze potrebbe appalesarsi nelle forme di
un meraviglioso rassicurante porto sicuro, di fronte allo scontro dolente e necessario
tra una realtà che è luogo e l’utopia che è il non-luogo, si sceglie di dedicare
l’attenzione, nelle pagine che seguono, alla combinazione di questi elementi
2
Poiché «tradizionalmente la filosofia intende per questione dell’essere la questione dell’ente in
quanto ente» (M. HEIDEGGER, La questione dell’essere (1955), trad. it., ora in M. HEIDEGGER, Segnavia,
Milano 20085, p. 335), anche il rapporto di immanenza dell’essere al pensiero viene trasfigurato in
un’immanenza dell’essere in quanto ente al pensiero, in virtù di una dimenticanza del senso dell’essere
che ha condotto la filosofia a privilegiare lo studio dell’ente in quanto ente a detrimento di un’analisi
sul senso dell’essere in generale.
3
M. HEIDEGGER, Il nichilismo europeo [1940-61], trad. it., Milano 20062, p. 205.
4
M. HEIDEGGER, Il linguaggio della poesia. Il luogo del poema di Georg Trakl (1952), trad. it., in M.
HEIDEGGER, In cammino verso il linguaggio, Milano 1973, pp. 45 ss.
5
Con il che si rende evidente anche il significato medico che in origine il termine krisis possedeva, e
su cui si rimanda alla recentissima traduzione di R. KOSELLECK, Crisi. Per un lessico della modernità
(1972-1997), trad. it., Verona 2012, p. 35.
80
contrastanti, e quindi all’utopia in un momento di crisi, che per forza di cose
corrisponde, con un gioco di parole, alla crisi nell’utopia o meglio nelle possibilità di
formulare un pensiero su ciò che non è perché troppo forte e pervasivo è il disagio per
ciò che è.
Per svolgere questo lavoro, potrebbe essere interessante ricapitolare per cenni il
pensiero di Carlo Michelstaedter e Giuseppe Capograssi, in parallelo6, due filosofi del
Novecento che in momenti e luoghi diversi hanno elaborato un’analisi della società in
grado di metterne in evidenza allo stesso tempo le criticità ed altresì le inarrestabili
tendenze al declino. Si sono scelti questi Autori, insomma, dacchè in essi il tema della
crisi è approfondito e trattato, si direbbe, in modo analitico; anzi, è da aggiungere che
in essi è estremamente comprensibile proprio l’elemento il fattore etimologico e
quindi, col senno di poi, didascalico della crisi: crisi da krino; così come critica viene
dal greco krino.
Crisi e critica in quanto tempi o momenti di una struttura dialettica che
attraversa la società e di cui la società stessa, cioè l’uomo ed il suo fare (il diritto)
sono il naturale fondamento. La crisi che al culmine della sua terribile forza pare
essere solamente crisi economica è dapprima crisi dell’uomo del suo pensiero e
quindi della società in cui vive e dello Stato entro il quale opera, del diritto che gli
fornisce taluni mezzi o modi coi quali esprimere la sua capacità relazionale: è questo
il motivo per il quale nel corso di questo breve e vago almanaccare si farà riferimento
alla filosofia del diritto ed alla metafisica come fossero i due capitoli di un’unica
materia — perché lo sono, dal momento che non esiste diritto senza metafisica, a
meno che non ci si riferisca al mero elenco dei diritti e degli istituti in quanto forza
delle forme e degli apparati, e perché al fondo dell’analisi giusfilosofica il problema
della crisi è, dapprima, inerente la metafisica, ovvero il rapporto tra il pensiero e
l’essere. E quindi in tutta la sua essenza, l’uomo7.
C’è da dire ancora, ad aggravare le condizioni di questo guazzabuglio che crisi
e critica sono i momenti di un unico passaggio, quello del giudizio (krino: ecco la
radice) e quindi della riflessione sui limiti del pensiero umano e sulle potenzialità
dello stesso e dell’esperienza propria dell’uomo: spesso «le possibilità dell’azione
vengono costrette dal concetto di crisi in una situazione nella quale gli agenti possono
scegliere solamente tra alternative in netta contraddizione tra di loro»8.
In questo caso, l’alternativa è proprio vivere/non-vivere.
Si accennava alla comune radice di quei due momenti, che al tempo attuale, ad
una riflessione superficiale paiono così distanti ed anzi inconciliabili — perché non se
6
In ciò cogliendo la felice intuizione di F. MERCADANTE, Giuseppe Capograssi filosofo e “cantore
dell’individuo”, in V. FERRARI (a cura di), Filosofia giuridica della guerra e della pace. Atti del XXV
Congresso della Società Italiana di filosofia del diritto (Milano e Courmayeur, 21-23 settembre 2006),
Milano 2008, p. 561.
7
Si coglie ed accoglie qui, tra le altre, l’intuizione tardo-heideggeriana per la quale «nessun cammino
del pensiero, neanche del pensiero metafisico parte dall’essenza umana per raggiungere l’essere o,
inversamente, dall’essere per ritornare all’uomo. Piuttosto ogni cammino del pensiero va già sempre
entro l’intera relazione tra essenza umana ed essere, altrimenti non sarebbe un pensiero» (M.
HEIDEGGER, Che cosa significa pensare? [1954], trad. it., Milano 1988, p. 137).
8
R. KOSELLECK, Crisi. Per un lessico della modernità, cit., p. 49.
81
ne scorge la comune vertigine costruttiva, fattiva e concreta. Nel complesso, proprio
di vertigine si dovrebbe parlare, perché è un senso di stordimento e di stravolgimento
che si impadronisce di chi voglia attraversare il passaggio l’apertura della crisi
attraverso la critica.
1. “So cosa voglio ma non ho cosa io voglia”9: la filosofia della crisi
La riflessione sulla volontà il tema della volontà è e rimane uno tra i massimi e più
gravi problemi del pensiero moderno. Lo aveva ben evidenziato Arthur Schopenauer,
che aveva in effetti rilevato come «questo mondo in cui noi viviamo e siamo, secondo
tutta la sua essenza è completamente volontà e al tempo stesso rappresentazione»; in
questo senso, «ognuno scopre sé stesso come questa volontà, in cui consiste l’intima
essenza del mondo, così come si scopre anche come soggetto conoscente, la cui
rappresentazione è il mondo intero, il quale pertanto ha un’esistenza soltanto in
relazione alla coscienza di lui, come proprio supporto necessario»10. Se non fosse che
la struttura stessa della volizione è dominata da un’angosciante inesauribile tensione:
«l’assenza di ogni fine, di ogni limite, appartiene all’essenza della volontà in sé, che è
una tensione infinita» dacché «ogni fine raggiunto è a sua volta l’inizio di un nuovo
percorso, e così all’infinito»11.
La nozione di volontà è messa a repentaglio dal suo stesso modo di essere, è
afflitta dalla sua stessa regola espansiva dall’evidenza per cui l’atto volitivo ha come
unica finalità o meglio come unico precetto lo stesso gesto di volere. Volere come
mezzo e contemporaneamente volere in quanto fine. Codesto diktum ha radici molto
profonde, che sono da ricercare dissotterrando e portando brevemente alla luce il
modo stesso col quale si è formato. In questo senso è da chiarire che ciò che ha reso
tale il pensiero moderno è stata la scoperta o meglio la identificazione della
soggettività: a partire da René Descartes «l’uomo è il fondamento eminente che staal-fondamento di ogni rap-presentare l’ente e della sua verità, e sul quale ogni
rappresentare e ciò che in esso è rappresentato sono e devono essere posti per avere
stabilità e sussistenza. L’uomo è subiectum in questo senso eminente»12.
All’origine di ogni esperienza umana e quindi di ogni realtà sta sempre e
soltanto il soggetto con la sua volontà taumaturgicamente volta a rendere sussistente e
dotato di stabilità ogni aspetto del reale, una volontà, quindi, che si fa storia
sostituendo il logos, anzi trasfigurandosi fino a diventare logos: volontà produttrice di
realtà volontà che si fa proprio legge universale del mondo13. Il logos, che
nell’esperienza aristotelica era il discorso razionale14 — la comunicazione creatrice di
relazione — per i moderni è sostituito dalla volontà indeterminata, volontà infinita,
9
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche (1910), Milano 1995, p. 7.
A. SCHOPENAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione (1819-59), trad. it., Roma 2011, p. 188.
11
A. SCHOPENAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, cit., p. 190.
12
M. HEIDEGGER, Il nichilismo europeo [1940-61], trad. it., Milano 20062, p. 203.
13
Il logos ha avuto un’estensione semantica siffatta grazie alla riflessione di Eraclito: sono da citare in
questo senso i frammenti B 1, B 2, B 16, B 50, B 72, B 115 e B 123 dell’opera del filosofo greco nella
diffusa citata edizione H. DIELS-W. KRANZ, I Presocratici. Testimonianze e frammenti, cit., pp. 194 ss.
14
ARISTOTELE, Politica, I, 1253 a.
10
82
infine volontà di volere. Perché la volontà è la vera legge universale, ed è ciò che
accomuna tutti gli individui, che in quanto tali stanno al fondamento di tutto ciò che
si può rappresentare.
Tutta l’analisi del soggetto e della vita sociale compiuta dal pensiero moderno
esalta la volontà ed allo stesso tempo ne è succube. Il soggetto che è comunemente
inteso in quanto portatore di volontà perché portatore di vita è così attivo nella genesi
di quella da non rendersi conto che l’apice la sublimazione della propria volontà
corrisponde alla sua perdita ed alla sua apocalisse15.
Questo percorso fatto di individualità volontà rappresentazione e infine
disumanizzazione questo circolo chiuso e paradossale è il più raffinato e allo stesso
tempo inaspettato lascito della filosofia moderna: tanto s’immaginava di sollevare
l’uomo sino a renderlo indipendente da Dio16 — perché egli era dio! — quanto
rimaneva inerte e indifesa di fronte alle conseguenze di siffatto circolo vitale. Quello
che doveva essere un prepotente circolo di potenza si è tramutato nella realtà (e
proprio a contatto con la realtà, in seguito e per effetto di quel contatto) in un corto
circuito, un fraintendimento che ha coinvolto le radici stesse l’origine medesima la
configurazione dell’individuo della sua vita naturale e sociale, del diritto come anche
dello Stato.
A conti fatti, tuttavia, ciò che rende ancor più sconcertante codesto tema, è che
il pensiero moderno nel suo tentativo di sviluppare la volontà umana in sistemi
sempre più complessi, non è riuscito a dare una risposta sufficiente o adeguata alle
domande che la vita (nel suo rapporto con la volontà) più immediatamente poneva e
attualmente pone17. Cosa volere, come vivere?
È in questi termini che si deve leggere l’opera di Carlo Michelstaedter18.
L’individuo di Michelstaedter, l’individuo moderno e per estensione dell’esperienza
contemporanea, sa che vuole perché sa cosa vuole. Conosce l’oggetto del volo
individuale, cioè sa volere — dacchè l’oggetto del volere è sempre ed ancora un
volere: semper plus ultra. Sa anzi che il suo proprio singolare volere è un indice del
suo stesso personale esistere: volo ergo sum, voglio quindi sono, siccome voglio so
che esisto. Ma tant’è rarefatta l’idea di essere, allo stesso modo è confusa ed
incompresa la radice del volere. Chè così stando le cose, voglio per dimostrare che
sono per sentire che sono, anche se allo stato dei fatti voglio senza avere un’idea
15
È sempre vera l’osservazione di Martin Heidegger sulla origine di questa apocalisse: il cogito
cartesiano lascia nell’indeterminatezza «il modo di essere della res cogitans, più precisamente il senso
dell’essere del sum» (M. HEIDEGGER, Essere e tempo [1927], trad. it., nuova ed. italiana, Milano 20105,
p. 38), con ciò privando l’essere del sum — con cui si conclude e perviene a compimento il cogito in
quanto movimento essenziale del pensiero — del fondamento ontologico e quindi della tanto ricercata
stabilità.
16
A. DEL NOCE, Appunti sull’irreligione occidentale (1963), ora in A. DEL NOCE, Il problema
dell’ateismo, Bologna 2010, pp. 299 ss.
17
G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica (1953), ora in G. CAPOGRASSI, La vita etica, Scritti scelti e
introduzione di Francesco Mercadante, Milano 2008, pp. 173 ss.
18
Tralasciando la nota biografica, si rimanda per informazioni e notizie sull’Autore all’intramontabile
G. BRIANESE, L’arco e il destino. Interpretazione di Michelstaedter (1985), Milano-Udine 2010 e
all’ampia bibliografia in esso contenuta.
83
precisa di ciò che comporta volere di ciò che consegue il volere indeterminato19. E
siccome nell’atto stesso del volere l’uomo moderno separa sé stesso dagli oggetti che
conosce e che vuole, l’intera esperienza sensibile è dominata da un abbrivio: in tanto
si espande il ruolo del soggetto che determina e crea e produce la realtà, in quanto
quella stessa realtà prende il sopravvento e si ribella al soggetto che l’ha creata:
«poiché in nessun punto la volontà è soddisfatta, ogni cosa si distrugge avvenendo e
passando»20.
L’abbrivio del volere dell’atto volitivo si scorge già a partire dall’esperienza che
l’uomo fa del mondo, nel mondo: il volere in quanto tale trasforma a tal punto il
rapporto — pur complesso — tra soggetto ed oggetto, che tutto per l’uomo diventa
creazione produzione oggetto, sino a perdere la cognizione reale del processo di
creazione e di quello di produzione, confusi in un unico atto di volontà dominio
onnipotenza. Il mondo delle cose soffre di questa confusione che è ben chiara laddove
si guardi alle trasformazioni o meglio alle degenerazioni subite dall’equazione
parmenidea di essere e pensiero: ad oggi l’equazione cui far riferimento è quella di
pensiero ed ente, il che significa che il pensiero si rapporta e si accosta all’instabile e
non conosce alcun centro di stabilità se non sè stesso, si immagina di poter
trasmettere la propria stabilità alle cose senza rendersi conto di non possederla
dapprincipio. Perché in fondo, quel volere è manifestazione e sintomo di un
mancamento: «la vita è volontà e la volontà implica essenzialmente la mancanza,
l’incompiutezza»21. Ed è da ciò che deriva il rammarico ed il grido di Michelstaedter:
“so che voglio” ma non vi sono oggetti che possano soddisfare il mio volere, perché è
un volere indeterminato, senza oggetti, senza un punto di stabilità perché l’individuo
è altrettanto instabile: «se non ho fame, se non ho sete, se non ho sonno, se non ho
bisogno di alcun’altra cosa determinata, il mondo mi è un grande insieme di cose
grigie ch’io non so cosa sono ma che certamente non sono fatte perch’io mi
rallegri»22.
In questo punto, nell’ambito della riflessione post-schopenaueriana sulla
volontà, si situa l’originalità della rilettura michelstaedteriana, e quindi l’argomento
che permette al giovane goriziano di superare il rischio di un regressus ad infinitum
insito in potenza nella concezione negativistica di Schopenauer e che consente a noi
di inquadrare più compiutamente il problema nell’ambito di un discorso più
propriamente tipico delle filosofie della prassi. Infatti l’opera michelstaedteriana deve
essere necessariamente letta su diversi piani: un primo piano in cui le nozioni
primitive ed elementari di rettorica e di persuasione sono, nel loro rispettivo e
reciproco rapporto con la volontà, l’occasione per stilare una sorta di manifesto
19
È questo il significato della potente immagine del gancio con cui si apre il primo capitolo de La
persuasione e la rettorica: «in nessun punto raggiunto fermarsi lo accontenta e vuol pur scendere, che
il prossimo punto supera in bassezza quello che esso ogni volta tenga» sino a scoprire che «in ogni
punto esso manca dei punti più bassi e vieppiù questi lo attraggono: sempre lo tiene un’ugual fame del
più basso, e infinita gli resta pur sempre la volontà di scendere» (C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e
la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 7).
20
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., pp. 11-2.
21
G. BRIANESE, L’arco e il destino, cit., p. 29.
22
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 76.
84
combattente, un programma rivoluzionario dedicato ed offerto ad uno spirito
infiacchito, com’è infiacchito lo spirito dell’uomo moderno secondo l’Autore. E
costituiscono i due momenti di un discorso utopistico negativo di cui si dovrà pur
parlare. Il secondo piano è quello dell’ontologia, che può essere letto anche
separatamente, o meglio che rappresenta una dimensione ulteriore della riflessione
michelstaedteriana, di cui l’opera, se letta unicamente nei termini di una critica della
società può anche fare a meno. Ma che è invece assolutamente necessaria e si direbbe
nucleare nel caso in cui la lettura de La persuasione e la rettorica non si arrestasse
alla mera apparenza della descrizione letteraria di un disagio esistenziale: infatti nelle
Seconda Appendice al testo23 vi è una dettagliata e piuttosto complessa esposizione
dei concetti di persuasione e di rettorica come sviluppo delle due diverse concezioni
del rapporto essere-pensiero. Vi è infine un terzo piano di lettura, che si connette più
direttamente al primo, e che riguarda i risvolti sociali dei concetti di persuasione e
rettorica, poco sviluppato dallo stesso Autore e che forse sarebbe stata la naturale
conseguenza l’esito in un certo senso marxista del suo pensiero24.
Inquadrato, o almeno parzialmente inquadrato il tema della volontà e della sua
intrinseca effettiva crisi evolutiva, ci si può rivolgere più agevolmente ai temi della
crisi e della sua concreta fenomenologia, quindi alla critica dello stato di crisi in
quanto momento di un unico processo che parte dalla crisi per giungere alla critica in
ciò formulando quello che potremmo definire come pensiero prognostico-utopistico
nella crisi, o come pensiero della crisi nell’utopia.
2. Krino 1: fenomenologia della crisi
Il fenomeno della crisi non è di difficile intuizione perché allo stato attuale è davanti
agli occhi di tutti: Reinhart Koselleck, nell’offrire uno spaccato della storia
concettuale del termine crisi ebbe a notare che «se la ricorrenza del termine è un
indicatore dell’esistenza effettiva della crisi, a partire dall’inizio del XIX secolo l’età
moderna potrebbe essere definita un’epoca di crisi»25. Non si tratta invero solamente
della crisi in ambito economico finanziario dell’industria, che è solamente e
disperatamente il punto più appariscente della crisi, il punto di arrivo di un lungo
processo, la registrazione contabile di un percorso storico attraverso fatti e rilevazioni
di evidenza economica. La crisi investe ogni settore della vita umana ogni momento
della esistenza associata della quotidianità dell’ordinario. È infatti una crisi
dell’ordinario perché si manifesta nell’ordinario. È una lacerazione del vivere che
viene da lontano e che si manifesta in tutti i punti che tocca o che riesce a toccare, in
tutti i punti in tutti gli elementi. Proprio per questo motivo, poiché la crisi «è un
concetto che ha più un valore emozionale che logico», e poiché il dato di partenza è
23
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., pp. 143 ss.
Si può leggere in questi termini il “Discorso al popolo”, ora nella silloge di testi C. MICHELSTAEDTER,
La melodia del giovane divino. Pensieri – Racconti – Critiche, Milano 2010, pp. 85 ss.
25
R. KOSELLECK, Crisi. Per un lessico della modernità, cit., p. 66. Sul tema si veda anche R. KOSELLECK,
Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti (2006), trad. it.,
Bologna 2009, p. 95.
24
85
proprio emozionale perché si parla di ciò che è realmente attuale, bisogna evitare per
quanto possibile che i diversi stati d’animo coi quali si percepisce la crisi influenzino
la riflessione: «la cosa migliore è limitarsi ai fatti, cercare di coglierli, seguire le linee
generali di svolgimento dei fatti, e vedere dove ci portano»26 — una fenomenologia
della crisi, degli elementi che compongono la crisi, propedeutica all’analisi della
critica di cui si dovrà parlare.
Zu den Sachen selbst!
I fatti, proprio i fatti, nella loro cronologia storica, nella loro collocazione
temporale potrebbero aiutare a comprendere e quindi ad inquadrare nella storia il
momento della crisi potrebbero consentire all’esegeta ed al cantore, all’osservatore ed
al nemico della crisi di stilare un documento in grado di offrire il più ampio ventaglio
di informazioni. È proprio questo il magistero di Giuseppe Capograssi27: i fatti
servono a compilare un documento ragionieristico della crisi in grado di
approfondirla e di offrire le più dettagliate istruzioni per ripensarla in funzione della
sua stessa critica. Spiega Capograssi, nell’analizzare quella crisi del diritto che aveva
investito l’esperienza dopo la catastrofe, che il mondo premoderno era caratterizzato
da una struttura d’ordine assolutamente rispettata. Quel mondo, da quel punto di
vista, non era in crisi; lo era da un altro punto di vista, diremmo preparatorio: «se la
crisi è mancanza di consapevolezza dei disordini segreti che compongono l’ordine
apparente della realtà, quel mondo era in crisi»28. Quel mondo era cioè in crisi perché
aveva reso astratta la logica colla quale era stato costruito e nell’astrazione si era
persa la complessità del reale, reso semplificato ed ordinato attraverso schemi di
pensiero. La differenza tra quel mondo ed il mondo contemporaneo, è, tuttavia, la
tensione distruttiva che caratterizza il nostro presente e che invece era del tutto
assente nel corso preliminare alla crisi. La storia preparatoria dell’evento recessivo
era piuttosto caratterizzata dalla costruzione, o meglio dalla predisposizione in senso
espansivo dell’individuo e della sua soggettività, della sua tensione volitiva, della sua
capacità di essere il protagonista indiscusso del dominio sul mondo delle cose e
quindi del processo di vertiginosa crescita dell’economia del diritto della filosofia
secondo schemi che potremmo definire senza dubbio di origine kantiana: una volta
concepita la struttura d’ordine non rimaneva che applicarla pedissequamente al reale,
in un’espansione della storia senza fine29 che avrebbe paradossalmente condotto alla
fine della storia. Quel turbine, recava in sé il suo proprio peccato originale, se è vero
che l’espansione incontrollata dell’individuo del suo volere per volere e quindi della
26
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo (1953), ora in G. CAPOGRASSI, Incertezze
sull’individuo, Milano 1969, p. 85.
27
Sulla vita e sulle opere di Giuseppe Capograssi è ora possibile consultare con grande profitto M.
D’ADDIO, Giuseppe Capograssi (1889-1956). Lineamenti di una biografia, Milano 2011.
28
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, cit., p. 86.
29
È questa l’idea da cui parte la metafisica kantiana in quanto filosofia della filosofia. Scrive Kant
nella Prefazione alla prima edizione della Critica della ragion pura: «la metafisica, secondo i concetti
che qui ne daremo, è la sola fra tutte le scienze che possa ripromettersi, e in breve tempo e con pochi
sforzi, ma associati, siffatta compiutezza, in modo che di poi altro non resti da fare alla posterità, se
non adattarla nella maniera didattica ai suoi scopi, senza peraltro poterne accrescere menomamente il
contenuto» (I. KANT, Critica della ragion pura [1781], trad. it., Roma-Bari 1966, pp. 10-1).
86
realtà prodotta attraverso il pensiero si sarebbe trasformata senza preavvisi in una
tempesta di proporzioni indicibili e proprio avversa all’individuo che
quell’espansione aveva avviato, capace di distruggere tutto quello che lo stesso
pensiero aveva precedentemente eretto, tutti i monumenti che celebravano la vittoria
della ragione sulla imprevedibile complessità del reale. Una catastrofe che avrebbe
preso di mira proprio lo schema attraverso il quale il pensiero controllava il
dispiegarsi della realtà, perché pel tramite di quello schema l’individuo avrebbe
condannato sé stesso ad un dominio passivo pari a quello in cui era stato costretto il
mondo delle cose, sino al limite della disumanizzazione del mondo della società del
diritto: «alle radici di tutta la crisi c’è un’idea arrivata nell’animo di molti al grado di
persuasione e di certezza, una falsa ma centrale idea dell’umanità e della vita.
L’umanità non ha valore per sé: l’individuo non è (più) un essere intelligente e morale
che ha una legge e una sua verità: non è che un astratto paradigma di forze,
un’astratta capacità di obbedienza, una forza puramente passiva. Quello che vale è il
fine, lo scopo che i gruppi dominanti vogliono realizzare e verso il quale vogliono
avviare l’individuo»30. Tutto ciò che gravita intorno alla vita sociale dell’uomo
gioisce e soffre della stessa invenzione: l’individuo soggetto dell’azione, l’individuo
oggetto di un’azione esteriore.
Quella catastrofe, che ha causato distruzione fisica e metafisica ha condotto il
mondo delle cose e degli eventi ad una vera e propria tabula rasa, «le società da una
parte e gli spiriti degli uomini da un’altra parte si trovano riportati a condizioni
elementari e quasi si direbbe originarie»31.
L’attualità dell’analisi capograssiana non fa che rendere evidente — più di
quanto già non lo sia — come la crisi attuale sia un esito o meglio l’esito di quel
processo che partendo dalla catastrofe della guerra, si è mimetizzato dissimulando32 la
pace la ricostruzione, per cogliere alla sprovvista il povero spirito umano infiacchito e
con il fiato corto per quanto poco gli è stato permesso di riposare sulle sue false
certezze. È il caso di riportare l’intera pagina di Capograssi al fine di percepirne le
terribili implicazioni e la triste relazione con il presente: «nascono tremendi stati di
necessità per le società distrutte. Per questi cataclismi fisici e metafisici le società
rivivono fasi primordiali della loro storia; si vedono e si risentono in modo imperativo
i bisogni elementari della esistenza, che gli esatti meccanismi della vita economica, il
normale funzionare dei sistemi produttivi, le ricchezze e la quiete del passato avevano
nascosto. Questo ritorno della vita a condizioni elementari, e la necessità di
provvedere ai bisogni di una umanità, stremata in uno stato di indigenza non solo
effettivo ma soprattutto spasmodicamente avvertito dalle vigili sensibilità degli
uomini e dei popoli, fa scoprire e riscoprire la vitale importanza delle cose, cioè i
beni, i processi, le leggi obiettive e strutturali delle produzioni e delle istituzioni.
Avviene quasi automaticamente, al di fuori di ogni consapevolezza e intenzione, uno
30
G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe (1950), ora in G. CAPOGRASSI, Incertezze sull’individuo,
cit., pp. 4-5.
31
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, cit., p. 88.
32
P. VALERY, La crisi del pensiero (1918), ora in P. VALERY, La crisi del pensiero e altri saggi quasi
politici, Bologna 1994, p. 29.
87
spostamento di valori. Al posto delle persone subentrano le cose. La società stessa
cessa di essere una società di persone: diventa un insieme di processi produttivi e
obiettivi; qualche cosa di naturale, e cioè e comunque qualche cosa che esclude la
volontà soggettiva, che non è che un mezzo e un elemento dello svolgersi obiettivo di
quei processi. Le società si automatizzano. Bisogna provvedere alla vita degli uomini,
ma per provvedere bisogna obbedire, secondo la vecchia frase, che in questa società
diventa di una terribile esattezza, alla natura delle cose; le cose i loro processi, le loro
esigenze prendono il dominio della vita»33. In questa temperie in questo destino
infelice della società sono le cose, dacché erano oggetti della vita, a tramutarsi in
soggetti, e in soggetti esigenti. Oramai, «per far vivere la società bisogna seguire la
volontà obiettiva delle cose e non la volontà subiettiva degli individui. Questi
processi obiettivi sono sovrani e sacrificano — come, dove più e dove meno, avviene
dovunque — volontà e soggetto»34. Questi processi obiettivi sono il gorgo del diritto
dell’economia della prassi, sono alla fine una voragine anche per l’uomo che credeva
di dominare ed invece è stato dominato.
La crisi è crisi del soggetto.
Tutto ciò che parte dal soggetto torna al soggetto.
Quel processo che aveva scatenato l’individuo moderno, quel processo di
manipolazione del mondo delle cose attraverso una manipolazione dell’esperienza o
meglio delle possibilità dell’esperienza, al termine della sua folle corsa, torna
all’individuo e lo travolge nelle più elementari e semplici modalità della sua vita, nei
più semplici ed immediati atti del suo vivere in consonanza con gli altri individui,
nella capacità di relazione che ne caratterizza, aristotelicamente, l’essenza. L’essenza
sociale l’essenza relazionale è essa stessa in pericolo, perché anch’essa è una forma
dell’esperienza.
Anche il diritto è una modalità della relazione e quindi dell’esperienza umana.
Ed anche il diritto, quindi, e l’esperienza giuridica soffrono: «c’è nello stesso intimo
realizzarsi dell’esperienza, nell’atto stesso del suo costruirsi, una specie di
mancamento, una specie di deficienza, una specie di venir meno che dimostra che il
suo non compiersi è quasi si direbbe insito intrinseco alla sua stessa struttura. In
sostanza è di immediata e quotidiana osservazione che l’esperienza giuridica che
nasce dallo slancio stesso dell’azione verso l’oggetto profondo della volontà che
vuole realizzare interamente questo oggetto e perciò riesce a costruire il mondo delle
volontà delle istituzioni degli ordinamenti che compongono l’esperienza giuridica,
tende quasi nell’atto stesso del suo concretarsi in istituti e ordinamenti, a rinchiudersi,
a materializzarsi in queste sue costruzioni come se queste cose fossero il suo oggetto
e il termine finale del suo slancio»35. È proprio la struttura di tale ragion giuridica che
conserva intrinsecamente interiormente il prototipico cavallo di Troia che ne ha
distrutto le fondamenta, è proprio la struttura di questo modo di incanalare
l’esperienza giuridica a soffrire del suo rigido schematismo: «staccata dalla profonda
33
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, cit., pp. 88-9.
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, cit., p. 89.
35
G. CAPOGRASSI, Incompiutezza dell’esperienza giuridica, postumo, ora in G. CAPOGRASSI, La vita etica,
cit., p. 855.
34
88
vita della volontà, tutta l’esperienza giuridica che è nata da questa vita, tende a
presentarsi secondo uno schema ridotto alla lineare e rudimentale semplicità di un
meccanismo»36. Si potrebbe dire così: l’azione in cui si concreta la volontà è in tanto
di interesse del ragionamento giuridico in quanto coinvolge l’uomo nella sua apertura
relazionale, in quanto è una maniera del contatto con altri uomini. Ed è di interesse
del ragionamento giuridico perché si concreta in una modalità attraverso cui si
manifesta l’esperienza giuridica. Ebbene, quando quel ragionamento vuol costringere
l’azione oltre il necessario ordinamento dei mezzi e si spinge al regolamento dei fini,
schematizzando le forme dell’agire umano, allora davvero la struttura sovrasta
l’azione e la norma diviene meccanismo nel senso deteriore del termine, perché
trasforma o meglio deforma l’uomo stesso, addentro a quel groviglio, in meccanismo
passivo. La struttura sovrasta l’azione, quell’azione che in origine, alla sua aurora era
proprio «sorella del sogno»37 e quindi libertà delle forme libertà dalle strutture.
Si tratta, come si è già annunciato, di un circuito difettoso, nel senso che tutto lo
sviluppo circolare del pensiero presenta una deficienza originaria: quella di non aver
previsto una soluzione chiara ai difetti di funzionamento alle anomalie del sistema,
perché, questo è oramai chiaro, il sistema si reggeva su sé stesso. Quando il
fondamento metafisico viene rimosso, è proprio questo che accade: la legge è il
fondamento di sé stessa, il diritto è all’origine di sé stesso, l’esperienza umana le cose
del mondo i fatti le azioni le volizioni non sono che un meccanico accadere slegato
dall’essere38. In una parola, assoluto. E allora si può senza tema affermare e
concludere che «tutta la vita dell’esperienza giuridica non è altro che una continua
crisi, una continua imperfezione un continuo non perfezionarsi nel senso di un
continuo non riuscire né all’adeguazione del mondo del diritto con tutte le forme
dell’esperienza né per conseguenza alla piena adeguazione della spinta originaria
dell’azione e dell’oggetto connaturale della volontà»39. Infatti la spinta primordiale
dell’azione, lo «stato di natura dell’azione»40 finisce sempre per incagliarsi nella
morsa fatale del volere che vuole per sé stesso, volere oppresso dal volere. L’azione
che era sorella del sogno e che nella sua vanità neonatale immaginava sé stessa come
assoluta viene inghiottita dall’incubo dell’irrealizzabilità dell’impossibilità di portare
a termine i propri progetti, di rendere effettivi i suoi propri obiettivi, abbandonati
nell’indifferenza e nella diffidenza del reale che circonda l’azione ed il suo soggetto.
È in questo preciso istante che si sperimenta che si svolge la crisi
dell’esperienza perché crisi dell’esperienza è crisi di “adeguazione” di adaequatio e
infine com’è evidente di rappresentazione. L’esperienza non si può rappresentare
perché non vi è consonanza (adeguazione, adaequatio) tra me che osservo e gli
oggetti che osservo, perché soggetto ed oggetto non sono inseriti in un unico senso
dell’essere in un’unica vita, ma riflettono le loro rispettive ansie di protagonismo nei
frantumi sparpagliati di uno specchio rotto. La crisi dell’esperienza giuridica, è
36
G. CAPOGRASSI, Incompiutezza dell’esperienza giuridica, cit., p. 856.
G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, cit., p. 63.
38
G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, cit., p. 509.
39
G. CAPOGRASSI, Incompiutezza dell’esperienza giuridica, cit., p. 855.
40
G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, cit., p. 64.
37
89
anzitutto crisi dell’esperienza umana, e quindi crisi della metafisica in quanto crisi
dell’ente che più non può e più non riesce a riferire la pluralità ed il divenire delle
esperienze dei fatti ad un principio in grado di ritenerli tutti: l’essere. Infatti l’ente
non ha più rapporti con l’essere dacché è stato rimosso e quindi dimenticato
trascurato dalla ragione, che ne ha decretato l’intangibilità e quindi l’insussistenza —
come se la rimozione fosse stata un espediente che la psicanalisi freudiana
spiegherebbe traverso il meccanismo dell’allontanamento di pensieri spiacevoli41. Di
qui l’insormontabile fatica di cui è testimone l’uomo di oggi che non è in grado di
relazionare le sue esperienze a quelle dei suoi simili (né di rappresentarle a sé stesso
ed agli altri), e non è altresì in grado di ricollegare sé stesso alla società e questa
società di cui è parte e fondamento, allo Stato o forse all’idea di Stato — e non
diciamo all’idea di diritto o di giustizia perché allora la fatica si tramuterebbe
addirittura in tormento, angoscia, desolazione, «vertiginosa solitudine»42. Si può così
affermare che «l’individuo non è più all’altezza, non è più al livello della sua concreta
esperienza sociale e storica; o, se si vuole, l’esperienza non è più ad altezza di uomo,
supera infinitamente l’individuo», tanto da far concludere che «l’individuo non è più
in grado di partecipare come soggetto del lavoro sociale all’esperienza, ma è soltanto
una forza, un cavallo a vapore al servizio dell’esperienza»43. Tale valutazione era
effettivamente già stata annunziata da Walter Benjamin che negli anni Trenta del
Ventesimo secolo aveva proclamato con un’efficace metafora proprio il crollo delle
quotazioni dell’esperienza in un breve ma intenso passaggio che si riporta per intero:
«le quotazioni dell’esperienza sono crollate. E sembrerebbe che si tratti di una
discesa senza fondo. Ogni sguardo al giornale ci rivela che essa è caduta ancora più in
basso, che, da un giorno all’altro, non solo l’immagine del mondo esterno, ma anche
quella del mondo morale ha subito trasformazioni che non avremmo mai ritenuto
possibili. Con la guerra mondiale cominciò a manifestarsi un processo che da allora
non si è più arrestato. Non si era notato, che, dopo la fine della guerra la gente
tornava dal fronte ammutolita, non più ricca ma più povera di esperienza
comunicabile? Ciò che poi, dieci anni dopo, si sarebbe riversato nella fiumana dei
libri di guerra, era stato tutto fuorché esperienza passata di bocca in bocca. E ciò non
41
E in un certo senso, come si vedrà tra poche righe, la rimozione è stata proprio un espediente che la
ragione ha utilizzato pur di non formulare un vero e proprio pensiero sull’essere, con ciò velandolo,
nascondendolo: la ragione moderna il pensiero moderno hanno nascosto l’essere, ne hanno velato il
senso pur di non doverlo spiegare. Compito della filosofia, analogamente al lavoro che la psicanalisi
svolge o vorrebbe svolgere sull’inconscio individuale, è di rimuovere le resistenze della ragione al fine
di far emergere proprio quel senso dell’essere che era stato allontanato nascosto e quindi dimenticato;
la filosofia del diritto in particolare ha proprio oggi questa fondamentale preoccupazione di far
emergere il senso dell’essere all’interno del discorso sullo Stato sulla società sull’uomo.
Michelstaedter, nel paragrafo de “La persuasione e la rettorica” intitolato “Un esempio storico”,
ricollega tale dimenticanza addirittura a Platone che ha spostato la questione dell’essere dalla terra al
cielo delle idee, rendendo quindi l’essere del tutto invisibile allo sguardo: cfr. C. MICHELSTAEDTER, La
persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., pp. 66 ss. e 143 ss. con le note giustificative.
42
Di una “vertiginosa solitudine” degli uomini (in particolare dei discepoli di Platone) parla proprio
Carlo Michelstaedter quando si riferisce alla contemplazione dell’alto mondo delle idee: C.
MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 71.
43
G. CAPOGRASSI, L’ambiguità del diritto contemporaneo, cit., p. 91.
90
stupisce. Poiché mai esperienze furono più radicalmente smentite di quelle strategiche
dalla guerra di posizione, di quelle economiche dall’inflazione, di quelle fisiche dalle
battaglie caratterizzate da grande dispiego di mezzi e materiali, di quelle morali dai
detentori del potere. Una generazione che era ancora andata a scuola col tram a
cavalli, si trovava, sotto il cielo aperto, in un paesaggio in cui nulla era rimasto
immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo di forze attraversato da
micidiali correnti ed esplosioni, il minuto e fragile corpo dell’uomo»44.
Giorgio Agamben, nel prendere le mosse da questa tragica considerazione
benjaminiania, ha chiarito che «in un certo senso, l’espropriazione dell’esperienza era
implicita nel progetto fondamentale della scienza moderna»: solamente un modello di
ragione come quella elaborata e forgiata dal pensiero moderno poteva condurre ad
una tale distruzione dell’esperienza, tanto più che «contrariamente a quanto si è
spesso ripetuto, la scienza moderna nasce da una diffidenza senza precedenti nei
confronti dell’esperienza com’era tradizionalmente intesa»45. Diffidenza che certo
deriva da una forma del conoscere com’è quella cartesiana, che pur rendendo
l’esperienza soggetta-al-soggetto, e proprio perché ha subordinato le possibilità di
esperienza al soggetto che pone al sicuro il reale presso la sua stessa soggettività, ha
rimosso, si potrebbe dire, il sum (il senso ultimo del sum) dal quale quell’uomo
quell’individuo e quindi quella conoscenza quella esperienza tradizionalmente
dipendeva, quel sum che non è nient’altro se non il senso dell’essere.
La rimozione cartesiana ha quindi un effetto rovinoso non solamente nei
confronti del valore da attribuire alla conoscenza (ed alla percezione) del reale ma
anche nei confronti di quel soggetto che proprio nel suo novello statuto recava iscritto
il ruolo il compito di attribuire un valore alla realtà46 — con ciò provocando un non
secondario effetto nocivo anche alla narrazione del reale, come spiega Benjamin,
perché la crisi dell’esperienza, e della percezione dell’esperienza, porta con sé come
fosse un effetto, anche la crisi delle parole con cui descrivere quell’esperienza. È
questa la rivelazione che ci induce ad indagare più approfonditamente la
trasfigurazione che ha subito nel tempo l’immanenza di essere e pensiero: se il
linguaggio è la casa dell’essere47, ed il senso dell’essere è dimenticato, abbandonato e
trascurato, anche quel linguaggio che gli offriva con un’immagine vitto ed alloggio è
per forza di cose abbandonato trascurato ed omesso. E di questa omissione occorre
44
W. BENJAMIN, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nikolaj Leskov (1936), trad. it., Torino 2011,
pp. 3-4.
45
G. AGAMBEN, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Nuova edizione
accresciuta, Torino 2001, p. 10.
46
La domanda che evidentemente e legittimamente si può porre è questa: il nuovo ruolo di attribuire
valore alla realtà, ne tenta l’essenza? L’uomo moderno, l’uomo pensato dal pensiero moderno è altresì
il protagonista di un’operazione primordiale colla quale rinominare le essenze, in ciò riformulando la
«costruzione concettuale e archetipica dell’universo»? (in questo senso sono assolutamente
fondamentali le riflessioni di D. COCCOPALMERIO, Laudatio di Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca
Ecumenico, in “Iustitia”, 4/2008, pp. 506 ss.)
47
M. HEIDEGGER, Lettera sull’«umanismo» (1946), trad. it., Milano 1995, p. 31.
91
tener conto perché incide profondamente proprio sulla spiegazione — per questo
goffa inelegante e dura nell’espressione48.
3. Krino 2: ontologia della critica
Quando si è fatto riferimento alla intangibilità ed alla insussistenza dell’essere
secondo la ragione moderna che per questo motivo ha prediletto la conoscenza
dell’ente-presente-allo-sguardo rispetto alla meditazione sull’essere si è inteso
alludere a quella dimenticanza del senso dell’essere che è stata mirabilmente descritta
da Martin Heidegger come “velamento-salvamento” (Ver-bergung), «un mettere in
salvo che preserva qualcosa di non ancora svelato»49. Quel velamento-salvamento si
vuol cercare di spiegare ricorrendo all’analisi michelstaedteriana del rapporto esserepensiero. In questa prospettiva sembrerebbe quasi che la questione dell’essere sia
stata (diligentemente o furbescamente) sotterrata in una scatola per nasconderla ed
allo stesso tempo però per salvarla dalle nefaste incursioni del tempo.
Al fine di formulare in modo più compiuto la sua personale filosofia della
storia, Carlo Michelstaedter prova a riscrivere la storia della filosofia secondo una
prospettiva anti-platonica e allo stesso tempo socratica, come se Platone avesse
violentemente tradito l’insegnamento socratico. Come se Platone avesse tradito
l’ideale socratico della realtà delle cose della vita vissuta, a favore di generose ed
edificanti astrazioni sulla realtà stessa. Platone, in questa rivisitazione, «fuori della
corrente della vita vissuta […] non sente più l’irragionevole, il doloroso di quel fluire
[…] ma contempla come l’acqua nella necessità del suo fluire sempre gli stessi vortici
forma e riforma negli stessi punti, e sugli stessi scogli, con le stesse onde, la stessa
spuma, gli stessi zampilli, gli stessi giuochi di luce si rompe, e più oltre con lo
specchio tranquillo l’immobilità del cielo e delle sponde riflette. Sempre nuova acqua
— sempre le stesse forme: la stabilità dell’instabile»50. Ma, al di là dell’astrazione
convenzionale, dei nomi convenzionali51, cosa rimane della corrente vorticosa della
vita vissuta della concretezza dell’esistenza? Come spiegare l’instabilità della
corrente che appare invece così forte e sicura da co-invorticare chiunque vi si
immerga? Infatti «il fiume, quando è grosso, non trascina soltanto verso il basso
cosicché uno che si tenga presso alla sponda sia sicuro di potervisi attaccare. Ma coinvortica irresistibilmente verso il mezzo per poco che uno vi si sia avanzato» 52. In
questo senso la dottrina platonica delle idee pare a Michelstaedter un deterrente per il
mal dell’anima, una soluzione alle mancanze ed alle deficienze che sempre la vita
suscita, la vera vita, la vita vissuta, quella vita dell’uomo delle cose che non conosce
luogo stabile o stabilità perché è tutta un continuo fluire, cosicché la vera difficoltà
48
Si esprime in questi termini M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p. 55.
M. HEIDEGGER, La questione dell’essere (1955), trad. it., ora in M. HEIDEGGER, Segnavia, cit., p. 364.
50
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 155 (corsivo
dell’Autore).
51
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 59 e p. 165.
52
C. MICHELSTAEDTER, Parmenide ed Eraclito. Empedocle. Appunti di filosofia (1909), Milano 2003, p.
47; cfr. anche C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 59.
49
92
risiede nell’individuazione di un “loco più stabile”; «ma questo loco più stabile non
v’è né alcuno può additarlo al suo compagno, dicendogli “siediti, là sarai felice,
libero, potente, là conoscerai il bene”. Questo “loco” è il qualunque punto dove uno è
purché vi permanga. Esso è stabile — poiché il resto fluisce nell’eterna deficienza» 53.
Tutta la vita è deficienza che non si può colmare; tutta la vita è eterna deficienza in
quanto tendenza all’altitudine, urgenza di astrazione e quindi urgenza d’irrealtà: è
proprio il succo dell’insegnamento platonico, quell’insegnamento che ha indicato nel
bisogno di ulteriorità il destino dell’uomo — mentre invece l’ideale della vita
persuasa secondo il goriziano è quello dell’essere-uno, dell’«aver tutto in sé»54. Il
mito dell’assoluta sufficienza dell’essere-uno contro la triste necessità di essere-inrelazione ad un ulteriore, l’uno che è e che ha tutto in sé, che vive il passato il
presente ed il futuro in un unico tempo che è il tempo dell’essere (che non è
determinabile attraverso il tempo) e che non ha cose oggetti da volere perché è ed ha
tutto — e quindi non può tendere a nulla — trova nella vita stessa un’insormontabile
difficoltà, che si riflette proprio nel vivere. La vita, come il fiume, co-invortica e
rende quindi di difficile o addirittura impossibile ricomposizione il dilemma posto
dall’eterno apparire delle cose, della differenza tra l’eterno flusso diveniente e la
stabilità dell’essere. Si tratta, come ben si comprende, non soltanto di un problema
ontologico, ma altresì di un problema sociale, afferente la vita dell’individuo.
L’individuo della rettorica, l’individuo che non ha (e che non è) tutto in sé sperimenta
l’inquietudine della relazione o meglio della necessità della relazione all’ulteriore, la
solitudine che emerge dalla deficienza dalla dolorosa mancanza di un al-di-là: «so che
voglio e non ho cosa io voglia»55. So che voglio perché sento la mancanza di qualcosa
che non riesco ad ottenere, ma allo stesso tempo non riesco ad ottenere quello che
voglio perché è in fondo l’ulteriore quello che voglio e non riesco a raggiungere,
perché ogni ulteriorità rimanda alla successiva in una straziante eppur reale vicenda
per la quale nulla è in grado di soddisfare la deficienza della vita umana.
Ciò che voglio è la stabilità, ma l’unica stabilità che riesco a raggiungere,
nell’instabile e costante farsi della vita, è la stessa smania di stabilità, il volere fine a
sé stesso: avrei bisogno di una tensione originaria una tensione in grado di condurre
al cuore, al senso dell’essere, eppure questa strada mi è inibita.
L’intuizione platonica dell’iperuranio, del mondo delle idee, infatti, slega
definitivamente l’essere dall’ente, nel senso che relega l’infinita stabilità dell’essere
ad un mondo diverso da quello umano, distaccato dall’uomo che non può più fare
esperienza dell’immutabile e che è costretto a vivere nell’umido e gretto antro di una
caverna fatta di percezioni e di ombre, in una parola di instabilità: «Platone ha creato
ora un mondo dove rivivono tutte le relazioni delle cose con le quali nella sua vita
mortale egli viene in contatto. E in questo mondo è nella sua lontana luminosa
immobile solitudine compreso tutto nell’idea del sommo bene, l’uno, sostanziale,
assoluto»56.
53
C. MICHELSTAEDTER, La melodia del giovane divino, cit., pp. 103-4.
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 164.
55
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 7.
56
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 174.
54
93
Assoluto in quanto distaccato.
L’immutabile distaccato dalla mutabilità.
L’uno non è più uno, indeterminato indeterminabile, ma piuttosto un’astrazione
del molteplice, una sommatoria, una sostanza immutabile che si riferisce ad una
forma tendente irresistibilmente a mutare, a non-essere.
L’essere convive apertamente con il non-essere: l’uno in cielo (oltre i cieli per
essere precisi) l’altro in terra. E l’uomo che si trova in mezzo a questa tremenda
burrascosa contraddizione non vive che nell’instabilità del non-essere senza poter
tendere all’assoluto essere dell’idea. Ecco quindi la solitudine e l’inquietudine del
vivere.
È così che Platone non solo tradisce Socrate e Parmenide, ma consegna la storia
della filosofia ad un’umanità che lui stesso ha declassato, riducendo l’individuo ad un
misero funzionario del non-essere, ad un ingegnere dell’instabile. Parmenide infatti
aveva intuito l’immanenza di essere e pensiero: «una cosa è il pensiero e la cosa c’hio
penso; non v’è pensiero astratto dalle cose. Una cosa è il mio vivere e il mondo ch’io
vivo. Se il mio vivere è un sapere assoluto, cioè fuori dall’attualità delle relazioni
delle mutazioni, il mondo ch’io vivo ed io stesso siamo in un punto assoluti,
immutevoli»57, persuasi, mentre Socrate aveva avvicinato tale persuasione tale
immediatezza dell’assoluto attraverso la sua elementare domanda la sua basilare
ricerca fondata sul sapere di non sapere e quindi la tendenza (in quanto tensione)
all’immedesimazione con l’assoluto con l’essere, «e all’uomo distratto nelle relazioni
aveva negato il sapere, in ciò che sapere sia dell’uomo sapiente — e l’uomo sapiente
da ogni relatività assoluto»58.
Platone, invece, «con la sua sapienza di nomi astratti, che ognuno può
conquistarsi, si trova ad avere un mondo del pensiero e un mondo delle cose; e poiché
la cosa di cui il pensiero è pensiero deve essere sostanziale, ché altrimenti il pensiero
non è pensiero, egli si trova ad avere due sostanze che l’una è per l’altra, è conforme
all’altra, è lo specchio dell’altra»59. Un mondo continuo nella sua unità e totalità ed
uno determinato dai mutamenti, in una parola dalla molteplicità. E allora il pensiero
non è solo pensiero dell’essere, ma anche pensiero dell’ente, cioè del non-essere,
pensiero dell’instabile. Attraverso questi passaggi Michelstaedter perviene ad una
riscrittura della storia della filosofia come storia del pensiero tradito e umiliato, del
pensiero che dimenticando la sua stessa immanenza con l’essere trascura il suo
fondamento. Lungo la direttrice storica che porta da Platone alla filosofia moderna
(un’unica direttrice, un unico binario60) ciò che resta costante è l’interesse esclusivo
del pensiero per l’esser-presente della cosa, trascurando con ciò completamente il
fondamento di quella mera presenza e che a conti fatti è ciò-che-sta-davanti, o
meglio, ciò che viene rappresentato come tale61; in questi termini si può affermare che
57
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., pp. 174-5.
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 175.
59
Ibidem.
60
M. HEIDEGGER, Che cosa significa pensare?, cit., pp. 110 ss.
61
M. HEIDEGGER, Che cosa significa pensare?, cit., pp. 208 ss.
58
94
nell’intendimento della filosofia occidentale post-platonica, il pensiero diviene62: nel
cartesiano cogito ergo sum, all’apice del suo frastagliato ma organico percorso
storico, il cogito corrisponde ad un non-sapere, ed anzi addirittura ad un confuso e
disorganico agitare concetti, sino alla drammatica constatazione per cui «cogito=non
entia coagito, ergo non sum»63. In conclusione e per estensione, l’idea platonica
postulando il non-essere terrestre, aveva condotto all’immanenza di pensiero e nonessere, e quindi, «implicito il non essere nel mio dire, io posso ormai fingere la
sostanzialità alla qualunque cosa ch’io dica»64.
Si può sostenere pertanto che l’avvilupparsi di pensiero e realtà giunga nel suo
intricato avvolgersi sino ad un punto ad un limite ad un confine estremo65. O il
pensiero, come la colomba di Kant (ed altresì come il mechanema di Platone ne La
persuasione e la rettorica66) tralascia il reale per volare più in alto, all’insegna di una
ricerca di ulteriorità, e per una insaziabile urgenza di irrealtà che potrebbe
corrispondere a certo pensiero utopistico — che nega la realtà del qui ed ora e che
tende per questo all’irrealtà dell’artificio attraverso il pensiero del non-ancora che è
pensiero del non-essere; oppure, conscio dei suoi limiti ed altresì delle potenzialità
del reale, il pensiero medesimo decide di compenetrarlo, il reale, la cosa, la res, per
ottenere da questa ri-unione più saldi benefici, al fine di ribadire che l’unico
fondamento di tutte le cose è immutabile, unico, originario: l’essere. Quel confine,
quel limite, che è un confine ed un limite del pensare, potrebbe corrispondere proprio
alla linea tombale del pensiero stesso: «en suma, que de ser la gran solución, la
inteligencia se nos ha convertido en el gran problema»67.
4. “A ogni momento si forma il mondo umano”: l’individuo, la sua vita
L’individuo vive per la libertà o meglio vive di quella libertà che caratterizza lo
spontaneo destreggiarsi dell’esperienza umana. Le parole d’ordine i motti della
filosofia capograssiana sono proprio «ogni momento è l’aurora dell’azione», «a ogni
momento si forma il mondo umano», ed allo stesso tempo, ogni momento della vita è
contrassegnato dalla volontà di scoprire e di costruire l’azione, quell’azione che unita
alla relazione all’emozione alla necessità sono il perenne cominciamento
dell’esperienza e quindi della realtà: «ogni momento l’individuo è nello stato di
natura, per così dire, della sua libera vocazione, del profondo incanto dei grandi
interessi e delle idee che danno valore alla vita»68.
L’uomo conosce e vorrebbe conoscere nel senso di possedere ciò che viene
conosciuto, infinitamente, e come la colomba kantiana, vorrebbe estendere a tal punto
62
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 61.
Ibidem.
64
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 183.
65
Ci si può legittimamente domandare se questo confine corrisponda alla Linie di Heidegger e Junger:
E. JÜNGER-M. HEIDEGGER, Oltre la linea (1949-1955), trad. it., Milano 19985.
66
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., pp. 66 ss.
67
J. ORTEGA Y GASSET, Historia como sistema y otros ensayos de filosofia (1935-41), Madrid 2003, p.
73.
68
G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, cit., p. 68.
63
95
le possibilità di conoscenza, sino ad ignorare i motivi che lo rendono umano (e che
rendono umano il suo stesso conoscere), senza rendersi conto che proprio quei motivi
ne determinano la vita.
Vita finita, certo, ma non per questo meno meritevole di essere vissuta, dacchè
ogni singola vita è un punto unico irripetibile del creato.
L’uomo ha questo limite, l’uomo è questo limite.
L’arena dei fitti rapporti nei quali s’immerge lo consolida nell’impressione
ch’egli stesso già possiede della sua propria umanità, ed anzi lo rafforza perché nel
gruppo egli sente l’unità. Unità dei rapporti unità dell’umanità unità dello spirito.
Unità nel contrasto e nell’unione.
L’uomo e la società sono, dapprincipio, unità, e per di più unità perfetta69, unità
non bisognosa d’altro che di sé stessa in virtù del suo «aver tutto in sé»70, come
l’uomo persuaso di Michelstaedter. Al principio dell’azione umana, in quell’aurora in
cui l’azione è sorella del sogno, non c’è che unità: a partire dall’unità dell’esperienza,
si direbbe con Gustavo Bontadini, perché l’uomo sperimenta l’unità di sé stesso con
le cose e con gli altri, nella presenza del mondo sensibile, nell’esser presente che
caratterizza ogni ente in quanto res, in quanto reale71. Una presenza che differisce in
modo così sostanziale dalla rappresentazione della presenza che caratterizza il cogito
moderno: l’una è unità del mondo dell’uomo delle cose, l’altra è molteplicità pluralità
ed infine dissociazione di elementi irrelati.
Nell’unità dell’esperienza, nell’unità degli elementi si forma il mondo umano
della vita, che non è nient’altro che il mondo degli uomini il mondo storico quale ci si
presenta allo sguardo, la quotidianità della relazione umana: un evento si direbbe
(perché la vita è un evento!) che non ha bisogno di alcun tipo di rappresentazione per
esistere perché la sua stessa sussistenza fa intrinsecamente parte della vita umana e
della sua connaturata libertà nel senso di naturalezza e di immediatezza. È proprio e
connaturato all’esser uomo il vivere insieme agli altri uomini sperimentando ad ogni
momento la naturalezza della vita.
Quel mondo umano della vita quell’istinto naturale alla vita ed alla relazione è
messo seriamente in discussione da un’idea da un concetto che in tutti i campi ha
messo in evidenza l’insussistenza dell’individualità e della spontaneità come
principio ordinatore della vita e quindi dell’associazione umana. Il pensiero moderno
è proprio quell’idea e quel concetto che ha negato il presupposto per cui
l’individualità in quanto immediatezza e naturalezza costituisce il principio della vita,
e quindi ha per ciò stesso negato l’uomo. Per il pensiero moderno ogni individuo è
l’esatto contrario della spontaneità, ogni uomo è una parabola crescente che prospera
e si sviluppa proporzionalmente all’estrinsecarsi dell’insoddisfazione per il reale, e
quindi ogni molteplicità di individui è portata di per sé a tendere all’espansione oltre
sé stessa ed oltre il reale, sino al superamento dei limiti imposti dal pensiero. Semper
plus ultra. Quell’uomo irrequieto e anonimo, quel dato statistico, diventa per lo Stato
69
G. CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, cit., p. 71.
C. MICHELSTAEDTER, La persuasione e la rettorica. Appendici critiche, cit., p. 164.
71
G. BONTADINI, La funzione metodologica dell’unità dell’esperienza (19462), ora in G. BONTADINI,
Conversazioni di metafisica, I, Milano 1971, p. 36.
70
96
e prima ancora per gli altri uomini, mera disponibilità, «un astratto paradigma di
forze, un’astratta capacità di obbedienza, una forza puramente passiva», «forza
puramente passiva di adesione emozionale»72.
L’individuo è disponibile, ed è, passivamente, ciò che viene deciso che sia.
La coscienza è mortificata, avvilita, de-individualizzata, resa inoffensiva ed
infine, offesa.
Di qui, si direbbe con il Rosmini tanto caro a Capograssi, il tema del
risentimento giuridico: risentimento per la coscienza offesa per la persona tradita per
la vita oltraggiata.
Rosmini di ciò parlando proprio esattamente sosteneva essere il diritto un
complesso che «nasce da quel dovere morale che c’impone di non far male a
persona»73; con il che riconosceva la spontaneità di quel sentimento del diritto, un
impulso universale che nasce da un dovere morale così elementare così primario da
risultare uno tra i sentimenti più diffusi come sono l’amicizia l’amore il fastidio la
diffidenza l’antipatia. Con una parola immediata e di pronta cognizione: un bisogno.
Un sentimento che quando viene violato — quando cioè quel dovere morale non
viene sentito adeguatamente — ingenera risentimento, quel «risentimento che l’uomo
dimostra quand’egli è persuaso che si offendono i suoi diritti»74, che in particolare «vi
ha solo allora che altri soffre perché gli è impedita la libertà»75, perché la libertà è così
naturalmente intrinseca all’uomo alla sua umanità da risultare elemento ad essa
coessenziale.
Libertà in quanto vita.
La teoria del risentimento giuridico di cui si parla, per come è stata posta e
proposta in effetti «ha il merito di richiamare l’attenzione sul primo momento in cui il
diritto si forma, che è il momento in cui l’individualità si sente offesa in
quell’espandersi che è la sua vita, il suo personale compiersi storicamente,
nell’esistenza, con l’esistenza»76. Tutto ciò non sarebbe possibile se non laddove «il
diritto è visto quale sviluppo dell’individuo che progredisce nella sua personalità, non
quale elemento statico, quasi ricevuto passivamente dagli individui come tali»77, in
un’idea in un’intuizione del “diritto come attività” cioè del diritto riportato al livello
dell’individuo e della sua azione, in una linea immaginaria che unisce Vico a
Romagnosi a Ferrari a Capograssi. Un’idea per cui il diritto è farsi, sforzo costante o
almeno sforzo reale col quale l’uomo fa la sua propria vita la sua propria umanità, nel
senso che la scopre in sé stesso e negli altri con cui instaura la relazione, che sono
uguali a lui in questo fare in questo preciso eppur paradossalmente indefinito fare
l’uomo. Fare l’uomo in quanto farsi del diritto in quanto il diritto è un fatto
72
G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, cit., p. 483.
A. ROSMINI-SERBATI, Filosofia del diritto, I, Milano 1841, p. 370.
74
A. ROSMINI-SERBATI, Filosofia del diritto, cit., p. 371.
75
Ibidem.
76
P. PIOVANI, Linee di una filosofia del diritto (1964), ora in P. PIOVANI, Per una filosofia della morale,
Milano 2010, pp. 553-4.
77
P. PIOVANI, Linee di una filosofia del diritto, cit., p. 553.
73
97
dell’uomo, nel senso dell’attività di realizzazione della persona e nel senso di
resistenza, con Vico, ai torti subiti.
Il diritto come realizzazione e come opposizione.
Vico spiega: «è proprietà dei forti gli acquisti fatti con virtù non rillasciare per
infingardaggine, ma, o per necessità o per utilità rimetterne a poco a poco e quanto
meno essi possono»78; il diritto, cioè il sentimento del diritto, nasce dapprima come
realizzazione del proprium dell’uomo, e poi come difesa come attività volta alla
difesa della stessa persona — da ciò il risentimento per le violazioni e quindi la forza
resistente dimostrata attraverso il risentimento. È proprio per questo motivo, ribadisce
Pietro Piovani, che «il diritto è l’attività volta alla creazione di mezzi idonei ad
impedire attentati all’espansione dell’individualità che si compie nel mondo
storico»79.
Il diritto è difesa: difesa dell’uomo dell’umanità della necessità ad essa
intrinseca di provare a farsi e quindi a diventare sé stessa secondo l’antico oracolo
che a Delfi pronunciava “diventa ciò che sei”. Di qui l’idea che il diritto (inteso in
quanto attività) è di per sé stesso ostacolo freno katechon da opporre alle invasioni
barbariche colle quali il medesimo diritto, nella sua degenerazione totalitaria avrebbe
negato nella storia più recente (ed anche attualmente nel nostro presente vivere la
cronaca) o addirittura travalicato violentato ed offesa l’umanità80. Il diritto in questo
senso è difesa dalla barbarie, dispositivo antibarbarico. Il diritto è un mettere-in-salvo
che nella sua struttura somiglia proprio al velamento-salvamento di cui ha parlato
Heidegger a proposito della dimenticanza del senso dell’essere. Ciò che è stato
dimenticato, e quindi sotterrato — ma proprio per questo salvato — è stato proprio il
concetto di persona.
Quando il diritto perde o disperde la sua ragion d’essere, e cioè il suo essere
ostacolo, difesa, quando il diritto dimentica il suo statuto che coincide in assoluto con
la messa in salvo della persona, allora l’uomo diviene quella forza disponibile a
qualsiasi utilizzo a qualsiasi scopo da parte della struttura da parte dello scopo
esogeno e per finire, da parte delle istituzioni.
Ed ecco, quindi, in tutta la sua forza, la crisi.
Crisi dell’uomo dello Stato del diritto. Crisi del pensiero.
Crisi come dimenticanza e come velamento, nascondimento.
Crisi che dev’essere studiata interpretata e quindi valutata (krino): ecco
l’elemento della critica, del giudizio della distinzione. La critica costruisce, ed anche
la crisi, quindi, può corrispondere ad un momento di costruzione, di edificazione,
ecco il lascito capograssiano. Nella crisi si rinnova la forza dell’uomo, l’ostinazione
dell’essere umano che sente pulsare nel cuore il desiderio di rinnovamento di
cambiamento, di critica. Nella critica, e quindi nel giudizio sullo stato di crisi si
rinnova la fede nel diritto che è fede nell’uomo.
78
G. VICO, La scienza nuova (1725), § LXXXI.
P. PIOVANI, Linee di una filosofia del diritto, cit., p. 554.
80
Si è riferito al tema della barbarie, ad esempio J. ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas (1947),
Madrid 2003, p. 253.
79
98
Il diritto in quanto ostacolo infatti, mette in salvo l’uomo nel sentiero che
attraversa e travalica il luogo di crisi.
5. L’idea, l’utopia, l’umanità
Si potrebbe quasi pensare che, di contro alla diffusione ed esegesi crociana e
gentiliana della dottrina idealistica di inizio Novecento, Giuseppe Capograssi faccia
camminare sulle proprie gambe l’idea hegeliana (per un paradosso del marxismo ed
ironia della storia, questa concretizzazione avviene nella luce dei Vangeli), che si
trasforma o meglio si incarna nell’uomo comune, nella coscienza comune, nelle
decisioni della vita di ogni giorno, come se tutta la vita dell’idea hegeliana fosse un
eterno romanzo di Raymond Queneau ed ogni suo singolo istante esistenziale un
breve feulleiton della domenica. L’idea è quindi divenuta uomo, si è fatta uomo, si è
fatta carne nervi sangue muscoli: concreta e sussistente umanità; ed è l’uomo, o
meglio l’individuo ad immedesimarsi nella struttura razionale della vita e della storia,
che infatti da quella coscienza deriva.
Il farsi dell’uomo corrisponde al farsi dell’idea, ed è proprio, a conti fatti, il
farsi dell’idea, e quindi della storia e del mondo. Parallelamente, il fatto del pensiero
è la coscienza; la coscienza è un fatto insomma, e come tale dev’essere messa nella
giusta relazione con il diritto: perché la coscienza, così come l’azione che ne
discende, fa parte dell’esperienza allo stesso modo in cui i fatti costituiscono il diritto.
Lo Stato non è che un momento dell’esperienza giuridica complessiva,
quell’esperienza che ha gli stessi limiti che ha l’uomo, perché l’esperienza è una
funzione dell’uomo e della sua volontà. Quando quello Stato sommerge l’esperienza
e quindi l’uomo con la sua autorità, si verifica la condizione per la quale l’uomo
viene annientato, l’esperienza viene assimilata al comando statuale, la legge impera,
la coscienza perisce.
Ogni vita umana è un momento irripetibile della creazione, ed in quanto tale
non può essere assimilata a nessuna altra, né può vedersi ridotti i margini di
spontaneità che ne caratterizzano l’organizzazione si direbbe la struttura interiore. Se
non fosse che, per effetto del pensiero moderno e del suo tenace ed intrigante
magnetismo, l’uomo moderno e soprattutto l’uomo contemporaneo, seppur non
rinunci nell’animo (e quasi in segreto seguendo la lezione koselleckiana) alla sua
profonda sensibilità e spontaneità che è semplicemente umanità, si sente attratto dalle
sirene della futilità e della frivolezza, di una vita condotta con leggerezza e
disattenzione81. Da un lato, infatti, l’uomo contemporaneo sente di aver bisogno di
punti fermi (eguaglianza, amicizia, speranza, secondo Capograssi82), dall’altro,
«l’inclinazione verso la futilità (…) spinge l’individuo a disperdersi nella sensazione
immediata, a perdere il pensiero e il ricordo di sé stesso e del suo destino»83. Qual
miglior ambientazione per uno sfruttamento dell’incertezza individuale da parte delle
81
In tal senso si era già espresso magistralmente M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., pp. 205 ss.
G. CAPOGRASSI, Su alcuni bisogni dell’uomo contemporaneo (1955), ora in G. CAPOGRASSI, Opere, V,
Milano 1959.
83
G. CAPOGRASSI, Su alcuni bisogni dell’uomo contemporaneo, cit., p. 543.
82
99
istituzioni, che possono profittare così della situazione di debolezza per utilizzare
l’uomo come fosse mero e servile paradigma di disponibilità?
Ecco l’incrocio presso il quale Capograssi e Michelstaedter si tengono per
mano.
La critica strutturale del pensiero moderno, permette a Capograssi di
riconoscere il limite di ogni teoria morale, politica e giuridica che non tragga spunto
dall’esaltazione del proprium dell’essere umano. Michelstaedter avrebbe detto della
persuasione. E con ciò, lo studio del limite serve a dimostrare la naturale inclinazione
di quelle teorie verso la mortificazione, l’avvilimento, la de-individualizzazione, ed
infine l’offesa dell’uomo in carne ed ossa, quando la teoria morale diventa pratica di
governo, come fu nel corso della catastrofe totalitaria divenuta guerra. La guerra
stessa non è che il punto finale di un abbrivio, appunto iniziato dal pensiero moderno,
che ha negato sin dal principio l’umanità del mondo umano della storia.
Della parola utopia, con Michelstaedter e Capograssi abbiamo percepito il
“non”: il non-essere-un-luogo, ma anche il non-essere-ancora e il non-essere-più.
“Non” che indica il volere o non volere essere, ma anche il potere o non poter essere.
Il “non” come crisi, come negazione e quindi come mancanza come momento
cruciale dell’esperienza morale dell’uomo contemporaneo. Il “non” dell’Aufebhung
hegeliano, e che a dispetto della dialettica triadica, però, non sfocia mai in una sintesi,
è uno dei momenti del vivere — perché l’idea, come si è detto, è vita nella storia.
Volere o non volere.
Voler fare o non voler fare.
Non ci sono altre possibilità. Tertium non datur.
L’uomo contemporaneo porta a termine il procedimento che l’ha forgiato e
fissa la vita in un semplificato vivere/non vivere, fare/non fare. Tutta la complessità
del reale passa attraverso queste colonne d’Ercole (delle dicotomie). Le quali a loro
volta vivono un infinito regressus, perché la semplificazione dicotomica si
contrappone, dicotomicamente, alla complicazione pluriversale all’impazzimento del
mondo e delle cose, che, appunto, possono perdere ogni punto di riferimento, punti
dicotomici compresi.
Nello sterminato campo dei fini immediati e delle volizioni particolari non ci
sono punti di riferimento. Nemmeno le dicotomie. Ed anche questa sembra essere una
dicotomia.
Valgono le considerazioni svolte a proposito dell’irrappresentabilità o
inenarrabilità del reale in quanto cifra della catastrofe e della crisi dell’esperienza
attuale — che da una catastrofe deriva. Come accade in Gorgia da Leontini, il nonessere e quindi il reale, la res, se anche fosse e se anche fosse pensabile, non sarebbe
comunicabile. La realtà cui fa riferimento Benjamin a proposito della Prima Guerra
mondiale è una realtà che corrisponde veramente al non-essere nel senso più deteriore
(e ovviamente non metafisico).
Parrebbe quasi che Capograssi usa l’hegelismo per estinguerlo. Ed anzi,
probabilmente l’obiettivo della filosofia dell’esperienza capograssiana è più
ambizioso di quel che sembra a prima vista perché superare Hegel significa ripensare
la dialettica e quindi, in senso ampio, la struttura del pensiero. Significa mettere in
100
discussione la pervasività della coppia reale-razionale e riaffermare l’emblematicità
del rapporto essere-pensiero. E quindi tornare a Michelstaedter (e per il suo tramite a
Parmenide).
Ciò che rimane, al di là di Hegel, è proprio la tensione che si è vista nei
ragionamenti velocemente raggruppati nelle precedenti pagine; tensione per
un’analisi della crisi che si fa utopia perché è rivolta alle possibilità dell’uomo, alle
possibilità che l’uomo storico l’uomo della cronaca ha di salvare il suo mondo ed il
suo vivere. Ed è soltanto in questa appassionata difesa della vita che è appunto difesa
del vivere, che la filosofia del diritto si fa filosofia della vita e quindi inno alla vita, e
con la parola del Poeta, inno alla gioia. Solo così la filosofia dell’utopia diventa
filosofia del qui-ed-ora in quanto difesa del luogo della parola e in ultimo dell’essere.
101
102