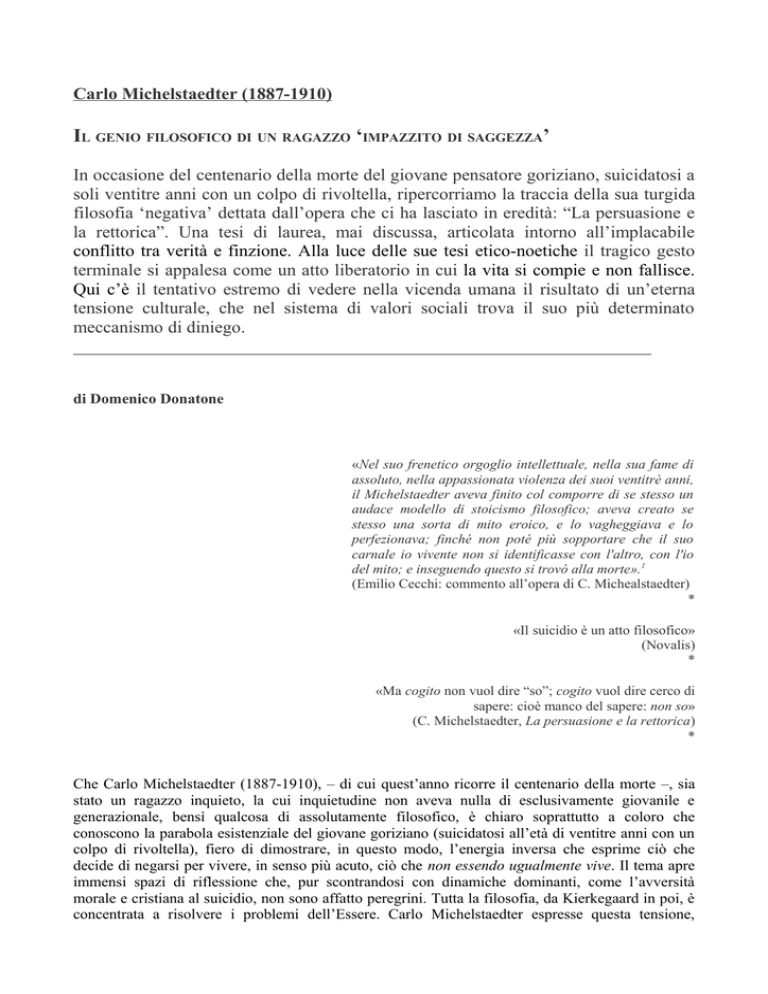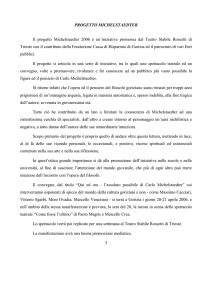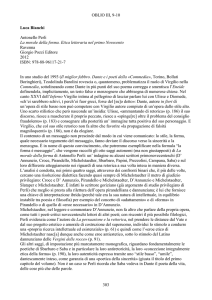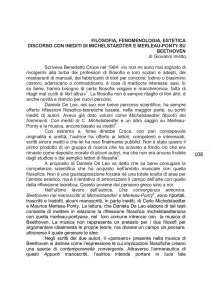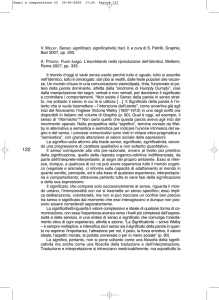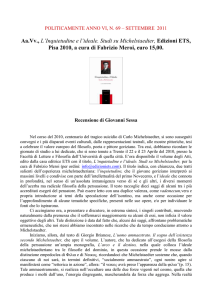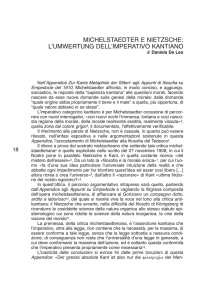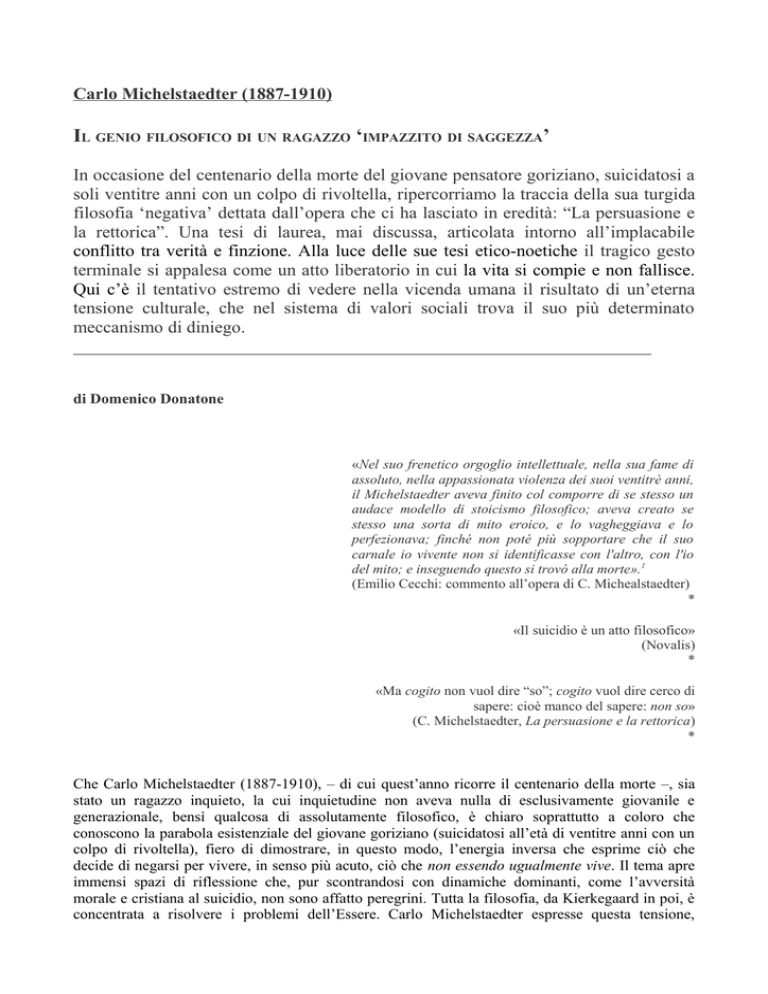
Carlo Michelstaedter (1887-1910)
IL GENIO FILOSOFICO DI UN RAGAZZO ‘IMPAZZITO DI SAGGEZZA’
In occasione del centenario della morte del giovane pensatore goriziano, suicidatosi a
soli ventitre anni con un colpo di rivoltella, ripercorriamo la traccia della sua turgida
filosofia ‘negativa’ dettata dall’opera che ci ha lasciato in eredità: “La persuasione e
la rettorica”. Una tesi di laurea, mai discussa, articolata intorno all’implacabile
conflitto tra verità e finzione. Alla luce delle sue tesi etico-noetiche il tragico gesto
terminale si appalesa come un atto liberatorio in cui la vita si compie e non fallisce.
Qui c’è il tentativo estremo di vedere nella vicenda umana il risultato di un’eterna
tensione culturale, che nel sistema di valori sociali trova il suo più determinato
meccanismo di diniego.
________________________________________________________________
di Domenico Donatone
«Nel suo frenetico orgoglio intellettuale, nella sua fame di
assoluto, nella appassionata violenza dei suoi ventitrè anni,
il Michelstaedter aveva finito col comporre di se stesso un
audace modello di stoicismo filosofico; aveva creato se
stesso una sorta di mito eroico, e lo vagheggiava e lo
perfezionava; finché non poté più sopportare che il suo
carnale io vivente non si identificasse con l'altro, con l'io
del mito; e inseguendo questo si trovò alla morte».1
(Emilio Cecchi: commento all’opera di C. Michealstaedter)
*
«Il suicidio è un atto filosofico»
(Novalis)
*
«Ma cogito non vuol dire “so”; cogito vuol dire cerco di
sapere: cioè manco del sapere: non so»
(C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica)
*
Che Carlo Michelstaedter (1887-1910), – di cui quest’anno ricorre il centenario della morte –, sia
stato un ragazzo inquieto, la cui inquietudine non aveva nulla di esclusivamente giovanile e
generazionale, bensì qualcosa di assolutamente filosofico, è chiaro soprattutto a coloro che
conoscono la parabola esistenziale del giovane goriziano (suicidatosi all’età di ventitre anni con un
colpo di rivoltella), fiero di dimostrare, in questo modo, l’energia inversa che esprime ciò che
decide di negarsi per vivere, in senso più acuto, ciò che non essendo ugualmente vive. Il tema apre
immensi spazi di riflessione che, pur scontrandosi con dinamiche dominanti, come l’avversità
morale e cristiana al suicidio, non sono affatto peregrini. Tutta la filosofia, da Kierkegaard in poi, è
concentrata a risolvere i problemi dell’Essere. Carlo Michelstaedter espresse questa tensione,
squisitamente primo-novecentesca, riferita al significato profondo dell’Essere, rendendosi fautore di
una «protosofia esiziale», una sorta di “pensiero primo della disfatta”, in cui la ricerca della verità,
non opinabile, stabilisce un sistema rigoroso d’indagine su quelli che sono i metodi che meglio
richiamano a sé le questioni fondanti la vita e, al contempo, la sana febbre di un malessere
esistenziale, vissuto stoicamente e alla maniera dei presocratici. L’obiettivo è decifrare il
meccanismo di persuasione e di retorica. La grandezza di Michelstaedter si sposa subito alla
smania di concludere l’esistenza (non per piacere o debolezza, ma per dovere morale), e per arrivare
presto al dunque egli assume dentro sé, mostrando i prodromi di una modernità antimoderna, la
strada nella quale l’essenza dello spirito dell’uomo, iconoclasta e stoico, non cessa la sua disputa.
Carlo Michelstaedter si confronta, giovanissimo, sui massimi sistemi della filosofia, adduce a sé
l’esempio dato dai presocratici e da Socrate, riprendendo le categorie platoniane e aristoteliche (nel
concetto di «persuasione» e di «retorica»); assorbe il pensiero di Leopardi e l’impianto della teoria
del piacere, il pessimismo cosmico come dato definitivo di manifestazione delle cose interne ed
esterne all’uomo, e guarda a Nietzsche in quanto filosofo della prassi moderna della conoscenza:
uomo dell’Anticristo, della Gaia scienza e del superuomo.
Diluita bene, la tesi di fondo del sapere per Michelstaedter rimane la consapevolezza che il mondo
reale condiziona il mondo interiore, il prevalere dell’«universo concreto», fatto di dolore e di cecità,
schiaccia lo spirito, comprime l’anima. Questo contrasto Michealstaedter lo sintetizza all’interno
della combutta dialettica estrema tra persuasione e retorica. Il lavoro, filosofico, ma principalmente
universitario, (perché non si deve mai dimenticare che Carlo Michelstaedter, nonostante la sua
levatura, rimane un ragazzo, un ventitreenne che improvvisamente impazzisce di saggezza), a cui si
attiene e s’impegna fino in fondo per esprime questo conflitto, è la sua tesi di laurea dal titolo
magnifico: La persuasione e la rettorica. Tesi scritta nel 1910 e mai discussa, che ha subito un
intenso lavoro di confronto con quanto la filosofia ha espresso in materia di Essere e Conoscenza.
Qualcosa che ha portato il laureando a ripensare, riscrivere e riaffermare la sua linea di fondo: il
conflitto inestinguibile tra verità e finzione, ovvero tra le cose sapute, reali, piene di sostanza
intrinseca, e la volontà di sopprimere questo sapere a favore dell’illusione. Un confronto che
conduce ad un ribaltamento del proprio fronte interno nella coscienza.
Le categorie di sintesi sono fondamentali in questo campo, non facile, di analisi: la persuasione
rappresenta l’accettazione radicale della finitudine umana, l’inevitabile esposizione dell’esistere alla
sofferenza, alla morte (la vera, cupa, triste verità); la retorica (anche se è detta “rettorica”, come a
quel tempo era corretto scrivere) rappresenta l’organizzazione complessiva dei valori apparenti e
artificiali (pace, giustizia, amore, carità). Ed è in base a questo secondo ordine di vita che l’uomo
stabilisce la sua esistenza, nel credo indefesso in valori la cui veridicità immancabilmente decade.
La rettorica è ciò che inquina la verità. Un sistema su cui si costruisce e si economizza il sapere
(ma in realtà è un sapere apparente, fittizio, che pretende di essere sempre ciò che non è).
Questo ragionamento se adattato ai nostri giorni, alla nostra era post 11 Settembre, ci si rende conto
che è semplicemente trasversale ad ogni epoca, e che il punto della situazione è ontologico e
insieme antropologico, perché ciò che degrada la vita è la sua costante superbia, la sua sicumera,
l’inversa proporzionalità tra vita e pensiero, tra fede e ateismo, tra ignoranza e sapere. Tanta più vita
è lontana, tanto vicino è il pensiero; tanta fede c’è in giro, tanto più vero è l’ateismo che si promana;
tanto più peso ha l’ignoranza, tanto meno è il ruolo di svolta da conferire al sapere. Tanto più
pacifismo si professa, tante più guerre e violenze accadono. Sulla proporzione inversa dei valori che
regolamentano la società, Michelstaedter intuisce il promuoversi costante di filosofie mendaci e
speranze deleterie. A fronte di quello che spesso accade, la vita è un’entità mobile a cui non si sa
porre rimedio, constatando così che il risarcimento è d’obbligo. Attraverso la ricompensa ogni
esistenza tenta di rimpadronirsi di sé, di ciò che le è mancato. Non è un sistema superficiale a cui si
tende, bensì il sistema principale di rappresentazione dell’umanità, di noi stessi. Fragili, lontani. In
tutto ciò c’è il rifiuto di ogni sistema di dominio, quindi di «retorica», perché Michelstaedter accetta
la natura dell’uomo, ma non pretende di redimerla con sistemi ideologici o filosofici di genere,
bensì ritiene che quello che sia lo slancio vitalistico debba conservarsi anche in accezioni che, a
torto, vengono recepite come non assimilabili al flusso della coscienza. La sua persuasione consiste
nel «salto», nel superamento di tutti i dati illusori a cui l’uomo si aggrappa, coltivando orizzonti
metafisici e intellettualistici, del sapere tradizionale, per scoprire che la verità sta nel porsi con
totale spirito riformista. È obiettivo preciso di Michelstaedter plasmare il mondo esteriore al mondo
interiore, far sì che la realtà coincida col pensiero.
In tal senso la sua azione si pone in maniera «fiduciosa», tentando di scandire le fasi
dell’approssimazione alla realtà come dati profusi di verità. Accade l’esatto contrario, ovvero che la
realtà imprigiona la verità, rendendola schiava di quella ribellione che s’agita, ma non matura,
dentro lo spirito dell’uomo. Il dominio dei caratteri tipici della comunicazione, l’azione menzognera
della politica e l’artificio che si scorge nel cuore delle ideologie, dei modelli, dei sistemi sociali, fa
sì che la felicità venga costantemente compromessa, ma soprattutto fraintesa nella mera pratica di
accumulo di oggetti e di speranze. Il salto dato dal sapere è quindi il suicidio.
Un colpo di rivoltella schiarisce le idee ad una umanità ancora presa dalle sue pratiche di ossequio e
presunzione. Il gesto di Carlo Michelstaedter è indubbiamente di rottura. Egli si uccide, certo, ma lo
fa per affrontare la vita, non la morte. In lui, giovane agitato, preso dalle turbolenze d’inizio secolo,
colto, erudito, e, al contempo, geniale, mai sprovveduto, riabilita le sue deficienze a puro
insegnamento, fa sì che il possesso di sé diventi un’arma dialettica. Per Michelstaedter concedersi a
quella che tutti ipocritamente definiscono la rovina (la morte, la fine), vuol dire concedersi alla
propria salvezza, ristabilire il contatto perduto con sé.
Il tema di fondo di Michelstaedter non è avvertire le tragedie della vita come dati unicamente
impenetrabili, quindi superiori al bene che la vita dovrebbe in totalità elargire, bensì avvertire
realmente l’esistenza come una tragedia, totale e complessiva, da essere di gran lunga migliore
scegliere la morte come riscatto per la vita tragica: «libertà va cercando che sì cara | come sa chi
per lei vita rifiuta», dice Dante Alighieri nel I canto del Purgatorio. Da ciò si deduce che gli eccessi,
la vita estrema, non sono un arrendersi, non sono una scorciatoia al dolore, non possono essere solo
follia, perché se nella follia c’è del metodo, questa follia non si esaurisce nel gesto, va oltre il
significato retorico. Così Michelstaedter rovescia la medaglia per indicare un altro cammino.
Tra vita e pensiero non ci dev’essere nessuna discrepanza, anzi il pensiero è superiore e stabilisce
parametri d’effrazione che la mera indagine non può rivelare. Si compie un gesto che è un passo: un
passo affascinante ma insieme terribile, perché pensare che si possa prendere parte alle cose del
mondo negandosi ad esse, dire con il suicidio che la vita si compie e non fallisce, è prerogativa di
alcuni spiriti la cui energia è, magari, instabile, ma fortemente rappresentativa della loro superiore
determinatezza.
La fine è l’ipotesi di una mente debole, che qui sperimenta l’esatto contrario mostrando la sua forza.
Il suicidio è dei forti. Tanto più la vita fa soffrire, tanto più il debole rimane a patire. Il forte, invece,
evade, tenta l’evasione dal mondo tornando ad appartenergli in altra maniera. L’amore che
Michelstaedter nutre per la vita non si coniuga, come per i suoi coetanei, al disperato desiderio di
sopravvivere di fronte alla paura della morte, bensì in un atto liberatorio, violentemente lucido,
come il suicidio, da lui inteso come azione del pensiero e non della disperazione, che assorbe le
illusioni incanalandole nella resa-vittoria. Per tali motivi si può scoprire con gioia nel presente tutto
ciò di cui non si ha bisogno. Ciò ci porta ad un discorso speculare a questo, più attuale, secondo cui
non si possono valutare i suicidi come atti compiuti da persone totalmente aliene, anzi, nell’epoca
attuale si fa strada una concezione diversa dell’esistenza, in cui il presupposto cristiano della
sofferenza come atto supremo d’amore è inversamente letto come un obbligo inumano, delle catene
da cui ci si vuole liberare, così finanche la motivazione dell’eutanasia esprime la sua obbiettiva
ragion d’essere. È il sunto di questo insegnamento filosofico.
Amico io guardo ancora l’orizzonte
dove il cielo ed il mare
la vita fondon infinitamente.
Guardo e chiedo la vita
la vita della mia forza selvaggia
perch’io plasmi il mio mondo e perché il sole
di me possa narrar l’ombra e le luci –
la vita che mia dia pace sicura
nella pienezza dell’essere.2
Il problema di Michelstaedter non è personale, è universale, ma in maniera personalistica egli offre
un metodo di soluzione. Certo nessuno vuole una società di gente che si toglie la vita, ma altrettanto
in questa società ci si toglie la vita per problemi che diventano dei veri e propri affronti ai quali
Michelstaedter ha reagito inculcando il seme di una straordinaria sapienza che sfiora la pura follia.
È meglio non esserci che far parte del mondo in maniera anonima, meglio fare ognuno il suo ballo
che ballare a ritmo di una musica che la politica o i regimi dettano. In questa straordinaria azione
del pensiero, che non ha nulla a che fare con quei suicidi la cui base di verità fa sorridere (come
l’amore), c’è tutta la gnoseologia dell’esistenza moderna, uno studio approfondito della conoscenza
che pone come istanza risarcitoria l’assunzione della vita a migliore compimento. Qui non ci si
lascia andare, ma ci si afferra; qui non ci si toglie la vita per amore ma per amore della vita, e nel
rispetto della propria dignità ci si libera.
Il fulcro del “pensiero negativo” cui Michelstaedter appartiene, è, di fatto, l’esempio evidente di un
fraintendimento eclatante ancora in atto. Carlo Michelstaedter dovrebbe stare tra i pensatori positivi.
Ciò darebbe senso alla sua verità. Mentre la sua verità è scambiata per una realtà personale, a cui il
giovane filosofo e poeta e disegnatore Michelstaedter, decide di dare immediata forma. Il suo gesto
repentino fu veloce quanto l’illuminazione filosofica. Forse per «eccesso di vita» – così tutto par
meglio detto e confluire nell’alveo della comprensione – il nostro pensatore si tolse la vita. Fu tale e
tanto, e su ciò non c’è dubbio, lo sforzo da lui compiuto nello scrivere la tesi di laurea, che la
stesura si è trasformata man mano in una sorta di processo alla persona (So che voglio e non ho
cosa io voglia, esordisce nel primo capitolo3), in cui l’uomo-Michelstaedter, come l’uomoLeopardi, osserva le miserie di sé, e intende raggiungere quell’infinito il cui sentiero alla ragione
umana è precluso.
Non aveva altra possibilità Michelstaedter, altro da fare per essere se non declinare: aveva
comportato un tale sforzo scrivere quella maledetta tesi di laurea che egli sentiva come unico futuro
possibile per la sua esistenza il declino, il tramonto di sé. Questo suo crollo fu tale e tanto, così
improvviso, da trasformarsi in sfida: il gesto di chi, venendo a patti con sé, strazia la bellezza del
vivere offrendo un antidoto eversivo, per evitare che «[…] ciò che vive si persuade esser vita la
qualunque vita che vive4». Certamente poeta mediocre, Carlo Michelstaedter avverte anche
l’impossibilità della poesia di farsi arte rappresentativa del suo pensiero, contrariamente a ciò che
accade in Leopardi, dove il pensiero si fa davvero sostanza esplicativa della poesia, per cui,
nell’inseguire il dovere accademico di laurearsi, Michelstaedter intercetta finalmente lo spazio
mancante alla sua opera e al suo pensiero costretto nella forma poetica, e coglie, con tutt’altra
ampiezza, il senso dell’intero percorso umano ed esistenziale. Suicidarsi non è certo la soluzione,
ma una risposta sicuramente assai esaustiva a quel sistema di valori, politici e caco-culturali, che
pongono dinanzi all’uomo come sua unica ragione d’esistere l’accettazione o il diniego.
III
«Ma gli uomini questo temono più della morte accidentale: temono più la vita che la morte: rinunciano
volentieri ad affermarsi nei modi determinati purché la loro rinuncia abbia un nome, una veste, una
persona per cui si conceda loro un futuro quanto più vasto – una crisi quanto più lontana e certa per altrui
forza – e nello stesso tempo un compito quanto più vicino: un’attività che fingendo piccoli scopi
conseguibili via via in un vicino futuro, dia l’illusione di camminare a chi sta fermo.
Per un nome, per una apparenza di persona gli uomini sacrificano volentieri la loro determinata
domanda, ché in questa pur sentono l’incertezza, e intimiditi s’adagiano alla qualunque fatica bruta: – in
ogni uomo si nasconde un’anima da fakiro.
Necessario è l’immediato tratto davanti agli occhi d’una via che si suppone finire in un qualche bene –
che certo proroga il dolore aperto e continuando fugge dall’abisso della cessazione. Perciò ogni via
tracciata è una nuova miniera, ogni vessillo un manto che copre l’insufficienza dei miseri, e concede loro
una persona e un diritto: – perciò irresistibile fiorisce la rettorica.»5
1
www.cantosirene.blogspot.com
www.filosofia.3000.it (C. Michelstaedter: Voglio e non posso e spero senza fede)
3
Vedi La persuasione e la rettorica, di C. Michelstaedter, a cura di S. Campailla, p. 39, Adelphi, Milano, 2005.
4
Vedi Storia della letteratura italiana (Il Novecento), di G. Ferroni, p. 99, Einaudi, Milano, 1991.
5
Vedi La persuasione e la rettorica, di C. Michelstaedter, a cura di S. Campailla, p. 128, Adelphi, Milano, 2005.
2