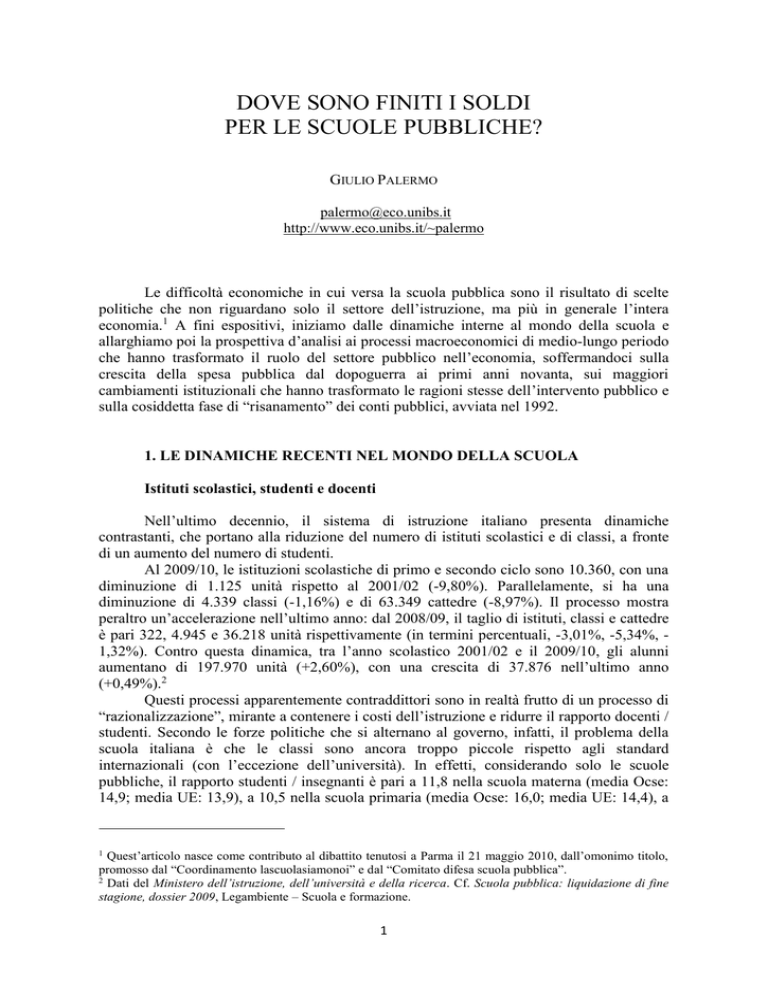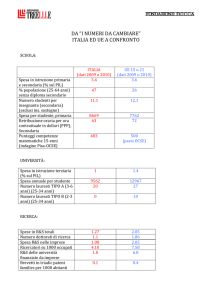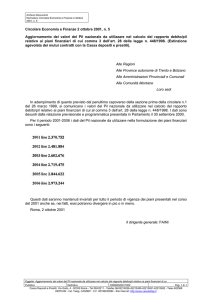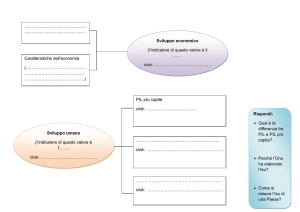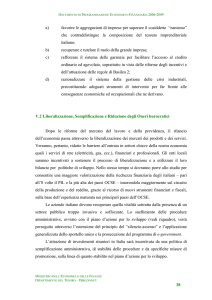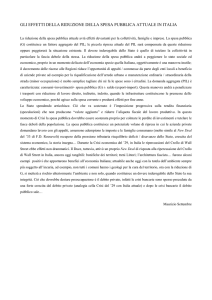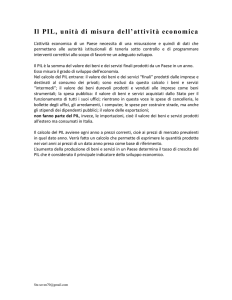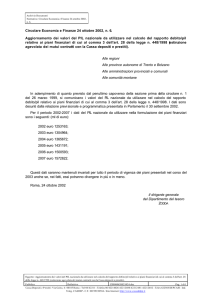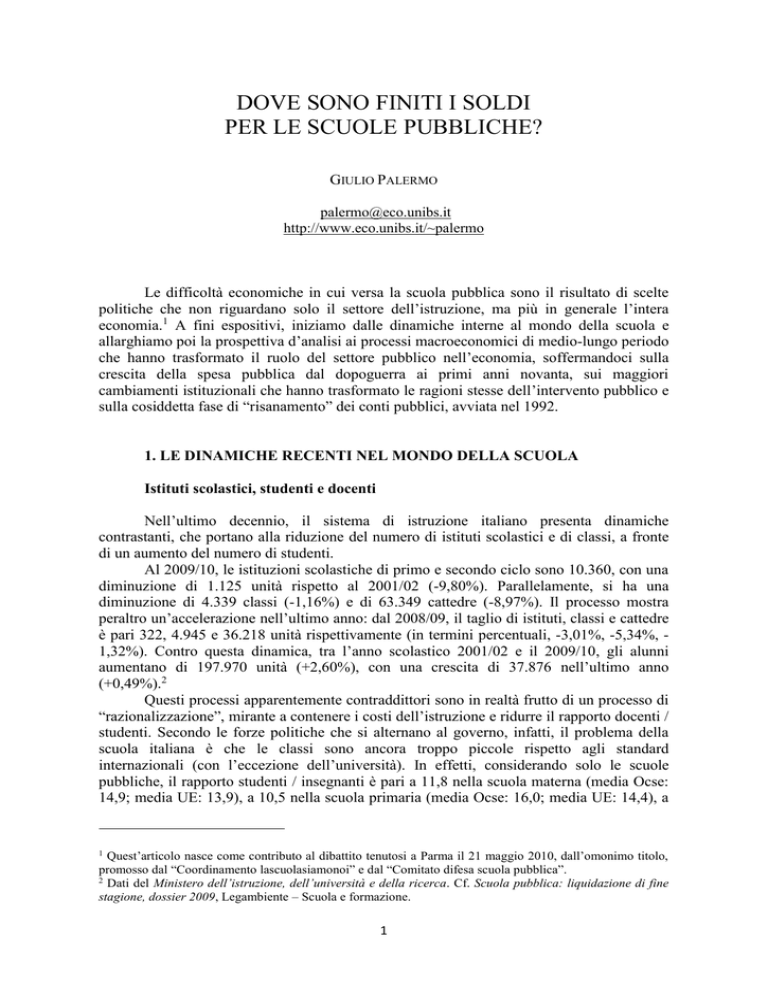
DOVE SONO FINITI I SOLDI
PER LE SCUOLE PUBBLICHE?
GIULIO PALERMO
[email protected]
http://www.eco.unibs.it/~palermo
Le difficoltà economiche in cui versa la scuola pubblica sono il risultato di scelte
politiche che non riguardano solo il settore dell’istruzione, ma più in generale l’intera
economia.1 A fini espositivi, iniziamo dalle dinamiche interne al mondo della scuola e
allarghiamo poi la prospettiva d’analisi ai processi macroeconomici di medio-lungo periodo
che hanno trasformato il ruolo del settore pubblico nell’economia, soffermandoci sulla
crescita della spesa pubblica dal dopoguerra ai primi anni novanta, sui maggiori
cambiamenti istituzionali che hanno trasformato le ragioni stesse dell’intervento pubblico e
sulla cosiddetta fase di “risanamento” dei conti pubblici, avviata nel 1992.
1. LE DINAMICHE RECENTI NEL MONDO DELLA SCUOLA
Istituti scolastici, studenti e docenti
Nell’ultimo decennio, il sistema di istruzione italiano presenta dinamiche
contrastanti, che portano alla riduzione del numero di istituti scolastici e di classi, a fronte
di un aumento del numero di studenti.
Al 2009/10, le istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo sono 10.360, con una
diminuzione di 1.125 unità rispetto al 2001/02 (-9,80%). Parallelamente, si ha una
diminuzione di 4.339 classi (-1,16%) e di 63.349 cattedre (-8,97%). Il processo mostra
peraltro un’accelerazione nell’ultimo anno: dal 2008/09, il taglio di istituti, classi e cattedre
è pari 322, 4.945 e 36.218 unità rispettivamente (in termini percentuali, -3,01%, -5,34%, 1,32%). Contro questa dinamica, tra l’anno scolastico 2001/02 e il 2009/10, gli alunni
aumentano di 197.970 unità (+2,60%), con una crescita di 37.876 nell’ultimo anno
(+0,49%).2
Questi processi apparentemente contraddittori sono in realtà frutto di un processo di
“razionalizzazione”, mirante a contenere i costi dell’istruzione e ridurre il rapporto docenti /
studenti. Secondo le forze politiche che si alternano al governo, infatti, il problema della
scuola italiana è che le classi sono ancora troppo piccole rispetto agli standard
internazionali (con l’eccezione dell’università). In effetti, considerando solo le scuole
pubbliche, il rapporto studenti / insegnanti è pari a 11,8 nella scuola materna (media Ocse:
14,9; media UE: 13,9), a 10,5 nella scuola primaria (media Ocse: 16,0; media UE: 14,4), a
Quest’articolo nasce come contributo al dibattito tenutosi a Parma il 21 maggio 2010, dall’omonimo titolo,
promosso dal “Coordinamento lascuolasiamonoi” e dal “Comitato difesa scuola pubblica”.
2
Dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Cf. Scuola pubblica: liquidazione di fine
stagione, dossier 2009, Legambiente – Scuola e formazione.
1
1
9,4 in quella secondaria inferiore (media Ocse: 13,2; media UE: 11,5), a 10,8 in quella
superiore (media Ocse: 12,5; media UE: 11,4), a 19,5 in quella universitaria (media Ocse:
15,3; media UE: 16,0).3
Questi dati, di cui la Ministra Gelmini si vanta sul sito web del suo Ministero, non
mostrano tuttavia la qualità del sistema di istruzione italiano, bensì il suo opposto. Infatti, il
basso rapporto studenti / docenti non è frutto di un’eccessiva espansione del corpo docente,
ma di una bassa partecipazione all’istruzione della popolazione in età scolare e di una
severa selezione nel percorso scolastico, che escludono dal diritto allo studio una quota
significativa della popolazione. La crescita del numero assoluto di studenti è infatti legata
in gran parte all’immigrazione, fenomeno che non migliora affatto il basso tasso di
scolarizzazione (visto che tra gli immigrati le difficoltà di accesso alla scuola sono ancora
maggiori). La posizione governativa al riguardo è peraltro nota: l’aumento di studenti
immigrati non è certo un fattore sociale positivo, ma un attentato alla qualità dell’istruzione
dei “nostri ragazzi”.
Sta di fatto che nel 2007, in Italia, su 100 persone di età compresa tra i 25 e i 64
anni, solo 14 conseguono un titolo universitario (media Ocse: 27; media UE: 24); 38
conseguono come titolo più alto il diploma di scuola secondaria superiore (media Ocse: 44;
media UE: 46); e 48 si fermano ad un livello inferiore (media Ocse: 30; media UE: 29). Se
le classi sono poco numerose non è dunque perché c’è abbondanza di docenti e di strutture,
ma perché le persone in età scolare non vanno più a scuola. Gelmini la chiama meritocrazia,
Tremonti parla di efficienza, ma, sotto il profilo economico e sociologico, questi processi
denotano solo l’irrigidimento della selezione di classe.
La spesa in istruzione
Al di là delle mistificazioni, il taglio di istituti, classi e cattedre risponde
essenzialmente all’obiettivo di contenere i costi della Pubblica amministrazione. Tale
obiettivo, secondo i governi neoliberisti di centrodestra e di centrosinistra, è ormai un
vincolo imprescindibile derivante dal sovradimensionamento degli investimenti pubblici
rispetto a quelli privati, con tutte le inefficienze e il proliferare dei “fannulloni” che questo
comporta. A sostegno di questa tesi, i ministri dell’istruzione e dell’economia sottolineano
da tempo che l’Italia è tra i paesi con la maggiore quota di finanziamenti pubblici (92,3%
dei finanziamenti totali, contro l’84,0% della media Ocse).4 Di qui l’esigenza di agire con
decisione e colmare il ritardo rispetto agli altri paesi economicamente avanzati.
In realtà, il peso significativo del finanziamento pubblico non è affatto causato da
eccessivi investimenti pubblici, ma è la conseguenza del livello irrisorio di investimenti
provenienti dalle istituzioni private. Considerando i dati del 2006, infatti, i finanziamenti
pubblici alla scuola sono in linea con quelli dei paesi Ocse: nell’istruzione primaria e
secondaria, l’Italia spende il 3,4% del Pil (dato coincidente con la media Ocse) e,
includendo anche l’istruzione terziaria, il 4,6% del Pil (leggermente inferiore alla media
Ocse, pari al 4,9%). Considerando anche i finanziamenti privati, l’Italia si colloca invece
ben al di sotto della media Ocse, sia nell’istruzione primaria e secondaria (3,5% del Pil,
contro il 3,7% della media Ocse), sia nel dato complessivo inclusivo dell’istruzione
terziaria (4,9% del Pil; media Ocse: 5,7%).
3
Dati Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Education at a glance 2009, Oecd
indicators.
4
I dati si riferiscono al 2006 e considerano tutti i livelli di istruzione aggregati. Oecd 2009.
2
La relativa scarsità di finanziamenti privati non può peraltro attribuirsi alle famiglie,
sulle quali ricade il 6,0% degli oneri del finanziamento di scuola e università, bensì sugli
altri soggetti privati, che ne finanziano appena l’1,7%. Da questo punto di vista, nonostante
i proclami ideologici in favore dell’entrata dei capitali privati nel sistema di istruzione, i
soggetti privati mostrano di preferire un sistema fortemente orientato alle imprese i cui
finanziamenti ricadono però sul settore pubblico e sulle famiglie degli studenti.
Tagli alla spesa e stipendi degli insegnanti
L’analisi della ripartizione della spesa tra conto corrente e conto capitale mostra che
i margini per tagliare gli investimenti in conto capitale sono ormai ridotti. Nel settore
scolastico, la spesa in conto corrente assorbe infatti il 95,7% della spesa totale (media Ocse:
92,0%), contro una spesa in conto capitale pari al 4,3% (media Ocse: 8,0%).
La spesa in conto corrente, a sua volta, si caratterizza per l’elevato impatto degli
stipendi del personale. Essa si ripartisce infatti nel modo seguente: 67,5% agli stipendi
degli insegnanti (media Ocse: 63,7%), 16,0% agli stipendi del resto del personale (media
Ocse: 15,3%) e per 16,6% ad altri scopi (media Ocse: 19,8%). Di qui l’obiettivo di
risparmiare sugli stipendi come strumento principale di contenimento della spesa.
Il paradosso è che gli stipendi degli insegnanti, in Italia sono già largamente
inferiori sia alla media Ocse, sia alla media UE. Considerando i dati aggiustati tramite
l’indice di parità del potere d’acquisto (in modo da poterli confrontare con quelli di altri
paesi), nel 2007, gli stipendi in euro degli insegnanti italiani sono i seguenti: lo stipendio
iniziale nella scuola primaria è pari a 21.901 (media Ocse: 25.187; media UE: 25.917),
dopo 15 anni passa a 26.493 (media Ocse: 34.248; media UE: 34.778), per arrivare a fine
carriera a 32.280 (media Ocse: 41.922; media UE: 42.589). Nella scuola secondaria
inferiore, lo stipendio iniziale è pari a 23.598 (media Ocse: 27.218; media UE: 27.8256),
dopo 15 anni passa a 28.850 (media Ocse: 36.870; media UE: 36.925), per arrivare a fine
carriera a 35.428 (media Ocse: 45.191; media UE: 45.028). Nella scuola secondaria
superiore, infine, lo stipendio iniziale è pari a 23.598 (media Ocse: 28.256; media UE:
28.926), dopo 15 anni è di 29.657 (media Ocse: 39.319; media UE: 39.961) e a fine carriera
di 37.033 (media Ocse: 47.798; media UE: 48.817).
Docenti di ruolo e precari
La riduzione del numero di docenti e il contenimento e dei loro stipendi si
accompagna ad un aumento della quota di docenti precari, meno onerosi e gestibili in modo
più flessibile, secondo le esigenze temporanee (ma ormai anche durature) delle scuole.
Dal 2001/02 al 2008/09, i docenti di ruolo diminuiscono di 29.302 unità (-3,99%),
da 734.193 a 704.891.5 Nello stesso periodo, i docenti precari aumentano di 36.380 unità
(+38,52%), da 94.455 a 130.835, arrivando a coprire il 15,66% del corpo docente. Questi
dati non lasciano dubbi sul ruolo strutturale dei docenti precari nella copertura delle
cattedre esistenti. Eppure, di anno in anno, la norma vuole che questi docenti siano
licenziati al termine delle attività didattiche, per essere riassunti alla ripresa dell’anno
scolastico: nel 2008/09, questa misura ha colpito 110.533 docenti.
5
Dati Miur, riportati nel Dossier 2009 di Legambiente.
3
Ricercare una strategia pedagogica in questi processi è solo una perdita di tempo.
L’irrigidimento nelle condizioni d’accesso al diritto allo studio, il taglio delle cattedre, il
contenimento degli stipendi e l’esplosione del precariato rispondono ad una sola logica:
colpire le voci di bilancio che consentono il maggior abbattimento dei costi.
2. LA CRESCITA DELLA SPESA PUBBLICA NEL PERIODO 1960-1990
Per comprendere la natura economica dei processi che investono il settore
dell’istruzione, dobbiamo ora inquadrarli nelle dinamiche economiche più generali che
hanno reso necessari i tagli generalizzati alla spesa pubblica, come condizione “esterna”,
imposta dagli accordi internazionali. Ma cominciamo, innanzi tutto, dal ruolo espansivo
svolto storicamente dalla spesa pubblica e, al suo interno, dall’importanza crescente della
spesa a carattere sociale.
La ricostruzione e il boom economico
Dopo la seconda guerra mondiale, l’Italia, come la maggior parte dei paesi coinvolti
nel conflitto, mantiene elevati livelli di spesa pubblica per far fronte alle esigenze
economiche e sociali della ricostruzione. Gli anni cinquanta sono caratterizzati dal boom
economico, guidato, all’interno, da politiche keynesiane incentrate sulla spesa pubblica e
sulle partecipazioni statali, e all’esterno, dal processo di creazione del mercato comune
europeo.
Nella composizione della spesa pubblica, cresce soprattutto la spesa in conto
capitale, attraverso il Piano Marshall, finalizzata alla creazione di infrastrutture e alla
produzione di beni capitali necessari anche al settore privato. La crescita economica è
inoltre sostenuta dal basso livello dei salari e dagli alti tassi di disoccupazione, concentrati
soprattutto nel mezzogiorno, che si accompagnano ad una forte emigrazione.
Dalla metà degli anni cinquanta, il processo di industrializzazione aumenta la
domanda di lavoro, migliorano le condizioni lavorative, crescono i salari, si riduce
l’emigrazione e migliora nel complesso la qualità della vita.
Lotte sociali, spesa pubblica e deficit spending
Negli anni sessanta e settanta, le lotte politiche e sindacali portano ad importanti
conquiste dei lavoratori. La spesa pubblica cresce sia sotto l’azione delle rivendicazioni
sindacali e politiche, sia come strumento di governo delle tensioni sociali. Inizialmente,
tuttavia, non si evidenziano particolari problemi di finanziamento. È solo a partire dagli
anni settanta che si sviluppano politiche di deficit spending, che portano, nel 1975, il
rapporto disavanzo pubblico / Pil all’11%, con una crescita del rapporto debito pubblico /
Pil di 20 punti percentuali in cinque anni. Durante gli anni ottanta, la spesa pubblica cresce
ulteriormente, passando dal 42,2% del Pil nel 1980 al 52,0% nel 1989.6
Complessivamente, dal 1960 al 1990, la spesa pubblica aumenta di 24 punti
percentuali rispetto al Pil (dal 29,0% del Pil al 53,5%). Nello stesso periodo, la pressione
6
I dati qui riportati sono estratti da Franco, D. L’espansione della spesa pubblica in Italia (1960-90),
Bologna: Il Mulino, 1993.
4
fiscale passa dal 25,7% del Pil al 39,7%. L’effetto combinato di questi due processi porta
ad una crescita del disavanzo e del debito pubblico. Il primo passa da poco più dell’1% del
Pil all’11%. Il secondo passa da poco meno del 40% del Pil a quasi il 100%, facendo salire
la quota della spesa pubblica destinata al pagamento degli interessi sul debito dall’1,5% del
Pil al 9,7%.7
La spesa sociale
Tralasciando la spesa per interessi, l’aumento della spesa pubblica è dovuto
principalmente alle voci di spesa sociale. Dal 1960 al 1990, la spesa per istruzione (che
comprende scuola, università e formazione professionale) passa dal 3,2% del Pil nel 1960 al
5,2% nel 1990, la spesa sanitaria dal 3,0% al 5,8%, quella in previdenza e assistenza dal
9,5% al 16,2%.8
La crescita della spesa per istruzione è da ascriversi alla crescita occupazionale del
settore, in risposta ai cambiamenti strutturali che investono la scuola, con l’allungamento
della durata della scuola dell’obbligo, l’istituzione della scuola materna statale e la volontà
politica di migliorare la qualità dell’istruzione attraverso l’innalzamento del rapporto
docenti / studenti. Gli occupati in questo settore, che nel 1960 costituivano il 27%
dell’occupazione pubblica (il 2% dell’occupazione complessiva) aumentano così nel 1990
al 32% (il 5% rispetto all’occupazione totale).
Accanto alla scuola, il settore della sanità è quello che mostra una dinamica in
termini percentuali più accentuata, con una significativa crescita della spesa legata
all’istituzione del Servizio sanitario nazionale nel 1978.
L’aumento della spesa in previdenza e assistenza è quello maggiore in termini
assoluti e, a differenza dei settori dell’istruzione e della sanità, è legato alle prestazioni
sociali in denaro per vecchiaia e invalidità, con un impatto modesto degli oneri per il
personale.
Il sistema tributario
Dal lato delle entrate fiscali, la riforma avviata nel 1973 aumenta l’incidenza delle
imposte dirette, rispetto a quelle indirette.9 L’incidenza delle prime passa dal 5,2% del Pil
nel 1960, al 15,6% nel 1990, quella delle seconde dall’11,3% al 10,6%, con il sorpasso
delle prime sulle seconde nel 1978.
Il carattere progressivo delle imposte dirette e la loro crescita rispetto a quelle
indirette costituiscono importanti elementi redistributivi nella politica tributaria di questo
periodo, volta a far ricadere il costo delle riforme sulle classi più abbienti. La pressione
tributaria passa così dal 16,5% del Pil al 25,2%. Le entrate fiscali crescono poi in modo
I dati sul disavanzo e sul debito sono tratti da Artoni, R. e Biancini, S. “Il debito pubblico dall’Unità ad
oggi”, in Storia economica d’Italia, a cura di Ciocca P. e Toniolo G., Roma: Laterza, 2003, pp. 269-380.
8
Dati ripresi da Franco 1993. I dati di questa sezione riguardanti il sistema di istruzione non sono
direttamente comparabili con quelli analizzati nella sezione sulle dinamiche recenti nel mondo della scuola,
poiché qui le spese nell’istruzione terziaria non sono scorporate da quelle per la spesa primaria e secondaria.
9
Dati estratti da Ceriani, V., Frasca, F. e Monacelli, D. “Il sistema tributario e il disavanzo pubblico: problemi
e prospettive” in Ente Einaudi (a cura di) Il disavanzo pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di
rientro, Bologna: Il Mulino, volume I, 1992.
7
5
ancora più significativo per effetto dei contributi sociali, che passano dal 9,2% del Pil al
14,5%, facendo crescere la pressione fiscale dal 25,7% del Pil al 39,7%.
Complessivamente, anche nel dibattito politico, tasse e spesa pubblica costituiscono,
fino agli anni settanta, strumenti di politica redistributiva, considerati necessari alla crescita
e alla coesione sociale.
3. LE RIFORME ISTITUZIONALI
L’indipendenza della banca centrale
Dagli anni ottanta, sulla scia della svolta neoliberista guidata da Thatcher e Reagan,
la spesa pubblica e il disavanzo assumono, nel dibattito politico, il carattere di fattori
pericolosi e destabilizzanti. Prendono così corpo gli studi accademici volti a mostrare la
necessità di meccanismi di disciplina della spesa pubblica e del disavanzo. Tra questi, la
teoria neoliberista insiste sull’indipendenza della banca centrale.
Prima del cosiddetto “divorzio” tra Tesoro e banca centrale, la Banca d’Italia era
tenuta ad acquistare tutti i titoli del debito pubblico non collocati nelle aste di mercato.
Ogni emissione di Buoni del Tesoro produceva dunque un aumento della base monetaria
pari al valore dei titoli acquistati da Bankitalia. Nel 1981, si stabilisce tuttavia il principio
dell’indipendenza della banca centrale, come strumento per disincentivare l’emissione di
titoli del debito pubblico e contenere il disavanzo.
Contrariamente alle previsioni, tuttavia, questo nuovo quadro istituzionale non ha
effetti significativi sul disavanzo e diventa invece una delle cause del rapido aumento del
debito. Nel 1985, a cinque anni dal divorzio, il rapporto disavanzo pubblico / Pil è ancora
alto, pari al 12%. Allo stesso tempo è proprio a partire dal 1980 che la dinamica del
rapporto debito / Pil diventa esplosiva, passando da valori medi attorno al 60%, nel periodo
1975-1980, al 100% nel 1991. Per compensare la diminuzione dei titoli del debito pubblico
acquistati dalla banca centrale, il Tesoro deve infatti offrire alti tassi di rendimento tali da
invogliare l’acquisto dei titoli da parte degli operatori privati. La spesa per interessi
aumenta così non solo per effetto dei continui disavanzi pubblici, ma anche a causa del
crescente differenziale di tasso di interesse che il Tesoro italiano deve offrire, rispetto agli
altri paesi, per collocare i propri titoli sul mercato.
Gli accordi valutari
Prima ancora della fine della seconda guerra mondiale i principali paesi
industrializzati convengono sulla necessità di definire un nuovo quadro istituzionale capace
di sostenere il commercio internazionale. A questo fine, gli accordi di Bretton Woods,
firmati nel luglio 1944, stabiliscono la convertibilità in oro del dollaro e l’impegno da parte
degli altri paesi di stabilizzare le loro valute rispetto al dollaro. Questo sistema cessa nel
1971, su iniziativa unilaterale degli Stati uniti. Dopo una breve parentesi in cui la
regolazione dei tassi di cambio è regolata dal Serpente monetario europeo, nel 1979 viene
istituito il Sistema monetario europeo (Sme): un sistema di tassi di cambio bilaterali
fluttuanti entro una fascia ristretta del 2,5%, con l’eccezione per alcuni paesi ad alta
inflazione, tra cui l’Italia, cui è concessa una fascia di oscillazione del 6,0%. Lo Sme
prevede inoltre la possibilità di aggiustare la parità bilaterali, consentendo ai paesi a più alta
inflazione di recuperare competitività attraverso la svalutazione del tasso di cambio. Paesi
6
come l’Italia, in cui le lotte dei lavoratori, la politica fiscale e le riforme sociali impongono
tassi di inflazione relativamente alti, possono dunque convivere accanto a paesi a più bassa
inflazione, come la Germania, a condizione di aggiustare periodicamente il loro tasso di
cambio bilaterale.
Lo Sme termina di fatto nel settembre 1992, con gli attacchi speculativi contro la
sterlina e la lira, data la riluttanza della Bundesbank (la banca centrale tedesca) ad
intervenire accanto alle banche centrali di Inghilterra e Italia, vendendo marchi e altre
valute pregiate in cambio di sterline e lire. Le ragioni del mancato intervento tedesco sono
di natura interna e dipendono dal processo di riunificazione. Sul piano tecnico, si deve
comunque notare che un intervento della Bundesbank avrebbe senz’altro salvato lo Sme,
poiché a differenza della Banca d’Italia e della Banca d’Inghilterra, la Bundesbank ha
riserve potenzialmente infinite di marchi (potendone stampare a volontà). Sotto il profilo
politico ed economico, inoltre, il paese deviante era proprio la Germania, la quale ha
innalzato i tassi d’interesse, al fine di attrarre i capitali necessari alla riunificazione,
esponendo le valute più deboli agli attacchi della speculazione internazionale.
Ma soprattutto, con l’unificazione tedesca nel 1990, la flessibilità dello Sme diventa
un ostacolo alle strategie di crescita della Germania. Aumentano così le pressioni per
muovere verso tassi di cambio veramente fissi, in cui i paesi ad alta inflazione non possano
più utilizzare la leva del tasso di cambio, ma debbano invece impegnarsi nel contenimento
dell’inflazione, attraverso la compressione dei salari, terreno nel quale il processo di
riunificazione pone la Germania in posizione di assoluto vantaggio.
Il trattato di Maastricht
Il 7 febbraio 1992, i 12 paesi membri della Comunità europea firmano il Trattato
sull’Unione europea (Trattato di Maastricht), che istituisce l’unione economica e
monetaria e definisce le tappe per l’adozione dell’euro. A questo fine, il 1° giugno 1998 è
istituita la Banca centrale europea (Bce), il cui scopo è il controllo dell’inflazione sotto il
2% annuo, un valore assai basso per la maggior parte dei paesi che adottano l’euro. Non
solo i paesi aderenti all’Unione perdono il controllo della politica monetaria come
strumento di governo dell’economia nazionale, per cederla ad un ente indipendente
sopranazionale, espressione degli interessi del mondo bancario europeo; ma la politica
monetaria assume un ruolo asimmetrico, di freno dell’attività economica. La Bce infatti non
ha alcun mandato per agire in sostegno della crescita e dell’occupazione e il suo obiettivo
esplicito è invece di contrastare qualsiasi tendenza espansiva, la quale inevitabilmente si
accompagna ad una crescita dei prezzi (la quale, a sua volta, riduce i profitti delle banche).
Gli accordi di Maastricht, sviluppati in seno ai paesi aderenti all’euro attraverso il
Patto di stabilità e crescita, impongono severe condizioni anche sul piano della politica
fiscale, fissando una serie di vincoli ai conti dello stato, tra i quali, in particolare: un
rapporto deficit pubblico / Pil non superiore al 3%, un rapporto debito pubblico / Pil non
superiore al 60% e un tasso d’inflazione non superiore dell’1,5% rispetto a quello dei tre
paesi a più bassa inflazione. Anche sul piano della politica fiscale, si introduce così una
distorsione restrittiva, operante indipendentemente dall’orientamento politico delle
coalizioni governative, che impedisce i tradizionali interventi espansivi in favore di crescita
e occupazione basati sul deficit spending.
Nel nuovo contesto istituzionale, fatto di tassi di cambio fissi e politiche monetarie e
fiscali restrittive, la competitività internazionale tra i paesi dell’Unione dipende sempre più
dalla capacità di contenere l’inflazione. Il contenimento della spesa pubblica e la
7
compressione dei salari diventano così le condizioni oggettive di successo nell’area
dell’euro.
4. IL “RISANAMENTO” DEI CONTI PUBBLICI
Nel 1992, prende il via il processo di “risanamento” del debito pubblico. A livello
internazionale, il quadro economico europeo è dominato dalla riunificazione tedesca e dal
processo di istituzione dell’unione economica e monetaria. Sul fronte della finanza
pubblica, il disavanzo è pari all’11% del Pil (quasi interamente generato dalla spesa per
interessi) e il rapporto debito / Pil ha ormai superato il 100%. Le principali voci di spesa del
settore pubblico riguardano la protezione sociale (39,7% della spesa pubblica totale), la
sanità (14,7%) e l’istruzione (12,7%).10
La svolta dei governi tecnici e la continuità tra centrosinistra e centrodestra
Il piano di risanamento dei conti pubblici è avviato nel luglio 1992 dal governo
tecnico Amato, mediante il contenimento delle spese e la realizzazione di un crescente
avanzo primario (il surplus al netto della spesa per interessi). A questo fine, il governo
ottiene la delega per attuare riforme strutturali in tutti i settori che concorrono
maggiormente alla spesa pubblica: previdenza, sanità, pubblico impiego e finanza locale. Il
governo avvia inoltre un imponente piano di privatizzazioni, come strumento per fare cassa
e per ridimensionare stabilmente il ruolo dello Stato nell’economia.
Il risanamento dei conti pubblici prosegue poi con il governo Ciampi (governatore
di Bankitalia durante l’attacco speculativo contro la lira nel 1992 e responsabile della
decisione di difendere a oltranza la valuta, dilapidando le riserve valutarie). La politica di
rigore diventa infine una costante dei governi di centrosinistra e di centrodestra, prima
come condizione necessaria per l’adozione della moneta unica (Trattato di Maastricht), poi
come condizione di stabilità dell’area dell’euro (Patto di stabilità e crescita).
I tagli alla spesa
Le maggiori azioni di contenimento della spesa pubblica riguardano la previdenza e
il pubblico impiego. Obiettivo principale della riforma della previdenza è la riduzione delle
prestazioni in denaro per vecchiaia e invalidità, la voce di spesa principale di questo
comparto. A questo fine, la riforma Amato del 1992 e quella Dini del 1995 irrigidiscono i
requisiti per l’accesso alla pensione, modificano la formula per il calcolo dei trattamenti
pensionistici, in modo da ridurre le prestazioni erogate, e segnano il graduale passaggio dal
sistema retributivo a quello contributivo. La riforma del 2004 innalza poi i criteri d’accesso
alla pensione anticipata.
Nel pubblico impiego, il risparmio dei costi è perseguito attraverso il doppio
obiettivo di ridurre il numero di dipendenti pubblici e la loro remunerazione. Il
contenimento delle assunzioni è attuato ponendo severi limiti al turn over. Nel 1992, il tetto
alle nuove assunzioni è fissato al 10% delle cessazioni nelle Amministrazioni statali (ogni
100 persone che escono definitivamente dal rapporto lavorativo sono possibili al massimo
10
Dati Istat, Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per funzione Serie Sec95 – anni 1990-2002.
8
10 assunzioni) e al 25% per gli enti pubblici non economici e le unità sanitarie locali. Dal
1994, il tetto del 10% è esteso a tutta la pubblica amministrazione, con alcune eccezioni tra
cui la scuola, cui sono dedicati specifici programmi di controllo delle assunzioni. Nel 1997,
si arriva al blocco totale delle assunzioni, incluse quelle a tempo determinato, in diversi
comparti del settore pubblico. Dal 1998 al 2001, viene formalmente istituita la
programmazione delle assunzioni allo scopo dichiarato di ridurre i dipendenti pubblici
secondo precisi obiettivi settoriali. Dal 2002, viene infine riproposto il blocco totale delle
assunzioni, con la possibilità di alcune assunzioni in deroga, nel rispetto comunque di un
tetto di spesa prefissato. Infine, le più recenti manovre del governo ripropongono il limite al
10% del turn over, consentendo peraltro che le nuove assunzioni (che vanno a rimpiazzare
posti a tempo indeterminato) siano a tempo determinato.
Sul fronte retributivo, grazie all’accordo sul costo del lavoro, fondato su flessibilità,
moderazione salariale e abolizione dei meccanismi di indicizzazione dei salari, i redditi da
lavoro dipendente scendono dal 12,5% del Pil nel 1992, al 10,8% nel 2002, allineandosi
allo schiacciamento della dinamica salariale già avviata nel settore privato.
Ulteriori misure di contenimento della spesa riguardano le prestazioni sociali, che
passano dal 18,1% del Pil nel 1992 al 17,0% nel 2002, e la sanità, dove i tagli si
concentrano nel periodo 1992-1995, con un abbattimento della spesa dal 6,7% del Pil al
5,2%.
Dal 1994 inizia anche a diminuire la spesa per interessi, dopo aver toccato un
massimo, nel 1993, al 12% del Pil. Si tratta in parte dell’effetto del contenimento del debito
pubblico e in parte dell’effetto della discesa dei tassi di interesse internazionali. Nel 2005,
l’incidenza della spesa per interessi rispetto al Pil tocca un minimo al 4,5%, per poi
stabilizzarsi attorno al 5% negli anni successivi, a causa della dinamica dei tassi d’interesse
mondiali.
Complessivamente, dal 1992 al 2007, la spesa pubblica passa dal 56,1% del Pil al
49,1%, dopo aver toccato un massimo nel 1993 al 57,8%.
Le entrate e la politica tributaria
Sul fronte delle entrate, crescono le imposte indirette, che nel 1998 superano
nuovamente quelle dirette, per stabilizzarsi entrambe attorno al 14-15% del Pil nel primi
anni del 2000, con effetti redistributivi di carattere regressivo che si abbattono sulle classi
più povere. La politica redistributiva del governo si completa con l’abolizione dell’imposta
sulle successioni e sulle donazioni e altre misure di sgravio fiscale all’indirizzo delle classi
agiate.
Le entrate beneficiano infine del piano di privatizzazioni avviato nel 1992, che
produce inizialmente proventi pari allo 0,4% del Pil, per salire al 2,21% nel 2001.
Accanto agli effetti redistributivi, queste misure producono complessivamente un
aumento delle entrate di 5,0 punti percentuali tra il 1991 e il 1997, cui segue una riduzione
di 3,5 punti nel periodo 1998-2005 e un nuovo aumento di 3 punti nel biennio 2006-2007.
Al 2007, l’incidenza delle entrate sul Pil è pari al 47,2%.
Disavanzo e debito pubblico
L’insieme di queste manovre produce una rapida crescita dell’avanzo primario che
passa dall’1,9% del 1992 al 6,7% nel 1997, per poi stabilizzarsi, dal 2002, attorno al 3% del
9
Pil, con alcune variazioni legate alla congiuntura (da cui dipendono in maniera pro-ciclica
le entrate fiscali).11
Sul piano della crescita economica, queste misure di politica fiscale restrittiva basate
su avanzi primari e tagli alla spesa, combinate alle politiche anti-inflazionistiche condotte
prima da Bankitalia e poi dalla Bce producono un rallentamento del tasso di crescita del Pil,
il quale rimane inferiore al 2% annuo per quasi tutto il periodo considerato. L’effetto sul
rapporto debito pubblico / Pil di queste politiche anti-keynesiane è l’inversione della sua
tendenza crescente nel 1995: dopo aver toccato un massimo nel 1994 al 124,3%, tale
rapporto si stabilizza, a partire dal 2003-2004, attorno al 104%.
5. CONCLUSIONI
Storicamente la spesa pubblica ha svolto un importante ruolo espansivo a sostegno
della crescita sociale, oltre che economica. Non si è trattato certo di processi spontanei, ma
di lotte condotte dalle forze sociali e politiche, guidate dal movimento dei lavoratori e dal
movimento studentesco.
Nel corso degli ultimi venti anni, i principi informatori dell’intervento pubblico
nell’economia hanno però subito una radicale trasformazione. L’egemonia politica
neoliberista ha imposto non solo la riduzione della spesa pubblica, ma anche la
ridefinizione dei suoi obiettivi. Nel campo della scuola, il contenimento dei costi si abbatte
principalmente sul costo del personale, che, per la natura stessa del sistema di istruzione,
costituisce la voce principale di spesa. Contenimento di salari e stipendi, severi vincoli al
turn over del personale e smantellamento del lavoro a tempo indeterminato sono i principali
strumenti di questa politica.
Ma questo è solo l’ultimo stadio di un processo di riforma volto a ridefinire le
funzioni sociali ed economiche dell’istruzione, orientando sempre più l’offerta formativa
alle esigenze delle imprese e irrigidendo la selezione e le misure disciplinari nel rapporto
didattico, allo scopo di formare futuri lavoratori, docili e competenti, come richiede il
mercato del lavoro. I vecchi obiettivi assegnati alla scuola, come strumento di crescita
culturale, formazione di pensiero critico, emancipazione soggettiva e diritto universale
lasciano ormai il posto, anche tra le forze che si autodefiniscono progressiste, ai nuovi
diktat dell’efficienza e della razionalizzazione del sistema scolastico, in funzione delle
esigenze delle imprese e del rigore nei conti pubblici.
Per fare giusto un esempio, di fronte all’evidenza empirica che mostra un rapporto
relativamente elevato tra docenti e studenti, frutto della privazione di fatto del diritto allo
studio per una quota significativa di popolazione, il dibattito pubblico non si sofferma sulla
necessità di avviare politiche di inclusione volte ad aumentare la partecipazione scolastica.
Al contrario, politici ed esperti di settore deducono all’unisono la necessità di accelerare le
politiche di tagli al personale docente, promuovendo eventualmente la docenza precaria,
nonostante gli ovvi problemi di continuità didattica nel rapporto pedagogico e le ben note
conseguenze di carattere esistenziale legate alla precarizzazione dei rapporti lavorativi.
L’esame delle dinamiche generali entro cui si sviluppa la riforma della scuola
mostra inoltre che i nuovi parametri del mercato che impongono i tagli alla spesa, la
precarizzazione dei rapporti lavorativi e la fine della spesa sociale non sono una specificità
settoriale, ma il risultato di un disegno coordinato di ridefinizione dei rapporti tra economia
11
Dati estratti dalle Relazioni annuali della Banca d’Italia del 1999, 2001 e 2003.
10
e società, con l’imposizione dei canoni di “razionalità” della prima ai principi di
funzionamento della seconda.
Che i conti pubblici siano più “sani” quando sono in attivo è un fatto sul quale
concordano le forze di governo e di opposizione, che si contendono il merito di queste
politiche, i sindacati confederali, più attenti alla concertazione con la controparte padronale
e governativa che agli interessi della base, Confindustria, che vede finalmente una società al
servizio del capitale privato, e il mondo bancario, che ha finalmente allontanato l’incubo
dell’inflazione che erode i suoi profitti. Qualche dubbio cominciano però ad avercelo i
lavoratori, che devono fare i conti con un tasso di disoccupazione in crescita, precarietà,
salari stagnanti, privazione dei diritti e smantellamento dei servizi pubblici.
La portata generale di quest’attacco di classe non lascia scampo ai tentativi di
difendere i settori chiave dello sviluppo economico su base solo settoriale. Chiedersi dove
sono finiti i soldi per le scuole pubbliche è una domanda legittima. La cui risposta però non
può che passare per una critica radicale dell’intero sistema di vincoli istituzionali che
impedisce oggi di sviluppare un modello di istruzione e di società basato sui diritti
individuali e sociali e non sulla logica del mercato e del profitto.
11