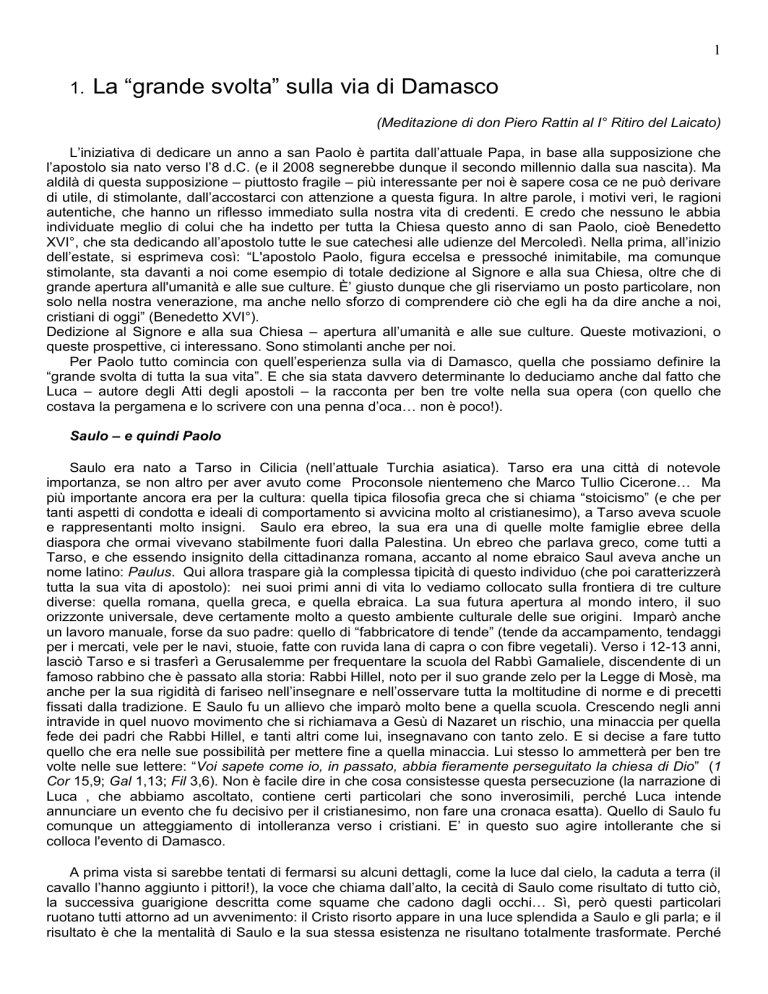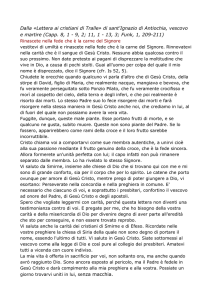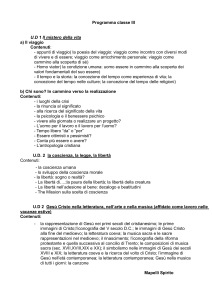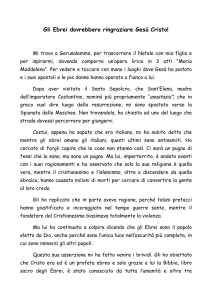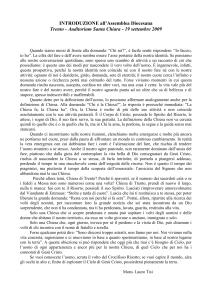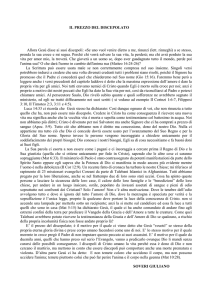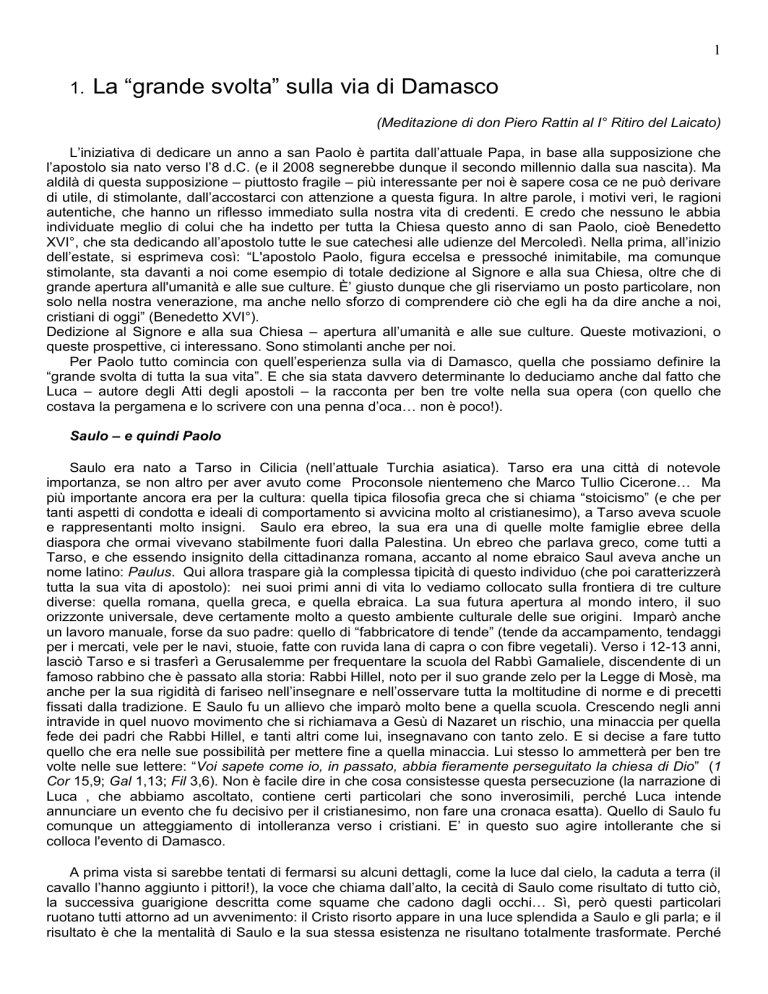
1
1.
La “grande svolta” sulla via di Damasco
(Meditazione di don Piero Rattin al I° Ritiro del Laicato)
L’iniziativa di dedicare un anno a san Paolo è partita dall’attuale Papa, in base alla supposizione che
l’apostolo sia nato verso l’8 d.C. (e il 2008 segnerebbe dunque il secondo millennio dalla sua nascita). Ma
aldilà di questa supposizione – piuttosto fragile – più interessante per noi è sapere cosa ce ne può derivare
di utile, di stimolante, dall’accostarci con attenzione a questa figura. In altre parole, i motivi veri, le ragioni
autentiche, che hanno un riflesso immediato sulla nostra vita di credenti. E credo che nessuno le abbia
individuate meglio di colui che ha indetto per tutta la Chiesa questo anno di san Paolo, cioè Benedetto
XVI°, che sta dedicando all’apostolo tutte le sue catechesi alle udienze del Mercoledì. Nella prima, all’inizio
dell’estate, si esprimeva così: “L'apostolo Paolo, figura eccelsa e pressoché inimitabile, ma comunque
stimolante, sta davanti a noi come esempio di totale dedizione al Signore e alla sua Chiesa, oltre che di
grande apertura all'umanità e alle sue culture. È’ giusto dunque che gli riserviamo un posto particolare, non
solo nella nostra venerazione, ma anche nello sforzo di comprendere ciò che egli ha da dire anche a noi,
cristiani di oggi” (Benedetto XVI°).
Dedizione al Signore e alla sua Chiesa – apertura all’umanità e alle sue culture. Queste motivazioni, o
queste prospettive, ci interessano. Sono stimolanti anche per noi.
Per Paolo tutto comincia con quell’esperienza sulla via di Damasco, quella che possiamo definire la
“grande svolta di tutta la sua vita”. E che sia stata davvero determinante lo deduciamo anche dal fatto che
Luca – autore degli Atti degli apostoli – la racconta per ben tre volte nella sua opera (con quello che
costava la pergamena e lo scrivere con una penna d’oca… non è poco!).
Saulo – e quindi Paolo
Saulo era nato a Tarso in Cilicia (nell’attuale Turchia asiatica). Tarso era una città di notevole
importanza, se non altro per aver avuto come Proconsole nientemeno che Marco Tullio Cicerone… Ma
più importante ancora era per la cultura: quella tipica filosofia greca che si chiama “stoicismo” (e che per
tanti aspetti di condotta e ideali di comportamento si avvicina molto al cristianesimo), a Tarso aveva scuole
e rappresentanti molto insigni. Saulo era ebreo, la sua era una di quelle molte famiglie ebree della
diaspora che ormai vivevano stabilmente fuori dalla Palestina. Un ebreo che parlava greco, come tutti a
Tarso, e che essendo insignito della cittadinanza romana, accanto al nome ebraico Saul aveva anche un
nome latino: Paulus. Qui allora traspare già la complessa tipicità di questo individuo (che poi caratterizzerà
tutta la sua vita di apostolo): nei suoi primi anni di vita lo vediamo collocato sulla frontiera di tre culture
diverse: quella romana, quella greca, e quella ebraica. La sua futura apertura al mondo intero, il suo
orizzonte universale, deve certamente molto a questo ambiente culturale delle sue origini. Imparò anche
un lavoro manuale, forse da suo padre: quello di “fabbricatore di tende” (tende da accampamento, tendaggi
per i mercati, vele per le navi, stuoie, fatte con ruvida lana di capra o con fibre vegetali). Verso i 12-13 anni,
lasciò Tarso e si trasferì a Gerusalemme per frequentare la scuola del Rabbì Gamaliele, discendente di un
famoso rabbino che è passato alla storia: Rabbi Hillel, noto per il suo grande zelo per la Legge di Mosè, ma
anche per la sua rigidità di fariseo nell’insegnare e nell’osservare tutta la moltitudine di norme e di precetti
fissati dalla tradizione. E Saulo fu un allievo che imparò molto bene a quella scuola. Crescendo negli anni
intravide in quel nuovo movimento che si richiamava a Gesù di Nazaret un rischio, una minaccia per quella
fede dei padri che Rabbi Hillel, e tanti altri come lui, insegnavano con tanto zelo. E si decise a fare tutto
quello che era nelle sue possibilità per mettere fine a quella minaccia. Lui stesso lo ammetterà per ben tre
volte nelle sue lettere: “Voi sapete come io, in passato, abbia fieramente perseguitato la chiesa di Dio” (1
Cor 15,9; Gal 1,13; Fil 3,6). Non è facile dire in che cosa consistesse questa persecuzione (la narrazione di
Luca , che abbiamo ascoltato, contiene certi particolari che sono inverosimili, perché Luca intende
annunciare un evento che fu decisivo per il cristianesimo, non fare una cronaca esatta). Quello di Saulo fu
comunque un atteggiamento di intolleranza verso i cristiani. E’ in questo suo agire intollerante che si
colloca l'evento di Damasco.
A prima vista si sarebbe tentati di fermarsi su alcuni dettagli, come la luce dal cielo, la caduta a terra (il
cavallo l’hanno aggiunto i pittori!), la voce che chiama dall’alto, la cecità di Saulo come risultato di tutto ciò,
la successiva guarigione descritta come squame che cadono dagli occhi… Sì, però questi particolari
ruotano tutti attorno ad un avvenimento: il Cristo risorto appare in una luce splendida a Saulo e gli parla; e il
risultato è che la mentalità di Saulo e la sua stessa esistenza ne risultano totalmente trasformate. Perché
2
rimane cieco? Perché in tal modo può rendersi conto perfino fisicamente della sua situazione interiore: di
fronte alla verità, alla luce che è Cristo, lui è un cieco, e da cieco si è comportato fin qui. Quando poi nel
battesimo darà la sua adesione a quel Gesù che ha sempre rifiutato, allora gli si riapriranno gli occhi, ma
non per vedere tutto come prima: tutto gli apparirà completamente diverso da prima, a cominciare dalla sua
persona, da se stesso. (Forse è anche a partire da questa sua esperienza che i cristiani dell’Oriente
daranno al Battesimo il nome di “photismòs”: illuminazione).
A partire da questo fatto, Luca non parlerà più di Saulo ma di Paolo (era già il suo nome latino, come
abbiamo visto), ma la variazione è motivata: cambia il nome perché è la persona tutt’intera che è cambiata,
o sta cambiando nella sua interezza poco a poco…
Paolo non parla mai in modo dettagliato nelle sue lettere di questo evento che ha cambiato la sua vita. Ne
accenna alcune volte, in modo molto sobrio, come se fosse qualcosa di risaputo nelle Comunità cristiane.
A quelli di Corinto chiede, in tono retorico: “Non ho forse veduto Gesù, nostro Signore?” (1 Cor 9,1) e
ricorda loro che Gesù - morto, sepolto e risorto – apparve prima a Pietro, poi ai Dodici, poi a cinquecento
fratelli tutti insieme, poi a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli, e infine aggiunge: “Ultimo fra tutti apparve anche
a me, come a un … neonato sopravissuto (alla morte della madre che l’ha partorito)” (1 Cor 15,8).
L’accenno più esplicito l’abbiamo nella lettera ai Galati e vale la pena sentire le parole esatte
dell’interessato: “Vi dichiaro, fratelli, che il vangelo da me annunziato io non l'ho ricevuto né l'ho imparato
da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un
tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel
giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni
dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si
compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare
nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e
poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Pietro, e rimasi
presso di lui quindici giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In
ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco. Quindi andai nelle regioni della Siria e della
Cilicia. Ma ero sconosciuto personalmente alle Chiese della Giudea che sono in Cristo; soltanto avevano
sentito dire: <<Colui che una volta ci perseguitava, va ora annunziando la fede che un tempo voleva
distruggere>>. E glorificavano Dio a causa mia”(1,11-24).
Quell’esperienza sulla via di Damasco ha preso – nella tradizione cristiana – il nome di “conversione di san
Paolo”. L’interessato, però, non parla affatto di conversione… forse perché non fu il risultato di un processo
psicologico, il punto di arrivo di una maturazione interiore (è questo che si intende di solito per
conversione). Il terremoto che Paolo ha sperimentato nella sua vita è stato provocato dal di fuori, e
precisamente da Gesù Cristo stesso. Colui che Paolo pensava morto si manifestò a lui risorto, e
quell’incontro fu anche per Paolo un’autentica esperienza di morte e di risurrezione. Quell’incontro,
provocato da Gesù Cristo, è la chiave per capire cosa è successo a Paolo.
Quale conversione?
Sì che possiamo parlare di conversione allora (anche se lui non ne parla), ma quella più radicale di tutte,
che non è frutto di un ripensamento personale ma iniziativa di qualcuno che è intervenuto dal di fuori: il
Signore Gesù. E questo determina davvero un sovvertimento di tutti gli ideali della persona, di tutti i suoi
criteri di riferimento. E’ su questa conversione – la più radicale di tutte – che dobbiamo riflettere, perché è
proprio questa che ha molto da dire anche alla nostra esperienza.
Di solito si parla di conversione a proposito di atei (passaggio dall’ateismo alla fede), oppure in
riferimento ai peccatori (da una vita tutta dedita al male a un’esistenza rivolta finalmente al bene); si parla
di conversione anche quando uno passa da una religione a un’altra (qui, ad essere esatti, nella religione
che quel tale abbandona si parla di apostasia, ma in quella nella quale entra si parla di conversione: in
questo senso ci sono in Italia musulmani che si sono convertiti al cristianesimo, ma anche cristiani che si
sono convertiti all’Islàm…). Ma Paolo non rientra in nessuno di questi casi. Non era affatto ateo, Paolo,
anzi: credente ebreo, e tra i più ferventi; a Dio si era già votato con passione. Non era affatto un
delinquente, un poco di buono, un peccatore che trasgrediva tutti i comandamenti… tutt’altro; nella lettera
ai cristiani di Filippi scrive: “Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne (cioè, in se stesso), io più di lui:
circonciso l'ottavo giorno, della stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla
legge; quanto a zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che deriva
dall'osservanza della legge” (Fil 3,4-6). No, non era né un ateo, né un peccatore incallito, né uno che ha
cambiato religione Paolo. Allora, di che conversione si è trattato? Lo dice lui stesso: “Ma quello che poteva
3
essere per me un guadagno (un motivo di affermazione personale) l'ho considerato una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublime opportunità di poter conoscere Cristo
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte quelle mie vecchie credenziali e le considero come
spazzatura, pur di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui: giusto e apposto non perché osservo con
scrupolo tutta la legge di Mosè e tutte le regole della tradizione, ma giusto perché mi affido senza
condizioni a Cristo: è lui che mi cambia e mi fa diventare giusto” (Fil 3,7-9).
La conversione che Paolo ha sperimentato è stato un capovolgimento proprio dentro la sua vita di
credente. A volte lo si dice come battuta, ma in realtà è vero: è più facile convertire i pagani, i peccatori,
che non i presunti giusti (credenti) che pensano di non aver bisogno di conversione… E’ così invalsa l’idea
che è chi cammina fuori strada che deve tornare sulla retta via, che quei tali che sulla retta via già pensano
di camminare, si illudono di non dover cambiare più nulla. Insomma è più difficile convertire i giusti che i
peccatori. Ecco perché quella dei giusti (o meglio, dei presunti giusti) è la conversione più difficile, più
radicale che ci sia.
Fino a quell’incontro sulla via di Damasco, Paolo era un credente zelante e appassionatamente impegnato:
sì, ma secondo i suoi gusti, i suoi parametri, i suoi modi di vedere e di valutare che – guarda caso – non
erano affatto in sintonia con quelli di Dio, né con il piano di Dio, così come l’aveva fatto conoscere Gesù.
Ed è fin troppo facile per le persone religiose, per i credenti in genere, cadere nell’illusione di piacere a Dio
perché fanno certe cose nel suo nome, perché compiono certe prestazioni a suo indirizzo, traendone una
gratificazione più o meno esaltante. Ma in realtà, al centro della loro esperienza non c’è Dio; ci sono loro
stessi, con il loro bisogno di realizzarsi secondo le loro attese e, soprattutto, con le loro stesse risorse. Dio
diventa semplicemente pretesto a tutto questo, o riempitivo – se si vuole – ma non ha modo di essere vivo
e operoso nella loro vita, perché non gli si dà spazio adeguato. Il posto di Dio è usurpato dall’io, un “io”
religioso senza dubbio, ma che finisce con l’essere la controfigura di Dio.
Quando Paolo confessa di aver vissuto da fariseo nel suo passato, è proprio questo che vuol dire. E
di questo abbiamo conferma in quella parabola evangelica che mette in scena appunto un fariseo (giusto, o
presunto tale) e un pubblicano (cioè un peccatore) in atto di pregare al tempio (Lc 18,9-12): “Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri… Io digiuno due volte la
settimana … io pago le decime di quanto possiedo”. Pregava tra sé ma in realtà si pregava addosso, non
pregava Dio. Dio era solo cassa di risonanza all’efficienza del suo io; difatti non fa che ripetere “io… io…
io”. Il peccatore, invece, fermo a distanza, che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, a Dio fa posto,
tutto il posto di cui ha bisogno per fare quell’unica cosa che solo Dio può fare, e cioè, avere pietà: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. La conclusione di Gesù è nota: “Questi tornò a casa sua giustificato, l’altro
invece no”.
Decentramento da se stessi per re-incentrarsi su Gesù Cristo.
Il capovolgimento, la conversione radicale nell’esistenza di Paolo, ha provocato un passaggio che è
davvero rivoluzionario, e che consta di due fasi successive: un decentramento da se stesso per reincentrarsi su Gesù Cristo. Da un’esistenza che ruotava attorno al suo io (con i suoi ideali, criteri e gusti
personali) a una vita al cui centro c’è Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto, con gli ideali e i criteri del suo
vangelo. E Paolo è al suo servizio. Forse quest’espressione “al suo servizio” non riscuote molto gradimento
nella nostra sensibilità moderna (noi oggi ci gloriamo di essere emancipati da tutto), ma non dimentichiamo
che l’unico davvero emancipato su tutti i fronti è Gesù Cristo, il quale - proprio perché si è fatto servo fino al
livello più basso della graduatoria – s’è conquistato il diritto di essere “Signore” totalmente affidabile, al
quale è un piacere consegnarsi senza condizioni. Con quanta soddisfazione Paolo parla del Signore Gesù
nelle sue lettere! In quella ai Romani arriva addirittura a definirsi “schiavo di Gesù Cristo”: per lui è un onore
presentarsi così… e probabilmente qui sta la vera grandezza di Paolo: nessuno è stato tanto libero come
lui; libero di fronte agli uomini, ai grandi di questo mondo, libero di fronte alle istituzioni (a partire da quelle
religiose), di fronte alle tradizioni, libero di fronte alle avversità, alle prove, di fronte alla morte stessa.
Libero anche nel senso della mentalità e della disponibilità; diceva Papa Benedetto in una delle sue
Catechesi: “L’incontro con Cristo quel giorno sulla via di Damasco ha allargato il cuore di Paolo, lo ha reso
aperto a tutti. Non ha perso nulla del bene che già c’era in lui, ma se n'è riappropriato in modo nuovo. Nello
stesso tempo, la sua ragione si è aperta alla saggezza dei popoli e delle culture; essendosi aperto a Cristo
con tutto il cuore, è divenuto capace di un dialogo ampio con tutti, è divenuto capace di farsi tutto a tutti”.
Ecco com’è libero Paolo. Libero perché “schiavo di Cristo Gesù”.
4
Quel decentramento di cui dicevo, e quel conseguente re-incentrarsi su Cristo, sapete che lui lo
esprime in quella celebre affermazione della lettera ai cristiani di Galazia: “Non sono più io che vivo: è
Cristo che vive in me”(2,20). “Per me il vivere è Cristo” scrive a quelli di Filippi (1,21).
Noi, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che siamo ancora distanti dal poter affermare qualcosa del
genere, però dobbiamo tener presente che se Paolo parla così non è per esibizionismo: è per porre davanti
alla coscienza di tutti i cristiani quello che è semplicemente l’obiettivo connaturale di ogni esperienza di
fede. E’ a questo che possiamo arrivare. Se noi siamo cristiani è per tendere a questo obiettivo.
E allora possiamo cominciare col fare di tanto in tanto una verifica e chiederci: Quali sono le nostre abituali
sicurezze? Proprio nel senso puro e semplice di ciò su cui poggiamo tutti i giorni, di ciò che ci fa alzare ogni
mattina e riprendere la nostra vita operosa, impegnata, forse anche un po’ affannata… Cos’è che ci motiva
ogni giorno? Su cosa, o su chi, contiamo al punto tale che se ci fosse sottratto perderemmo la bussola, la
serenità, il gusto di vivere? Questi interrogativi li butto lì per tutti, ci riguardano come cristiani quale che sia
il nostro stato di vita, di lavoro, di professione… ma ci riguardano soprattutto in quella dimensione di
responsabilità verso gli altri che tutti sperimentiamo: nell’ambito della famiglia, all’interno della Comunità,
specie in quelle mansioni che richiedono disponibilità di cuore, prima ancora che di cervello o di tempo.
Siamo persone religiose, certo, ma se dovessimo mettere sui piatti della bilancia la nostra operosità
personale, la nostra efficienza, il nostro impegno – da una parte – e dall’altra la considerazione e
l’importanza che attribuiamo a Gesù Cristo nel concreto del nostro vivere, quale sarebbe il piatto che pesa
di più?
E’ questione di primato, insomma, o di priorità. Sulla via di Damasco, Paolo ha capito che il primato
era molto meglio se lo riservava a Cristo, invece che a se stesso, e questa è diventata via via una
convinzione sempre più lucida e determinante, tanto che trova espressioni molto precise e molto concise
per comunicarla, come se lui se le sentisse risuonare dentro senza interruzione: “Nessuno di noi vive per
se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo,
moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore” (Rom 14,7.8).
Anche l’impegno e la vita morale respirano
Oh, non che questo significhi rinunciare all’operosità, all’iniziativa, al darsi da fare, per piombare
nell’inerzia; del resto, se c’è uno che eccelle proprio per operosità e per iniziativa agli inizi del cristianesimo,
questi è proprio Paolo. E basta osservare quanta parte delle lettere Paolo dedichi ad esortare anche i
cristiani a essere operosi, a fare il bene in tutte le maniere, e verso tutti, e in tutte le circostanze. Ma un
conto è agire in proprio, in base a progetti e programmi che abbiamo in mente noi, altro conto è operare
con zelo e diligenza su incarico di un altro, al quale diamo non solo la priorità ma soprattutto incondizionata
fiducia. Paolo è zelante, instancabile, inarrestabile… da servo – anzi – da “schiavo” di Cristo Gesù.
Primato o priorità di Gesù Cristo hanno a che vedere soprattutto con l’agire morale, cioè quel terreno
quotidiano di condotta in cui tutti produciamo opere buone e anche opere meno buone, se non
decisamente cattive. Fino al giorno di quell’incontro sulla via di Damasco, Paolo aveva sempre pensato –
da bravo fariseo – che una persona si realizza se costruisce la sua vita nel modo che piace a Dio. Ora il
modo di vivere che piace a Dio per ogni ebreo è descritto nei comandamenti; non solo: è così decisivo
realizzarsi nella vita che i comandamenti rischiano di essere parametri un po’ troppo generici; ecco che
allora, tra l’uno e l’altro, è meglio mettere altri paletti, altre regole, altri precetti: più spiccioli, più concreti… E
così, da 10 Comandamenti in partenza si arrivò a 613 precetti: tutti da osservare, non si faceva neanche un
passo senza che non ci fosse un precetto che lo regolava. La Legge, insomma: le opere della legge. E
quelli che l’osservavano con scrupolo non potevano esimersi dal sentirsi bravi e soddisfatti per la
gratificazione che ne traevano; ma a che prezzo? A prezzo di presunzione e di disprezzo per tutti quelli che
non erano come loro (come quel fariseo della parabola)? Ma allora quella bravura era molto sospetta, e la
presunzione di essere giusti davanti a Dio era tutta da mettere in discussione: ecco l’argomento che
appassiona così tanto Paolo da renderlo perfino polemico. “E’ solo la fede in Gesù Cristo che ci rende
giusti; l’osservanza della legge non può rendere giusto nessuno” (Gal 2,16).
Insomma, una cosa è puntare tutto sull’impegno (“bisogna impegnarsi” si va dicendo), sulla propria
buona volontà, sui propositi, sulle risorse personali (con l’eventualità di insuperbirsi se si riesce, o di
scoraggiarsi se non si riesce), tutt’altra cosa è affidarsi anzitutto a Gesù Cristo e sperimentare così che la
“grazia” non è una bella parola e basta, ma è energia e risorsa che viene da fuori di noi, con la quale è
possibile raggiungere certi obiettivi senza per questo montarsi la testa, e anche accettare certi fallimenti
senza sentirsi troppo a terra…
In altre parole, è la fede incondizionata in Gesù Cristo il motore dell’agire cristiano: “la fede che opera
attraverso la carità” come dice bene Paolo. E fede in Gesù Cristo – lasciatemelo ribadire – è decentrarsi da
5
sé per re-incentrarsi su di lui: ma in modo vitale, proprio nel senso di educarsi progressivamente a non
prendere nessuna iniziativa, a non fare nessuna scelta, a non assumere nessun comportamento, senza
riferirsi a lui, senza confrontarsi con lui.
Questo decentramento da sé, Paolo l’ha sperimentato subito, ancora quel giorno sulla via di
Damasco. E’ una scena perfino patetica quella che ci presenta Luca nella sua descrizione: l’intollerante
difensore delle tradizioni, abituato ad agire di sua iniziativa, ecco che riesce appena a rialzarsi in piedi e,
siccome barcolla perché è cieco, deve dipendere da altri e lasciarsi guidare per mano come un bambino…
Più decentramento di così!
Ma non solo: se vuole ricuperare la vista, ha ancora bisogno dell’intervento di qualcun altro: Anania, il
discepolo di Damasco che il Signore manda ad imporgli le mani. Il persecutore è ridotto ad aver bisogno di
coloro che perseguitava, anche se non sono audaci e pieni di iniziativa come lui, infatti è forte il contrasto
tra Saulo e questo Anania: il primo, spavaldo e perfino arrogante nella sua audacia, e l’altro che invece
trema di paura solo al sentir pronunciare il nome di Saulo! Eppure, il recupero della vista e il dono dello
Spirito è proprio attraverso di lui che Paolo l’ottiene. Comincia a sperimentare che Cristo non ha bisogno di
protagonisti, ma di collaboratori; che se poi sono anche poveri e apparentemente inadeguati, meglio
ancora. E’ un aspetto che approfondiremo meglio in un altro dei nostri incontri.
***
“Venendo a noi, ci chiediamo: che senso ha per noi l’evento vissuto da Paolo sulla via di Damasco?
Significa anzitutto che anche per noi il cristianesimo non è una nuova filosofia o una nuova morale. Cristiani siamo
soltanto se incontriamo Cristo. Certamente Egli non si mostra a noi in questo modo irresistibile, luminoso, come ha
fatto con Paolo per farne l'apostolo di tutte le genti. Ma anche noi possiamo incontrare Cristo, nella Sacra Scrittura,
nella preghiera, nella vita liturgica della Chiesa, nel servizio ai fratelli... Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire
che Egli tocca il nostro. Solo in questa relazione personale con Cristo, solo in questo incontro con il Risorto
diventiamo realmente cristiani. E così si apre la nostra ragione, si apre tutta la saggezza di Cristo e tutta la ricchezza
della verità” (Benedetto XVI°).
Il fatto sulla via di Damasco è stato definito “conversione”: conversione di san Paolo (anche la festa
del 25 gennaio infatti porta questo nome). Gli studiosi però oggi parlano più propriamente di “vocazione” o
“chiamata”: lì, quel giorno, Cristo ha chiamato Saulo a diventare Paolo, cioè l’apostolo delle nazioni; difatti,
lo dice espressamente il Signore ad Anania: “Va’ da lui: io l’ho scelto perché porti il mio nome a tutti i
popoli…”.
Io penso che, per Paolo, conversione e vocazione furono un’unica esperienza. E si tratta di una
combinazione che probabilmente vale anche per noi: quando ci si converte a Gesù Cristo nel senso che è
lui il centro dell’esistenza, viene da sé il vivere quell’esistenza come una vocazione, una missione, quale
che sia lo stato di vita o la professione che si sceglie. In questi anni si va ripetendo a iosa che “tutti i
cristiani sono missionari”… Mah, prima di tutto si dovrebbe adoperare il condizionale: “potrebbero essere
missionari”. Sì, ma se viene da sé… va bene, se invece è una forzatura, un obbligo, è meglio che non lo
siano affatto, perché allora si fa fare brutta figura anche a Gesù Cristo.
Penso che, in quest’anno di san Paolo, abbiamo l’opportunità di correggere il tiro. E’ meglio cominciare a
dire: i cristiani – tutti – cerchino di lasciare davvero a Gesù Cristo il primo posto nella loro vita. Allora verrà
da sé che si ritroveranno testimoni o missionari: senza forzature, senza pose prestabilite, ma in tutta
spontaneità. E solo allora saranno coerenti e credibili.