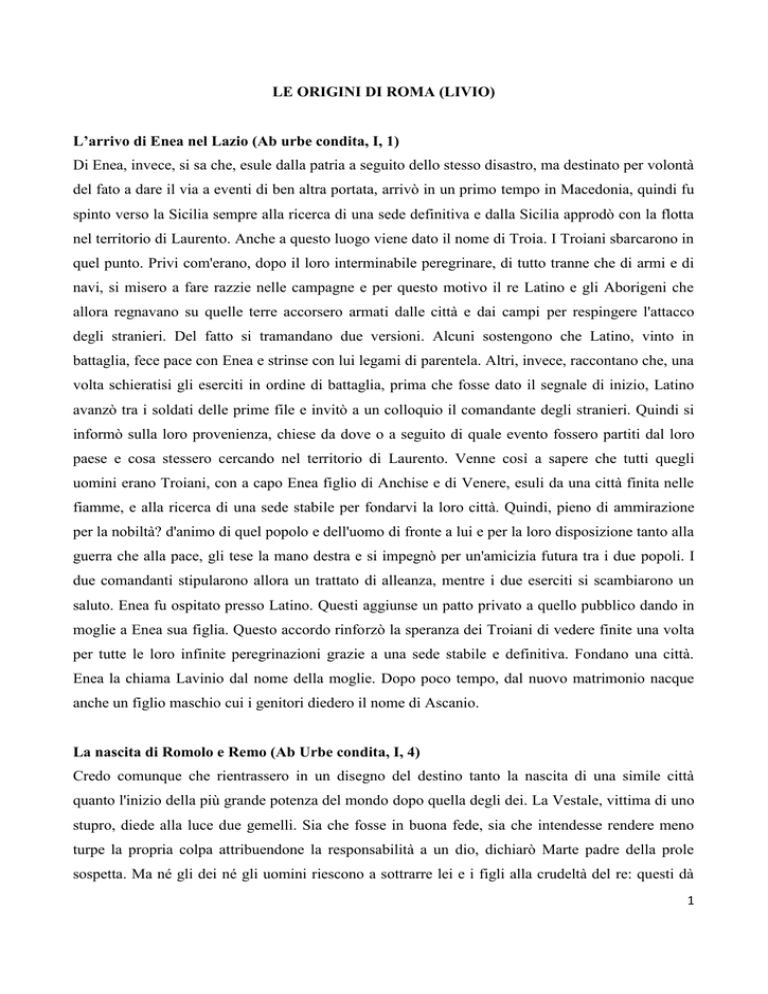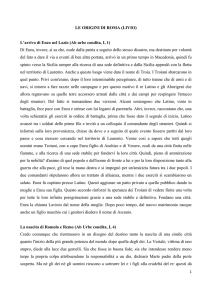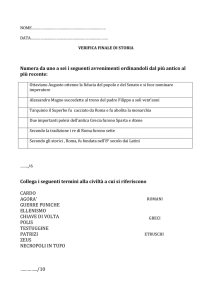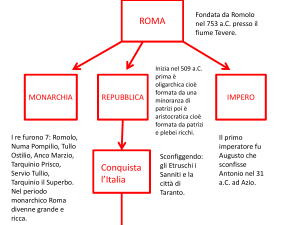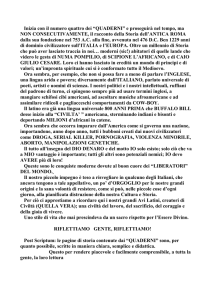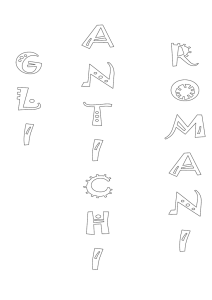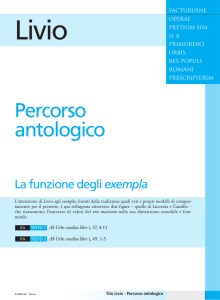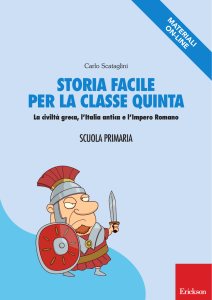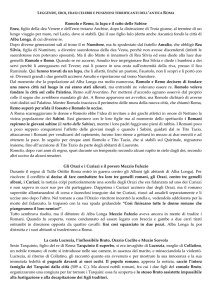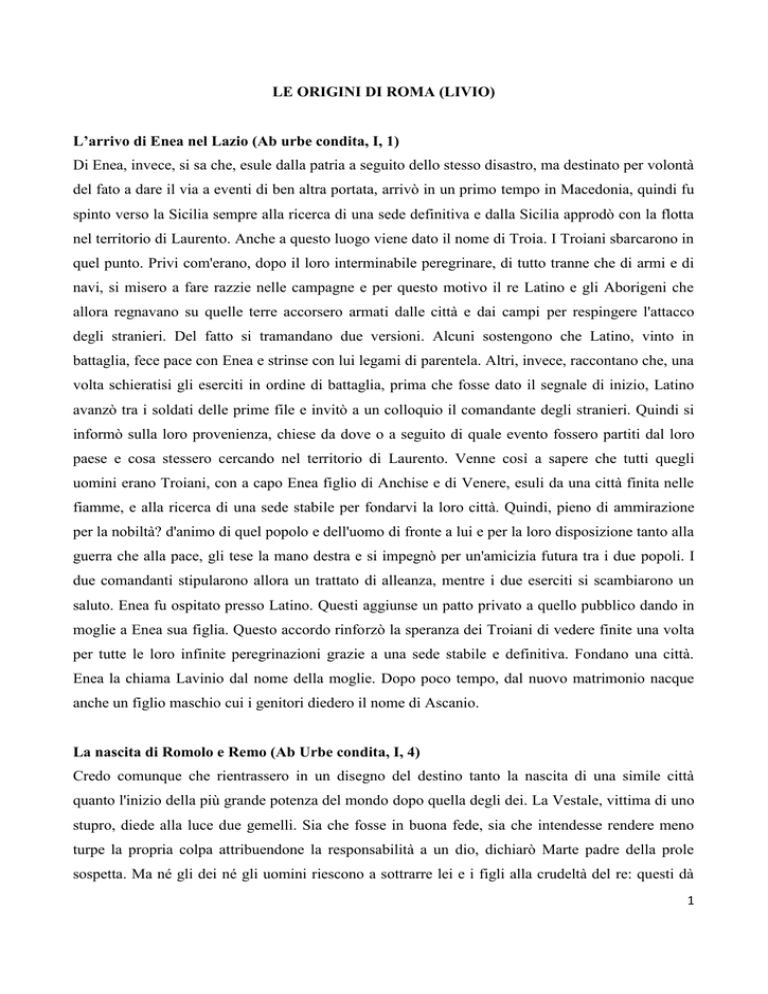
LE ORIGINI DI ROMA (LIVIO)
L’arrivo di Enea nel Lazio (Ab urbe condita, I, 1)
Di Enea, invece, si sa che, esule dalla patria a seguito dello stesso disastro, ma destinato per volontà
del fato a dare il via a eventi di ben altra portata, arrivò in un primo tempo in Macedonia, quindi fu
spinto verso la Sicilia sempre alla ricerca di una sede definitiva e dalla Sicilia approdò con la flotta
nel territorio di Laurento. Anche a questo luogo viene dato il nome di Troia. I Troiani sbarcarono in
quel punto. Privi com'erano, dopo il loro interminabile peregrinare, di tutto tranne che di armi e di
navi, si misero a fare razzie nelle campagne e per questo motivo il re Latino e gli Aborigeni che
allora regnavano su quelle terre accorsero armati dalle città e dai campi per respingere l'attacco
degli stranieri. Del fatto si tramandano due versioni. Alcuni sostengono che Latino, vinto in
battaglia, fece pace con Enea e strinse con lui legami di parentela. Altri, invece, raccontano che, una
volta schieratisi gli eserciti in ordine di battaglia, prima che fosse dato il segnale di inizio, Latino
avanzò tra i soldati delle prime file e invitò a un colloquio il comandante degli stranieri. Quindi si
informò sulla loro provenienza, chiese da dove o a seguito di quale evento fossero partiti dal loro
paese e cosa stessero cercando nel territorio di Laurento. Venne così a sapere che tutti quegli
uomini erano Troiani, con a capo Enea figlio di Anchise e di Venere, esuli da una città finita nelle
fiamme, e alla ricerca di una sede stabile per fondarvi la loro città. Quindi, pieno di ammirazione
per la nobiltà? d'animo di quel popolo e dell'uomo di fronte a lui e per la loro disposizione tanto alla
guerra che alla pace, gli tese la mano destra e si impegnò per un'amicizia futura tra i due popoli. I
due comandanti stipularono allora un trattato di alleanza, mentre i due eserciti si scambiarono un
saluto. Enea fu ospitato presso Latino. Questi aggiunse un patto privato a quello pubblico dando in
moglie a Enea sua figlia. Questo accordo rinforzò la speranza dei Troiani di vedere finite una volta
per tutte le loro infinite peregrinazioni grazie a una sede stabile e definitiva. Fondano una città.
Enea la chiama Lavinio dal nome della moglie. Dopo poco tempo, dal nuovo matrimonio nacque
anche un figlio maschio cui i genitori diedero il nome di Ascanio.
La nascita di Romolo e Remo (Ab Urbe condita, I, 4)
Credo comunque che rientrassero in un disegno del destino tanto la nascita di una simile città
quanto l'inizio della più grande potenza del mondo dopo quella degli dei. La Vestale, vittima di uno
stupro, diede alla luce due gemelli. Sia che fosse in buona fede, sia che intendesse rendere meno
turpe la propria colpa attribuendone la responsabilità a un dio, dichiarò Marte padre della prole
sospetta. Ma né gli dei né gli uomini riescono a sottrarre lei e i figli alla crudeltà del re: questi dà
1
ordine di arrestare e incatenare la sacerdotessa e di buttare i due neonati nella corrente del fiume.
Per una qualche fortuita volontà divina, il Tevere, straripato in masse d'acqua stagnante, non era
praticabile in nessun punto del suo letto normale, ma a chi li portava faceva sperare che i due
neonati venissero ugualmente sommersi dall'acqua nonostante questa fosse poco impetuosa. Così,
nella convinzione di aver eseguito l'ordine del re, espongono i bambini nel punto più vicino dello
straripamento, là dove ora c'è il fico Ruminale (che, stando alla leggenda, un tempo si chiamava
Romulare). Quei luoghi erano allora completamente deserti. Tutt'ora viva la tradizione orale
secondo la quale, quando l'acqua bassa lasciò in secco la cesta galleggiante nella quale erano stati
abbandonati i bambini, una lupa assetata proveniente dai monti dei dintorni deviò la sua corsa in
direzione del loro vagito e, accucciatasi, offrì loro il suo latte con una tale dolcezza che il pastorecapo del gregge reale - pare si chiamasse Faustolo - la trovò intenta a leccare i due neonati. Faustolo
poi, tornato alle stalle, li diede alla moglie Larenzia affinché li allevasse. C'è anche chi crede che
questa Larenzia i pastori la chiamassero lupa perché si prostituiva: da ciò lo spunto di questo
racconto prodigioso. Così nati e cresciuti, non appena divennero grandi, cominciarono ad andare a
caccia in giro per i boschi senza rammollirsi nelle stalle e dietro il gregge. Irrobustitisi così nel
corpo e nello spirito, non affrontavano soltanto più le bestie feroci, ma assalivano i banditi carichi di
bottino: dividevano tra i pastori il frutto delle rapine e condividevano con loro svaghi e lavoro,
mentre il numero dei giovani aumentava giorno dopo giorno.
Il ratto delle Sabine (Ab Urbe Condita I,9)
Già lo stato romano era così potente da essere eguale in guerra a qualunque delle città vicine ma per
mancanza di donne la grandezza era destinata a durare una sola generazione poiché non avevamo
speranza di prole in patria né matrimonio con i popoli vicini. Allora su consiglio dei senatori
Romolo mandò ambasciatori ai popoli vicini che chiedessero alleanza e matrimoni per il nuovo
popolo: anche le città come le altre non nascono dal piccolo; e poi quelle che sono aiutate dal
proprio valore e dagli dei si conquistarono una grande potenza ed una grande forza. Era ben noto
che al sorgere di Roma avevano assistito gli dei e che a Roma non sarebbe venuto meno il valore:
quindi non rifiutassero di mescolare uomini con uomini, il sangue e la stirpe. In nessun luogo
l’ambasciata fu ascoltata con favore; a tal punto disprezzavano e nello stesso tempo temevano una
così grande potenza che cresceva per sé e per i posteri. Gli ambasciatori furono congedati mentre i
più domandavano se avessero aperto un asilo anche per le donne; quello veramente sarebbe stato un
matrimonio ben combinato. I giovani romani non sopportavano questo e la situazione cominciò a
volgere decisamente verso una soluzione violenta. Per offrire ad essa tempo e luogo adatto,
2
Romolo, dissimulando il suo risentimento, prepara a bella posta dei giorni solenni, in onore di
nettuno equestre e li chiama “consuali”. Ordina poi che lo spettacolo sia annunciato ai popoli
confinanti e lo celebrano con tutta la celebrità di cui erano capaci a quei tempi per rendere
l’avvenimento splendido ed attraente. Convennero molti uomini anche per curiosità di vedere la
nuova città e specialmente tutti i più vicini, gli abitanti. E poi tutta la folla dei Sabini venne con figli
e le mogli. Invitati ospitalmente casa per casa avendo visto il luogo e le mura e la città ricca di cose,
si stupiscono che in così breve tempo la potenza romana fosse tanto cresciuta. Quando venne il
momento dello spettacolo ed erano concentratissimi sui giochi, allora secondo quanto stabilito
scoppiò un parapiglia e al segnale convenuto la gioventù romana si slancia da una parte per rapire
le vergini. Una gran parte fu rapita per caso, a seconda di colui in cui ciascuna si imbatteva; ma
alcune, le più belle destinate ai senatori, più in vista, le trasportavano a casa uomini della plebe, ai
quali era stato dato quell’incarico. Una che spiccava di gran lunga fra le altre per la bellezza
dell’aspetto, poiché molti chiedevano a chi la portassero, rapita dalla squadra di un certo Talassio,
si gridava continuamente perché nessuno la violasse e la portavano a Talassico; di qui è nato questo
grido nuziale.
Sconvolta la festa a causa della paura, i genitori delle fanciulle sdegnati si danno alla fuga,
denunciando la violazione del diritto di ospitalità ed invocando il dio, alla solennità ed ai giochi del
quale erano giunti, ingannati contro la legge religiosa e contro la parola data. Né le donne rapite
avevano miglior speranza sulla propria sorte né la loro indignazione era minore. Ma Romolo in
persona si aggirava (fra le donne) e spiegava che quell’azione era stata compiuta per la superbia dei
loro padri, che avevano negato il matrimonio ai (Romani) confinanti; esse, tuttavia, sarebbero state
spose ed avrebbero condiviso tutti i beni, la cittadinanza e – fatto di cui non esiste nulla di più
gradito al genere umano – i figli; frenassero almeno l’ira e dessero i loro animi a coloro cui il
destino già aveva dato i loro corpi.
Spesso da un’offesa nasce poi l’affetto ed avrebbero trovato i loro mariti tanto migliori, in quanto
ciascuno per parte sua avrebbe cercato, una volta compiuto a sua volta il suo compito, di colmare
anche la nostalgia dei genitori e della patria. Si aggiungevano le dolci parole dei mariti che
giustificavano l’accaduto con la passione amorosa, che sono un argomento davvero efficace a
piegare l’animo femminile.
La fine del ratto delle Sabine (Ab Urbe condita I,13)
Allora le donne sabine, a causa delle quali era scoppiata la guerra, con i capelli sciolti e le vesti
strappate, vinto dai mali il timore tipico delle donne, osarono gettarsi fra i dardi che volavano,
3
separare le schiere nemiche dopo aver essersi gettate in mezzo dal lato, e porre fine alle ire,
pregando da una parte i padri e dall'altra i figli, che non le macchiassero col sangue nefando dei
suoceri e dei generi e che non insozzassero col parricidio i propri figli, i primi la discendenza dei
nipoti, i secondi quella dei figli. "Se vi danno fastidio la parentela che esiste tra di voi ed il
matrimonio, volgete le vostre ire contro di noi: noi siamo la causa della guerra, noi delle ferite e
delle morti per mariti e genitori. Faremo meglio a morire piuttosto che vivere vedove od orfane di
uno o l'altro di voi". Questo gesto commuove sia la folla che i comandanti: calano improvvisi il
silenzio e la quiete. Poi avanzano i comandanti per stipulare un patto; e non siglano solamente la
pace, ma creano una sola città da due che erano. Associano i due regni, portano tutto il potere a
Roma. Così, resa duplice la città, perché qualcosa fosse concesso anche ai Sabini, presero il nome di
Quiriti dai Curii.
La scomparsa di Romolo (Ab Urbe condita, I, 16)
Dopo aver compiuto queste opere immortali, mentre teneva un’assemblea al campo (Marzio) presso
la palude della Capra, per passare in rassegna l’esercito, una tempesta scoppiata all’improvviso con
gran fragore e tuoni avvolse il re con una nuvola così spessa che tolse la vista di lui all’assemblea; e
Romolo non fu più in terra. I giovani Romani, quando infine si calmò la paura, dopo che da una
tempesta così oscura tornò la luce chiara e serena, quando videro vuoto il trono del re, anche se
avevano abbastanza fiducia nei senatori, che avevano occupato le posizioni a lui più vicine (e che
affermavano) che (Romolo) fosse stato rapito al cielo dalla tempesta, tuttavia, quasi colpiti dal
terrore di essere rimasti senza padre, per un po’ di tempo rimase in triste silenzio. Poi, quando un
piccolo gruppo iniziò, tutti insieme invitano a salutare Romolo come dio nato da un dio, re e padre
della città di Roma; con preghiere invocano il suo favore, affinché protegga sempre, benevolo e
propizio, la sua progenie.
Prime voci sulla scomparsa (Ab Urbe condita, I, 16)
Credo che vi fossero fin d’allora alcuni che, pur senza dirlo apertamente, pensavano che il re fosse
stato fatto a pezzi per mano dei senatori; anche questa voce si diffuse, ma in modo assai oscuro;
l’ammirazione per Romolo e la presente situazione di incertezza diedero credito all’altra voce. Si
dice che fu aggiunta credibilità all’accaduto anche dall’accorgimento di un uomo. Infatti Proculo
Iulio, mentre la città era angustiata per la nostalgia del re ed era ostile ai senatori, si fece avanti
nell’assemblea come autorevole testimone di un fatto pur straordinario. “Romolo – disse – o Quiriti,
4
padre di questa città, alle prime luci dell’alba di oggi, calatosi giù dal cielo improvvisamente mi si è
presentato.
Romolo viene divinizzato (Ab Urbe condita, I, 16)
Poiché io, pieno di sacro terrore ed in atto di riverenza, ero rimasto immobile, pregandolo che mi
fosse lecito guardarlo in volto, mi disse: “Va’, annuncia ai Romani che i celesti vogliono che la mia
Roma sia capitale del mondo; coltivino dunque l’arte militare, sappiano e tramandino ai discendenti
che nessuna potenza umana può resistere alle armi dei Romani.” E, dopo aver detto queste parole –
disse – se ne andò in cielo”. E’ straordinario quanto credito sia stato dato a quell’uomo che
annunciava queste parole e quanto sia stato lenito il rimpianto di Romolo presso la plebe e
l’esercito, una volta diffusa la certezza della sua immortalità.
Orazi e Curiazi (Ab urbe condita I, 25 - 26)
Concluso il fatto, così come si era convenuto, i tre gemelli prendono le armi. Mentre i loro li esortavano da
entrambe le parti, ( dicendo ) che gli dei patrii, la patria e i genitori, i cittadini in patria ed in armi avevano
allora gli occhi rivolti alle loro armi ed alle loro mani, fieri per loro propria natura e confortati dalle voci di
chi li esortava, avanzano in mezzo alle due schiere. I due eserciti avevano preso posto da entrambe le parti
davanti al proprio accampamento, liberi più dal presente pericolo che dall’ansia; certamente era in
discussione un potere posto nel valore e nella fortuna di così pochi. Così dunque in piedi e pieni di ansia
rivolgono l’attenzione ad uno spettacolo per niente gradito.
Viene dato il segnale, e con le minacciose armi a tre per parte i giovani, come schiere, con l’ordine dei grandi
eserciti, si slanciano. Né a questi né a quelli si presenta all’animo il proprio pericolo, ma il potere pubblico e
la pubblica schiavitù e la sorte futura della patria sarebbe stata quella che essi stessi avevano fatto. Grande
orrore prende i presenti, non appena, al primo assalto, le armi risuonarono e brillarono le spade scintillanti, e,
poiché la speranza non piegava da nessuna parte, le voci ed il respiro erano paralizzati. Venuti alle mani,
quando ormai si vedevano non soltanto i movimenti dei corpi ed il reciproco balenare di dardi e scudi, ma
anche le ferite ed il sangue, dopo aver ferito i tre Albani, due Romani morendo caddero l’uno sull'altro.
Quando l’esercito degli Albani esultò di gioia per la loro caduta, ormai ogni speranza, ma non ancora la
preoccupazione, avevano abbandonato le legioni romane, sbigottite per la sorte di quel solo che i tre Curiazi
avevano circondato. Per caso costui era incolume, e come da solo non era in grado di combattere contro tutti,
così tuttavia era abbastanza forte da combattere contro ciascuno. Quindi cercò di fuggire per poterli
combattere separatamente, pensando che l’avrebbero inseguito, come a ciascuno lo consentiva il corpo ferito.
Si era ormai allontanato di un certo tratto dal luogo dove si era combattuto, quand’ecco che, guardando
indietro, vede che gli inseguitori sono a grandi distanza tra loro; uno non era molto distante da lui. Tornò
verso quest’ultimo caricandolo, e mentre l’esercito albano esorta i Curiazi a portare aiuto al fratello, ormai
5
l’Orazio, ucciso il nemico, vincitore si dirigeva verso il secondo combattimento. Allora i Romani esortano il
loro soldato con le urla tipiche dei sostenitori all’improvviso. Ed egli si affretta a porre fine al
combattimento. Prima dunque che il terzo, che non era molto lontano, potesse raggiungerlo, uccide anche il
secondo Curiazio; ormai ad armi pari uno per parte era rimasto, ma non erano pari speranze e forze. Il corpo
senza ferite e la duplice vittoria rendevano il Romano sicuro per il terzo combattimento; l’altro, trascinando
il corpo stanco per la ferita e per la corsa e avvilito dalla strage dei fratelli ( morti ) prima di lui, si abbandona
al nemico vincitore. E quello non fu un combattimento. Il Romano, esultante, disse: “Due li ho offerti ai
Mani dei miei fratelli; il terzo lo darò alla causa di questa guerra, perché i Romani governino sugli Albani”.
Conficca la spada nella gola dell’altro, che sostiene a stento le armi. Lo spoglia una volta morto a terra. I
Romani esultanti e congratulandosi accolgono l’Orazio con gioia tanto maggiore quanto più la situazione era
stata disperata. Si accingono alla sepoltura dei propri morti con animi ben diversi, perché gli uni erano
cresciuti in potere, gli altri erano divenuti soggetti al dominio straniero. I sepolcri esistono ancora, proprio
dove ciascuno è caduto, due romani in un luogo vicino ad Alba, tre albani nelle vicinanze di Roma, ma
distanti tra loro, come appunto si combatté. L’Orazio se ne andava davanti a tutti, portando in mostra davanti
a sé le spoglie appartenenti ai tre gemelli; e la sua giovane sorella, che era stata promessa sposa ad uno dai
Curiazi , gli venne incontro davanti alla porta Capena e, riconosciuto il mantello del fidanzato – che aveva
fatto lei stessa – sopra le spalle del fratello, si sciolse i capelli e piangendo chiama per nome il fidanzato
morto. Il pianto della sorella, nel momento della vittoria e di una così grande felicità pubblica, suscita l’ira
del fiero giovane. Impugnata dunque la spada, maledicendola nello stesso momento a parole, trafigge la
ragazza. “Vattene ora da qui con il tuo inopportuno amore, dimentica dei fratelli morti e di quello vivo,
dimentica della patria – disse – e così se ne vada qualunque donna romana piangerà per un nemico!”.
L’azione sembrò atroce ai senatori ed alla plebe, ma il merito recente rendeva meno orribile l’accaduto.
Tuttavia fu condotto in giudizio davanti al re.
Lucrezia la casta e la fine della monarchia (Ab Urbe condita, I, 57-59)
I Rutuli possedevano Ardea, città molto fiorente e ricca per quei tempi e per quelle contrade; e
proprio questa era stata la causa della guerra, che il re di Roma, consumato il patrimonio nelle spese
per le grandiose opere pubbliche, cercava sia di rinsanguare le sue sostanze, sia di placare con
largizioni di bottino gli animi del popolo, avverso alla monarchia, oltre che per l'arroganza tirannica
di Tarquinio, anche perchè irritato di essere stato impiegato così a lungo dal re in mestieri da
operaio e in lavori servili. I Romani tentarono di prendere Ardea subito d'assalto, ma essendo fallito
il tentativo cominciarono a stringere i nemici d'assedio costruendo opere di fortificazione. In questa
vita di accampamento, come suole avvenire nelle guerre più lunghe che aspre, venivano facilmente
concesse licenze, agli ufficiali più che ai soldati, e i giovani figli del re spesso passavano il tempo in
banchetti e gozzoviglie. Una volta, mentre stavano bevendo nella tenda di Sesto Tarquinio, e
6
partecipava al banchetto anche Collatino, figlio di Egerio, il discorso cadde sulle mogli, e ciascuno
celebrava la sua con le maggiori lodi. Essendosi accesa la discussione, Collatino disse che le parole
erano vane: in poche ore potevano rendersi conto di quanto la sua Lucrezia fosse superiore alle
altre. "Siamo giovani e vigorosi: perché non montiamo a cavallo e non andiamo a constatare coi
nostri occhi la virtù delle nostre donne? La miglior prova per tutti sarà lo spettacolo che ci
offriranno mentre non si aspettano l'arrivo del marito". Riscaldati dal vino tutti gridano:
"Benissimo, andiamo", e spronati i cavalli volano a Roma. Giunti qua al calar delle tenebre, si
dirigono successivamente a Collazia, dove trovano Lucrezia non trascorrere il tempo in banchetti e
divertimenti con le compagne, come avevano visto fare le nuore del re, ma a notte inoltrata intenta a
filare la lana, seduta in mezzo alla casa tra le ancelle veglianti al lume di una lucerna. La palma di
quella gara femminile toccò a Lucrezia. Essa accoglie benevolmente il marito che giunge in casa e i
Tarquini, e Collatino vincitore invita cortesemente i figli del re a trattenersi. Qui Sesto Tarquinio
vien preso dalla brama di far violenza a Lucrezia: sono stimolo alla libidine sia la bellezza, e sia la
provata pudicizia. Ma per allora dopo quel notturno svago giovanile ritornano nel campo.
Alcuni giorni dopo Sesto Tarquinio all'insaputa di Collatino si reca a Collazia con un solo uomo di
scorta. Quivi accolto benevolmente da quelli di casa, ignari del suo proposito, dopo la cena fu
condotto nella stanza degli ospiti; quando, acceso dal desiderio, gli parve che tutto fosse tranquillo
all'intorno e la casa fosse immersa nel sonno, impugnata la spada entrò dove Lucrezia dormiva, e
con la sinistra ferma sul petto della donna disse: "Taci, Lucrezia: sono Sesto Tarquinio; ho in mano
la spada: se mandi un grido sei morta". Mentre la donna sorpresa nel sonno e impaurita non scorge
aiuto in alcuna parte, ma solo la morte starle sul capo, Tarquinio le dichiara il suo amore, la
supplica, unisce alle preghiere le minacce, con ogni mezzo tenta l'animo della donna. Quando la
vide ostinata non piegarsi neppure dinanzi alla minaccia di morte, aggiunge alla paura il disonore:
dice che avrebbe posto vicino al suo cadavere uno schiavo nudo sgozzato, perché la credessero
uccisa
in
vergognoso
adulterio.
Vinta
con
questa
minaccia
l'ostinata pudicizia, la libidine fu in apparenza vincitrice, e Tarquinio se ne partì fiero di aver
espugnato l'onore di una donna; frattanto Lucrezia dolente per tanta sventura mandò un messaggero
a Roma presso il padre e ad Ardea dal marito, pregandoli di venire coll'amico più fido: la cosa era
necessaria e urgente perché era capitata un'orribile sciagura. Spurio Lucrezio andò accompagnato da
Publio Valerio, figlio di Voleso, e Collatino da Lucio Giunio Bruto, col quale per caso si trovava
mentre recandosi a Roma si era imbattuto nel messaggero della moglie. Trovano Lucrezia seduta
mesta nella sua stanza. All'arrivo dei suoi cari le spuntano le lacrime, e alla domanda del marito "Va
tutto bene?" ."No", rispose; "qual bene infatti rimane ad una donna quando sia perduto l'onore ? Nel
7
tuo letto, o Collatino, vi sono le impronte di un altro uomo; però solo il corpo è stato violato,
l'animo è innocente: la morte ne sarà la prova. Ma datemi la mano e la parola che l'adultero non sarà
impunito. E Sesto Tarquinio, che da ospite divenuto nemico la notte scorsa con la violenza e con le
armi ha colto qui un piacere esiziale per me, ma anche per lui, se voi siete uomini". Tutti uno dopo
l'altro dànno la loro parola, e cercano di consolare l'afflitta riversando ogni colpa da lei costretta
sull'autore del misfatto: solo l'anima può peccare, non il corpo, e la colpa manca dove sia mancata la
volontà. "A voi", rispose, "spetterà il giudicare qual pena a colui sia dovuta; quanto a me, se anche
mi assolvo dal peccato, non mi sottraggo alla pena: nessuna donna in futuro vivrà disonorata
seguendo l'esempio di Lucrezia". Si infisse nel cuore un coltello che teneva celato sotto la veste, e
abbattutasi morente sulla ferita cadde al suolo. Il marito e il padre levano alte grida.
Mentre
quelli
si
abbandonano
al
dolore,
Bruto
estratto dalla ferita di Lucrezia il coltello grondante sangue e tenendolo davanti a sé dice: "Per
questo sangue, castissimo prima del regio oltraggio, giuro e invoco voi a testimoni, o dei, che
caccerò col ferro, col fuoco, e con qualunque altro mezzo mi sia possibile Lucio Tarquinio Superbo,
insieme alla scellerata consorte e a tutta la discendenza dei figli, né sopporterò che costoro od alcun
altro regni in Roma ". Consegna poi il coltello a Collatino, e successivamente a Lucrezio e a
Valerio, stupefatti per quel miracolo, che si chiedevano donde mai nascesse quel nuovo animo nel
petto di Bruto. Giurano come loro era stato prescritto, e dal dolore passati interamente all'ira
seguono la guida di Bruto che già li invita a dar l'assalto al regno. Portato fuori della casa il corpo di
Lucrezia lo espongono nel foro, e accendono gli animi del popolo, come suole avvenire, con lo
stupore e l'indignazione per l'inaudito misfatto: ciascuno per parte sua deplora la scellerata violenza
della stirpe regia. Li commuovono sia il dolore del padre, sia le parole di Bruto che biasima i pianti
ed i vani lamenti, e li esorta ad agire come si conviene a uomini ed a Romani, prendendo le armi
contro chi si è comportato da nemico. Tutti i giovani più animosi si presentano volontari con le
armi; gli altri seguono il loro esempio. Quindi, lasciato un presidio a Collazia e poste sentinelle alle
porte per evitare che qualcuno porti la notizia della sommossa al re, gli altri armati agli ordini di
Bruto partono per Roma. Appena giunta colà, ovunque avanza quella turba armata getta lo
scompiglio
e
la
paura;
ma
quando
poi
i
Romani vedono che marciano alla testa i migliori fra i cittadini, pensano che non si tratti di un gesto
sconsiderato qualunque ne sia la causa. Un misfatto così esecrando desta non minor emozione a
Roma che a Collazia: da tutte le parti della citta si accorre al foro. Come si giunse qua il banditore
convocò l'assemblea popolare in nome del comandante della cavalleria, carica che Bruto allora
rivestiva. Egli tenne qui un discorso che non pareva affatto proprio di quell'animo e di quell'ingegno
8
che aveva simulato fino a quel giorno: ricordò la violenza e la libidine di Sesto Tarquinio, il
nefando oltraggio e la pietosa fine di Lucrezia l'orbità di Tricipitino, cui la causa della morte della
figlia era ancor più dura e lacrimevole della morte stessa. Parlò poi della tirannia del re, delle
miserie e delle fatiche della plebe sprofondata a scavare fosse e cloache: gli uomini di Roma,
vincitori
di
a
i
fare
tutti
muratori
i
e
popoli
gli
vicini,
scalpellini,
erano
da
guerrieri
stati
che
ridotti
erano.
Ricordò ancora l'infame uccisione del re Servio Tullio, la figlia che era passata coll'empio cocchio
sul corpo del padre ed invocò le divinità vendicatrici dei genitori. Con questi argomenti, e, credo,
con altri anche più forti, che l'indignazione del momento suggeriva, ma che non è facile agli storici
tramandare esattamente, infiammò la folla, e la indusse a privare il re del potere e ad intimare
l'esilio a Lucio Tarquinio insieme con la moglie ed i figli. Bruto stesso, arruolati ed armati i giovani
che si offrivano volontari, partì per il campo di Ardea con l'intenzione di sollevare contro il re
l'esercito; lasciò il potere in Roma a Lucrezio, che già prima era stato nominato dal re governatore
della città. Allo scoppio della sommossa Tullia fuggì dalla reggia, e dovunque passava uomini e
donne la maledicevano e invocavano su di lei le furie vendicatrici del padre.
L'assalto notturno dei Galli a Roma (Ab Urbe condita, V, 47)
Mentre a Veio si discutevano questi fatti, nel frattempo la rocca romana ed il Campidoglio furono in
grande pericolo. Infatti i Galli, sia che avessero notato tracce del passaggio di un uomo dove il
messaggero era giunto da Veio, sia che si fossero accorti di una roccia adatta alla scalata presso il
tempio di Carmenta, durante la notte molto chiara, dopo aver mandato avanti un uomo che, senza
armi, tentasse al via, consegnando poi loro le armi dove ci fosse qualche difficoltà, gli uni con gli
altri, spingendosi e sollevandosi a vicenda e trascinandosi l'uno con l'altro, come il luogo
richiedeva, in tanto silenzio raggiunsero di soppiatto la cima che ingannarono non solo le sentinelle,
ma non svegliarono neppure i cani, che pure sono animali che si svegliano facilmente per i rumori
notturni.
Le oche salvano Roma (Ab Urbe condita, V, 47)
Non ingannarono le oche che, per il fatto di essere sacre a Giunone, anche nell'estrema scarsità di
cibo tuttavia venivano risparmiate. E questo fatto garantì la salvezza; infatti M. Manlio, che tre anni
prima era stato console, uomo di ottima disciplina militare, svegliato dal loro starnazzare e dal
rumore delle ali, afferrate le armi, si precipita risoluto chiamando tutti gli altri alle armi e mentre gli
altri si preparano in fretta colpisce con l'umbone e fa precipitare un Gallo che già si era fermato
9
sulla sommità. Mentre dunque la caduta di costui, che era scivolato, travolgeva quelli più vicini,
abbatte altri Galli impauriti che, abbandonate le armi, abbracciavano le rocce alle quali tentavano di
aggrapparsi con le mani. Ormai altri riunitisi procuravano confusione ai nemici con dardi, frecce e
sassi, e al schiera dei nemici al completo, travolta dalla caduta, cade a precipizio. Una volta messa
fine alla confusione, il resto della notte fu dedicato al riposo, per quanto era possibile nelle menti
sconvolte, poiché il pericolo passato li teneva in ansia.
10