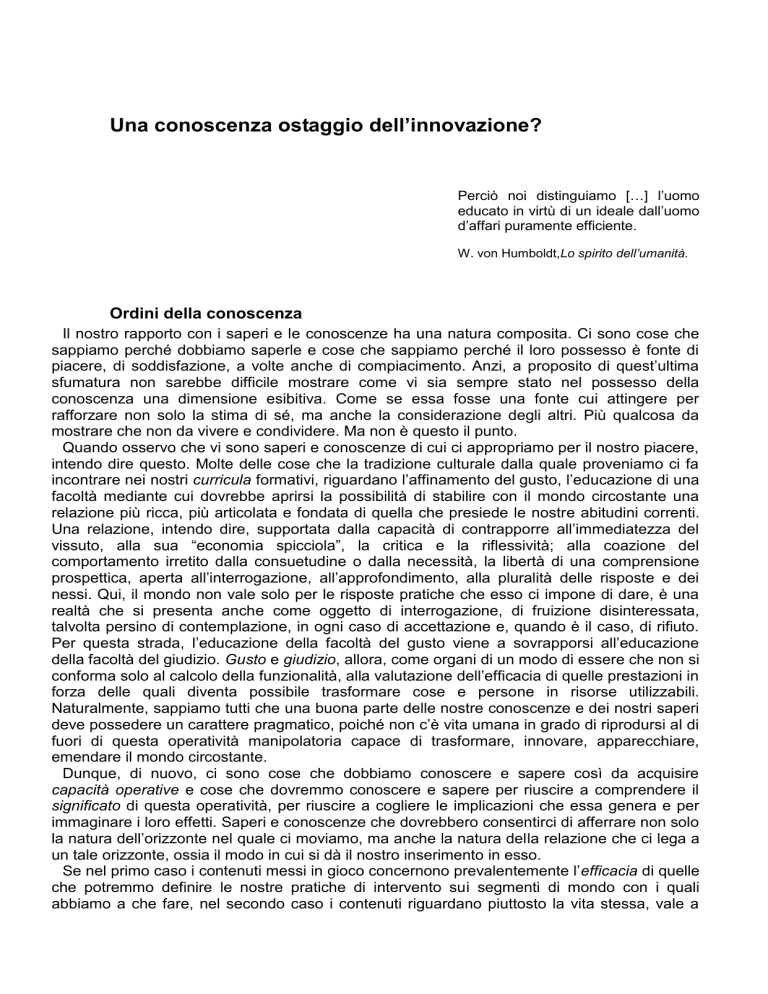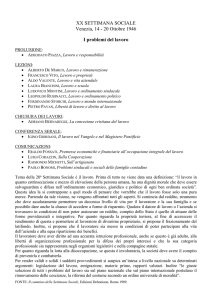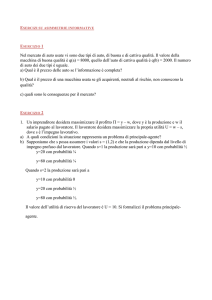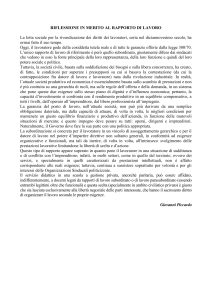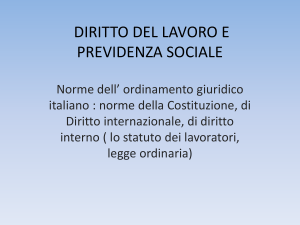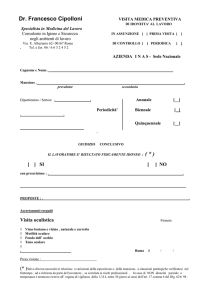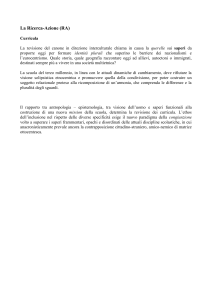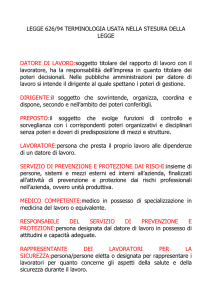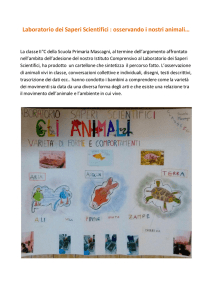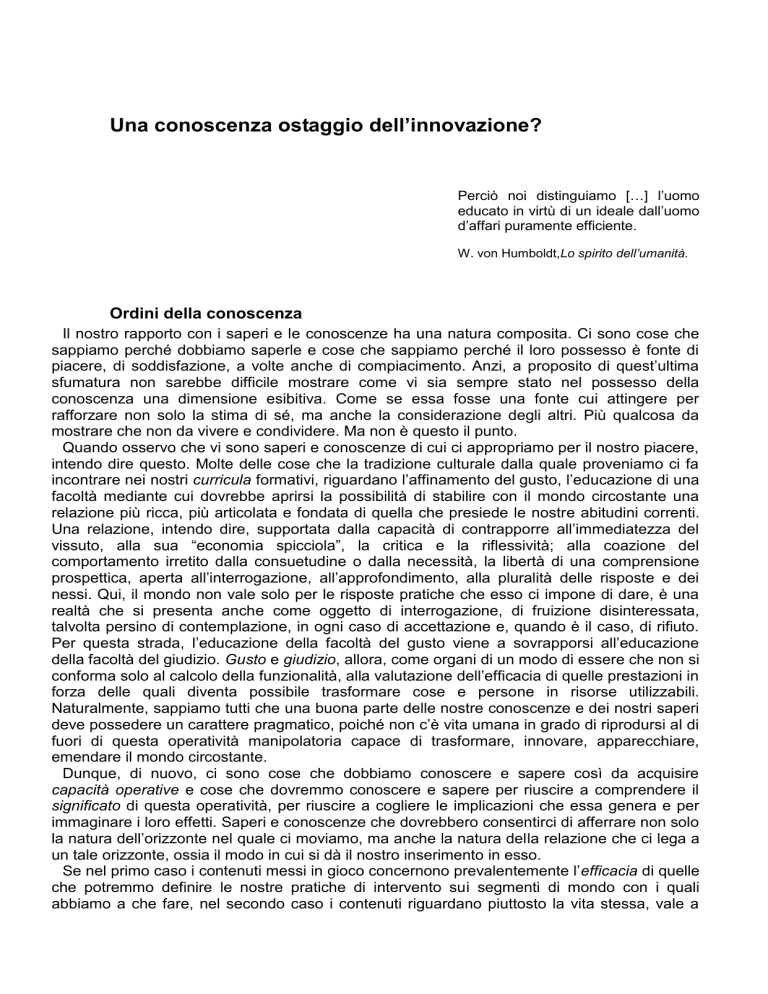
Una conoscenza ostaggio dell’innovazione?
Perciò noi distinguiamo […] l’uomo
educato in virtù di un ideale dall’uomo
d’affari puramente efficiente.
W. von Humboldt,Lo spirito dell’umanità.
Ordini della conoscenza
Il nostro rapporto con i saperi e le conoscenze ha una natura composita. Ci sono cose che
sappiamo perché dobbiamo saperle e cose che sappiamo perché il loro possesso è fonte di
piacere, di soddisfazione, a volte anche di compiacimento. Anzi, a proposito di quest’ultima
sfumatura non sarebbe difficile mostrare come vi sia sempre stato nel possesso della
conoscenza una dimensione esibitiva. Come se essa fosse una fonte cui attingere per
rafforzare non solo la stima di sé, ma anche la considerazione degli altri. Più qualcosa da
mostrare che non da vivere e condividere. Ma non è questo il punto.
Quando osservo che vi sono saperi e conoscenze di cui ci appropriamo per il nostro piacere,
intendo dire questo. Molte delle cose che la tradizione culturale dalla quale proveniamo ci fa
incontrare nei nostri curricula formativi, riguardano l’affinamento del gusto, l’educazione di una
facoltà mediante cui dovrebbe aprirsi la possibilità di stabilire con il mondo circostante una
relazione più ricca, più articolata e fondata di quella che presiede le nostre abitudini correnti.
Una relazione, intendo dire, supportata dalla capacità di contrapporre all’immediatezza del
vissuto, alla sua “economia spicciola”, la critica e la riflessività; alla coazione del
comportamento irretito dalla consuetudine o dalla necessità, la libertà di una comprensione
prospettica, aperta all’interrogazione, all’approfondimento, alla pluralità delle risposte e dei
nessi. Qui, il mondo non vale solo per le risposte pratiche che esso ci impone di dare, è una
realtà che si presenta anche come oggetto di interrogazione, di fruizione disinteressata,
talvolta persino di contemplazione, in ogni caso di accettazione e, quando è il caso, di rifiuto.
Per questa strada, l’educazione della facoltà del gusto viene a sovrapporsi all’educazione
della facoltà del giudizio. Gusto e giudizio, allora, come organi di un modo di essere che non si
conforma solo al calcolo della funzionalità, alla valutazione dell’efficacia di quelle prestazioni in
forza delle quali diventa possibile trasformare cose e persone in risorse utilizzabili.
Naturalmente, sappiamo tutti che una buona parte delle nostre conoscenze e dei nostri saperi
deve possedere un carattere pragmatico, poiché non c’è vita umana in grado di riprodursi al di
fuori di questa operatività manipolatoria capace di trasformare, innovare, apparecchiare,
emendare il mondo circostante.
Dunque, di nuovo, ci sono cose che dobbiamo conoscere e sapere così da acquisire
capacità operative e cose che dovremmo conoscere e sapere per riuscire a comprendere il
significato di questa operatività, per riuscire a cogliere le implicazioni che essa genera e per
immaginare i loro effetti. Saperi e conoscenze che dovrebbero consentirci di afferrare non solo
la natura dell’orizzonte nel quale ci moviamo, ma anche la natura della relazione che ci lega a
un tale orizzonte, ossia il modo in cui si dà il nostro inserimento in esso.
Se nel primo caso i contenuti messi in gioco concernono prevalentemente l’efficacia di quelle
che potremmo definire le nostre pratiche di intervento sui segmenti di mondo con i quali
abbiamo a che fare, nel secondo caso i contenuti riguardano piuttosto la vita stessa, vale a
dire la comprensione che l’esistenza ha di sé nella sua relazione con il mondo all’interno del
quale essa accade. Da una parte, dunque, ci sono i saperi che aumentano il nostro potere di
adattamento alle situazioni del mondo, dall’altra i saperi che aumentano il nostro potere di
riflessione sulle situazioni del mondo, il potere di distanziarci dalle risposte più o meno efficaci
che siano in grado di attivare al loro cospetto: un potere che, prima di ogni altra cosa, è potere
dell’individuo su se stesso.
Si tratta di due modalità della conoscenza inscritte all’interno di finalità molto diverse, così
come diverse sono le motivazioni alla base degli investimenti e delle risorse necessari a
promuoverle. Diverso è però, in primo luogo, il potere di affermazione delle rispettive finalità e
la rispettiva capacità di attrarre investimenti e risorse. Ora, parlare di finalità, di investimenti e
di risorse, in questo caso, significa giocoforza sottrarsi a qualsiasi tentazione idealista. Perché
il riferimento alla loro realtà, colloca immediatamente il discorso al cospetto delle logiche da
cui, sempre, dipendono la nascita, l’incremento e lo sviluppo di saperi e conoscenze. Se si
tiene presente questo punto, sarà allora più facile riconoscere dietro la produzione della
conoscenza, la presenza di soggetti collettivi che rispondono a interessi, si rifanno a valori,
traducono nelle loro azioni un disegno di società ritenuta auspicabile, in quanto funzionale e
pertinente al dispiegarsi di determinate congiunture. Sono tutti quei “portatori di interesse” che
nel contesto delle società attuali – dove, come vedremo, anche la conoscenza tende sempre
più ad assumere lo statuto della merce - intervengono sulle politiche di sviluppo dei saperi in
base ad un sistema di attese al cui potere di promozione corrisponde un non meno rilevante
potere di inibizione. Ed è proprio a questo livello che intervengono i poteri, ossia che i poteri
interagiscono con i saperi. La “società della conoscenza” esemplifica perfettamente questa
logica. Basti pensare al fenomeno che essa interpreta come il suo principale asse portante:
l’innovazione.
L’innovazione
Sul versante degli investimenti e delle risorse, l’innovazione è un desideratum che canalizza
energie e progettualità, un obiettivo delle società avanzate sul quale convergono politica e
economia, formazione e impresa, un obiettivo capace quindi di mobilitare, ancor prima che
capitali, discorsi, programmi, auspici, visioni del mondo condivise. Un insieme di disposizioni,
quindi, che ne fa un fattore decisivo, se non il fattore principale, della produzione di
conoscenze. Altra cosa è osservare che questo straordinario catalizzatore di consensi genera,
oggi, forme di conoscenza che stabiliscono però con il reale una relazione ambigua, se è vero
che per il suo tramite viene messo in gioco al contempo l’elemento del superamento e quello
della conservazione. “Superamento” per quanto concerne i risultati cui l’innovazione approda:
nuovi oggetti, nuove forme, nuovi design, nuovi materiali, incremento della potenza, della
velocità, delle prestazioni, delle funzioni e dell’efficienza dei risultati prodotti. “Conservazione”,
invece, per quanto concerne i meccanismi di subordinazione della società al mercato,
secondo quel tipico movimento di trasformazione delle varie istituzioni umane in semplici
accessori delle leggi del mercato, che Karl Polanyi, nei suoi studi degli anni ’40, riconosceva
come l’elemento capitale dell’affermazione, a partire dal XVIII secolo, dell’economia di
mercato1.
Sul versante delle finalità, poi, l’innovazione, in quanto obiettivo principale degli investimenti
nel campo della conoscenza, si presenta come uno fra i più rilevanti dispositivi di
concorrenzialità, di eccellenza e di crescita economica. Il che, come si capisce, costituisce una
potentissima cornice generativa di affermazione e di sviluppo delle conoscenze stesse. E
1
Cfr. K. Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca
(1944), tr. it., Einaudi, Torino 1974, pp. 88-98.
questo, in ragione della sua capacità, non solo di orientarle, ma anche di gerarchizzarle, di
selezionarle e, quindi, in ultima analisi, di produrle.
E’ un orientamento, questo, che si lascia cogliere bene nell’attuale riorganizzazione delle
Università e dei centri di ricerca pubblici. La gestione del transfert della conoscenza prodotta
al loro interno in direzione delle imprese – uno dei nuovi compiti cui sono chiamati -, modifica
radicalmente il profilo della ricerca e della conoscenza, introducendo parametri di
orientamento al mercato e, in generale, al risultato che tendono a delegittimare quelli che
potremmo chiamare i “saperi senza programmazione del fine”. Cioè i saperi che non nascono
da una relazione perspicua, controllabile e pianificabile, tra attività di ricerca e pianificazione
dei risultati. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che interviene in profondità,
raggiungendo le motivazioni stesse della conoscenza e della ricerca: una trasformazione, direi
persino, che agisce sulla stessa libido sciendi. E questo perché, a monte delle questioni
sollevate dalla gestione del transfert, a cui oggi il sapere è chiamato con forza, vi è l’azione
stessa dell’imperativo del transfert sull’indirizzo della conoscenza: la trasferibilità come
principio operativo della politica della conoscenza, con i suoi effetti “riformisti”
sull’organizzazione degli studi, degli insegnamenti e soprattutto della ricerca.
Se al riguardo ho parlato di “libido sciendi” è perché non è difficile vedere come ciò che è in
gioco in questa trasformazione è il valore stesso della operazione conoscitiva, il valore
conseguibile dalla conoscenza nella misura in cui vi è qualcosa in relazione al quale essa
acquista un senso che, da sé, non è più in grado di garantire; qualcosa solo al cui cospetto
essa è abilitata a valere.
Le due forme di conoscenza cui ho fatto riferimento nel paragrafo precedente identificano in
modo molto diverso questo “qualcosa”. Anche la legittimazione che ne traggono è, però, a sua
volta, del tutto diversa. Per capire come si costruisce questa duplice differenza, dobbiamo
guardare da vicino la congiuntura nella quale essa si è affermata.
Contesto
Siamo oggi confrontati a un’articolazione di poteri in ragione della quale la solidarietà
venutasi a creare tra produzione e conoscenza, lavoro e formazione tende ad esautorare
dall’universo dei saperi una certa idea di cultura. Come si è giunti a questa situazione?
Possiamo dire, per ora, che l’odierna centralità della dimensione del lavoro, a seguito delle
trasformazioni intervenute negli ultimi anni nella sfera della produzione, dove l’incremento del
profitto è misurato come ritorno economico a brevissimo termine, si rivolge alla formazione
con alcune domande precise rispetto alle quali conoscenze e saperi possono rispondere solo
a condizione di spogliarsi di alcuni tratti specifici. Sono propriamente i tratti concernenti
quell’idea di cultura che, come abbiamo visto, anziché orientare al risultato, predispone alla
comprensione e al significato. La conoscenza che vale, oggi, è quella che riesce a
circoscrivere il proprio orizzonte in modo tale da corrispondere, attraverso il percorso più breve
possibile, alla percezione che mercato e imprese hanno delle competenze e delle occorrenze
concernenti il proprio potenziamento, in termini di crescita e di diffusione immediata. Tra
conoscenza e interesse si stabilisce così un’alleanza che promuove l’affermazione di una
temporalità abbreviata, dove l’intelligenza dei nessi e dei sistemi di relazione complessa, cioè
l’intelligenza delle implicazioni ad ampio raggio e a lungo termine, viene sostituita con una
intelligenza della risposta, fulminea e puntuale, coinvolta, assieme ad altre forze, nella
questione di come massimizzare il ritorno del capitale d’investimento.
Parlare di “centralità della dimensione del lavoro”, oggi, può sembrare paradossale, non
appena si pensi alla grande eterogeneità della qualità dell’offerta, delle condizioni contrattuali,
alla sua svalorizzazione e subalternità rispetto al capitale. Per non dire dei meccanismi di
automazione attraverso cui il capitale perviene oggi, con una efficacia crescente, a
estromettere quote rilevanti di lavoro dal processo produttivo, al fine di svincolarsi dai suoi
ritmi temporali2. Tuttavia, proprio a causa della volatilità e mobilità del lavoro - due caratteri
che non fanno che riflettere la natura stessa del mercato -, in ragione cioè della sua instabilità
e della sua perdita di potere rispetto al capitale, esso acquista per le vite degli individui un
rilievo inedito. Il lavoro - come necessità, dovere, investimento, ideale - si ripercuote
sull’esistenza coinvolgendola su più fronti: quello dell’impegno cui le persone sono chiamate,
se intendono rimanere oppure mettersi “in gioco”, quello dell’incertezza provocata da un
“gioco” sempre più aleatorio e, infine, quello dell’ansia riguardo alla “posta” in gioco, una posta
che non smette di lievitare, considerata l’instabilità attuale del sistema. Fuor di metafora, in un
modo o nell’altro, il lavoro entra nelle nostre vite attraverso forme del tutto inedite. E’ una
centralità che, del resto, riflette la rilevanza stessa del lavoro – una volta svincolato da talune
tutele legislative maturate in mezzo secolo di negoziazioni – nel processo di riproduzione della
ricchezza e come inaggirabile fattore di competitività. Che poi l’incremento della produttività,
via l’attività lavorativa, vada piuttosto a beneficio della voce profitto, anziché della voce salario,
è un problema di ridistribuzione che non invalida assolutamente l’osservazione sulla centralità
del lavoro nel sistema di produzione post-fordista.
Come detto, sono in atto oggi innegabili tendenze di subordinazione del lavoro alle necessità
del capitale. Allo stesso modo, è presente una forte propensione alla svalorizzazione del
lavoro, alla riduzione del suo costo, onde poter competere con le economie di quei paesi dove
i prestatori d’opera sono esposti senza alcuna tutela agli interessi della produzione. Ma
nonostante vi sia ancora chi crede possibile salvaguardare “il mito del lavoro come appendice
cieca di una classe manageriale pensante”3, è vero che la flessibilità delle tecnologie e la sua
ricaduta sui rapporti tra produzione e mercato, l’altalena tra innovazione e obsolescenza di
tecnologie e competenze, il ruolo crescente assunto dalla conoscenza, tutto ciò conduce
inevitabilmente a fare del lavoro “il primo fattore di produttività dell’impresa”4, soprattutto
quando questo lavoro assume la forma di una intelligenza funzionale ai diversi regimi di
utilizzabilità delle risorse (tecnologica, logistica, comunicazionale, manageriale) che articolano
l’odierna attività produttiva.
Imprenditorialità diffusa
Non è allora difficile comprendere perché la pressione che il lavoro esercita a vario titolo
sugli individui, si traduca nel fatto che sempre più fenomeni, sino a ieri estranei alle sue
necessità, siano ora posti nella condizione del confronto diretto. Fra le ragioni di questo
confronto, vi è senz’altro il fatto che il movimento di decentramento, delocalizzazione e
terziarizzazione dell’unità produttiva – tre fattori distintivi di ciò che siamo ormai soliti chiamare
economia post-fordista - si accompagna a una strategia di amplificazione dei margini di
autonomia della forza-lavoro funzionale all’aumento del profitto. Dal punto di vista del
lavoratore, questo significa una cosa molto precisa. Significa che la responsabilità
dell’accesso al lavoro e della sua qualità viene viepiù individualizzata, tanto che le condizioni
lavorative sembrano dipendere in primo luogo dal profilo del lavoratore, dalla sua capacità di
autopromozione sul mercato del lavoro. Egli risulta esserne il principale responsabile, poiché i
livelli di remunerazione si presentano come dipendenti prevalentemente dal tenore delle
prestazioni, e in ultima analisi dalle qualità della persona stessa. L’investimento individuale
che ne deriva, in termini umani e finanziari, ricade ora soprattutto sulle spalle del singolo
lavoratore. Dato che è il singolo lavoratore a portarne la faccia, in ragione anche di una
pressione sociale che enfatizza le ragioni individuali dell’eccellenza e del suo contrario,
attraverso idealizzazioni del merito e della perfomance personale confermate, appunto, a
Cfr. A. Ponzio, Formazione, occupazione, migrazioni, in “Quaderno di comunicazione”, n. 8,
2008, pp. 39-49.
3 B. Trentin, Un nuovo contratto sociale, in “Gli argomenti umani”, n. 9, 2002, p. 10.
4 Ibid.
2
livello salariale. Il terreno sul quale si è giocata questa individualizzazione dei rapporti
lavorativi come spinta alla responsabilizzazione del singolo prestatore d’opera è quello del
tempo lavorativo. Tende a scomparire, anche al livello del lavoro esecutivo, l’idea del tempo
come misura del salario5. Se questa è la prospettiva, il tempo lavorativo, il tempo che
articolava fino a ieri la giornata di lavoro, si presenta ora come una misura variabile asservita
alla prestazione. E’ la prestazione, quale prodotto valutabile, a entrare idealmente in relazione
diretta con la retribuzione: la responsabilità del risultato mette in gioco una disponibilità che
non è più solo quella di erogare un certo numero di ore giornaliere di lavoro. La quantità di
tempo necessario a conseguire il risultato, diventa allora una questione che ricade per intero
sulla persona del lavoratore. Il che implica un’inedita messa in gioco del lavoratore nella sua
relazione con il prodotto della prestazione, quanto a competenze, capacità di pianificazione,
efficienza, produttività. In questo caso, il prestatore d’opera subentra, in un certo senso, al
datore di lavoro, perché è chiamato egli stesso ad interviene direttamente nell’organizzazione
del suo tempo lavorativo. Tendenzialmente, questa assunzione di responsabilità, da parte del
lavoratore, circa il risultato del suo operato rende del tutto irrilevanti le tradizionali otto ore
lavorative giornaliere, per quanto in molti casi esse continuino ad essere presenti in termini
contrattuali. Quando è principalmente il risultato a diventare il principale fattore di valutazione,
il quantum temporale, nella sua determinatezza, non garantisce nulla in sé. Del resto, è lo
stesso “lavoratore responsabilizzato” a celarlo oppure ad esibirne l’esubero rispetto alla norma
contrattuale. All’interno di una logica dove gli “straordinari” non sono più oggetto di
remunerazione, l’esibizione del surplus temporale o il suo occultamento diventa una questione
personale, da valutare a seconda dei casi. “Personale” proprio nel senso che spetta al singolo
lavoratore salariato stimare quale delle due opzioni (esibizione o occultamento) assicuri un
guadagno competitivo all’interno o all’esterno dell’organizzazione. Si tratta, in entrambi i casi,
del tempo come luogo in cui si esprime una disponibilità che, di volta in volta, può assumere i
tratti della devozione, del sacrificio o dell’interesse. Nel migliore dei casi, l’esito è quello di un
sentimento di auto-imprenditorialità che nobilita anche i lavori più esecutivi, nel peggiore quello
di un sentimento di sfinimento che annichilisce e “brucia” il lavoratore.
L’individualizzazione
della
responsabilità,
a
questo
livello,
corre
parallela
all’individualizzazione del lavoratore, alla sua solitudine “contrattuale”, a quella perdita di unità
d’interessi – un effetto dello sganciamento dell’attività lavorativa dalle sue tutele – che
consente di parlare del lavoro nei termini di una realtà ormai priva di rappresentanza6.
Se, nonostante tutto, è ancora possibile parlare del lavoro come di una delle funzioni del
riconoscimento sociale, bisogna però aggiungere che è un riconoscimento in cui si smarrisce
la dimensione comunitaria di categoria. Il riconoscimento passa semmai attraverso prestazioni
individualizzate, spesso in competizione tra loro, incapaci di generare identità lavorative
coese. In questo senso, la retribuzione anziché accomunare comunità salariali riconoscibili
nella loro uniformità, distingue individui singoli che non coesistono più in base ad una serie
omogenea e rappresentabile di mansioni. La forma della loro relazione è ora piuttosto quella
della compresenza degli uni agli altri, ognuno inquadrato secondo forme contrattuali tali da
prevedere anche importanti differenze in termini retributivi o di tutela . Come dire, tutti al lavoro
ma, letteralmente, ciascuno per proprio conto. In linea di principio, il riconoscimento
dell’identità lavorativa cessa di essere assicurato dal lavoro, se con “lavoro” si intende un
campo uniforme di azioni identificanti, veicolo di identità professionali condivise e riconoscibili
nella tipicità di prestazioni e interessi. Ora ciò che è professionalmente identificante è invece il
risultato del lavoro, con tutte le strategie messe in campo per assicurarne l’eccellenza, come si
ama dire oggi, ossia per produrre quel vantaggio competitivo attraverso cui istituzioni e
Ivi, p. 13. Il declino dell’idea del tempo di lavoro quale misura del salario è reso possibile
dall’idea che “la qualità della prestazione di lavoro e l’intervento del lavoratore sono
fisiologicamente diversi in un’ora di lavoro rispetto ad un’altra”.
6 Cfr. P. Ciofi, Il lavoro senza rappresentanza, Manifestolibri, Roma 2004.
5
individui pervengono a distinguersi dai loro concorrenti. Sempre meno, l’individuo al lavoro
pensa se stesso come parte di una comunità che condivide finalità e interessi. Sempre più,
qualità, originalità, velocità, abilità – che sono i caratteri mediante cui è possibile aggiungere
un alto valore alla propria attività – costituiscono l’orizzonte in base al quale misurare il
riconoscimento professionale. La parola magica è “valore aggiunto”. Nel confronto con questa
abilità che consente di differenziarsi in un regime produttivo altamente competitivo qual è
quello odierno, l’impresa mette in gioco la sua affermazione sugli attori del mercato, e il
singolo individuo mette professionalmente alla prova se stesso.
Conoscenza e interesse
Si capisce allora in che senso un vasto campo di attività, disposizioni, investimenti e risorse
finisce con l’essere convogliato nell’orbita del lavoro. Conoscenza, creatività, comunicazione,
ricreazione, socievolezza: tutto ciò riceve una nuova destinazione, cioè un nuovo
orientamento, nel momento in cui si trasforma in materiale indispensabile alla riproduzione e
alla produttività del lavoro. Qui però si tratta di un lavoro a senso unico, giacché la possibilità
di capitalizzare in chiave economica conoscenza, creatività, comunicazione, ricreazione e
socievolezza, consegue dal fatto che il lavoro, dal canto suo, è inteso oggi principalmente,
quando non esclusivamente, quale vettore di creazione del valore. Qualsiasi altro significato è
tendenzialmente messo in ombra. Tra lavoro e produzione si stabilisce una linea diretta,
esclusiva, che spinge al margine rappresentazioni e pratiche del lavoro non immediatamente
convertibili in questo modello, se non a costo di una radicale trasformazione dei modi di agire
e di pensare. Una trasformazione particolarmente evidente in quei lavori che si sono pensati
attraverso una forte idealizzazione della loro missione, anzi che si riconoscono proprio come
motivati da una missione, una missione alimentata dalla vocazione dei suoi attori. E’ il caso,
ad esempio, delle professioni nelle quali è centrale la relazione di cura, la trasmissione del
sapere, la dimensione della solidarietà - laddove, cioè, entra in gioco la componente della
donazione di sé.
L’enfatizzazione della relazione tra lavoro e produzione, vale a dire la tendenza a
circoscrivere i significati del primo ai meccanismi di incremento della seconda, è alla base
della forma che assume oggi la relazione tra conoscenza e interesse. Il prezzo di tale
trasformazione è, come detto, il declino di una certa idea di cultura. La natura della relazione
tra conoscenza e interesse economico, come pressione dell’uno sull’altra, diventa
perfettamente visibile là dove aumento della produzione, ricchezza e creazione del valore
sono fatti dipendere dalla formazione di un homo technologicus innovativo, flessibile e capace
di imprenditorialità, dunque da una forma della soggettività che è qualcosa di più del
“semplice” homo sapiens. Certamente, l’organizzazione della produzione odierna mostra ogni
giorno come l’investimento sul capitale cognitivo, di per sé, non sia sufficiente a creare valore.
L’appello alla conoscenza e all’innovazione nasconde sovente una realtà molto meno nobile.
Nasconde, o tende a non vedere, sapendolo però benissimo, quanto sia decisiva per l’odierno
sviluppo economico la dimensione territoriale e quella contrattuale. Quanto siano rilevanti per
la creazione del valore sia l’insediamento di segmenti della produzione nelle aree geografiche
maggiormente convenienti alle diverse fasi di realizzazione delle merci e dei servizi, costi quel
che costi in termini di diritti umani e di sostenibilità ambientale, sia la possibilità di poter
contare su una riduzione sistematica del costo del lavoro. Ma ora non è questo il punto.
Il punto è, come detto, il declino di una certa idea di cultura. Per capire in che modo ciò sia
reso possibile e quale idea di cultura sia precisamente in declino, occorre vedere più da vicino
il tipo di impegno cui è chiamato l’individuo dall’odierno mercato del lavoro. Il che ci permetterà
di capire meglio, in conclusione, che cosa si intenda con conoscenza nell’attuale “società della
conoscenza”, e come la sua affermazione ostacoli quella forma di cultura che più sopra
abbiamo chiamato intelligenza delle implicazioni ad ampio raggio e a lungo termine.
Unilateralità
La natura “a tutto campo” dell’impegno richiesto al lavoratore contemporaneo discende
principalmente dal fatto che l’attuale organizzazione dell’esperienza lavorativa valorizza il
lavoratore quasi esclusivamente attraverso le risposte immediate che il mercato dà alle sue
performance. In quanto lavoratore, ciò che valgo dal punto di vista salariale lo raccolgo
direttamente sul mercato7. La relazione diretta che si viene così a creare tra prestazione e
mercato, chiede al lavoratore un onere che sovrappone all’attività lavorativa in sé, l’attività
necessaria a riprodurre continuamente le condizioni affinché il mercato del lavoro si mostri
interessato alle sue prestazioni.
“Auto-imprenditorialità” è il termine con cui, oggi, si definisce sia questo surplus di lavoro, sia
l’individualizzazione della responsabilità che ciò comporta. La volatilità del mercato, il suo
estendersi selettivo e dinamico al mondo intero, come continuo riorientamento in direzione
delle opportunità migliori, è all’origine di un sentimento di insicurezza cui si chiede di
rispondere con un’attivazione totale di risorse personali che non tollera alcuna delega di
responsabilità. In questo quadro, l’assunzione in toto della responsabilità da parte del
lavoratore, costituisce il principale movente della mobilitazione di risorse operata dal singolo
individuo.
Nel momento in cui la responsabilità nei confronti di ciò che mi accade come lavoratore
ricade completamente su di me – in una comprensione completamente falsata di che cosa
significhi essere parte di un tutto –, è la stessa considerazione del valore di se stessi ad
essere messa in gioco in modo nuovo, rispetto al recente passato. Perché se il valore della
mia prestazione viene misurato esclusivamente in relazione alle esigenze del mercato, ciò che
esso finisce con l’esprimere direttamente attraverso le sue riposte è un giudizio sul mio merito
in quanto individuo. Un giudizio formulato sì in base ad una precisa selezione di ciò che è
valorizzante, ma la cui rilevanza è tale da interpellare l’individuo nella sua totalità.
Saltano in un certo senso tutte le mediazioni, politiche, sociali, comunitarie, con i loro
rispettivi interessi e processi di valorizzazione: ci sono ancora solo la mia prestazione e il
banco di prova sul quale viene misurata la sua capacità di farsi valere concorrenzialmente. Si
capisce allora meglio il ruolo giocato dalla responsabilità: spetta a me in quanto lavoratore
mettere in gioco tutto quanto possa servire a superare la prova, consapevole del fatto che
essa non è mai superata una volta per tutte. Dunque: risvegliata da una responsabilità che mi
interpella in quanto artefice a tutto campo della mia biografia - in una relazione diretta e senza
mediazioni con il mondo e le sue sanzioni -, la mobilitazione a cui sono chiamato ha per
oggetto soprattutto l’incremento di quelle facoltà che hanno valore di risorsa.
La responsabilità, allora, è qui da mettere in relazione con l’autoproduzione di sé come
risorsa, ancora prima di qualsiasi intervento strategico di ordine imprenditoriale relativo allo
sviluppo delle cosiddette “risorse umane”. Voglio dire che sotto la regia del singolo individuo,
lo sviluppo di facoltà-risorsa diventa, certo, una questione di responsabilità, ma di una
responsabilità dove ognuno è spinto a porre se stesso al centro delle proprie attenzioni: una
responsabilità per così dire auto-centrata. Tanto più se è vero che la riduzione dei possibili
referenti della responsabilità (ciò verso cui mi sento responsabile) alla produzione di sé quale
risorsa operativa, fa leva non solo sulla necessità di incrementare continuamente la propria
concorrenzialità per poter rimanere all’interno del mercato del lavoro, ma anche, e forse
soprattutto, su un approccio ugualmente restrittivo alla considerazione di sé e all’autostima,
perché orientato ad una selezione unilaterale dei contenuti che ne garantiscono la presenza.
E’ questo un orientamento che incrina completamente il senso della cura di sé, alla quale ci
ha educato la tradizione occidentale. E poiché ogni cura di sé mette in gioco la capacità di
7
Cfr. R. B. Reich, L’infelicità del successo, tr. it. Fazi Editore, Roma 2001, p. 155
raccontarsi all’interno di un orizzonte vasto e articolato, in grado di attingere a risorse
altrettanto estese e differenziate, questa restrizione rispetto alla considerazione di sé e
all’autostima, finisce inevitabilmente con il trasdursi in una sconsolante debolezza del
soggetto, a fronte delle sfide che lo attendono. Paradossalmente, in piena vulgata
economicista, egli sembra così sospinto a sottrarre la sua stessa persona al “sacrosanto”
principio della differenziazione degli investimenti. Ma questo non è che il rovescio della
medaglia di quell’unilateralità che, come abbiamo visto, contraddistingue gli investimenti nella
conoscenza della cosiddetta “società della conoscenza”.