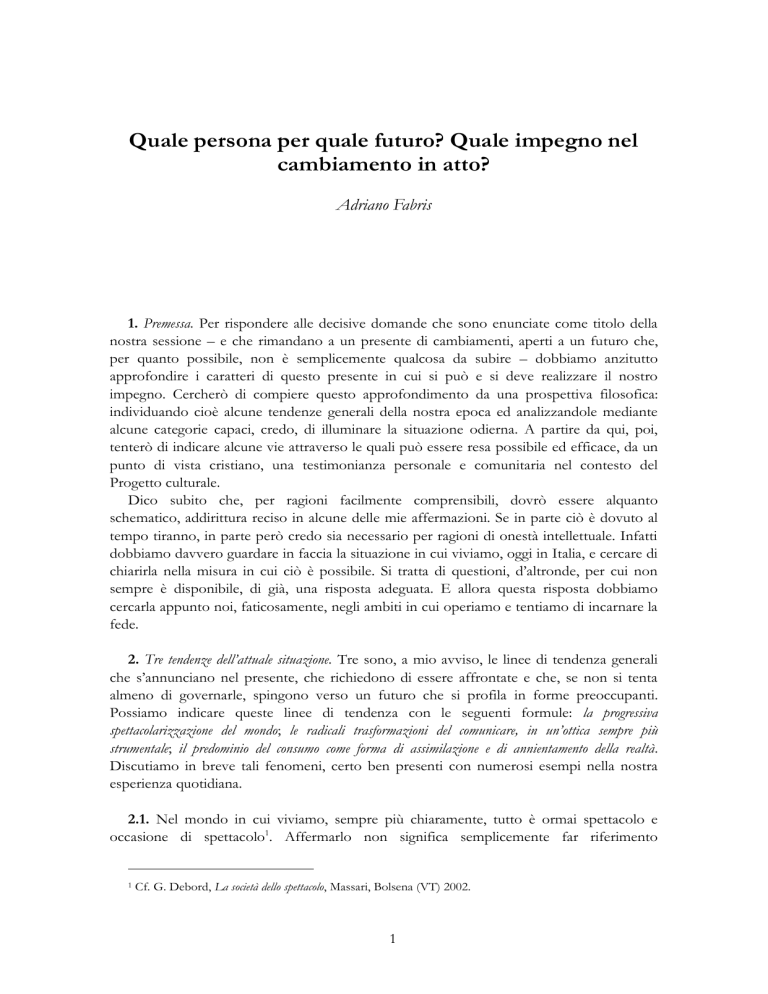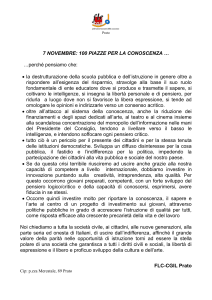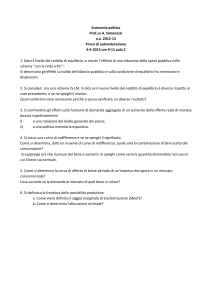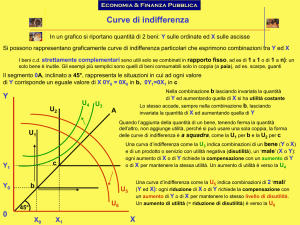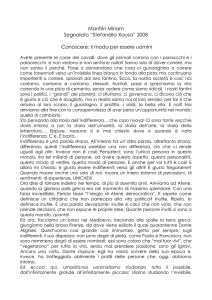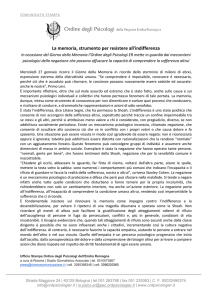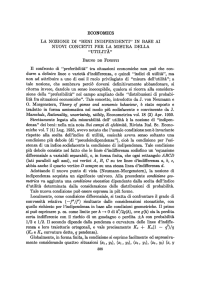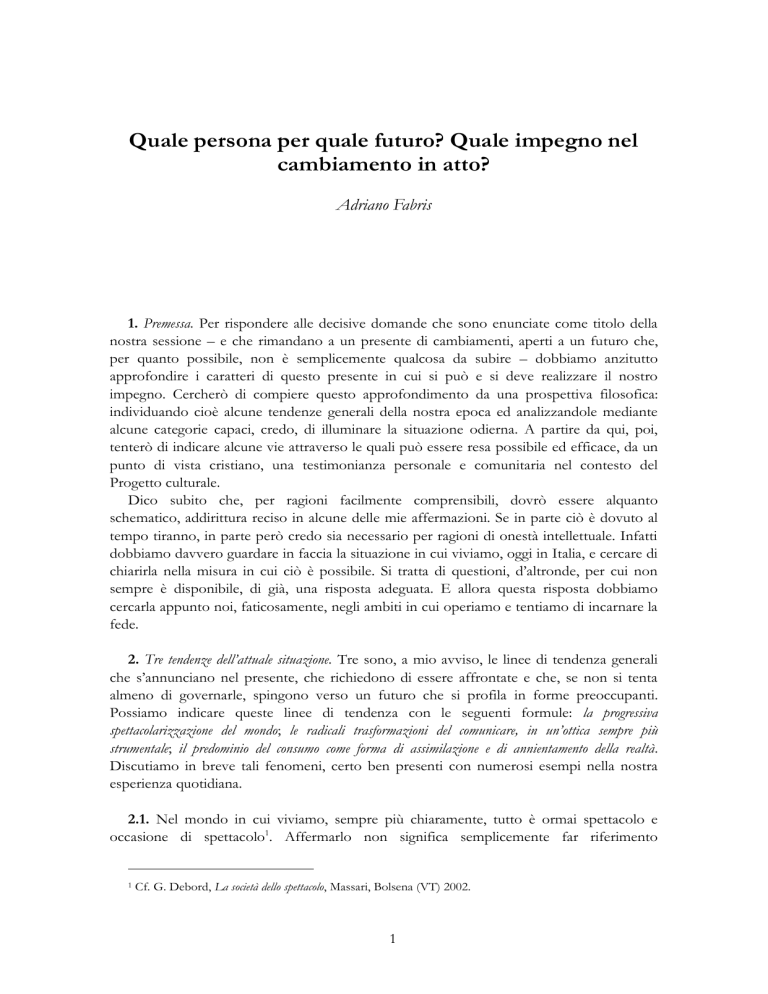
Quale persona per quale futuro? Quale impegno nel
cambiamento in atto?
Adriano Fabris
1. Premessa. Per rispondere alle decisive domande che sono enunciate come titolo della
nostra sessione – e che rimandano a un presente di cambiamenti, aperti a un futuro che,
per quanto possibile, non è semplicemente qualcosa da subire – dobbiamo anzitutto
approfondire i caratteri di questo presente in cui si può e si deve realizzare il nostro
impegno. Cercherò di compiere questo approfondimento da una prospettiva filosofica:
individuando cioè alcune tendenze generali della nostra epoca ed analizzandole mediante
alcune categorie capaci, credo, di illuminare la situazione odierna. A partire da qui, poi,
tenterò di indicare alcune vie attraverso le quali può essere resa possibile ed efficace, da un
punto di vista cristiano, una testimonianza personale e comunitaria nel contesto del
Progetto culturale.
Dico subito che, per ragioni facilmente comprensibili, dovrò essere alquanto
schematico, addirittura reciso in alcune delle mie affermazioni. Se in parte ciò è dovuto al
tempo tiranno, in parte però credo sia necessario per ragioni di onestà intellettuale. Infatti
dobbiamo davvero guardare in faccia la situazione in cui viviamo, oggi in Italia, e cercare di
chiarirla nella misura in cui ciò è possibile. Si tratta di questioni, d’altronde, per cui non
sempre è disponibile, di già, una risposta adeguata. E allora questa risposta dobbiamo
cercarla appunto noi, faticosamente, negli ambiti in cui operiamo e tentiamo di incarnare la
fede.
2. Tre tendenze dell’attuale situazione. Tre sono, a mio avviso, le linee di tendenza generali
che s’annunciano nel presente, che richiedono di essere affrontate e che, se non si tenta
almeno di governarle, spingono verso un futuro che si profila in forme preoccupanti.
Possiamo indicare queste linee di tendenza con le seguenti formule: la progressiva
spettacolarizzazione del mondo; le radicali trasformazioni del comunicare, in un’ottica sempre più
strumentale; il predominio del consumo come forma di assimilazione e di annientamento della realtà.
Discutiamo in breve tali fenomeni, certo ben presenti con numerosi esempi nella nostra
esperienza quotidiana.
2.1. Nel mondo in cui viviamo, sempre più chiaramente, tutto è ormai spettacolo e
occasione di spettacolo1. Affermarlo non significa semplicemente far riferimento
1
Cf. G. Debord, La società dello spettacolo, Massari, Bolsena (VT) 2002.
1
all’enorme impatto che i mezzi di comunicazione di massa hanno ormai nella realtà
quotidiana. Significa soprattutto mettere in luce una tendenza ben precisa nel modo in cui
le cose ci si presentano e in cui noi ci rapportiamo ad esse. Questa tendenza è, appunto,
quella all’esibizione. Il che significa che, nella prospettiva dell’esibizione, qualcosa vale nella
misura in cui ed entro i limiti in cui si dà a vedere. Non in quanto tale, cioè, non di per sé.
Ne consegue una svalutazione di ciò che è irriducibile o refrattario a un tale esibirsi.
Pensiamo per esempio alla crisi – ai cui effetti assistiamo – del sentimento del pudore.
Tutto ciò, naturalmente, ha nella “cultura televisiva” la sua rappresentazione più piena e
il suo emblematico luogo di attuazione. Ma non si tratta affatto di demonizzare la
televisione: un medium certo in grado di essere usato anche per scopi importanti. Si tratta
invece di rilevare una specifica conseguenza che deriva da questo predominio
dell’esibizione. Quella tendenza per cui, lo ripeto, una persona non vale per quello che è,
ma per come si esibisce: anzi, propriamente vale solo in quanto si esibisce. E tale
conseguenza consiste, per esprimerci in termini generali, nell’implicita riduzione di ogni cosa al
suo apparire. Una cosa non solo vale, ma è quello che è unicamente in quanto appare. Se invece
non appare, se non dà spettacolo di sé, propriamente non è affatto.
Il che comporta, a ben vedere, una conseguenza ancora più radicale, connessa alla
generalizzazione di questa tendenza: la conseguenza che tutto, in tal modo, viene riportato
alla sua apparenza. Tutto è per come appare. E se ogni cosa è solo nella misura del suo
apparire, allora non vale più la distinzione, classica e propria del senso comune, fra realtà ed
apparenza: perché appunto, lo ripeto, tutto viene ad essere apparenza. Lo vediamo molto
spesso non solo, nuovamente, nell’ambito del medium televisivo – dove i cosiddetti reality
shows, lungi dall’essere specchio della realtà, altro non solo che una artificiosa creazione di
essa2 –, ma soprattutto nei contesti della moda e, più in generale, delle mode. Lo vediamo
addirittura nel nostro modo di parlare: non si spiegherebbe l’uso, a cui ormai ci ha abituato
internet, dell’espressione di “realtà virtuale”, se ormai non fossimo abituati a questo
assorbimento del reale nella sfera dell’apparire3.
Ne risulta una situazione in cui ogni cosa è, per dir così, senza spessore, in tutto
s’annuncia e si dilegua, in cui non possiamo fare affidamento su nulla, in cui nulla, in
definitiva, ha più senso. Le cose, nella loro apparenza, sono infatti tutte sullo stesso piano.
E dunque ci possono bensì incuriosire, ma, alla fine dei conti, ci sono per lo più indifferenti,
scorrendo sullo schermo di quell’apparenza che ce le propone. E lo sono a buon diritto:
giacché l’indifferenza è appunto la nostra difesa nei confronti del fatto che esse
costantemente dileguano.
2.2. Il secondo aspetto di cui abbiamo parlato, la seconda tendenza all’opera nel
presente, riguarda le radicali trasformazioni del comunicare alle quali assistiamo da qualche
tempo. “Comunicazione”, originariamente, significa creazione di uno spazio comune,
condiviso, del quale ognuno, purché capace di parlare, può con piena legittimità aver parte.
2
Ciò non significa però aderire in toto alle tesi, estreme, sostenute da J. Baudrillard nel suo libro Il delitto
perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Cortina, Milano 1996.
3
Cf. in proposito il libro di P. Lévy, Il virtuale, Cortina, Milano 1997.
2
Da questa concezione, che peraltro è centrale nella tradizione cristiana 4, derivano
conseguenze importanti, capaci di dare orientamento nei rapporti interpersonali e, più in
generale, nella costruzione di una comunità. Ed emerge da qui, inoltre, una prospettiva etica
forte, che si radica appunto fatto stesso che comunichiamo e nel modo in cui, propriamente,
lo facciamo5.
Tuttavia non è questa la concezione del comunicare che ormai, oggi, si è imposta.
Comunicare non è affatto funzione di comunione. Comunicare, semplicemente, è
trasmettere messaggi o informazioni nella maniera più efficace. Il che significa: colpendo
l’interlocutore in modo che gli effetti permangano il più a lungo possibile. E così accade, ad
esempio, nell’ambito della comunicazione pubblicitaria, che è diventata il modello, in molti
casi, anche della comunicazione pubblica e di quella politica.
L’interlocutore, quindi, non è una persona con cui dialogare: è, letteralmente, un target.
Bersaglio, appunto, da raggiungere, da persuadere, da controllare. E tutto ciò facendo uso
di strumenti d’indagine e di misurazione soprattutto di tipo quantitativo. I quali risultano
affatto indifferenti nei riguardi di chi realmente ho di fronte: nei riguardi cioè della sua
individualità, del suo essere, del suo valere.
La comunicazione diviene perciò, propriamente, comunicazione di massa.
Comunicazione rivolta alla massa, ma anche guidata, per poter essere davvero efficace, dai
gusti della massa. Una massa che, in ogni caso, non è fatta di persone concrete, reali, in
carne ed ossa, ma da soggetti tutti omologati, incasellati, secondo i loro possibili modi di
apparire. Rispetto ai quali, di nuovo, possiamo a buon diritto assumere un atteggiamento
d’indifferenza. Giacché i diversi modi di apparire – caricati ormai di una ben precisa
funzione comunicativa, come mostrano la moda e il look, i modi dell’espressione giovanile e
i vari comportamenti condivisi, spesso senza un perché – hanno certo una loro
riconoscibilità, ma non rendono possibile un’effettiva e stabile identificazione di chi li
assume. Anche la comunicazione dell’identità, oggi, è infatti divenuta oggetto di consumo.
2.3. Il predominio del consumo è l’ultimo elemento a cui in breve mi voglio richiamare
per descrivere la situazione del presente6. È indubbio infatti che il nostro rapporto con le
cose e, più in generale, con il mondo è da sempre caratterizzato dagli atteggiamenti, fra loro
connessi, del desiderare, dell’acquisire, del consumare. Oggi però – ed è l’“oggi” che da
qualche decennio viene a definirsi appunto come “società del consumo” – assistiamo alla
radicalizzazione o, addirittura, al pervertimento di alcuni processi legati a queste attività.
Infatti, schematicamente, possiamo dire che il desiderio di altro, che fin dal pensiero
antico era considerato sintomo di una mancanza e stimolo al suo superamento, e che
dunque risultava funzionale all’apertura ad altro da parte di un sé conscio dei suoi limiti, si è
ora trasformato nell’occasione di una rinnovata sottolineatura della centralità di questo sé.
Quest’ultimo appare come un soggetto che si ritiene padrone dei propri desideri e che è
4
Cfr. ad esempio C. Giuliodori, G. Lorizio (a cura di), con una Prefazione del Card. Camillo Ruini,
Teologia e comunicazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2001.
5
Si veda in proposito A. Fabris, Etica della comunicazione interculturale, Eupress, Pregassona (Svizzera) 2004.
6
Una panoramica in lingua italiana riguardo a questo problema è offerta dal recente libro di Vanni
Codeluppi, Il potere del consumo. Viaggio nei processi di mercificazione della società, Bollati Boringhieri, Milano 2003.
3
persuaso che il mondo sia sostanzialmente relativo al loro soddisfacimento. In altre parole,
la dinamica del desiderio risulta ormai andare di pari passo con quella dell’edonismo7.
In parallelo, poi, l’acquisizione di ciò che manca come completamento e
perfezionamento della persona è divenuta assimilazione di ciò che, appunto, si è riusciti ad
acquisire: un’assimilazione che riconferma il soggetto desiderante nella sua parzialità e nella
sua limitatezza, semplicemente gettando nell’abisso del suo desiderio tutto ciò che egli è
capace di ottenere. L’acquisizione, così, si fa propriamente consumo. E il consumo si
presenta, nello specifico, come una forma di assorbimento dell’altro: come l’esercizio
reiterato del suo annientamento. Senza però che, in questo annientamento, il soggetto
consumatore trovi davvero il proprio appagamento.
È qui che si radica la coazione a ripetere propria del consumatore e la ragione del
diffondersi sempre più ampio di una mentalità orientata al consumo. Infatti se, come ho
detto, l’acquisizione di un bene non è in grado di appagare il desiderio, ciò avviene perché
essa non è occasione del perfezionamento di una persona, attraverso il suo collegamento
all’altro da sé. Di conseguenza, l’inquietudine che nasce da questo mancato appagamento
spinge a reiterare il consumo e a sottoporvi ogni cosa, senza limiti e senza rispetto. Anche
la natura, perciò, diventa oggetto di sfruttamento e di assimilazione, e si trasforma in
qualcosa di sempre più artificiale: capace tuttavia di resistere e di ribellarsi al tentativo della
sua consumazione. Anche l’uomo, addirittura, diventa oggetto di consumo e di
manipolazione, nei modi che sempre più di frequente abbiamo sotto gli occhi. È dunque
necessario e urgente, in questa situazione, elaborare un’etica del consumo, capace di chiarire le
dinamiche di questo fenomeno e di aiutare a governarle8. Altrimenti tutto rischia, ancora
una volta, di ricadere nell’inquietudine e nell’indifferenza.
3. Il problema dell’indifferenza. Se infatti vogliamo indicare un elemento comune ai tre
aspetti che ho brevemente analizzato, e che caratterizzano il tempo presente – la
spettacolarizzazione del mondo, la riduzione del comunicare a individuazione e coglimento
di un bersaglio, il predominio del consumo come modello di rapporto con la realtà –
possiamo individuarlo proprio nel fenomeno dell’indifferenza. Viviamo infatti in un’epoca di
indifferenza più che in un’età di grandi contrapposizioni: indifferenza nei confronti del
mondo; indifferenza nei confronti degli uomini; indifferenza nei confronti del “problema
Dio” (ciò che più propriamente viene chiamata “indifferenza religiosa”). E, a ben vedere, la
riduzione di tutto a semplice apparenza, l’omologazione quantitativa del target nell’ambito
delle comunicazioni di massa, l’annientamento a cui conduce l’impulso reiterato e inquieto
a consumare altro non sono che forme in cui un atteggiamento d’indifferenza sempre più
diffuso prende corpo.
Insinuandosi, peraltro, anche nei mondi religiosi. Non è affatto un paradosso, infatti,
sostenere che gli odierni fondamentalismi non sono affatto il contraltare, bensì un’ulteriore
espressione di una tale diffusa indifferenza. Infatti, se ciò che conta in essi è solamente
l’obbedienza, l’adesione alla lettera del testo sacro o alle parole della guida spirituale,
7
Su questo collegamento, che ha nel romanticismo la sua prima manifestazione, si veda il libro di Colin
Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell, Oxford 1987.
8
Sull’argomento si veda A. Cortina, Por una ética del consumo, Taurus, Madrid 2002.
4
diventa assolutamente irrilevante tutto il resto: la comprensione di questo testo e di queste
parole, la possibilità di un rapporto autentico con altre culture e altre religioni, il rispetto
dell’altro uomo anche nella sua eventuale diversità di credenze, il senso stesso, infine, della
rivelazione di Dio9.
Ma, appunto, che cosa s’intende, qui, con “indifferenza”? Il concetto di indifferenza, a
ben vedere, risulta ambiguo. Esso può indicare infatti sia una mancanza di distinzioni, sia
un’assenza di interesse. L’atteggiamento d’indifferenza comporta cioè sia un’indistinzione (fra
ciò che potrebbe o dovrebbe essere differenziato), sia un disinteresse (nei confronti di
qualcosa). Si tratta, nel primo caso, dell’indifferenza in qualcosa, nel secondo,
dell’indifferenza rispetto a qualcosa.
In entrambi i casi, comunque, ciò che avviene è un processo analogo. Sia
nell’indistinzione che nel disinteresse ciò che si verifica è infatti l’annullamento di un rapporto.
In questo annullamento emerge il tratto nichilistico dell’indifferenza. Ed il rapporto in
questione subisce l’annullamento perché viene negato che vi possa essere una qualche
diversità fra i termini che potrebbero entrare in un tale rapporto. Perciò tutto risulta
indistinto. E, di fronte all’indistinto, non c’è nulla che mi può attrarre, nulla che suscita il
mio interesse. Io non sono più coinvolto, motivato. Tutto, quindi, mi appare privo di senso.
In questa prospettiva possono essere pensate esperienze e stati d’animo – come la noia,
l’angoscia, la depressione – la cui trattazione in termini meramente psicologici,
psicoterapeutici o, addirittura, psichiatrici rischia di essere affatto insufficiente.
4. Il compito del presente. Insomma: di fronte a questa situazione, di fronte a un tale imporsi
dell’indifferenza quale tratto complessivo della nostra epoca, nonostante si annuncino
elementi che indicano anche in altre direzioni, nella prospettiva di un cambiamento in atto
che richiede di essere governato, quale può essere una via d’uscita possibile? Quale può
essere una soluzione alla nostra portata, e fedele alla tradizione del cristianesimo? Quello
che può fare il filosofo, in un tale contesto, è aiutare una più adeguata comprensione di
siffatte tendenze, consentire, nei confronti di esse, un’effettiva presa di distanze. Quello che
può fare il filosofo, per tale via, è indicare il modo in cui una mentalità che pare ormai
universalmente accolta, almeno in Occidente, può invece essere cambiata. Per recuperare in
tutta la sua profondità il senso della persona umana.
Brevemente, ancora una volta, tre dinamiche possono esse fatte valere in controtendenza
rispetto ai fenomeni che abbiamo esaminato. Nei confronti della trasformazione del
mondo in spettacolo, riguardo cioè al dissolversi dell’apparizione in apparenza, va
recuperato quel rimando a un’alterità che proprio nell’apparenza si trova nascosto; davanti
alle trasformazioni del comunicare e al suo utilizzo meramente strumentale bisogna
riscoprire il carattere strutturalmente etico della comunicazione; al cospetto del privilegio
del consumo, quale modello assimilativo di ogni rapporto con l’altro, dobbiamo tener
presente quanto ogni assimilazione incontri di insormontabile resistenza e lasci di
irriducibile residuo. Esaminiamo queste possibili soluzioni in maniera un poco più
dettagliata.
9
Cfr. M. Riesebrodt, Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der „Kampf der Kulturen“, Beck,
München 2001.
5
4.1. Vi è, abbiamo detto, qualcosa di profondo anche nella superficialità dell’apparenza.
Esso è dato dal fatto che tutto quello che si manifesta, tutto ciò che si rivela, si manifesta e
si rivela sotto certo aspetti, e ne nasconde altri. Anzi, nasconde proprio ciò che è all’origine
di questa manifestazione: ciò che la struttura, la rende possibile, la motiva.
In questo consiste proprio la dinamica della rivelazione cristiana: quel processo trinitario
nel quale, appunto, il Padre si rivela nel Figlio attraverso quel legame, universalmente
estendentesi, che è lo Spirito. Ma il Padre stesso non è il Figlio, e si sottrae a Lui (come
mostra il grido dell’ora nona). E il Figlio stesso non si dissolve nel mondo in cui s’incarna,
ma si eleva al di sopra di esso e lo giudica. Il cristianesimo, dunque, contiene nella stessa
struttura della sua rivelazione l’antidoto contro ogni appiattimento a una sola dimensione,
contro il risolversi di tutto a una mutevole apparenza. In esso, invece, proprio nel rivelato si
manifesta, insieme, anche il rinvio a un’alterità: emerge, in altre parole, la profondità di una
differenza che non si sottrae al legame, pur restando differenza.
4.2. Qualcosa di analogo accade nell’ambito della comunicazione. Infatti ciò che la
comunicazione, come autentica apertura di uno spazio comune, di fatto rende possibile è
non già l’omologazione, ma il legame tra differenti che, attraverso la parola, condividono tutti
una medesima dimensione. Una dimensione in cui ciascuno, secondo giustizia, ha diritto di
accesso, condivide con altri, solidarmente, la partecipazione alla medesima comunità, è
responsabile, insieme ad essi, del mantenimento di un’interazione comunicativa che si
realizza anche attraverso il suo dire10.
Ciò che è decisivo, comunque, è che qui, nel comunicare, si attua davvero una
promozione delle identità specifiche e delle inevitabili diversità degli interlocutori. Tutto
ciò, proprio per quella via – la via della parola –, consente ad essi di rapportarsi l’uno
all’altro in un legame effettivo. “In principio era il Logos”, l’incipit giovanneo, qui significa
davvero che in principio è da sempre il rapporto, la relazione: una relazione che, di nuovo,
non appiattisce le differenze, ma appunto le costituisce, le accoglie e le promuove, secondo
la logica evangelica dell’amore11.
4.3. Questo conduce, da un punto di vista ancor più marcatamente etico, a rifiutare
l’idea che tutto sia consumabile senza residui e senza conseguenze. Non solo perché, di
fatto, questi “residui” – i rifiuti, di cui diventa sempre più problematico, al giorno d’oggi, lo
“smaltimento” – si accumulano sempre più in abbondanza. E nemmeno, unicamente,
perché le conseguenze, tragiche, dell’annientamento consumistico della natura e dell’uomo
sono sotto gli occhi di tutti. Ma perché, eticamente appunto, è necessario prendere
coscienza di nuovo, proprio mediante queste esperienze, che l’uomo, il mondo – in altre
parole: l’intero ambito del creato – richiede rispetto. Proprio per la sua irriducibile
differenza. Proprio perché resiste alla nostra assimilazione.
10
Si veda, per questi aspetti, K.-O. Apel, Etica della comunicazione, Jaca Book, Milano 1992.
11
Per un approfondimento di questa tematica mi sia consentito rinviare al mio libro I paradossi dell’amore fra
grecità, ebraismo e cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2000.
6
S’annuncia dunque la prospettiva di un nuovo legame, per il quale possiamo e dobbiamo
impegnarci. È quel legame che si realizza nel rispetto e nell’accoglienza, nella cura e nell’attenzione:
nell’attenzione per ciò che l’altro è, non per come appare. È quel legame che non riduce tutto
a strumento di controllo e di dominio, ma in cui si esprime una forma paradossale di
interesse: ancora una volta, l’interesse disinteressato dell’amore. È il legame, insomma, che
consente di “dare del tu” all’uomo e al mondo, e che rilegge il creato nella prospettiva della
relazione interpersonale. Dal momento che persona è appunto colui o colei che mai
potranno essere consumati.
5. Conclusione. Concludendo: quale idea di persona può essere allora adeguata al futuro
che ci attende? Possiamo rispondere, con una formula: quella persona che è in grado di
reintrodurre le differenze in una situazione d’indifferenza ormai diffusa; quella persona che è capace di
governare un tale futuro reintroducendo tutte le diversità che sono suscettibili di essere in
relazione e di promuovere relazioni. E che può farlo attraverso la parola, l’azione, l’amore.
Perché solo così, cristianamente, potrà essere compreso il senso del nostro essere e del
nostro operare. Perché solo così potrà essere indicato, nella testimonianza quotidiana, quel
senso ultimo che illumina ogni cosa.
7