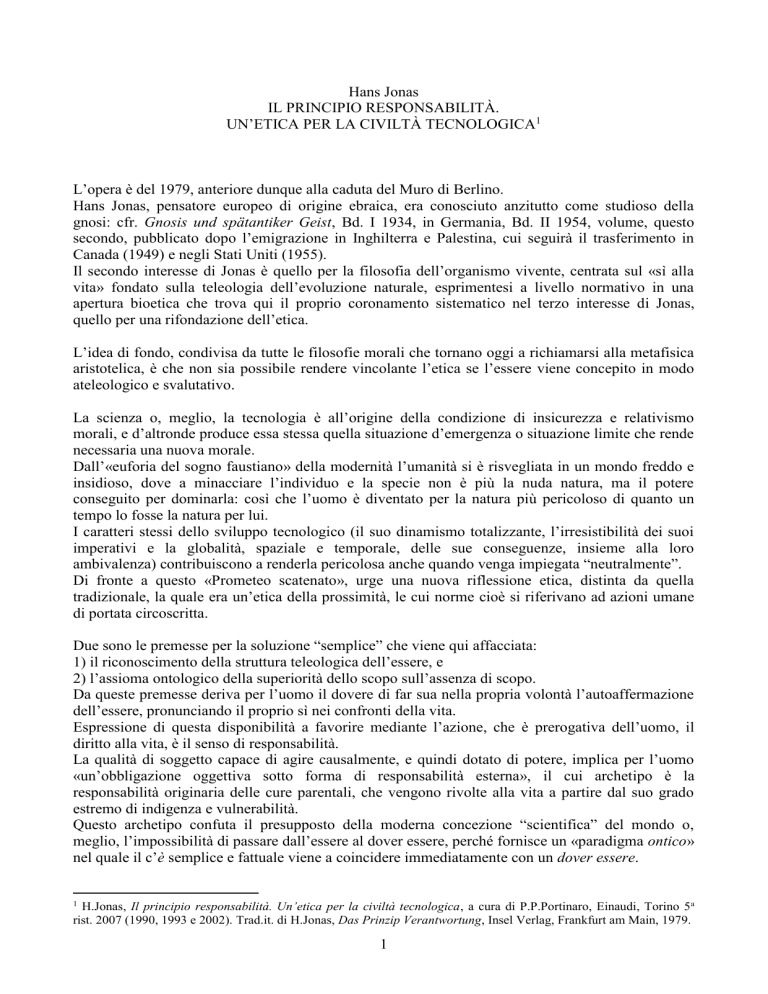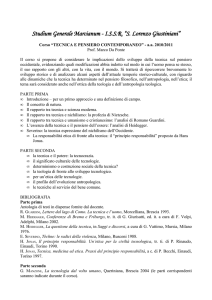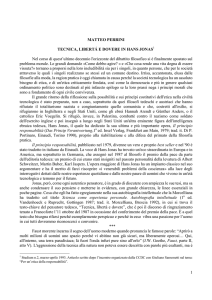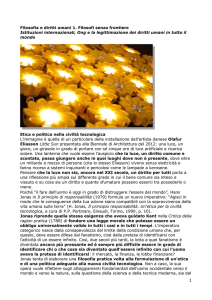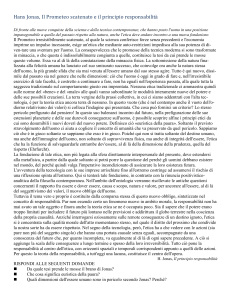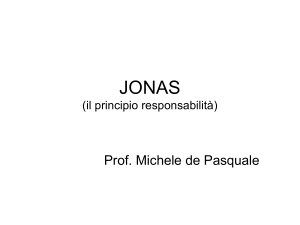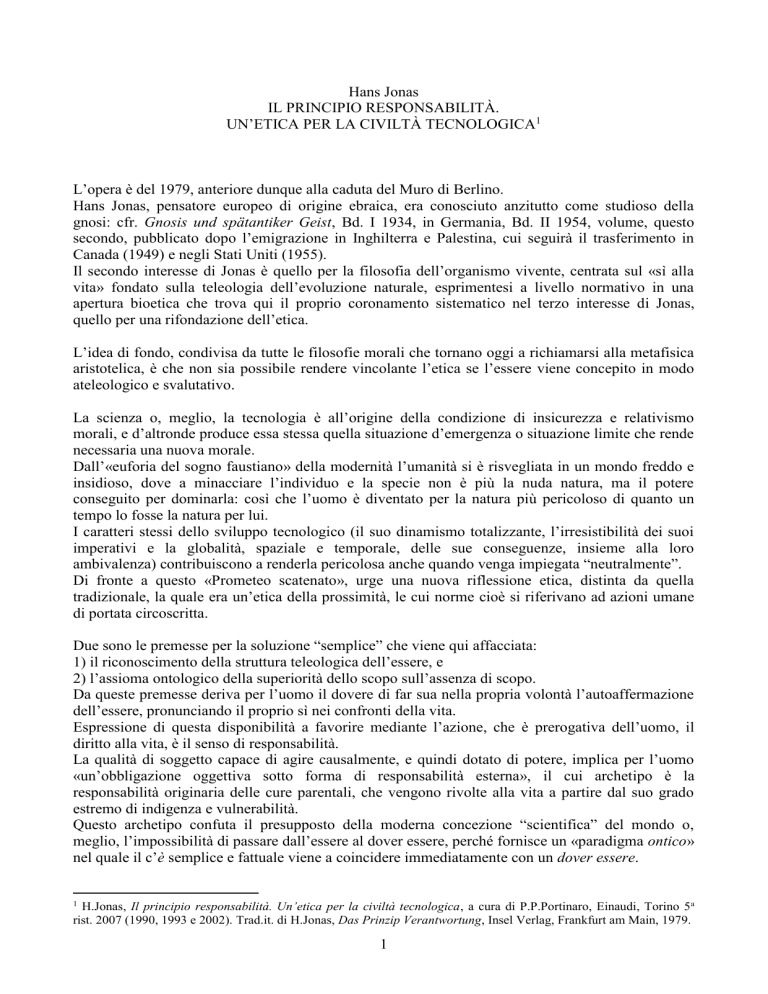
Hans Jonas
IL PRINCIPIO RESPONSABILITÀ.
UN’ETICA PER LA CIVILTÀ TECNOLOGICA1
L’opera è del 1979, anteriore dunque alla caduta del Muro di Berlino.
Hans Jonas, pensatore europeo di origine ebraica, era conosciuto anzitutto come studioso della
gnosi: cfr. Gnosis und spätantiker Geist, Bd. I 1934, in Germania, Bd. II 1954, volume, questo
secondo, pubblicato dopo l’emigrazione in Inghilterra e Palestina, cui seguirà il trasferimento in
Canada (1949) e negli Stati Uniti (1955).
Il secondo interesse di Jonas è quello per la filosofia dell’organismo vivente, centrata sul «sì alla
vita» fondato sulla teleologia dell’evoluzione naturale, esprimentesi a livello normativo in una
apertura bioetica che trova qui il proprio coronamento sistematico nel terzo interesse di Jonas,
quello per una rifondazione dell’etica.
L’idea di fondo, condivisa da tutte le filosofie morali che tornano oggi a richiamarsi alla metafisica
aristotelica, è che non sia possibile rendere vincolante l’etica se l’essere viene concepito in modo
ateleologico e svalutativo.
La scienza o, meglio, la tecnologia è all’origine della condizione di insicurezza e relativismo
morali, e d’altronde produce essa stessa quella situazione d’emergenza o situazione limite che rende
necessaria una nuova morale.
Dall’«euforia del sogno faustiano» della modernità l’umanità si è risvegliata in un mondo freddo e
insidioso, dove a minacciare l’individuo e la specie non è più la nuda natura, ma il potere
conseguito per dominarla: così che l’uomo è diventato per la natura più pericoloso di quanto un
tempo lo fosse la natura per lui.
I caratteri stessi dello sviluppo tecnologico (il suo dinamismo totalizzante, l’irresistibilità dei suoi
imperativi e la globalità, spaziale e temporale, delle sue conseguenze, insieme alla loro
ambivalenza) contribuiscono a renderla pericolosa anche quando venga impiegata “neutralmente”.
Di fronte a questo «Prometeo scatenato», urge una nuova riflessione etica, distinta da quella
tradizionale, la quale era un’etica della prossimità, le cui norme cioè si riferivano ad azioni umane
di portata circoscritta.
Due sono le premesse per la soluzione “semplice” che viene qui affacciata:
1) il riconoscimento della struttura teleologica dell’essere, e
2) l’assioma ontologico della superiorità dello scopo sull’assenza di scopo.
Da queste premesse deriva per l’uomo il dovere di far sua nella propria volontà l’autoaffermazione
dell’essere, pronunciando il proprio sì nei confronti della vita.
Espressione di questa disponibilità a favorire mediante l’azione, che è prerogativa dell’uomo, il
diritto alla vita, è il senso di responsabilità.
La qualità di soggetto capace di agire causalmente, e quindi dotato di potere, implica per l’uomo
«un’obbligazione oggettiva sotto forma di responsabilità esterna», il cui archetipo è la
responsabilità originaria delle cure parentali, che vengono rivolte alla vita a partire dal suo grado
estremo di indigenza e vulnerabilità.
Questo archetipo confuta il presupposto della moderna concezione “scientifica” del mondo o,
meglio, l’impossibilità di passare dall’essere al dover essere, perché fornisce un «paradigma ontico»
nel quale il c’è semplice e fattuale viene a coincidere immediatamente con un dover essere.
H.Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P.Portinaro, Einaudi, Torino 5 a
rist. 2007 (1990, 1993 e 2002). Trad.it. di H.Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1979.
1
1
In particolare, la responsabilità dell’uomo di Stato ne fornisce la generalizzazione più significativa,
nel passaggio dalla tutela dell’esistenza individuale a quella della sicurezza e del benessere
collettivi.
«Il Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e
l’economia imprime un impulso incessante, esige un’etica che mediante auto-restrizioni impedisca
alla sua potenza di diventare una sventura per l’uomo» (Prefaz., p. XXVII).
«In questo suo balenarci incontro dal futuro, nella prefigurazione delle sue estensioni planetarie e
delle sue durevoli conseguenze sull’uomo, è possibile scoprire alfine i principî etici da cui sono
desumibili i nuovi doveri del nuovo potere. Definisco ciò “euristica della paura”» (Ibidem).
Qui «il tema vero e proprio è costituito dalla comparsa stessa di questo nuovo obbligo, sintetizzato
nel concetto di responsabilità. Pur non essendo certo un fenomeno nuovo in ambito morale, la
responsabilità non ha mai avuto un tale oggetto e finora anche la teoria etica se ne è occupata poco.
Sia il sapere che il potere erano troppo limitati per includere il futuro più lontano nelle previsioni e
addirittura il globo terrestre nella coscienza della propria causalità»: per cui «la teoria della
responsabilità, a tutt’oggi una lacuna, costituisce il centro dell’opera» (Prefaz. p. XXVIII).
Dall’ampliamento della dimensione futura della responsabilità consegue quale tema conclusivo
l’utopia, con il connesso confronto con il marxismo, «la sola etica caratterizzata da una visione
globale del futuro che già esista […, che] ha elevato appunto, nel suo legame con la tecnica, l’utopia
a fine esplicito» (Prefaz. pp. XXVIII-XXIX).
Cap. I. La mutata natura dell’agire umano
La triplice premessa dell’etica tradizionale (1. La determinatezza della condizione umana, 2. La
determinazione del bene umano, 3. L’essere circoscritto dell’agire umano e della sua responsabilità)
sono cadute, in quanto «in seguito a determinati sviluppi del nostro potere si è trasformata la natura
dell’agire umano, e poiché l’etica ha a che fare con l’agire, […] il mutamento nella natura dell’agire
umano esige anche un mutamento dell’etica» (p. 3): non solo in quanto nuovi oggetti dell’agire ne
hanno ampliato l’ambito materiale, «ma in quello ben più radicale che la novità qualitativa di talune
nostre azioni ha dischiuso una dimensione del tutto nuova di rilevanza etica che non era prevista»
(Ibidem).
Nell’etica tradizionale, insomma, «L’universo morale consiste di contemporanei e il suo orizzonte
futuro è limitato alla durata probabile della loro vita» (p. 8), mentre «La natura come responsabilità
umana è certamente una novità sulla quale la teoria etica deve riflettere» (p. 10), spettandole «il
compito di istruire il sempre più necessario autocontrollo del nostro smisurato potere» (p. 12): la
biosfera sembra «qualcosa che è dato in custodia all’uomo e avanzi perciò nei nostri confronti una
sorta di pretesa morale, non soltanto a nostro ma anche a suo favore e in base a un proprio diritto»
(Ibidem), laddove «la scienza naturale non esaurisce l’intera verità della natura» (p. 13), al cui
riguardo «la tecnologia assume una rilevanza etica in virtù della centralità ora occupata nella finalità
umana soggettiva» (Ibidem): e qui «è il futuro indefinito, molto più che non lo spazio
contemporaneo dell’azione, a costituire l’orizzonte rilevante della responsabilità» (p. 14).
La città universale si pone ora come seconda natura: «Infatti il confine tra “polis” e “natura” è stato
cancellato. La città degli uomini (…) si estende ora alla totalità della natura terrena e ne usurpa il
posto. La differenza tra naturale e artificiale è sparita» (Ibidem), e «Questioni che non furono mai in
passato oggetto della legislazione, diventano di competenza delle leggi che la “città” totale deve
darsi affinché ci sia un mondo per le generazioni future» (p. 15).
Di qui la considerazione centrale innervante la proposta etica di Jonas: «La presenza dell’uomo nel
mondo era un dato originario e indiscutibile dal quale scaturiva ogni idea di dovere nel
comportamento umano; adesso essa stessa è diventata un oggetto dell’obbligazione – e
precisamente dell’obbligazione di assicurare per l’avvenire il presupposto fondamentale di ogni
obbligazione, ossia la presenza di semplici candidati a un universo morale nel mondo fisico»
(Ibidem), giacché «l’idea che l’umanità cessi di esistere non è affatto autocontraddittoria, come non
lo è l’idea che la felicità delle generazioni presenti e di quelle immediatamente seguenti sia ottenuta
2
al prezzo della sventura o addirittura della non esistenza delle generazioni future» (p. 16). Jonas
sviluppa in proposito un’argomentazione dialettica assai stringente, almeno a partire dal suo
postulato generale: «Il sacrificio del futuro per il presente non è, sul piano logico, più confutabile
del sacrificio del presente per il futuro. La differenza è soltanto che in un caso la serie [delle
generazioni] continua, nell’altro no. Ma il fatto che debba continuare, a prescindere dalla
distribuzione di felicità e sventura, anzi persino con il prevalere della sventura sulla felicità e
addirittura dell’immoralità sulla morale, non è deducibile dalla regola di autocoerenza all’interno
della serie […]. Si tratta di un imperativo di tutt’altro tipo, esterno e anteriore a essa, che si può
fondare in definitiva soltanto nell’ambito della metafisica» (Ibidem) [scilicet: in quanto è un
postulato metafisico che ogni essere tenda alla propria conservazione, mentre l’obbligo a dovervi
tendere sembra essere questione religiosa, lasciata per il momento in sospeso: cfr. p. 17].
Comunque, «Un imperativo adeguato al nuovo tipo di agire umano e orientato al nuovo tipo di
soggetto agente, suonerebbe press’a poco così: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione
siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra”» (p. 16).
Si evince agevolmente che l’imperativo non costringe a “sopravvivere a qualsiasi costo”, bensì
spinge a mantenere una vita dignitosa o degna di tale nome: sicché, precisa Jonas, «Io posso volere
il bene attuale sacrificando quello futuro; come posso volere la mia fine, posso volere anche la fine
dell’umanità. Senza cadere in contraddizione con me stesso, posso preferire, per me come anche per
l’umanità, il breve fuoco d’artificio di un’estrema autorealizzazione alla noia di una continuazione
infinita nella mediocrità. Ma il nuovo imperativo afferma appunto che possiamo sì mettere a
repentaglio la nostra vita, ma non quella dell’umanità», in quanto non abbiamo questo diritto, ed
abbiamo invece un dovere rispetto a ciò che non esiste ancora (pp. 16-17).
Il nuovo imperativo si rivolge molto di più alla politica pubblica che non al comportamento privato,
in relazione alla reciproca relazione causale, mentre «L’imperativo categorico kantiano era diretto
all’individuo e il suo criterio era nel presente» (p. 17): «Il nuovo imperativo evoca un’altra
coerenza: non quella dell’atto con se stesso, ma quella dei suoi effetti ultimi con la continuità
dell’attività umana nell’avvenire. E l’”universalizzazione” che esso prende in considerazione non è
affatto ipotetica, non è cioè la proiezione puramente logica dell’”io” individuale a un “tutti”
immaginario …» (Ibidem).
La proposta di Jonas di un’etica della responsabilità concernente il futuro è stata anticipata in
passato da tre forme di “etica del futuro”: «la condotta della vita terrena fino al sacrificio della
propria felicità in vista della salvezza eterna dell’anima; la preoccupazione preveggente del
legislatore e dello statista per il bene comune futuro; e la politica dell’utopia» (p. 18).
Se la prima, votata per Jonas ad un’etica dell’autoperfezione, egoistica e individualistica,
riconferma l’arrestarsi al presente dell’etica tradizionale – ma, in realtà (osserviamo), cade in realtà
con la stessa piena secolarizzazione della religione rivelata, ebraica o cristiana che sia (cfr. a p. 31:
«Ma una religione che non c’è non può sgravare l’etica dal suo compito» –, e la seconda si proietta
in un futuro pensato come sostanzialmente identico al presente, «L’etica dell’escatologia
rivoluzionaria considera se stessa come etica della transizione, mentre l’etica autentica
(sostanzialmente ancora ignota) le subentrerà a pieno diritto solo quando quella ne avrà creato le
condizioni attraverso la propria autoeliminazione» (p. 23). Oltre l’utopismo marxista, Jonas
ribadisce anzitutto che «Il potere della tecnica sul destino umano ha superato persino quello del
comunismo, che, al pari del capitalismo, pensava semplicemente di potersene servire» (Ibidem).
Lo strapotere della tecnica apre anzitutto nuove prospettive nel prolungamento della vita, stante che
la biologia cellulare apre la concreta prospettiva di contrastare i processi biochimici di
invecchiamento e di prolungare la durata della vita umana, differendone addirittura indefinitamente
(dice Jonas, qui forse troppo ottimisticamente) il termine. Ora, fino a che punto ciò è auspicabile,
per l’individuo e per la specie? Ne risulterebbe una percentuale decrescente di giovani in una
popolazione anziana: in che misura ciò inciderebbe positivamente o negativamente sulla condizione
umana generale? E fino a che punto sarebbe giusto occupare preventivamente il posto della
gioventù? (p. 25). In particolare, al limite, «se eliminiamo la morte, dobbiamo eliminare anche la
3
procreazione, perché quest’ultima è la risposta della vita alla morte [da notare qui l’incidenza della
concezione ebraica veterotestamentaria della vita]: avremmo così un mondo di anziani senza
giovani e di individui già noti senza la sorpresa di coloro che non esistevano precedentemente. Ma
forse è proprio questa la saggezza insita nella dura disposizione della nostra mortalità: quella di
offrirci la promessa sempre rinnovata di originarietà, immediatezza ed entusiasmo propria della
gioventù, unitamente al costante apporto di alterità in quanto tale» (pp. 25-26).
Una seconda prospettiva problematica è offerta dal controllo del comportamento che, originato
dall’esigenza appropriata di sollevare pazienti malati di mente da sintomi tormentosi e inibenti, si
estende al liberare la società dalla molestia di un comportamento individuale “problematico”,
trapassando dall’applicazione medica a quella sociale: «I gravosi problemi del dominio e
dell’anomia nella moderna società di massa rendono l’estensione di tali metodi di controllo a
categorie non mediche estremamente allettante ai fini della manipolazione sociale», donde «il
difficile problema di un’assistenza sociale che riduce il cittadino a suddito anziché emanciparlo» (p.
27), e sostituisce l’affrontare umanamente problemi umani con il cortocircuito di un meccanismo
impersonale che toglie dignità alla persona, procedendo sulla via che porta dai soggetti responsabili
ai sistemi programmati di comportamento.
In terzo luogo si pone il problema della manipolazione genetica, con la connessa «questione
concernente il diritto morale di condurre esperimenti su futuri esseri umani» (p. 28): «Ciò che non è
esistente non possiede nessuna lobby e i non nati sono impotenti. Pertanto il rendiconto dovuto a
questi ultimi non è ancora una realtà politica nell’attuale processo decisionale, e quando essi lo
potranno esigere, noi, i colpevoli, non ci saremo più» (p. 30).
Cap. II. Questioni relative ai fondamenti e al metodo
Oggetto dell’agire pubblico è il bene necessario ai remoti più che quello dei prossimi, per cui è
«difficile dire in che modo l’eventuale sapere dei pochi possa influire sull’agire dei molti» (p. 33).
Jonas ci prova, tentando una scienza oggettiva degli effetti a lungo termine o una scienza delle
previsioni ipotetiche, una “futurologia comparata” (che, a tratti, sa di fantafilosofia).
Questa scienza è centrata su quella che Jonas denomina «euristica della paura», alimentata da un
principio dialettico della conoscenza del bene e del male, espresso da Jonas in forma caratteristica:
«Sappiamo che cosa è un gioco soltanto se sappiamo che è in gioco. Infatti è naturale che la
percezione del malum ci riesca infinitamente più facile della conoscenza del bonum; essa è più
immediata, più plausibile, molto meno esposta a divergenze di opinioni e soprattutto non
intenzionale. (…) C’è da dubitare che qualcuno avrebbe mai tessuto le lodi della salute senza
perlomeno la vista della malattia, le lodi dell’onestà senza la vista della frode e quelle della pace
senza conoscere la miseria della guerra. Sappiamo molto meglio ciò che non vogliamo che ciò che
vogliamo. Perciò la filosofia morale deve consultare i nostri timori prima che i nostri desideri per
accertare quello che veramente apprezziamo. Ma benché ciò che è maggiormente temuto non sia
necessariamente ciò che va davvero temuto, e benché, ancor meno, il suo opposto sia
necessariamente il bene supremo (…) – benché dunque l’euristica della paura non sia certo l’ultima
parola nella ricerca del bene, essa è purtuttavia una prima parola estremamente utile» (p. 35), in
quanto «soltanto il previsto stravolgimento dell’uomo ci aiuta a formulare il relativo concetto di
umanità da salvaguardare; abbiamo bisogno della minaccia dell’identità umana (…) per accertarci
angosciati della reale identità dell’uomo [incidenza di Heidegger]. Finché il pericolo è sconosciuto,
non si sa che cosa ci sia da salvaguardare e perché. Il saperlo scaturisce, contro ogni logica e
metodo, dalla percezione di ciò che occorre evitare» (Ibidem).
Conseguentemente Jonas ritiene non solo utile, ma indispensabile «affidarsi alla guida della paura.
Questo avviene nell”etica del futuro” (…) nella quale ciò che va temuto non è ancora esperito», per
cui dovrà essere elaborato intenzionalmente (pp. 35-36), dove siamo non sul piano dell’apodittico,
ma del probabile, e dove risulta così inane la casistica tradizionale, in quanto l’ordine di grandezza
degli effetti a lungo termine non voluti è superiore a quello dell’effetto a breve termine voluto. In
forza dell’irresolutezza della previsione, il principio regolativo verrà ad esprimersi nel «precetto
4
secondo cui si deve prestare più ascolto alla profezia di sventura che non a quella di salvezza» (p.
39): «L’impresa fortunata è soltanto una fra innumerevoli alternative, che per il resto sono tutte,
quale più quale meno, colpi andati a vuoto [Karl R.Popper afferma che per raggiungere il bersaglio
in un tentativo occorre esprerirne 10.000, a vuoto, ma necessari per cogliere quel bersaglio]: ma se
nelle piccole cose l’uomo se ne può permetttere molti in vista delle più rare probabilità di successo,
nelle grandi cose se ne può permettere pochi e in quelle molto grandi, irreversibili (…) non se ne
può permettere in realtà nessuno» (pp. 39-40).
A ciò si aggiunge il fatto che «La grande impresa della tecnologia moderna, né paziente né lenta,
concentra (…) gli innumerevoli e piccoli passi dell’evoluzione naturale in pochi e colossali
interventi, privandosi così del vantaggio di una natura che, procedendo a tastoni [tentoni?], assicura
la vita», e «si priva altresì del tempo di correggere gli errori – ormai inevitabili e non più di poco
conto» (p. 40). Stante la sostituzione «della lunga scadenza dell’evoluzione naturale con la relativa
breve scadenza dell’agire umano», ed insieme il fatto che «ciò che per l’evoluzione è un lasso di
tempo molto breve, per l’uomo è invece molto lungo» (per la nostra impotenza circa le previsioni a
lungo termine), «ne deriverà l’esigenza imperiosa di attribuire, in materia di eventualità capitali, un
peso maggiore alla minaccia che non alla promessa» (Ibidem).
Come terzo fattore od elemento, caratterizzzante l’incedere del progresso tecnologico, si pone la sua
progressione a dir poco geometrica, per cui «alla constatazione che l’accelerazione dello sviluppo
alimentato dalla tecnologia non lascia più tempo all’autocorrezione, si aggiunge quella che anche
nel tempo lasciato le correzioni diventano sempre più difficili e la libertà di farle sempre più ridotta.
Il che consolida il dovere di vigilare sugli inizi» (p. 41: già san Tommaso, all’inizio del De ente et
essentia, ispirandosi al De coelo aristotelico, avvertiva che un piccolo errore all’inizio diventa
grande alla fine), «riconoscendo alle eventualità di sventura fondate con sufficiente serietà (e
diverse da semplici fantasie angosciose) una priorità sulle speranze, anche se queste non sono
peggio fondate di quelle» (Ibidem).
Sebbene il principio secondo cui «la posta in gioco non deve mai concernere la totalità degli
interessi altrui e soprattutto non la loro vita» possa trovare un’eccezione nel fatto che «Non si vorrà
contestare all’uomo di Stato il diritto di mettere a repentaglio l’esistenza futura della nazione,
quando siano davvero in gioco questioni ultime. Così vengono prese le terribili, ma moralmente
giustificabili decisioni sulla guerra e la pace in cui, in vista del futuro, la posta in gioco diventa il
futuro stesso» (p. 45: come accadde per es. nel caso dell’Inghilterra di Winston Churcill verso la
Germania di Adolf Hitler), resta che «Nella sua decisione fatale lo statista può tener conto idealiter
del consenso di coloro per i quali decide, in quanto loro intermediario. Ma dall’umanità futura non è
possibile ottenere e neppure supporre un consenso sul suo non-essere e sulla sua disumanizzazione»
(p. 46). A fronte di questa eventualità si erge il principio o postulato caratteristico dell’intera etica di
Jonas: «Infatti esiste (…) un incondizionato dovere dell’umanità all’esserci, che non va confuso con
il dovere condizionato di esistere di ogni singolo. Sul diritto individuale al suicidio si può discutere,
sul diritto dell’umanità al suicidio invece no» (p. 47) [per cui sembra superiore il valore della specie
su quello dell’individuo, e non pare il diritto di quella fondato sul diritto di questa]. Il nesso viene
chiarito nell’ulteriore enunciazione del principio: «non si deve mai fare dell’esistenza o dell’essenza
dell’uomo globalmente inteso una posta in gioco nelle scommesse dell’agire» (Ibidem). Si tratta di
un rovesciamento del dubbio cartesiano, o di una variante della scommessa di Pascal, svincolata dal
carattere eudemonistico (= individualistico) di quella.
Se l’obbligazione morale è qui espressione «di un dovere primario verso l’essere contro il nulla» (p.
48), e parimenti se «La pretesa all’essere inizia soltanto con l’essere» (p. 49: scilicet: dell’umanità),
poiché l’etica che cerchiamo ha a che fare con il non ancora esistente, «il suo principio di
responsabilità deve essere indipendente sia da ogni idea di diritto sia da quella di reciprocità» (p.
49): «Ora già nella morale tradizionale esiste un caso (…) di un’elementare non-reciproca
responsabilità e obbligazione, che viene riconosciuta e praticata spontaneamente: quella nei
confronti dei figli» (Ibidem), e la cura parentale della progenie rappresenta appunto per Jonas
l’archetipo emblematico del principio responsabilità, benché egli si affretti subito a chiarire che il
5
dovere verso le generazioni successive non è propriamente quello verso i figli, fondato questo «a
partire dalla responsabilità fattuale della nostra paternità» e «a partire dal diritto (…) inerente alla
(…) [loro] esistenza» (p. 50).
Il “dovere primario verso l’essere contro il nulla” comporta la decisa priorità del dovere verso
l’esserci dell’umanità futura sul dovere, pur coimplicato, verso il suo essere-così, per cui non è
legittimo «far dipendere l’auspicabilità e l’obbligatorietà di un’umanità futura dalle prevedibili
condizioni della sua esistenza» (p. 52). Quindi, «non consultiamo anticipandoli i desideri della
posterità (che possono essere un nostro prodotto), ma il suo dover essere (…). Rendere impossibile
ai posteri il loro dover essere è l’autentico crimine al quale fanno seguito solo in seconda battuta,
per quanto colpevoli possano essere, tutte le frustrazioni del loro volere. Questo significa che non
dobbiamo tanto vigilare sul diritto degli uomini futuri – ossia sul loro diritto alla felicità (…), ma
sul loro dovere, vale a dire sul loro dovere di autentica umanità: quindi sulla loro capacità di
attribuirsi e assolvere tale dovere» (p. 53), che resta pertanto subordinato all’obbligo, già
menzionato, verso l’esistenza di soggetti giuridici futuri, «il quale non risponde ad alcun diritto, ma
anzitutto ci conferisce fra le altre cose il diritto di mettere in vita esseri come noi senza interpellarli»
(Ibidem: e ciò, osserviamo, si spiega con il fatto che noi ci costituiamo termini del dono della vita
nel momento stesso nel quale la riceviamo). Per cui l’obbligo è «non tanto a donare la vita a coloro
che verranno dopo di noi (…) quanto piuttosto a pretenderla da loro».
Il primo imperativo di quest’etica è dunque quello che ci sia un’umanità, cui sono subordinati tutti
gli altri, imperativo fondato sulla responsabilità ontologica per l’idea dell’uomo, per cui «non siamo
assolutamente responsabili verso gli uomini futuri, bensì verso l’idea dell’uomo, che è tale da
esigere la presenza delle sue incarnazioni nel mondo» (p. 54: con il che si ribadisce il primato del
genere sull’individuo e dell’astratto sul concreto), come un imperativo non solo ipotetico, ma
categorico.
In proposito, Jonas critica due pregiudizi ricorrenti nel pensiero post-moderno: anzitutto, che non vi
sia nessuna verità metafisica; in secondo luogo, che non si possa dare passaggio dall’essere al dover
essere.
Contro il primo pregiudizio, Jonas rivendica, in un primo momento, l’”ordine della creazione” che,
non più sussumibile per fede, può però essere guadagnato razionalmente in sede, appunto,
metafisica, purché questa non sia costretta nei limiti angusti della scienza positiva, ed il cui vero
fondamento è la assoluta priorità dell’essere sul nulla: con l’avvertenza che «Il riconoscimento di
quella priorità, e quindi di un dover essere a favore dell’essere, non implica naturalmente dal punto
di vista etico che il singolo deva in ogni caso decidere per la propria sopravvivenza contro una
morte possibile o sicura, che deva cioè aggrapparsi alla vita. Il sacrificio della propria esistenza per
la salvezza altrui, per la patria, per una causa dell’umanità è un’opzione per l’essere e non per il non
essere» (p. 59). Ma, in generale ed anzitutto, la domanda leibniziana «Perché l’essere piuttosto che
il nulla?» trova risposta nella bontà del Creatore, ma, anche indipendentemente dalla fede religiosa,
essa sottointende il passaggio dall’essere di fatto all’essere di diritto: «Pertanto il senso della
questione del perché c’è qualcosa e non nulla deve essere: perché qualcosa deve avere la priorità sul
nulla, qualunque sia la causa per cui viene all’esistenza» (p. 61). Ed alla risposta a questo quesito è
dedicata la “posizione teleologica” dell’essere (di ascendenza vagamente aristotelica, cap. 3), che
comporta il superamento del secondo pregiudizio, cui è dedicato il cap. 4.
Cap. 3. Sugli scopi e la loro posizione nell’essere
xxx
6
BILANCIO CRITICO
La proposta di Jonas è stata oggetto di varie valutazioni e critiche:
- da una parte, Karl-Otto Apel, preso atto che si tratta di «un’etica della conservazione, della
salvaguardia, della prevenzione e non del progresso e della perfezione», ha rilevato come
problematica sia la rinuncia all’idea moderna di progresso, con il suo contenuto di emancipazione e
la sua carica utopica;
- in secondo luogo, anche il porsi il fine minimo della sopravvivenza dell’umanità e di un’umanità
definita ontologicamente in base all’idea della dignità dell’uomo, la sua salvaguardia può risultare
effettiva solo in virtù di un’estensione planetaria dei rapporti sociali e dell’evoluzione e del
progresso tecnologico e sociale che tale dignità storicamente riflettano e inverino.
- in terzo luogo, questo ripensamento della morale trova effettiva fondazione meno sulla fondazione
metafisica del primato del dover essere su quello dell’essere, o sul «dover essere dell’essere», che
su quella che Jonas propone, come vedremo, come un’«euristica della paura».
- da parte nostra, osserviamo anzitutto che, di diritto e di fatto, il futuro, in quanto tale, non può
essere oggetto diretto di norma morale;
- rileviamo inoltre come sia alquanto problematico fare della vita il valore supremo, vita che, in
effetti, può essere di fatto sacrificata per un’ideale più alto o per amore (come nel caso dei martiri o
degli eroi),
- mentre la stessa idea del postulato assoluto o della condizione primaria della sopravvivenza
dell’umanità ci sembra rifletta piuttosto l’espressione di una secolarizzazione di un preciso
elemento della religiosità ebraica, che vedeva, nell’Antico Testamento, proprio nella prole e nella
abbondanza della generazione una particolare benedizione divina.
L’opzione di Jonas per la via di mezzo, la moderazione e la cautela pone il «principio
responsabilità» (Das Prinzip Verantwortung) in una posizione di equidistanza rispetto alle due voci
estreme della filosofia del Novecento, tra il (più celebre) «principio speranza» (das Prinzip
Hoffnung) di Ernst Bloch, cui l’opera di Jonas intende esplicitamente contrapporsi, e il «principio
disperazione» di G.Anders: filosofie comunque tutte accomunate non solo dall’urgenza di fare del
futuro il loro problema centrale, ma anche dalla ferma volontà di mantenersi fedeli ad un concetto
integro di umanità, non depauperato della sua dimensione emotiva e delle sue radici organiche.
7