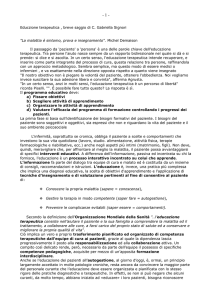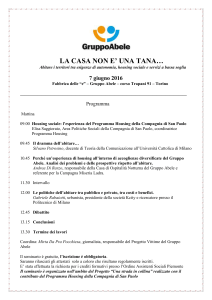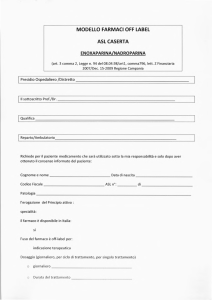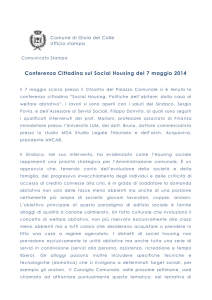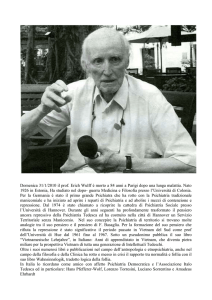La Comunità Terapeutica
nel continuum dell'assistenza a lungo termine
Antonio Maone
Non basta far nascere,
bisogna poi far vivere.
Racamier (1997)
In questo capitolo tenterò di mettere a fuoco una questione che attraversa tutto il campo della
psichiatria di comunità e che coinvolge in modo particolare la funzione delle Comunità
Terapeutiche. Si tratta del problema di come integrare e rendere coerenti, in una prospettiva di
lungo termine, i diversi interventi terapeutici che si succedono lungo il decorso dei disturbi mentali
gravi. Lungo tale prospettiva temporale, la presa in carico in Comunità Terapeutica rappresenta
senz'altro un nodo strategico essenziale, in quanto su di essa convergono tipicamente forti
investimenti e aspettative. Tuttavia, benché intensamente investito ed esteso nel tempo, questo
percorso finisce comunque per rappresentare “solo” un segmento della storia clinica e dell'intero
ciclo vitale del paziente. Ed è verosimile che, in carenza di coerenza ed appropriatezza delle azioni
che si susseguono dopo il percorso in Comunità Terapeutica, i risultati grazie ad esso raggiunti
rischino non solo di non evolvere ulteriormente, ma perfino di disperdersi e vanificarsi.
Dopo aver riassunto gli indizi e le prove a conferma di questa tesi, tenterò di indicare lungo quali
direzioni ci si possa oggi muovere e attraverso quali paradigmi sia possibile cercare nuove
soluzioni. A tal fine, eviterò di addentrarmi, se non marginalmente, nel processo inerente
l'intervento terapeutico-riabilitativo in Comunità per sé, che pure è strettamente correlato al nostro
tema per la rilevanza che le dinamiche separative possono assumere nel processo di dimissione e
per come possano condizionare il seguito del percorso terapeutico. Prenderò in considerazione,
invece, in una prospettiva più ispirata ad un approccio di salute pubblica, ciò che si situa al di là del
percorso comunitario, iniziando da alcune evidenze riguardanti proprio il primo snodo, quello in cui
può essere messa in questione la stessa praticabilità della separazione e della dimissione del
paziente.
Strutture intermedie e dipendenza istituzionale
C'è un leitmotiv che si ripropone lungo i vari passaggi del processo di de-istituzionalizzazione,
relativo al rischio (accompagnato da disillusione e preoccupazione) che le strutture intermedie
tendano a riprodurre il fenomeno della dipendenza istituzionale. E' un fenomeno indagato
dall'osservazione epidemiologica ed a cui fanno riscontro osservazioni “impressionistiche” che
hanno dato luogo a metafore pregnanti, nel corso degli ultimi decenni.
Fin dagli anni '70, nell'ambito degli Hopitaux de Jour francesi, ad esempio, o dei Day Hospital
britannici, sono emersi richiami in questo senso, sintetizzati da rappresentazioni metaforiche che
descrivono il modo in cui una struttura, un gruppo di lavoro, si auto-percepiscono: “il demone della
cronicizzazione” (Chanoit, 1977), che ci si era illusi di aver messo fuori gioco con il superamento
del manicomio, ma che rientra e si installa insidiosamente nelle strutture intermedie alternative ad
esso, alimentato dal perdurare indefinito della dipendenza dei pazienti; o l'immagine del silting up,
cioè l'insabbiamento dei porti (Pryce, 1982), per rappresentare gli effetti del lento turn-over; o,
ancora, l'immagine del campo sociale della Comunità Terapeutica come “labirinto” istituzionale dal
quale può essere molto difficile uscire (Moroni et al., 1998). Metafore che legittimano la
proposizione del dilemma paradossale: “sortir de la psychose ou sortir de la psychiatrie?” (Reynaud,
1990); e che confermano la necessità di formulare una via d'uscita, ripensando la riabilitazione
psichiatrica proprio in termini di “fine dell'intrattenimento” (Saraceno, 1995).
L'indagine epidemiologica sui sistemi di psichiatria di comunità ha dato consistenza quantitativa a
tali rappresentazioni; sia, su un piano più generale, attraverso l'evidenza della lungoassistenza nei
servizi psichiatrici territoriali (Wing & Haley, 1972; Tantam & McGrath, 1989; Balestrieri, 1990;
Veltro et al., 1993), sia riguardo alle strutture semi-residenziali (Maone, 1998; Maone et al., 2002) e
residenziali. In queste ultime, in particolare, è stato evidenziato (de Girolamo et al., 2002) che il 38
% di esse non ha dimesso alcun paziente in un anno ed il 31% ne ha dimesso uno o due. Bisogna
tener presente, tuttavia, che questo studio ha esplorato un campo fortemente eterogeneo,
comprensivo di tutte le tipologie di strutture residenziali non ospedaliere. Inoltre, per il 40% si tratta
di pazienti con un lungo passato istituzionale, precedentemente ricoverati in ospedale psichiatrico.
Non sappiamo, quindi, quante siano le strutture che abbiano, almeno programmaticamente, una
mission che ricada propriamente nel campo degli interventi terapeutico-riabilitativi. Nonostante tali
limitazioni, però, da questo studio emerge anche che i responsabili delle strutture ritengono che per
il 28% dei pazienti ospitati sarebbe opportuno un minore livello di “protezione”: tuttavia, solo per il
7% è prevista la dimissione nei 6 mesi successivi (de Girolamo et al, 2005). Un campione limitato,
ma più utile alla nostra analisi, è stato oggetto di uno studio svolto in tre strutture residenziali in
Lombardia, caratterizzate da una mission terapeutico-riabilitativa. Gli Autori concludono che,
malgrado quanto dichiarato programmaticamente, “le strutture esaminate non hanno carattere
puramente transizionale, in quanto circa ¾ dei pazienti ha degenze protratte talvolta per anni” (Lora
et al., 2004)1.
E' un fenomeno, peraltro, la cui interpretazione può rivelarsi controversa. Da una parte, infatti, esso
può essere considerato come indizio di una situazione morbosa, nella quale aspetti inerenti alla
psicosi interagiscono con risposte istituzionali collusive, in un gioco di rinforzo reciproco che dà
luogo ad interventi routinari, restringimento progressivo delle prospettive evolutive, perdita di
vitalità e dinamismo, rassegnazione, o perfino regressione e degrado; dall'altra, il perdurare della
presa in carico intensiva può essere legittimamente interpretato come un'opportuna adattabilità del
servizio ai bisogni a lungo termine dei pazienti più gravi (Wiersma et al., 1995).
Operatori e pazienti, buone intenzioni e circoli viziosi
La dipendenza istituzionale, con le sue conseguenze negative e “cronicizzanti”, sembra dunque
essere un rischio implicito nei dispositivi di cura e riabilitazione dei disturbi mentali. La
complessità della sua analisi è verosimilmente dovuta ad una serie di macro e micro-fattori che
interagiscono incessantemente (aspetti intrinseci ai disturbi e al loro decorso, atteggiamenti dei
familiari e degli operatori, pregiudizi sociali, vincoli legislativi e istituzionali, situazioni locali,
ecc.). Il fenomeno osservabile è solo il portato finale di tale complessa interazione.
Da tale complessità cercheremo ora di enucleare un aspetto centrale, quello riguardante l'interazione
fra pazienti e operatori, intorno a cui nel corso delle ultime decadi sono state prodotte analisi
approfondite. In particolare, nell'ambito della riflessione guidata da un approccio di derivazione
psicoanalitica, si possono citare alcuni contributi significativi. Correale (1991), ad esempio, ha
messo a fuoco il rischio di una dipendenza reciproca illimitata che può favorire nel paziente, sulla
base di una debolezza delle forze coesive del Sé, un uso tossicomanico dell’istituzione curante.
In modo ancora più incisivo, Pazzagli e Rossi hanno sostenuto che proprio nell'offrire la propria
mente come contenitore dell'altro si delinea il grande problema del circolo vizioso fra curante e
curato, in cui il curante sopravvive mentalmente solo per la presenza del curato, ed il paziente
instaura quella dipendenza che o è “in mancanza di meglio”, o è distruttiva per la salute mentale
1
A proposito dell’utilità e dei rischi del perdurare della presa in carico in Comunità Terapeutica, sono
interessanti i risultati di uno studio recente sull’utenza delle Comunità Terapeutiche del Lazio; è stato
osservato, attraverso l’uso di strumenti di valutazione, che i livelli di isolamento emotivo e appiattimento
affettivo ed alcuni aspetti cognitivi si riducono significativamente nei pazienti nel corso dei primi 2 anni di
permanenza, mentre tornano ad aumentare successivamente, col prolungarsi di essa (Soscia et al, 2005).
sua, ma anche degli operatori. Questo anaclitismo, questa “nuova patologia, la patologia seconda, è
in realtà la relazione col curante, che è forse la condizione migliore che si possa ottenere, (...) e che
il servizio potrebbe tanto più accentuare quanto meglio funziona” (Pazzagli e Rossi, 1991).
Per quanto riguarda la Comunità Terapeutica, sembra che un elemento fondamentale nella genesi
del problema sia da rintracciare nelle procedure necessarie all'ingaggio del paziente psicotico nel
processo terapeutico, nella creazione delle condizioni minime necessarie alla sua trattabilità; ovvero
nella necessità di favorire, lungo la fase di inserimento, “lo sviluppo di un rapporto simbioticofusionale, preludio indispensabile per dare avvio ai primi movimenti identificativi (…) e per la
costruzione di un’alleanza terapeutica” (Agrimi e Vigorelli, 1998). Il paziente deve trovare, in altri
termini, una “residenza emotiva” (Zapparoli, 1987), in cui l’equipe garantisca la risposta ai bisogni
di attaccamento e di accudimento. Il rischio insito in questo irrinunciabile passaggio, tuttavia, è che
la gratificazione ottenuta alimenti idealizzazioni onnipotenti e durevoli (nei pazienti e nei curanti),
rendendo complesso, poi, il lavoro di dimissione. Lavoro che va quindi previsto, formulato e
pianificato, con tutta l'attenzione necessaria alle dinamiche separative ed ai lutti connessi. A questo
proposito, Sassolas, riprendendo una concettualizzazione di Racamier, sostiene che il paziente
sviluppa “una strategia inconscia di seduzione narcisistica, la quale è agita, non fantasmatizzata o
pensata, espressa dunque in azioni e comportamenti in grado di attivare nei curanti il fantasma di
essere indispensabili alla sua sopravvivenza psichica e fisica, cioè comportamenti di autosqualificazione. Se si prendono per denaro contante questi comportamenti, cioè se si vede in essi
l'espressione di una patologia definitivamente insediata, piuttosto che un elemento della relazione
del paziente con i curanti, la situazione rischia di bloccarsi nella ripetizione e quindi nella cronicità”
(Sassolas, 2007).
Il concetto di auto-squalificazione così formulato sembra trovare una certa analogia con quello,
proveniente da tutt’altro ambito teorico, di “passività appresa” (learned helplessness), dove pure è la
situazione ambientale, caratterizzata da paternalismo e rassegnazione, ad alimentare nel soggetto il
graduale strutturarsi della convinzione di non farcela da solo (Seligman, 1994). Una concezione
analoga si ritrova poi alla base dei recenti modelli statunitensi di riabilitazione psichiatrica (Farkas,
2007) e di case management (Rapp e Goscha, 2006), che puntano su un ribaltamento dell’approccio
riabilitativo tradizionale, condizionato dal medical paternalism e focalizzato sulla fragilità e sul
deficit, a favore di una visione che valorizzi i “punti di forza” e le risorse personali e ambientali.
La diffusione dell’atteggiamento paternalistico sembra essere documentata da ricerche che hanno
esplorato le attitudini ed i pregiudizi degli operatori psichiatrici. Uno studio condotto a Zurigo
(Nordt et al., 2006) su un vasto campione, ha sorprendentemente rilevato la stessa “distanza
sociale” e gli stessi pregiudizi verso la malattia mentale negli operatori rispetto a quelli rilevati nella
popolazione generale. Altri studi hanno evidenziato sostanziali diversità di punti di vista fra
operatori e pazienti circa i bisogni e i desideri di questi ultimi (Middleboe et al., 1998; Fakhoury et
al., 2005); in particolare, in merito alle aspettative di dimissione da strutture residenziali, gli
operatori mostrano marcati pregiudizi riguardo al desiderio dei pazienti di accedere ad una
prospettiva di vita autonoma.
Sembra dunque che uno dei fattori essenziali alla base della dipendenza istituzionale possa essere
individuato nella relazione del paziente coi curanti, nella quale, anche a causa della paradossalità
del mandato (coinvolgere il paziente nel processo terapeutico attraverso un'”accoglienza”
persuasiva e protettiva, ma nel contempo non perdere di vista la necessità di favorire l’autodeterminazione) e malgrado le migliori intenzioni, è sempre operante il rischio che si instaurino
circoli viziosi di difficile risoluzione, che possono anche esitare in pratiche cronicizzanti, o perfino
iatrogene. Si direbbe anzi, in questo senso, che proprio nelle pieghe della relazione pazienteoperatore si potrebbero rintracciare alcuni dei meccanismi che sostengono la “costruzione sociale”
della disabilità e della cronicità.
Va ricordato, infine, che se una struttura nasce col mandato di “restituire” il paziente alla comunità,
dopo un’adeguata presa in carico intensiva all’interno di un setting residenziale di durata
ragionevole, ma poi, di fatto, risulta impedita ad operare tale restituzione non solo per i fattori
appena descritti, ma anche per ragioni esterne (vincoli istituzionali e normativi, scarse opportunità
per far transitare i pazienti in setting meno intensivi, carenza di mezzi e di competenze, ecc.), ciò
finisce per ripercuotersi sul clima interno e sul morale degli operatori, che rischiano di sperimentare
tale impedimento come fallimento, più o meno esplicito, del mandato stesso. Le conseguenze di
situazioni di questo tipo sono tutt’altro che secondarie, ed alimentano un ulteriore circolo vizioso,
se si considera il sostanziale impatto di fattori come l’atmosfera, il milieu e la motivazione degli
operatori sulla validità e la qualità delle pratiche comunitarie, e quindi, in ultima analisi, sugli esiti.
Continuità e transitorietà
Se da una parte è opportuno, come abbiamo visto, sorvegliare i circoli viziosi che caratterizzano
l’interminabilità della relazione, dall’altra va tenuta presente la necessità, dettata dalla durata e dalla
imprevedibilità dei decorsi psicotici, di garantire la continuità della presa in carico. Tale continuità
viene generalmente intesa non come costanza o invariabilità del setting, bensì come coordinamento
e flessibilità delle risposte ai differenti bisogni nelle differenti fasi e circostanze del decorso, nonché
garanzia della pronta accessibilità di tali risposte nel tempo (Haggerty et al., 2003).
Il processo di deistituzionalizzazione e lo sviluppo della psichiatria di comunità sono stati
accompagnati da una costante insistenza intorno a questa necessità. Lo stesso concetto di settore, o
di area territoriale, si fondano su questa pietra angolare. Ed è da questa matrice che ha preso forma e
si è diffuso il concetto di linear continuum nell’ambito della residenzialità psichiatrica (Budson,
1990): lo sviluppo di un continuum graduale di programmi di trattamenti residenziali attraverso il
quale il paziente “progredisce” verso un migliore funzionamento sociale e quindi verso setting
meno restrittivi (Lehman e Newman, 1996). Per realizzare ciò in ogni area territoriale è necessario
prevedere un ventaglio coordinato e coerente di strutture a diversi livelli di intensità assistenziale,
ognuna delle quali possa rispondere in modo appropriato ai bisogni contingenti. Il paziente
dovrebbe quindi transitare lungo tale filiera di servizi, in relazione al grado di autonomia raggiunto,
tendendo idealmente ad uscirne per accedere alla “vita indipendente”, o, eventualmente,
“retrocedere” in caso di peggioramento del suo stato. Si tratta di un paradigma che, forse anche per
la sua apparente semplicità concettuale, ha trovato una larga diffusione. Esso è, per esempio,
implicito nelle raccomandazioni del Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000
(Ministero della Salute, 1999), in cui, “con lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità
emancipative”, sono previste strutture “differenziate in base all’intensità di assistenza sanitaria (24
ore, 12 ore, fasce orarie)”.
Se compiutamente realizzato, un sistema di questo tipo dovrebbe perciò, ad esempio, assicurare che,
una volta “concluso” il programma terapeutico-riabilitativo in Comunità Terapeutica e risolta in
modo ottimale la dipendenza del paziente dalle relazioni significative che lì ha intrattenuto, si
inauguri un cursus honorum verso il reinserimento sociale a pieno titolo.
Ma, per una serie di ragioni, ciò accade molto di rado. Innanzitutto perché realizzare una tale rete di
strutture differenziate in ciascuna area territoriale è complicato e costoso. Molto spesso l’impresa
viene pianificata, ma poi, per inerzia istituzionale o per carenza di risorse viene realizzata solo in
parte; costituendo ciò un primo ostacolo2. Qualora, poi, il “posto” in una struttura a minore
assistenza fosse disponibile, questa dovrebbe prendere in carico il paziente solo per un ulteriore
segmento temporale (se così non fosse, il sistema si saturerebbe rapidamente, compromettendo il
turn-over). Peraltro, questo processo di transizione richiede delicati passaggi del paziente da
2
Nell'ambito del Progetto PICOS-Veneto, un recente studio multicentrico regionale, è stata realizzata
un'indagine sui DSM, che, a proposito della residenzialità, conclude: “Il gradiente decrescente della dotazione di
residenze, da quelle a maggiore protezione ed intensità di trattamento verso quelle che prevedono maggiori livelli di
autonomia, fa ipotizzare che in molti DSM possa configurarsi una situazione a “collo di bottiglia” in uscita: la scarsa
dotazione di Comunità Alloggio e Appartamenti semiprotetti potrebbe impedire ai DSM di promuovere, per quegli
utenti delle Comunità Terapeutico-Riabilitative con più bassi livelli di disabilità, una possibile esperienza di vita
progressivamente autonoma, favorendone invece lo stazionamento in Comunità e procrastinando sine die gli eventuali
tempi della verifica finale; da ciò ne conseguirebbe una saturazione dei posti letto, scarso o assente turn-over degli
utenti (...), col rischio di cronicizzazione per i nuovi e più giovani psicotici che magari potrebbero beneficiare di un
tempestivo trattamento riabilitativo in una cornice protetta residenziale” (Lasalvia et al., 2007).
un’equipe ad un’altra; e tale delicatezza può essere fonte di instabilità, vulnerabilità e perdita dei
supporti sociali costruiti nella situazione precedente.
In ogni caso, le varie transizioni vengono decise dai curanti sulla base di una propria valutazione di
“idoneità”; di conseguenza il paziente rischia di non avere alcuna opportunità di scelta personale. E
d’altronde, considerata anche la ristrettezza a monte delle opzioni possibili, non sempre i curanti
possono scegliere la soluzione più adeguata al caso, dovendosi spesso accontentare di sistemare il
paziente “dove c’è posto”.
Che il paradigma del continuum residenziale fosse inaffidabile, del resto, è già apparso chiaro da
tempo nelle situazioni in cui era stato pianificato e sottoposto a verifica: le transizioni attese si
realizzavano solo in minima parte, e generalmente il percorso dei pazienti si bloccava nel primo slot
della serie prevista (Geller, 1993). Ad una valutazione a posteriori, le conseguenze della sua
applicazione sono state descritte come una sorta di “ottovolante di successi e fallimenti indotti dal
sistema stesso, che lasciava tutti gli attori coinvolti in uno stato di grave frustrazione e
demoralizzazione” (Bigelow, 1998); e si è fatta strada la convinzione che il “mito” del continuum
lineare andasse seriamente ridimensionato.
Continuità e flessibilità
L'errore di fondo che rende difficoltosa l'applicazione del continuum residenziale risiederebbe nello
stretto legame fra alloggio e assistenza che lo caratterizza in tutti i suoi passaggi (Ridgway e Zipple,
1990). Mentre, infatti, il bisogno di assistenza, derivante dagli aspetti clinici e dalla disabilità, può
manifestare variazioni significative lungo il decorso (come dimostrano gli studi catamnestici), il
bisogno di un luogo in cui vivere è invece una necessità costante ed universale, non solo per il
paziente, ma per tutti gli esseri umani e per tutta la vita. La sistematica (ed impropria)
sovrapposizione di queste due dimensioni rischia di creare le premesse perché diventino confuse e
fra esse intercambiabili. Se poi si considera l'andamento delle evoluzioni a lungo termine dei quadri
psicotici, lungo le quali fatalmente le aspettative e gli investimenti sul trattamento tendono ad
affievolirsi, allora il luogo in sé, cioè la mera collocazione fisica del paziente, rischia di divenire
l'obiettivo sostanziale, verso cui tende a confluire ed a esaurirsi l'intero senso del “progetto
terapeutico”. Col passare del tempo, il bisogno del paziente tende a coincidere con il bisogno della
sua collocazione, peraltro mai definitiva. Infatti, i diversi segmenti del continuum vengono
concepiti come transitori, e ognuno di essi deve essere provvisto di una cornice istituzionale atta a
regolare la durata della permanenza, le forme ed i livelli di tutela dei pazienti e le rispettive
responsabilità dei curanti.
L'effetto complessivo di tale processo è che la traiettoria esistenziale del paziente si trova ad essere
costantemente vincolata alla collocazione spaziale del provider (Saraceno, 2005), anziché essere
modulata sulla naturale variabilità temporale dei suoi bisogni.
Nei primi anni '90 è stato proposto un ribaltamento radicale del paradigma del continuum lineare,
ribaltamento fondato innanzitutto sulla disgiunzione (de-linking) fra alloggio e assistenza. Ne
consegue che: 1) bisogno di alloggio e bisogno di assistenza possono essere messi a fuoco e valutati
separatamente; 2) si può rispondere al primo con una casa “vera e propria”, dignitosa e non
transitoria; 3) ai bisogni di cura e assistenza si provvede attraverso una rete flessibile di assistenza
domiciliare, associata ad una reperibilità di 24 ore su 24 degli operatori (Carling, 1993). Questo
approccio, definito supported housing3, ha avuto una certa diffusione negli Stati Uniti ed in Canada,
dove è stato anche sottoposto a verifiche di efficacia (Ridgway e Rapp, 1997; Rog, 2004) ed è stato
accreditato come best practice (Public Health Agency of Canada,1997; SAMHSA, 2003). Il terreno
su cui esso ha preso le mosse è quello dell’empowerment e del modello di riabilitazione psichiatrica
di Boston, armonizzandosi con le filosofie di intervento basate sui concetti di recovery ed autodeterminazione (Anthony et al., 2003), incontrando anche grande favore da parte delle associazioni
di utenti e familiari (Power, 2006).
Del resto, anche in Italia, in una serie di esperienze innovative che si vanno sviluppando negli
ultimi anni, si ritrovano alcuni dei principi essenziali di questo approccio: la rete di appartamenti
nel centro di Torino (Xocco et al, 2006), ad esempio, o la Comunità Sabrata di Roma, in cui una
onlus di familiari e utenti svolge un ruolo di mediazione sociale per il reperimento degli alloggi nel
libero mercato immobiliare (Maone, 2005; Maone et al., 2008).
Il potenziale vantaggio di questo tipo di approcci sta nella possibilità di promuovere, attraverso
l’abitazione, intesa quale elemento-chiave dell’intero processo, uno stabile radicamento del paziente
nel tessuto sociale, una sorta di restituzione di un pezzetto di territorio su cui egli possa avere il
controllo, costruendo intorno ad esso una rete di supporto flessibile ma dotata di coerenza e
continuità e modulata sul profilo individuale dei bisogni. La sua realizzazione, però, richiede uno
sforzo “collettivo” che sia in grado di superare gli steccati convenzionali dei ruoli, fra sociale e
sanitario, fra pubblico e privato, ma anche fra utenti e servizi, familiari e servizi. In altri termini,
sembra che piuttosto che dall’essere pianificate dall’alto, il successo di tali iniziative dipenda
proprio dalla possibilità di agire dal basso, mettendo insieme le risorse disponibili sul campo,
3
Questo termine è usato nella letteratura anche con un significato più generale, con riferimento ad
ogni tipo di alternativa residenziale extra-ospedaliera. Nel significato ristretto qui utilizzato è stato invece
introdotto da Ridgway e Zipple (1990) e Carling (1993). Parkinson (1999) lo distingue, inoltre, anche dal
termine supportive housing, riferito alle soluzioni abitative di tipo istituzionale, come board and care homes,
halfway houses, ecc. Per una revisione in italiano della letteratura sull'approccio di supported housing si
rimanda a: Maone (2006).
mettendo in moto e coordinando, attraverso leadership adeguate, la partecipazione attiva di tutti gli
attori in gioco.
Tali “spinte in avanti” ricordano da vicino la lezione di Ciompi, che affermava la necessità di
“provocare uno scatto terapeutico onnipervasivo che spinga in una direzione chiaramente definita,
al quale, alla fine, tutti coloro che si trovano coinvolti non possano sottrarsi”; adottare “quale
supremo principio terapeutico la formulazione di obiettivi espliciti e concreti, ad esempio il
trasferimento in un’abitazione privata”; considerare la scelta dell’obiettivo “già una parte essenziale
della terapia, stabilito mediante una trattativa, sotto forma di un contratto da tutti approvato nel
lavoro in comune con il paziente, i componenti della famiglia, l’équipe terapeutica e le altre persone
coinvolte nell’assistenza” (Ciompi, 1982; corsivi dell’Autore).
L’abitazione con supporto flessibile sembra quindi riuscire a scardinare la macchinosità del
continuum residenziale, ponendosi come obiettivo concreto da realizzare ad un certo punto del
percorso e formulato insieme al paziente. La diffusa implementazione di questo tipo di soluzione
potrebbe ottenere due significativi risultati: da una parte, dotare la Comunità Terapeutica di una rete
esterna in grado di assicurare una effettiva presa in carico territoriale a lungo termine, evitando così
prolungamenti impropri e dannosi, nonché dispersioni e drop-out; dall’altra, stimolare nei servizi
territoriali un deciso decentramento dell’asse dell’assistenza dagli ambulatori ai luoghi reali di vita,
in più stretta conformità al mandato della psichiatria di comunità, avvalendosi di pratiche ormai
ampiamente accreditate, come l’assertive outreach (Burns e Firn, 2003).
Occorrerebbe che la soluzione abitativa fosse però già ben presente nella mente degli operatori e dei
pazienti della Comunità Terapeutica fin dall’inizio del percorso, secondo accordi stabiliti con i
servizi territoriali, prevedendo dispositivi che possano far “scivolare” l’investimento (secondo la
definizione di investissement glissant; Sassolas, 2007) dall’equipe della Comunità Terapeutica
all’equipe di supporto domiciliare.
Peraltro, la realizzazione di progetti di questo tipo è oggi semplificata, almeno teoricamente, dal
quadro normativo introdotto in Italia nel 2000 con la legge 328, la quale consente la realizzazione di
progetti socio-sanitari integrati nell’ambito dei Piani di Zona, con la partecipazione di
rappresentanti delle famiglie e degli utenti, dimostratisi in molte esperienze adeguati a rispondere
alle necessità percepite dalle comunità locali.
Il nuovo ruolo degli utenti e dei familiari
La diffusione dei modelli di assistenza basati sull’abitazione indipendente è stata sottesa fin
dall’inizio da una diversa concezione della posizione del paziente nella relazione con i curanti.
L’impostazione tradizionale, basata sulla preminenza del ruolo dei curanti nella valutazione dei
bisogni e nella formulazione degli obiettivi, viene progressivamente superata, nello sforzo di
restituire al paziente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di partecipare alle
decisioni che lo riguardano (secondo il noto slogan, nothing about me, without me).
Ma la consistenza di questo nuovo approccio non si fonda solo sulla retorica degli slogan: negli
ultimi dieci anni importanti evidenze sono emerse dall’ambito degli studi sulla qualità della vita,
che dimostrano che il coinvolgimento attivo dei pazienti nelle scelte riguardanti i trattamenti, nella
pianificazione dei servizi, nella conduzione di programmi di ricerca, è un fattore che può essere
decisivo sulla soddisfazione e sugli esiti (Sartorius, 2006). Nello stesso ambito sono emersi con
chiarezza alti livelli di discrepanza nella visione di utenti e terapeuti, basati prevalentemente sulle
diverse priorità rispetto agli esiti desiderati4 (Lasalvia et al., 2005; Ruggeri et al., 2005).
E questo diverso “ascolto” dei pazienti ha fatto emergere le loro preferenze in merito alle opzioni
inerenti la residenzialità psichiatrica. Numerosi studi hanno dimostrato in modo inequivocabile che
i pazienti, se potessero scegliere, preferirebbero di gran lunga soluzioni assistenziali corrispondenti
al modello di supported housing descritto sopra (Tanzman, 1993; Friedrich et al., 1999; Forchuk et
al, 2006).
Questo diverso posizionamento dell’utente (divenuto nel frattempo consumer/survivor, ovvero
cittadino “sopravvissuto” alla malattia mentale ed alle sue conseguenze e quindi “competente” in
materia di risposte ai propri bisogni; Agnetti, 2007) sembrerebbe promettere un’azione decisiva sui
processi di auto-squalificazione e sui circoli viziosi di cui si è discusso sopra, inserendo nuovi e più
chiari elementi di negoziazione e responsabilizzazione all’interno della tradizionale concezione
dell’alleanza terapeutica.
Anche il ruolo delle famiglie sta attraversando, in questi anni, significative trasformazioni. Intanto
va ricordato che si tratta di una popolazione di familiari sempre più anziani: quelli i cui figli hanno
avuto un esordio schizofrenico all’epoca della riforma sono ormai ultrasettantenni. Di fronte ad un
sistema di assistenza psichiatrica tuttora frammentario e carente in molte aree del paese, ed alle
4
Mirella Ruggeri (2007) ha così riassunto le priorità degli utenti emerse dalla letteratura recente: a) ricevere
informazioni appropriate ed essere coinvolti nelle decisioni; b) avere un buon rapporto con i propri curanti;
c) essere coinvolti in programmi terapeutici chiari che includano anche una buona preparazione alla
dimissione o al termine del trattamento ambulatoriale e prevedano dei follow-up; d) un buon
coordinamento fra i servizi con cui interagiscono; e) essere messi in contatto con gli altri pazienti affinché si
attivi una forma di supporto tra pari. I familiari esprimono richieste molto simili a quelle dei pazienti, ma
pongono un’enfasi più netta: a) sull’informazione ricevuta; b) sul proprio coinvolgimento nei trattamenti; e)
sull'importanza di interventi supportivi ed intensivi nell'emergenza e, infine, d) sulla necessita di una presa
in carico a lungo termine.”
prese con il sistema della residenzialità ancora contraddittorio nelle sue prospettive temporali e
privo di una visione coerente e di lungo respiro, i familiari sono comprensibilmente preoccupati del
“dopo di noi”. Molti di loro hanno accumulato una storia di rapporti con i servizi caratterizzata
dall’alternanza di speranze e delusioni, deleghe e rigetti, spesso intessendo la propria tragedia
personale e familiare con le storie naturali dei servizi e con le loro alterne vicissitudini, o
sperimentando l’attribuzione di essere agenti eziologici del disturbo e di ostacolo al trattamento,
senza riuscire infine a discernere quanta sofferenza si sarebbe potuto evitare e quanta fosse
ineluttabile. E’ comprensibile, perciò, che una parte di familiari, mossi dalla preoccupazione per il
futuro, cerchino e trovino alleanze ed esercitino pressioni nell’intento di moltiplicare le “strutture”
per la presa in carico a lungo termine, verso ulteriori e più “rassicuranti” forme di
istituzionalizzazione.
Ma la situazione è in realtà molto eterogenea. In molti servizi si va diffondendo da qualche anno la
pratica del coinvolgimento dei familiari, sia attraverso le varie tipologie di gruppi multifamiliari, sia
con la partecipazione alla gestione degli stessi servizi o di alcune sue componenti (De Stefani,
2007). Anche in questo campo, pratiche nate dal basso, dalle situazioni locali, operazioni “creative”
di bricolage istituzionale, tendono a ribaltare i paradigmi tradizionali e vengono poi assimilate a
livello normativo5.
Ma l’aspetto più interessante ed innovativo sembra evidenziarsi dal momento in cui i familiari, più
informati e coinvolti nell’attività dei servizi, anziché limitarsi ad una funzione consultiva, o
semplicemente essere oggetto di supporto psicoeducativo, si propongono come soggetti attivi e
corresponsabili nella realizzazione di progetti e reti di assistenza. E' verosimile, infatti, che se la
devastante ferita narcisistica in opera nei familiari si installa come un potente aspetto conflittuale,
relativo ai gravi sensi di impotenza e colpa, una porzione di questo contenuto mentale abbia
difficoltà ad essere correttamente riconosciuto ed integrato con altri contenuti (sollecitudine,
percezione dei limiti, riparazione) e che venga quindi proiettata sulle équipe. D'altra parte, le équipe
si prestano facilmente ad accogliere questo tipo di proiezioni, essendo per lo più, a loro volta,
inadeguate all'aspettativa di debellare la malattia, di operare una guarigione. E' possibile, allora, che
una riformulazione del rapporto con i familiari, basata sulla condivisione dell'inadeguatezza e sul
reciproco riconoscimento dei limiti, possa mettere in discussione questa fissità di ruoli e di deleghe.
Se poi i familiari sono messi in grado di agire concretamente, insieme all'équipe, nella realizzazione
5
Nelle raccomandazioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale 2002-2003 (Ministero della Salute,
2002) si legge, fra l’altro: “coniugare gli aspetti organizzativi con la possibilità che il paziente sia partecipe ad
ogni livello del programma d’intervento, anche attraverso la scelta consapevole del luogo di cura e del
curante per migliorare l’adesione al trattamento; mettere in campo nuovi strumenti per l’integrazione sociale
e lavorativa del paziente, nel contesto del tessuto sociale e non in surrogati di esso, superando barriere e
stigmatizzazioni che ancora oggi riducono le opportunità per pazienti e familiari”.
delle condizioni più idonee per una “sopravvivenza” a lungo termine del paziente nella comunità,
ciò può meglio favorire l'elaborazione del lutto e l'attivazione di funzioni riparative.
Nelle pratiche di supported housing, in particolare, la collaborazione diretta dei familiari può creare
le condizioni di una separazione del paziente dalla famiglia senza che ciò si traduca in una rottura o
in un'espulsione. La famiglia può infatti mantenere un rapporto col paziente e contribuire da parte
sua alla rete di supporto.
Del resto, già Racamier, negli anni ’70, in palese controtendenza rispetto ai tempi, sosteneva che la
“partecipazione responsabile e collettiva” dei familiari “all’insieme dell’impresa terapeutica, la loro
identificazione ai curanti, le informazioni che ricevono, li aiutano in molti casi a superare le loro
ferite narcisistiche e ad impegnarsi in posizioni nuove” (Racamier, 1974).
Conclusioni
Il destino a lungo termine dei pazienti della community care generation, che non hanno
conosciuto la realtà dell’ospedale psichiatrico ed i cui decorsi sono stati plasmati nell’interazione
con i servizi di comunità, rappresenta oggi un problema di dimensioni notevoli ed una sfida per i
sistemi di welfare. In tempi dominati dall’esigenza di razionalizzare e tenere sotto controllo la
spesa, si verifica la situazione paradossale per cui lo scenario prevalente dell’assistenza è sempre
più incentrato sulle soluzioni residenziali, che sono le più costose ed assorbono la maggior parte
delle risorse dei servizi psichiatrici (Bonizzato et al, 2000; Grignoletti et al., 2004). Concepite come
transitorie, col mandato di ridimensionare la disabilità e “restituire” il paziente alla comunità, esse
tendono purtroppo a riprodurre stanzialità, con il rischio già paventato di ricreare forme aggiornate
di istituzionalizzazione. Il basso turn-over le rende poi facilmente sature, e ciò incrementa la
domanda, che viene invariabilmente letta ed interpretata come “bisogno” di residenzialità e si
traduce in richiesta di ulteriori “posti-letto” e strutture. L’affacciarsi, su questo scenario, di gruppi
imprenditoriali che possano offrire risposte a tale domanda con soluzioni di lungo-assistenza e di
dubbia qualità, renderebbe ancora più concreta la possibilità di una re-istituzionalizzazione su larga
scala. Eppure abbiamo constatato che i delicati meccanismi nascosti nelle pieghe del sistema e che
verosimilmente contribuiscono a mantenere questa situazione possono essere analizzati e se ne può,
in qualche misura, invertire la tendenza.
L'importanza di questa prospettiva è cruciale per le Comunità Terapeutiche: non tenerne
conto può comportare il rischio, già attuale, che esse, nella percezione collettiva, vengano assorbite
nella generale tipologia delle “strutture residenziali”, in cui la funzione si sovrappone alla struttura,
come in un continuo e confondente effetto stroboscopico, e in cui il mandato propriamente
terapeutico venga costantemente minacciato, attraverso una serie di ambiguità e malintesi, e fatto
tacitamente confluire verso il “compito impossibile” della psichiatria di comunità. Nei trent'anni
trascorsi dalla riforma, tale compito sembra essere sotterraneamente “migrato” dai servizi
territoriali, ai centri diurni, alla residenzialità, come nel tentativo di dislocarne e procastinarne la
soluzione. Se si considerano gli effetti di tale ambiguità, lucidamente descritti da Foresti e Rossi
Monti (2004) nei termini di un deterioramento irrimediabile del funzionamento dei singoli e dei
gruppi, si comprende quanto essi possano risultare implosivi per le Comunità Terapeutiche, proprio
per il situarsi di esse al capolinea di quella catena di deleghe e rinvii. Esse perciò necessitano di una
definizione più chiara e sostenibile del loro mandato; e ciò può avvenire solo nella misura in cui il
sistema di salute mentale nel suo complesso abbandoni la prospettiva segmentale adottando
finalmente una visione sistemica a lungo-termine, in cui la Comunità può giocare un ruolo
strategico essenziale.
In direzione opposta, anzi proponendosi come antidoto alla prospettiva sopra descritta, sembrano
oggi muoversi gli approcci che tentano di ribaltare i paradigmi tradizionali. Essi rientrano,
prevalentemente e di fatto, nella cornice teorica della recovery (Anthony, 1993; Farkas, 2007), che
sta conoscendo una vasta diffusione ed è ormai inclusa come principio-guida nelle policy di diversi
Paesi occidentali, inclusi la Gran Bretagna e gli Stati Uniti (NIMHE, 2004; New Freedom
Commission, 2005). Questo termine, come è noto, allude ad una condizione di recupero, ripresa,
reintegrazione, piuttosto che alla guarigione clinica6; si riferisce perciò a pazienti che, malgrado la
persistenza dei sintomi e della disabilità, e al di là di esse, possono riannodare i fili di un progetto
esistenziale compatibile e sostenibile, e recuperare senso e significato all’esperienza vissuta ed
anche alla sofferenza. L'approccio di un servizio recovery-focussed non sarà basato, quindi, su
obiettivi definiti dai curanti ma piuttosto sarà guidato dall’ascolto delle opinioni dei pazienti e ne
terrà conto nella pianificazione degli obiettivi.
Ma c'è un altro risvolto importante di questo diverso orientamento: la comunicazione che il curante
rivolge al paziente, nell’ascoltare e nell’indagare il suo punto di vista, sembra contenerne altre due,
implicite ma altrettanto rilevanti:
il riconoscimento dei limiti del servizio nei confronti dei bisogni e delle aspettative dei pazienti
e dei familiari;
la necessità che le esigenze e gli obiettivi espressi dagli utenti tengano conto di tali limiti e siano
sostenuti dalla partecipazione responsabile di chi li formula.
6
Per una analisi approfondita del significato del termine recovery si veda: Carozza (2006); Schrank e
Slade (2007).
Il riconoscimento dei limiti e la condivisione della relativa inadeguatezza possono costituire un utile
argine al “compito impossibile” inerente al mandato della psichiatria di comunità, e quindi creare le
premesse per una esplicita ridefinizione e rinegoziazione di esso. Inoltre, la compartecipazione di
utenti e familiari, con il ruolo di “esigenti” nella formulazione di obiettivi sostenibili a lungo
termine, può dare più oggettività e cogenza alla pianificazione delle risorse necessarie ed alla
contrattazione di esse con le aziende sanitarie e con le agenzie di welfare7.
Ci si potrà chiedere quanto ci sia di evidenza e quanto di retorica in questa visione; o si potrà essere
perplessi di fronte alla prospettiva di affidare alla spontaneità e al “meticciato” un così delicato e
complesso compito. Tuttavia la ricerca potrà dare risposte e potrà guidare questo processo
evolutivo. Mike Slade (2007), un ricercatore inglese che recentemente ha sottolineato l'urgenza di
approfondire l'indagine in questo campo, ritiene che vi siano tre possibili esiti futuri: i nuovi
approcci potranno fallire nell’impatto sui servizi e gradualmente scomparire; potranno essere
introdotti nelle pratiche, ma essere poi lentamente dimenticati, analogamente al destino che in
passato hanno avuto altri “movimenti” in questo campo; oppure potranno divenire i modelli
dominanti e condurre a fondamentali e accreditate innovazioni nelle pratiche.
7
Il concetto di “esigente” è qui inteso nel senso che ne dà Cavicchi (2007): “Ormai il senso più
profondo che le aziende sanitarie non sono in grado di cogliere – e non per sbadataggine – è quello per il
quale l'esigente è il portatore sia di una cultura societaria sia di una cultura comunitaria. Egli non si propone
tanto nei confronti dell'istituzione sanitaria in termini di rivendicazione (voglio questo e voglio quello) anche
se è un domandante o un reclamante, né rivendica nei confronti dell'istituzione chissà quali elargizioni, o
prestazioni, ma al contrario si propone sul piano della responsabilità e quindi della
corresponsabilizzazione.”
Agnetti G. (2007) Arrivano i consumatori: dove andiamo? Psichiatria di Comunità, VI, 2, 73-79
Agrimi E., Vigorelli M. (1998) La Comunità Terapeutica per giovani psicotici adulti. Introduzione.
In: Ferruta A., Foresti G., Pedriali E., Vigorelli M. (a cura di) La Comunità Terapeutica. Tra
mito e realtà. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Anthony W., Cohen M., Farkas M., Gagne C. (2003). Riabilitazione Psichiatrica. CIC Edizioni
Internazionali: Roma.
Balestrieri M. (1990) Il registro dei casi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi psichiatrici.
Rivista Sperimentale di Freniatria, vol. CXIV, Suppl. al fascicolo N. 1/1990.
Bigelow D.A. (1998). Supportive homes for life versus treatment way-stations: an introduction to
TAPS Project 41. Community Mental Health Journal 34, 403-405.
Bonizzato P., Bisoffi G., Amaddeo F., Chisholm D. & Tansella M. (2000) Community-based
mental health care: to what extent are services costs associated with clinical, social and
service history variables? Psychological Medicine, 30, 1205-1215.
Budson, R. D. (1990) Models of supportive living: community residential care. In: Hertz M. I.,
Keith S. J., Docherty J. P. (eds.) Psychosocial Treatments of Schizophrenia; Handbook of
Schizophrenia, Vol. 4. Elsevier, New York.
Burns T. & Firn M. (2003) La presa in carico intensiva sul territorio. Il Pensiero Scientifico, Roma.
Carling P.J. (1993). Housing and support for persons with mental illness: Emerging approaches to
research and practice. Hospital and Community Psychiatry 44, 439-450.
Carozza P. (2006) Principi di riabilitazione psichiatrica. Franco Angeli, Milano.
Cavicchi I. (2007) Autonomia e responsabilità. Un libro verde per medici e operatori della sanità
pubblica. Edizioni Dedalo, Bari.
Chanoit P.F. (1977) Hospital de Jour ou asile de jour? Revue de Médicine Psychosomatique, 1977,
205-208.
Ciompi L. (1982) Logica affettiva. Una ricerca sulla schizophrenia. Feltrinelli, Milano.
Correale A. (1991) Il campo istituzionale. Borla, Roma.
de Girolamo G., Picardi A., Santone G., Falloon I., Morosini P., Fioritti A. & Micciolo R. for the
Progres Group (2005). The severely mentally ill in residential facilities: a national survey in
Italy. Psychological Medicine. 35, 421–431.
de Girolamo G., Picardi A., Santone G., Falloon I., Morosini P., Fioritti A. & Micciolo R. for the
Progres Group (2005). The severely mentally ill in residential facilities: a national survey in
Italy. Psychological Medicine 35, 421–431.
de Girolamo G., Picardi, A., Micciolo R., Falloon, I., Fioritti, A., and Morosini P. for the
PROGRES Group (2002) Residential care in Italy. National survey of non-hospital facilities.
British Journal of Psychiatry, 181, 220-225.
De Stefani R. (2007) Quando il disagio psichico diventa una competenza. Animazione Sociale
(inserto), Ottobre 2007.
Fakhoury W.K.H., Priebe S. & Quraishi M. (2005). Goals of new long-stay patients in supported
housing: A UK study. International Journal of Social Psychiatry 51, 45-54.
Farkas M. (2007) The vision of recovery today: what it is and what it means for services. World
Psychiatry. 6, 4-10.
Forchuk C., Nelson G. & Hall G.B. (2006). "It's important to be proud of the place you live in":
Housing problems and preferences of psychiatric survivors. Perspectives in Psychiatric Care
42, 42-52.
Foresti G., Rossi Monti M. (2004) La “psicoterapia istituzionale” trent’anni dopo. Rivista di
Psicoanalisi, L, 1, 233-249.
Friedrich R.M., Hollingsworth B., Hradek E., Friedrich H.B. & Culp K.R. (1999). Family and client
perspectives on alternative residential settings for persons with severe mental illness.
Psychiatric Services 50, 509-514.
Geller J.L. & Fisher W.H. (1993). The linear continuum of transitional residences: debunking the
myth. American Journal of Psychiatry 150, 1070-1076.
Grignoletti L., Amaddeo F., de Girolamo G., Picardi A., Gruppo Nazionale PROGRES (2004) I
costi delle strutture residenziali psichiatriche italiane. Epidemiologia e Psichiatria Sociale,
13, 4, 262-269.
Haggerty J. L., Reid R. J., Freeman G. K., Starfield B. H., Adair C. E., McKendry R. (2003)
Continuity of care: a multidisciplinary review. British Medical Journal, 327, 1219-1221.
Lasalvia A., Gentile B., Ruggeri M. et al. (2007) Etereogeneità dei DSM veneti a dieci anni dal
Progetto Obiettivo “Tutela Salute Mentale 1994-1996”. Quali implicazioni per la pratica
clinica? Indagine sui servizi partecipanti al Progetto PICOS-Veneto. Epidemiologia e
Psichiatria Sociale, 16, 1, 59-70.
Lasalvia A., Bonetto C., Malchiodi F., Salvi G., Parabiaghi A., Tansella M., Ruggeri M. (2005)
Listening to patients’ needs to improve their subjective quality of life. Psychological
Medicine, 35 (11) 1655-1665.
Lehman A. F., Newman S. J. (1996) Housing. In: W. R. Breakey (ed.) Integrated Mental Health
Services. Oxford University Press, New York.
Lora A., Contartese A., Franco M., Lo Maglio M.C., Molteni E., Pallavicini A., Rasi E., Rossini M.
(2004) L’efficacia nella pratica delle strutture residenziali territoriali: uno studio
osservazionale. Epidemiologia e Psichiatria Sociale. 13, 198-208.
Maone A. (1998) Centri diurni e assistenza a lungo termine. In: A. Maone e G. Ducci (a cura di) La
sfida della cronicità. Franco Angeli, Milano.
Maone A. (2005) Il ruolo dei familiari nel trattamento della schizofrenia nella comunità. In: F.
Asioli e M. Purpura (a cura di) La Comunità Terapeutica. Istruzioni per l’uso. Biblink
Editori, Roma.
Maone A. (2006) Le chiavi di casa. Possibilità e limiti dell’approccio di Supported Housing.
Psichiatria di Comunità, 5, 4, 222-235.
Maone A., Berardi R., Spagnuolo O. (2008) The house keys. An innovative approach to supported
housing in Rome. Housing, Care and Support, 11. 1, July 2008, 32-35.
Maone A., Ducci G., Lombardi F., Stentella C., Vasques P. (2002) Day Programs in Italy for
Persons with Severe Mental Illnesses. A Nationwide Survey. International Journal of
Mental Health, 31, 3, 30-49.
Middleboe T., Mackeprang T., Thalsgaard A. & Christiansen P.B. (1998). A housing support
programme for the mentally ill: need profile and satisfaction among users. Acta Psychiatrica
Scandinavica 98, 321–327.
Ministero della Salute (1999) Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000.
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
Ministero della Salute (2003) La salute mentale nel Piano Sanitario Nazionale 2002-2004.
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=115&sub=4&lang=it
Moroni A., Bertolotti L., Boienti C. (1998) L’esperienza della “Comunità Don Gnocchi”
dell’Istituto Fatebenefratelli di S. Colombano al Lambro. In: Ferruta A., Foresti G., Pedriali
E., Vigorelli M. (a cura di) La Comunità Terapeutica. Tra mito e realtà. Raffaello Cortina
Editore, Milano.
New Freedom Commission on Mental Health (2005). Achieving the Promise: Transforming Mental
Health Care in America. Department of Health and Human Services. Rockville, MD: U.S.
NIMHE National Institute for Mental Health in England (2004). Emerging Best Practices in Mental
Health Recovery. NIMHE, London.
Nordt C., Rössler W., Lauber C. (2006) Attitudes of Mental Health Professionals Toward People
With Schizophrenia and Major Depression. Schizophrenia Bulletin. 32, 709 – 714.
Parkinson S., Nelson G. & Horgan S. (1999). From housing to homes: a review of the literature on
housing approaches for psychiatric consumer/survivors. Canadian Journal of Community
Mental Health 18, 145-164.
Pazzagli A., Rossi R. (1991) Schizofrenia: cronicità o bisogno inappagabile? Il Pensiero
Scientifico, Roma.
Power A.K. (2006). Mental health care: what lies ahead for North Carolina? In: National Alliance
on Mental Illness North Carolina Spring Conference 2006. Raleigh, NC.
http://www.mentalhealth.samhsa.gov/newsroom/speeches/042906.asp
Pryce I.G. (1982) An expanding “stage army” of long-stay psychiatric patients. British Journal of
Psychiatry, 141, 757-763.
Public Health Agency of Canada (1997). http://www.phac-aspc.gc.ca/mhsm/pubs/bp_review/index.html
Rapp C. A., Goscha R. J. (2006) The Strengths Model. Case Management with people with
psychiatric disabilities. Oxford University Press. New York.
Reynaud M. (1990) Sortir de la psychose ou sortir de la psychiatrie? L’information psychiatrique.
66, 2, 145-162.
Ridgway P., & Rapp C.A. (1997). The active ingredients of effective supported housing: A research
synthesis. Lawrence, Kansas: The University of Kansas School of Social Welfare.
Ridgway, P. & Zipple, A.M. (1990). The paradigm shift in residential services: From the linear
continuum to supported housing. Psychosocial Rehabilitation Journal 13, 11-31.
Rog D.J. (2004). The evidence on supported housing. Psychiatric Rehabilitation Journal 27, 334344.
Ruggeri M. (2007) Quality of Life, Enjoyment and Satisfaction Questionnaire. Presentazione.
Epidemiologia e Psichiatria Sociale. 16, 1, 79-81.
Ruggeri M., Nosè M., Bonetto C., Cristofalo D., Lasalvia A., Stefani B., Malchiodi F., Tansella M.
(2005) Changes and predictors of change in objective and subjective quality of life. A
multiwave follow-up study in community psychiatry patients. British Journal of Psychiatry,
187, 121-130.
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (2003). Use EvidenceBased and Promising Practices,
http://www.mentalhealth.samhsa.gov/media/ken/pdf/SMA04-3870/SMA04-3870.pdf
Saraceno B. (1995) La fine dell’intrattenimento. RCS, Milano.
Saraceno B. (2005) Nuovi paradigmi per la salute mentale. Psichiatria di Comunità 4, 1-4.
Sartorius N. (2006) Quality of Life and Mental Disorders: a global perspective. In: Quality of Life
in Mental Disorders (ed. H. Katsching, H. Freeman and N. Sartorius). John Wiley & Sons,
Chichester.
Sassolas M. (2007) Un obstacle au changement: la seduction narcissique. Revue des Hopitaux de
Jour Psychiatriques et des Thérapies Institutionnelles, N. 6.
Schrank B. & Slade M. (2007). Recovery in Psychiatry. Psychiatric Bulletin 31, 321-325.
Seligman, L. (1994) Developmental career counseling and assessment. Thousand Oaks, CA: SAGE
Publications.
Slade M. & Hayward M. (2007). Recovery, Psychosis and Psychiatry: research is better than
rhetoric. Acta Psychiatrica Scandinavica 116, 81-83.
Soscia F., Ruberto A., Girardi P., Torricelli F. D., Mannu J., Recchi G., Moinzadeh Z., Smeriglio
G., Narracci A., Ionta P., Antonelli E., Ceppi F., Uriati P., Perilli S., Rocco S., Di Matteo L.,
Kotzalidis G. D., Tatarelli R. (2005) Approccio evidence-based alla valutazione del
trattamento comunitario: outcome di pazienti psichiatrici nelle comunità terapeuticoriabilitative del Lazio. Psichiatria e Psicoterapia, 24, 273-290.
Tantam D., McGrath G. (1989) Psychiatric Day Hospitals: another route to institutionalization?
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 24, 96-101.
Tanzman B. (1993). An overview of surveys of mental health consumers’ preferences for housing
and support services. Hospital and Community Psychiatry 44, 450-455.
Veltro, F., Magliano, L., Lobrace, S. & Morosini, P. L. (1993) Severely and persistently mentally ill
patients in Italy: an overview of epidemiological and psychosocial findings. International
Journal of Social Psychiatry, 30, 285-302.
Wiersma, D., Kluiter, H., Nienhuis, F.J., Ruphan, M., & Giel R. (1995) Costs and Benefits of
Hospital and Day Treatment with Community Care of Affective and Schizophrenic
Disorders, British Journal of Psychiatry, 166 (suppl.27), 52-59.
Wing J. K., Hailey A. M. (1972) Non-residential services for the mentally ill, 1964-1971. In:
Evaluating a Community Psychiatric Service (eds. J. K. Wing and A. M. Hailey). Oxford
University Press.
Xocco V. & Cerutti M.C. (2006) A supported housing programme in Turin, Italy. IX World
Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation, Athens, Greece, 12-15
October 2006.
Zapparoli G. C. (1987) La psicosi e il segreto. Bollati Boringhieri. Torino.