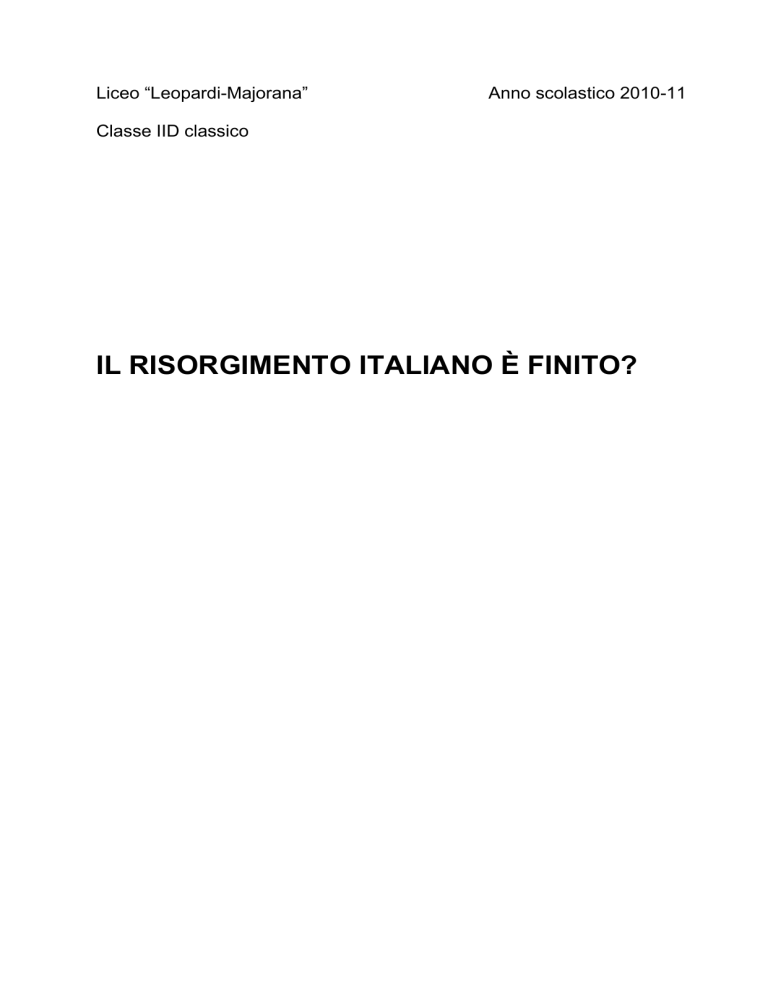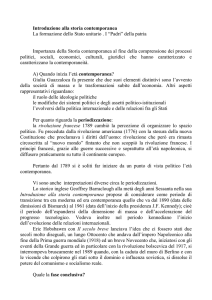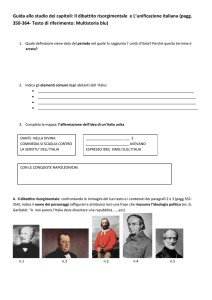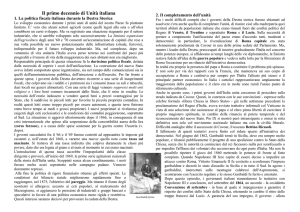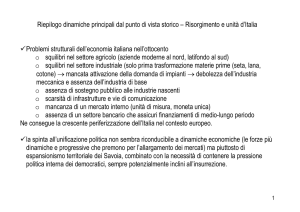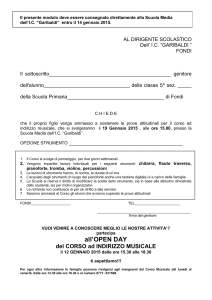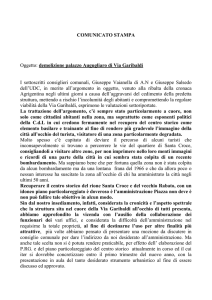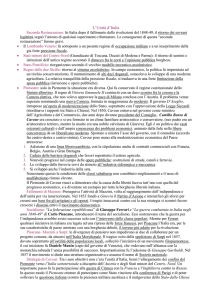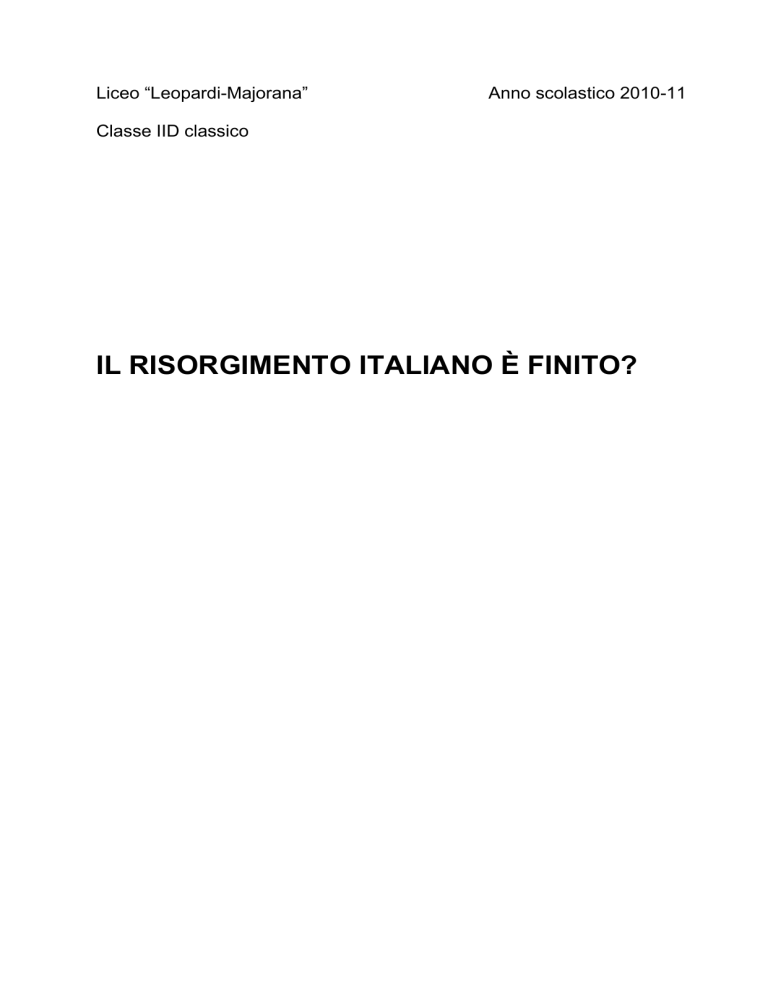
Liceo “Leopardi-Majorana”
Anno scolastico 2010-11
Classe IID classico
IL RISORGIMENTO ITALIANO È FINITO?
1. GLI AVVENIMENTI
1.UN’IDEA CHE VIENE DA LONTANO
Lo storico Lucio Villari, nell'Introduzione al primo volume de Il Risorgimento,
intitolata “Il lungo cammino dell'idea di Italia”, esordisce affermando che la
nascita dell'Italia è stata lenta; traccia poi una serie di tappe fondamentali per
il nostro Paese dall'inizio del secondo millennio fino all'epoca napoleonica,
per capire meglio cosa per molto tempo ha impedito e contemporaneamente
cosa ha portato all'unità d'Italia.
Uno dei principi della nostra nazione è la lingua: quando il volgare, originato
dal latino, comincia a diffondersi da nord a sud e diventa una lingua
condivisa, che permette la comunicazione in tutta la penisola, si instaura un
legame “nazionale” che preannuncia la futura unità. Inizialmente, come
testimoniano i documenti in nostro possesso, questa lingua è utilizzata
soprattutto per scopi economici e giuridici, che saranno alla base delle
principali attività dei Comuni dopo il Mille.
I primi due secoli dopo il Mille sono caratterizzati dalla “società feudale”, che
con i suoi costumi, valori, relazioni e comportamenti costituirà un edificio
rigidamente gerarchico e caratterizzato dal dominio aristocratico. Le grandi
istituzioni sono l'Impero, il Papato e i Comuni; accanto a queste, si trovano
però anche le idee di scrittori e filosofi che auspicano un ritorno all'antico,
cioè allo splendore dell'Impero romano, che però si ritiene possa risorgere
sotto il dominio degli imperatori tedeschi e non sotto quello dei papi. Questo
avvia il fatale conflitto tra papato e impero; la creazione di uno stato nazionale
italiano molti anni prima del 1861 viene impedita dagli scontri dovuti al
desiderio di entrambi i rappresentanti del potere di prevalere uno sull'altro. Gli
Imperatori tedeschi progettavano l'unificazione della penisola ma a loro si
opponevano sia il papa che le famiglie nobili romane a lui affiliate, che
preferivano essere sottomesse al papa che a un imperatore tedesco. Il
progetto più famoso di tentata unificazione è quello di Federico II di Svevia,
che aveva tentato di unificare l'Italia meridionale e i Comuni settentrionali per
creare una sorta di monarchia nazionale come stava succedendo allora in
Francia, Inghilterra e Spagna. Proprio durante l'unificazione dell'Italia
nell'Ottocento, come ricorda Villari, liberali e democratici guardavano alla
libertà dei Comuni e al sogno dell'imperatore tedesco come modelli: un'Italia
libera dalla Chiesa e unita sotto un unico sovrano. Un progetto ancora attuale
se si pensa ai dibattiti in corso su federalismo e centralismo. Dal 1154 le
armate di Federico I Barbarossa avevano cercato di imporre l'autocrazia
imperiale nei Comuni dell'Italia settentrionale; il papa, di conseguenza,
appoggiava la lotta delle città per l'indipendenza. I Comuni erano alleati della
chiesa, ma questo non impedì la nascita di schieramenti guelfi e ghibellini
all'interno delle città, una tragica guerra civile secolare che divideva italiani e
concittadini. Fu vittima di questi eventi anche Dante Alighieri, che espresse
nei suoi scritti la speranza dell'arrivo di un sovrano inviato da Dio in grado di
risollevare l'Italia dilaniata. Con una passione ancora maggiore, un altro
importante poeta si è dedicato al destino politico dell'Italia: Francesco
Petrarca, che auspicava un'identità nazionale moderna costruita però sulle
fondamenta del mondo classico.
La lotta fra papato e impero ha determinato la fine del sogno imperiale di
creare un sistema politico omogeneo nell'Italia del nord, portando così allo
sviluppo dei Comuni, città libere e indipendenti. Questa libertà è un tratto
distintivo della vita nelle città italiane, non riscontrabile negli altri Paesi
europei. Lo splendore dei queste città portò alla fioritura delle arti e delle
scoperte tecnologiche e scientifiche e soprattutto fece nascere nei letterati il
bisogno di tramandare la memoria del proprio tempo; la produzione letteraria
più abbondante allora fu quella storiografica che, nella maggior parte dei casi,
non era una cronaca oggettiva, bensì un appassionato racconto degli
avvenimenti di cui gli autori erano testimoni.
L'ideale delle città era il “buongoverno”, perseguito purtroppo mediante
guerre interne ed esterne; questa fase di scontri permanenti durerà fino alla
seconda metà del Cinquecento. Molti storici evidenziano come lo scontro tra
Comuni avrebbe almeno dovuto unificare le fazioni all'interno di una stessa
città, invece gli odi tra concittadini erano quasi superiori a quelli verso i nemici
esterni. Appartenere a una delle due fazioni, guelfi o ghibellini, significava
appoggiarsi a una delle due grandi istituzioni medievali, Chiesa o Impero; il
guelfismo incarnava il rifiuto dell'intervento dell'impero nelle cose italiane,
mentre il ghibellinismo l'opposizione all'intromissione della Chiesa negli affari
temporali. I Comuni però non riuscirono ad affermare pienamente la loro
indipendenza né dall'impero né dalla chiesa, diventando così nei secoli
successivi solo merce di scambio all'interno degli interessi internazionali,
rendendo la penisola aperta alle dominazioni straniere. Tutto questo
succedeva semplicemente a causa della mancanza di una forza unificatrice
superiore. Dai comuni infatti non si poté sviluppare un'intera nazione
unificata, ma si crearono solo “città allargate”, che diventarono signorie e
principati (Estensi, Gonzaga, Visconti, Medici, Sforza, Scaligeri, Savoia), che
si affiancarono alle Repubbliche di Venezia e Genova, al regno di Napoli e
allo Stato della Chiesa.
Negli anni tra il 1347 e il 1354 sembrò realizzarsi il sogno politico-letterario di
Petrarca, la rinascita sulle rovine della Roma classica di una Roma moderna,
tramite le iniziative di Cola di Rienzo, un tribuno romano. Il suo esperimento
consisteva nel ripristinare un governo popolare che veniva denominato con la
classica formula Senatus Populusque Romanus: la sovranità e il potere non
dovevano più dipendere dagli interessi delle famiglie nobili romane, ma da un
ideale superiore e dal consenso dei cittadini. Il progetto di Cola era sostenuto
anche dal papa, che però si trovava dal 1305 ad Avignone e quindi aveva
scarse possibilità di intervento nelle vicende romane. La vittoria di Cola sui
nobili fu effimera, perché i signori romani, poco tempo dopo, convinsero i
cittadini che il tribuno fosse un tiranno oppressore e una sommossa popolare
lo uccise. La situazione fu però sfruttata dal cardinale Albonorz, che riuscì a
sottomettere i nobili ribelli e a riaffermare l'autorità del papato, preparando
anche il terreno per il ritorno a Roma dei papi (nel 1377). Il cardinale
organizzò l'intelaiatura di uno stato pontificio centralizzato, che avrebbe
conservato quelle strutture per cinquecento anni, fino al suo crollo durante le
guerre di indipendenza nell'Ottocento. Le imprese di Cola di Rienzo furono
esaltate durante il Risorgimento da liberali, democratici e repubblicani; infatti
il tribuno aveva cercato di affermare un'idea di Italia, convocando nel 1348 a
Roma i rappresentanti di tutte le città italiane. Ma la riunione non ebbe mai
luogo, anche a causa dell'epidemia di peste che aveva colpito l'Europa in
quell'anno, creando un diffuso clima di angoscia. L'unico in grado di
trasformare questo evento in un inno alla vita, alla rinascita, anticipando temi
dell'Umanesimo e del Rinascimento, fu Giovanni Boccaccio. La ricchezza
culturale dell'Italia e la sua modernità intellettuale rispetto al resto dell'Europa
non corrispondevano però ad un analogo sviluppo nel campo politico. Il
tramonto dei Comuni durante il Trecento e la conseguente nascita delle
signorie non fece che peggiorare la situazione e rendere ancora più lontana
la possibilità di un paese unito. Il potere dei più forti (quindi i più ricchi) aveva
il vantaggio di poter evitare le lotte tra fazioni; infatti, il superamento della
“divisione dei poteri” tipica dei Comuni portò ad un potere più centralizzato e
quindi più efficace. Nello stesso tempo, nelle altre nazioni europee avveniva il
processo inverso, cioè il potere prima detenuto da vari signori feudali
passava nelle mani di un solo monarca nazionale. I tanti piccoli stati di cui era
composta l'Italia non giunsero a costituirne uno solo, forte e unitario.
In Italia, alla fine del Trecento, c'è il rigoglio delle arti, la magnificenza delle
città, un modello ineguagliabile per il resto dell'Europa, ma anche una
costante instabilità politica che la rende debole rispetto a tutte le altre nazioni.
L'età rinascimentale è un altro momento in cui l'Italia trionfa per lo sviluppo
delle arti e delle lettere. La storiografia sembra aver escluso da questo
processo l'Italia meridionale, circoscrivendo l'area fiorente nelle città signorili
da Roma in su, mentre anche il sud Italia ha avuto importanti centri artistici.
La società del Rinascimento è però piuttosto passiva; i committenti delle
opere sono importanti, ma non esercitano ruoli attivi. L'eccezione è la Chiesa,
che non esita a farsi celebrare con quadri, sculture a architetture. Inoltre, il
peso politico dei papi è sempre più significativo, tanto che è impossibile
evitarne le conseguenze rovinose: tra il 1517 e il 1527 Roma è saccheggiata
dai lanzichenecchi, di fede luterana, dell'imperatore Carlo V.
Anche nel Cinquecento un ruolo importante spetta agli intellettuali: Francesco
Guicciardini, che con la sua Storia d'Italia sembra anticipare l'idea di una
nazione unita; Niccolò Machiavelli, grande teorico della politica moderna. Alle
novità delle idee politiche e dell'arte rinascimentali si aggiungono poi le
scoperte di Galileo Galilei, innovatore del pensiero scientifico. Ancora una
volta interviene la Chiesa, ostacolando questi sviluppi culturali nel clima della
Controriforma.
Il barocco per l'Italia è il periodo delle dominazioni straniere. La Spagna di
Filippo II assoggettò il Regno di Napoli, la Sicilia, la Sardegna, il Ducato di
Milano e stabilì un'importante relazione con lo stato pontificio, a favore della
lotta contro i protestanti e i musulmani. La Spagna riscuoteva le tasse, ma
non favoriva lo sviluppo della nostra penisola. Manzoni, nei Promessi Sposi,
rappresenta la terribile condizione di Milano in quel periodo, tra peste e
degrado: il Ducato, prima molto produttivo, era stato condotto
all'impoverimento dalla politica spagnola. Anche nel Regno di Napoli, il
controllo economico della Spagna non dava slancio positivo, tanto che, nel
corso della crisi economica internazionale (a causa dell'afflusso di oro e
argento dai domini spagnoli in America, che fece crollare il valore delle
monete e accrescere l'inflazione) e durante la guerra dei trent'anni, proprio a
Napoli scoppiava una rivoluzione popolare capeggiata da Masaniello (1647).
Nel corso della guerra (1618-1648) la nostra penisola fu coinvolta come
territorio di scambio tra Francia, Germania e Spagna o come campo di
battaglia. Le testimonianze più vive su questo periodo sono proprio quelle
che abbiamo dai Promessi Sposi.
Dalla pace di Westfalia (1648), che decretò la fine dell'influenza politica del
papato, non vennero però risposte ai problemi dell'economia, della crisi
politica e sociale che aveva portato a Napoli alla rivolta di Masaniello, che
possiamo considerare, insieme alla contemporanea e ben più importante
rivoluzione inglese di Cromwell, il primo confronto tra sostenitori della
monarchia e seguaci degli ideali repubblicani. L'ordine politico appena
instaurato quindi non era ancora al sicuro; sembrava inevitabile un
cambiamento di pensiero, ma i sovrani e il potere religioso rifiutavano
l'apertura alla rivoluzione scientifica.
Un'altra data importante è il 1707, quando le truppe austriache penetrarono
nel Regno di Napoli, mettendo cosi fine al bisecolare dominio spagnolo in
Italia. Gli Asburgo vollero differenziarsi dagli spagnoli operando riforme, ma
non ci furono grandi cambiamenti: utilizzarono lo stesso apparato
amministrativo e le stesse modalità fiscali, talvolta aggravando ancora di più
la situazione finanziaria. I nuovi metodi di governo austriaci, tuttavia,
rafforzarono le istituzioni del regno napoletano. Un personaggio importante
per questa città negli anni dal 1734 al 1776 fu Bernardo Tanucci, a cui si
devono numerosi atti di governo volti a trasformare il regno in uno stato
moderno ed efficiente; uno di questi, se realizzato, avrebbe forse potuto
cambiare il corso della storia non solo per l'Italia meridionale. Il Settecento
napoletano fu “europeo”: il Regno, infatti, fu prima retto dalla Spagna, poi
dall'Austria; c'era insomma un'atmosfera internazionale, diversa dalle
tradizioni del regno meridionale, le basi per una società quasi mitteleuropea
che però non si svilupperà mai. Viaggiatori, poeti descrivevano Napoli come
una terra felice, ma dietro questa apparenza si celava la minaccia di una
“distruzione sociale”, che avverrà nel 1799 ad opera di contadini e popolani
capeggiati dal cardinale Fabrizio Ruffo per contrastare la Rivoluzione.
Al nord, è Milano la capitale dell'illuminismo italiano. Qui i governanti
richiedevano spesso la competenza degli intellettuali in campo politico, ma il
movimento riformatore in Italia non dava speranze, tanto che gli stessi
intellettuali erano costretti ad ammettere che l'unico modo per cambiare
qualcosa fosse la rivoluzione.
Una nuova epoca inizia nel 1796 con l'arrivo di Napoleone Bonaparte, che
porta in Italia i principi della rivoluzione del 1789. Napoleone aveva avuto dal
Direttorio l'ordine di costringere gli austriaci, che occupavano l'Italia del nord,
a ritirarsi. Questo progetto non aveva molto a che fare con i principi della
rivoluzione, era semplicemente un'operazione militare destinata a proteggere
i confini francesi dalle invasioni austriache. Napoleone però non si accontentò
di eseguire questo facile compito e volle dare anche un valore politico alla
campagna d'Italia, richiamandosi ai valori della rivoluzione. Grazie a lui, l'Italia
guadagnò una libertà prima nemmeno immaginabile; questo successo e,
inoltre, i primi effetti della incipiente rivoluzione industriale hanno permesso al
nostro Paese di uscire dalla condizione di isolamento in cui si trovava da
secoli rispetto al resto dell'Europa e hanno dato una forte spinta verso gli
ideali del Risorgimento, fino alla conquista di una nazione unita.
(Francesca Basso- Valentina)
2. I PRODROMI DEL RISORGIMENTO
Lucio Villari, nel primo volume dell’opera già ricordata si sofferma sul fatto
che verso la fine del 700 si diffonde una tempesta politica e culturale dalla
Francia rivoluzionaria. L'Italia per prima assapora quest'aria e in essa si
diffonde il concetto di libertà. La figura simbolo della libertà in Italia è appunto
Napoleone, il quale viene visto come portatore di libertà attraverso il mito
della rivoluzione francese, diventando alla fine lui stesso un mito della
modernità.
L'idea di Napoleone era di invadere l'Italia, ma questa invasione faceva parte
di un astuto piano militare per allontanare gli Austriaci dall'Italia del nord, e
quindi di liberare il confine sud orientale francese dalle minacce di invasione.
Allontanati gli Austriaci e vinti i loro alleati italiani, i Piemontesi, Bonaparte si
sarebbe concentrato nella guerra contro l'Inghilterra che, come gli Austriaci,
era nemica della Francia rivoluzionaria. La campagna d'Italia, elaborata da
Bonaparte con l'aiuto dei Giacobini, fu sottoposta al governo della Francia, il
Direttorio. La proposta venne approvata, così Napoleone parti a capo
dell'armata d'Italia il 2 marzo 1796.
Questa era la versione ufficiale, ma quali erano i progetti segreti del Direttorio
da una parte, e di Napoleone dall'altra?
L'intenzione del Direttorio era quella di tenere fuori dalla Francia un militare
abile che i conservatori, stanchi dell' politica provocata dalla rivoluzione,
vedevano come il possibile capo che, con energia, risolveva i problemi del
paese.
Bonaparte invece vedeva nel buon esito delle campagne militari il trampolino
di lancio per conquistare il potere politico.
Questi propositi, contrapposti e segreti, si incrociavano con due ordini precisi
che Napoleone ricevette dal Direttorio: l'armata francese era incaricata di
depredare l'Italia delle maggiori ricchezze possibili per rimpinguare le casse
dello stato. Così fu, infatti, e l'Italia fu letteralmente depredata per anni.
Il secondo ordine del Direttorio consisteva nel non suscitare sentimenti
giacobini in Italia e quindi accantonare ogni spirito rivoluzionario. In realtà per
molti Italiani l'arrivo dei Francesi era legato proprio alla diffusione del
pensiero rivoluzionario.
La tattica di Napoleone, fino a quando lasciò l'Italia, fu quella di scatenare da
una parte le speranze nella rivoluzione, dall'altra di tenerle sotto controllo,
tanto da venir sempre visto come liberatore, piuttosto che come
conquistatore. Infatti non si accontentava di lasciare un’ impronta di vincitore
militare, ma voleva segnare più profondamente il territorio anche come
organizzatore di nuovi istituti politici, giuridici ed economici : fu questa la vera
rivoluzione provocata da Napoleone.
La prima campagna in Italia portò alla formazione della Repubblica
Cispadana (27 dicembre 1796) che si fondò in seguito con la Repubblica
Cisalpina nel Giugno 1797. Con la formazione della Repubblica Cisalpina
esplosero le ragioni, gli ideali sociali e culturali dell'identità nazionale italiana.
All'interno di questi territori, deboli furono le insorgenze contro i francesi da
parte di moderati conservatori fedeli al Papa.
Con la fine del 1797 si proclamò anche la Repubblica Ligure, in seguito (15
febbraio 1798) si formò invece la Repubblica Romana, che vide il Papa
ritirarsi a Siena. Se pur per un breve periodo questa indipendenza dimostrava
che il potere temporale del Papa poteva essere spazzato e di conseguenza
Roma poteva diventare uno stato moderno e libero. Si dimostrava inoltre con
questa operazione lo spirito laico della rivoluzione francese.
I francesi proseguirono per Napoli nonostante le resistenze e i tentativi di
liberare Roma da parte di Ferdinando IV e Carolina ma anch'essi furono
costretti a rifugiarsi a Palermo. Il 23 gennaio 1799 i francesi occuparono
Napoli. I ceti più poveri rimasero fedeli al re e la repubblica fu diretta e
sostenuta dagli esponenti della borghesia. Fu stesa una Costituzione sul
modello di quella francese del ‘95, che riconosceva l'uguaglianza e la
solidarietà come valori fondamentali. Fu anche redatta una proposta di legge
che aboliva i privilegi feudali che però il nuovo governo non riuscì a
promulgare. Questo governo non riuscì ad ottenere il consenso del popolo
che considerava la borghesia ceto sociale ricco e distante dalle esigenze
della popolazione. Su tale insofferenza poggiò la spedizione del cardinale
Ruffo che consenti la riconquista del regno di Napoli. Ciò fu possibile grazie
anche a sconfitte subite dai francesi per mano austriaca. Il governo cisalpino
si rifugiò in Francia e il 14 giugno l'esercito si ritirò anche dalla Campania. A
Napoli tornò il re che giustiziò più di cento patrioti; da questo momento in poi i
ceti colti si allontanarono definitivamente dalla dinastia Borbone. Questo
evento avrà poi un peso nella storia del Risorgimento.
IL RISORGIMENTO. Si può dire che ebbe inizio nel 1796, con i fatti appena
citati, e si concluse nel 1860-70. Tutto quindi ebbe origine con l'intervento
francese in Italia, che da un lato iniziò a modificare irreversibilmente il tessuto
sociale ed economico e, dall'altro, favorì il diffondersi di nuovi ideali politici.
Influenzati da Napoleone, gli uomini di cultura simpatizzarono per la
rivoluzione francese. La capacità di Bonaparte infatti fu quella di svegliare un
popolo alla propria coscienza, incitarlo, entusiasmarlo, renderlo consapevole
della capacità di rendersi libero. In tutto ciò Napoleone assicurava protezione
e per questo veniva visto come un messia. Egli si appoggiò dapprima agli
elementi più democratici: la borghesia e i nobili progressisti, allontanando gli
aristocratici reazionari che volevano rimanere fedeli al vecchio sistema di
privilegi.
In seguito i comandanti francesi cercarono di avvicinarsi a personalità
politicamente più moderate.
Bonaparte era solito ricordare che c'erano tre raggruppamenti: gli amici degli
antichi governi, coloro che volevano l'autonomia dell'Austria e coloro che
volevano una pura democrazia su modello francese. Egli cercò di
incoraggiare i secondi, che erano ricchi proprietari terrieri ed una parte del
clero, ceti che potevano contare su un maggior consenso popolare; mentre
moderava i terzi, scrittori e uomini di cultura che volevano fare la rivoluzione
perché amanti della libertà.
In ogni caso per l'Italia fu importante l'impulso alla rivoluzione dato da
Bonaparte, in quanto con esso maturava l' esigenza dell'unificazione e le
speranza di una trasformazione dei rapporti economico-sociali in senso
liberale.
I patrioti settentrionali erano persone di cultura appartenenti agli ambienti alto
borghesi e in genere ricchi. Questa condizione sociale costerà cara al
movimento democratico italiano perché si identificavano i ricchi con i
giacobini, ma ciò rendeva il popolo diffidente nei confronti degli ideali
rivoluzionari.
I patrioti sognavano comunque per l'Italia liberale, una repubblica
democratica centralista (su modello francese) o federalista, disputa questa
che si protrarrà per diversi anni.
PACE DÌ CAMPOFORMIO. La principale causa che disingannò i patrioti, i
quali divennero finalmente coscienti del vero interesse francese, fu appunto
questo Trattato, che vedeva il Veneto (appena conquistato dai Francesi)
passare nelle mani dell'Austria, insieme all'Istria e la Dalmazia. Alla Francia
vennero riconosciuti i territori alla sinistra del fiume Reno, ma venne anche
riconosciuta la repubblica Cisalpina che si arricchiva di Brescia, Bergamo e
Crema. La cosa fondamentale è che per la prima volta veniva legittimato uno
Stato rivoluzionario. Per i patrioti il Trattato venne invece inteso come
rinuncia o disinteresse alla causa dell'unificazione dei territori italiani e quindi
essi si sentirono traditi dai Francesi.
LA REPUBBLICA CISALPINA (Lombardia, Emilia Romagna, Trentino). Agli
occhi dei democratici giacobini essa rappresentava il primo nucleo di Stato
nazionale.
Quando i francesi si accorsero che le spinte autonomistiche erano troppo forti
e che la repubblica Cisalpina cercava di emanciparsi dall'ordine creato da
Bonaparte nel 1798, attraverso un piccolo colpo di stato porteranno al
governo di questa repubblica dei parlamentari fidati e vicini a loro.
Le repubbliche italiane piacevano fintanto che rimanevano assoggettate ai
Francesi. Ma questo atteggiamento arrogante cominciava a disturbare non
solo i giacobini italiani.
Si creò così una coalizione antifrancese (ne facevano già parte Inghilterra,
Austria e Russia), che si estese fino a Roma e Napoli partendo dalla
Repubblica cisalpina. A Roma tutti i simboli della cristianità erano osteggiati
dai francesi, in più le tasse e la nuova riorganizzazione socio-economica
contribuirono ad un malumore collettivo. A Napoli il nuovo governo abolì le
istituzioni feudali, ma il popolo, non ancora pronto a ciò, vedeva in questo la
demolizione di un assetto tradizionale che garantiva solidità e si sentiva
vicino non alla borghesia intellettuale bensì alle antiche figure: il re e il
signore feudale. Questi malumori, nel momento in cui Napoleone era
impegnato nella campagna d’ Egitto, scoppieranno facendo sì che i vecchi
organismi riprendessero il potere.
Ma l'allontanamento di Napoleone durò poco e tornato in Italia da imperatore
spazzò via la coalizione antifrancese e allontanò anche gli austriaci dalla
Lombardia e dalla Liguria.
Tra il 1801 e il 1805 Napoleone Bonaparte costruì le fondamenta di uno stato
borghese- liberale italiano attuando riforme amministrative, finanziarie,
economiche, culturali e giuridiche. L'Italia venne comunque divisa per
mantenere l'equilibrio dei rapporti internazionali: a Roma ritornò il Papa, nel
Regno di Napoli tornarono i Borboni, nel granducato di Toscana e di Parma si
impose invece Lodovico di Borbone.
Fra la figura di Napoleone e lo Stato della Chiesa si instaurarono subito
conflitti inconciliabili. Napoleone adottò un atteggiamento ostile nei confronti
dell'indipendenza della Chiesa in materia di religione e organizzazione
ecclesiastica (il suo Codice civile del 1804 riduceva al minimo le prerogative
della Chiesa in materia di matrimonio e rafforzava i poteri dello Stato).
Chiaramente questo atteggiamento indispose il papa che non accettava la
figura dell'imperatore come capo religioso e l'occasione per contrastarlo gli
venne offerta allorchè rifiutò l'imposizione imperiale a bloccare i commerci
con l'Inghilterra. Napoleone così occupò Roma nel 1809. Questa città per
l'Imperatore francese doveva riagganciarsi all'immagine di capitale imperiale
e slegarsi dalla tradizione cristiana: doveva divenire quindi la città del popolo,
della scienza, della modernità e della laicità. Allo stesso modo la penseranno
anche i patrioti ottocenteschi Mazzini, Cavour e Garibaldi che la vedevano
come capitale naturale dell'Italia unita.
Napoleone cercò di trasformare la città in modello esemplare della "potenza
imperiale" e usò, per raggiungere l'obiettivo, l'architettura e l'urbanistica. A
Napoli e in Toscana invece intervenne con strumenti di politica economica,
con istituti giuridici che avevano lo scopo di piegare definitivamente le classi
politiche tradizionali. In particolare, a Napoli, si redistribuirono le terre tra
aristocrazia e nuovi proprietari di origine borghese, creando così delle forme
amministrative meno subalterne al potere nobiliare. Nel nord agì cercando di
riorganizzare il sistema finanziario con interventi di tipo capitalistico e con una
riforma agraria. I nuovi strumenti che Napoleone cercò di introdurre in ogni
stato saranno i punti di partenza "liberali" cui si ispireranno tutti i governi
rivoluzionari successivi.
L'INIZIO DELLA FINE. Napoleone voleva conquistare la Russia in quanto
riteneva questa conquista fondamentale per ottenere l'egemonia politica ed
economica sul continente. La Russia dal canto suo era stanca dell'alleanza
con Napoleone poiché da questa era costretta ad un perenne isolamento
economico.
La campagna di Russia portò ad una pesante sconfitta francese e
l'imperatore fu costretto ad abdicare.
Gli austriaci e gli inglesi mandarono le loro truppe in Italia incuranti delle
offerte di amicizia proposte da Murat. Egli era il reggente francese di Napoli
che prese le distanze da Napoleone durante la campagna russa e
avvicinatosi di più ai napoletani aveva abbracciato la causa dell'unificazione
che voleva far partire proprio da quel territorio. L'occasione l'ebbe quando
Napoleone, fuggito dall'isola d'Elba, sbarcò in Francia e tornò al trono per
circa cento giorni. Murat nei primi mesi del 1815 partì con 80.000 uomini da
Napoli alla volta del Po per battersi contro gli Austriaci. Il 30 marzo lanciò un
appello agl'Italiani affinchè si levassero con lui per guadagnarsi con le armi
l'unità e l'indipendenza. Era il "proclama di Rimini" in cui Murat così
sollecitava lo spirito patriottico: "Italiani! Dall'Alpi allo stretto di Scilla odasi un
grido solo: l'indipendenza dell'Italia... Una Costituzione degna del secolo e di
voi garantisca la vostra libertà e prosperità interna": L'appello cadde nel vuoto
e di li a poco Murat fu sconfitto definitivamente.
Il 18 giugno seguì a Waterloo la sconfitta definitiva di Napoleone. Murat fece
un ultimo tentativo per riconquistare Napoli, tornata sotto il dominio dei
Borbone, Ferdinando e Carolina, sbarcando in Calabria e inneggiando alla
libertà d'Italia ma fu subito arrestato e condannato a morte.
(Maria Vittoria Bellot)
3. DAL 1820 AL 1846
Nel terzo volume de Il Risorgimento, Lucio Villari ricostruisce i principali
eventi storici del periodo tra il 1831 e il 1846. Egli inizia osservando come,
nonostante gli insuccessi dei moti italiani del 1820-21, gli sforzi e le agitazioni
legate a quegli avvenimenti ottennero una risonanza a livello internazionale.
La Francia divenne la vera Nazione portatrice di cambiamenti. In Italia come
in altri Stati europei ci furono diverse insurrezioni, ma fu la Francia a divenire
il vero scenario delle novità politiche. Al tempo c’erano i liberali (come ad
esempio Thiers o Constant) che si opponevano ai conservatori battendosi per
i diritti dei cittadini. I monarchi di conseguenza dovettero concedere maggiori
libertà per assicurarsi il consenso popolare. Luigi XVIII aveva concesso una
Carta Costituzionale per mantenere il controllo della situazione, al momento
della Restaurazione Carlo X invece non riuscì a reggere le crescenti richieste
progressiste, e nel 1830 scoppiò una crisi politica che il sovrano cercò di
nascondere dando inizio alla conquista dell’Algeria. Le imprese coloniali
servivano per da distogliere l’attenzione sulla delicata situazione interna.
Tuttavia il suo fu uno sforzo vano: la popolazione si accorse dei cambiamenti
contro i progressisti che stava effettuando Carlo X, e il 26 giugno scoppiò una
rivolta a Parigi, con il risultato che il re fu costretto ad abdicare e il
Parlamento investì della suprema autorità Luigi Filippo, duca d’Orleans. che
aveva sempre mostrato la sua solidarietà verso le idee liberali.
In questo modo si avviò la graduale creazione di un’ Europa liberale, che
comprendeva parte degli Stati occidentali, in cui fossero garantite pari libertà
a tutti i cittadini.
Dunque il liberalismo, come sistema politico, si estendeva all’Inghilterra, al
sistema Americano e Stati dotati di un sistema parlamentare, e il suolo
francese era governato da un sistema costituzionale.
Di fatto però questi cambiamenti sul suolo francese rappresentavano una
frattura nei confronti della Santa Alleanza, tanto che la Francia dichiarò di non
voler più intervenire negli affari interni dei singoli Stati negando così il
privilegio d’intervento come diritto delle Grandi Potenze di sorvegliare gli altri
Stati. Così si giunse alla formazione di una nuova Europa, suddivisa in due
blocchi: il primo, formato da Austria, Russia e Prussia, conservatore; e il
secondo, comprendente Francia e Inghilterra, liberale.
In questo secondo blocco, per altro, si sperimentarono riforme politiche più
avanzate. L’Inghilterra, ad esempio, divenne lo scenario di una nuova riforma
elettorale, che favorì l’eguaglianza e la giustizia in materia di diritti politici e
sociali.
Gli echi di queste riforme raggiunsero altri Stati europei. In Belgio, Paese
cattolico e industriale, il 25 agosto 1830 ci fu un’insurrezione che ottenne
l’indipendenza del Paese e la fine dell’unione con l’Olanda che era stata
decisa nel Congresso di Vienna. Nel novembre del 1830 il Belgio si dichiarò
territorio neutrale, e nello stesso periodo la Francia si staccò dalla Santa
Alleanza (Conferenza di Londra).
In Italia un anno più tardi, il Ducato di Modena e lo Stato Pontificio furono i
territori maggiormente soggetti ai moti liberali, e i Carbonari cominciarono
preparare ed attuare atti di forza.
In Francia nel frattempo si creò “La Società dell’italiana emancipazione” che
fece stringere I rapporti tra i Carbonari italiani e i repubblicani francesi. Luigi
Filippo disse che avrebbe ceduto Lombardia, Parma e Toscana a Francesco
IV duca di Modena in cambio di un rapporto privilegiato con la Francia. Ciò
non avvenne, tuttavia Francesco IV voleva ingrandire I suoi domini e si ritrovò
a fianco Enrico Misley, un patriota favorevole alla Carboneria. Altra figura di
rilievo nell’organizzazione di quei moti, fu Ciro Menotti, che invitò Francesco
IV a partecipare alle cospirazioni carbonare. Non e’ chiaro, non esistendo
documenti in proposito, se il sovrano abbia effettivamente preso parte alle
attività carbonare. Anche se e’ certo che ad un certo punto il duca diffidò di
Menotti dal mettere in atto il piano di una rivolta nell’Italia centrale.
Lo scrittore Giovanni Ruffini che vi aderì, ha spiegato che la struttura della
Carboneria era caratterizzata da un verticalismo e da complessi rituali
simbolici, che erano allo stesso tempo la sua forza e il suo punto debole.
Tutto ciò infatti faceva assumere alla società segreta un carattere molto
chiuso che rendeva particolarmente difficile il contatto con i suoi affiliali.
In un secondo momento, le tensioni della penisola si trasformarono in
insurrezioni che coinvolsero le città di Bologna e Parma nelle giornate del 4 e
del 14 febbraio 1831; videro la vittoria degli insorti, i quali si unirono creando
il Governo delle Nazioni Unite (che comprendeva Romagna, Marche e
Umbria).
La situazione divenne subito complicata: a Bologna si instaurò un fragile
governo provvisorio, che aveva Monaldo Leopardi, padre del celebre
Giacomo, come deputato. Egli, aristocratico antirivoluzionario, chiuso agli
influssi culturali del secolo, si trovò a dover affrontare il problema della
“conquista” delle masse popolari, che dopo la Rivoluzione francese, avevano
visto la crisi delle vecchie fedeltà fondate sulla deferenza.
A Modena, invece, (il 10 marzo) il generale Zucchi fu costretto ad
abbandonare la città dopo l’avanzata austriaca; a Parma il governo di Maria
Luigia ormai in crisi fu sostituito da un nuovo governo provvisorio. Lo Stato
Pontificio cadde anch’esso in crisi, e dopo la morte di Pio VII non si riusciva a
designare il suo successore. Infine a Napoli salì al potere Ferdinando II, che
aveva solo 20 anni.
In questo frangente furono diversi i poeti e gli scrittori di rilievo (come
Giovanni Berchet) che sostennero la causa della libertà comune, cercando
supportare con le loro opere i cambiamenti in atto.
Tuttavia ciò non fu sufficiente. Gli Austriaci, vista la situazione di debolezza
delle Province Unite, diedero inizio alla conquista dell’Italia centrale. Qui si
tentò di organizzare rapidamente un esercito efficiente, ma la scarsità di
tempo e di risorse, lasciò il via libera agli Austriaci, che nel 1832 rioccuparono
l’Italia.
Intanto Francesco IV si vendicò su Minotti e lo fece condannare a morte. Gli
avvenimenti del 1831 determinarono in Italia la crisi del movimento settario.
Ne uscì diminuita la Francia, con la sua deludente politica a favore dell’Italia.
Il governo francese infatti, aveva chiesto all’Austria di ritirare le truppe dai
territori italiani occupati, in particolare dallo Stato pontificio. Ma questa
richiesta non fece altro che aggravare la situazione delle popolazioni locali,
dal momento che la Francia chiedeva al pontefice di concedere delle riforme
e in particolare di ammettere la costituzione di governi locali laici con ampia
autonomia amministrativa. Il papa ovviamente rifiutò.
L’Austria sgomberò le Legazioni dei suoi soldati, che vennero sostituite da
dure e insolenti milizie pontificie. Quest’ultime erano talmente violente che
nacquero proteste così insistenti, che pochi mesi dopo, nel gennaio 1832, gli
austriaci tornarono a occupare Bologna come i liberatori e i protettori delle
popolazioni locali. La Francia, spaventata all’idea di poter perdere ulteriore
credibilità, occupò Ancona. Tuttavia il papa non cedette mai, e solo dopo sei
anni, nel 1838, austriaci e francesi lasciarono Bologna e Ancona.
L’esperienza dei moti del ’30-’31, fondamentalmente non aveva portato
cambiamenti radicali dal punto di vista politico, tuttavia aveva aperto le menti
migliori e le forze più giovani del movimento liberale spingendole ad
elaborare programmi più adatti alla lotta contro l’Austria e contro i governi
reazionari.
Primo tra tutti fu Giuseppe Mazzini che nel 1832 fondò una nuova
associazione, la “Giovane Italia”, che aveva priorità politiche insurrezionali, il
cui programma veniva pubblicato su un periodico al quale fu dato lo stesso
nome. L'obiettivo di questa organizzazione era quello di trasformare l'Italia in
una repubblica democratica unitaria, secondo i principi di libertà,
indipendenza e unità, destituendo i governi dei precedenti Stati Preunitari.
In realtà la Giovine Italia fu ideata nel 1831, quando Mazzini si trovava a
Marsiglia in esilio dopo l'arresto e il processo subito l'anno prima in Piemonte
a causa della sua collaborazione con la Carboneria. Non potendo provare la
sua colpevolezza, la polizia lo mandò esilio. Mazzini nel febbraio del 1831
passò in Svizzera, da qui a Lione e , infine, a Marsiglia. Qui entrò in contatto
con i gruppi di Filippo Buonarroti e col movimento sansimoniano allora diffuso
in Francia. Con questi gruppi si avviò un'analisi delle cause del fallimento dei
moti nei ducati e in Romagna del 1831.
Si concordò sul fatto che le sette carbonare avevano fallito innanzitutto per la
contraddittorietà dei loro programmi e per l'eterogeneità delle classi che ne
facevano parte. Non si era riusciti poi a mettere in atto un collegamento più
ampio delle insurrezioni per le ristrettezze provinciali dei progetti politici,
com'era accaduto nei moti di Torino del 1821 quando era fallito
analogamente ogni tentativo di collegamento con i fratelli lombardi. Infine
bisognava desistere, come nel 1821, dal ricercare l'appoggio dei principi e,
come nei moti del 1830-1831, l'aiuto dei francesi.
Al programma della Giovine Italia aderirono soprattutto i giovani in Liguria, in
Piemonte, in Emilia e in Toscana, i quali si misero subito alla prova
organizzando negli anni 1833-1834 una serie di insurrezioni che si
conclusero tutte con arresti, carcere e condanne a morte. In quegli stessi
anni, durante il periodo dei processi in Piemonte e dopo il fallimento della
spedizione di Savoia, l'associazione scomparve per quattro anni.
Nel 1833 organizzò i tentativi insurrezionale a Chambery, poi a Torino,
Alessandria e Genova, dove contava vaste adesioni. Ma prima ancora che
l'insurrezione iniziasse la polizia sabauda a causa di una rissa avvenuta fra i
soldati in Savoia, scoprì e arrestò molti dei congiurati. Fra i condannati
figuravano i fratelli Giovanni e Jacopo Ruffini, l'avvocato Andrea Vochieri e
l'abate torinese Vincenzo Gioberti. Tutti subirono un processo dal tribunale
militare, e dodici furono condannati a morte, fra questi anche il Vochieri,
mentre Jacopo Ruffini pur di non tradire si uccise in carcere mentre altri
riuscirono a salvarsi con la fuga.
Il fallimento di questo moto non fermò Mazzini: rifugiatosi a Ginevra, assieme
ad altri italiani e alcuni polacchi, organizzò un'azione militare contro lo stato
dei Savoia. A capo della rivolta mise il Generale Gerolamo Ramonio, questa
scelta però si rivelò un fallimento, perché il Ramorino, rimasto senza soldi,
rimandava continuamente la spedizione, e quando si decise a passare con le
sue truppe il confine con la Savoia, la polizia ormai allertata da tempo,
disperse i volontari con molta facilità.
Nello stesso tempo doveva scoppiare una rivolta a Genova, sotto la guida di
Giuseppe Garibaldi, che si era arruolato nella marina da guerra sarda per
svolgere propaganda rivoluzionaria tra gli equipaggi. Quando giunse sul
luogo dove avrebbe dovuto iniziare l'insurrezione, però, non trovò nessuno e
fu costretto a fuggire. Di questa fuga, ne parla lo scrittore Alexandre Dumas,
che nel suo libro “Garibaldi” ci ricorda come il generale italiano aveva
combattuto a fianco degli Uruguaiani e poi degli Argentini, accrescendo la
sua fama oltre oceano.
Mazzini, invece, poiché aveva personalmente preso parte alla spedizione con
Ramorino, fu espulso dalla Svizzera e dovette cercare rifugio in Inghilterra. Lì
continuò la propria azione politica attraverso discorsi pubblici, lettere e scritti
su giornali e riviste, aiutando a distanza gli italiani a mantenere il desiderio di
unità e indipendenza. Anche se l'insuccesso dei moti fu assoluto, dopo questi
eventi, la linea politica del re dei Piemontesi Carlo Alberto mutò, per il timore
che reazioni eccessive potessero diventare pericolose per la monarchia. Fu
così che Carlo Alberto cominciò a mostrare vaste aperture verso i sostenitori
della causa italiana.
I movimenti popolari di ispirazione liberale e patriottica si svilupparono in
un’Europa che era ormai arrivata verso lo sviluppo industriale. Innanzitutto
l’Inghilterra, che prima della metà dell’Ottocento diede inizio a una vera e
propria <<febbre ferroviaria>> che ben presto raggiunse gran parte
dell’Europa. Se da una parte però i liberali guardavano con orgoglio queste
innovazioni, le classi dirigenti tradizionali cominciarono a sospettare di esse,
ritenendole promotrici di tendenze rivoluzionarie.
In Italia lo sviluppo di questa nuova risorsa fu ampiamente appoggiata dal
milanese Carlo Cattaneo, il quale vedeva nella ferrovia il futuro della libertà e
della mobilità di uomini e merci, che avrebbe aiutato ad attenuare le
differenze sociali. Cattaneo grazie alla creazione di una rivista divenne il
fautore di una prospettiva politica legata alle autonomie e al federalismo
basato su una moderna cultura della <<città>>.
Altro accanito sostenitore del sistema ferroviario, per il suo valore economico
e simbolico, fu Camillo Benso di Cavour, giovane piemontese aperto al
progresso e alle innovazioni tecniche.
Nonostante il cofavore dei progressisti settentrionali, la prima rete ferroviaria
italiana fu inaugurata a Napoli. Infatti era proprio nel Regno delle Due Sicilie
che si trovava un gruppo dirigente curioso nei confronti delle novità
scientifiche, sebbene fosse molto chiuso verso le riforme politiche e sociali.
Queste innovazioni però non bastarono a spingere i governi stranieri ad
approvare riforme politiche, e gli italiani si trovarono davanti ad un dilemma: il
cambiamento sarebbe stato raggiunto tramite lente e graduali riforme, oppure
si sarebbe dovuto ricorrere a rivolte e rivoluzioni più incisive?
Ci fu un tentativo di rivolta nel 1844 quando, dopo l’attacco mazziniano fallito
ad Imola, fratelli Emilio ed Attilio Bandiera prepararono una spedizione
rivoluzionaria con patrioti italiani che si trovavano a Corfù e a Malta. Essi
crearono una società segreta, “l’Esperia”, che si rifaceva agli ideali liberali
democratici ed erano mossi dalla speranza di riuscire a realizzare una
sollevazione popolare nel Sud Italia.
Il 13 giugno 1844, partirono da Corfù alla volta della Calabria seguiti da 17
compagni, dal brigante calabrese Giuseppe Meluso e dal corso Pietro
Boccheciampe. Il 16 giugno 1844 sbarcarono alla foce del fiume Neto, vicino
Crotone e appresero che la rivolta scoppiata a Cosenza si era conclusa e che
al momento non era in corso alcuna ribellione contro l'autorità del re. Pur non
essendoci alcuna rivolta in atto su cui far leva, i fratelli Bandiera vollero lo
stesso continuare l'impresa e partirono per la Sila. Il Boccheciampe, appresa
la notizia che non c'era alcuna sommossa a cui partecipare, sparì e andò al
posto di polizia di Crotone per denunciare i compagni. L'allarme dato
raggiunse anche la cittadina di San Giovanni in Fiore.
Subito iniziarono le ricerche dei rivoltosi ad opera delle guardie civiche
borboniche. Proprio quando il gruppetto si trovava alle porte di San Giovanni
in Fiore, venne avvistati dalle guardie civiche partite dal paese, e in seguito
ad alcuni scontri a fuoco, i cospiratori vennero tutti catturati (meno il brigante
Giuseppe Meluso). Furono portati dinanzi la corte marziale, che li condannò a
morte. Il re Ferdinando II fu severo e ne graziò pochi; i fratelli Bandiera con
altri sette compagni, vennero fucilati nel Vallone di Rovito nei pressi di
Cosenza il 25 luglio 1844.
La delusione e il dolore di Mazzini e dei suoi seguaci fu grande ma non tale
da fermarli. Nel 1845 organizzarono un’insurrezione nello Stato della Chiesa:
l’attacco a Rimini servì per risvegliare la Romagna, ma anche questo
tentativo fu facilmente represso. Si capì, di conseguenza, che bisognava
percorrere qualche altra strada per raggiungere l’indipendenza italiana.
Massimo d’Azeglio nel 1846 scrisse “Degli ultimi casi di Romagna”, in cui
evidenziò appunto l’inefficacia delle continue ribellioni mazziniane. Nello
stesso anno d’Azeglio si fece ricevere da Carlo Alberto col l’intento di
convincere il sovrano che il Piemonte potesse essere il candidato adatto per
condurre la rivoluzione italiana, così da evitare ulteriori rivolte.
Inaspettatamente fu la Chiesa ad accogliere la richiesta di d’Azeglio, e nel
1846 il pontefice Pio IX emanò “l’Editto del perdono” e nominò segretario di
Stato Pasquale Gizzi, conosciuto per l’appoggio che da sempre aveva dato
alle riforme.
Nella società italiana si assistette all’impegno di molti artisti (scrittori,
compositori..) che cogliendo gli influssi della nuova società orientata verso
l’eguaglianza civile, scrissero e misero in scena capolavori ancora oggi
riconosciuti come tali. Tra questi e’ importante ricordare: “il Nabucco” di
Giuseppe Verdi, “Giovanna d’Arco” di Temstocle Sulera, e soprattutto “I
promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Quest’ ultimo scrisse il suo romanzo
più celebre utilizzando una lingua popolare. Che fosse comprensibile per
chiunque.
Un’altra figura di rilievo del Rinascimento italiano e’ senza dubbio Vincenzo
Gioberti. Questi rifletté sull’identità europea e ne ricavò che non era altro che
il prodotto del cristianesimo. Da ciò ne dedusse che l’Italia, poiché era la sede
del Papato, era lo Stato più importante di tutta l’Europa. Esplicitò questa sua
tesi nel trattato “Il primato” del 1843, nel quale per l’appunto sottolineava la
supremazia italiana sul resto dell’Europa. Tuttavia Gioberti negò la possibilità
di formare una Stato unitario italiano. Poiché questo doveva reggersi sulla
sovranità popolare, che pur potendo contare sui prerequisiti dell’identità’
nazionale (come una lingua, una storia comuni..), era tuttavia priva di una
coscienza politica comune. La soluzione che propose Gioberti fu perciò
quella di unire tutti gli Stati della penisola già esistenti, lasciando che ognuno
mantenesse una propria autonomia e creando così una confederazione.
Questa prospettiva politica fu approvata da Cesare Balbo, un altro scrittore di
rilievo del Risorgimento, che giustificò l’impossibilita di un’Italia Unita con le
differenze storiche e geografiche delle diverse parti d‘Italia.
(Margherita Pontisso)
4. L’INSURREZIONE DI MILANO
Uno dei protagonisti delle Cinque Giornate di Milano fu Carlo Cattaneo,
esponente del fronte democratico risorgimentale, storico ed economista,
nato il 15 giugno 1801 a Milano. Il padre Melchiorre era un semplice orafo e,
dunque, non essendo le sue condizioni economiche molto agiate non poté
mandare il figlio in prestigiose scuole. Carlo comunque passò gran parte della
sua infanzia a dividersi tra la città in cui viveva e i soggiorni nella non molto
distante Casale, dove era solito curiosare e dedicarsi alla lettura dei classici
nella biblioteca del prozio Giacomo Antonio. Il suo amore per le lettere lo
indusse comunque a proseguire gli studi e, non potendo permettersi
l’iscrizione a scuole importanti, li intraprese nei seminari di Lecco prima e
Monza poi, che avrebbero dovuto portarlo alla carriera ecclesiastica, ma già
all'età di diciassette anni, abbandonò il seminario per continuare la sua
formazione presso il Sant'Alessandro di Milano e in seguito al liceo di Porta
Nuova dove si diplomò nel 1820. Sempre nello stesso anno la
Congregazione Municipale di Milano gli propose il ruolo di insegnante di
grammatica latina ed in seguito di scienze umanistiche presso il ginnasio di
Santa Maria. Cattaneo dovette accettare tale proposta a causa delle sue
ristrettezze finanziarie e qui rimase per quindici anni. Durante questo periodo
il giovane milanese cominciò a frequentare anche i corsi di diritto tenuti da
Gian Domenico Romagnosi presso l’università di Pavia ove si laureò in
giurisprudenza nel 1824. Numerose sono le vicissitudini che lo
accompagnarono sino al 1848; anno in cui ottenne alcune concessioni da
parte del vice governatore austriaco che vennero però immediata risposta a
questo atteggiamento seguito a questa negazione Cattaneo, che era alla
testa del Consiglio di Guerra, insieme a tutti i milanesi insorse contro il
nemico austriaco nel corso delle Cinque giornate di Milano – dal 18 al 22
marzo 1848 - liberandosi in questo modo dalla soffocante presenza austriaca
e rifiutando contemporaneamente anche l’intervento piemontese dal
momento che Cattaneo credeva, o meglio, riteneva che il Piemonte non fosse
un Regno con cui ci si potesse alleare, data la sua arretratezza sia
economica che politica e soprattutto che fosse davvero in grado di
contrastare il nemico. In seguito, dato l’esito fallimentare della guerra,
Cattaneo fuggì dall’Italia per cercare riparo in Svizzera dove, per altro, stabilì
una dimora fissa a Castagnola, presso Lugano, dove muore nel 1868. Pur
essendo più volte eletto in Italia come deputato del Parlamento dell'Italia
unificata, rifiutò sempre di andarci per non giurare fedeltà ai Savoia. Nel 1849
Cattaneo scrive un importante saggio dedicato al racconto dei fatti avvenuti in
Italia durante il dominio austriaco “L’insurrezione di Milano nel 1848”. Nel libro
vi sono due prefazioni dedicate una ai Francesi e l’altra agli Italiani. La prima
serviva ad introdurre ai Francesi le tappe con cui si erano svolti realmente i
fatti avvenuti in quei momenti –e Cattaneo era stato un testimone e un
protagonista di quei tumulti- e per far quindi meglio comprendere che quello
avvenuto a Milano era solo il primo stadio di una rivoluzione che,
cominciando a mettere in luce gli aspetti negativi del dominio straniero, aveva
in tal modo minato le basi dell’impero austriaco davanti agli occhi di gran
parte degli Italiani.
La prefazione rivolta invece a questi ultimi non ha finalità didattiche (che
sarebbero state decisamente inutili); Cattaneo decide di usarla per riuscire a
spiegare il motivo per cui ha scritto questo libro. Egli infatti fin dall’inizio ci
informa di come gli altri stati hanno visto questa rivolta: i Francesi credevano
che Carlo Alberto avesse tentato di aiutare tutta la popolazione italiana
compiendo addirittura degli atti eroici che, però, erano stati vanificati dalla
perfidia e dalla discordia degli stessi Italiani. Cattaneo decise di scrivere
questo opuscolo perché, avendo egli vissuto di prima persona tali
avvenimenti, desiderava far conoscere a tutti coloro che avrebbero letto il
libro la verità circa i fatti avvenuti al 1848, in modo tale da individuare i meriti
ma anche gli errori e le responsabilità all’origine della sconfitta militare.
Il primo capitolo è intitolato “Antecedenti fino al 1847” e narra come, in
seguito alla caduta di Napoleone, mentre l’Italia era solamente conquistata la
Francia era invece assolutamente e totalmente vinta. Il Congresso di Vienna
decretò che la Francia fosse posta sotto il controllo di un esercito straniero
per prevenire qualunque insurrezione popolare. Venne fatta la stessa cosa
nel Lombardo- Veneto ma qui la forza straniera era vista come una sorta di
guardia di svizzeri; gli Austriaci erano infatti considerati dagli italiani più che
altro alla stregua di difensori personali e quelli si fecero credere tali fino a che
decisero di far crollare le apparenze; mostrandosi per ciò che erano
realmente: occupatori. Ovviamente questi, temendo che nel popolo a loro
sottomesso potesse nascere la volontà di creare una nazione coesa,
decisero di smantellare non solo l’esercito ma anche ogni struttura o figura
che avesse con questo qualche collegamento. Oltre a ciò vennero ad
aggiungersi delle ingiustizie non solo a livello finanziario (secondo Cattaneo
l’Italia in quegli anni pagava un terzo delle imposte dell’Impero sebbene gli
Italiani fossero solamente un ottavo della popolazione complessiva) ma
anche a quello intellettuale poiché stampa, dibattiti politici ed insegnamento
erano sviliti dalla presenza di personalità ignote che pretendevano di
modificare dalle fondamenta tutto il nostro sapere accumulato nel tempo. Tali
ingiustizie e soprusi pesavano talmente tanto sul capo di molti Italiani che
questi decisero di ribellarsi agli occupanti ma non avendo un esercito proprio
e non volendo affidarsi a quello francese, decisero di rivolgersi, ne 1821, alla
casata dei Savoia che però si mostrò riluttante ad intervenire; eccezion fatta
per Carlo Alberto di Carignano (principe della casa di Savoia) che però,
rendendosi conto della difficoltà dell’impresa, decise di ritirare il suo aiuto da
questa “congiura” ai danni dell’Austria; lasciando così in balia della crudeltà
austriaca tutti coloro che avevano dato vita a tale rivolta. Per la prima volta
anche i nobili, che sempre avevano trattato con riverenza gli invasori, si
ritrovarono ora a guardarli con una maggiore diffidenza e freddezza;
instillando in tal modo negli altri paesi la credenza che fossero le classi
agiate, in Italia, fomentare l’idea di rivoluzione. Questo era completamente
sbagliato poiché in generale i nobili, osserva Cattaneo, si interessavano a
stabilire facili alleanze con gli invasori in modo tale da poter conservare i loro
privilegi di classe. Erano invece i cittadini borghesi a pensare all’unità della
nazione; arruolandosi per questo scopo nella Giovine Italia e cercando di
smuovere gli animi di tutti gli altri. Dopo un periodo di relativa tranquillità il
governo austriaco tornò ad ostentare le antiche abitudini e i nobili, delusi
ulteriormente da ciò, si rivolsero nel 1838 nuovamente a Carlo Alberto il
quale, essendo divenuto regnante (1831), aveva la possibilità di organizzare
un proprio esercito in funzione anti austriaca. Il ritorno degli esuli unito
all’elezione di Pio IX contribuirono a far crescere la speranza negli Italiani di
poter riconquistare quella libertà che da molto tempo avevano perduto. Era
necessaria dunque una nuova rivoluzione che troncasse nettamente i rapporti
con il passato politico dell’Italia.
Nel secondo capitolo si parla invece delle “Dimostrazioni” fatte dal popolo;
ossia quelle azioni atte a mostrare deliberatamente allo straniero la propria
avversità nei confronti del regime a cui era sottoposto. Cattaneo qui ci
descrive il comportamento che il popolo milanese ebbe quando venne eletto
un arcivescovo italiano in seguito alla morte di quello austriaco Gaisruck.
Attorno al Duomo e per le vie attigue i Milanesi festeggiarono tale
avvenimento, esaltando il nuovo prelato come un vessillo della nazione.
Questo “piccolo” moto di esaltazione nazionale venne subito messo a tacere
dall’esercito nemico il quale, infiltratosi nella folla di nascosto, sguainò le
sciabole per far finire tutto nel sangue. Da come si può capire dimostrazioni di
questo tipo erano inutili e pericolose solamente per i cittadini; accanto a
queste ve n’erano però delle altre che avevano una visione maggiormente
lungimirante in quanto miravano ad attuare modifiche riguardo aspetti politici
e legislativi del governo austriaco e cominciando dunque a far crollare le basi
del potere nemico.
Nel terzo capitolo intitolato “Prime Ostilità” Cattaneo racconta quello che gli
italiani dovettero subire da parte dei soldati austriaci i quali, capeggiati dal
crudele generale Radetzky, infliggevano deportazioni e dure punizioni a
patrioti; da ricordarsi il 3 gennaio 1848 quando, dopo che di comune accordo
molti giovani avevano smesso di fumare per creare problemi finanziari al
governo austriaco, i granatieri ungheresi ed i dragoni tedeschi si sentirono
autorizzati dai propri superiori a scagliarsi con le sciabole contro tutto il
popolo che in quel momento era presente nel centro di Milano.
Nel quarto capitolo si tratta finalmente della sollevazione degli Italiani. La sera
del 17 marzo 1848 infatti, mentre si vociferava riguardo l’abolizione della
censura, mentre Cattaneo si preparava a scrivere un articolo che spingesse
tutti gli Italiani a creare una grande alleanza in grado di respingere i nemici, il
podestà Casati (che era invece uomo succube tanto degli austriaci quanto dei
sabaudi) si recò presso la struttura ove si trovava il governo nemico per
domandare alcune concessioni da parte del popolo. Fu questo l’inizio della
ribellione del 18 marzo 1848. Gli Austriaci e il generale Radetzky, terrorizzati
che questa rivolta fosse stata istigata e governata da qualcuno, si ritirarono
dalle loro postazioni abituali. Il generale austriaco trovò rifugio nel castello e
da lì cominciò repentinamente a muovere assalti contro il popolo, che tentò in
ogni modo di resistergli. La mattina del 19 marzo, contro le aspettative
pessimistiche del Cattaneo, il popolo riprese ad accorrere presso le barricate
che erano state erette la sera prima in maniera preventiva per tornare a
combattere come il giorno prima. Nello stesso momento apparve la possibilità
proposta da parte del generale Rivaira di affiancare agli insorti i 300 gendarmi
presenti in Milano; questa offerta di aiuto venne però vanificata a causa della
viltà del podestà Casati che voleva chiedere prima il permesso da parte del
comandante della polizia austriaca di poter accettare tale supporto. Non
restava altro da fare se non continuare a lottare e creare un Consiglio di
Guerra con cui decidere le istruzioni belliche da dare al popolo non solo per
agire contro il governo ma anche per difendersi. Casati, troppo timoroso per
andare contro il governo, si limitò a creare una Congregazione Municipale in
cui autorizzava certe personalità a presiedere tale azione militare in
mancanza di un’autorità politica superiore. Collateralmente Cattaneo, insieme
a Terzaghi, Clerici e Cernuschi, creò un vero e proprio Consiglio di Guerra il
cui scopo principale era quello di rendere l’Italia libera e abbattere di
conseguenza il nemico.
Nel quinto capitolo intitolato “Il Consiglio di Guerra” Cattaneo informa che la
prima cosa che fece il Consiglio di Guerra fu quella di dare un comune intento
agli sforzi dei cittadini ribelli i quali, inoltre, furono esortati a non versare una
stilla di sangue all’infuori dei combattimenti. Verso il 20 marzo arrivò un
collaboratore del generale Radetzky che chiedeva di conoscere quale fosse
la volontà della città riguardo quel conflitto. La Congregazione Militare
capeggiata dal Casati proponeva un armistizio affinché Radetzky andasse a
Vienna per riferire quanto accaduto e ottenesse la facoltà di fare le
concessioni al popolo. Il Consiglio di guerra guidato invece da Cattaneo non
era assolutamente concorde con tale decisione poiché ipotizzava il pericolo di
un attacco a sorpresa da parte dei soldati austriaci, a meno che il generale
non avesse lasciato nel Regno i soldati italiani conducendo fuori dai confini
tutti gli altri. Infine era del tutto impossibile attuare l’armistizio proposto dal
Casati perché i cittadini non avrebbero mai accettato di allontanarsi dalle
barricate ove combattevano per proteggere i loro ideali. A causa di questo
rifiuto, in seguito, la municipalità decretò di assumere ogni potere fino al
ristabilimento dell’ordine: i milanesi erano dunque pronti a ripudiare il nome
degli austriaci per passare sotto l’egida di un nuovo padrone.
Intanto l’insurrezione popolare continuava e, per far giungere i messaggi di
rivolta anche fuori Milano, la gente si ingegnò in moltissimi modi. Un esempio
è quando cominciò a mandare in aria dei palloni che portassero messaggi in
altri luoghi ove il suono dei cannoni non s’era ancora udito. A quel punto gran
parte della penisola italiana era in fermento e moltissima gente decideva
perfino di recarsi Milano da cui venivano inviati messaggi di speranze sempre
più concrete per un’Italia libera. Durante il 21 marzo la Congregazione
Militare ed il Consiglio di Guerra tornarono ad unirsi dal momento che
avrebbero dovuto dare nuove disposizioni ai consoli austriaci. Questa volta la
municipalità proponeva un armistizio di tre giorni durante i quali, attraverso
una porta della città, veniva dato il libero accesso alla consegna dei viveri per
la popolazione e, attraverso un’altra, era concessa la libera uscita per cittadini
e stranieri. Cattaneo si oppose a tale idea e anche questa volta, dunque, non
si trovò un accordo comune. Successivamente a ciò subentrò un altro
problema: il Martini, inviato da Carlo Alberto, voleva che tutta la penisola si
piegasse alla volontà del re sabaudo nel creare un governo provvisorio
avente lui come capo, egli di conseguenza sarebbe giunto subito in soccorso
dei ribelli. Cattaneo si oppose perché, per fare questo, sarebbe servita una
votazione che in quel momento avrebbe distratto tutto il popolo dal
combattimento. Era meglio dunque aspettare la fine della rivolta per prendere
decisioni politiche. Inoltre, dando tutto il potere a Carlo Alberto, si sarebbe
coinvolto solamente il Piemonte quando sarebbe stato meglio coinvolgere
l’Italia intera. Se ciò però non fosse avvenuto,Carlo Alberto sarebbe stato
l’unico alleato e, di conseguenza, egli sarebbe stato il nuovo padrone
dell’Italia. Ma, a causa delle continue e pressanti sollecitazioni del Martini
congiunte alla totale insicurezza della municipalità circa una vittoria sui
nemici, nella tarda notte del 21 marzo, si decise di dare vita al governo
provvisorio che, in tal modo, non richiedeva più la presenza del Consiglio di
Guerra.
All’alba del 22 Marzo appunto questa organizzazione deponeva il potere ma
rimaneva comunque una istituzione necessaria in quanto il popolo obbediva
solamente al loro comando. Il governo provvisorio, avendo preso atto di tale
realtà, non si annunciò apertamente. Il Consiglio di Guerra visse ancora
solamente per 48 ore.
Nel sesto capitolo intitolato “il Comitato di Guerra” Cattaneo racconta di come
il 22 Marzo tutti gli insorti si scagliarono contro l’esercito di Radetzky – che
non aveva più forza di domare la città – in modo tale da cacciarlo
definitivamente da Milano. Alla sera dello stesso giorno il generale arrancava
in una disperata e precipitosa fuga. Dopo cinque dure giornate di lotta,
costellate di numerosi morti, Milano si poteva dire libera dai nemici, ma ciò
nonostante decise comunque di mantenere la città totalmente sorvegliata. Il
giorno seguente alla vittoria il Comitato di Guerra decise di dividere la
popolazione volonterosa parte nella guardia civica e parte nelle colonne
mobili che avrebbero dovuto tenere occupate le Alpi, per rendere ancor più
difficoltosa l’eventuale passaggio del nemico per quei luoghi. Le popolazioni
accanto a Milano vennero invitate a dare un aiuto oppure a cercare e ad
armare tutti gli uomini che volevano aiutare a rendere difficoltosa la fuga degli
Austriaci. Accanto a tale impeto popolare Cattaneo pensò però di creare
anche un ministero di guerra in cui si coniugassero la saggezza dei veterani
con la forza della gioventù, in modo tale da rendere la forza militare
maggiormente compatta e omogenea. Ma in quel momento subentrò il
governo provvisorio che, volendo togliere il comando di tali azioni al popolo
per rimetterlo in uno stato di servile obbedienza, aveva cominciato a
pretendere che le decisioni del Consiglio di Guerra venissero sottoposte al
suo controllo e, quando Carlo Alberto superò il Ticino, esautorò totalmente di
ogni potere l’organizzazione di Cattaneo per rimettersi in tal modo nelle mani
del re sabaudo. L’ultimo giorno di Marzo i componenti del Consiglio di Guerra
diedero le loro dimissioni.
Cattaneo spende tutto il settimo capitolo intitolato “La Politica di Carlo
Alberto” per parlare della politica del re sabaudo. Questi era mosso a guerra
da svariate ragioni: prima tra tutte era la possibilità di guadagnare più sudditi
e dunque espandere in tal modo il suo regno. In secondo luogo compiendo
tale passo avrebbe impedito la nascita di una Repubblica in Italia, cioè la
forma di governo che da sempre aveva avuto in questa nazione grande
gloria.
Per farsi accettare in suolo italico era necessario che però si attorniasse con
molte menti con false illusioni di libertà o comprando direttamente facendo
leva sulla cupidigia del genere umano. L’8 febbraio 1848 il re di Savoia aveva
promesso al suo popolo addirittura un patto costituzionale ma durante le
cinque famose giornate di Milano, mentre i cannoni nemici vomitavano fuoco
sugli italiani, si limitò ad inviare Martini il quale vendeva l’aiuto del re a patto
che gli insorti tutti si piegassero al suo volere. Con la vittoria del popolo
milanese però Carlo Alberto si ritrovò alle strette dal momento che l’insorgere
del popolo avrebbe potuto creare il rischio di vedere sorgere una repubblica;
decise allora il 23 marzo di dichiarare guerra. A causa dell’enorme ambizione
di Carlo Alberto nel possedere quante più terre italiane poteva, egli non si
curava degli screzi che intanto si andavano a creare all’interno dello stato,
causate dalla sua smania di potere incontrollata e dettata dalla paura che
qualche cosa potesse essere modificato senza il suo consenso. Inoltre vi
furono molte lagnanze anche sul fatto che Torino, secondo il volere del re,
avrebbe potuto superare d’importanza Milano, città più importante e che sin
dai tempi più antichi era divenuta un punto cruciale dell’Italia settentrionale.
Carlo Alberto era inoltre avverso nei confronti di tutti i volontari che avevano
lottato durante le cinque giornate poiché questi avrebbero potuto traviare
l’esercito sabaudo con fuorvianti discorsi sulla libertà; tale eventualità portò il
re sabaudo ad accentrare nelle sue mani tutto il potere militare.
Nell’ottavo capitolo intitolato “Il Governo Provvisorio” Cattaneo narra la
situazione che si era venuta a creare in Italia dopo la precipitosa ritirata dei
nemici al termine delle cinque giornate di Milano e dei vili comportamenti che
tenne il Governo Provvisorio. Questo infatti era andato praticamente in
bancarotta dal momento che, con l’ordinanza del 26 marzo con cui metteva a
carico dei cittadini ogni sussistenza dell’esercito piemontese, svuotando in tal
modo le proprie casse poiché ebbe a rimborsare ciò che gli altri avevano
speso. Si ridusse in tal modo il Governo Provvisorio ad elemosinare presso i
sudditi, senza tra l’altro essere in grado di risollevarsi dalle proprie difficoltà.
Altra angheria che fece il governo, oltre che sottomettere costantemente la
Lombardia al Piemonte, fu quella di ricreare la polizia plasmandola sullo
stampo di quella austriaca, che in realtà vessava non solo gli uomini liberi ma
reprimeva anche tentativi dell’opposizione di rendere nota la verità. La
situazione che si era dunque venuta a creare era molto difficile: da una parte i
nemici stavano tornando furtivamente nei luoghi da loro abbandonati mentre
la guerra era nelle mani del re Carlo Alberto che non si decideva a far nulla
prima che tutta l’Italia e soprattutto la Lombardia non si fosse piegata al suo
volere. Il 12 Maggio venne alla fine posto dal Governo Provvisorio una sorta
di “aut aut” in cui si chiedeva al popolo o una totale astensione dalla politica o
un’assoluta sottomissione a Carlo Alberto. Quest’ultima scelta era fortemente
voluta da tutti coloro che sostenevano il re sabaudo e con ogni mezzo
spingevano gli indecisi a fare lo stesso passo. In quel giorno venne stipulato
un patto di sudditanza che sarà poi visto come la rovina dei patrioti.
Nel capitolo seguente, il nono, Cattaneo descrive la situazione che si era
venuta a creare tra le file dei nemici, dal momento che il titolo è “Gli
oppositori”. In realtà è solo un’ulteriore e ancora più drammatica ricostruzione
dei fatti che in quel momento scuotevano l’Italia: l’ingordigia di potere del re
Carlo Alberto, i contrasti tra coloro che sostenevano ancora il dominio
austriaco e la sciocca fiducia che il popolo italiano riponeva nei traditori.
Il decimo capitolo intitolato “L’esercito del Re”è riservato appunto all‟esercito
o, per meglio dire, alla totale mancanza di un cospicuo numero di soldati che
potesse essere definito un vero esercito. Carlo Alberto infatti aveva rifiutato
qualsiasi aiuto non solo da parte di nazioni quali Francia, Polonia e Svizzera
che avevano un odio comune per l’Austria, ma anche da parte di tutti quegli
italiani volontari o che, nel corso delle cinque giornate, si erano distinti per
particolari capacità. Le forze armate erano dunque state ridotte dai 25 mila
che si poteva credere all’inizio a 5 mila unità, prese solamente dal Piemonte.
Bisogna inoltre dire che alle operazioni belliche partecipò lo stesso Carlo
Alberto il quale però, come i suoi generali, non aveva esperienza alcuna nel
campo strategico e, di conseguenza, con le sue incapacità militari causava il
progressivo indebolimento dell’Italia a favore dell’Austria che, dopo essersi
ripresa dalla sconfitta del 22 marzo 1848, stava lentamente riprendendo forza
e terreno. Inoltre, la mancanza di cibo, di organizzazione sanitaria e
disciplinare tra i sudditi contribuivano a far precipitare lo Stato
inesorabilmente ed inconsapevolmente verso la rovina a cui contribuiva
l’ottuso orgoglio ostentato da un re troppo sicuro delle sue risorse e capacità.
Nel capitolo undici intitolato “La Guerra” Cattaneo racconta minuziosamente
tutte le fasi della guerra: dall’inizio, in cui tutti erano fiduciosi di poter
sbaragliare il generale Radetzky che in quel momento volgeva in fuga, fino
alla terribile e rovinosa conclusione per l’Italia che, dal nord sino agli
Appennini di Toscana, era ritornata in mano al nemico austriaco. Questa
disastrosa fine, come lo scrittore milanese ha più volte sottolineato, è stata
causata dall’inesperienza e dalla dappocaggine non solo del re Carlo Alberto
ma anche di tutti i generali del suo esercito.
“……….si fa sempre più manifesto il vero di ciò che primamente dissi: non
esservi stato in quella guerra pensiero militare; avervi dominato il solo
pensiero politico, di tenere occupata la Lombardia, finché l’Austria fallita
segnasse una nuova pace di Campoformio, e i popoli scorati e stanchi vi si
rassegnassero”. (C. Cattaneo ”L’insurrezione di Milano nel 1848”, ed
Feltrinelli,1973, p. 166).
“….. E perciò i giuramenti o non si devono fare, o si devono fare alla patria e
alla legge; non alle persone dei principi”. (C. Cattaneo, op. cit., p.191).
(Valeria Del Tedesco)
5. LA REPUBBLICA ROMANA DEL 1848-1849
Stefano Tommasini, autore del libro “Storia avventurosa della Rivoluzione
romana” racconta come a Roma e in tutto lo Stato della Chiesa, Pio IX, dopo
l’ondata di simpatia che avevano suscitato le sue presunte convinzioni liberali
e filo-unitarie, aveva cominciato a risentire di una crescente opposizione
politica, dovuta all'allocuzione del 29 aprile (il pontefice aveva infatti deciso di
ritirare le truppe regolari comandate dal generale Giovanni Durando ed
inviate contro l'Austria nella prima guerra di indipendenza nel 1848) ed alle
sue conseguenze. Già nei giorni successivi, a Roma la Guardia Civica aveva
occupato Castel Sant'Angelo e le porte della città e, oltre a ciò, ci furono le
dimissioni di ben sette ministri. Il 3 maggio Pio IX compiva un estremo
tentativo di raddrizzare la situazione: affidando l'incarico per un nuovo
governo al conte Terenzio Mamiani (uomo politico, filosofo e scrittore italiano
dell'epoca il quale però darà a sua volta le dimissioni per dissenso rispetto
alla linea strettamente neutralista del pontefice) e scrivendo una lettera
privata a Ferdinando I nella quale lo si invitava a rinunciare al LombardoVeneto, Regno di profonda fede cattolica. Tuttavia l'imperatore non
risponderà nemmeno a tale richiesta del pontefice.
Pio IX tentò allora l'ultima carta affidando l'incarico del governo al conte
Pellegrino Rossi, già ambasciatore di Luigi Filippo di Francia. Rossi si mostrò
attento alle istanze patriottiche, decretando sussidi e pensioni ai feriti e alle
vedove di guerra e chiamò a dirigere il dicastero della Guerra il generale
Zucchi, già generale di Eugenio di Beauharnais e patriota risorgimentale. Il 15
novembre riaprì il Parlamento e Pellegrino Rossi venne accoltellato da un
gruppo di cui faceva parte un figlio del capopopolo democratico Ciceruacchio.
In serata lo stesso Ciceruacchio inscenò sotto il Quirinale, una tumultuosa
manifestazione, per chiedere "un ministro democratico, la costituente italiana
e la guerra all'Austria".
La scena si ripeté un giorno più tardi, la sera di venerdì 17, quando la stessa
folla armata si ripresentò davanti al Quirinale, chiedendo l'allontanamento
degli Svizzeri. Successivamente i ministri presenti a Roma (Muzzarelli,
Galletti, Sterbini, Lunati) pubblicarono un programma di governo che si
diceva “ in perfetta armonia, non solo co' principi proclamati dal popolo, ma
con quelli che, dopo matura deliberazione, furono accettati dalle nostre
Camere Legislative”. Pio IX sarà costretto ad accettare non solo il principio
della nazionalità italiana, ma anche quello per la lotta dell'indipendenza e
della convocazione in Roma di una Costituente in vista della federazione.
La mattina di sabato 25 novembre l'abate Rosmini venne informato che il
papa, preoccupato dalla situazione insurrezionale, era partito la sera
precedente in incognito, vestito come un semplice sacerdote, avendo come
direzione Gaeta per riposarsi e poi riprendere il viaggio: l'obiettivo, infatti, era
quello di raggiungere le Baleari. Rosmini riteneva che la scelta di lasciare le
Stato Romano fosse troppo incauta e anch'egli partì per raggiungere il
pontefice. Giunto alla fortezza napoletana di Gaeta, Pio IX consegnò all'abate
una lettera, nella quale il pontefice nominava una Commissione Governativa
a cui affidava la direzione temporanea dei pubblici affari. L'intenzione era
quella di mostrare che il papa, pur essendosi allontanato da Roma, non
lasciava lo Stato senza governo. C'era poca chiarezza su cosa effettivamente
fosse questa Commissione e a cosa servisse. Il comportamento del papa
appariva agli occhi dei contemporanei come il modo più diretto per gettare
Roma e alla lunga tutto lo Stato nella più assoluta anarchia.
La sera di domenica 3 dicembre il Consiglio dei deputati si riunì e il
presidente dell'Assemblea, Francesco Sturbinetti, sostenne la nullità dell'atto
pontificio. Aggiunse anche che esso non era valido poiché emesso fuori del
territorio dello Stato e fatto forse sotto costrizione. Il dottor Pantaleoni, politico
italiano appartenente al gruppo dei moderati, presentò una proposta che
prevedeva il pieno mantenimento dei poteri del governo nominato dal papa il
16 novembre e l'invio di un delegazione a Gaeta per chiedere a Pio IX di
rientrare nello Stato e nella capitale. La maggior parte dei colleghi deputati
ritenne che Pantaleoni avesse ragione e il 6 dicembre fu inviata la
delegazione che venne però respinta ai confini napoletani da un ispettore di
polizia, che aveva ricevuto l'ordine di impedire a qualunque delegazione di
entrare nel Regno di Napoli. Il governo protestò vivacemente e, lunedì 11
dicembre, il Consiglio dei deputati deliberò la nomina di una Giunta di Stato
che facesse le veci del sovrano per il tempo in cui fosse stato assente.
“É costituita una Provvisoria e Suprema Giunta di Stato.
Che è composta di tre persone scelte fuori del Consiglio dei deputati,
nominata a maggioranza assoluta di schede dal Consiglio dei Deputati stessi,
e approvata dall'Alto Consiglio.
La Giunta a nome del principe ed a maggioranza dei suffragi eserciterà tutti
gli uffici pertinenti al Capo del Potere Esecutivo nei termini dello Statuto e
secondo le norme e i principi del diritto costituzionale.
La Giunta cesserà immediatamente le sue funzioni al ritorno del Pontefice, o
qualora esso deputi con atto vestito della piena legalità, persona a tener le
sue veci, ed adempire gli uffici, e questa assuma di fatto l'esercizio di dette
funzioni”.
Si trattava di un colpo di Stato che, di fatto, poneva termine al potere
temporale del Papa. E, infatti, il 17 dicembre il Papa protestò vivacemente,
lamentando l'“usurpazione dei Sovrani poteri” . Il 20 dicembre la giunta emise
un proclama in cui prometteva la convocazione di una Costituente romana:
Art 1. È convocata in Roma un'Assemblea Nazionale, che con pieni poteri
rappresenti lo Stato Romano.
Art 2. L'oggetto della medesima è di prender tutte quelle deliberazioni che
giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare, compiuto e
stabile ordinamento alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze
di tutta, o della maggior parte, della popolazione.
Art 3. I Collegi Elettorali sono convocati il dì 21 gennaio prossimo per
eleggere i rappresentanti del popolo all'Assemblea Nazionale.
Art 4. L'elezione avrà per base la popolazione.
Art 7. Il suffragio sarà diretto, e universale.
Art 8. Sono elettori tutti i cittadini dello Stato di 21 anni compiti, che vi
risiedono da un anno, e non sono privati o sospesi dai loro diritti civici per una
disposizione giudiziaria.
Art 11. Lo scrutinio sarà secreto. Niuno potrà essere nominato
Rappresentante del popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragi.
Il pontefice, poco dopo la pubblicazione di tale decreto, scrive un documento
all'interno del quale vi sono due scomuniche: quella contro chi ha convocato
l'Assemblea Costituente e in qualsiasi altro modo ha attentato al potere
temporale della Chiesa e quella, solo minacciata, a chi volesse dare seguito
alla elezione dell'Assemblea e poi allo svolgimento della sua azione. Con la
minaccia della scomunica su chi si fosse prestato all'usurpazione del potere
pontificio partecipando all'elezione della Costituente, il destino di Roma non
era più affidato al voto, né a una sempre più remota composizione tra le parti
in conflitto, ma era già quasi tutto nelle mani dei governi europei chiamati dal
Papa a restaurare il potere temporale della Chiesa.
Gli Stati europei che maggiormente si mostrarono sensibili al richiamo papale
furono la Francia e la Spagna. Il generale francese Cavaignac inviò
tremilacinquecento soldati francesi affinché “assicurassero la persona del
Santo Padre, la sua libertà, e il rispetto che gli si deve”, e per cercare di
convincerlo a trasferirsi a Marsiglia o in qualsiasi altro luogo della Francia.
L'iniziativa, poi abortita, di Cavaignac era dettata soprattutto da ragioni di
politica interna: le elezioni presidenziali. Aveva puntato tutto sull'impresa di
salvare il papa per contrastare l'ascesa di Luigi Napoleone Bonaparte. Ad
avere la meglio, però, fu proprio quest'ultimo e la questione passò nelle sue
mani. Il duca d' Harcourt, uomo politico e diplomatico, decise di non
appoggiare la richiesta di offrire al pontefice un appoggio non solo morale,
ma anche militare e pecuniario, in quanto la Francia avrebbe rischiato di
impegnare troppe forze per ottenere un risultato incerto e rischioso.
Ad essere più solidale con Pio IX era Madrid, che il 21 dicembre aveva
inviato una lettera circolare ai propri rappresentanti a Parigi, Vienna, Lisbona,
Monaco, Napoli, Torino e Firenze. Le nazioni cattoliche venivano sollecitate a
occuparsi di comune accordo della questione di ”assicurare in maniera stabile
e permanente la Suprema Autorità del Pontefice.” Per questo veniva proposta
la convocazione di una conferenza internazionale da tenersi in Spagna. Le
risposte non furono entusiastiche: il governo napoletano replicò che sarebbe
stato preferibile che la conferenza si tenesse a Napoli, luogo più vicino al
papa, e che fosse allargata a Inghilterra, Prussia e Russia. La Francia invece
osservò che la vicenda dello Stato Pontificio poteva essere discussa nella
conferenza già prevista a Bruxelles sulla situazione italiana. Era però ormai
chiaro che l'intervento militare ci sarebbe stato e lunedì 5 febbraio si riuniva a
Roma la nuova Assemblea Costituente.
Nonostante la scomunica, il 21 e 22 gennaio andarono a votare circa
duecentocinquantamila elettori. Il 5 febbraio 1849 si aprirono il lavori della
Costituente: Garibaldi stesso affermò che l'Assemblea non sarebbe stata
sospesa fino a quando non fosse riuscita a soddisfare le aspettative del
popolo. Anche il deputato Bonaparte interviene a sostenere questa tesi: “se
mi è lecito interpretare le parole del generale Garibaldi, egli propone che,
previa la immediata e facile verifica dei poteri, prima di occuparci della
nomina del presidente e dei segretari, ci occupiamo di quella Costituzione
che incombe a noi di redigere; prima che si organizzi lo Stato, si riconosca da
tutti fin da questo momento che la forma di Governo che compete a questo
Stato è la forma repubblicana; che noi non usciamo da questa sala, questa
sera o domani mattina, prima che la Repubblica in genere non sia da noi
decretata”. Intervenne anche il deputato di Roma e ministro Sterbini.
“L'Assemblea nazionale romana oggi diventerà un tribunale innanzi al quale
deve formarsi un giudizio reclamato da tanti secoli; e questo giudizio non si
pronunzia con una parola, non si pronunzia nell'impeto di una passione, ma
dopo maturo esame, ma dopo lunghe discussioni, dopo aver udito il pro e il
contra, perché l'Europa intera dica: i romani sono oggi quale era l'antico
Senato in cui si discutevano i destini della Patria, non per impeto di passione,
ma per maturità di senno”.
Giovedì 8 febbraio i rappresentanti del popolo tornano a riunirsi per discutere
della “sostanza”, le scelte sull'ordinamento. La maggior parte dei presenti era
pienamente d'accordo con il deputato di Bologna Savini, nel dichiarare la
decadenza di diritto della sovranità temporale dei pontefici. Non tutti
credevano però che “l'Italia fosse un ideale capace di muovere le moltitudini e
neppure credeva che quelle moltitudini trovassero altro interesse nella libertà
che il beneficio, già acquisito, della liberazione dalla servitù”. Infatti, altri
deputati come Terenzio Mamiani, erano ancora schierati “a difesa del papa”
ed erano unicamente disposti ad affidare al Piemonte e al suo esercito le sorti
militari e politiche di tutta la nazione. Non vi era quindi un consenso unanime
circa la netta scissione tra la Chiesa e lo Stato, perché il timore di questo
numero ristretto deputati frenava la svolta verso una nuova fase politica.
La prima proposta di decreto fondamentale era molto dura nei confronti del
Papato ed era così concepita: Art 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto
dal Governo temporale dello Stato Romano.
Art 2. Saranno date al Sommo Pontefice, anche di concerto colle altre
potenze cattoliche, tutte le
più convenevoli, sicure e stabili guarentigie pel pieno, libero e indipendente
esercizio della sua potestà spirituale.
Art 3. La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e
prenderà il glorioso nome di Romana Repubblica.
Art 4. Gli sforzi della Romana Repubblica saranno in modo tutto speciale
diretti al miglioramento morale e materiale della condizione di tutte le classi
della società. Art 5. Le relazioni della Repubblica Romana cogli altri membri
della grande famiglia Italica saranno sovranamente determinate
dall'Assemblea Costituente Italiana.
Gli articoli vennero discussi con particolare attenzione, specialmente riguardo
alle relazioni della neo repubblica con gli altri Stati italiani. Infine si preferì
enfatizzare il concetto di nazionalità non menzionando quindi la Costituente,
poiché vi erano ancora molti dubbi se questa potesse davvero riunirsi, e
pesava anche l'esigenza di non separare i destini della Repubblica Romana
da quelli della nazione italiana. A seguito dell'intervento di Garibaldi che
ricordava l'importanza degli altri Stati italiani nella realizzazione della libertà
italiana e della causa italiana, il decreto nel suo complesso fu così votato:
Art 1. Il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello
Stato romano.
Art 2. Il Pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per la
indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale.
Art 3. La forma del Governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e
prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana.
Art 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la
nazionalità comune.
Un punto che non fu invece dibattuto sono le due parole che compaiono nel
terzo articolo, “democrazia pura” . “Democrazia è governo del popolo, è la
forma di Stato che prevede la sovranità popolare, che si esercita
normalmente attraverso un Parlamento che è appunto l'insieme dei
rappresentanti del popolo: esattamente il caso della Repubblica Romana”.
L'attributo “puro” vuole sottolineare come il popolo è il principio “nel quale
deve poggiare tutto l'edificio politico”(Mazzini): senza il popolo non c'è
fondamento della politica, non c'è politica. Il primato non è come nel
liberalismo, dell'individuo, bensì nel popolo. La definizione “democrazia pura”,
osserva Tommasini, contiene in sé qualche rischio di condotta illiberale. Non
si può infatti ignorare, sostiene l'autore, che “l'intensità” di pensiero di
Mazzini, con il suo carattere totalizzante conteneva qualche seme che
incontrollato, era capace di generare totalitarismo. La difficoltà sta nel riuscire
a gestire un così alto concetto del popolo e della sua sovranità senza che
questa si mutasse in tirannide. “Con quelle due parole “democrazia pura” i
costituenti romani avevano fatto, consapevoli o no, la scelta più ambiziosa, la
più difficile, sotto diversi aspetti la più rischiosa”.
L'Assemblea il 21 febbraio si occupò della Chiesa in modo concreto,
decretando l'incameramento dei beni ecclesiastici. Per far fronte alla
situazione delle finanze statali decretò un prestito forzoso, necessario a
sopperire ai bisogni della guerra e tutelare l'indipendenza. La Chiesa non
rimase in silenzio di fronte alla presa di posizione nei suoi confronti e scrisse
all'Assemblea che dichiarava la nullità del decreto e faceva appello alle
potenze amiche per il mantenimento del “sacro diritto del temporale dominio
della Santa Sede”. Tale dichiarazione non turbò affatto l'Assemblea, che
invece approvò un altro decreto, secondo il quale tutte le campane venivano
requisite per fare cannoni e che si provvedeva all'equipaggiamento ed
armamento delle truppe. L'esempio più evidente dei difficili rapporti fra il
nuovo potere statale e il potere religioso sta nell'abolizione del tribunale del
Sant'Uffizio, che in seguito venne anche aperto al pubblico affinché fossero
chiaramente rappresentate le malefatte del governo papale. Si voleva così
“condannare il Papato per tutta l'opera svolta nella storia simbolicamente ma
anche molto materialmente nell'opera del Santo Uffizio, in cui lo spirituale e il
temporale si erano identificati con gli esiti più nefasti”. Dall'altro lato, però, vi
era la volontà da parte dei governanti romani a non rinunciare ai segni della
religione che potessero “illustrare nonostante le condanne pontificie, la
continuità della fede cattolica e forse anche un certo favore divino verso il
nuovo regime”.
Il 5 marzo Mazzini arrivò a Roma da Firenze e fu molto ben accolto
dall'Assemblea. Egli tenne due discorsi e nel secondo riferì della situazione in
Toscana, in cui “la parte più energica, più attiva, più importante della
popolazione risultava a favore dell'unificazione con la Repubblica Romana”.
Questo però non avvenne e la sconfitta di Carlo Alberto presso Novara e la
vittoria dei Borboni sull'insurrezione siciliana costrinse l'Assemblea a
prepararsi ad una guerra per l'indipendenza e la salvezza della Repubblica,
istituendo il 29 marzo un triumvirato plenipotenziario composto da Saffi,
Armellini e Mazzini. La questione di un intervento francese in Italia era tornata
d'attualità non solo per la richiesta fatta dal Papa alle quattro potenze
cattoliche, Francia, Austria, Spagna e Napoli, ma anche perché, a seguito
della sconfitta di Carlo Alberto, Parigi temeva che l'Austria potesse diventare
la “potenza assoluta della penisola”. L'intervento francese in Italia era
contraddittorio anche dal punto di vista della stessa Costituzione francese, il
cui articolo quarto diceva che la Francia non avrebbe mai usato le proprie
armi contro la libertà dei popoli. Il 25 aprile il corpo di spedizione francese
comandato dal generale Oudinot sbarcò a Civitavecchia.
Egli spiegò alla delegazione del governo romano che gli eventi europei si
erano accelerati così improvvisamente che la Francia aveva preferito
intervenire in modo immediato; inoltre, non avendo intenzione di riconoscere
il nuovo governo romano, contrario al potere temporale del Papa, qualsiasi
annuncio della spedizione avrebbe implicato una qualche forma di
riconoscimento della Repubblica Romana. Il generale voleva in tal modo
spiegare come la Francia si andava ad immischiare negli affari di un altro
Paese senza essere stata chiamata. In definitiva le offerte di Oudinot erano
inaccettabili e come tali vennero respinte. Roma era difesa da circa 10000
soldati e le sue truppe erano suddivise in quattro brigate comandate da
Garibaldi, la cui legione italiana era giunta a Roma il 27 aprile e dai colonnelli
Luigi Masi, Savini e Galletti. Il contingente di Oudinot che attaccò il 30 aprile
venne preso a cannonate e fucilate e respinto.
Nei combattimenti, durati sino a sera, si distinse principalmente Garibaldi il
quale, intervenuto quando i Francesi stavano già per desistere, con un
attacco alla baionetta sorprese alle spalle gli assedianti che si ripararono a
Civitavecchia. Al termine della giornata, la Repubblica aveva ottenuto un
trionfo: aveva mostrato l'attaccamento della popolazione e dell'esercito,
aveva fermato l'invasione volta al restauro del governo assolutistico del
potere temporale. Informato degli eventi, Luigi Napoleone, presidente della
Repubblica Francese, non mostrò alcuna esitazione e inviò il barone di
Lesseps, ambasciatore plenipotenziario, con l'ordine di pattuire una tregua
d'armi. Napoleone, oltre che dalle necessità elettorali, era spinto anche dal
voler reprimere la concorrenza delle altre potenze desiderose di esercitare la
loro influenza sulla penisola italiana. Lesseps pattuì una tregua d'armi e con
Mazzini prese a negoziare un accordo duraturo, negoziando un trattato con
cui la Francia si impegnava nella difesa del Lazio dalle truppe austriache,
spagnole, napoletane e alla non-ingerenza negli affari interni della
Repubblica Romana. Ma Luigi Napoleone, ben deciso ad ottenere il massimo
risultato elettorale, ordinò ad Oudinot di procedere con l'assedio della città, e
a Lesseps di dare le dimissioni. Oudinot mise insieme 30,000 uomini e il 4
giugno riprese le ostilità. Il 30 giugno sul Gianicolo si combatté l'ultima
battaglia della storia della Repubblica Romana e il 1 luglio, giorno di tregua,
Garibaldi confermò che era impossibile continuare a resistere.
Il 3 luglio 1849, giorno in cui di fatto la Repubblica finiva, l’Assemblea
promulgava dal Campidoglio la sua Costituzione. I costituenti erano consci
che nessuno se ne sarebbe potuto servire ma, come disse il relatore Aurelio
Saliceti, “la Costituzione repubblicana [...] sarà eterna come legge di Dio”.
Quanto all’elezione dei “consoli” era stata scelta l’indiretta. “La vera
democrazia non posa sul principio che tutti siano chiamati ad esercitare gli
stessi diritti, il popolo non può direttamente esercitare il diritto di nominare i
consoli, perché il più delle volte sarebbe incapace di fare una buona scelta”.
Dalla Costituzione venne inoltre esclusa la possibilità di una dittatura per
governare situazioni di emergenza. Saliceti a tal riguardo disse che “violar la
costituzione per salvarla è come uccidere per salvar la vita”.
La Repubblica Romana fu il concreto tentativo di dare ad una parte all’Italia di
allora un governo di tipo democratico che, sostenuto dalla volontà di tutti i
cittadini, riuscisse a separarsi dall’opprimente controllo della Chiesa,
difendesse la propria terra dallo straniero, dando così voce al popolo. Questa
breve esperienza di repubblica rappresentò comunque, per Tommasini, “la
possibilità che gli italiani si governassero come popolo, l’invenzione ufficiale
di una democrazia italiana, che ancora avrebbe faticato moltissimo ad
affermarsi, ma pure veniva affermata in principio e codificata per legge”.
(Anna Benedetto e
Andrea Magliocchi)
6. IL DECENNIO DI PREPARAZIONE
Nel sesto volume de “Il Risorgimento” dedicato al “decennio di preparazione”
Lucio Villari, espone molte questioni riguardanti il processo dell'unificazione
italiana.
Villari mette in chiara luce personaggi che hanno operato in modo costante
e tenace per arrivare alla tanto desiderata meta, raggiunta solamente nel 17
marzo del 1861.
Nell'esordio lo scrittore fa una panoramica dell'Europa della seconda metà
del'800 soffermandosi, ovviamente, sulla questione italiana.
L'Italia si trova in un periodo di grande incertezza e disorientamento politico,
c'è infatti una grande difficoltà da parte delle principali figure politiche di
capirsi, non c'è un terreno comune che faccia da intermediario tra tutte le
diverse idee e opinioni politiche. Il nostro Paese si trova dunque in un difficile
momento riguardante oltre alla sfera politica quella sociale, ma soprattutto
quella economica.
Dal 1850 però si avviava per l'Europa un nuovo periodo, quello dell'ascesa
della borghesia e dello sviluppo economico internazionale. L'ideologia del
progresso, largamente diffusasi in Europa e negli Stati Uniti, stava anche per
arrivare in Italia.
Il culmine di questo progresso giunse con l'Esposizione Universale di Londra
nel 1851, tenutasi ad Hyde Park alla presenza della regina Vittoria e del
principe Alberto. Fu uno di quegli eventi destinati a cambiare la storia.
In un enorme edificio di ferro e vetro avvenne la più grande esposizione di
prodotti industriali provenienti da ogni parte del mondo. In quel giorno venne
ufficialmente riconosciuta l'egemonia
britannica , in campo economico,sulle altre nazioni, e inoltre venne celebrato
il progresso borghese i risultati ottenuti attraverso lla rivoluzione industriale.
Questo grande evento richiamò l'attenzione da parte delle forze economiche
europee. Si trattò del vero e proprio trionfo del capitalismo e del libero
scambio che faceva da contrasto al fallimento delle insurrezioni nazionali e
delle rivoluzioni sociali avvenute tra il 1848 e il 1849. Le profezie di Marx di
un imminente abbattimento del capitalismo si rivelarono illusorie.
All'Italia non rimaneva dunque che stare ad ammirare e a prendere esempio
dalla nuova potenza inglese.
Il primo esponente politico italiano che si accorse del grande messaggio
politico che stava dietro al grande evento economico come l’Esposizione
Universale fu proprio Cavour. Egli in un articolo scrisse che l'Esposizione era
stata il più bel congresso di pace, e che aveva fornito molte indicazioni sul
come muoversi verso la risoluzione dei principali problemi politici del
momento. Cavour inoltre spiegava che cos'erano i rapporti di produzione del
capitalismo e quanto rispetto ad essi fossero fittizie e antinazionali le politiche
di molti governi conservatori. Ma seguendo questo suo ragionamento era
impossibile non chiedersi come questi ambiziosi traguardi ottenuti
dall'Esposizione avrebbero potuto produrre il rovesciamento o la riforma dei
sistemi politici o sociali esistenti richiesti dai movimenti democratici e
patriottici. Anche perché la maggior parte dei sistemi di governo esistenti in
Italia, essendo privi di vere e proprie forme costituzionali, poggiavano su
illegalità ed ingiustizie, sulla brutale repressione di movimenti nazionali e su
forme di impostura religiosa. Secondo Cavour quindi i moti rivoluzionari
scoppiati ovunque in tutta Italia non potevano essere ignorati.
Villari prosegue quindi analizzando il pensiero di uno dei protagonisti del
Risorgimento, Carlo Cattaneo.
Secondo quest'ultimo una rivoluzione politica doveva impiegare strumenti
adeguati e soprattutto aprirsi alle possibilità offerte dalla modernizzazione.
Questa strada verso il Risorgimento era possibile grazie ad una giusta
miscela politica composta dai rigorosi e astratti percorsi mazziniani e
dall'ideologia moderata di Cavour. L'Italia dunque per ottenere ciò che voleva,
doveva contare, più che sulle armi, sulla crescita culturale ed economica
come era avvenuto nella progredita Lombardia, in cui le trasformazioni
economiche avevano preparato il cambiamento politico.
Cattaneo poi però si chiede come potrà mai avvenire questo tipo di
rivoluzione pacifica, attraverso l'evoluzione dell'economia e della tecnica, in
un Paese come il Regno delle due Sicilie, appena toccato dal processo di
modernizzazione. Qui,sotto il regno di Ferdinando II la libertà di stampa e di
opinione erano considerate superflue. I Borboni disprezzavano anche tutto
ciò che riguardava la scrittura, la cultura e l'ingegno,il loro interesse
riguardava solamente alcune attività industriali e poche innovazioni tecniche.
Il governo dei Borboni si sentiva infatti più vicino alla plebe e agli ignoranti,
secondo cui in un governo non erano necessarie le persone colte e dotte.
L’ unico sapere che poteva davvero essere utile era quello dei medici e degli
ingegneri. Si trattava di un'incontrollabile mediocrità che si era riversata ormai
in tutto il regno. Persino le forze armate erano viste in modo diffidente dal re
che temeva una classe militare più colta e cosciente di sé. Preferiva ufficiali
militari grossolani e bonari, purchè rimanessero sempre fedeli. Questa quindi
era la situazione presente nel Regno delle Due Sicilie.
Villari fa poi un quadro generale riguardante tutti coloro che avevano
combattuto per l'Indipendenza dell'Italia, ai quali toccava spesso affrontare
l'amara realtà dell'esilio. Tra gli scritti proposti emergono, sicuramente, quelli
di Gioberti, una tra le principali figure del Risorgimento. Egli affermava che
per arrivare all'unificazione degli stati italiani era necessario superare gli
egoismi regionali e i municipalismi. Secondo Gioberti la personalità giusta per
affrontare tutto ciò era quella di Cavour, il quale dopo aver fatto uscire il
Piemonte dalle ristrettezze municipalistiche, lo avvierà verso il ruolo di guida
liberale della nazione. Quattro furono dunque le iniziative che diedero slancio
alla politica italiana nel 1850 per il raggiungimento dell'unità. La prima fu
quella scaturita dal “ proclama di Moncalieri” testo scritto da D'Azeglio, con
cui il re, Vittorio Emanuele II, invitava il popolo a scegliere rappresentanti
consci della tragica ora dello Stato, dopo aver sciolto il Parlamento, per fare
in modo che i nuovi eletti accettassero le sue direttive. Il nuovo Parlamento
risultò composto per due terzi da moderati favorevoli al governo di Massimo
D'Azeglio.
La seconda iniziativa riprendeva il pensiero di Cavour, il quale sosteneva che
essere liberali significava essere primi nel riformare, sia in ambito legislativo,
sociale e scolastico. Questo era dunque l'unico modo per poter prevalere sui
rivoluzionari. Iniziò con il riformare i rapporti tra Stato e Chiesa, ma
soprattutto ridefinendo il ruolo di quest'ultima secondo una concezione laica e
liberale. Cavour dunque abolì i privilegi di cui i sacerdoti e la Chiesa
godevano rispetto alle leggi dello Stato. Grazie a questi valori Cavour riuscirà
a costruire una solida politica anche in campo economico, dopo essere
diventato ministro dell'Agricoltura. Egli dunque s'ispirava all'Inghilterra e alla
sua politica economica liberalistica, e cercava di realizzare riforme analoghe
nello Stato Piemontese.
La terza iniziativa era legata all'esperienza della Repubblica Romana che
aveva chiuso la sua vicenda emanando una Costituzione d'avanguardia
insieme a quella democrazia la cui attivazione per tutta l'Italia vedrà la luce
soltanto cento anni dopo.
Con queste esperienze democratiche lo stesso Piemonte dovette fare i conti
soprattutto per quanto riguardava il principio di separazione tra Stato e
Chiesa. Il liberalismo avviatosi in Piemonte non poteva quindi ignorare il
collegamento con alcuni principi affermatisi nell’ esperienza romana.
La quarta iniziativa infine fu l'impronta liberistica data da Cavour sia per
quanto riguardava l'economia interna, sia per le relazioni internazionali. Egli
faceva ciò per legare le sorti piemontesi all'economia europea, primo passo
di una strategia che mirava a porre in tutti i tavoli delle trattative internazionali
la “questione italiana”.
Cavour diventò dopo la sua elezione a ministro dell'Agricoltura una figura
sempre più importante. Egli potè giovarsi della sua competenza di
imprenditore agricolo oltre che di esperto conoscitore dei meccanismi
finanziari e bancari. Fu il primo ad utilizzare in campo agricolo i fertilizzanti
chimici guardando sempre ai possibili rapporti tra il mondo delle campagne,
l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e quella chimica della
produzione dei concimi. Allo sviluppo dell'industria però erano connesse delle
disponibilità finanziarie alle quali Cavour provvedette creando delle società di
imprenditori, finanziati dalle banche che erano in grado di anticipare i capitali
richiesti. Di pari passo a questi piani di sviluppo erano necessarie però delle
efficienti reti di comunicazione, che il conte di Cavour seppe realizzare
costruendo canali e linee ferroviarie.
Intanto però in un'altra parte d'Italia la situazione era sempre più difficile, si
trattava della zona Lombardo-Veneta ancora sotto il duro governo degli
Austriaci.
Se la precedente rivoluzione combattutasi a suon di barricate era fallita, ora
doveva essercene una silenziosa ed invisibile, questa era la nuova strategia
elaborata da Mazzini in esilio a Londra. Egli dunque pensò di creare dei
Comitati rivoluzionari a Milano, Venezia, Brescia e Mantova con eventuali
ramificazioni al centro e al sud. La funzione principale di questi nuovi gruppi
rivoluzionari era quella di far circolare le cartelle del prestito nazionale per
finanziare il movimento patriottico. Tutto ciò in breve tempo però venne
scoperto dal governo austriaco che,senza mezze misure iniziò la sua
repressione contro i colpevoli di questa cospirazione. Mazzini però non si
arrese e volle fare confluire il patriottismo nella protesta sociale di un
proletariato che aveva proprie ragioni,soprattutto economiche, per
partecipare ai moti per la libertà e l'indipendenza dallo straniero. Milano
dunque si ritrovava nuovamente in un tentativo insurrezionale da parte
questa volta di nuclei della classe operaia che, in un attacco armato il 6
febbraio del 1853 assalirono le caserme e i depositi armati austriaci. Anche
questo tentativo fallì, ma tutto ciò non modificava i piani di Mazzini il quale
pensava che i continui tentativi di insurrezione si sarebbero estesi a tutta la
popolazione generando una volontà collettiva a parteciparvi. In Lombardia
continuò dunque la politica di repressione da parte del governo austriaco
verso tutte le forme di rivolte e soprattutto per prevenirle. Mazzini sperava
che le altre potenze avrebbero visto nelle repressioni austriache così crudeli
un motivo di contestazione, di critica verso i metodi spietati messi in atto per
far tacere l'opinione pubblica.
Mentre la Lombardia e il Veneto continuano le loro rivolte,in Piemonte,
Cavour continuava con la sua politica di riforma. Egli mise in atto misure
contro gli abusi e lo strapotere della Chiesa. Il 1853 e il 1854 furono due
pessime annate sia per quanto riguardava l'agricoltura sia per la salute dei
cittadini, infatti ci furono numerosi casi di colera. Molti oppositori accusarono
Cavour di aver provocato con la sua politica un po' troppo antireligiosa,
queste disgrazie. Addirittura una folla tumultante si presentò sotto la
residenza di Cavour per protestare, ma nemmeno in questo momento il conte
ebbe la minima paura o esitazione e continuò la sua politica laicista. Nel
1855,infatti, egli presentò una riforma di legge che proponeva la
soppressione dei monasteri, delle comunità religiose e degli stabilimenti
ecclesiastici. Questo quindi provocò l'immediata risposta di Pio IX che
pubblicò un documento dove, oltre a condannare la libertà di stampa e
l'istruzione pubblica affermava che il re non avrebbe mai firmato una proposta
di legge simile. Vedendo che il re tentennava e non riusciva a prendere una
decisione, per evitare il peggio la Chiesa offrì un'enorme somma di denaro
allo Stato pur di far ritirare questa proposta di legge, Cavour offeso da questa
proposta, chiese il supporto del re che glielo negò. Il governo allora si dimise
e questa sarebbe stata la fine anche della scelta liberale del Piemonte e
dell'evoluzione del nostro Risorgimento, se non fosse intervenuto Massimo
D'Azeglio, il quale scrisse una nobile lettera al re chiedendo di ripensarci, di
ritornare indietro. Il re allora rispose positivamente al richiamo di D'Azeglio e
diede a Cavour l’incarico di costituire il nuovo governo. Questi realizzò il suo
programma di elevare il Piemonte al rango di Stato- guida nel processo di
unificazione nazionale in particolare grazie a un abile disegno di politica
estera. L'occasione per fare assumere al Piemonte un ruolo nei giochi
d'equilibrio che le grandi potenze compivano in Europa fu data proprio dalla
guerra in Crimea. Si trattò di un episodio che rimise in moto la competizione e
la conflittualità tra i grandi Stati che ambivano al predominio nell'Europa.
In questa cornice si inserì la diplomazia piemontese: Cavour, che non aveva
previsto la neutralità austriaca, si era adoperato per stringere accordi con
Francia e Inghilterra in vista di una comune azione contro Austria e Russia; e
si trovò costretto a prendere parte al conflitto con degli alleati che avevano
però l'interesse di garantire all'Austria che, se fosse intervenuta al loro fianco,
nulla sarebbe accaduto alle sue spalle, cioè in Italia. Tuttavia Cavour ritenne
che l'intervento piemontese, pur nella mutata situazione, fosse opportuno, ed
i fatti successivi gli diedero ragione. Così inviò un capo di spedizione, verso la
metà del 1855, in Crimea. L'obiettivo che Cavour si prefiggeva era la
partecipazione del Piemonte alle trattative di pace e la conseguente
possibilità di porre le situazione dell'Italia al centro degli accordi generali tra
le potenze europee. Ciò avvenne al Congresso di Parigi dove i rappresentanti
delle potenze europee si riunirono per le trattative di pace nel 1856. Il gioco di
Cavour era perfettamente riuscito: come rappresentante del piccolo Stato
piemontese egli sedeva, accanto a Francia, Inghilterra, Austria, Russia, e
poteva illustrare, in una seduta suppletiva chiesta ed ottenuta, le penose
condizioni di soggezione e vassallaggio in cui le popolazioni del LombardoVeneto e dell'Italia meridionale erano tenute dagli Asburgo e dai Borboni. La
questione italiana era posta come qualcosa di cui l'Europa progressista
doveva in qualche modo occuparsi. Oltre a ciò, con la partecipazione al
Congresso di Parigi, il Piemonte si guadagnò definitivamente, agli occhi del
movimento liberale italiano, il ruolo di protagonista della lotta contro l'Austria.
Dal punto di vista economico e sociale, nel decennio che precede la nascita
dello Stato italiano nelle altre nazioni si assiste ad un’accelerazione
dell’economia capitalistica. Gli Stati Uniti mostrano una forte fiducia nel
progresso tecnico e nel benessere che ne può derivare, in particolare un
notevole sviluppo delle ferrovie; dal 1852 era scoppiata la “febbre dell’oro” e
c’è un’altra scoperta, quella del petrolio, destinata a generare una nuova
“rivoluzione industriale”.
In Inghilterra gli investimenti esteri incrementano le esportazioni di capitali
che permettono un’espansione dell’economia ben al di là dei confini europei.
Un esempio si può vedere nelle costruzioni ferroviarie in India.
Anche in Italia, pur ancora frammentata politicamente, ci si apre al liberoscambismo, che implica una rottura di tutte le forme economiche chiuse, il
superamento delle barriere doganali e,in prospettiva, delle frontiere politiche
e un ampliamento delle libertà rivendicate dai cittadini. Sul piano politico,
Villari sottolinea il fatto che la spinta verso l’unificazione italiana veniva anche
dalle esigenze poste dallo sviluppo economico, in primo luogo dalla necessità
di un “mercato nazionale”, abbastanza ampio da favorire la crescita della
produzione e dello scambio.
L’Austria, con l’arrivo al potere di Massimiliano d’Asburgo,viceré in Lombardia
con idee quasi liberali, allenta la pressione autoritaria e repressiva, anche
perché teme gli atteggiamenti provocatori da parte del Piemonte, che dal
canto suo vede un accrescimento delle attività industriali, ma allo stesso
tempo un aumento del debito pubblico.
Nell’agosto del 1857, a Torino, La Farina, Manin e Pallavicino Trivulzio
fondano la Società Nazionale, che si prefiggeva come programma l’unità
dell’Italia sotto la monarchia dei Savoia. Cavour diede il suo consenso alla
Società. Mazzini rimase estraneo alla Società con i suoi più convinti seguaci.
LA SPEDIZIONE DI SAPRI
Nel dicembre del 1856, Carlo Pisacane cominciò a pensare all’opportunità di
un’azione insurrezionale al Sud, teorizzando la rivoluzione come il risultato di
un’azione dal basso, capace di coinvolgere le masse popolari. Si era, quindi,
allontanato dalle idee mazziniane e aveva anche qualche dubbio sulla tecnica
della guerriglia garibaldina.
Pisacane, pur essendo venuto a sapere che Mazzini si stava impegnando per
raccogliere nuovi mezzi e forze per un colpo in Toscana, non evitò di
proporgli un’azione nel Mezzogiorno. Mazzini accettò la proposta con la
convinzione che la rivolta avrebbe avuto maggiori probabilità di successo se,
contemporaneamente, fossero insorte anche le città di Genova e Livorno.
Mazzini, quindi, cominciò a lavorare sul progetto collegandosi con esponenti
clandestini del suo movimento presenti nel Salernitano e nel Cilento.
Pisacane, però, era assalito da nuove perplessità. Per questo, sotto
pressione della propria compagna, Enrichetta Di Lorenzo, scrisse e consegnò
alla giornalista Jessie White il suo “Testamento politico”, un testo di dignità
ideologica, umanità e intelligente pessimismo. Nel testo, Pisacane dichiara
una fedeltà ai valori del socialismo, l’ineluttabilità della rivoluzione italiana e
afferma che è possibile una rivoluzione morale, un impulso che spinga ad un
movimento deciso e che lui stesso è disposto a sacrificare la propria vita per
il raggiungimento di tale scopo.
Il 25 giugno,quindi, Pisacane si imbarca da Genova sul piroscafo “Cagliari”
con ventiquattro patrioti, con i quali si impossessa della nave e di un carico di
armi. La rotta era diretta a Ponza, dove liberarono trecento detenuti, per lo
più politici. Il 28 sera, il “Cagliari” raggiunge Sapri.
Essendosi sparsa la voce che briganti,ergastolani erano sbarcati per rubare e
nuocere alla popolazione locale, tutti gli abitanti di Sapri si chiusero in casa
sbarrando porte e finestre. Pisacane decise,quindi, di puntare su Padula. Il
primo giorno, in uno scontro con guardie e soldati di stanza nel luogo, furono
massacrati quasi tutti i patrioti.
Visto il fallimento dei suoi progetti, Pisacane si suicidò con un colpo di pistola.
Si ricordano a questo punto i versi della Spigolatrice di Sapri,scritti da Luigi
Mercantini, “ eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti..”,una ballata
politica messa a sigillo di un patriottismo profondamente permeato di senso
morale. Fallivano, intanto, anche i moti di Genova e Livorno.
Per Pisacane e i suoi compagni, animati solamente da un puro ideale, ci fu
da parte di tutti i patrioti un sentimento di pena e una solidale partecipazione.
ACCORDI DI PLOMBIÉRES- LES BAINS E VENTI DI GUERRA
Cavour, attraverso degli accordi diplomatici, cercava di allacciare un’alleanza
con l’imperatore francese Napoleone III, necessaria per muovere guerra
all’Austria. Napoleone III, per accettare quest’alleanza, pone però alcune
condizioni. Chiede prima di tutto al governo piemontese di censurare la
stampa democratica e di promuovere leggi contro le organizzazioni che
facevano parte di movimenti democratici.
Il 14 gennaio del 1858, alcuni esuli mazziniani a Parigi guidati da Felice
Orsini, lanciarono bombe contro Napoleone III e sua moglie che rimasero
miracolosamente illesi. Orsini e i suoi compagni furono ghigliottinati in piazza
a Parigi il 13 marzo, ma prima di salire al patibolo Felice aveva inviato
un’accorata e nobile lettera a Napoleone III chiedendo il suo intervento a
favore dell’indipendenza italiana. La lettera suscitò una grande impressione,
tanto che ebbe luogo un incontro tra Cavour e Napoleone III. La nipote
diciannovenne di Cavour, Virginia Oldoini, fu gettata tra le braccia
dell’imperatore per piegarlo dolcemente alla causa italiana. Furono molti i fili
con cui lo statista piemontese tesseva la sua tela.
Napoleone III decide, quindi, di appoggiare lo Stato Sabaudo in una guerra
contro l’Austria, purché questa non perseguisse scopi rivoluzionari.
L’accordo siglato a Plombières prevedeva altre clausole: Napoleone III voleva
una ricomposizione dell’Italia in una Confederazione di tre Stati, sotto la
presidenza del Papa e il controllo francese; la cessione di Nizza e della
Savoia. Il matrimonio tra Napoleone Girolamo Bonaparte, cugino
dell’imperatore, e Maria Clotilde di Savoia, figlia primogenita del re, doveva
suggellare il fatto raggiunto.
SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA
Nel gennaio del 1859 Cavour si stava adoperando per provocare l‟Austria
alla guerra e stava quindi cercando un “casus belli”: accordi con Garibaldi,
esodo in Piemonte dei giovani lombardi, richiesta di prestiti straordinari al
Parlamento, preparativi insurrezionali nell’Italia centrale.
Napoleone III, di fronte a tanto attivismo, si mostrò esitante. Tanto che
l’Inghilterra offrì un congresso per la pacificazione degli Stati che Napoleone
III accettò. L’Austria, al contrario pose la condizione che non vi
partecipassero gli Stati Italiani. Inoltre il 23 aprile 1859 il governo di Vienna
inviò un ultimatum al Piemonte chiedendo il disarmo dei volontari. L’Austria
era caduta nella trappola di Cavour.
Il 29 aprile l’armata austriaca penetrò in territorio piemontese. Il 12 maggio i
francesi riuscirono a raggiungere i soldati italiani grazie anche ad un
impantanamento delle truppe austriache nelle risaie della Sesia provocate dai
contadini. La controffensiva prevedeva l’esercito franco-piemontese diviso in
due ali. Gli scontri tra l’esercito franco-piemontese e quello austriaco
avvennero tra il 20 e il 31 maggio a Buffalora, Palestro, Montebello. Gli
austriaci furono battuti in tutte e tre le occasioni e così gli alleati ebbero
l’opportunità di una facile avanzata verso Milano. Il 4 giugno il generale
francese Patrice de Mac-Mahon ebbe la meglio sugli avversari e quattro
giorni dopo Vittorio Emanuele II entrava a Milano. Ancora una volta i
Cacciatori delle Alpi di Garibaldi avevano contribuito alla vittoria assestando
duri colpi all’esercito austriaco negli scontri di Sesto Calende, San Fermo, e
Varese. Il nome di Garibaldi comincia a suscitare ammirazione in tutta la
popolazione dagli uomini,alle donne, anche ai ragazzi. Fu questo un
momento di forte sentimento patriottico che si rinnoverà con la spedizione dei
Mille e con la liberazione del Mezzogiorno nel 1860.
LA GUERRA E LA RIVOLUZIONE
Per merito della propaganda e dell’organizzazione della Società Nazionale,
l’Italia centrale stava per entrare in ebollizione. Tra aprile e la metà di giugno
fuggì da Firenze il granduca sostituito dal conte Boncompagni in
rappresentanza del re di Sardegna, fu poi la volta di Parma e del ducato di
Modena dove furono nominati commissari regi in nome di Vittorio Emanuele
II. La rivoluzione coinvolse, poi, lo Stato Pontificio e gli austriaci furono
cacciati da Bologna e Ferrara. Insorsero anche le Marche e l’Umbria: il 20
giugno la repressione voluta dal Papa provocò una strage di civili a Perugia.
Il 24 giugno, in due battaglie, si giunse alla resa dei conti. Si scontrarono, da
una parte, 80 mila francesi e 90 mila austriaci a Solferino, dall’altra, a San
Martino 31mila piemontesi e 29 mila austriaci. In entrambe le battaglie furono
sconfitti gli austriaci, che cominciarono la loro ritirata, ma fu grandissimo da
entrambe le parti il prezzo di vite umane, tanto che un testimone, lo svizzero
Henri Dunant promosse la Conferenza di Ginevra e la fondazione della Croce
Rossa.
VILLAFRANCA: CAMBIA LA SCENA
L’armistizio firmato a Villafranca da Napoleone III e Francesco Giuseppe
sanciva che la Lombardia,ad eccezione di Mantova e Peschiera, era ceduta
alla Francia che a sua volta l’avrebbe consegnata al Piemonte. La Toscana,
Parma, Modena e le Legazioni dovevano tornare ai legittimi sovrani, tutti gli
stati italiani avrebbero formato una Confederazione sotto la presidenza del
pontefice.
La popolazione italiana avvertì l’armistizio come un tradimento, ma per i
francesi non era possibile una soluzione diversa del conflitto. Inoltre
Napoleone III temeva la formazione di un grande Stato unitario ai confini con
la Francia e aveva capito che l’esercito austriaco non era da sottovalutare.
Vittorio Emanuele II si vide costretto ad accettare l’armistizio, mentre a
Cavour,vedendo fallire il suo progetto, non restò che dare le dimissioni.
Il nuovo governo La Marmora-Rattazzi fu costretto a richiamare i commissari
regi, ma i rappresentanti delle popolazioni dell’Italia centrale elessero dei
“dittatori” nominati per volontà popolare. Il 20 settembre 1859 Mazzini invitò
Vittorio Emanuele II ad assumere la guida di un movimento unitario e a
promuovere un accordo tra le forze politiche nazionali.
A questo punto l’Inghilterra decise di prendere una posizione nel caso italiano
richiamandosi al principio della sovranità popolare. Napoleone III si accostò,
quindi, nuovamente al Piemonte e iniziò la ricerca di una mediazione.
Il 20 gennaio 1860 Cavour fu richiamato al governo, essendo nota la sua
capacità di volgere le contraddizioni della politica verso obiettivi più costruttivi.
Si trattava di utilizzare diplomaticamente la rivoluzione popolare del centro
nord. Furono indetti dei plebisciti per lasciare alle popolazioni il diritto di
decidere.
Il voto diede un netto consenso all’annessione, confermata subito dopo dalle
elezioni politiche. I candidati liberali ispirati a Cavour ebbero un grande
successo, la Sinistra di Rattazzi conquistò qualche decina di seggi mentre
scomparve la Destra reazionaria. Intanto,secondo i trattati di Plombiéres,
Nizza e la Savoia venivano cedute alla Francia.
Era l’aprile del 1860.
LUCE A MEZZOGIORNO: LA SPEDIZIONE DEI MILLE
La rete cospirativa della Sicilia, decisa a riprendere l’ iniziativa
insurrezionale, si infittì grazie ai collegamenti con Mazzini e con i comitati
segreti di Messina,Catania e Palermo.
Francesco Crispi, un esule democratico, si incontrò a Firenze con Mazzini per
definire il piano di insurrezione. Anche Vittorio Emanuele II, informato del
clima, si mostrò favorevole, anche perché il movimento unitario otteneva
sempre più consensi in tutti gli strati dell’opinione pubblica siciliana.
Nella notte tra il 3 e 4 aprile a Palermo scoppiò l’insurrezione. Subito Crispi e
Nino Bixio invitarono Garibaldi,appena eletto deputato,a guidare una
spedizione in Sicilia. La sera del 5 maggio circa quaranta volontari,comandati
da Nino Bixio, si impadronirono di due piroscafi nel porto di Genova con i
quali si diressero alla scogliera di Quarto,dove si imbarcò Garibaldi con il
grosso dei volontari.
La mattina del 6 maggio la spedizione salpò per la Sicilia.
(Maria Agnese Arban
Alice Dalpiaz)
7.CRONISTORIA DELL'IMPRESA DEI MILLE
In un capitolo centrale del suo saggio "Bella e perduta, l'Italia del
Risorgimento", Lucio Villari fa una ricostruzione minuziosa della principale
impresa garibaldina, che qui riassumiamo.
Le ore tra il 5 e il 6 maggio 1860 sono state descritte da Garibaldi come "una
notte stellata, bella, solenne", durante la quale si conclusero pian piano i
preparativi della partenza da Genova.
I giorni precedenti erano stati carichi di tensioni, messaggi, ordinazioni di armi
che sarebbero servite per la spedizione.
Ci sono Nino Bixio, Crispi, La Masa, Carini, e i famigliari, gli amici, salutano
coloro che stanno per imbarcarsi.
Garibaldi sale sul piroscafo chiamato Piemonte, Bixio sul Lombardo, e tutti
partono alla volta della Sicilia.
Tra coloro che erano a bordo, c'erano quarantacinque siciliani, novecento
lombardi, veneti, liguri, toscani; professionisti e intellettuali, ma anche operai
ed artigiani.
La mattina del sette maggio le navi approdano a Talamone, dove esiste un
presidio militare; Garibaldi fa scorta di armi, polvere, piombo, viveri.
Tra i "Mille" c'è Callimaco Zambianchi, il quale avrebbe poi suscitato rivolte
nello Stato pontificio, per distogliere l'attenzione dalle navi garibaldine.
Degli informatori avevano però già reso nota la notizia; uno di questi era
Alessandro Amero d'Aste, il quale teneva Cavour al corrente riguardo a tutto
ciò che accadeva nell'isola siciliana.
Lì erano frequenti cortei spontanei con acclamazioni a Vittorio Emanuele II.
Persino durante la Messa, i Palermitani gridavano frasi in onore dell'Italia e di
Vittorio Emanuele II.
Il 7 maggio, Cavour telegrafa al capitano Amero d'Aste la notizia che
Garibaldi e i suoi "proseliti" sono partiti, ma che non doveva fare nulla per
ostacolarlo.
Questa era la tattica di Cavour per sorvegliare i suoi movimenti.
La presenza delle navi di Garibaldi nei vari porti d'Italia creano timore nelle
autorità e, ad esempio, l'ambasciatore del Regno delle Due Sicilie, scrive a
Cavour preoccupato riguardo a ciò che sta accadendo, e per chiedergli quali
provvedimenti avrebbe preso.
L'11 maggio le coste siciliane sono in vista per la "flotta" garibaldina;
Garibaldi decide di sbarcare a Marsala, e a mezzogiorno le due navi entrano
in porto. Le truppe borboniche hanno intanto lasciato la città, però tornano
indietro, mentre i garibaldini sbarcano sul molo.
Aprono il fuoco; in quell'istante però ci sono anche due piroscafi inglesi nel
porto, e sono apparse delle bandiere inglesi alle finestre. La presenza nelle
acque siciliane di navi inglesi proteggerà tutto il corso degli avvenimenti legati
alla spedizione.
Durante i venti giorni tra lo sbarco a Marsala e la liberazione di Palermo,
Garibaldi crea un esercito di 25.000 uomini(tra contadini, aristocratici, preti
liberali, monaci e monache), utilizzando la propria intelligenza tattica e abilità
diplomatica.
Garibaldi viene paragonato a Cristo perchè anch'egli porta giustizia e amore
tra le persone.
Dopo lo sbarco in Sicilia, cerca di far nascere negli abitanti l'impulso alla lotta
e di avere la loro legittimazione politica dell'impresa dei Mille.
La mattina del 12 riprende la marcia, con l'ordine di inoltrarsi all'interno
dell'isola puntando verso Palermo, rispettando sempre e comunque i civili ed
i loro beni.
Garibaldi giunge con i "picciotti" a Salemi il 13 maggio, accolto dalla
popolazione in festa: proclama di assumere la dittatura(intesa come
magistratura degli stati eccezionali) della Sicilia in nome dell'Italia e di Vittorio
Emanuele II, avendo così il permesso di esercitare i pieni poteri civili e militari
per oltre quattro mesi.
Il 15 maggio all'alba si riprende il cammino verso Calatafimi, dove sono
concentrati i borbonici guidati dal generale Francesco Landi, schierati sulla
collina detta Pianto dei Romani, opposta a quella che occupano i garibaldini.
Questi vengono immediatamente attaccati dai nemici; Garibaldi ordina il
contrattacco e riesce a farli allontanare, e a conquistare le terrazze mentre le
armi sparano in continuazione, e quando sono finite le munizioni, vengono
lanciate delle pietre.
I garibaldini vincono dopo sei ore di combattimento, il primo combattimento,
riportando trenta caduti e centocinquanta feriti.
Centinaia di insorti siciliani continuano ad unirsi alle "camicie rosse", man
mano che queste attraversano Alcamo, Partinico, Borsetto.
Il 21 maggio, a poca distanza da Monreale, le truppe borboniche scatenano
un attacco, avendo ottenuto 3.000 uomini guidati dal colonnello svizzero Luca
von Mechel.
Dello stesso numero di combattenti è aumentato anche l'esercito garibaldino.
Garibaldi a quel punto finge di ritirarsi all'interno dell'isola portando con se'
l'esercito nemico: giunto alle vicinanze di Corleone, ordina ai carriaggi e una
squadra di volontari di continuare per quella via, mentre egli torna sui propri
passi, si unisce ai siciliani di La Masa e piomba di sorpresa su Palermo a
Porta Termini il 27 maggio. La battaglia per la conquista dura tre giorni.
Il generale Ferdinando Lanza, comandante della piazza, invita Garibaldi, il 30
maggio, ad un incontro sulla nave inglese Hannibal, mediatore l'ammiraglio
Mundy, e si concorda la fine delle ostilità.
Il 2 giugno Garibaldi forma un governo con sei ministeri; il 6, Lanza accetta la
capitolazione, con l'impegno che entro il 19 l'intera guarnigione avrebbe
lasciato Palermo.
Da quel momento la stampa internazionale inizia a pubblicare corrispondenze
e cronache dalla Sicilia.
Il dittatore e i suoi collaboratori si sono insediati nel palazzo reale, e giungono
persone a chiedergli aiuto, portando anche dei doni per il loro eroe.
Garibaldi è visto come un uomo politico di originale statura, e le monache dei
conventi palermitani di clausura sono "santamente invaghite" di quest'uomo.
In Inghilterra ed in Francia l'opinione pubblica è ben disposta verso Garibaldi,
e questi Paesi vogliono inviargli soccorsi e denaro.
Cavour è abbastanza confuso riguardo questa evoluzione politica in Sicilia, e
si chiede che soluzione ci sarebbe potuta essere per questa vicenda che non
aveva precedenti.
Ad un certo punto invia in Sicilia Giuseppe La Farina perchè acceleri
l'annessione dell'isola al Piemonte, e convinca il dittatore a modificare il
proprio governo escludendo Crispi e le sue idee "socialiste".
Il 17 luglio La Farina viene prelevato da agenti della nuova polizia
palermitana ed espulso dalla Sicilia.
Numerosi aiuti continuano a giungere dall'Europa e da altre parti d'Italia.
Poichè giungono ingenti somme di denaro, viene organizzata l'Intendenza
garibaldina, una specie di ministero delle Finanze, la cui responsabilità è
affidata ad Ippolito Nievo.
Mazzini durante questo periodo cerca di fronteggiare e neutralizzare le
pressioni moderate del governo di Torino, e di raccogliere aiuti per Garibaldi.
A Napoli il re Francesco II ha accolto l'invito del Piemonte di concedere la
Costituzione, visto che la caduta di Palermo si è ripercossa anche lì. Negli
ambienti della corte tuttavia si parla di tradimento dei generali in Sicilia, e di
complotti interni.
Alla fine di giugno il re crea un governo costituzionale presieduto da Antonio
Spinelli con Liborio Romano come ministro dell'Interno.
Resta intanto da conquistare il resto della Sicilia, da Palermo a Messina,
dove si è concentrata la maggior parte dell'esercito borbonico, forte di 22.000
uomini. Lo scontro avviene nei pressi di Milazzo il 20 luglio.
Ci sono numerosi morti e feriti, circa ottocento, tra i garibaldini, e meno tra i
nemici, circa centocinquanta; i borbonici decidono di ripiegare su Messina e
rinchiudersi nella Cittadella. Garibaldi ritiene ormai libera la strada per lo
sbarco in Calabria, l'avanzata su Napoli e su Roma.
I contadini poveri che abitano nella Sicilia orientale si sono rivoltati
ferocemente contro i "baroni", perchè vedono in Garibaldi la figura tanto
attesa del Salvatore che può liberarli dalla "servitù" a cui sono sottoposti;
bisogna accelerare i tempi della liberazione politica del Mezzogiorno.
Su questa situazione agiscono due iniziative parallele ma divergenti l'una
dall'altra: la prima di Vittorio Emanuele II che il 27 luglio invita Garibaldi a
fermarsi. Questo "declina l'invito"(anni dopo si scoprì che il re aveva allegato
alla lettera un bigliettino col quale lo pregava di rispondere negativamente
alla sua offerta).
L'altra iniziativa è di Cavour, il quale vuole creare trambusto suscitando a
Napoli un movimento costituzionale e popolare per rovesciare il governo di
Francesco II, cosicché sarebbe stato possibile stabilire un governo liberale
napoletano che avrebbe potuto neutralizzare il programma unitario e
rivoluzionario di Garibaldi. Obbiettivo di Cavour è impedire manovre
democratiche e repubblicane e un inevitabile attacco allo Stato pontificio.
Varcare lo Stretto di Messina ed occupare la piazzaforte di Reggio è per
Garibaldi la seconda tappa della marcia verso Napoli; non è possibile
attaccare Reggio direttamente, poichè ben difesa.
Così Garibaldi e 3.000 camicie rosse scelgono il percorso più lungo: si
imbarcano sui vapori Torino e Franklin nella notte tra il 19 e 20 agosto dalla
rada di Giardini, sotto Taormina.
Puntano su Melito Porto Salvo, a sud di Reggio, dove sono attesi da comitati
e insorti liberali pronti all'azione.
Le navi borboniche si accorgono troppo tardi di ciò che è accaduto:
incendiano il Torino, ma lo sbarco in Calabria si rivela un autentico successo.
Gran parte della popolazione si mobilita per aiutare i garibaldini.
In Calabria stazionano più di 20.000 soldati borbonici, che pattugliano ogni
zona.
Nella notte tra il 20 e 21 agosto i volontari si mettono in cammino.
Quando "attaccano" Reggio, i cittadini collaborano con le camicie rosse, ed
appena questi penetrano nelle stradine, dal castello si comincia a fare fuoco.
Dopo quasi otto ore di scontri, il castello issa la bandiera bianca.
Il 24 agosto il dittatore nomina Antonino Plautino governatore di Reggio; egli
per prima cosa destituisce tutte le autorità e magistrati della città.
I generali borbonici iniziano la ritirata dopo aver firmato la resa in una casa di
campagna sopra Villa San Giovanni. Lasciate indietro le sue truppe, divenute
ora "Esercito meridionale", Garibaldi raggiunge Salerno, poi Cava dei Tirreni,
e da qui, con quattordici suoi aiutanti, ufficiali e collaboratori, il 7 settembre,
sale su un treno che lo porta a Napoli.
Francesco II e la regina Maria Sofia hanno lasciato il 6 settembre la capitale
via mare per Gaeta, sotto la protezione francese. A Gaeta il re vuole
preparare la controffensiva.
Il 7 settembre Cavour ottiene il benestare di Napoleone III, ma non quello di
Pio IX, per intervenire in difesa preventiva di un eventuale sconfinamento dei
garibaldini.
L'arrivo di Garibaldi viene intanto festeggiato dai napoletani.
L'esercito piemontese varca i confini dello Stato pontificio il 18 settembre, ed
occupa le Marche, l'Umbria, e costringe Ancona alla resa.
Viene promosso un plebiscito che sanziona l'annessione di queste regioni al
regno di Vittorio Emanuele II, il 29 settembre 1860.
L'1 e il 2 ottobre sanciscono la fine del regno napoletano.
L'esercito borbonico, con 50.000 uomini, si batte strenuamente e nella
località di Caiazzo costringe i garibaldini a ritirarsi, ma i 30.000 soldati
dell'Esercito meridionale hanno la meglio e la vittoria è completa e decisiva.
Garibaldi instaura a Napoli un nuovo governo e continua ad esercitare il
potere dittatoriale fino ad ottobre. In Sicilia ha lasciato come prodittatore
Agostino Depretis, il quale però è favorevole all'annessione dell'isola al
Piemonte, e poiché le sue idee sono d'accordo con quelle di Cavour, ma non
con quelle di Garibaldi, si dimette.
Il clima continua a surriscaldarsi.
Garibaldi non è contro l'annessione, però vuole prima portare a compimento
la liberazione di Roma dal potere temporale.
La Russia, l'Austria e la Prussia rompono le relazioni diplomatiche col
Piemonte, preoccupate per la piega troppo democratica degli avvenimenti.
Il 29 settembre Vittorio Emanuele II prende il comando delle truppe sarde ed
entra in Abruzzo puntando su Napoli.
Garibaldi chiede al re di mandare soldati a Napoli, così da far sembrare agli
occhi stranieri il suo governo meno pericoloso, visto che rappresenta una
rivoluzione in atto.
Cavour ha il timore che si ribalti tutto il delicato quadro europeo a favore della
"questione italiana" e che si creino le condizioni per un intervento straniero in
Italia.
Di qui l'urgenza di convocare comizi elettorali e procedere con i plebisciti.
Mazzini, Cattaneo, e Crispi, fanno un ultimo tentativo di abbinare i plebisciti
alla convocazione dell'Assemblea Costituente, ma falliscono.
Cavour vuole ormai costituzionalizzare la rivoluzione di Garibaldi e
legittimarne il successo con i plebisciti.
Essi alla fine si svolgono il 21 ottobre.
I sì sono 432.000, i no 667, in Sicilia; mentre nella parte continentale i sì sono
302.000 ed i no 10.312.
Il 26 ottobre Garibaldi e il re si incontrano nei pressi di Teano e Garibaldi lo
saluta "re d'Italia";
il 7 novembre il re ed il dittatore sfilano insieme a Napoli tra la folla festante.
L'avventura è finita; si imbarca col figlio e alcuni collaboratori dal molo di
Santa Lucia verso Caprera.
Il 7 gennaio 1861 il principe Eugenio di Savoia viene nominato luogotenente
del re per le province napoletane e sceglie come ministri Liborio Romano e
figure prestigiose del liberalismo meridionale.
Il 27 gennaio si svolgono le elezioni per il nuovo Parlamento italiano, la cui
sede resta a Torino.
Salgono i candidati liberali e moderati.
Cavour sta dando a questo Stato maggiore autorità culturale e dignità
istituzionale sottraendolo alle interferenze della Chiesa.
Rispetto a Cavour, Garibaldi ha un senso della nazione.
L'Italia è abitata da 26 milioni di persone e i suoi rappresentanti sono stati
eletti da 500.000 votanti.
Ottanta seggi sono andati ai candidati del Parito d'Azione, sostenuto da
Mazzini, tra cui Garibaldi, Bixio, De Sanctis, Bertani, Crispi.
Cavour invia a Giuseppe Verdi una lettera per invitarlo a far parte del
Parlamento italiano, e questo accetta l'invito. L'inaugurazione del nuovo
Parlamento viene fissata per il 18 febbraio e il giorno dopo vi è la prma
seduta della Camera dei deputati.
Il 17 marzo Vittorio Emanuele II viene proclamato re d'Italia.
Il nuovo Stato comprende gran parte del territorio nazionale; rimangono
ancora fuori il Veneto e lo Stato pontificio.
Cavour cerca in tutti i modi di far capire a quest'ultimo che la difesa del potere
temporale rappresenta la negazione di un'effettiva indipendenza e libertà
della Chiesa di fronte allo Stato. Bisogna che Roma diventi la capitale d'Italia;
solo così finirebbe il potere della Chiesa.
Egli vuole un'Italia laica ed unita.
Muore il 6 giugno. Si apre un decennio carico di enormi problemi da risolvere,
di questioni che esplodono, come l'unificazione da realizzare nelle istituzioni,
negli apparati ammanistrativi dello Stato, nelle strutture economiche, nel
senso di appartenenza degli italiani ad una patria comune.
(Veronica Maggi)
8. LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO
Nel suo recente saggio storico dedicato all’unità d’Italia e intitolato “La forza
del destino”lo storico Christopher Duggon dedica un capitolo ai problemi del
nuovo Stato, soprattutto legati alle differenze marcate in campo economico,
ma anche sociale e politico, tra le diverse aree del Paese.
Pontelandolfo, 14 agosto 1861
Come sosteneva Massimo d’Azeglio la cosa più difficile in Italia nel periodo
immediatamente successivo alla tanto desiderata unità era riunire “volontà e
cuori divisi”. Per spiegare il senso di queste parole prendo ad esempio quello
che accadde nel piccolo borgo di Pontelandolfo, non facile da raggiungere,
nelle vicinanze di Napoli: una sorta di enclave pontificia posta sotto il governo
dell’arcivescovo locale. La popolazione era costituita da contadini a parte una
ristretta cerchia di ricchi proprietari terrieri che ovviamente dominavano la vita
politica ed economica della comunità, facilmente distinguibili dal resto della
popolazione. La situazione non era facile per i normali braccianti ed era
ulteriormente peggiorata nel 1806 quando le terre comuni vennero recintate,
la pressione demografica gravava sulle risorse locali, mantenendo bassi i
salari. Dal momento che buona parte dei lavoratori della terra aveva un
lavoro solo per un ristretto periodo dell’anno o proprio non ne aveva uno e
non possedeva nemmeno un proprio podere e animali da cui ricavare cibo,
era molto diffusa la pratica del furto. Inoltre la mortalità aveva un tasso
particolarmente alto e le condizioni igieniche erano pessime, perciò ogni
minimo onere finanziario costituiva un grosso guaio. Tuttavia queste
privazioni materiali erano controbilanciate da un vigoroso patriottismo locale,
che avrebbe reso difficile per gli abitanti di Pontelandolfo sviluppare un
attaccamento parallelo a una più ampia entità geografica quale l’Italia. Tale
paesino aveva infatti una articolata percezione del suo passato, per lo più
raccontato oralmente in poemi epici e canzoni. Poiché la sua storia constava
di continue invasioni e distruzioni, quando nel 1860 arrivò l’esercito
garibaldino con a seguito i piemontesi, era naturale che prevalesse un senso
di scetticismo verso questi liberatori, e per il loro presentarsi come portatori di
prosperità, giustizia e libertà. Infatti nel rapporto con i nuovi venuti oltre le
differenze culturali, anche la lingua rappresentava un grosso ostacolo: il
dialetto locale era per i soldati spediti a presidiare la provincia di Benevento e
per i forestieri in generale incomprensibile. Per altro l’analfabetismo era molto
diffuso tra i poveri, sotto l’influenza esclusiva di preti e galantuomini del posto
o delle voci raccolte nei paesi limitrofi. La violenza e l’assassinio erano parte
integrante del tessuto di vita quotidiana e così i legami tra briganti e abitanti
del posto, il più delle volte voluti dai ricchi che se ne servivano per tenere a
bada la popolazione in cambio di cibo e protezione: tutto ciò era qualcosa di
incomprensibile per i piemontesi. Nemmeno la religione era fonte di un punto
di unità: nel meridione vigevano ancora culti pagani superstiziosi e pratiche
stregonesche, percepiti come sciocchi dagli uomini del nord Italia e dallo
stesso prete di Pontelandolfo, don De Gregorio, il quale tuttavia chiudeva un
occhio su tale questione.
In una sera di agosto del 1861, durante la festa cittadina di San Donato,
patrono del luogo, giunsero una quarantina di banditi, guidati da Cosimo
Giordano, un ex soldato borbonico, e furono accolti a braccia aperte, visto
che i rapporti con le autorità erano tesi a partire dalla fine del 1860, perché
“Italia” significava oltre alla coscrizione obbligatoria, anche tasse più elevate e
l’ira della Chiesa cattolica, per l’usurpazione infinita da parte dello Stato
italiano. A peggiorare le cose c'era stata inoltre la definitiva privatizzazione
delle terre un tempo comuni, visto che ormai i galantuomini locali erano
divenuti rappresentanti del governo di Torino, nonostante il fatto alcuni di loro
fossero stati in precedenza sostenitori dei Borbone. Ad ogni modo quella sera
gli abitanti di Pontelandolfo devastarono la sede della Guardia Nazionale e
tutto ciò che c’era di piemontese o del nuovo Regno Italiano. distrussero
anche i registri delle nascite, in modo da non rendere possibile la coscrizione
al nuovo Stato. Dei bersaglieri che furono inviati per sedare la rivolta, caddero
in un’imboscata e ne furono uccisi quarantuno, forse proprio ad opera di
fittavoli di Iacobelli, impegnato con molta probabilità in un subdolo doppio
gioco. Fu proprio costui infatti ad avvertire il comandante militare e
responsabile per l’Italia meridionale della rivolta, pregandolo affinché
giungesse a infliggere ai suoi barbarici compaesani un trattamento
esemplare; e così accadde. Vennero uccisi uomini, donne, anziani e bambini
indiscriminatamente. Le case furono prima saccheggiate da parte dei soldati
e poi bruciate. Nei mesi successivi coloro che erano riusciti a sfuggire al
massacro vennero catturati e in buona parte processati, ma non Giordano
che emigrò a Marsiglia.
Questo è solo un esempio della “guerra al brigantaggio”, fenomeno molto
diffuso nel Mezzogiorno: solo Giuseppe Ferrari ebbe il coraggio di riferire alle
Camere la crudeltà con cui i soldati massacravano le popolazioni accusate di
favorire i briganti, ma ciò veniva considerato antipatriottico e dannoso per il
fragile status della nuova Italia, in quanto appariva come l’ammissione di una
guerra civile. Ferrari fu zittito. I disordini dei primi anni post unitari erano
classificati sotto “criminalità in atto comune”: così fu estremamente difficile
distinguere atti di brigantaggio da vere e proprie rivolte di massa. Questa
situazione convinse molti settentrionali che ciò che avevano di fronte fosse
non tanto una popolazione politicamente arretrata, quanto un popolo a un
diverso stadio della civiltà: si ingigantirono in questo modo i preconcetti,
l’intolleranza, allargando l’abisso di incomprensione tra nord e sud. Dietro a
queste considerazioni stava una miscela di tornaconto e paura: tornaconto
perché così l’imposizione della Costituzione piemontese, delle loro leggi e del
loro sistema amministrativo appariva pienamente giustificata, in quanto
bisognava riportare al passo coi tempi le regioni arretrate del Meridione;
paura perché l’arretratezza e il brigantaggio, se non arginati con durezza,
rischiavano di diffondersi in tutta l’Italia, mettendone a rischio l’unità. Dunque
il sud veniva considerato come una malattia, una piaga, per la quale era
difficile trovare una cura: secondo i democratici e Cavour era necessario dare
a questa terra, sottomessa a secoli di governo oppressivo e straniero, un
governo libero e liberale; tuttavia si imposero scelte autoritarie nel governo
del Paese soprattutto a causa del senso di profonda insicurezza “che a
partire dal 1860 s’impadronì dei leader del paese e che fece sì che queste
idee apparissero utopistiche, tanto che c’erano elementi per ritenere che
l’agitazione nel Mezzogiorno fosse sobillata da agenti dei Borboni deposti e
dal clero”. Inoltre si temeva per una seconda “spedizione dei mille” verso
Roma. Per tali motivi a prevalere erano l’uso della forza e la repressione.
L’aspirazione all’unità e a un’unica patria da amare che prima aveva
mobilitato molti patrioti italiani ora era sopraffatta da un sentimento di rabbia e
delusione a causa appunto di questa difficile situazione, fonte di imbarazzo
per i governi dell’epoca. Nel 1862 fu varata un’inchiesta parlamentare per
studiare le ragioni del brigantaggio: ci si concentrò soprattutto sulle condizioni
socioeconomiche del Meridione, tralasciando in gran parte la questione del
diffuso rifiuto del nuovo assetto politico come motivo dei disordini. Ma la cosa
più grave fu che si fece di tutto affinché le risultanze dell’inchiesta
rimanessero segrete. Un altro problema era l’ostilità dell’esercito a qualunque
intrusione dell’autorità civile nella sua sfera, senza contare che non rendeva
conto del suo operato al Parlamento, col risultato che non si indagò mai sulle
dimensioni e sulla crudeltà di operazioni come quella di Pontelandolfo,
accadute perché i soldati si sentivano frustrati per essere considerati ostili e
guardavano alle popolazioni meridionali solo come una “razza di briganti”.
IL PIEMONTE CONTRO L’ITALIA
Una volta unificato il territorio italiano sotto quello che un tempo era lo Stato
piemontese, si doveva provvedere a realizzare una unità “morale”, ma ciò
non era facile, dal momento che i governanti del nuovo paese erano
soprattutto piemontesi. Di questo problema si faceva portatore Francesco De
Sanctis, di origine napoletana, figura dominatrice nella vita culturale italiana
degli anni Sessanta e Settanta. Circondato da rispetto e ammirazione, venne
nominato ministro dell’istruzione nel 1861. Il suo sogno era insegnare agli
italiani ad essere liberi: la libertà era una condizione morale acquistabile solo
tramite educazione paziente dell’intelletto e delle emozioni; implicava
l’apprendere il rispetto della legge, lo sviluppo di un senso dei doveri verso lo
Stato, il nutrire sentimenti di simpatia e considerazione verso tutti i
compatrioti, la partecipazione attiva alla vita politica della nazione. La vera
libertà era la spontanea identificazione con una collettività più ampia, quella
italiana, scrollata delle vecchie fedeltà municipali e regionali. Ma ciò non era
facile da realizzarsi, poiché questa convinzione presupponeva che la nazione
fosse una sintesi di tutte le parti che la componevano, mentre ciò che si stava
realizzando era l’imposizione delle leggi e dell’amministrazione di un singolo
Stato al resto del paese. Infatti a causa dei continui disordini quali il
fenomeno del brigantaggio o le rivolte dei contadini si dovette rinunciare
all’originario progetto della decentralizzazione, ossia la devoluzione dei poteri
dal centro alla periferia, e adottare il progetto inverso, cioè la centralizzazione
e il trapianto in tutta l’Italia delle leggi e delle istituzioni piemontesi, senza
considerare le potenzialità e le specificità delle altre regioni italiane. Tale
processo incominciò nel 1860 per poi velocizzarsi nel 1861, causando
problemi enormi, in quanto per esempio la Sicilia non era abituata alla
coscrizione militare obbligatoria e ciò creava senza dubbio malcontento;
inoltre molte botteghe, officine, fabbriche del sud sopravvivevano grazie a
dazi doganali, e ora che erano stati abbassati queste piccole imprese locali si
trovavano a dover affrontare un periodo di crisi, che il più delle volte portò alla
loro chiusura, aumentando così in divario già evidente tra nord e sud. Un’
ulteriore ragione di scontento era l’atteggiamento dello stesso re, il quale si
era rifiutato di cambiare il suo nome da Vittorio Emanuele II a Vittorio
Emanuele I, perché primo re del Regno italiano e non più re di un Regno di
Sardegna che aveva inglobato gran parte dei territori italiani. Ad irritare era
anche la formula con cui si dovevano firmare i documenti ufficiali: “ per grazia
di Dio e volontà della Nazione, re d’Italia”. Come si può notare la prima parte
contraddice seccamente la seconda, e mette in questione lo status giuridico
delle votazioni plebiscitarie. Il re per i primi decenni post unitari si rifiutò
anche di cambiare le sue abitudini di vita allo scopo di dedicarsi ai suoi doveri
politici e a viaggiare per il paese al fine di conoscere i nuovi sudditi e di farsi
conoscere da loro. Figura molto apprezzata invece era Garibaldi con il suo
esercito di volontari, a cui il governo di Torino però guardava come una
minaccia, forse per la sua popolarità, particolarmente elevata nei territori
meridionali, in cui gente lo considerava quasi una divinità, ma non
trascurabile neanche all’estero, come in Gran Bretagna, dove molti pamphlet
celebravano le sue imprese. Ma Vittorio Emanuele e Cavour non vollero
riconoscere a Garibaldi il contributo che aveva dato alla creazione dello stato
italiano con la sua spedizione in meridione: egli infatti aveva poi consegnato
al Piemonte i territori che era riuscito a conquistare. Questa intolleranza nei
confronti di tutti ciò che rappresentava una sorta di opposizione al sistema
governativo e amministrativo piemontese o una minaccia alla nuova unità
sotto le ali dello Stato dei Savoia si prolungò anche in campo militare: una
volta che il servizio di leva obbligatorio fu esteso a tutte le regioni italiane, gli
uomini che avevano servito sotto i comandanti borbonici o pontifici furono
trattati con profonda diffidenza e furono oggetti di “discriminazione”. Fatti
prigionieri a migliaia, vennero spediti in penitenziari dove molti di essi
morirono. Gli ufficiali invece venivano inglobati nel neonato esercito italiano,
tuttavia al solo scopo di togliere al popolo dei potenziali capi rivoluzionari;
anche essi erano però trattati in maniera molto severa. Una diffidenza ancora
maggiore colpì i volontari che avevano combattuto con Garibaldi.
Il PARLAMENTO
Il nuovo Regno d’Italia era una monarchia parlamentare e nel 1860 Cavour
indisse le elezioni e, come da lui atteso, ottenne una solida maggioranza,
questo anche perché il diritto di voto era esteso solo a chi pagava almeno
quaranta lire di imposte all’anno, aveva una laurea o una qualificazione
professionale e aveva più di 25 anni. Quindi circa 1 maschio su 10. Questi
provvedimenti erano stati presi affinché il paese fosse governato da uomini in
grado di farsi un giudizio informato e indipendente sulle questioni politiche.
Ma per la verità molti degli elettori tendevano ad appoggiare il governo di
quella che diventerà poi la Destra storica in attesa di vantaggi materiali. Ad
ogni modo Cavour era una figura politica molto abile e carismatica, ma
nonostante questo non mancavano le opposizioni ideologiche, dimostrate dal
fatto che nel 1861, di coloro aventi il diritto di voto, aveva votato solo il 57%.
Un altro problema per il Parlamento era che esso non occupava un posto di
spicco nel contesto della “nazione”: di fatto la lotta per l’unificazione e
l’indipendenza era stata concepita come liberazione del paese
dall’oppressione straniera, ma la libertà non doveva essere conquistata dal
Parlamento o per il Parlamento, bensì con sacrificio personale, cospirazione,
insurrezione. Inoltre questa istituzione tendeva a richiamare alla mente la
discordia, la debolezza e la divisione. Infatti i Comuni medioevali, governati
appunto da una sorta di forma parlamentare, sì avevano consentito un grado
eccezionale di democrazia, ma avevano favorito le lotte di fazione, le guerre
intestine. Ciò che i patrioti del Risorgimento invece desideravano era la
concordia e non confidavano nel fatto che ci fosse una leadership nel
parlamento in grado di garantirla. Paradossalmente anche la tradizione
letteraria e retorica italiana costituiva un grosso ostacolo per il Parlamento: la
predilezione per la retorica era sfociata in una scissione del pensiero
dall’azione, quindi spesso si preferiva fare uno di quei discorsi pomposi e
persuasivi anziché esporre la mera verità. L’ultimo intralcio era il fatto che
essendo il Parlamento un’istituzione di natura rappresentativa, esso non
poteva che rispecchiare un popolo, che però non mostrava di essere coeso.
Così la tendenza dei deputati parlamentari era piuttosto quella di
raggrupparsi secondo linee regionali e guardare al Parlamento solo come
uno strumento per salvaguardare gli interessi locali, familiari, degli amici e dei
parenti. Per lo stesso motivo quella che, in esso, doveva essere
l’opposizione, in realtà non si fece sentire più di tanto. Tutti questi fattori
portarono alla delusione anche in quei patrioti che avevano riposto fiducia nel
Parlamento come elemento decisivo nel processo di educazione della
nazione.
(Marta Mazzocut)
2. I PROTAGONISTI
1.GARIBALDI. L’INVENZIONE DI UN EROE
Secondo Lucy Riall, Garibaldi rappresenta il trionfo della concezione
“mazziniana” dell’unità di pensiero e di azione: la sua fama è il prodotto
congiunto di un’elaborazione culturale e di imprese militari.
Egli, infatti, realizza una connessione fra la nazione intesa come identità
culturale e il nazionalismo come movimento politico rivoluzionario, come un
eroe letterario, Garibaldi è virile e attraente, affascinante con i suoi capelli
lunghi e gli abiti al vento. Ma, soprattutto, egli è un soldato, un eroe militare
che apre la strada al “giorno glorioso” in cui l’Italia risorgerà a nuova vita.
Come gli eroi immaginari o storici dei romanzi e dei dipinti risorgimentali,
Garibaldi incarna l’idea romantica di nazione, e fa parte di una comunità
fraterna, di liberi e uguali.
Garibaldi rende sempre onore ai caduti e ai feriti della legione,
ridimensionando il proprio contributo ed esaltando le virtù religiose e
romantiche dei martiri.
La sua legione simboleggia un nuovo ideale politico, quello della fraternità e
del sacrificio, derivante dal “giacobinismo” e dalla Rivoluzione francese.
In quasi tutte le descrizioni compare il contrasto fra gli squallidi insulti,
scagliati contro Garibaldi e la sua unità militare dagli stranieri e dai nemici
dell’Italia, e la diversa realtà rivelata dai patrioti italiani e dai giornalisti onesti.
Queste accuse servono a mettere in ulteriore rilievo la magnifica e vera storia
di quella schiera di soldati.
Fra i primi del 1846 e la fine del 1847, Garibaldi divenne un simbolo della
“nuova” Italia, un’Italia risorgente. In altre parole, divenne un “segno”, oltre
che un’ “esistenza vissuta”; la sua vita diventò importante per ciò che poteva
simboleggiare e per l’immaginazione che era in grado di suscitare.
Particolarmente rilevante è forse l’assai riuscita combinazione fra rettitudine
morale e coraggio, qualità personali che erano a loro volta identificate con un
concetto generale di italianità idealizzata.
Bisogna inoltre considerare quanto le sue idee e la sua immagine furono
forgiate dalle esperienze vissute lontano dall’Italia; la conoscenza che egli
aveva del socialismo francese e della politica sud-americana, furono
altrettanto importanti, per la sua formazione, come gli incontri con i
“mazziniani”.
RIVOLUZIONE
In Italia, Garibaldi giocò un ruolo decisivo in virtù dei suoi successi militari, e
in modo particolare della sua vittoria contro i francesi del 30 aprile 1849.
In questo modo veniva messa in risalto l’importanza dell’apporto dei volontari
per la riuscita delle rivoluzioni italiane; sebbene nel 1848-49 i volontari
venissero guardati con sospetto dall’esercito piemontese, il loro giovanile
entusiasmo rappresentò un importante contributo alla lotta nazionale.
Nel 1849, inoltre, in occasione sia della battaglia per la Repubblica Romana
sia nella difesa delle altre città, i volontari ebbero una seconda opportunità,
dalla quale seppero trarre grande vantaggio.
Da questo punto di vista, la sconfitta finale della Repubblica Romana potè
sembrare meno importante dell’esempio che un esercito di giovani volontari
aveva dato della resistenza valorosa e della sconfitta onorevole. Così la
formazione di milizie volontarie è sembrata poter offrire una soluzione al
duplice problema della debolezza militare e dell’apatia del popolo che aveva
afflitto il partito “mazziniano” fin dalla nascita del movimento nei primi anni
‘30.
Il messaggio di redenzione nazionale si è rivelato quindi del tutto convincente
proprio per il fatto di essere vero, di scaturire dalle azioni di uomini in carne
ed ossa piuttosto che dall’immaginazione degli scrittori.
Nel corso degli eventi di quel biennio, Garibaldi rappresentò un punto di
raccordo visibile e concreto fra l’immagine dell’Italia proposta dai romantici e
l’ideale di impegno politico sostenuto da Mazzini.
Nel 1848/49 si rivelò estremamente utile il fatto che così tanti mazziniani,
compreso Garibaldi, avessero una notevole esperienza nell’azione di
propaganda.
In effetti, agli occhi dello storico del ventunesimo secolo, ciò che appare più
rilevante, non sono tanto gli atti di valore militare quanto il moto di crescente
interesse che essi suscitarono nei mezzi di informazione.
L’“esplosione del giornalismo” in Europa, fra il 1847 e il 1848, fu un chiaro
sintomo dei cambiamenti politici in corso e di una crescente partecipazione
popolare.
Nel 1849, poi, fu grande l’attenzione dedicato a Garibaldi dalla stampa
straniera tanto da conferirgli una reputazione a livello internazionale, nella
doppia veste di idolo dal potere seduttivo e di pericoloso “filibustiere”.
In quel periodo appare chiaramente che, come simbolo politico, Garibaldi si
colloca decisamente al di fuori di ogni consuetudine comunemente accettata.
In veste di soldato, ad esempio, appare e si comporta più come un bandito
che come un ufficiale. Come icona nazionale, non è né giacobino né
napoleonico; nella sua figura si rileva solo un accenno alla bellezza e alla
dignità dei modelli classici.
In altre parole, Garibaldi è una figura intensamente romantica, ribelle,
indipendente ed emotiva piuttosto che austera, conformista e autoritaria. In
termini politici, egli rappresenta un ideale decisamente democratico e aperto
alla partecipazione, cerca di proporsi come l‟incarnazione delle aspirazioni
popolari e appare più come un membro della comunità e della nazione che
come un grande uomo, isolato e capace di grandi gesta.
L’eccezionale talento che i democratici avevano mostrato nel fare
propaganda a se stessi non fu affiancato da un’analoga capacità di
organizzare e di coordinare la loro azione politica.
Nel 1948/49 il fronte rivoluzionario vide delinearsi delle divisioni e furono
proprio queste tensioni e questa mancanza di coordinamento a determinare
la sconfitta poiché ciò portò a una carenza di iniziative pratiche in grado di
consolidare la rivoluzione.
Tuttavia queste tensioni avrebbero potuto risultare meno gravi se non si
fossero prolungate e irrigidite, influenzando a loro volta il pensiero e l’azione
dei democratici nel decennio che fece seguito alla conclusione della
rivoluzione.
A Garibaldi la rivoluzione lasciò un ricordo amaro, un senso di frustrazione e,
dopo la morte di sua moglie, un profondo dolore personale.
Per gli stessi protagonisti della vicenda e soprattutto per i “mazziniani”, la
memoria della rivoluzione fu un’importante fonte di divisione e quindi essi
sembrarono meno capaci di mantenere alto quel messaggio di fraternità che
con tanto successo avevano promosso. Il più duro e persistente contraccolpo
di questo insuccesso fu il riemergere, al centro della storia nazionale italiana,
dei più tradizionali temi della morte, della decadenza e del tradimento.
IN ESILIO
A Bologna, il 5 agosto, le Autorità Austriache emanarono un proclama
secondo il quale si sarebbe proceduto in base al “giudizio statuario militare”
contro “chiunque scientemente avesse aiutato, ricoverato o favorito il profugo
Garibaldi, o altro individuo della banda da lui condotta o comandata”.
Garibaldi arrivò dunque a Chiavari dove provocò un notevole subbuglio; il suo
arresto venne ordinato quasi immediatamente dal Gen. Alfonso La Marmora,
Commissario Reale a Genova, sulla base dell’accusa pretestuosa, secondo
la quale avrebbe fatto ingresso nel paese illegalmente.
Mentre era agli arresti, Garibaldi rifiutò il denaro offertogli dal governo
Piemontese limitandosi a chiedere aiuto per sua madre e i bambini
guadagnandosi così la simpatia dei funzionari governativi che rimasero colpiti
anche dal suo buon senso e dalla sua franchezza.
Le lettere di Garibaldi durante gli arresti rivelano che la sua principale
preoccupazione, più che la politica, erano le ristrettezze finanziarie,
soprattutto per mantenere la famiglia; per risolvere queste sue esigenze,
tornato in libertà, emigrò a New York per procurarsi un’imbarcazione e
guadagnarsi da vivere come marinaio mercantile. L’arrivo di Garibaldi a New
York venne annunciato già prima che avvenisse; si può quindi dire che
l’accoglienza preparata per lui si inseriva in una particolare tradizione politica
americana. Più specificamente, i politici statunitensi furono ben contenti di
poter sfruttare le rivoluzioni europee del 1848/49 per scopi politici interni.
Nell’Aprile del 1851 Garibaldi lasciò New York per l’America centrale e per
due anni non si ebbero sue notizie. Nel Novembre 1953 tornò in Europa:
forse il fatto che il Governo Piemontese avesse dato da intendere che egli
sarebbe stato benvenuto in Patria, a patto di rinunciare a svolgere qualsiasi
attività politica, lo convinse ad imbarcarsi ancora una volta come marinaio
mercantile, stavolta in veste di Capitano di una nave che doveva portare un
carico a Londra e a Genova.
Nonostante che la sconfitta delle rivoluzioni avesse dimostrato la capacità di
reazione del conservatorismo a livello internazionale, a metà degli anni
Cinquanta la coalizione di forze che aveva sostenuto i conservatori nel
biennio rivoluzionario era entrata in crisi. L’Austria subì un duro colpo al
proprio prestigio internazionale in conseguenza alla guerra di Crimea (185456). La sua debolezza avrebbe potuto rivelarsi meno grave se i regimi
conservatori italiani fossero riusciti a trovare una propria stabilità e ad
acquistare consensi, ma all’indomani della rivoluzione i governanti italiani
commisero l’errore di spostarsi ulteriormente a destra.
Nel corso degli anni Cinquanta, Ferdinando II di Napoli ignorò l’evidente
esigenza di riforme, anche nei settori cruciali delle finanze e
dell’amministrazione, reintrodusse la censura sulla stampa e respinse ogni
compromesso. A Roma Pio IX si schierò contro il liberalismo e si dedicò
prevalentemente alla definizione dei dogmi del cattolicesimo, lasciando le
questioni politiche nelle mani del cardinale Giacomo Antonelli, le cui tendenze
nepotistiche e il gusto per la ricchezza e i lusso alimentarono una serie di
accuse contro la corruzione della Curia. Dopo la guerra di Crimea e il
mutamento delle relazioni internazionali a svantaggio dell’Austria cresce la
condanna internazionale dei loro regimi italiani. Notevole rilievo assunse poi
nel febbraio del 1856 la decisione del ministro britannico Lord Clarendon di
sollevare la questione italiana al Congresso di Parigi, criticando sia il papa
che i Borboni ed esprimendo simpatia per le aspirazioni nazionali italiane.
Nel decennio seguente si delineò una straordinaria trasformazione del Regno
piemontese; dopo il 1852, con Camillo Benso di Cavour, il governo
costituzionale venne rafforzato, il potere della Chiesa ridimensionato e
l’economia piemontese rivoluzionata con una serie di misure che introdussero
la libertà di commercio e migliorarono le infrastrutture finanziarie e il sistema
dei trasporti. Per la prima volta nella penisola italiana esisteva una vera
alternativa vincente sia al conservatorismo che alla rivoluzione.
In questo periodo Cavour e il suo partito sottrassero l’iniziativa politica e
ideologica sia ai democratici che ai reazionari piemontesi. Egli gettò il
movimento democratico piemontese in una crisi dalla quale esso non si
sarebbe mai del tutto ripreso.
Gran parte dei moderati, compreso Cavour, non condividevano inizialmente
la causa nazionale italiana, essi erano anti-austriaci e, in generale, puntavano
all’espansione del potere e dell’influenza del Piemonte.
A metà degli anni Cinquanta si verificarono importanti cambiamenti: vi fu una
straordinaria impennata dell’immigrazione politica, soprattutto in città come
Torino e Genova, che contribuì a fare del Piemonte il nucleo di un reinventato nazionalismo italiano; ne trasse vantaggio Cavour che estese il suo
controllo sulla politica piemontese, soprattutto dopo la fine della guerra di
Crimea nel 1856.
Nello stesso periodo diventarono più consistenti le critiche nei confronti di
Mazzini, anche fra i suoi stessi sostenitori. Rimasero a lui fedeli i vari Aurelio
Saffi, Filippo De Boni e Francesco Crispi mentre, tra i tanti, si dissociarono
Jacopo Ruffini, Felice Orsini, Antonio Mordini ed il poeta satirico Giuseppe
Giusti.
Anche Garibaldi, all’atto di lasciare gli Stati Uniti per la seconda volta nel
1954, aveva lasciato intendere di essere scettico sull’effettiva utilità dei
metodi e delle tattiche messe in atto da Mazzini e, rientrato in Italia, rifiutò di
continuare a collaborare con lui.
Tra il 1856 e il 1859 si delineò il fallimento del mazzinianesimo e Garibaldi si
alleò ufficialmente con Cavour che successivamente promosse un incontro
con Vittorio Emanuele II: ne nacque quindi una fiducia e simpatia reciproca.
Nonostante tale amicizia con il governo piemontese, Garibaldi non rinunciò
mai all’idea di compiere spedizioni rivoluzionarie rimanendo convinto che una
rivoluzione potesse consentire un riscatto a livello nazionale secondo la
visione religiosa che Mazzini aveva di “nazione”.
Tuttavia, alleandosi con la monarchia piemontese, a una tradizione politica
essenzialmente pragmatica e per molti aspetti conservatrice, e a Cavour che
era il più opportunista tra i politici, la Società Nazionale non solo confinò la
rivoluzione a un ruolo secondario, ma la spogliò anche della sua <vitalità>
morale.
Lo scopo supremo dell’unità finì per oscurare ogni altra divisione politica e le
altre questioni ancora irrisolte. Inoltre il coinvolgimento di Garibaldi provocò
tutta una serie di equivoci, malintesi e tradimenti. Anche in termini pratici, il
suo atteggiamento poteva essere causa di difficoltà. Infatti, nonostante la sua
precedente reputazione di uomo d’azione, in gran parte della sua azione
politica degli anni Cinquanta si può rilevare una strana passività e una
mancanza di reale iniziativa. Per diversi anni Garibaldi intervenne in modo
sporadico e irregolare. In effetti, dopo l’acquisto di Caprera, egli prese
l’abitudine di comparire all’improvviso sulla scena politica per poi ritirarsi
nuovamente sull’isola. Si può quindi dire che continuò a vivere in una strana
sorta di “auto-esilio” anche dopo essere tornato in patria.
IL CANONE GARIBALDINO
I mutamenti che investirono la penisola italiana nel corso degli anni
Cinquanta e nel periodo successivo non furono semplicemente il risultato di
eventi di “alta politica”. L’esito della guerra di Crimea, l’isolamento
internazionale dell’Austria e i conflitti fra e all’interno dei gruppi politici in Italia
possono contribuire a spiegare il rilievo sempre maggiore assunto dalla
questione italiana agli occhi della diplomazia europea. Uno dei più importanti
sviluppi politici di questo decennio fu l’affermarsi, sia in Italia che a livello
internazionale, di un’opinione pubblica liberale che non solo guardava con
favore al nazionalismo italiano, ma era appassionatamente coinvolta dalla
questione del futuro dell’Italia.
Il nazionalismo dipendeva dalla cultura stampata; senza l‟espansione della
parola e dell’immagine scritta, sarebbe stato impossibile per le complesse
società moderne “dare forma” a un concetto di comunità e di appartenenza
nazionale.
Garibaldi rappresentò e sostenne un movimento politicamente radicale, ma la
diffusione della sua fama fu un sintomo della democratizzazione della cultura
politica, un segno dell’ingresso di una società “non rispettabile” nella sfera
pubblica, che si portava dietro nuove regole e nuove risposte. Il suo fascino
fu confezionato per venire incontro a quelli che apparivano i gusti e le
esigenze di questa nascente cultura politica, ed egli stesso operò per crearla.
Coloro che si impegnarono a diffonderne l’immagine provenivano in parte da
ambiti esterni all’èlites tradizionali. La popolarità di Garibaldi rifletteva anche
una lotta per il controllo della sfera pubblica; essa contribuì al rafforzamento
delle tematiche nazionali, ma né Garibaldi, né il nazionalismo italiano furono
amati da tutti e la fama dell’eroe riuscì a mascherare solo in parte le profonde
divergenze tra prospettive politiche rivali rispetto alla questione nazionale.
UNA GUERRA MEDIATICA
Il conflitto italiano del 1859 fu l'evento più rilevante dell'anno che coinvolse il
pubblico tramite i nuovi mezzi di comunicazione come la fotografia e
soprattutto il telegrafo, grazie ai quali era possibile rispondere all'enorme
domanda di informazioni rivolta ai giornali. Per quanto riguarda il telegrafo,
esso assumeva un ruolo cruciale, un esempio fu la compagnia Reuter che
trasmise le notizie delle battaglie e i dispacci di Napoleone, fornendo infatti
regolarmente copie dei documenti ai direttori dei giornali. Ai tempi non
esisteva il diritto d'autore: ciò rendeva possibile la scrittura di più articoli
basati sugli stessi materiali. L'occhio pubblico era fisso sull'Italia, in
particolare sulla battaglia di Solferino, della quale scrisse anche il Times
riportando in prima pagina pure la cartina del campo di battaglia. Ai primi del
1860 si cominciò ad utilizzare anche la stampa a colori per le foto e i
supplementi relativi alle battaglie.
Il pubblico europeo e americano era interessato alla guerra, tanto che c'erano
pure alcuni turisti stranieri nei pressi dei campi di battaglia. Il livello di
coinvolgimento della gente comune era talmente alto da alimentare il mercato
di souvenir sulla guerra, volto a commemorare le battaglie.
Lucy Riall, mette in evidenza il fatto che fu assai notevole la reazione
dell'opinione pubblica all'attività di Garibaldi e alle guerre d'indipendenza
italiane. Quest'entusiasmo per il famoso generale si diffuse in tutta Europa e
anche negli Stati Uniti, fatto confermato dall'enorme consenso che ottennero
poi le innumerevoli pubblicazioni su di lui. In queste ultime , il radicalismo
garibaldino tendeva ad essere sfumato o svuotato del suo significato politico.
Ma non c’era solo entusiasmo, è necessario mostrare anche l’altro lato della
medaglia, in quanto molti giornali non erano a favore della guerra e dei suoi
effetti disastrosi.
Anche nella Francia di Napoleone III si andavano creando dissensi,
nonostante il controllo imposto del governo sulla stampa. Nacque in queste
condizioni una guerra di opuscoli pubblicati da destra e sinistra, in conflitto
riguardo alla linea che avrebbe dovuto essere seguita in Italia. Inoltre le
questione italiana creò in Francia un distacco vero e proprio tra Chiesa e
Regime. Per esigenze di politica interna, la guerra agli occhi dei francesi
veniva presentata come un'esperienza positiva e patriottica, che rappresentò
per i giornali e le riviste un'occasione di guadagno, ma anche di
rinnovamento di quest'ultimi tramite supplementi, illustrazioni e altri materiali
visivi. Per rimarcare il favore che il pubblico dava alla guerra furono pubblicati
una serie di canti di guerra, alcuni corredati anche da spartiti per pianoforte.
L'accompagnamento dei resoconti della guerra formato da illustrazioni, foto,
cartine, litografie, scene di battaglia, fu alla base della nascita di album molto
costosi e illustrati, che incontrarono il favore del pubblico.
IL GENERALE
Garibaldi, nonostante la sua abilità nel presentare di se un'immagine
pittoresca e nel catturare l'attenzione di tutti, non fu il dominatore
incontrastato dei resoconti della guerra del 1859, in fondo per la stampa non
clericale era un rivoluzionario e nemico della Francia, quindi si andava
creando la tendenza a depoliticizzarlo, presentandolo semplicemente come
eroe buono, fedele, disciplinato e pieno di coraggio. Si tendeva per lo più a
lasciare nell'ombra il suo passato da repubblicano, mettendo in evidenzia le
sue qualità di gentiluomo e l'aspetto d'ufficiale, ma nonostante tutto, gli echi
del suo passato non convenzionale sopravvivevano. Si fece notevole sforzo
per collocarlo in un Pantheon ideale di generali e rispettabili capi nazionali, ad
esempio gli veniva riservato un posto vicino Cavour e Napoleone III. Gli unici
accenni a Garibaldi “il bandito” servirono a ricordare ai lettori che gli austriaci
lo trattavano come tale, prova di quanto essi fossero prevenuti e
malintenzionati. Molta attenzione c'era anche nel presentare i volontari come
gruppo di uomini rispettabili, il meglio che l'Italia poteva offrire. Secondo
l'opinione comune Garibaldi era in grado d'attirare i giovani nel servizio
militare, anche quelli delle classi più elevate. Questa fu una prova
dell'eccezionale carisma di Garibaldi. Egli era di certo una persona affabile e
piacevole, calma, forte, intelligente, di bell'aspetto, ma mai prepotente, dai
modi schietti, ma allo stesso tempo signorili, passionale e determinato, ma
controllato, calcolatore.
UNA VITA IMMAGINARIA
Durante la guerra del 1859, giornalisti e scrittori fecero a gara nel produrre
biografie e di fatto ognuna di esse doveva contenere un racconto diverso
della vita di Garibaldi. Molti giornali famosi , come il New York times o il
Journal pour tous, dedicarono a Garibaldi una biografia. In generale queste
biografie erano composte da opuscoli a basso prezzo ed erano stati
pubblicati in tutta fretta. Ogni biografia presentava la propria versione della
vita di Garibaldi, ma comunque tutte prendevano spunto da una base
comune di conoscenze. La maggior parte di esse conteneva il ritratto
dell'eroe (sempre in uniforme militare), quasi sempre affiancato da un
richiamo all'Italia (ad esempio il tricolore) e spesso concedeva ampio spazio
allo stretto rapporto tra vita marinara e la sua natura passionale. Nonostante
ciò, tutte le biografie tendevano all'iperbole e alla miticizzazione del
personaggio guerriero e invincibile. Gran parte del materiale da cui traevano
spunti questi scritti era pura invenzione, che dava al tutto un taglio fortemente
romanzato. La prima gioventù a Nizza e le avventure in Sud America poi,
offrivano l'opportunità di inserire nel racconto elementi fantastici. Gli episodi
inventati venivano ripresi a loro volta da altri scrittori, creando una rete
intricata di eventi mai accaduti realmente.
L'elemento realmente nuovo delle biografie di quegli anni non era la finzione,
ma l'estrema libertà inventiva ed espressiva degli autori e il
ridimensionamento del vero contenuto politico. In Gran Bretagna l'entusiasmo
per Garibaldi si manifestò anche con altri mezzi: le rappresentazioni teatrali
(“Garibaldi's Englishman”, ad esempio, era una satira sul personaggio politico
divenuto poi celebre).
La caratteristica principale del processo di mitizzazione di Garibaldi fu la
libertà con cui vennero mescolati insieme fatti reali ed episodi inventati,
soprattutto riguardo alla vicende sentimentali, con Anita ad esempio.
Tutte queste memorie sono un esempio di come venne ricreata la vita di
Garibaldi da storia in storia e di come l'atmosfera fosse di stile scandalistico:
si narra spesso di omicidi, seduzione e soprattutto mistero. Particolarmente
interessante è la continua promessa di dire la verità su Garibaldi, anche se
essa non verrà mai del tutto rispettata. Il rifiuto delle consuete distinzioni fra
realtà e finzione era del resto un tratto caratteristico della cultura romantica
dell'Ottocento.
Un effetto comune prodotto dalle biografia era che il fascino personale di
Garibaldi diventò subito più importante delle tematiche politiche. L'aspetto
politico, proprio per questo motivo, sembra ridursi all'impegno per liberare
l'Italia dall'oppressione austriaca. Quindi tali biografie tendevano a
depoliticizzare Garibaldi, rimuovendo il suo passato repubblicano. Molti
vedevano in lui un rivoluzionario ma in alcune iconografie, Garibaldi era
associato ad un'estetica banditesca e ad un passato medievale. Tuttavia è da
ricordare che esisteva allora una censura, per cui appare quindi assai
improbabile che gli scrittori avessero deciso deliberatamente di dare una tale
immagine a Garibaldi.
La guerra del 1859 ebbe fondamentale importanza secondo Lucy Riall per
dar vita al cosi detto “culto di Garibaldi” e fu una componente essenziale per
la costruzione del mito del “risorgimento” italiano. Garibaldi era il simbolo di
tutto ciò che c'era da ammirare nella lotta per l'indipendenza italiana e
avvicinava un po' tutti all'idea di nazione che andava creandosi.
Sulla popolarità di Garibaldi non c'è il minimo dubbio, essa è confermata dalla
quantità inverosimile di scritti sulla sua persona, segno di come si stava
creando una comunità di lettori liberale e cosmopolita di carattere
internazionale. Questo culto non coinvolse solo gli uomini; molte biografie
erano scritte da donne e alcune di esse erano esplicitamente dedicate ad un
pubblico femminile. Grazie a queste opere si può verificare l'esistenza di tale
pubblico, ovviamente interessato più agli aspetti patetici che ai fatti storici. Di
Garibaldi insomma c'erano due versioni: quella reale e quella immaginaria. Il
suo grande successo non fu privo di problemi. Dal punto di vista politico, la
sua posizione non era affatto chiara, molti volevano oscurarne addirittura il
mito che diventava via via sempre più eclettico e ambiguo. Nel Garibaldi
immaginario è possibile osservare come egli si muovesse in modo autonomo
e con rispetto attorno ai politici. Tutta la sua fama e il suo successo
diventavano infatti un problema per le autorità piemontesi che non riuscirono
ad ostacolarle.
Nel 1859, Garibaldi cadde in errore fidandosi troppo di Cavour, ma non per
questo si può dire che egli fosse politicamente incapace: egli aveva infatti una
naturale abilità politica, come dimostrano i discorsi in pubblico, a volta troppo
enfatici, ma politicamente efficaci.
Egli comprese immediatamente i vantaggi legati a questa sua vita
immaginaria e si preoccupò subito a proteggerla.
I MILLE
MIRACOLO A MARSALA
La spedizione che salpò da Quarto verso la Sicilia era male equipaggiata e
aveva pochi uomini, dal momento che il governo piemontese aveva
confiscato I fucili e Garibaldi era dovuto partire in fretta. Partirono il 5 maggio
e fecero tappa a Talamone (Toscana) per entrare in possesso in alcuni fucili
Enfield e di munizioni assortite. I volontari riuscirono ad ottenere anche due
cannoni e altri pezzi d'artiglieria di scarso valore. Il motto della spedizione era
“l'Italia e Vittorio Emanuele” e i volontari vennero divisi subito in sette
compagnie; fu nominato uno stato maggiore comprendente Bixio, Crispi e il
colonnello ungherese Türr. In quei giorni fallì il tentativo di invasione dello
Stato Pontificio.
Dopo Talomone, i volontari s'imbarcarono per la Sicilia. Qui, grazie alla
mancanza delle truppe borboniche, che avevano precedentemente lasciato la
città, i Mille riuscirono senza troppi problemi a sbarcare a Marsala,
immediatamente bloccarono il collegamento telegrafico con Trapani e
convinsero i consiglieri comunali a riconoscere Garibaldi, in qualità di
rappresentante di Vittorio Emanuele, dittatore della città. Molti dei Mille
venivano dal Nord e in generale non vennero accolti cordialmente in città,
solo quelli siciliani poterono comunicare con la gente dell'isola. In questa
spedizione si mischiarono audacia politica, buona sorte e impreparazione
militare. Dopo Marsala, fu la volta delle colline di Salemi il 13 maggio; qui i
Mille provocarono un gran subbuglio, mentre Garibaldi si proclamò ancora
dittatore della città. Il dittatore istituì la leva militare dai 17 ai 50 anni; egli
stava cercando di creare un esercito eterogeneo per attaccare i Borboni e
liberare la Sicilia. Il 15 maggio i garibaldini si mossero verso le truppe
borboniche che aspettavano a Calatafimi. Qui i volontari riuscirono ad
attraversare la collina nonostante l'inferiorità militare e la disorganizzazione, e
riuscirono anche a disperdere i Borboni tra le campagne. Questa vittoria dette
alla spedizione una spinta enorme e un'aura di successo, pure molti siciliani
decisero a questo punto di schierarsi con i volontari. Garibaldi puntò allora a
Palermo, allestendo l'accampamento sull'altopiano di Renda. Con uno
stratagemma, quello di inviare feriti e bagagli a sud, fece credere ai Borboni
che stava organizzando la ritirata. Poi con le stesse scarpe logore e distrutti
dalla fatica e dalla pioggia, i volontari assieme a Garibaldi entrarono a
Misilmeri, qui si unirono nuove forze arruolate da un generale di Garibaldi,
Giuseppe La Masa. Il 26 da Gibilrossa progettarono d'attaccare Palermo. Il
27 notte, sorpresero le truppe borboniche attaccando la città. Seguirono tre
giorni di combattimenti per strada, finché il 30 maggio il governo borbonico
chiese una tregua. Si firmò un armistizio che durò fino al 6 giugno. I Borboni
ritirarono le truppe, Garibaldi e i volontari vinsero. La buona sorte fu d'aiuto a
Garibaldi, in quanto l'esercito nemico era anche attaccato da una crisi
finanziaria. Nel 1859, morì Ferdinando II, al quale successe il giovane
Francesco; il governo era debole, l'esercito per far fronte a Garibaldi lasciò le
province dove scoppiarono poi rivolte, il numero dei criminali aumentò e i
funzionari pubblici e la polizia abbandonarono i loro posti, interrompendo le
comunicazioni furono interrotte e le banche assaltate. Nella primavera del
1860 nel regno Borbone ci fu un collasso dei poteri statali e Garibaldi ne
approfittò. Audace per natura poi Garibaldi sfruttò al massimo l'alleanze dei
siciliani, come La Masa, Pilo e Corrao. La conquista di Palermo fu un trionfo
dovuto alla strategia militare e alla conoscenza dei luoghi. Garibaldi si
dimostrò coraggioso, determinato e sprezzante del pericolo, intimorendo e
demoralizzando i nemici.
I PROBLEMI DEL GOVERNO
Alla base dell'organizzazione del nuovo governo occorreva una strategia e
una pianificazione. Crispi fu fondamentale. Egli era segretario di stato: stabilì
la necessità di governatori in ognuno dei ventiquattro distretti della Sicilia,
abolì la tassa sul macinato, istituì tribunali militari e decretò la pena di morte
per reati di furto, saccheggio e omicidio. Fece riforme di stampo popolare,
istituì un governo civile, fece un programma dei lavori pubblici ed ordinò
l'espulsione dei Gesuiti, reprimendo le loro ricchezze e terre. Il decreto della
riforma agraria rimase inattuato e ciò scatenò rivolte e malcontenti, e ciò
andava di pari passo con l'aumento dei reati penali. La leva divenì un metodo
per combattere il banditismo. Per mantenere il controllo sulle campagne,
l'esercito era sempre più costretto alla repressione. Non erano chiare, a
questo punto, le intenzioni di Cavour che sembrava preoccuparsi del
mazziniano Crispi e del tentativo di unificare l'Italia partendo dal Meridione.
Cavour voleva avere il controllo sulla Sicilia e usò La Farina per ottenere i
suoi scopi. Crispi sia per le sue idee separiste e sia per la rudezza del
comportamento, fu costretto a dimettersi. Successivamente anche La Farina
fu espulso dall'isola. Questi conflitti -Crispi contro La Farina- erano lo
specchio dei conflitti interni all'isola. Nel 1860 gli esponenti siciliani non si
misero d'accordo sull'annessione al Piemonte o sull'autonomia, ad esempio.
C'erano gruppi molto divisi anche al loro interno e che spesso entravano in
contrasto.
DA PALERMO A NAPOLI
Ciò che non fu mai messo in dubbio era lo spirito antiborbonico di Garibaldi e
di Crispi. Alcune organizzazioni fin dall'inizio cominciarono a reclutare
volontari per la Sicilia, anche Cavour contribuì molto. Fu inviata una nave
guidata da Giacomo Medici con molti più uomini e armi. Più tardi partì un'altra
spedizione con il comandante Enrico Cosenza. Furono mandati altri aiuti e
altri uomini. Dopo Palermo l'attenzione si spostò a Messina e sulle
campagne. Le truppe furono divise in tre gruppi, comandati da Medici, Bigio e
Türr. Medici si scontrò a Milazzo con i borbonici, era il 20 luglio 1860. La
battaglia fu vinta dai garibaldini. Importanza particolare spetta all'aiutante di
Garibaldi, Missori. Messina si arrese senza neanche combattere, così
Garibaldi continuò il suo viaggio verso la Calabria senza problemi. La
Calabria era assediata a quel tempo dai Borboni. Il 22 agosto, Garibaldi e
Cosenz, presero Reggio Calabria e il 26 raggiunsero la truppa di Medici,
fermatasi a Nicotera. Catanzaro si schierò con i volontari. Garibaldi cominciò
l'esplorazione spostandosi molto velocemente. Il 29 raggiunge gli uomini del
generale Ghio e requisì i ciuchi e i carri dell'area. Dopo un periodo
abbastanza notevole d'esplorazione (andò infatti a Cosenza, Sapri, Monti
Cilento e Casalnuovo), il 6 settembre giunse a Salerno dove fu accolto da
folle entusiaste. Garibaldi giunse due giorni prima delle sue truppe. I Borboni,
scoraggiati, temevano Garibaldi. Il 7 settembre egli entrò a Napoli senza
incontrare opposizioni, arrivando in treno da Salerno, anzi fu accolto da una
grande folla entusiasta, che festeggiò per i due giorni successivi.
L’UNITA’
Dopo Napoli, Garibaldi spostò l'attenzione su Roma. Seppe che l'esercito
piemontese era entrato nello Stato pontificio, secondo il piano di Cavour.
Garibaldi entrò pubblicamente in contrasto con Cavour, che s'allarmò sempre
più dalla presenza dei mazziniani e dello stesso Mazzini a Napoli. I Borboni si
prepararono in linea di difesa lungo il fiume Volturno (erano circa 50000) con
l'intento di riconquistare Napoli. Il loro generale, Ritucci, decise d'attaccare
l'esercito garibaldino a Caiazzo. Vinse l'esercito di Garibaldi, grazie alla sua
presenza di spirito. Garibaldi si convinse che l'unica via per l'unificazione era
venire a patti con Torino. Acconsentì a indire un plebiscito sulla questione:
con questa decisione Garibaldi era consapevole di dare i propri poteri a
Vittorio Emanuele. Il 21 ottobre 1860 fu la data dei plebisciti. Oltre il 99% votò
per il sì all'annessione della Sicilia al Piemonte e quindi sì all'unificazione
dell'Italia, anche se non fu un voto del tutto libero.
Dopo il voto Garibaldi restò a Napoli tre settimane, fino a che il 25 ottobre non
incontrò il re a Teano. Garibaldi chiese di diventare viceré, ma la richiesta fu
negata dal re. Successivamente il re propose a Garibaldi di diventare
generale dell'esercito piemontese, ma l'offerta fu rifiutata. Non erano più in
buoni rapporti come prima della spedizione. A Palermo in piazza Marina era
stato eretto un enorme monumento a Garibaldi. L'Italia ufficialmente unita nel
febbraio seguente, con Vittorio Emanuele II come Re e Torino come capitale;
Venezia e Roma erano ancora sotto gli oppressori stranieri.
Il 1860 fu l'anno mirabilis del Risorgimento. Le imprese di Garibaldi portarono
al collasso il regno delle due Sicilie e all'unificazione politica dell'Italia.
Garibaldi seppe sfruttare la crisi che c'era nel Meridione e l'atteggiamento
benevolo del governo britannico. Comunque dette prova di un grande talento
militare, per la capacità d'improvvisare e di agire di sorpresa. Si rivelò abile
nel presentare la rivoluzione in maniera positiva. Ottenne meno successi nei
negoziati politici, era infatti insofferente alle discussioni sull'annessione. Egli
si ritirò a Caprera, in una specie d'esilio in patria. Così la spedizione per
l'unificazione di fatto si concluse con un compromesso politico che non
soddisfaceva nessuno.
NASCITA DEGLI EROI ITALIANI
I provvedimenti economici e sociali vennero affrontati da un forte appello alle
emozioni della gente e da una credibilità alimentata da feste e cerimonie
pubbliche. Garibaldi e il suo governo fecero continui sforzi per non offendere
la Chiesa, dato che senza il sostegno di essa si sarebbe potuto realizzare
ben poco.
Garibaldi durante tutto il corso della campagna, fece riferimenti ai Vespri e
all'orgoglio dei siciliani, egli esortava le donne a mandare i figli in guerra. I
discorsi di Garibaldi seguivano una formula canonica e avevano come scopo
sia convincere gli uomini ad arruolarsi sia convincere le donne a fornire aiuto
materiale e morale alla campagna garibaldina. Insolita è l'attenzione che
rivolgeva Garibaldi ai preti. Chi non si univa alle truppe era ritenuto codardo.
Nel 1860 Garibaldi, ormai eroe, veniva accolto spesso nelle città da
cerimonie pubbliche. Spesso nei suoi discorsi in pubblico, Garibaldi era in
grado di ricorrere a espressioni tratte dal gergo religioso per avvicinarsi
maggiormente alla popolazione. Quest'ultima lo innalzava fin a divinità.
L'assimilazione del culto di Garibaldi ai culti religiosi era stata creata dall'alto.
Egli riceveva benedizioni e aveva posto d'onore in alcune celebrazioni. Nel
corso della sua campagna, Garibaldi ebbe la massima cura d'osservare i culti
del luogo, accettando quindi anche il potere della Chiesa. Aveva una
personalità amichevole e disponibile nei confronti dei suoi sostenitori. La sua
figura era un miscuglio tra l'autorità rituale e la rilassata intimità del capo
democratico e proprio grazie a questo mix ebbe un tale successo. Il giorno
del suo compleanno, il 19 luglio a Palermo, anche se in periodo di crisi,
divenne una celebrazione pubblica. Tutti erano in festa fin dal primo mattino e
in città avevano appeso delle tele con raffigurate alcune scene della
campagna di Garibaldi. Successivamente si svolsero in tutta la città parate e
processioni. Lo stesso giorno fu festa anche a Marsala. Queste celebrazioni
sembravano un esempio di come si costituisse una nazione dal basso e
avevano comunque scopo di far sorgere un senso di appartenenza
nazionale. Questo tipo di celebrazioni non erano nuove, in quanto erano già
state utilizzate dai Borboni, ma erano piene di simbolismo tradizionale e
religioso e quindi molto apprezzate dal popolo. Anche durante l'estate del
1860 ci furono cerimonie pubbliche di questo tipo per cercare di fissare una
narrazione ufficiale degli eventi di quell'anno. Il simbolo del regno borbonico
era il castello di Castellamare che fu demolito durante una cerimonia
pubblica. Si organizzarono funerali pubblici per coloro che avevano
combattuto per la patria (il più grandioso fu quello di Rosalino Pilo, amico di
Crispi). I sostenitori di Garibaldi controllavano anche la stampa che aveva il
dovere di mettere in risalto la figura di Garibaldi. Tutte queste celebrazioni
rappresentano un significativo tentativo di rendere sacra la nazione e di
trasformare l'agire politico in oggetto di culto religioso. Qui si può capire come
il concetto di “religione politica” di Mazzini trovò realizzazione sul piano
pratico ancor prima dell'Unità; in queste cerimonie si prestò grande
attenzione a non offendere la Chiesa.
IL MITO DEI MILLE
La “dittatura” di Garibaldi dedicò grande cura all'opera di autopromozione,
non solo mirata al Meridione, ma anche al Settentrione e all'ambito
internazionale. Una buona opinione pubblica facilitava la riuscita della
campagna, che era stata vista fin dall'inizio come un punto di partenza per un
attacco allo Stato pontificio. Garibaldi scrisse alcune lettere che oltre che
incitare gli italiani alla collaborazione, avevano lo scopo di giustificare
l'insurrezione e quindi la spedizione diventava un eroico tentativo messo in
atto per l'Italia in nome del Re. Facendo pubblicare queste lettere sui giornali,
Garibaldi sperava di convincere i giovani che leggevano notizie sui Mille, ad
unirsi a lui. Oltre che nella pubblicità dei giornali, Garibaldi faceva affidamento
sull'intento propagandistico nato nel Settentrione tramite poesie, discorsi e
iniziative celebrative. Tra i Mille poi c'erano molti poeti, scrittori e pittori, e
quindi ci si affidava alla loro esperienza personale per darne senso di
immediatezza e intimità agli eventi politici, tramite l'intensità politica delle
opere. Nella stampa democratica la spedizione di Garibaldi veniva
rappresentata come un'ideale famiglia italiana e un modello di coinvolgimento
democratico. Tutte le fonti epistolari sembrano testimoniare l'esistenza di un
generale consenso riguardo all'opera di costruzione e promozione di una
“storia dei Mille” come narrazione esemplare del Risorgimento. Il vero centro
dell'attenzione restava Garibaldi, che dava notorietà.
GIORNALISTI E PUBBLICO DI LETTORI
La benevolenza della stampa fu fondamentale per contrastare qualsiasi
critica venisse rivolta al suo operato. Si deve sempre tener conto che all'inizio
l'esercito garibaldino aveva rubato due navi e aveva attaccato uno stato
riconosciuto internazionalmente. Il governo borbonico potè denunciarlo,
seguito da gran parte dell'Europa legittimista. Per questi motivi, il generale
non ebbe un'ottima fama fin da subito. Poi quando cominciò a vincere le
battaglie ottenne pian piano il favore della stampa, anche di quella estera.
Per la stampa internazionale non c'erano dubbi: il 1860 era l'anno di
Garibaldi. Garibaldi era soggetto ad una vera e propria mania, sostenuto
dalla stampa e caratterizzato da un massiccio interesse. I nazionalisti di ogni
tendenza politica fecero a gara nel celebrare ciò che era stato realizzato. Più
in generale la stampa moderata seguì i democratici nell'elevarne il
rivoluzionario al rango di un nuovo santo nazionale. In questo coinvolgimento
massiccio della stampa non c'era nulla di casuale. Garibaldi cercò sempre di
ingraziarsi I giornalisti, in particolare, egli li invitava ad unirsi alla campagna
per poi raccontarla dall'interno. Era molto amico di Dumas, romanziere e
giornalista e di Eber, ufficiale inglese, che voleva scrivere di lui. Tutti I
giornalisti rimanevano colpiti dalla sua ospitalità e gentilezza. Ed è soprattutto
dalla stampa straniera che si nota la tendenza a dipingere la campagna di
Garibaldi come un'avventura. Mentre la guerra del 1859 era stata raccontata
come una normale vicenda bellica, gli eventi del 1860 vennero descritti come
una rivoluzione. Attraverso la pubblicazione di ritratti, I giornali illustrati
stranieri contribuirono anche a fare dei protagonisti della rivoluzione delle
celebrità politiche. Nel complesso, si può dire che I tentativi di convincere I
giornalisti che la rivoluzione nell'Italia meridionale rappresentava un eroico
atto di giustizia ebbero successo. La stampa, soprattutto quella illustrata,
preferì evitare I temi politici, preferendo alleggerire le questioni.
LE VITE DI GARIBALDI
Tutta la pubblicità assicurata dalla stampa a Garibaldi fu accompagnata da
nuove storie e biografie sull'eroe. Dopo il 1860 uscì una quantità enorme di
storie sui Mille e la loro campagna tutte diverse per quantità e qualità. Oltre
alla storia dei Mille gli scrittori ora avevano a disposizione le memorie di
Garibaldi. Dumas scrisse una versione già a giugno che ebbe grande
successo per la velocità in cui venne stampata e tradotta delle altre lingue.
Alcune biografie erano pure stampate a colori con un largo uso della bandiera
italiana. Anche all'estero esisteva un mercato pronto per le biografie e le
storie sulla campagna garibaldina. Le biografie e I racconti delle spedizioni
miravano a vendere la figura di Garibaldi a un pubblico il più ampio possibile.
In genere il materiale era piuttosto economico e di facile accesso per la
maggior parte delle persone. Tutta questa produzione differente permetteva
alla gente di scegliere cosa leggere e a quale livello informarsi, se da lettere
dei volontari o biografie, poesie o canti, ecc.
La storia di Garibaldi nel 1860 è interessante di per sè e anche per
l'ampiezza e per le diverse forme di diffusione.
Esistono diverse memorie dei Mille e delle vicende che ne scaturirono. I
volontari miravano a rovesciare un intero regno difeso da un potente esercito,
per far prevalere nell'Italia del futuro la propria prospettiva democratica. Il
governo di Garibaldi dedicò molto tempo ed energia a farsi conoscere e a
rendere popolare l'idea di “Italia”. Nel Sud fu promosso un vero e proprio
culto alla sua persona. Garibaldi aveva l'ostilità di Cavour, e ciò non
sorprende. Cavour era infatti ostile alla rivoluzione perché avrebbe significato
mettere in discussione il potere dei moderati sulla politica italiana. Ma Cavour
riuscì solo temporaneamente a controllare Garibaldi e a neutralizzare la
minaccia rappresentata dalla spinta nazionale italiana, quando si rese conto
che quella spinta non poteva essere arrestata, agì nelle vesti di difensore
dell'Italia. Per controllare l'unificazione nazionale ormai inevitabile, ne diventò
l'architetto. Garibaldi, pur essendo uscito vittorioso sul piano militare, venne
sconfitto su quello politico. L'impresa tramite tutti I racconti che si fecero
sembrò un'avventura popolare e moralmente giustificata, destinata ad un
esito glorioso se solo gli italiani si fossero uniti ad essa. Nel 1860 l'impresa di
Garibaldi aveva assunto un sapore romanzesco, alimentato dai vari racconti.
Garibaldi aveva come scopo quello di promuovere, sostenere e giustificarne
un processo di violento e rapido mutamento di regime.
Il momento di Garibaldi.
Il 1860 fu il momento di Garibaldi. Nonostante l'anno fosse cominciato male,
egli riuscì a rovesciare il regno borbonico e contribuì a costruirne un altro,
ottenendo una grande notorietà. Garibaldi incontrò e promosse un ideale
politico, tentarono di costruire un senso di identità nazionale. La visione di
Garibaldi non era la stessa per i siciliani, i volontari e i simpatizzanti stranieri.
Verso le fine della Campagna del Meridione, un comitato napoletano
organizzò una sottoscrizione pubblica in onore di Garibaldi. L'idea era di
offrirgli armi e denaro; egli accettò, ma ebbe scarso successo. C'era
indifferenza tra I siciliani per la rivoluzione. La gente non pagava le tasse e la
leva militare fallì. C'era molta ostilità e si cercò di modificare il decreto per
suscitare meno malumori. L'entusiasmo dei siciliani per Garibaldi era in realtà
del tutto superficiale, ci fu sempre una distanza tra I garibaldini e I siciliani. Il
governo garibaldino aveva scarsa idea di come era in realtà la maggior parte
dei siciliani. La mancanza di un consenso di massa contribuì a sancire la
vittoria di Cavour su Garibaldi. Innanzitutto bisogna ricordare che la guerra
non era tipica della Sicilia e l'esenzione del servizio era considerata un
privilegio. E' vero che molti siciliani non esitarono ad entrare tra I volontari. Il
problema era che questi volontari siciliani erano guardati con sospetto dai
garibaldini.
La politica culturale del governo garibaldino ricercava una base democratica
e quindi si differenziava dalle altre forme di nazionalismo. L'idea di
appartenenza nazionale legava tra loro anche quelli che spesso venivano
esclusi da tutto. Ci fu un aumento della produzione dei giornali. La stampa
palermitana fu solerte nel raccogliere e perseguire la proposta di fare di
Garibaldi il capo di una nuova religione e di alimentare gli atti di patriottismo,
esaltando la guerra e il servizio volontario, di promuovere anche le virtù del
martirio e di incoraggiare il culto dei martiri locali. Tutto questo sostegno della
stampa è accompagnato dalla mancanza di sostegno materiale al governo da
parte dei siciliani. Nei teatri e negli spettacoli venivano messe in scena
tematiche nazionalistiche, vi fu una vera e propria proliferazione poetica
patriottica, miscuglio di lessici religiosi, mitologici e patriottici. E'
estremamente significativo che in Sicilia la Chiesa tollerasse l'uso blasfemo
del proprio lessico per promuovere una religione dell'umanità alternativa, il
clero era patriottico, poiché conosceva le condizioni precarie della gente
sfruttata e percepiva il bisogno di riforme sociali. Alcuni di loro condannarono
pubblicamente la politica del pontefice che voleva difendere il suo potere
temporale. Vi sono anche testimonianze sull'entusiasmo della monache per
la rivoluzione. Fra le siciliane in generale c'erano ammiratrici di Garibaldi,
c'erano comitati femminili che raccoglievano fondi per morti e feriti. Tutto
questo sostegno religioso può essere difatti considerato uno dei grandi
successi di Garibaldi. E' possibile che Garibaldi fosse già famoso ancor prima
del suo ingresso nell'isola, poiché Pilo e Corrao gli avevano già fatto
pubblicità. Il suo arrivo produsse un notevole impatto sulla cultura e sulla
memoria popolare. Furono composte innumerevoli canzoni accomunate dal
gusto per la guerra e per la violenza.
LA NAZIONE ARMATA
Uno degli aspetti più rilevanti fu la corsa dei giovani della Lombardia e
dell'Italia centrale per combattere nel 1859 contro l'Austria. Ciò avvenne in un
clima nazionalista. Nel 1860 la guerra di Garibaldi contro I Borboni suscitò
reazioni simili tanto che ai primi del 1860 tutti I progetti erano combinati nella
“nazione armata”. Il fenomeno del volontariato e dei sostegni dal Piemonte
furono molto importanti, poiché per esempio I soldi provenivano da gruppi
rivali diversi. La spedizione che partì da Quarto ebbe un che di romantico in
quanto molti fecero di tutto per parteciparvi. L'appello ai volontari da parte di
Garibaldi provocò una grande corsa per unirsi a lui, in quanto egli non si
riferiva a qualcuno in particolare, ma a tutti e di tutti I mestieri. Un gran
numero delle offerte arrivava da ufficiali, ufficiali a riposo, soldati e uomini che
avevano già combattuto come volontari in altre guerre. Ci fu insomma un
enorme successo di Garibaldi nell'Italia Settentrionale e Centrale. Nel
complesso gli uomini che combatterono con Garibaldi furono ventunmila. Ci
furono anche spedizioni “amiche” come quella dei Medici ( 2500 uomini).
Ovunque c'erano richieste di centinaia di uomini per aiutare Garibaldi, ma
molti non venivano accettati, sarebbero stati decisamente troppi. Molti si
sentivano in dovere di partire per dimostrare il loro credo patriottico, il loro
eroismo disinteressato, in parte vedevano la Sicilia come un'avventura
violenta e in parte come una possibilità economica vantaggiosa. I volontari
restavano comunque incapaci di cogliere I particolari del messaggio
democratico, in quanto questi non vennero mai distinti dagli ideali
simboleggiati dal Piemonte.
L’ENTUSIASMO DEGLI STRANIERI
L'entusiasmo degli stranieri per Garibaldi non si limitò ai drammi e alle
pubblicazioni, molti espressero il loro sostegno in termini pratici con l'invio di
uomini e armi . Le somme inviate dai britannici furono consistenti,furono
organizzati raduni, si raccolsero fondi; si composero indirizzi a sostegno di
Garibaldi. Analoghe iniziative furono organizzate pure New York da dove nel
giro di due anni (1858-1860)arrivarono circa 100000 dollari. Furono fondati
anche qui comitati locali, sottoscrizioni raccolte di soldi per il fondo per un
milione di fucili. Note personalità americane unite in un comitato si
impegnarono per fare pubblicità. Ci furono concerti e spettacoli in onore di
Garibaldi. Da Gran Bretagna e Stati Uniti arrivarono anche volontari e altri
aiuti materiali, navi ad esempio.
In Francia c'erano delle restrizioni governative che impedivano così aperte
manifestazioni di sostegno , ma i giornali più importanti riuscirono comunque
a ricevere e a distribuire fondi per Garibaldi. Altri fondi furono bloccati dalla
polizia. Furono dai 300 ai 500 francesi che arrivarono in Sicilia passando per
Genova nonostante tutto.
In molti scrissero lettere a Garibaldi, fornendo aiuti o semplicemente
dimostrando ammirazione ed interesse. Molte di queste lettere avevano un
tono interessante, quasi a voler proporre un clima di intimità tra che scriveva
e Garibaldi. Il fatto che molte lettere conservate provenissero da Gran
Bretagna e da Stati Uniti indica quanto era forte in quegli stati il consenso per
Garibaldi. L'aspetto più sorprendente del consenso a Garibaldi è il suo
carattere cosmopolita, infatti I volontari provenivano oltre che dall'Italia del
Nord e Centrale anche da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Ungheria,
Polonia, Germania. Tutto ciò conferma il successo della campagna di Mazzini
di circa 22 anni prima a favore dell'Italia e fa vedere quanto potere di
influenzare le masse avessero i giornali. Resta comunque importante
ricordare come egli non fosse amato dal mondo intero. Non era amato per
esempio dalla destra francese. Anche in Gran Bretagna si era formato un
gruppo antigaribaldino. I cattolici erano in generale contro il nazionalismo.
Nell'Irlanda cattolica la campagna a favore di Garibaldi non era di certo vista
in luce positiva.
Nel 1860 Garibaldi non godeva in unanimi consensi ma di certo era difficile
ignorarlo. In Sicilia s'era ingraziato la Chiesa e il suo governo era celebrato in
vari modi , in breve tempo riuscì a comporre un esercito di volontari. Durante
l'estate fu sommerso di offerte d'aiuto e espressioni d'ammirazione
provenienti dall'estero. La risposta dei volontari al suo appello può essere
considerata un trionfo delle idee e dei metodi di Mazzini, che si basava sulla
trasformazione della guerra e della rivoluzione in eventi simbolici o comunque
in mezzi che la mettevano in luce positiva. Il garibaldismo diventò un vero e
proprio culto, quasi una religione per i suoi seguaci. Garibaldi riconosceva
l'importanza dei legami affettivi per il funzionamento del proprio esercito,
faceva appello all'emotività come base della proprio popolarità. Nel suo
esercito c'era un senso di grande famiglia e di affetto per la comunità
internazionale. La “dittatura” garibaldina mostra una notevole capacità di
creare un appassionato sentimento di identità politica. Le reazioni a Garibaldi
erano basate su una miscela di simboli autoritari e democratici. Egli aveva
capacità d'essere allo stesso tempo magnifico e umile; fu questa semplicità
ad ammaliare la gente.
Garibaldi fu l'artefice del proprio personaggio ma il suo culto fu alimentato da
spettacoli, giornali, lettere. Alcune di queste erano intrinse di emotività anche
se gli scrittori non avevano mai incontrato Garibaldi e ne avevano solo sentito
parlare.
DOPO L’UNITA’
A CAPRERA
Quando nel novembre del 1860 Garibaldi decise di ritirarsi a Caprera dalla
scena politica, gettò al vento tutti I suoi sforzi. Inizialmente non se ne rese
nemmeno conto del tutto. Ci tenne a ringraziare coloro che lo avevano
aiutato, forse pensava di ricorrere ancora al loro aiuto. Con I suoi generali
Garibaldi prospettò la creazione di cinque divisioni armate pronte per una
prossima guerra contro l'Austria. Tutto lasciava intendere che Garibaldi
sarebbe tornato in scena l'estate dopo con un'altra campagna per Venezia o
Roma. Aveva tutte le buone ragioni per essere fiducioso di farcela; all'inizio
del 1861 il suo prestigio era immenso. Nelle elezioni politiche fu eletto a
Napoli, ma molte organizzazioni e città si preoccuparono di informarlo del loro
sostegno. Caprera fu il centro di intensa attività: egli era circondato dalla
famiglia e da vari ospiti fissi (Specchi, Carponeto, Basso che erano I suoi
segretari). La sua solitudine era infranta dai visitatori. La casa a Caprera
divenne parte integrante della sua fama; la sua esistenza lì divenne un
elemento da mostrare al pubblico. I giornalisti approfittarono di misurare la
sua vita privata e pubblica a Caprera in nuovi articoli. Il fascino iconografico
della cittadina rimase intatto anche dopo. A sua volta Caprera assunse una
valenza politica. Il suo stile di vita sull'isola dimostrava che eroe genuino e
modesto fosse, fatto che ispirò molti scrittori. Garibaldi passò parte
dell'inverno a scrivere e a rispondere alle lettere, la maggior parte delle quali
proveniva dall'estero. Forse esaltati dalla prospettiva di una guerra per
conquistare Roma, I protestanti britannici furono tra I corrispondenti più
assidui.
IN PARLAMENTO
L'elevata statura del personaggio Garibaldi mascherava in realtà sviluppi
politici meno positivi. Nel 1861 all'interno del movimento democratico
cominciarono a prodursi divisioni. Infatti si doveva tener conto dell'estensione
parlamentare all'intera penisola italiana o quasi. C'erano tre correnti: quella
guidata da Antonio Mordini, che si concentrava sull'attività parlamentare;
quella guidata da Francesco Crispi, che voleva restare nella legalità, pur
sostenendo movimenti ed agitazioni extraparlamentari; quella più estrema,
guidata da Agostino Bertoni, che mirava a promuovere la rivoluzione.
Garibaldi s'avvicinava a quest'ultimo gruppo e si avvicinò pure a Mazzini. Di
fatto quindi non esisteva una chiara linea politica dei democratici. Questa
confusione dette a Cavour un vantaggio enorme, che mirò ad eliminare
insieme a Fonti, un generale, l'esercito di Garibaldi. Pian piano di andavano
sostituendo la guardie nazionali con I soldati piemontesi. Nuovi regolamenti
imposero limiti alle ammissioni. L'azione contro I democratici del sud si rivelò
però un errore, perchè cancellò il consenso politico. Il Re stesso notò
l'entusiasmo dei volontari e temette il loro malcontento una volta sciolti.
Garibaldi volle protestare tramite lettere e apparizioni in pubblico, la prima fu
quella in Parlamento che suscitò l'interesse della stampa, anche perchè in
quell'occasione indossò la divisa rossa garibaldina. Da quest'episodio
crebbero I malcontenti e la disputa continuò poi sulla stampa e risolta in un
incontro con Cavour e il Re. Il fatto che la disputa Cavour- Garibaldi avvenne
in pubblico ci fa capire quanto entrambi volessero influenzare l'opinione
pubblica. Questa prima incursione di Garibaldi in politica dopo l'Unità, non
può essere considerata un successo.
ASPROMONTE
Dopo lo scontro Garibaldi tornò a Caprera. Giravano parecchie dicerie sulle
sue prossime mosse, lui agì contro ogni previsione. Fece di tutto per far unire
a Genova tutta la sinistra italiana in un congresso, esortandoli a concentrarsi
sul problema Roma e Venezia. Allo stesso tempo Vittorio Emanuele
approfittando della scomparsa di Cavour, decise di agire in modo più diretto.
In questo periodo la popolarità di Garibaldi si mantenne inalterata. Fu in
questa atmosfera caratterizzata da un'aspettativa popolare carica di significati
politici che Garibaldi fece un viaggio in Lombardia con il patrocinio del
governo, con lo scopo di promuovere nuove affiliazioni. Sfruttò come al solito
la propaganda per avere uomini I soldi per la campagna per Venezia;
scriveva lettere a contadini, associazioni femminili, preti, organizzazioni. Fece
anche altri viaggi, ma questa ritrovata unità patriottica si interruppe all'inizio di
maggio, quando gruppi sospettati furono arrestati. Garibaldi si ritirò a
Caprera. Gli aventi si modificarono ulteriormente e l'uomo partì per Palermo,
organizzando una spedizione per Roma, appellandosi al popolo per reclutare
volontari. Partirono il 19 agosto e nonostante avessero contro lo Stato italiano
riuscirono a passare lo stretto e ad arrivare a Messina. Il governo decise di
intervenire con durezza; Garibaldi e le sue truppe furono bloccati infatti sui
rilievi dell'Aspromonte. Il governo sospese la libertà di stampa e sciolse le
società emancipatrici a Genova. Fu un disastro. Nel sud ci fu una violenta
repressione militare; la vicenda gettò discredito sul governo e sul presidente
del Consiglio. Garibaldi stesso ne uscì ferito ad un piede e dopo lo scontro
venne arrestato e portato con la famiglia a Varignano vicino La Spezia. Qui
con un operazione gli tolsero la pallottola al piede, restò in inverno in
carrozzella o stampelle a Caprera. L'episodio venne ripreso dalla stampa
internazionale, c'era chi lo elogiava e chi lo criticava. Nonostante la
disavventura, Aspromonte assicurò una fonte di successo riguardo la
propaganda per la sinistra democratica, grazie alla quale lo scontro cessò di
essere considerato sconfitta per Garibaldi e assunse il carattere di un evento
doloroso per la storia nazionale italiana. Garibaldi era considerato un eroe,
quasi un martire e Aspromonte era la prova finale di una vita esemplare, per
la sua coerenza. Rimase a Caprera per le precarie condizioni di salute, ma
continuò ad avere una fitta corrispondenza.
LONDRA
Nella primavera del 1864 Garibaldi lasciò Caprera e si diresse in Inghilterra.
Vittorio Emanuele d'Azeglio, ministro londinese, sostenne che quella visita
poteva essere utilizzata per indirizzare l'opinione pubblica inglese a favore
dell'Italia. I motivi del viaggio non sono tutti chiari. Può essere che puntasse a
spingere il governo a intervenire nella guerra tra Prussia e Danimarca, può
anche darsi che fosse una visita del tutto privata. Sembra che l'idea del
viaggio non fosse nemmeno sua, ma dei mazziniani Saffi e Bertoni, con lo
scopo di influenzare l'opinione pubblica. Il soggiorno di Garibaldi però
divenne un evento politico, era circondato da ammiratori, scrittori, eccetera,
partecipò a ricevimenti privati in suo onore. Questa visita era esempio di
politica spettacolare: tutta la stampa era concentrata su di lui. Anche se
aristocratici e borghesi conservatori non erano entusiasti dell'arrivo di
Garibaldi. Sia in Italia che all'estero Garibaldi provocava problemi per la sua
vicinanza ai radicali. Proprio per l'avversione incontrata, decise
improvvisamente di partire, inventandosi dei problemi di salute, cancellando
gli altri impegni. La folla che lo accolse era fatta di poveri e operai. Di certo
non era gente come la regina che esultò quando egli partì. Garibaldi tuttavia
colpì parecchi cuori di donne, sia per il fisico attraente, ma anche per la sua
abilità a sfruttare l'attrazione sessuale. Questo speciale rapporto con le
donne faceva parte di una strategia a lungo termine. Egli aveva successo
anche perchè aveva pochi concorrenti, solo Mazzini aveva fatto simile uso
delle donne inglesi facendole interessare alla politica oltre che alla sua sfera
privata.
Garibaldi nella versione finale delle sue memorie dedica otto pagine
all'Aspromonte e dopo quell'evento ritiene la sua vita inutile. Anche se dal
1860 al 1865 egli ebbe un ruolo centrale nella politica italiana, cercando di far
restare le questioni Roma e Venezia attuali, incoraggiò un po' tutti a
partecipare alla vita politica, elaborò uno stile di politica di massa, utilizzando
gli spazi pubblici per i suoi discorsi. I democratici dovettero scegliere se
continuare la via parlamentare o affidarsi alla sola rivoluzione. La fedeltà alla
Corona di Garibaldi e la sua fede nella Rivoluzione risultavano sempre più
incompatibili. Il suo comportamento di quel tempo creò non pochi
malcontenti. Il suo ritiro a Caprera erano il segno dell'insoddisfazione di
Garibaldi nei confronti dell'Unità. La sua immagine veniva usata ovunque e in
diversi modi, anche opposti.
Dopo la sconfitta dell'Aspromonte, Garibaldi più di venti anni e partecipò ad
altre campagne militari. La prima, nell'estate del 1866, a fianco del Re con la
Prussia verso l'Austria. Anche in questa occasione i suoi volontari furono
armati all'ultimo e combatterono nel Tirolo( due battaglie Suello e Bezzecca e
Garibaldi fu ferito ad una coscia) . Guerra che fu un drammatico fallimento.
L'umiliazione italiana fu completata dalla Prussia , che firmò un armistizio
separato con l'Austria. L'Austria cedette il Veneto alla Francia che lo
consegnò all'Italia e mantenne per sé il Tirolo. La guerra venne vissuta come
un disastro nazionale per la pessima prestazione militare . Ci fu una rivolta a
Palermo. Con questa guerra emerge nella sfera pubblica un malcontento
morale rispetto alla nazione italiana. Garibaldi accettò la pace( telegramma al
re “ obbedisco”) e si ritirò a Caprera .Il governo cadde nel 1867; poi venne
formato un esecutivo giudato da Rattazzi.
L'attenzione di Garibaldi e del governo si rivolse ora a Roma. Nel 1864 con la
Francia fu stipulata la “convenzione di settembre” L'Italia si impegnava a
spostare la capitale da Torino a Firenze e di mantenere l'indipendenza dello
stato pontificio.
La Francia di Napoleone III acconsentiva a ritirare entro un certo termine le
truppe poste a difesa di Roma. L'accordo fu impopolare e ci furono proteste
di piazza. Il governo Rattazzi insieme al Re elaborò un piano in cui Garibaldi
avrebbe dovuto invadere i territori pontifici. Garibaldi riprese l'attività politica.
Da Firenze fece un giro trionfale per Bologna, Rovigo e poi Venezia. In
questa occasione fece una serie di discorsi anticlericali. Suo figlio Ricciotti
raccolse soldi in Gran Bretagna per finanziare la campagna per Roma.
Ricevette parecchi sostegni. Era praticamente pronto per attaccare quando il
Re o Rattazzi , per la pressione di Napoleone III, lo fermarono ed egli venne
riportato a Caprera. Ora si puntava a provocare un'insurrezione popolare nei
territori pontifici, per non violare gli accordi e per avere come scusa per
l'intervento armato. Il 3 novembre in un primo scontro a Mentana , Garibaldi
ottenne una vittoria. L'arrivo dei rinforzi francesi cancellò i vantaggi, poiché
avevano nuovi fucili “chassepot”, capaci di fuoco a ripetizione e a lunga
distanza. Garibaldi uscì sconfitto e fu rinchiuso nella fortezza di Vanigrado.
Mentana mise in evidenza il fallimento della nuova Italia.
Da allora Garibaldi non si fidò più del Re e di Rattazzi e divenne apertamente
critico della monarchia e del sistema politico dell'Italia liberale. Si ritirò a
Caprera per tre anni Il triennio 1870 -1871 fu un importante punto di svolta
del diciannovesimo secolo.
La Germania stava emergendo come potenza dominante dell'Europa
continentale .
La conquista di Roma nel 1870 annullò le tensioni tra l'opposizione
parlamentare legale e la sinistra estrema. La Comune parigina nel 1871
spinse esponenti politici della sinistra a due diverse fazioni: socialista e
antisocialista. Garibaldi ruppe con Mazzini che era per una sinistra
antisocialista e si avvicinò ai giovani radicali per entrare di nuovo nella vita
politica. Si incontrarono tutti i democratici al teatro Argentina dove si discusse
sul suffragio universale, obbligatorietà e laicità dell'istruzione,imposte, riforma
amministrativa, abolizione della pena di morte. Venne firmato il “patto di
Roma “ .Garibaldi scrisse un documento di taglio anticlericale e anti
mazziniano. Continuò la sua attività politica e sociale e nel 1880 si espresse
pubblicamente per il suffragio universale. All'inizio di Giugno morì nel suo
letto per un'infezione ai bronchi . Voleva essere cremato e aveva detto ai suoi
familiari di comunicare la notizia a cerimonia avvenuta . Nelle istruzione che
lasciò per il funerale si riflette la sua sensibilità di stampo romantico. Vale
ricordare che fino la 1888 la cremazione non era consentita. Ci fu il funerale e
molte processioni funebri per tutta Italia . Le prime pagine sui giornali listate a
lutto e nei Municipi le bandiere esposte a mezz'asta , discorsi su discorsi. La
morte di Garibaldi venne considerata l'apoteosi della sua vita : ci fu lotta per il
controllo della sua immagine.
LA POLITICA DELLA MEMORIA
È ormai luogo comune affermare che all'indomani dell'unità d'Italia i
governanti italiani dovettero “fare gli italiani.” Fu Crispi ad utilizzare Garibaldi
per promuovere il proprio programma nazionalista e tentò di trasformarla in
simbolo sacro dell'unità nazionale. Tuttavia la cultura italiana restò piuttosto
locale e regionale. Garibaldi ebbe molta fama durante gli anni 1860-1870. Fu
in questo clima di radicalismo politico e religiosità popolare che Garibaldi si
spense. Il suo funerale a Caprera rappresentò una vittoria dell'ufficialità laica.
Il principale obiettivo delle polemiche garibaldine in questi anni fu però la
Chiesa. Al tentativo di Garibaldi di fare gli italiani e di creare una religione
civile il cui codice etico potesse prendere il posto di quello del cattolicesimo, i
nazionalisti italiani non parlarono però in modo concorde. I romanzi di
Garibaldi non ebbero particolare successo (Clelia, I Mille, Manlio). Anche la
sua morte fu vista in maniera diversa: ovviamente non per tutti era un eroe.
LE <ROME> RIVALI
Oltre ai radicali, anche la Chiesa era contro lo Stato italiano, molti addirittura
continuarono a seguire l'indirizzo del “non expedit.” In quel periodo il Papa
assunse un atteggiamento più aggressivo verso il mondo liberale. Pio IX
rappresentò un nuovo modo di intendere la figura del Pontefice, più
personale e meno regale. Pio IX fu il primo pontefice ad essere fotografato.
La Roma papale era sempre stata ostile a Garibaldi, e dopo Mentana, attaccò
la sua reputazione. Per la stampa Cattolica tutti i nazionalisti erano pericolosi
e così veniva alimentata sulla contrapposizione tra civiltà cattolica e barbarie
rivoluzionarie. La stampa cattolica lo attaccavaimputandogli mancanza di
capacità militare e pochezza delle sue realizzazioni. Quanto alla reputazione
criminale di Garibaldi non vi era dubbio che corrispondesse in parte al
vero(brigante che cospirava e guerreggiava). Dopo la morte di Pio IX sembrò
aprirsi la possibilità di nuovi rapporti tra Stato e Chiesa.
La vita di Garibaldi ha avuto un grande valore politico e simbolico. Garibaldi e
i suoi compagni radicali affermano di rappresentare la vera anima del
Risorgimento e si appropriano del suo sistema simbolico. Identificavano la
Chiesa come nemico della nazione e attribuivano colpe pure al governo.
Anche la Chiesa combatté per entrare nel cuore degli italiani. La battaglia per
inventare i simboli ufficiali dell'identità nazionale fu un testa a testa tra Vittorio
Emanuele e Garibaldi, e poi tra loro stessi ed il Papa. Garibaldi utilizzava una
miscela di elementi laici e religiosi per far presa sull'emotività popolare.
L'Italia è sempre stata considerata uno stato debole. Ciò è dovuto al fatto che
chi perdeva cercava di denigrare i successi dei vincitori. Un simile
atteggiamento provocava un contrasto insormontabile tra la visione poetica
dell'identità nazionale e la prosaica e deludente realtà dei governi italiani.
L'Italia non fu una Nazione riuscita e fu politicamente divisa. Il successo di
Garibaldi rimane circoscritto, secondo Lucy Riall, alle sue capacità di
introdurre il linguaggio patriottico nel dibattito politico e alla grande attitudine
a suscitare entusiasmo e coinvolgimento politico.
(Caterina Alzetta
Jessica Campanerut)
2.CAVOUR
Attraverso una documentata e ampia biografia,lo storico Adriano Viarengo
illustra la figura di Camillo Benso, conte di Cavour, uno dei padri della patria,
protagonista del Risorgimento come sostenitore delle idee liberali, del
progresso civile ed economico, dell’anticlericalismo, dei movimenti nazionali
e dell’espansionismo del Regno di Sardegna ai danni dell’Austria e dello
Stato Pontificio. L’autore raccoglie notizie su Cavour attingendo dai giornali
dell’epoca e dai diari di Cavour al fine di realizzare un quadro completo del
nobile piemontese, nato in realtà francese poiché il Piemonte nel 1810 era un
département dell'impero napoleonico. Vengono sottolineati l'atteggiamento
autoritario, le aspirazioni verso il cambiamento ma anche le incertezze del
personaggio, che comunque si mostrò un modello di intelligenza dal punto di
vista politico, di saggezza e di intuito, dotato di passione politica ma anche
freddo e distaccato quando le circostanze lo richiedevano. Ebbe un ruolo di
primissimo piano nella formazione e nella proclamazione del regno d' Italia
nel 1861, anno in cui divenne il primo Presidente del Consiglio del nuovo
Stato.
Iniziò la sua carriera politica come ministro dell'Agricoltura (1850), in un primo
momento, per poi ricoprire l' incarico di ministro delle Finanze, durante il
governo di Massimo d'Azeglio, allora capo del governo sabaudo. Cavour, in
questo ruolo, favorirà lo sviluppo economico del Piemonte, consolidando la
politica del libero scambio. Tra le sue prime decisioni ridusse le tariffe
doganali, ampliò e migliorò il funzionamento delle linee ferroviarie, annullò
alcuni antichi privilegi signorili e si occupò della creazione di istituti e scuole.
In seguito alla caduta del governo d' Azeglio (1852), Cavour abbandonò
l'alleanza con la destra e, nello stesso anno, strinse un' alleanza (“connubio”)
con il leader della sinistra riformista Urbano Rattazzi, al fine di accelerare il
progresso economico e civile. Trasformò il regime politico piemontese da
costituzionale a parlamentare, potenziò le infrastrutture e l' attività agricola.
Per quanto riguarda la sua politica in campo religioso scelse una linea di
laicità e di separazione tra Stato e Chiesa (libera Chiesa in libero Stato).
Dopo la guerra di Crimea e i moti del 1848 Cavour acquistò la stima di molti
mazziniani, i quali cominciavano a condividere le posizioni moderate da lui
sostenute, sperando così di raggiungere più facilmente l' unità nazionale.
Cavour, tuttavia, inizialmente, progettava la sola liberazione della Lombardia
e l' espansione del Regno di Sardegna verso le regioni padane.
AL POTERE
1-nella crisi del dopoguerra: Cavour non sedette alla Camera dei deputati
nella seconda legislatura; tuttavia fu eletto consigliere comunale della
capitale, Torino. Si occupò, quindi, della vita amministrativa, più che politica.
Venne poi invitato a entrare nella delegazione del governo nato dopo la
sconfitta di Novara (1848), ma egli, non avendo ottenuto il permesso di
condurre i negoziati a suo modo, decise di rinunciarvi. Una volta tornato alla
Camera dovette affrontare due problemi; uno riguardante l' approvazione del
trattato di pace con l' Austria, e l'altro riguardante il risanamento delle finanze.
L' unica soluzione possibile da attuare sembrava essere il ricorso alla
diplomazia e con essa la creazione di una rete di alleanze internazionali. La
situazione del Regno era agli occhi di Cavour “ grave e piena di pericoli”.
Nelle sue previsioni, infatti, ci sarebbe stato un “ temporaneo trionfo del
dispotismo e una battuta d' arresto nella marcia della civiltà”. In seguito
Cavour dovette affrontare alla Camera la discussione riguardante la fusione
tra la Banca di Torino e quella di Genova, che tuttavia non ebbe luogo a
causa dell'opposizione liberaldemocratica di Lorenzo Valerio. Quest' ultimo,
infatti, affermava che si sarebbe creato un monopolio se tutti i capitali si
fossero concentrati unicamente nelle mani di poche persone.
Un semi-colpo di stato? Il proclama di Moncalieri: nel 1849 venne firmato,da
Vittorio Emanuele secondo il proclama di Moncalieri, con il quale egli fece
appello agli elettori del Regno di Sardegna, affinché portassero in parlamento
una maggioranza favorevole alla ratifica del trattato di pace con l'impero
austriaco, alla quale la Camera si opponeva. D'Azeglio voleva, infatti ,
cogliendo l' occasione, sbarazzarsi di una Camera riottosa. Cavour era
preoccupato per la situazione, e credeva che si sarebbe arrivati all'anarchia,
ma soprattutto aveva il timore di un colpo di Stato. Non nutriva, infatti, alcuna
fiducia nel nuovo sovrano. In realtà non avvenne un colpo di Stato; il re,
tuttavia, riuscì nel suo intento e venne raggiunta la nuova maggioranza, da lui
agognata.
Una volta al governo il conte cambiò la sua posizione, inizialmente
conservatrice in una posizione più aperta. Pensò che fosse necessario
conquistare la fiducia della Camera per godere di un più vasto sostegno
politico, sostegno che avrebbe ottenuto solo allontanandosi dai conservatori.
Riuscì, quindi, a separarsi definitivamente dalla Destra, adottando una
politica riformatrice, accettata dal Centro e condivisa dalla Sinistra. Diventò il
leader indiscusso del “Centro-sinistro”. Lo statista piemontese più volte pose
l'accento sulle condizione finanziarie dello Stato e si fece notare per le sue
capacità di analisi, per la sua fede nel progresso, per le sue conoscenze e
per le sue idee liberali, che lo portarono ad ottenere, seppure con grandi
esitazioni, il Ministero di Agricoltura, Commercio, e quello della Marina. Il suo
principale obiettivo rimasero, comunque, le Finanze.
Il ruolo di Cavour era rilevante all'interno del governo e poteva contare su un
buon livello di favore nell'opinione pubblica.
Nei suoi piani c' era l' esigenza di dare una spinta all'economia del Paese
attraverso i prodotti locali più appetibili, quali il riso e la seta e ottenendo
facilitazioni all'importazione di macchinari e manufatti dall'estero. Era,
pertanto necessario, secondo la visione di Cavour, agevolare il libero
scambio e attivare politiche liberiste. Bisognava anche consolidare le
infrastrutture, ferrovie, strade, canali al fine di favorire il commercio. Lo scopo
era quello di restituire slancio alla vita economica, per potere avere un flusso
di risorse nelle casse dello stato, che consentisse altri investimenti. Con
maggiori possibilità economiche si sarebbe potuto anche potenziare l'
esercito, facendo in modo che il regno sabaudo potesse conservare il suo
prestigio. Cavour, allora, pensò di reintrodurre alcune imposte dalle quali
ricavare i fondi necessari. L'imposta fondiaria doveva essere posta al centro
del sistema. Rinnovò, quindi, il sistema fiscale basandolo non solo sulle
imposte indirette ma anche su quelle dirette, che colpivano sopratutto i grandi
redditi. Inoltre egli si occupò di stipulare trattati commerciali con numerosi
Stati europei. Con la Francia, però, non ottenne risultati vantaggiosi, in
quanto questa nazione era poco favorevole alla collaborazione con il
Piemonte. Mentre con il Belgio, l' Olanda e altri stati esteri ( Portogallo,
Inghilterra, Svezia, Norvegia, Austria) vennero stipulati numerosi trattati e
accordi. Contemporaneamente avvenne una riduzione delle tariffe doganali
del regno. Per far fronte ai problemi di carattere finanziario, Cavour pensò di
servirsi di “alcune operazioni di credito interno” e ad “una operazione da farsi
all'estero, preferibilmente in Inghilterra”.
La mossa vincente: il “connubio”. Nel 1852 si decise di stipulare un accordo
politico segreto, anche se ostacolato dal Presidente del Consiglio del
Centrodestra allora in carica, D’Azeglio, tra Cavour, leader della destra
moderata, e Urbano Rattazzi, leader del centrosinistra. Allo scopo di attuare
una politica liberal- riformista e di formare insieme una nuova maggioranza. L’
ambizione di Cavour era quella di prendere le redini del governo, ma gli
occorreva la maggioranza che trovò proprio nell’alleanza con il suo
avversario. L’ accordo con Rattazzi avvenne tramite gli uomini di fiducia dei
due protagonisti, l’ avvocato Castelli per Cavour e il deputato Buffa per
Rattizzi. Per entrambe le forze politiche questa unione avrebbe portato dei
vantaggi; infatti, mentre Cavour puntava all’incarico di capo del governo,
Rattazzi mirava alla vicepresidenza della Camera. In seguito al “connubio”,
che durò cinque anni, D’Azeglio si dimise e Cavour poté prendere il suo
posto. Una volta al potere costituì il suo primo Ministero, con Rattazzi
vicepresidente.
Presidente del Consiglio. Quando d’Azeglio, il 22 ottobre 1852, diede le
dimissioni, Vittorio Emanuele secondo propose a Cavour di formare un nuovo
governo, a condizione che il conte negoziasse con lo Stato Pontificio alcune
questioni rimaste aperte, come quella dell’introduzione in Piemonte del
matrimonio civile. Cavour, dopo alcune esitazioni, e dopo aver indicato
Cesare Balbo come valida alternativa, accettò di formare il nuovo governo,
dato che Balbo non prese il posto di D’Azeglio. Si impegnò a favore del
matrimonio civile, che però fu respinto al Senato, costringendo il conte a
rinunciarvi. Una volta capo del governo valorizza e modernizza l’agricoltura
grazie all’uso dei concimi chimici e ad una vasta opera di canalizzazione,
destinata ad eliminare le frequenti carestie, dovute a mancanza d’acqua per l’
irrigazione , e a facilitare il trasporto dei prodotti agricoli; l’industria viene
irrobustita attraverso la creazione di nuove fabbriche e il potenziamento nel
settore tessile; il commercio è basato sul libero scambio interno ed estero;
rinnova il sistema fiscale, provvede inoltre al potenziamento delle banche con
una istituzione della “Banca Nazionale” per la concessione di prestiti a bassi
interessi. In seguito Cavour si preoccuperà di fare uscire il Piemonte
dall'isolamento, impegnandosi in una politica estera più aperta e dinamica.
Con l’inizio del nuovo governo di Cavour, quattro ministri su sei rimasero
quelli del precedente governo dell’Azeglio; tutti, comunque, di orientamento
liberale moderato. Le principali questioni a cui Cavour doveva far fronte
riguardavano, oltre al matrimonio civile, il bilancio dello Stato. La politica, già
intrapresa, di riduzione dei dazi e la costruzione delle infrastrutture ( allargò la
rete ferroviaria ) rendevano la situazione tutt’ altro che rosea: le uscite
riprendevano a crescere, mentre le entrate si incrementavano di poco.
Cavour decise di chiedere un consistente prestito, nuovamente al barone di
Rotschild. Vennero rialzate le imposte e vennero toccati anche i ceti meno
abbienti, per quanto riguarda i beni alimentari di prima necessità. Nonostante
le molte questione sulle quali doveva lavorare il conte, almeno inizialmente
non trovò forti opposizioni, anzi affermò di notare “presso tutti i partiti una
condiscendenza che rende il mio compito meno difficile”.
1853. Un anno complicato. Nel 1853 Cavour si trovò ad affrontare la sua
prima crisi nel campo della politica estera. Infatti, il movimento repubblicano
che faceva capo a Giuseppe Mazzini non smetteva di preoccupare Cavour: il
6 febbraio del 1853 scoppiò una sommossa contro gli austriaci a Milano e il
conte, temendo l’allargarsi del fenomeno al Piemonte,fece arrestare diversi
mazziniani. Tale decisione gli attirò l’ostilità della sinistra. Nel frattempo si era
sviluppata una vera e propria crisi europea scaturita da una disputa religiosa
fra l’ Impero Ottomano, in declino, e la Russia, con a capo lo zar Nicola, che
aspirava alla protezione dei cristiani fra le popolazioni turche dei Balcani.
Queste aspirazioni provocarono l’ostilità del governo inglese che sospettava
che la Russia volesse conquistare Costantinopoli e la Francia si schierò con
la Gran Bretagna. Allora la Russia dichiarò guerra all’ impero ottomano e la
Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla Russia. Cavour affermò
che il Regno di Sardegna sarebbe intervenuto nella guerra se anche l’ Austria
avesse attaccato la Russia. Nel 1855 il conte firmò l’adesione finale del
Regno di Sardegna al trattato anglo-francese. Il Piemonte avrebbe fornito
supporto militare e le potenze alleate avrebbero garantito la protezione del
Regno di Sardegna nel caso di un eventuale attacco austriaco.
Una speranza da Oriente. In seguito ai contrasti tra Impero ottomano e
Impero russo, la regina Vittoria dichiarava ufficialmente guerra alla Russia,
dopo pochi giorni anche Napoleone terzo e il regno di Sardegna si unirono
all’impresa, lasciando la Russia priva di alleati, durante la guerra di Crimea. Il
4 marzo 1855 Cavour dichiarò guerra alla Russia e il 25 aprile il contingente
piemontese salpò da La Spezia per la Crimea. La partecipazione alla guerra
di Crimea, vittoriosa per gli alleati e che ebbe fine nel 1856 con il Congresso
di Parigi, permise a Cavour di partecipare l’anno successivo alla conferenza
di pace di Parigi, ponendo tra gli argomenti in discussione la situazione
italiana. Gli accordi segreti siglati successivamente a Plombierès, stipulati tra
l’imperatore Napoleone terzo e Cavour, nel 1858 garantirono al Piemonte
l’appoggio della Francia nella lotta contro l’Austria. L’ultimatum inviato nel
1859 dal governo austriaco al Piemonte fu l’occasione per far scoppiare il
conflitto che si concluse con l’armistizio di Villafranca che prevedeva
l’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna, in cambio della rinuncia
ad ulteriori espansioni territoriali. Cavour sollecitò il re a continuare la guerra
anche senza l’appoggio dei francesi, ormai ritiratisi dal conflitto, ma, nel 1859,
di fronte al rifiuto di Vittorio Emanuele secondo, il primo ministro si dimise. Fu
rimpiazzato per breve tempo dal ministero La Marmora - Rattazzi e poi venne
richiamato al potere. Pochi giorni dopo i plebisciti dichiararono l’annessione
dell’Emilia e della Toscana al Piemonte.
Tra Roma e Sebastopoli. La guerra di Crimea si concluse con un anno di
assedio a Sebastopoli. La Russia venne sconfitta e Sebastopoli, importante
città russa, venne presa dagli alleati. Il governo Cavour, nel 1854 presentò
alla Camera una legge anticlericale sui conventi. Si opponevano, però, il
Senato Subalpino e il re Vittorio Emanuele secondo. Scoppiò in quel periodo,
nel Regno di Sardegna, la crisi Calabiana, così chiamata dal nome del
vescovo Luigi di Calabiana, oppositore della legge, il quale provocò le
dimissioni di Cavour nell’aprile del 1855. Il conte però, dopo un breve
periodo, riprese la carica di presidente del Consiglio. E riuscì ad accordarsi
con il Senato e a far passare la norma che fu firmata dal re con un
emendamento che lasciava i religiosi nei conventi fino all’estinzione naturale
delle loro comunità. In risposta Papa Pio nono scomunicò tutti coloro che
avevano permesso l’approvazione della legge, compresi Cavour e il re
Vittorio Emanuele.
In conclusione possiamo affermare che senza la forte personalità di Cavour
non saremmo giunti alla proclamazione del Regno d'Italia. Nel 1861, anno in
cui il presidente del Consiglio morì, l'Italia era stata “fatta” ed egli era riuscito
nei suoi obiettivi sia sul piano del progresso economico e politico della
nascente nazione, sia sul piano della politica religiosa. Se infatti in economia
si era fatto promotore, con buoni esiti, del libero-scambio, nella politica aveva
portato avanti riforme liberali. Fu in grado di sostenere, nel suo sviluppo, il
Regno di Sardegna, dal punto di vista delle istituzioni, dell'agricoltura, dei
commerci e dell'industria. Si occupò inoltre del rapporto tra lo Stato e la
Chiesa, in quanto fece una distinzione tra le due istituzioni, secondo la
formula "libera Chiesa in libero Stato".
(Delia Piazza)
3.GIUSEPPE MAZZINI
Giuseppe Mazzini nacque a Genova nel 1805 da Giacomo e da Maria Drago,
donna austera e religiosissima.
Si laureò in Giurisprudenza nel 1827 ma, mentre era ancora studente,
cominciò a sentire con viva sensibilità il problema dell’Italia divisa ed
assoggettata allo Straniero.
Iniziò allora la sua collaborazione con l’ “Indicatore Livornese” e con l’
“Indicatore Genovese”, presto soppressi perché di ispirazione chiaramente
patriottica.
In quegli anni aderì anche alla Carboneria, ma si rese presto conto che la
Carboneria con i suoi strani riti, il carattere misterioso limitato e settario non
avrebbe in alcun modo potuto risolvere le questioni italiane.
Arrestato nel 1830 come cospiratore, fu rinchiuso nel carcere Priamar di
Savona e, in seguito, condannato all’esilio. Arrivato a Marsiglia dopo un breve
soggiorno a Ginevra, Mazzini fondò la “Giovine Italia”, un’associazione che si
proponeva la liberazione dell’Italia dallo straniero e la sua unità in una
repubblica democratica.
A questo movimento aderirono moltissimi patrioti italiani, appartenenti
soprattutto alle classi medio alte, come professionisti, intellettuali e studenti,
che portarono il fresco entusiasmo della loro giovinezza.
Primo atto politico dell’esule genovese fu il messaggio al nuovo re di
Sardegna, Carlo Alberto, con cui il giovane sovrano veniva invitato a porsi a
capo del movimento nazionale di riscossa, facendo così ammenda al suo
comportamento ambiguo del 1821.
Carlo Alberto ignorò la lettera e Mazzini proseguì decisamente la sua
propaganda rivoluzionaria promovendo la congiura di Genova nel 1833 e la
spedizione della Savoia nel 1834, concluse entrambe con un fallimento.
Mazzini, infatti, si andava sempre più convincendo che l’unico modo per
liberare l’Italia dallo Straniero era quello di organizzare delle insurrezioni
isolate, a macchia di leopardo che potessero sorprendere le guarnigioni
militari nemiche, obbligandole a spostarsi e a dividersi per poterle
fronteggiare.
Questo, naturalmente, fidando sull’ardimento e sulla fede patriottica degli
insorti, in grado di sconfiggere truppe meglio armate ma scarsamente
motivate.
Condannato a morte in contumacia in seguito a questi primi moti, fu costretto
a riparare in Svizzera dove, rinchiuso nella sua piccola camera di Berna,
fondò la “Giovine Europa”. L’idea di un’Europa unita in una Confederazione,
sul modello degli Stati Uniti d’America, cominciò ad essere il principale dei
suoi pensieri e avrebbe dovuto nascere dall’unione delle varie Congreghe
nazionali, con un solo motto ed un solo simbolo comune: l’edera.
Trovò rifugio in seguito in Inghilterra, dove cercò di propiziarsi i favori del
governo inglese e di alcuni banchieri per finanziare tutti i moti insurrezionali
che aveva intenzione di promuovere in Italia e che, purtroppo, tristemente
naufragarono.
Se ne possono ricordare alcuni che passarono alla storia perché, pur finiti
miseramente nell’insuccesso, misero in luce il coraggio e l’eroismo dei
partecipanti.
1) Il 13 giugno 1844 i fratelli Attilio ed Emilio Bandiera nati a Venezia ed ex
ufficiali della flotta austriaca, con uno sparuto gruppo di compagni, tra cui
Nicola Ricciotti e Domenico Moro, sbarcarono sulle coste calabre alle foci del
Neto. Non sapevano di essere stati preceduti dalla delazione di Domenico De
Nobili ed, in seguito, dal tradimento del corso Pietro Boccheciampe. Furono
perciò subito catturati dalle forze borboniche a cui si era aggiunto un gruppo
di contadini locali che li avevano scambiati per briganti: ne seguì la condanna
a morte e la successiva fucilazione.
2) Nel 1850 un movimento insurrezionale, sorto in Mantova, si accentrò
intorno alla figura del prete Enrico Tazzoli. Ne fecero parte Carlo Poma, Attilio
Mori, Giovanni Acerbi ed moltissimi altri. Il movimento si avvaleva
finanziariamente del prestito mazziniano gestito da Banche inglesi. Furono
arrestati nel 1852 gli affiliati, il prete Giovanni Grioli e Luigi Pesci, nelle cui
case vennero ritrovati documenti che portavano all’illustre esule genovese.
Furono fatti prigionieri molti cospiratori tra cui lo stesso Tazzoli, Carlo Poma e
Tito Speri. Vennero processate 110 persone di cui molte condannate a morte.
Furono impiccati nel forte di Belfiore una trentina di cospiratori tra cui Tazzoli,
Poma, Speri e da ultimo Calvi, che la Storia ricorda col nome “Martiri di
Belfiore”.
3) Il 6 marzo 1853 alle cinque del pomeriggio, ultima domenica di carnevale,
un gruppo di uomini armati penetrò nel palazzo reale di Milano dal portone di
via Rastrelli e, senza incontrare alcuna resistenza, si gettò sulle rastrelliere
delle armi e disarmò le poche sentinelle presenti. Era giorno di libera uscita,
di baccanali, di feste e Mazzini che aveva tessuto da Lugano le fila
dell’insurrezione, pensava che la popolazione milanese si sarebbe unita agli
insorti nel ricordo delle eroiche “Cinque Giornate” del 1848. Ma la
popolazione quasi non si accorse di quanto stava avvenendo perché dei
quattrocento insorti preventivati per l’attacco alla guardia del palazzo reale
solo 20 si presentarono al raduno. Benché troppo pochi rispetto alle
aspettative del Mazzini, riuscirono a disarmare e a rinchiudere gli sbigottiti
Austriaci e a impadronirsi di due cannoni abbandonati. Ma i cannoni
mancavano di munizioni e, comunque, nessuno degli insorti era in grado di
farli funzionare. Le sentinelle rinchiuse in uno stanzone sfondarono la porta
con il calcio di un fucile trovato in un angolo e riuscirono a liberarsi.
Intervennero anche alcuni ufficiali austriaci che stavano seduti nel bar di
fronte insospettiti dallo strano trambusto; sguainata la spada uccisero alcuni
dei rivoltosi e misero in fuga gli altri. Neppure l’attacco al castello sforzesco
ebbe esito migliore. Dei 500 previsti solo 30 uomini risposero all’appello.
Fallirono ugualmente gli assalti organizzati al comando generale austriaco di
Via Brera e ai corpi di guardia di Porta Vigentina e di Porta Ticinese. Tutto si
risolse in una serie di piccoli scontri, in sporadiche scaramucce, in atti di
valore, spesso di disperazione, slegati l’uno dall’altro. Invano Mazzini
aspettava da Lugano la notizia del successo. Le sue illusioni si sarebbero
frantumate in poche ore. Aveva creduto di disporre di 10.000 uomini, ma solo
poche centinaia erano scese per le strade. Aveva creduto che gli insorti
disponessero di fucili ed esplosivi, che avrebbero dovuto arrivare da Londra
in casse che portavano la scritta “strumenti musicali” ma, al momento dello
scontro si vide solo qualche pugnale ed alcuni coltelli da cucina. Aveva
pensato alle barricate come nelle gloriosissime “Cinque Giornate di Milano”
del 1848 e il tutto si era risolto in due tavoli da osteria posti sulla strada ed
una carrozza rovesciata. Mazzini recitò il mea culpa, si dichiarò
completamente responsabile dell’insuccesso, ma questo non impedì al
maresciallo Radetzky una reazione durissima e spietata. Dopo questo evento
molti seguaci abbandonarono Mazzini per passare nelle file dei liberali moderati. Eppure quella insurrezione così tragica e sfortunata, che innescò
misure di eccezionale rigore da parte del governo austro-ungarico
(coprifuoco, contribuzioni forzate, sequestri arbitrari, sfratti indiscriminati) finì
per favorire i piani di Cavour. Lo statista infatti non avrebbe potuto arrivare
all’alleanza con Napoleone III senza potersi avvalere, sia del contributo dato
dalle truppe piemontesi nella guerra di Crimea, sia di fare leva anche sulle
condizioni disperate in cui si trovava ormai il Lombardo - Veneto.
4) Carlo Pisacane ex ufficiale borbonico trasferitosi in Francia per motivi
familiari ed in seguito arruolatosi anche nella legione straniera, concordò col
Mazzini uno sbarco in Italia meridionale. Imbarcatosi nel 1857 sulla nave
Cagliari con un seguito di circa 30 uomini avrebbe dovuto ricevere in mare le
armi da Rosolino Pilo; ma quest’ultimo mancò una prima volta
All’appuntamento perché, a causa della bonaccia non era riuscito a navigare
e una seconda volta perché, a causa della tempesta, aveva dovuto disfarsi
delle armi e rientrare in porto. Pisacane non si scoraggiò e ritentò l’impresa:
liberò a Ponza 300 prigionieri politici, rinchiusi in quel carcere, e con questi
unitisi a lui sbarcò a Sapri. Di qui marciarono verso l’interno ma le truppe
borboniche, che nel frattempo erano state avvertite, li massacrarono. Lo
stesso Pisacane ed il suo luogotenente Falcone per non cadere nelle mani
del nemico si uccisero.
Questa è l’ultima impresa di stampo insurrezionale che si ricordi e come le
altre fu stroncata duramente dai giornali inglesi e francesi che invece
avrebbero esaltato tre anni dopo l’impresa di Garibaldi e delle sue 1000
camice rosse in Sicilia.
Ora viene spontaneo chiedersi: ma chi era veramente Giuseppe Mazzini?
Ci viene in aiuto Giovanni Spadolini, storico e politico dell’Italia del dopo
guerra, convinto repubblicano militante dal 1972 nel PRI di Ugo La Malfa.
Spadolini nel suo libro “Gli uomini che fecero l’Italia” ci ricorda le lezioni che
Francesco De Sanctis, famoso critico della Letteratura Italiana, tenne
all’università di Napoli nel 1974. Mazzini fu giudicato da De Sanctis “Il Mosè
dell’unità”. Nel caso concreto non fu Mazzini, ma la monarchia sabauda a
realizzare l’unità d’Italia perché aveva saputo meglio calarsi nella realtà del
momento storico.
Mazzini fu un profeta o meglio un precursore, uno dei tanti uomini di valore i
quali, seppero individuare linee dell’avvenire.
Mazzini fu un apostolo, un sognatore, un illuso che si pose il problema
dell’unità d’Italia come una missione.
Due schieramenti politici prevalevano allora in Italia: la scuola democratica
che faceva capo a Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo e ad Aurelio Saffi e la
scuola liberal–moderata che aveva fra i suoi rappresentanti Massimo
d’Azeglio, Cesare Balbo e Vincenzo Gioberti.
Anche i sistemi per raggiungere l’obiettivo: i democratici privilegiavano le
azioni insurrezionali con l’unico scopo di raggiungere l’indipendenza, l’unità e
la repubblica, rimandando ad un periodo successivo le riforme sociali
necessarie per andare incontro ai bisogni delle classi più indigenti; i liberal–
moderati pensavano invece di procedere per gradi partendo dal presupposto
che non vi potesse essere libertà senza che fosse raggiunta l’uguaglianza tra
tutti i cittadini. La repubblica che si proponeva di realizzare Mazzini si fondava
anche su una profonda rinnovazione religiosa, che tenesse unite le coscienze
in una unione politico-religiosa. Dopo l’impresa dei mille e l’atto di
sottomissione di Garibaldi a Vittorio Emanuele II a Teano, con cui il sovrano
sabaudo venne praticamente incoronato re d’Italia, a Mazzini non rimase che
cercare di avvicinarsi a quelle classi diseredate che aveva inizialmente
trascurato: erano questi gli artigiani, gli operai e i contadini che avrebbero
dovuto legarsi in un movimento per sfociare col tempo in una forma di
laburismo di tipo inglese.
Questa sua ultima presa di posizione gli valse la critica e gli insulti di Marx e
di Engels, che nei loro scritti lo avevano diffamato per anni, non limitandosi
ad attaccare la sua dottrina ma proponendosi di colpire l’uomo. “Lanciare
mine contro Mazzini” era il loro motto e, nel loro linguaggio, il grande
genovese diventò l’”Arrogante Teopompo” e lo “Scaltrito Fanatico”.
Ma si avvicinava per Mazzini l’epoca del tramonto: ospite degli amici Nathan
a Lugano rielaborò le sue teorie messe a punto nella creazione della “Giovine
Europa”, come un’unione federale degli stati europei, destinata a rinascere
circa un secolo più tardi dopo le rovine prodotte dalla II guerra mondiale. La
nuova Europa di cui Mazzini è stato definito e non solo in Italia, “Il profeta”.
Ma erano prossimi gli anni della fine, consolati, da quanto è dato leggere su “I
Radicali dell’ottocento” di Spadolini dal ricco carteggio di 46 lettere scambiate
con Daniel Stern. In queste lettere dominavano inizialmente gli argomenti
filosofici e letterari ma, in seguito, riemerge l’ansia dell’uomo politico che
vorrebbe rovesciare con una grande partecipazione di popolo la monarchia
sabauda per passare ad una repubblica democratica e liberare Roma con un
decreto dell’Assemblea Costituente. Arrestato sulla nave, che con un
travestimento lo stava portando in Sicilia, dove sperava di mettersi a capo di
un movimento insurrezionale, passò gli ultimi due anni della sua vita a Pisa
ospite sempre dei Nathan, tollerato dal governo italiano sotto il falso nome di
dottor Brown. Qui ebbe la sua ultima delusione, la liberazione di Roma
attraverso la braccia di Porta Pia che egli considerò come una profanazione
delle città eterna. Mazzini morì a Pisa nel 1872 e, cosa che stupì molto gli
italiani, le autorità permisero che il suo feretro percorresse in treno il tratto da
Pisa a Genova fermandosi in ogni stazione. Al suo arrivo nella città della
lanterna il cadavere venne esposto per alcuni giorni, perché tutti potessero
rendergli omaggio. Tutta la città osservò un lutto stretto e le sirene delle navi
ormeggiate nel porto suonarono per un estremo saluto prima che la bara
venisse tumulata nel cimitero di Stalieno.
Profeta e precursore, creatore di formule, animatore di passioni, seminatore
di ideali, ma assolutamente incapace di calarsi nella realtà contingente del
momento storico, Mazzini è stato rivalutato e riconosciuto come colui che
accarezzò per primo l’idea di un’Europa unita.
(Enrico Bocchieri)
4. LE DONNE NEL RISORGIMENTO
Nel terzo volume de “Il Risorgimento” (a cura di L. Villari) Marta Barsanti
traccia un breve profilo sulla condizione della donna nel XIX in Italia e non
solo.
“Il regno della donna è in casa; ivi se son belle, paion più belle; ivi se son
buone, più buone”. Così Cesare Baldo scrisse nel 1854, quasi a sottolineare
che le uniche qualità femminili potessero essere quelle relative alla bontà e
alla bellezza. Infatti la donna durante tutta la prima parte dell'Ottocento fu
tracciata come una figura che non deteneva una propria autonomia; essa
infatti ci viene descritta come una sorta di oggetto vivente, posta in una
condizione di totale dipendenza dall'uomo.
Fin da giovanissime le fanciulle venivano educate ad obbedire ad padri non
solo in quanto tali, ma anche presupponendo che dovessero sempre essere
rispettose nei confronti del sesso maschile.
Costrette alla totale sopportazione al momento dei maltrattamenti fisici e
psicologici, della donna venne esaltata la caratteristica di “angelo del
focolare”: i ruoli di moglie e di madre erano le ambizioni più grandi a cui una
donna potesse aspirare durante la sua esistenza.
La morale borghese ottocentesca imponeva che la donna si realizzasse
pienamente rimanendo fedele al proprio uomo, servendolo e onorandolo;
mantenendo sempre una bontà paragonabile a quella divina.
Eppure la figura femminile, dal punto di vista sociale, era tutt'altro che vicina
ad una divinità. Furono infatti virtù, sensibilità, castità, fedeltà e
predisposizione al sacrificio le uniche caratteristiche che poterono stabilire
quale fosse una donna degna di vita e quale no.
C'è da dire che fu proprio la Chiesa cattolica a promuovere questo ideale per
il quale esse avrebbero dovuto reincarnare tutti i valori morali e accettare
caritatevolmente le trasgressioni affettive e sessuali dei mariti. Abbiamo
oltretutto un'esaltazione del ruolo materno ed un accostamento della donna
procreatrice alla “madre patriottica” che è pronta a sacrificare la propria prole
per la patria.
La subordinazione del gentil sesso venne ulteriormente enfatizzata nel 1865,
anno nel quale venne sancito il Codice Pisanelli, il quale prevedeva
innanzitutto la superiorità della volontà paterna nell'educazione dei figli,
approvava la cosiddetta autorizzazione maritale (che vincolava l'autonomia
femminile) e, infine, sanzionava gravemente l'infedeltà delle mogli.
Quindi ritroviamo le donne in uno status alquanto svantaggiato: non solo
furono penalizzate dal punto di vista pubblico- quindi emarginate nei diritti
civili- ma anche da quello privato.
Si ricordi infatti che, nella marcata distinzione borghese tra sfera pubblica e
sfera privata, il posto della donna era solo ed esclusivamente relegato
all'interno della “domus”.
Un altro punto fondamentale a loro svantaggio fu il regime dotale; infatti se
una famiglia non possedeva un'adeguata dote da “regalare” allo sposo
assieme alla figlia, questo era motivo di grosso disagio per l'ammogliamento
della fanciulla, vista, come era solito, come qualcosa da consegnare ad altri
entro una certa data.
Un'ulteriore discriminazione nei confronti delle donne fu quella dell'accesso
all'istruzione. Come si può immaginare, infatti, sebbene in Italia i tassi di
analfabetismo fossero altissimi anche per gli uomini, il genere femminile era
ancora più svantaggiato in questo campo. Sotto quest'aspetto c'è da dire che
una donna con un libro in mano non era vista di buon occhio, soprattutto
dall'istituzione clericale, che bandì i romanzi perchè considerati
potenzialmente “pericolosi”.
Con questi luoghi comuni ci sembra di tornare all'Antica Grecia. Con una
differenza, infatti nell'Antica Grecia le donne, pur essendo sessualmente e
politicamente svantaggiate, detenevano una certa libertà nella manipolazione
degli uomini e spesso venivano venerate come dee.
Anche nella sfera dell'intimità la condizione delle giovani donne era
caratterizzata da una forte passività, ad esse infatti spettava il compito di
soddisfare gli istinti del marito senza opporsi in alcun modo; non godevano
quindi di alcuna libertà nell'atto sessuale.
Tuttavia la condizione femminile variava a seconda della classe sociale ed
economica a cui si apparteneva e a seconda dell'occupazione che veniva
svolta.
In seguito, più o meno alla fine dell'Ottocento, avvennero dei forti mutamenti
legati all'evoluzione del mondo del lavoro. Infatti abbiamo un inserimento del
gentil sesso nel mondo lavorativo, che prima di allora era riservato solo agli
uomini.
Naturalmente le donne ricevevano una paga bassissima e a causa di ciò
emerse una sorta di “femminilizzazione” del lavoro, in quanto la donna,
avendo un salario più basso assunse un ruolo più competitivo rispetto a
quello dell'uomo. Ovviamente furono molto ristretti i campi in cui la donna
poteva esercitare la propria attività lavorativa: si limitavano infatti
all'insegnamento, al durissimo lavoro nei campi e al settore delle manifatture
tessili. Con lo sviluppo delle occupazioni femminili (di necessità solo per i ceti
più poveri) abbiamo anche un miglioramento della condizione culturale della
donne appartenenti ai ceti più agiati. Queste infatti, sempre verso la fine
dell'Ottocento, ebbero la fortuna di poter avere un'educazione perlomeno
elementare che prevedeva anche lo studio della musica, del pianoforte e
delle regole di comportamento.
D'altra parte, a sottolineare la durezza del lavoro nei campi, è il fatto che le
donne fossero costrette a lavorare anche durante le numerose gravidanze,
con una paga che non bastava per sopravvivere (e che, comunque, andava
sempre a finire nelle mani dei mariti o dei padri). Pochi giorni dopo il parto,
inoltre, era imposto l'obbligo del ritorno alle mansioni. In ogni caso le donne
contadine vivevano per lo più racchiuse in un contesto familiare, al di fuori del
quale la loro identità personale era pressocchè inesistente.
In seguito all'incremento del lavoro femminile abbiamo una modernizzazione
del pensiero e della condizione sociale delle donne, che iniziano a vivere una
graduale emancipazione rispetto alle precedenti continue limitazioni della loro
dignità e della loro persona.
Così, verso la fine dell'Ottocento, nonostante i lavori più diffusi non fossero
per nulla appaganti né ben retribuiti (da ricordare anche l'altissimo tasso di
donne che lavoravano come prostitute, la maggior parte delle quali immigrate
ed analfabete), il panorama generale per esse cominciò a colorarsi di una
sfumatura più rosea. Pur essendo condannate alla subordinazione sociale,
molte donne, soprattutto nei ceti sociali più agiati, si distinsero per la loro
indipendenza, forza psicologica e vivacità intellettuale: caratteristiche per le
quali talvolta fu possibile abbattere il muro tra sfera pubblica e sfera privata, e
che consentirono a queste eroine del nuovo secolo di intraprendere una lotta
per i loro diritti politici e sociali.
Abbiamo grandi donne “rivoluzionarie”, ad esempio, in Anna Maria Mozzoni e
Jessie White, donne che rappresentarono due dei tanti esempi di
cambiamento radicale in una società che non attribuiva alle donne altri scopi
se non quelli di misericordia e procreazione.
Anna Maria Mozzoni si battè per tutta la vita per il diritto femminile al voto,
presentando mozioni al Parlamento italiano nel 1877 e nel 1906, rappresentò
l'Italia al Congresso per i diritti delle donne a Parigi e l'anno seguente fondò a
Milano la “Lega promotrice degli interessi femminili”.
Jessie White si occupò a sua volta non solo dei maltrattamenti femminili, ma
difese anche i diritti di tutti i lavoratori.
È a figure come queste, a mio parere, che l'antica morale borghese e la
Chiesa vollero limitare il potere. Come sempre, nella storia, le istituzioni più
potenti cercarono di ostacolare coloro che avrebbero potuto minacciare
seriamente la loro supremazia e forza: le donne.
(Marta Giannelli)
3. INTERPRETAZIONI
1. ANTONIO GRAMSCI
Antonio Gramsci, nei Quaderni del carcere, effettua una riflessione accurata
sulla storia d'Italia, incentrata sul Risorgimento ma rivolta anche a rintracciare
i caratteri della precedente storia che ha avuto luogo nella penisola italiana.
Ciò gli permette di cogliere gli elementi culturali che hanno avuto una
ripercussione sia positiva che negativa nell'Età del Risorgimento. Per
esempio si sofferma su: 1)Medio Evo o Età dei Comuni in cui si costituiscono
i nuovi gruppi sociali cittadini; 2) l'età del mercantilismo e delle monarchie
assolute che in Italia presentano manifestazioni di scarsa portata nazionale
dal momento che la penisola è sotto l'influsso straniero.
Gramsci attua una lunga meditazione sul processo storico che, nel secolo
XIX, ha prodotto la travagliata costruzione dello stato italiano unitario. A
dirigere questo processo sarebbero state, a suo parere, le forze moderate
mentre il cosiddetto Partito d' azione (cioè il complesso di gruppi e di correnti
che si richiamavano in parte a Mazzini e a Garibaldi) si sarebbe rivelato
incapace di agire in maniera incisiva e trasformatrice nel contesto politico del
tempo. Una “rivoluzione mancata”, ecco come viene definita dallo stesso
autore quella risorgimentale. Le cause di tale fatto storico sono da individuare
essenzialmente in ambito sociale. Il Partito d'azione è rimasto da sempre un
partito borghese di èlite, privo dell'appoggio dei ceti non borghesi, più
schiettamente popolari e contadini. Nell' Italia dell'Ottocento non c'era un
proletariato industriale e dunque era impensabile una classe operaia
organizzata, vista come il solo soggetto sociale in grado di promuovere una
trasformazione radicale della società. Gramsci tuttavia fa trasparire quanto il
Risorgimento avrebbe potuto e soprattutto dovuto allo stesso modo assumere
un carattere più rivoluzionario, garantendosi l'appoggio della classe
contadina.
Proprio i contadini costituivano, infatti, quella massa popolare, di fatto la
stragrande maggioranza della popolazione, la cui partecipazione all' azione
risorgimentale le avrebbe dato un sostanziale contenuto sociale e un
adeguato impulso rinnovatore. Gramsci precisa che il movimento
democratico avrebbe realizzato tale disegno e tale strategia se fosse stato
capace di farsi partito "giacobino", ovvero se avesse saputo far propri gli
interessi e le esigenze della classe contadina attraverso una riforma agraria,
indirizzata verso la creazione di un ceto di contadini piccoli proprietari
ponendo fine al latifondo. Provvedimenti di tale misura infatti, erano già stati
presi dai giacobini francesi, i quali avevano in tal modo evitato l' isolamento
delle città e convertito le campagne alla rivoluzione. Solo così essi erano
riusciti a superare la situazione di minoranza elitaria in cui si erano trovati
inizialmente, e a sconfiggere le forze della reazione aristocratica. Ciò non
vuol dire che l'autore veda il Risorgimento esclusivamente come un processo
storico negativo. In effetti esso ha favorito non solo l' unificazione della
penisola ma anche la crescita della borghesia, gettando con ciò alcune
premesse per lo sviluppo di una fase capitalistica in Italia, poi rivelatasi,
anche essa, insoddisfacente perchè debole e poco incisiva. Inoltre il nuovo
stato si è costituito su una base sia economico sociale sia politica, assai
ristretta. Da una parte il capitalismo (concentrato nelle sole regioni
settentrionali), non ha potuto usufruire di un adeguato mercato per i suoi
prodotti, a causa dell' arretratezza economica della società italiana,
soprattutto meridionale. Dall' altro verso le masse indigenti (in primo luogo i
ceti contadini) essendo state abbandonate sostanzialmente a loro stesse,
non sono riuscite a divenire parte attiva della nuova compagine statuale. I
raggruppamenti politici anche più aperti e democratici, si sono rivelati
incapaci di approfondire i loro legami con le forze sociali potenzialmente
disponibili a un' azione di reale emancipazione. Gramsci che scrive la sua
opera nel carcere a cui è stato condannato dal regime fascista e che
considera questo stesso regime come la dimostrazione più evidente dei limiti
dello stato italiano costituito nel corso del Risorgimento, ritiene necessaria
una profonda trasformazione della realtà italiana che, secondo lui, deve avere
come obbiettivo finale quella rivoluzione sociale (o meglio socialista) che il
Risorgimento non ha saputo compiere. A suo avviso tale rivoluzione potrà
essere fatta solo attraverso un' alleanza tra proletariato settentrionale e
contadini meridionali: essi, infatti, rappresentano gli unici soggetti sociali
interessati in concreto alla realizzazione di un progetto politico così
impegnativo e radicale.
(Enrico Verardo)
2. ROSARIO ROMEO
“Risorgimento e capitalismo” è il frutto dell‟unione di due saggi, “La
storiografia politica marxista” e “Problemi dello sviluppo capitalistico in Italia
dal 1861”.
La storiografia politica del secondo dopoguerra, secondo Rosario Romeo, è
uno dei settori della cultura italiana che più vivamente ha avvertito la svolta
del 1945. Essa fu largamente influenzata da una nuova prospettiva da cui
guardare alla genesi dello Stato italiano, al processo della formazione unitaria
e ai sui suoi legami con il secolare sviluppo della società italiana. Spesso
questo nuovo lavoro interpretativo avvenne in modo assai torbido e
incompleto, facendo derivare la soluzione di problemi specificatamente
culturali da eventi di ordine pratico e politico. Esempi di tali incertezze ci
furono offerti dalle vicende della storiografia politica di tendenza marxista. A
questa ultima l’autore rimprovera lo scarsissimo interesse per periodi più
antichi, precedenti dunque alla Rivoluzione francese e al Risorgimento. In
realtà, la storiografia marxista si prefigura essenzialmente come storia del
Risorgimento e dello Stato unitario. Essa si accentra per lo più intorno alla
tesi del Risorgimento come rivoluzione agraria mancata che va generalmente
sotto il nome di Gramsci. Questa contiene la formulazione della critica alla
borghesia risorgimentale per non aver saputo ampliare il moto nazionale,
mobilitando anche le masse contadine per il rovesciamento e l‟eliminazione
dei residui feudali nelle campagne. Gramsci scorge proprio nella supremazia
dei moderati la causa dell’incapacità del Partito d’azione a svolgere in modo
coerentemente giacobino l’inclusione delle finalità sociali, tuttavia Romeo
sottolinea i gravi problemi storici e metodologici che la tesi comporta. Egli
afferma che questo criterio di giudizio pecca di un fondamentale
anacronismo, non nasce dalla concreta storia del tempo, ma dai più tardi
problemi che allo storico si pongono. Il presupposto di tutta la tesi è
l’esistenza di una struttura contadina mobilitabile per realizzare una
rivoluzione democratica. Nonostante i dati relativi alle insurrezioni e ai moti
contadini che la storiografia ci fornisce, la indubbia esistenza di condizioni di
grandi miseria in gran parte delle campagne, i larghi residui feudali
soprattutto nel Mezzogiorno, la presenza di una popolazione contadina di
oltre quindici milioni nel 1860, l’ alternativa gramsciana rimane fuori della
realtà storica e politica. Infatti pare certo che una rivoluzione agraria e
giacobina in Italia avrebbe provocato uno schieramento antitaliano di tutte le
maggiori potenze europee, interessate alla conservazione sociale e legate a
una visione dei rapporti internazionali profondamente ostile a quel genere di
sovvertimenti. Già Gramsci si era chiesto se in Italia fosse possibile una
rivoluzione di tipo giacobino in mancanza di una “autonomia internazionale”,
quando invece la Francia era da secoli potenza egemonica in Europa.
Tuttavia, a questo proposito, il suo pensiero rimase particolarmente intricato.
Egli affermò che la borghesia italiana, pur non potendo estendere la sua
egemonia sui vasti strati popolari, avrebbe comunque potuto creare
un’atmosfera di azione sui contadini. In questo modo mise il luce un
ambiguità: è singolare che si affermi la possibilità di azione sui contadini dopo
aver negato che si potesse estendere l’egemonia borghese sugli strati
popolari.
Sarebbe stata possibile, inoltre, la creazione di una democrazia rurale
conoscendo le estreme difficoltà di trasformare l’Italia meridionale in un
paese provvisto di risorse tecnico-agrarie adeguate? Una siffatta politica,
sottolinea Romeo, o si sarebbe sviluppata in una generale sollevazione per la
conquista della terra o avrebbe dovuto soccombere, specie nelle zone più
arretrate, alla sopravvivenza della vecchie strutture feudali. La realizzazione
sociale ed economica affermatasi con il Risorgimento rappresenta dunque
una fase storica più arretrata rispetto a quella che si sarebbe raggiunta
attraverso la rivoluzione agraria? In realtà il problema dello sviluppo
capitalistico italiano non può essere identificato né con quello francese, che si
distingue per un andamento delle città e del capitalismo urbano decisamente
più rapido e più vigoroso, né con la situazione presente nei paesi arretrati
dell’Oriente europeo, caratterizzati da un’estrema debolezza dello sviluppo
cittadino e borghese. Il quadro globale italiano è ben diverso: qui l’industria
fino al XIX secolo aveva un peso quasi trascurabile nello svolgimento
complessivo dell’attività economica, e anche il commercio, nonostante
avesse un rilievo assai maggiore, era tuttavia subordinato all’agricoltura.
Esistevano anche nelle città italiane grosse fortune immobiliari, ma
l’importanza di quelle fortune nel complesso dell’economia nazionale era
assai meno considerevole che in Francia. Accedeva perciò che da noi,
ancora verso il 1860, i soli fenomeni capitalistici capaci di dar luogo a forme
moderne di organizzazione produttiva si riscontrassero nell’agricoltura, con lo
sviluppo nella Valle Padana, fra Sette e Ottocento, di grandi gestioni agricole
caratterizzate da largo impiego di capitali e di manodopera salariata,
miglioramento di metodi di coltura, aumento notevole dei mezzi tecnici e della
produzione. Romeo afferma che è su tale sfondo di debole sviluppo del
capitalismo cittadino e di incipiente capitalismo agrario che va studiato il
significato della mancata rivoluzione contadina auspicata da parte marxista.
In un paese come l’Italia del diciannovesimo secolo la borghesia aveva già
posto le mani su buona parte della proprietà ecclesiastica e l’introduzione del
codice di Napoleone aveva cancellato ogni differenza giuridica tra proprietà
feudale e proprietà borghese. Di conseguenza, una rivoluzione agraria
avrebbe colpito anche il Nord e il Centro della penisola, aree in cui vi si erano
già consolidate forme più avanzate di economia agraria, liquidando in tal
modo gli elementi capitalistici dell’agricoltura italiana per sostituirvi un regime
di piccola proprietà indipendente e imprimendo all’Italia agricola una
fisionomia di democrazia rurale. A tutto ciò si sarebbe certo accompagnata
l’eliminazione dei residui feudali ma nel processo generale questa rivoluzione
avrebbe assunto un valore diverso; è sufficiente rifarsi alle conseguenze della
Rivoluzione nelle campagne francesi; essa, pur migliorando le condizioni dei
contadini non segnò tuttavia un progresso tecnico e produttivo dell’agricoltura
francese. Tanto è che nella prima metà del secolo XIX essa comportò una
stagnazione profonda contrassegnata da scarsissimi miglioramenti. Solo
nella seconda metà del secolo lo sviluppo del capitalismo urbano aprì la via
anche alle campagne, assoggettandosi i rapporti agrari e insinuandosi
fortemente tra il produttore e il consumatore, realizzando così dei profitti a
scapito dell’uno e dell’altro. L’arresto del capitalismo agrario francese,
tuttavia, venne in buona parte fronteggiato dall’ascesa del capitalismo
finanziario, industriale e commerciale, condizione fondamentale che mancava
in Italia. Nella realtà italiana, infatti, una volta eliminato dalla rivoluzione
contadina il capitalismo agrario, uno dei settori più progrediti, nella generale
debolezza di quello industriale, il paese avrebbe subito un calo nella sua
evoluzione a paese moderno. E’ indubbio che una fonte importante
dell’accumulazione capitalistica fu la politica connessa alla fondazione e allo
sviluppo dello Stato unitario, che fin dall’inizio indirizzò grosse quantità di
denaro verso l’esecuzione di grandi opere urbanistiche, favorì le speculazioni
finanziarie, stimolò industrie con la politica degli armamenti anche se una
parte cospicua di questi investimenti venne attribuita al capitale straniero,
soprattutto francese. La parte principale, nel complesso, rimase comunque al
capitale nazionale, il quale era in larga misura capitale derivante da antichi
negozianti o banchieri che solo più tardi si volsero all’industria. Nonostante
ciò alcune attività agricole erano già penetrate da elementi capitalistici. Il
capitalismo agrario, infatti, rappresentò una delle fonti principali di
accumulazione del capitale che più tardi sarebbe affluito alle industrie.
Rendite e profitti agrari diedero vita a una corrente che stimolò l’economia
urbana e fecondò nuove iniziative e intraprese. Perciò, mentre la formazione
del capitale necessario allo sviluppo e alla produzione industriale in
Inghilterra e in Francia aveva già avuto luogo nel Cinquecento e nel Seicento,
con le “enclosures”, il commercio coloniale, la politica mercantilistica, in Italia
essa si realizzò solo nel corso del XIX secolo, dal momento che, fino al
Settecento, aveva raggiunto proporzioni modestissime. Questo capitale si
formò essenzialmente nelle campagne, a spese dei ceti contadini più poveri.
Ma questo suo ritardato sviluppo e le particolari condizioni storiche della
penisola impressero un carattere composito al processo di accumulazione
italiano. L’impulso fu caratterizzato per l’appunto dal profitto agrario, dal
momento che ad accelerarlo intervenne la pressione del mercato mondiale
capitalistico. Questo rese possibili i larghissimi guadagni di alcune
esportazioni agrarie, e il compito dei moderati sarebbe stato quello di
garantire le condizioni politiche necessarie al compimento di tale processo. In
questa direzione operò il liberismo di Cavour e della Destra che si trasformò
in consapevole politica di sviluppo industriale qualche decennio dopo il 1860.
Sarebbero state molto gravi secondo Romeo le conseguenze di una
rivoluzione agraria che, difendendo i contadini dallo sfruttamento, avrebbe
travolto l’unica forma di capitalismo esistente, destinato a funzionare come
meccanismo essenziale per attuare il trasferimento dei redditi agricoli al
servizio dello sviluppo urbano e industriale. Tutto ciò sarebbe accaduto nelle
regioni dell’Italia centro-settentrionale, ma non sarebbe stato pensabile che il
Partito d’azione scatenasse la rivoluzione dei contadini del Meridione senza
che si estendesse al Nord.
Romeo si sofferma, oltretutto, sull’analisi di alcune tesi a sostegno di quella
gramsciana. Il Sereni, ad esempio, afferma che la rivoluzione agraria,
innalzando il livello di vita dei contadini ovunque avessero consolidato il loro
possedimento di terra, avrebbe assicurato un più ampio mercato all’industria
cittadina. Ciò è tuttavia opinabile poiché, pur ammettendo un miglioramento
nel tenore di vita di questo strato sociale, è anche vero che, specie in questa
fase in cui ancora largamente sopravvive l’industria domestica, è cosa assai
diversa la creazione di una piccola proprietà contadina dalla formazione di un
grande mercato per l’industria capitalistica. Lo stesso Marx ha esposto le
condizioni affinché esistesse questa forma economico-sociale: “Questa forma
della proprietà terriera presuppone che, come nelle più antiche forme di essa,
la popolazione della campagna possieda una grande prevalenza numerica su
quella cittadina (…),che una parte prevalente del prodotto agricolo debba qui
esser consumata dai suoi stessi produttori, i contadini, e solo parte eccedente
debba entrare come merce negli scambi con le città”. Certo i rapporti
capitalistici di produzione avrebbero comunque assoggettato al loro dominio il
nuovo regime terriero, ma la rivoluzione agraria si sarebbe figurata più come
un elemento d’arresto che come un elemento d’impulso. Il maggior pericolo
della tesi del Gramsci era quello infatti di adottare una prospettiva falsata del
problema dello sviluppo capitalistico in Italia. Infatti, la condizione arretrata
delle città italiane non consentiva più nel XIX secolo alle classi dirigenti
cittadine di condurre una rivoluzione antifeudale, e quindi basata sull’alleanza
con le masse contadine, se non pagando per questa alleanza un prezzo
storicamente troppo grave in termini di ritardo dello sviluppo in senso
moderno e occidentale. Nelle condizioni storiche dell’Italia di allora, la
rivoluzione agraria avrebbe rappresentato uno sforzo in senso contrario alla
tendenza che da oltre un secolo si era determinata in buona parte delle
campagne del Nord e del Centro avrebbe cioè rappresentato non un
potenziamento dello sviluppo storico reale, ma una deviazione violenta verso
una direzione diversa e contraria. Avrebbe comportato, dunque, una fase di
accentuato antagonismo fra borghesia e contadini. Essa, già oltrepassata
dalla Francia nell’età della Rivoluzione, sopravvivrà al Risorgimento e sarà
questo ritardato sviluppo antifeudale a dar vita a una grave passività nella
storia d’Italia.
In realtà solo una considerazione diretta degli specifici problemi della storia
d’Italia può mostrare come una rivoluzione agraria a direzione democratica
non potesse essere un fattore di progresso. Un altro elemento discutibile è
dato dall’illegittimità dell’assunzione dello sviluppo storico francese a modello
esemplare dello svolgimento di un moderno paese borghese e capitalistico.
Secondo Romeo non è corretto, come avviene nella tesi del Gramsci,
stabilire dei continui raffronti con esso.
Incoerente è inoltre l’assunzione di Parigi a capitale-modello, e il continuo
confronto tra la funzione di autentico centro economico, politico, morale che
essa ha esercitato nelle storia della Francia, e quella assai minore di Roma
nella storia d’Italia, dove la capitale politica non è mai stata un grande centro
produttivo. Non è corretto, del resto, vedere Parigi come la capitale ideale,
quando sono note tutte le passività che alla Francia sono derivate da questa
sua città-monstre, assorbente tutto il meglio per sé, con danno e
impoverimento politico, culturale e spirituale per il resto della nazione.
Per Gramsci tuttavia, la tesi aveva una portata che andava ben oltre i dati
economici e strutturali. La rivoluzione agraria si presentava infatti come la
grande istanza risolutiva dei contrasti profondi della storia del paese, come
un potente strumento unificatore di tutta la società italiana, che avrebbe
creato un rapporto più profondo tra lo Stato e le forze nazional-popolari. Ma si
chiede Romeo, un simile rivolgimento, che avrebbe fatto dell’Italia un paese
conforme agli ideali della democrazia piccolo-borghese del primo Ottocento,
avrebbe concretamente realizzato l’unità profonda tra città e campagna, alla
luce delle stesse conseguenze della Rivoluzione francese, che pur aveva
gettato le basi di una grande tradizione democratica? In fondo, nel Gramsci,
la rivoluzione agraria assunse un valore assai simile a quello risolutivo che il
marxismo attribuì alla rivoluzione proletaria, e nel suo significato più intimo,
finì quasi per identificarsi con essa.
Dalla interpretazione gramsciana del Risorgimento la storiografia marxista
riprese soprattutto la tematica politico-sociale, sforzandosi di documentare in
modo sempre più sostenuto la realtà di un’alternativa giacobina al
Risorgimento. Se pur è lecito parlare di una corrente di studi marxisti riguardo
a questo evento, va tenuto presente che all’interno di essa vi sono differenze
notevoli. Molti studiosi infatti, formatisi alla scuola dello storicismo liberale,
soltanto in una seconda fase si “convertirono” al marxismo. E talvolta questa
conversione, a parere di Romeo, andò assai meno nel profondo di quanto
non sospettassero gli stessi convertiti. L’autore non vuole scatenare una
polemica distruttiva nei confronti della storiografia marxista ma si propone di
meditarne gli apporti dopo aver ripreso in esame le tesi gramsciane sul
Risorgimento, in particolare sul tema dello sviluppo del capitalismo nel nostro
paese.
Il concetto di “accumulazione primitiva” venne formulato da Marx come fase
antecedente all’inizio del processo di riproduzione del capitale. In tale fase
non esiste ancora il capitale industriale, perciò ha fondamentale importanza
la formazione di quelle concentrazioni di ricchezza e di quelle posizioni di
predominio nella vita economica, che si traducono in più elevata capacità di
risparmio da parte dei ceti più fortunati. Tale capacità di risparmio, rimasta
sterile finché la società è dominata da modi di produzione arretrati, prende
poi la via dei finanziamenti industriali quando si è entrati nella nuova fase del
progresso tecnico e del predominio delle attività mobiliari, ed esercita una
funzione importante specialmente all’inizio del processo di
industrializzazione. La fase dell’accumulazione non va, per altro,
necessariamente concepita come cronologicamente antecedente a quella
dello sviluppo industriale. Ma va osservato che, in un paese in fase di
economia preindustriale, i vari processi di tale sviluppo si riportano tuttavia a
una base comune, ove avviene un drastico spostamento del rapporto tra
consumi e investimenti, diretto a intensificare l’afflusso di risparmio prodotto
in altri settori economici verso il settore degli investimenti industriali. Qui si
scorge l’equivoco fondamentale al quale si riduce la tesi del Gramsci secondo
Romeo. La rivoluzione agraria infatti, e la relativa conquista della terra da
parte dei contadini, si traduce essenzialmente in un innalzamento dei
consumi delle masse rurali e quindi in un ampliamento del mercato. Gramsci
sostiene che proprio nella ristrettezza del mercato derivante dalla mancata
rivoluzione agraria si individua la limitazione fondamentale dello sviluppo
capitalistico italiano. In realtà secondo Romeo il problema principale non è
l’ampliamento del mercato ma l’accumulazione del capitale come strumento
diretto a conseguire un aumento della produttività. Tanto è vero che anche un
paese enormemente popolato rimane un mercato povero se è bassa la
produttività media per abitante. L’avviamento di una larga parte del reddito
nazionale agli investimenti industriali è possibile solo nel quadro di tutta una
serie di premesse: libertà personale, libera mobilità della manodopera rurale,
la formazione di un moderno ordinamento giuridico, l’abbattimento degli
ostacoli al commercio interno e degli impedimenti legali alla libera
associazione dei capitali. Queste premesse erano già state create in Italia al
tempo della Rivoluzione e dell’Impero napoleonico, e gli ultimi residui del
mondo pre-borghese furono abbattuti con l’Unità. La difficoltà che si
presentava alla società italiana a metà del XIX secolo era quella di una
modernizzazione della vita economica, di un suo ingresso in un libero
mercato e nella concorrenza industriale con le nazioni più progredite. Tale
problema poteva essere risolto solo con un contenimento dei consumi di
massa, in particolar modo quelli rurali. L’aumento della produttività agricola
sarebbe stata una premessa necessaria all’industrializzazione, in vista
dell’aumentato fabbisogno di materie prime per i nuovi centri industriali, e
della necessità di liberare una parte della manodopera prima impiegata
nell’agricoltura per i nuovi compiti dell’industria. Ma va sottolineato che i frutti
dell’aumentata produttività agricola non si sarebbero dovuti tradurre in un
aumento dei consumi rurali. Perciò, se si fosse voluto che agissero come
acceleratore del processo di industrializzazione, avrebbero dovuto essere
sottratti, in una forma o nell’altra, ai contadini. Negli anni Ottanta
dell’Ottocento, tuttavia, dopo una lunga fase di liberismo intransigente, il
livello dello sviluppo economico appariva ancora insoddisfacente. Allo scopo
di incentivare la crescita si adottò la tariffa generale del 1887, che decideva di
affrontare le difficoltà dell’industria e della cerealicoltura ( il mercato dei
cereali era occupato dai grandi paesi produttori e l’Italia, non essendo
autosufficiente, era tra i maggiori importatori) tramite una protezione
doganale, da cui erano esentate la maggior parte delle materie prime utili
all’industria e quasi l’intera produzione industriale. Imponendo questa tassa,
si andò a creare un protezionismo industriale a Nord e un protezionismo
granario a Sud, visto spesso come lo sbocco del compromesso politico tra
forze rivoluzionarie e borghesi del Nord ed elementi semifeudali del Sud, sul
quale si era fondata la soluzione unitaria del 1860. Ma il dazio sul grano ebbe
solo uno scarso effetto compensatorio rispetto alla prevalente copertura
concessa alle industrie. Dalla tariffa del 1887 venne colpita in particolar modo
l’agricoltura, dunque specialmente il Mezzogiorno, danneggiato nelle sue
esportazioni e costretto ad acquistare a un prezzo più alto i manufatti
dell’industria nazionale, ormai esclusiva padrona di tutto il mercato interno.
Peggiorò dunque la ragione di scambio tra prodotti agricoli e prodotti
industriali, mentre nello stesso tempo si accelerò potentemente il processo di
accumulazione capitalistica nell’industria, dove si determinò un afflusso di
risparmio a danno dell’agricoltura. Con tale protezione doganale dunque, non
solo venne ripreso sotto nuova forma quel processo di sfruttamento
dell’agricoltura a vantaggio dell’industria, che nei primi decenni dell’Unità era
avvenuto con il suddetto contenimento dei consumi rurali per l’accumulazione
del capitale, ma vennero aggravati i caratteri antagonistici del processo
attraverso il quale si era compiuta l’unità nazionale, fra città e campagna,
Nord e Mezzogiorno. Tutto ciò volle dire accentuazione non solo
dell’inferiorità economica del Sud, ma anche del suo deterioramento sociale e
civile, e della miseria e sofferenza delle genti meridionali che trovò la sua
espressione più vistosa nell’emigrazione. In conclusione l’autore vuole porre
l’accento sul fatto che, proprio in virtù del sacrificio imposto per tanti decenni
alla campagna e al Mezzogiorno, un paese povero di territorio e di risorse
naturali e sottoposto ad una fortissima pressione demografica come l’Italia,
sia riuscito a creare un grande apparato industriale e una civiltà urbana
altamente sviluppata, che in gran parte del paese ha diffuso più civili e
indipendenti rapporti tra gli uomini e una più larga partecipazione degli italiani
ai beni materiali e morali del mondo moderno. Lo sviluppo del capitalismo in
Italia viene preso in considerazione non solo come un aspetto della nostra
storia, ma soprattutto come lo sforzo fondamentale tra tutti quelli che gli
italiani hanno compiuto per edificare la civiltà moderna nel proprio paese. Un
processo certo meno limpido e lineare che in altre nazioni, nate assai prima
della nostra alla vita moderna. Anche perché, secondo Romeo, diversamente
che in altri paesi, è mancata in Italia una specifica ideologia
dell’industrializzazione. Difatti, il movimento protezionista non acquistò mai
un’egemonia intellettuale, che rimase invece possesso della scienza e della
polemica liberista, nonostante la sua inadeguatezza nell’affrontare i problemi
della nuova era. Non meno insufficiente si rivelò, in tal senso, il pensiero
marxista italiano. Il riconoscimento di tutto questo non deve essere pretesto
per velare la gravità dei problemi derivarono dal modo in cui si realizzò lo
sviluppo capitalistico. La compressione delle campagne fu una condizione
fondamentale per l’accumulazione primitiva del capitale italiano dopo l’Unità e
si configurò come la risultante di un processo storico-politico che aveva
accentrato nelle mani del ceto dirigente un potere tale da imporla ai ceti rurali,
che non l’avrebbero accettata qualora ad essi fosse stata concessa una più
larga partecipazione al potere politico, qualora cioè il Risorgimento fosse
stato un moto non solo di forze cittadine, ma anche di plebi rurali. Proprio in
questo nesso si scorge la fondamentale unità di tutto il processo e come non
si possa prospettare una visione del Risorgimento come rivoluzione agraria
mancata senza accettare tutte le implicazioni che sarebbero derivate sul
piano delle strutture economiche. La compressione dei consumi agrari,
mentre nella fase iniziale della industrializzazione ebbe un contenuto
storicamente positivo,in un secondo tempo si rivelò un ostacolo all’ulteriore
sviluppo capitalistico. La miseria delle campagne del Sud, dipendente dal
processo storico sopra ricordato, si tradusse infatti in un limite assai grave
per la stessa espansione industriale, rimasta concentrata in un’area del
paese e incapace di diffondersi in modo omogeneo in tutto il territorio
nazionale.
(Elena Manfrin)
3.INTERPRETI DEL RISORGIMENTO
F.De Sanctis e A.Omodeo
Nel suo ampio saggio di storia della storiografia ,intitolato “Interpretazioni del
Risorgimento”, Walter Maturi ci offre una panoramica sugli studi e sugli
approfondimenti dedicati al Risorgimento italiano .
Quest’opera è suddivisa in più capitoli ,e ogni capitolo corrisponde ad uno
storico che ci spiega il suo punto di vista sul Risorgimento ,cercando di
esporci cause scatenanti ,conseguenze e ogni minimo dettaglio mirato ad
una più accurata comprensione di quel periodo che ha portato all’Unità
d’Italia .
Dal saggio di Maturi emerge la complessità della vicenda risorgimentale che
certo non si riduce alla spedizione dei Mille portata avanti da Garibaldi .Il
Risorgimento italiano è molto di più e in molti hanno contribuito a questo
grande miracolo italiano. Mazzini ,ad esempio , costituendo “La giovine
Italia”,cominciò a diffondere le sue idee sul patriottismo e iniziò a risvegliare
una popolazione che sembrava in letargo da anni ,dato che agli occhi
dell’Europa,gli italiani erano una popolazione oppressa e rassegnata ad un
destino di eterna sottomissione .
Sulla figura di Mazzini ,Walter Maturi ci offre l’autorevole punto di vista di
Francesco De Sanctis ,il quale scrisse “La Letteratura italiana del secolo
XIX”. Quest’opera riveste notevole importanza ,ed è il frutto di due corsi,tenuti
dal De Sanctis ,negli anni accademici 1872-73 e 1873-74 all’Università di
Napoli. Essa in seguito venne raccolta in un volume dal filosofo Benedetto
Croce .
Ciò che contraddistingue questo volume dal punto di vista della forma,è il
modo di esprimersi molto diretto e talora colorito , ben lontano dallo stile
aulico dell’Accademia . Considerata ,poi ,dal punto di vista
contenutistico,l’opera di De Sanctis ruota attorno ad un preconcetto
fondamentale legato al Romanticismo ,ovvero che la letteratura sia
espressione d’una società senza però concepire la letteratura stessa come
un prodotto meccanico della società .
Entrando invece in quelli che sono gli argomenti politici ,il De Sanctis vede il
Risorgimento come una continua lotta fra due scuole di pensiero , quella
liberale e quella democratica .Egli sostiene che queste due scuole non si
siano sfidate soltanto nell’ambito politico ma anche nella scienza ,nella
metafisica e nella letteratura .In ambito politico-militare ,in sintesi l’Unità
d’Italia è stata il risultato del genio di Cavour ,il liberale , e del patriottismo di
Garibaldi ,il democratico .E secondo De Sanctis per una rivoluzione popolare
era necessario che le due fazioni collaborassero assieme per lo stesso
scopo,tanto che i due eroi del Risorgimento vengono definiti complementari
l’uno con l’altro :Cavour era un grandissimo statista e rappresentava a pieno
l’ideale di grande politico mentre Garibaldi era un uomo d'azione,passionale
,un patriota , disposto a dare la vita in campo di battaglia .Su questa
questione avrà poi qualcosa da obiettare Benedetto Croce ,il quale sostiene
che ci siano altre correnti di pensiero che a loro modo hanno contribuito
all’Unità d’Italia :i democratici di Cattaneo e Ferrari e le posizioni del Muscetta
e La Farina .
Un altro argomento trattato dal De Sanctis è il Cattolicesimo liberale e
neoguelfismo,che secondo la sua opinione trova le sue più antiche radici
nella concezione politica di Dante Alighieri ,ovvero un governo fondato sulla
base del Vangelo .
Questo movimento ebbe diversi fautori :è giusto citare Rosmini , Gioberti,
Manzoni , D’Azeglio e Cantù ,tutti esponenti di questa corrente di pensiero
che,però ,fallì miseramente per l’inconsistenza delle sue teorie e delle sue
proposte dal punto di vista politico .
Dopo questa breve spiegazione sul Cattolicesimo liberale ,Maturi ci offre la
analisi del De Sanctis sulla figura di Mazzini;su questa figura ci sono dei
passaggi poco chiari poiché il De Sanctis non riesce a definire Mazzini dal
punto di vista politico e dal punto di vista sociale e si pone una domanda :chi
fu Mazzini?
De Sanctis ci offre questa riflessione su Mazzini:
a) Mazzini, ebbe, senza dubbio, un certo fervore di aspirazioni religiose,
ma non fu un riformatore religioso, perché gli mancavano idee concrete
in questo campo. Il suo Dio è un Dio politco, che, invece di essere
aderente alla Santa Alleanza, è aderente all’Internazionale democratica
e nazionalitaria. Il Concilio, che ne pensiero mazziniano avrebbe dovuto
fissare le norme della nuova religione, non era altro che la traduzione in
termini ecclesiastici dell’idea della Costituente;
b) Mazzini non fu un filosofo: l’unica sua idea valida è quella del
progresso, che non è un concetto filosofico molto peregrino;
c) Mazzini non fu un uomo politico perché profetizzò dei fatti che furono
compiuti da altri e per vie diverse da quelle che egli additava.
Che cosa fu dunque?
a) fu un grande agitatore, che seppe tener desta l’idea dell’Unità italiana
con incrollabile tenacia;
b) fu un grande educatore etico-politico, che seppe insegnare il valore
morale dell’azione, dell’insurrezione ai fini dell’educazione concreta del
genere umano;
c) fu un grande precursore;
Walter Maturi ,infine ,sviluppa una riflessione sulla posizione del De Sanctis:è
necessaria una visione della politica che vada oltre il partito affinché lo stato
goda di riforme (laiche ovviamente) mirate al bene comune di tutti gli italiani .
Questo punto di vista appare molto attuale e ciò sta a significare che anche a
quel tempo ci si era posto il problema del ruolo dei partiti e della necessaria
dialettica tra la visione politica del partito, inevitabilmente parziale e la tutela
del bene comune.
Walter Maturi ,ci propone anche una sintesi del pensiero di un altro storico
del Risorgimento :Adolfo Omodeo .Questi ha scritto un manuale scolastico
chiamato “L’età moderna e contemporanea” ,che non venne adottato nel “25
,dato che al suo interno non vi erano cenni riconducibili al culto del Duce e al
regime fascista ;così decise di trasformarlo in un libro per lettori colti
(possibilmente poco vicini agli ambienti fascisti) ,chiamato “L’età del
Risorgimento italiano” .In questo libro ,però ,vi sono però molti cenni
all’Illuminismo e alle vicende politiche europee ,il che lo rende poco
specializzato e con molti eventi raccontati in modo abbastanza vago .
Omodeo diede moltissima importanza all’opera di Mazzini nel
Risorgimento,riconoscendo nei suoi ideali ,l’espressione religiosa che sta alla
base della terza Italia .Omodeo attribuisce proprio a quest’ultimo un concetto
di “nazionalità” ,e attacca ,quindi ,gli storici europei che attribuiscono ai
movimenti liberatori in Italia ,le colpe di aver causato tumulti e scossoni in
tutta l’Europa .
Omodeo ,poi ,tratta dell’influenza delle idee dell’illuminismo ,e nonostante le
sue posizioni apertamente pro-cattolicesimo ,non è affatto ostile a queste
correnti nonostante il conflitto tra cattolicesimo e filosofia dei lumi .Egli
sostiene che nonostante la predominanza del pensiero romantico ,nel
Risorgimento italiano ebbero notevole importanza anche le idee deIl’
illuminismo .
In polemica con le tesi del filosofo Gentile ,che aveva esaltato il ruolo di
Gioberti ,considerandolo accanto a Mazzini per importanza e
carisma;Omodeo definì Gioberti un’opportunista che adottò ,come cavallo di
battaglia delle sue campagne politiche ,il mito del Neoguelfismo ,per attirare a
se i cattolici che al tempo costituivano la maggior parte della popolazione
italiana.
Le sue critiche colpirono anche re Carlo Alberto ,definito un re contraddittorio
e un sovrano molle ,inconcludente sul piano politico e militare. Inizialmente
Omodeo sembra prendere di mira anche l‟operato di Cavour definito un
indeciso con la colpa di aver dato un impronta troppo piemontese allo stato
italiano .Poi però Omodeo apprezza la sua attività diplomatica e ,soprattutto
,è sedotto dal fatto che Cavour non volle mai essere servitore di Carlo
Alberto. Nel paragone con Mazzini , Cavour esce vincitore data la
concretezza delle sue idee a differenza di Mazzini ,grande sognatore ,grande
agitatore ,ma mai in grado di portare avanti idee realizzabili e credibili .
Ciò che emerge da questo libro sono le numerose opinioni sul Risorgimento
italiano e il fatto che tra queste opinioni vi sono numerose divergenze. Gli
storici appaiono in disaccordo ,ma su un punto sono tutti assolutamente sulla
stessa lunghezza d’onda :l’importanza della collaborazione e della fusione fra
più correnti di pensiero per ottenere miglioramenti sociali e politici .Se per il
De Sanctis fu necessaria una cooperazione politica fra liberali e democratici
,per Omodeo fu necessaria la fusione del pensiero romantico con quello
illuministico . Quello che emerge da questa prospettiva è che se vogliamo
cambiamenti politici e sociali ,è necessaria la collaborazione fra più parti ,non
solo politiche ma anche culturali ;e se per il Risorgimento furono fondamentali
le collaborazioni fra gruppi diversi a maggior ragione oggi ,nelle condizioni in
cui versa il nostro stato , sarebbe opportuno un maggiore dialogo fra le forze
politiche perché se gli obiettivi sono comuni ,si arriva sempre ad un punto
d’incontro. Alla base di tutto ,però ,deve esserci la buona volontà delle parti .
Quindi Risorgimento come punto di partenza e non come punto d’arrivo…
(Cattaruzza Alberto)
4. GAETANO SALVEMINI E LUIGI SALVATORELLI
Maturi si sofferma sul giudizio che due importanti storici, hanno espresso nei
confronti della figura di Giuseppe Mazzini. Come è ben noto, a partire dai
primi anni trenta dell'Ottocento, Mazzini si impose come personalità politica di
primo piano e divenne membro della Carboneria nel 1830. La sua attività di
ideologo e organizzatore lo costrinse a lasciare l'Italia nel 1831 per fuggire a
Marsiglia, dove fondò la Giovine Italia, un movimento che raccoglieva le
spinte patriottiche per la costituzione di uno Stato unitario e repubblicano, da
inserire in una più ampia prospettiva federale europea. Mazzini continuò a
perseguire il suo obiettivo dall'esilio con inflessibile costanza. Tuttavia,
l'importanza delle sue azioni fu più ideologica che pratica. Dopo il fallimento
dei moti del 1848, durante i quali Mazzini era stato a capo della breve
esperienza della Repubblica Romana, i patrioti italiani cominciarono a
vedere nel re del Regno di Sardegna e nel suo Primo Ministro Camillo
Benso conte di Cavour le guide del movimento di riunificazione. Ciò volle
dire separare l'unificazione dell'Italia dalla riforma sociale e politica invocata
da Mazzini. Cavour fu abile nello stringere un'alleanza con la Francia e nel
condurre una serie di guerre che portarono alla nascita dello stato italiano tra
il 1859 e il 1861, ma la natura politica del nuovo Stato era ben lontana dalla
Repubblica democratica vagheggiata da Mazzini. Il primo dei due storici è
Gaetano Salvemini, il quale approfondisce in una monografia classica il
pensiero mazziniano, alla quale dà il titolo di Mazzini. Salvemini, procede
scindendo da subito il pensiero e l'azione del personaggio in questione,
considerandole due realtà distinte e ben separate. Sorvolando sul fatto che
essa, come osserva Maturi possa essere interpretata come una distinzione
ben poco mazziniana (in quanto il personaggio stesso, riteneva il pensiero
tale soltanto se compiuto dall'azione) a Salvemini va riconosciuto senza
dubbio il merito di aver realizzato una sistemazione organica di tale
pensiero a partire da uno studio accurato delle fonti stesse del pensiero di
Mazzini da collocare nel contesto storico nel quale è inserito. In secondo
luogo, Salvemini riconosce la sincerità dell'ispirazione religiosa di Mazzini ma
constata che essa andò incontro ad un completo insuccesso. Secondo lo
storiografo il fallimento va infatti ricercato nelle tendenze laiche della prima
democrazia liberale italiana, che impedì alle idee mazziniane di trovare un
terreno favorevole. La sua instancabile predicazione è, tuttavia, difesa e
valorizzata dal Salvemini che, anzi, la interpreta in una curiosa chiave di
lettura; secondo l'autore infatti, essa può essere avvicinata alle istanze
proprie del Movimento Socialista. Questa particolare interpretazione (a cui
possiamo assegnare l'appellativo di “mazzinianesimo sociale”) può essere
interpretata in base al fatto che Salvemini riconosce come centrale nel
pensiero di Mazzini il cosiddetto “principio dell'associazione”, in base al
quale egli predicava il valore dell'azione collettiva tra i suoi seguaci. Ideale
decisamente rintracciabile tra i cardini del Pensiero Socialista. In definitiva
secondo il Salvemini, il mazzianesimo sociale una volta spogliato dalla sua
rigida corteccia teocratica e subordinato al principio della lotta sociale, non
sarebbe stato molto distante dall'idea socialista. Dulcis in fundo, è giusto
ricordare chi venisse effettivamente riconosciuto dal Salvemini come vera e
propria guida spirituale nel Risorgimento Italiano: vale a dire, Carlo
Cattaneo. Tra le sue opere, figura anche infatti un piccolo compendio
intitolato Le più belle pagine di Carlo Cattaneo. Con la redazione di questo
testo egli si propone, perciò, di descrivere la vera genesi del sistema
accentratore e a chiarire la sconfitta di Cattaneo nel Risorgimento. Maturi
prende in esame anche l'interpretazione di un altro storico: Luigi Salvatorelli,
la cui visione del Risorgimento è decisamente incentrata sul ruolo che la
personalità e il pensiero di Giuseppe Mazzini nel Risorgimento. Innanzitutto
Salvatorelli svolge un'indagine sull'illuminismo italiano, e ai suoi effetti nella
civiltà del 1800. Ad essa diede il titolo di Il pensiero politico italiano dal 1700
al 1870. E con questa opera, il vero obbiettivo dell'autore non fu tanto di
ricercare i fondamenti del pensiero illuminista quanto quello di introdurre una
tesi effettivamente originale: quella concernente il collegamento tra
Settecento illuminista e Ottocento romantico. Novità assoluta, tenendo conto
del fatto che in precedenza i due periodi venivano considerati assolutamente
distanti e incompatibili. Contro ogni aspettativa, secondo Salvatorelli, le salde
radici del credo risorgimentale dell'Ottocento sono da ricercare proprio nella
ragione illuministica. E il carattere composito sul piano culturale del
Risorgimento, il Salvatorelli lo vede indiscutibilmente rappresentato dal
contrastante binomio Mazzini-Cavour, l'uno, già presentato, come
rappresentante l'iniziativa democratica dal basso, l'altro di quella liberalemonarchica dall'alto. Salvatorelli, presenta i due, assegnando
immediatamente la parte di vincitore (per ciò che concerneva la diffusione del
proprio messaggio politico) a Cavour, e del vinto a Mazzini, discostandosi
dalla visione di un altro autore a lui contemporaneo, l'Omodeo, che
considerava invece il rapporto tra i due come una vera e propria integrazione
dialettica di compiti. Tuttavia questa specifica interpretazione dello storico,
viene in ogni caso a “risolversi”, quasi in accordo con quella dell'Omodeo;
infatti tutti e due gli autori espongono la propria visione dei fatti, tenendo
conto che, dalla disputa scaturita dall'integrarsi del pensiero mazziniano con
quello cavouriano, sorsero, comunque, delle correnti di pensiero politico che
ebbero il loro sbocco nel secolo successivo. Perciò, assistiamo ad un dibattito
senza fine tra due pensieri immortali, laicità razionalistica da un lato e il
misticismo politico-religioso dall'altro, entrambi egualmente necessari nel
corso del processo storico. Salvatorelli, interessato a rapportare il pensiero
mazziniano ad altre correnti politiche dell'Ottocento, trova il modo di
compararlo ad un'altra importante figura politica di questo movimentato
secolo. E, così, nel volume Rapporti contrastanti tra Napoleone III e Mazzini
nella politica europea fra il 1850 e il 1860, viene svolto un serrato confronto
tra le concezioni politiche di queste due personalità. Esattamente come per
Cavour sul piano italiano così per Napoleone III su quello internazionale,
Mazzini rappresentò l'alternativa rivoluzionaria democratica all'imperatore
francese che, nonostante i suoi connotati autoritari, rientra nella corrente del
Umanitarismo Liberale del Sette-Ottocento.. Viene inoltre ricordato il fatto,
che sia Mazzini che Napoleone III derivarono i propri ideali dal
Sansimonismo, un movimento progressista francese, di cui svilupparono i
principi in modo profondamente diverso. Maturi esprime un certo dissenso
rispetto alle valutazioni di Salvatorelli riguardo alla politica di Napoleone III.
Questi sarebbe piuttosto da paragonare ai despoti Illuminati del Settecento
con, in peggio, tratti inquietanti di nazionalismo totalitario. Forse, conclude
Maturi, il giudizio troppo generoso di Salvatorelli si può far risalire alla
gratitudine, molto presente nei liberali moderati italiani, verso colui che nel
1859 aveva cooperato alla costruzione dell'unità italiana.
(Leonardo Feletto)
5. PIERO GOBETTI Nel suo saggio storico, intitolato "Risorgimento senza
eroi" pubblicato nel 1926, Piero Gobetti si sofferma sulla situazione del
Piemonte, che ad Unità compiuta, dovette affrontare una grave crisi, dovuta
principalmente al fatto che per conquistare l'Italia aveva dovuto rinunciare alle
proprie caratteristiche e tradizioni proprio mentre nel resto del Paese si
assisteva ad un affievolirsi del regionalismo e delle tradizioni antiunitarie delle
province e delle città italiane. Senza tenere in considerazione queste
problematiche, non è possibile fare una corretta analisi dello spirito di questa
regione di fronte ai principali fatti del tempo. Durante il regno di Carlo Felice,
ultimo re piemontese, i valori del Piemonte erano principalmente la
burocrazia e la diplomazia, mentre gli ideali erano ancora incarnati in una vita
aulica e cavalleresca. Infatti, dopo l'onta subita nel periodo napoleonico, si
era affievolita in Carlo Felice l'audacia battagliera che aveva caratterizzato i
re del Settecento. Lo spirito che, però, ha sempre distinto il Piemonte, è il
culto della pratica e il disdegno per le complicazioni psicologiche e
romantiche. La soluzione di questa regione ai problemi spirituali era quella di
confinare le eresie all'estero per accettare la religione più semplice e
conveniente: il cattolicesimo, inteso soprattutto come rispetto per l'autorità.
Un esempio di questo spirito si ha nella tolleranza del Piemonte nei confronti
dei valdesi. Essi furono infatti tutelati solo a patto che restassero confinati
nelle valli più solitarie. Ciò indica anche il carattere di questa regione:
scontroso e aspro, diffidente e inaccessibile. Si può anche comprendere che
la popolazione non era incline agli ardori religiosi, tant'è che Gioberti non
ebbe qui lo stesso successo suscitato nel Mezzogiorno. Perciò il Piemonte, in
cerca di una via per risollevarsi dalla crisi, concentrò le sue forze
nell'economia e in una vita sociale autonoma. Dopo pochi decenni di duro
lavoro, Torino si trasformò in un centro animato dal fervore industriale, abitato
non più dalla plebe ma dal proletariato, fedele alla dignità del lavoro e del
sacrificio. Da questa trasformazione è possibile capire che il pragmatismo
delle classi dirigenti piemontesi, poco interessate alla cultura letteraria, era
destinato ad incontrarsi con il desiderio di affermazione del proletariato
stesso e con il comune interesse ad intraprendere il cammino verso la
democrazia moderna.
Ma volendo analizzare il Risorgimento italiano nella sua totalità, secondo
Gobetti, bisogna porsi alcune domande: esso è nato come imitazione della
rivoluzione francese o perchè veramente voluto dalla popolazione? E' solo il
frutto delle strategie diplomatiche dell'Ottocento o pone le sue basi nel
tormento teorico del secolo precedente? A queste domande non è possibile
dare una risposta certa: tuttavia si può affermare che durante il Settecento in
quasi tutta l'Europa la classe aristocratica ed ecclesiastica era in declino, solo
che mentre in Francia e in Inghilterra il cosiddetto Terzo Stato era pronto a
farsi avanti, in Italia la borghesia non poteva ancora contare sull'abbondanza
e la rapidità di circolazione del capitale mobile. In questo quadro di incertezze
c'era ancora bisogno dell'iniziativa del principe: questo spiega il fenomeno
centrale del Settecento italiano, ovvero l'assolutismo illuminato. Questo
modello non promuove cambiamenti radicali in nome di idee nuove o di uno
stile liberale, ma si indirizza, secondo una mentalità conservatrice, verso una
moderata applicazione dell'illuminismo europeo. Volendo riassumere, il
quadro politico settecentesco è sintetizzabile nel modo seguente:
una monarchia che domina tutte le forze: lungimirante e audace nel
Piemonte, in decadenza nel Sud; nobili e grandi ecclesiastici reazionari,
feudali e teocratici: perciò alleati; plebi assenti: escluse dalle poche industrie,
condannate al pauperismo e all'elemosina, clienti delle parrocchie; la classe
politica: in scarsa parte proveniente dalla borghesia dei nuovi ricchi o dei
professionisti, nella sostanza formata da nobili, più fedeli al principe che al
feudalismo, perchè educati secondo tradizioni burocratiche o militari.
Quindi se nel Settecento l'iniziativa del principe era ancora necessaria,
nell'Ottocento prevale quella di una nuova classe politica. E' perciò solo in
questi anni che si può parlare di "uomini nuovi" e di Risorgimento. Mentre in
questo secolo le altre nazioni europee si sono affermate, liberandosi dalle
ideologie dogmatiche, gli italiani non possono pensare ad una riforma
religiosa perchè sono troppo impegnati a sconfiggere il dominio territoriale dei
pontefici, attaccando la Chiesa in ambito politico anzichè in quello dogmatico.
Le plebi continuano a vivere intorno ai conventi, mantenendosi cattoliche più
per tradizione che per interesse; l'iniziativa spetta ad una borghesia troppo
impegnata ad attuare con Cavour una politica nuova di liberalismo economico
al fine di formare il primo capitale circolante in Italia. Se la rivoluzione
francese ha assunto le dimensioni di un dramma europeo, caratterizzato dalla
rivendicazione di masse popolari nuove condotte dalla classe borghese
contro un'aristocrazia destinata a tramontare, il Risorgimento italiano è la
lotta del singolo, o di pochi isolati, contro la cattiva letteratura di un popolo
dominato dalla misera. Vittorio Alfieri fu l'unico italiano in grado di sentire, già
in pieno Settecento, la necessità di una rivoluzione dal basso, condotta da
minoranze repubblicane in senso unitario. Per certi versi le sue idee
anticiparono la rivoluzione francese. Egli è il primo uomo nuovo, dominato
dalla passione di un'affermazione romantica ed individualista. La sua
inquietudine avventurosa lo porta a sentire il bisogno di rifiutare le autorità
costituite, i dogmi fatti ed imposti e le tirannie politiche e religiose. Alfieri
costituisce uno dei più grandiosi esempi di resistenza intellettuale attiva
dell'individuo contro le oppressioni politiche, come un uomo libero in tempo di
schiavitù. Egli si è formato nel fervore spirituale europeo che ha preparato il
terreno al culto dell'individualismo e della libertà.
Nella concezione di Alfieri, il papa è complice del tiranno: i dogmi della
religione sono gli stratagemmi con cui si impedisce il libero pensiero. Se i
popoli credono a tali concetti è solo per ignoranza, la quale è l'antitesi della
libertà. Ogni popolo che ammette e rispetta l'autorità del pontefice è destinato
a essere schiavo per sempre. Infatti se si affida unicamente al papa come
guida religiosa, lo stesso farà con l'imperatore in quanto guida temporale.
Secondo Alfieri la libertà è l'unica e vera esistenza del popolo, in quanto è
fonte di tutte le grandi cose create dall'uomo. Secondo questa teoria, l'unica
religione a cui bisogna fare affidamento è quella in cui Dio spinge l'uomo ad
essere libero. In virtù di ciò, il popolo -che non è più plebe- deve essere
mosso dallo spirito di sacrificio, in quanto solo questo, insieme all'impulso
naturale e all'ira del popolo illuminato, aprirà la strada alla libertà.
(Shabnam Najaf Zadeh)
6. IL RISORGIMENTO RILETTO OGGI. GIORGIO RUFFOLO
L‟unità nazionale dell‟Italia viene considerata da Giorgio Ruffolo, autore del
libro “Un paese troppo lungo”, edito da Einaudi, malsicura e minacciata: essa
infatti, a suo parere, non è mai stata veramente attuata e la stessa
formazione dello stato italiano sembra costituire il risultato di una
concatenazione di eventi casuali. Ma accanto a quel Risorgimento, definito
dallo stesso Ruffolo, freddo, in quanto frutto di circostanze impreviste e di
opportunistiche adesioni, sussiste anche un Risorgimento caldo, che invece
nasce da slanci e sentimenti autentici e costituisce la vera forza ideale
risorgimentale. Il Risorgimento caldo viene identificato dall’autore con la parte
iniziale dei moti risorgimentali: a suo parere infatti le “gloriose sconfitte” di
inizio Ottocento furono più propulsive delle battaglie vinte in seguito.
E’ nell’Italia napoleonica che deve essere individuata la nascita del
sentimento nazionale nella popolazione e, pertanto, l’inizio della fase “calda”.
Napoleone Bonaparte, probabilmente consapevole di ciò, volle che l’Italia
restasse divisa tra repubbliche satelliti (Cisalpina, romana, partenopea) e
ducati, da spartire fra i parenti prossimi. In questo periodo tuttavia porzioni
minoritarie di popolazione iniziarono a sostenere una battaglia letterarioculturale, che non rimase finalizzata a vuote perorazioni retoriche, ma che si
concretizzò in quelle battaglie militari, che, sebbene si fossero rivelate un
fallimento sul piano politico-territoriale, alimentarono l’ideale nazionale.
A Napoli, nel 1799, esplose la prima grande fiammata del Risorgimento
italiano. Essa recentemente è stata oggetto di una dettagliata ricostruzione
ad opera di Enzo Striano, autore del romanzo il resto di niente. Napoli era
caratterizzata tanto dallo sfarzo vistoso quanto da una innegabile corruzione.
La regina Maria Carolina, temendo gli effetti della rivoluzione francese,
perseguitò, durante tutto il suo regno, “li Giacobbe”, ovvero i Giacobini, e
screditò l’élite intellettuale napoletana, tra le più brillanti in Europa. Sebbene
la stragrande maggioranza della popolazione fosse povera e ignorante,
oppure “si facesse gli affari propri” (B. Croce), lo strato colto della
popolazione, pur minoritario, ritenendo inaccettabili i soprusi della regina,
combatté per ottenere la libertà e la felicità, che raggiunse solo per poco più
di un semestre con la costituzione della Repubblica partenopea. Ma sarebbe
riduttivo considerare questi uomini coraggiosi solo come i fondatori
dell’effimera repubblica partenopea: essi infatti ridestarono l’Italia da un
profondo torpore e, secondo Ruffolo, costituirono la spinta originaria dei moti
risorgimentali. Anche a Roma iniziarono a svilupparsi sentimenti liberali alla
fine del Settecento. Le due Repubbliche che vennero realizzate in Roma in
quel periodo, ne sono la prova evidente, sebbene la prima possa risultare
una vittoria alquanto indecorosa1. La seconda Repubblica, invece,
sviluppatasi nel 1849, quasi mezzo secolo dopo, fu il risultato di un
improvviso cambiamento del clima politico: il nuovo papa Pio IX infatti non
solo decise di concedere un’amnistia ai condannati di reati politici, suscitando
una ondata irrefrenabile di entusiasmo, ma istituì anche una sorta di governo
e una consulta con un parlamento. E furono proprio queste concessioni
papali, nonché il forte patriottismo del popolo romano che portarono un
gruppo di uomini, guidati da P. Rossi e da Garibaldi, ad esautorare
completamente il potere temporale del papa nel 1849. Ma anche in questo
caso, sebbene il popolo romano combattesse senza tregua e “senza
speranza” (G. Ruffolo) venne sconfitto rapidamente dall’esercito francese.
Tuttavia quel popolo che ballava e cantava davanti al Quirinale, dopo la
vittoria, costituiva ormai l’emblema di quel sentimento liberale che iniziava ad
aleggiare nella popolazione.
1 La
prima Repubblica romana potrebbe apparire il frutto di un equivoco: alcuni giovani insorti contro la
tirannia pontificia, chiesero l’appoggio dell’ambasciatore francese, che li cacciò malamente, infuriato per una
simile compromissione. Ma un drappello di soldati pontifici che seguivano gli insorti, dopo aver varcato la
soglia dell’ambasciata, uccise accidentalmente un generale francese. Ciò determinò la nascita di un conflitto
fra i Francesi, a cui si allearono ovviamente i Giacobini romani, e il papa Pio VI, che sfociò in una vittoria
poco dignitosa, di fronte alla quale il popolo appariva indifferente e diffidente.
Nel frattempo, grazie a personaggi come Menotti a Modena, attraverso
ammutinamenti, complotti, insorgenze e impiccagioni crebbe lo spirito
collettivo nazionale nonché l’odio profondo nei confronti degli “Austriaci
colonizzatori” e la ferma convinzione espressa dall’esortazione di Menotti:
“Italiani, […] non dovete fidarvi che di voi stessi”.
Un altro evento emblematico del Risorgimento Caldo è sicuramente quello
delle “Cinque giornate di Milano”. Milano era una città operosa, con
un’aristocrazia colta (a differenza di quella napoletana), una borghesia
industriosa, una vasta classe mercantile e un ceto intellettuale che
appoggiava le correnti illuministe francesi (Cesare Beccaria, i fratelli Verri).
Una città tanto progredita non poteva rimanere soggiogata al potere
austriaco, e pertanto nacque un’insurrezione, che Radetzky, generale
austriaco, ricorda come una terribile rivolta che si estendeva a persone di
“ogni età e rango”. A capo della insurrezione vi era la figura di Carlo
Cattaneo, uomo di cultura vastissima ma, soprattutto, convinto federalista,
che affermava la necessità di realizzare uno stato unitario, quando tutte le
regioni avessero raggiunto il livello economico della Lombardia. Egli
interpretò perfettamente la volontà popolare, opponendosi fermamente alle
proposte di un armistizio, che avrebbe indebolito lo slancio della lotta. E
contrariamente a ciò che molti pensano egli si rivelò anche un nazionalista
convinto, come risulta dalle pagine che dedicò a Roma e al tricolore.
Chiaramente anche le “Cinque giornate” si conclusero in un fallimento dal
punto di vista politico-militare, ma certamente rafforzarono la coesione e la
solidarietà popolare.
Sorte analoga ebbe Venezia, con la figura di Daniele Manin, che guidò
un’insurrezione contro gli Austriaci, a guisa di Garibaldi a Roma e di Cattaneo
a Milano. Anche in questo caso la libertà sopraggiunta durò molto poco ma gli
Austriaci lasciarono partire indenni, per l’esilio, tutti i capi della resistenza.
Con il 1849, pertanto, si chiudeva quell‟epoca di rivolte e insurrezioni che
coinvolsero non solo le classi intellettuali ma anche quelle classi popolari che
fino a quel momento erano risultate succubi dello strapotere dei ceti nobiliari.
Ma il popolo fu in grado di riscattarsi solo grazie alla guida di uomini risoluti,
come Garibaldi, Cattaneo e Manin, che, interpretando la volontà popolare,
portarono a termine azioni vittoriose contro eserciti di militari professionisti.
L’unità d’Italia, tuttavia, non fu realizzata attraverso queste entusiasmanti
rivolte bensì attraverso una serie di azioni studiate e premeditate: esse
costituiscono il Risorgimento freddo, di cui Cavour, economista e conoscitore
attento delle realtà europee, fu il regista spassionato governando
prudentemente (nel senso latino del termine) il Piemonte. Egli innanzitutto
integrò i fuoriusciti italiani e li sostenne finanziariamente, portò a compimento
una quanto mai ardita riforma laica dello stato, modernizzò tecnicamente le
aziende e le liberalizzò. Fu in grado di sostenere queste grandiose riforme
grazie al forte sostegno del parlamento, con cui Cavour seppe collaborare
magistralmente.
Per quanto concerne la politica estera, Cavour dovette trovare delle alleanze
in Europa, in cui alla diminuzione del potere austriaco corrispose l’aumento di
quello dell’Italia. Egli decise di conquistare ancora più prestigio sulla scena
europea con la partecipazione alla guerra in Crimea, alla quale non lo legava
alcun interesse territoriale. Il Piemonte, pertanto, si alleò con la Francia di
Napoleone III. Cavour e Luigi Napoleone si accordarono che in caso di
vittoria sarebbero stati costituiti un regno dell’alta Italia, comprendente
Piemonte Lombardia e Veneto, un regno dell’Italia centrale, comprendente
Toscana ed Emilia, lasciando il Meridione ai Borbone. All’ultimo momento
sembrò svanire il sogno di Cavour: Inghilterra e Russia vollero risolvere
pacificamente il conflitto. L’Austria, tuttavia, offesa da una provocazione
orchestrata da Cavour, attaccò comunque il Piemonte, che resistette anche
grazie alle auxilia francesi. Infine tuttavia le numerose perdite di soldati nelle
battaglie sul Mincio e presso Solferino costrinsero i Francesi a chiedere
l’armistizio di Villafranca, che prevedeva anche il reinsediamento dei sovrani
nei regni e ducati dell’Italia centrale. Cavour fu costretto alle dimissioni.
Tuttavia la restaurazione non avvenne in quanto nessuna potenza europea
volle contrastare l’Italia. Sorse proprio in questo periodo l’idea di Mazzini di
unificare il paese attraverso l’invasione piemontese dell’Abruzzo e delle
Marche e quindi del Mezzogiorno. Il disegno mazziniano si compì realmente
in seguito ma senza Mazzini. Sebbene tutta questa concatenazione di eventi
possa apparire al lettore assai casuale, essa in realtà costituisce il risultato di
un movimento “di fondo” (G. Ruffolo), di un’azione popolare ben determinata.
L’impresa più nota che permette di caratterizzare con maggiore precisione
questo Risorgimento freddo è sicuramente l’impresa dei Mille, a lungo
vagheggiata da Mazzini, ma portata a termine lungo due distinte direttrici da
Cavour e Garibaldi: il primo attraverso l’invasione da Settentrione delle
Marche e dell‟Umbria, il secondo attraverso l‟invasione del regno borbonico
dalla Sicilia. Garibaldi poté portare a termine la sua operazione grazie alle
condizioni di insorgenza che si erano ormai definite in Sicilia contro i
Napoletani. Tuttavia è una serie di fortunati eventi che porterà Garibaldi alla
conquista del regno borbonico: infatti raggiunta la Sicilia, sebbene una nave
borbonica avesse visto arrivare l’imbarcazione piemontese, non sparò,
attendendo il permesso degli Inglesi, permettendo ai Mille di sbarcare con
tranquillità; Successivamente, presso Calatafimi, i Garibaldini, sebbene
avessero perso numerosi uomini, riescono a conseguire una vittoria grazie
all’intervento di alcuni uomini che erano casualmente rimasti indietro lungo il
tragitto.; a Palermo “per il volere della provvidenza” (Garibaldi) il comandante
napoletano Lanza, sebbene stesse vincendo la battaglia, decise di
patteggiare e di permettere ai Garibaldini di attraversare la città (ciò fu
possibile anche grazie alla eccezionale indole diplomatica e strategica di
Garibaldi). L’unico momento in cui la fortuna sembra abbandonare Garibaldi
è quello dell’attraversamento dello Stretto: l’imbarcazione infatti aveva una
falla; il grande senso pratico di Garibaldi gli permette tuttavia di turarla e di
ripartire. Fu invece solo la genialità del generale a permettere la vittoria della
battaglia del Volturno, in cui con una serie di manovre strategiche riesce a
sconfiggere l’esercito napoletano, che non solo era più numeroso, ma
possedeva anche armi nettamente migliori ed era sostenuto dalla
popolazione. Garibaldi a questo punto sarebbe potuto diventare il dittatore
delle due Sicilie, ma fu prevenuto da Cavour e dal re. Dopo la consegna del
regno borbonico al re Vittorio Emanuele II da parte di Garibaldi presso Teano,
l’Italia tuttavia risulta solo apparentemente unita: in realtà proprio in quel
momento si profilarono due Italie.
Normalmente le opinioni degli storici riguardo al Risorgimento risultano
seguire due interpretazioni opposte: quella di Benedetto Croce, e quella di
Gramsci.
Benedetto Croce ritiene che tutto il Risorgimento sia il frutto dell’azione di una
minoranza acculturata della popolazione, che trionfò su una maggioranza
inerte: nel suo complesso, esso risulterebbe l’affermazione del sentimento
liberale italiano, successivamente tradito dall’ascesa del fascismo, di cui è
l’antitesi.
Secondo Gramsci invece il Risorgimento si rivelò una costruzione fragile
poiché il sentimento rivoluzionario non si tradusse nella mobilitazione delle
masse contadine ma in una politica moderata, che prevalse sul sentimento
democratico. Ciò, secondo la tesi gramsciana, ebbe risvolti negativi anche dal
punto di vista economico a causa di una mancata distribuzione delle terre, da
cui è conseguito l’immobilismo sociale nelle campagne, e quindi una
limitazione all’espansione dell’industria, che non era sorretta dalla domanda,
né alimentata da un’abbondante offerta di lavoro. La mancanza di un’alleanza
dello Stato con il mondo contadino meridionale provocò una permanente
spaccatura fra lo Stato e la società civile e l‟esasperazione del dualismo fra
Nord e Sud. Dopo il Risorgimento peraltro la società meridionale risultava
composta da quattro classi: la grande massa contadina amorfa, la borghesia,
i grandi proprietari terrieri e lo strato degli intellettuali. Questi ultimi non sono
in grado di interpretare la volontà popolare e di tradurla in riforme condivise e
avvertono il mondo contadino come una minaccia. Il vuoto creatosi fra lo
stato e la società permise secondo Gramsci la successiva nascita del
fascismo, le cui radici sarebbero da rintracciare proprio nel Risorgimento.
Dal punto di vista economico-sociale le tesi gramsciane vengono spesso
osteggiate: Rosario Romeo per esempio in “Risorgimento e Capitalismo”
sembra escludere il fatto che i contadini avessero quel forte potenziale
rivoluzionario che Gramsci attribuiva loro. I contadini assistevano in modo
passivo (talvolta addirittura ostile) agli avvenimenti risorgimentali e, peraltro,
difficilmente la borghesia settentrionale avrebbe intrapreso rapporti
commerciali con il sud Italia, essendo maggiormente interessata a
intrattenere rapporti con i mercati esteri ricchi.
In ogni caso va criticata, secondo Ruffolo, la demolizione fine a se stessa dei
moti risorgimentali in quanto essa rischierebbe di corrompere la ricerca della
verità. Il Risorgimento deve essere considerato nella sua vera portata, come
un evento importante, o addirittura fondante del nostro paese.
Negli anni “60 dell’Ottocento mentre il Nord sembrava uscire da un lungo
torpore economico, il Sud appariva invece molto più arretrato: infatti in
Piemonte, Lombardia e Toscana progredì notevolmente la filatura del cotone
e della seta soprattutto a livello artigianale quando nel Mezzogiorno
sopravvivevano ancora estesi latifondi posseduti da nobiltà e clero. Dal punto
di vista politico inoltre sorsero altri problemi: infatti il conflitto con la Chiesa
cattolica allontanò molti cittadini della partecipazione attiva della vita politica e
gli uomini di destra che governarono in principio l’Italia cercarono invano di
porre rimedio alla eterogeneità attraverso una costituzione fortemente
accentratrice, soluzione definita dallo stesso Ruffolo “stupida e ingenua”.
Una delle cause dell’arretratezza del Mezzogiorno va ricondotta all’utilizzo di
sistemi di coltivazione antiquati, nonché alla presenza di vaste distese
paludose e malariche. A livello industriale, invece, la scarsa capacità di
ricorso al credito e quindi lo scarso investimento di capitali, causarono una
bassa resa produttiva. Al contrario, al Nord, reti di scambio ricche e articolate
permisero un notevole sviluppo che si contrappose all’arretratezza
meridionale. Secondo Ruffolo, questa “questione agraria” sta alla base della
“questione meridionale”, costituendo peraltro un fattore scatenante della
“guerra di repressione” contro il brigantaggio.
Questo fenomeno si differenziò dalla criminalità “privata”, in quanto contrastò
soltanto le istituzioni statali: esso fu generato dalla diffidenza della
popolazione nei confronti dello stato, che, come affermato precedentemente,
non riuscì ad apportare una reale redistribuzione delle terre; inoltre, un calo
della fiducia nelle istituzioni fu causato dall‟obbligo di coscrizione militare, che
determinò l’allontanamento degli uomini dalle famiglie per lunghi periodi e il
conseguente impoverimento della società contadina. Le bande dei briganti
pertanto non erano formate soltanto da delinquenti comuni, ma soprattutto da
quegli uomini appartenenti al mondo contadino che non si sentivano tutelati
dalle istituzioni statali: essi in molti casi avevano sperato nella vittoria dei
Garibaldini, ma erano rimasti successivamente delusi dal governo
piemontese. La collera portò questi uomini a uccidere i propri nemici in modo
violento e spesso truce, incrementando i pregiudizi del popolo settentrionale
nei confronti dei Meridionali e pertanto esasperando quel dualismo Nord-Sud
che caratterizza tuttora la società italiana. Nino Bixio, per esempio, definiva le
regioni meridionali dei “veri porcili” in cui gli uomini non hanno “il senso del
giusto e dell’onesto e “straziano” il nemico. Anche Massimo d’Azeglio, L.
Carlo Farini e Ippolito Nievo disprezzarono amaramente il comportamento dei
Meridionali, mentre Napoleone Colajanni confermò in una lettera la diffusione
dei pregiudizi nei confronti del Mezzogiorno anche all’interno delle classi
colte. Il Nord pertanto attaccò altrettanto brutalmente il brigantaggio
meridionale senza prestare ascolto a Cavour, che prima di morire aveva
sconsigliato una dura repressione, ritenendo la libertà l’unico strumento che
avrebbe permesso lo sviluppo economico-sociale di quel popolo. La guerra
costituì infatti un fallimento sul piano sociale, poiché i nobili mantennero un
ruolo predominante sulla massa di contadini, che risultarono i veri sconfitti
della guerra. Pertanto, a differenza della Guerra di Secessione americana in
cui il Nord si era battuto per la liberazione degli schiavi del Sud, nella Guerra
di Repressione italiana, secondo Ruffolo, il Nord si era battuto per reprimere
gli schiavi del Sud, ovvero i contadini.
Dopo la guerra contro il brigantaggio, il dualismo italiano assunse un
carattere sempre più evidente e rilevante: nel primo dopoguerra, con
l’adozione di un modello libero-scambista, sia il Nord che il Sud sembrarono
progredire a livello agricolo; ma le industrie italiane, necessitando di
investimenti, non riuscirono a svilupparsi senza il sostegno dello Stato che,
pertanto, convertì il modello liberista in un modello protezionista già condiviso
da tutti i paesi europei, ad eccezione dell’Inghilterra; in tal modo lo Stato
diveniva protagonista dell’economia, governando l’aumento dei dazi a favore
dei vari settori industriali. Ciò permise un notevole progresso delle industrie
settentrionali che non solo venivano finanziate dallo Stato (furono definite
ironicamente “Trivellatori” delle casse statali da L. Einaudi), ma spesso
rappresentavano vere e proprie aziende parastatali. Il Mezzogiorno, al
contrario, non riuscì ad uscire dal torpore che caratterizzava la sua economia
industriale. Il protezionismo permise pertanto l’industrializzazione dell’Italia
settentrionale, da cui derivò la nascita della figura dell’industriale
professionale (Agnelli, Pirelli, Olivetti), che interessato a promuovere lo
sviluppo tecnologico, più che il proprio inserimento nella politica. Il modello
protezionista venne presto sostituito con quello liberista-capitalista; accanto
allo sviluppo industriale e tecnologico, tuttavia si inserì un risvolto speculativo,
originato dall’intreccio, patologico, della politica con il mondo affaristico. A
Roma, nel periodo giolittiano, la speculazione edilizia assunse proporzioni
colossali: essa determinò, allo stesso tempo, la nascita e il fallimento delle
prime grandi banche italiane. Lo stesso Giolitti rimase implicato in un grave
scandalo e dovette fuggire in Germania. Le industrie settentrionali riuscirono
tuttavia a resistere alla crisi bancaria che ne conseguì. Il maggiore sviluppo
industriale del Paese si concentrava nel cosiddetto triangolo industriale ai cui
vertici erano situate le città di Torino, Genova e Milano. Esso assunse
caratteristiche simili a quelle di Francia e Germania. Nacquero in questo
periodo le tesi di coloro che ritenevano le fortune del Nord, frutto dello
sfruttamento del Mezzogiorno. E’ tuttavia ormai opinione condivisa dalla
maggior parte degli storici che lo sviluppo del Nord avvenne in modo del tutto
autonomo e che la causa dell’arretratezza del Mezzogiorno sia da ricondurre
alla mancanza di un rapporto diretto con le economie degli altri paesi europei
e a quella “Guerra di repressione” che accentuò il potere dei latifondisti sui
contadini. La Sicilia peraltro rimase la regione più arretrata del Meridione
anche dal punto di vista agricolo: i metodi con cui si coltivava la terra (che di
per sé era ed è molto più fertile di quella toscana) erano assai arretrati e
l’usura rimase assai diffusa anche agli inizi del XX secolo; lo stesso
Franchetti affermò in un suo saggio che “la sola ricchezza del contadino è la
festa religiosa della domenica”: per questo motivo, sebbene i contadini
siciliani fossero ferocemente sfruttati anche dal mondo ecclesiastico,
rimasero sempre legati alla religione cattolica, da cui non erano aiutati ma
perlomeno compianti.
L’arretratezza economico-sociale del Sud diede origine a tre conseguenze:
l’emigrazione verso altri paesi economicamente più avanzati, l’”invasione
burocratica” del Mezzogiorno e la nascita della realtà mafiosa. Per quanto
concerne l’emigrazione, essa risultò un mezzo per fuggire dalle oppressioni
dello stato (elevata tassazione, coscrizione militare obbligatoria) e per
cercare “nuova fortuna”, sebbene comportasse tremendi disagi, materiali e
morali. La diminuzione della forza lavoro e l’aumento dei salari che ne
conseguirono furono estremamente sfavorevoli ai proprietari: il governo cercò
quindi invano di impedire sia l’emigrazione clandestina sia quella legale,
senza risultati soddisfacenti. Essa calerà solo durante la seconda guerra
mondiale e dopo gli anni Settanta del Novecento. La seconda “risposta del
Sud” (Ruffolo) fu, come detto in precedenza, la “burocratizzazione del
Meridione” o “meridionalizzazione della burocrazia”: lo Stato cercò di ottenere
una maggiore fiducia nel Mezzogiorno, restio alle istituzioni statali, inserendo
i cittadini meridionali all’interno dell’ambiente burocratico: ciò determinò un
distacco dello Stato dal Nord, in cui erano situate le maggiori imprese del
paese. Peraltro nel Meridione si ottenne l’effetto opposto rispetto a quello
desiderato, indebolendo, anziché rafforzare, il rapporto fra Stato e società e
creando le condizioni favorevoli alla formazione di organizzazioni intermedie
criminose: le mafie. Queste organizzazioni, approfittarono della sfiducia dei
cittadini nei confronti dello Stato per farne le veci. Esse non costituiscono
pertanto, secondo Ruffolo, un residuo feudale, bensì organizzazioni nate
contemporaneamente allo sviluppo del capitalismo, alla cui logica
dell’accumulazione legarono quella della violenza. Lo Stato centrale perse
quindi progressivamente la sua prerogativa essenziale: il monopolio della
forza, come dimostra il caso Notarbartolo, sindaco di Palermo, contro il quale
si scagliarono, nel 1893, le organizzazioni mafiose, assassinandolo.
Queste “risposte del Sud” ovviamente non ridussero la dicotomia Nord-Sud,
bensì l’accentuarono considerevolmente: il Nord, florido e in costante crescita
economica, si contrapponeva alla ristagnante economia del Mezzogiorno, in
cui, come afferma lo stesso Ettore Ciccotti, “l’assenza di stimoli alla
conoscenza e all’intrapresa inclina al parassitismo”. Il Risorgimento aveva
dato pertanto origine ad un’Italia non solo eterogenea sul piano culturale, ma
anche su quello economico-sociale; Ruffolo nutre tuttavia la speranza che la
porzione di popolazione acculturata, riesca, a guisa dei letterati durante i moti
risorgimentali, a mantenere nel Paese quella coesione necessaria per
fronteggiare le sfide dell’economia globale: come egli stesso afferma
concludendo l’Introduzione al suo libro “una speranza, per quanto
controversa, c’è.
(Andrea Poli)
7. IL RISORGIMENTO RILETTO OGGI. A.M.BANTI
Alberto M. Banti , nel suo saggio “La nazione del Risorgimento, sottolinea il
fatto che per molto tempo la storiografia, sia ottocentesca sia
contemporanea, non si è occupata di come sia nato il concetto di identità
nazionale nell'Italia del Risorgimento, concetto che è stato considerato un
dato di fatto. Solo negli ultimi anni gli eventi internazionali e interni hanno
costretto tutti, collettività e specialisti, a esaminare la questione dell’identità
nazionale da una nuova prospettiva. Ciò nonostante, gli studi si sono
concentrati soprattutto sulla fase postunitaria, sul bisogno del neo-Stato
italiano di diffondere una vera e propria pedagogia della nazione, mentre
continua a mancare un esame dei significati che, già durante il Risorgimento,
si attribuivano all'idea di nazione.
Ma che cos’erano la nazione e la patria per gli uomini e le donne del
Risorgimento? Che cosa designavano queste parole in nome delle quali,
nella prima metà dell’Ottocento, molte persone decisero di agire, e di farlo
pericolosamente, rischiando l’esilio, la prigione, la vita?
Patria e nazione all’epoca volevano dire qualcosa di notevolmente diverso
rispetto al significato che avevano avuto fino alla fine del Settecento. Esse,
infatti, avevano subito un mutamento importante, di quelli che segnano in
profondità il panorama concettuale di un intero periodo.
Ma prima è opportuna una veloce analisi su quali fossero i principali significati
che ne l corso del XVIII secolo erano stati attribuiti a quelle due parole.
Il termine patria possedeva due accezioni preminenti. Da un lato stava ad
indicare “luogo dove si nasce o dove si trae origine”, e poteva riferirsi al
singolo paese natio, o alla città natale, o a un più ampio ambito territoriale;
capitava, così, che patria designasse tanto singole città, quanto regioni come
la Sardegna o la Sicilia, oppure stati come la Repubblica di Venezia, il regno
di Napoli, oppure aree culturali come l’Italia e la Germania. Dall’altro lato
patria aveva anche il significato di sistema politico- istituzionale al quale i
sudditi o i cittadini dovevano lealtà, quando fosse stato regolato dalla virtù di
un buon principe o di un buon corpo di magistrati.
Il termine nazione possedeva, invece, tre significati principali. In un’accezione
arcaica, ma registrata dai vocabolari, poteva significare “nascita”, ovvero
“estrazione familiare, o sociale”; in forma derivata da questo etimo, voleva
dire “generazioni di uomini nati da una medesima provincia, o città”, una
variante che proiettava su un soggetto collettivo il primo significato censito
per il termine patria. A partire da questo ambito semantico, nazione aveva
acquisito anche il senso di collettività dotata di “habitus” comune, fatto di usi e
costumi specifici e differenziati rispetto a quelli di altre collettività appartenenti
ad ambiti territoriali diversi.
A partire dall’inizio del Settecento, infine, il termine si arricchiva anche di un
terzo campo semantico, specificamente votato a designare l’esistenza di una
comunità culturale italiana, dotata di lingua e letteratura comune. L’origine
della nazione italiana si ebbe, storicamente, con l’espansione di Roma,
quando la città estese a tutti i municipi della penisola i privilegi della città
originaria. Se la patria italiana era una koinè storica e culturale, tuttavia il
patriottismo che ne deriva non si traduceva in negazione dei fondamenti della
sfera pubblica degli antichi stati, della legittimità delle loro istituzioni, della
sovranità dei loro principi. Anzi, qui trovano conciliazione due modi diversi di
essere patriota: se sul piano culturale era necessario cercare di contribuire al
progresso delle arti e della scienza che facevano dell’Italia una nazione, sul
piano politico la fedeltà alla propria “piccola patria” era assolutamente fuori
discussione.
Così il vocabolario politico risorgimentale, oltre a riutilizzare termini già
ampliamenti utilizzati nel discorso politico, è anche caratterizzato da almeno
due fondamentali novità: uno riguarda la presenza di nuovi lemmi in
precedenza esclusi, com’era certamente il caso del termine nazione: nel
triennio giacobino questo termine, pur non perdendo gli antichi significati, fu
sottoposto ad un arricchimento del proprio campo semantico, che lo
condusse trionfalmente all’interno del nuovo lessico politico rivoluzionario,
perché andava a descrivere proprio la comunità fondamentale, il soggetto
originario, da cui discendeva la legittimità delle istituzioni che in uno spazio e
in un tempo dato avrebbero dovuto disciplinare la vita collettiva.
La seconda novità riguardava, in un certo senso, la morfologia complessiva
del nuovo paradigma lessicale utilizzato per parlare del politico e della sfera
pubblica, e derivava direttamente dall’arricchimento semantico cui era
sottoposto il termine nazione; proprio questa parola, infatti, tese ad assumere
una posizione centrale nella logica della nuova costellazione concettuale,
tanto da subordinare a se tutti, o quasi, gli altri lemmi che vi appartenevano.
Diversamente da ciò che accadeva nei decenni precedenti, ora patria non
indicava indifferentemente qualunque sistema istituzionale fosse governato
con giuste leggi, ma un singolo assetto costituzionale. Ovvero quello di una
repubblica dotata di istituti rappresentativi: pertanto, come scrive Erasmo
Leso, patriottismo non indicava più il generico “amor per la patria”, ma
specificamente, “ l’amore della patria democratica e repubblicana” la somma
cioè degli atteggiamenti e degli orientamenti etico- politici dei patrioti.
Proprio negli ambienti patriottici si parlava sempre più frequentemente di
nazione o patria italiana e, ciò che è ancora più importante, proprio sulla base
dei diritti alla sovranità della nazione si cominciarono a formulare progetti di
formazione di uno stato unitario italiano. A far decollare il discorso su un
possibile stato unitario italiano dette un contributo decisivo Filippo Buonarroti,
principale mediatore tra Direttorio e gli esuli italiani a Nizza.
L‘evoluzione del pensiero di Buonarroti è documentata da diverse lettere; le
ultime testimoniano un fondamentale cambiamento di registro rispetto a
lettere scritte precedentemente : mentre in queste si parlava, genericamente,
di unità d’azione tra i patrioti italiani, nelle ultime, più esplicitamente, si
tracciavano le linee per la convocazione di una convenzione nazionale in
grado di elaborare la costituzione per uno stato italiano.
Questi progetti che lo stesso Buonarroti abbandonò in quanto arrestato, non
vennero, comunque, lasciati cadere.
Chi si espresse a favore del progetto di una repubblica italiana, sostenne
questa opinione facendo ricorso soprattutto a d argomenti di carattere militare
e politico- costituzionale.
Uno stato con un territorio così ampio e una popolazione così numerosa,
come la possibile repubblica italiana, avrebbe meglio resistito alle pressioni
delle potenze vicine, cancellando così la debolezza che da secoli aveva
minato le varie e numerose formazioni statali che avevano convissuto nella
penisola.
Il presupposto logico che sostiene tutte queste proposte era l „esistenza di
una nazione italiana che, in quanto unica depositaria della sovranità, aveva
diritto di trovare riconoscimento in una repubblica di cui potesse scegliere gli
assetti istituzionali. Sapere quali erano i caratteri di questa nazione, sapere
perché ad essa si riconoscesse una priorità sulle nazioni piemontese, o
lombarda, o veneziana, di cui pure, in questi anni, si continuava a parlare,
avrebbe dovuto essere un passaggio ineliminabile, tanto più impellente,
quanto più centrale era il ruolo che, teoricamente, si attribuiva alla nazione
come soggetto fondativo del politico.
Alla fine del Settecento, sull’esistenza di una coesa comunità nazionale,
legata a profondi vincoli di italianità, si potevano sollevare molti e seri dubbi;
gli stati esistenti erano dodici, spesso molto diversi tra loro per storia,
modalità di formazione, e istituzioni.
Le numerose città che costellavano la penisola erano amministrate in modi
differenti, in ragione delle leggi generali dei diversi stati in cui erano incluse,
così come degli innumerevoli statuti o regolamenti cittadini ancora attivi, che
ciascuna di esse poteva vantare.
All’ inizio dell’Ottocento una notevole omogeneizzazione normativa ed
istituzionale era stata introdotta dalle riforme cui era stata sottoposta l’Italia
durante l’epoca napoleonica.
Mentre da un lato l’esperienza era stata breve, dall’altro la riorganizzazione
istituzionale dei nove stati della Restaurazione aveva reintrodotto varianti
normative e istituzionali che di nuovo differenziavano, talora profondamente,
l’uno stato dall’altro. Effetti più coesivi avevano le attività produttive e
commerciali.
Prendiamo il Sud della penisola: montuoso, povero di strade, privo di fiumi
agevolmente navigabili.
Parti apprezzabili del volume delle produzioni agricole o tessili si fermavano
intatti nell' ambito delle famiglie contadine sotto forma di retribuzioni in natura,
o di quote,di beni prodotti, o come risultato delle attività lavorative marginali
svolte dalle donne della famiglia.
Un altro gruppo di prodotti prendeva invece la strada dei mercati settimanali o
delle grandi fiere periodiche.
In effetti lo spazio mercantile che davvero contava era un altro : era quello del
commercio a lunga percorrenza di prodotti agricoli come l'olio o il grano, che
erano destinati a mercati urbani lontani dalle aree di produzione, o che,
soprattutto venivano indirizzati verso l’esportazione.
Ma quali erano le destinazioni? Nel corso del Settecento le rotte commerciali
che partivano dal sud cominciarono a prendere altre direzioni: verso ovest le
nuove mete erano la Francia (Marsiglia), l Olanda, l’Inghilterra; verso est era
Trieste che lentamente andava a soppiantare lo sbocco veneziano e ad
assicurare un ponte commerciale con i mercati della Mitteleuropa.
L „economia che più si rese partecipe del processo di industrializzazione fu
quella meridionale: essa riuscì a trascinare con se anche un’altra
trasformazione significativa, questa volta nella composizione merceologica
dei prodotti destinati all’esportazione.
Tra fine Settecento e inizio Ottocento cominciò infatti a declinare il peso fin
allora prioritario dell’esportazione granaria, mentre sempre più importanti si
fece il ruolo dell’olio.
Le destinazioni di questo prodotto erano, certamente, tavole delle famiglie più
ricche di Inghilterra, Germania, Olanda, sebbene in realtà non fosse
necessariamente questa la corrente primaria di vendita. Una parte cospicua
era infatti destinata alle industrie tessili inglesi, avide del cosiddetto cloth oil
impiegato nel processo di filatura dei panni; e un’altra parte ancora, costituita
dagli oli di scarto, quelli di qualità più scadente, si indirizzava verso Marsiglia,
dove erano le industrie produttrici di saponi e farne un uso intensivo.
L’olio rappresentava allora il collegamento stretto dell’economia meridionale
con le aree della grande trasformazione economica.
Altri prodotti strettamente collegati ad esse erano lo zolfo, gli agrumi, che si
indirizzarono inizialmente verso l’ Inghilterra, ma che ben presto trovarono la
strada di mercati assai più lontani, e, successivamente, il vino, destinato ad
essere usato sul mercato francese soprattutto come vino da taglio. I mercati
che ricorrono ai prodotti dell’agricoltura meridionale sono soprattutto esterni
alla penisola.
I rapporti commerciali con gli stati dell’ Italia preunitaria erano infatti assai
ridotti sia che si osservino i flussi e le quantità delle esportazioni, o che
invece ci si concentri sul traffico di importazione. Appare, quindi, chiaro che
l’economia meridionale apparteneva ad un circuito commerciale che la
ricollegava saldamente ai paesi del Nord e del centro Europa, mentre i flussi
di scambio con gli altri stati della penisola erano piuttosto modesti.
Ma il punto cruciale è che le varie economie d’Italia erano costituite intorno ad
una rete di interdipendenze interne ed esterne che rendevano non
conveniente o non necessaria l’attivazione di circuiti e transazioni reciproche.
I mercati meridionali, mal strutturati al loro interno, e modesti quanto ad
intensità di domanda, non potevano costituire un esito attraente per i beni
industriali prodotti nelle aree settentrionali; e viceversa i prodotti agricoli
meridionali più pregiati, come gli agrumi, l’olio o il vino, erano troppo costosi
per i mercati ancora comparativamente poveri dell’Italia centrosettentrionale.
E così, nonostante ci fossero forme di parziale integrazione fra stati diversi, ci
si trovava di fronte ad un’ impotente disarticolazione commerciale.
Il patrimonio linguistico e letterario che diversi indicavano come uno dei
principali legami tra popoli della penisola era una questione che riguardava
solo fasce ristrettissime di elite colte.
Al momento dell’ Unita d’Italia coloro che parlavano correttamente l’italiano
come prima lingua, erano un’infima minoranza sul totale della popolazione
del neonato Regno d’Italia.
Tutti gli altri facevano uso del dialetto, o di una lingua straniera, come per
esempio il francese in Piemonte.
All’inizio del XIX secolo, alcuni dei personaggi più in vista della scena
letteraria della penisola misero al centro delle loro fatiche il tema della
nazione italiana dei suoi diritti.
Un ruolo di primo piano, in questa dinamica, lo svolse senza dubbio Ugo
Foscolo.
La fortuna di letterati come Foscolo dipese dalla capacità che ebbero di
muoversi con efficacia sul mercato pubblicistico o su quello degli impieghi
pubblici o semipubblici. Che ad elaborare il tema della nazione fossero
proprio delle stelle del firmamento letterario dell’epoca come Foscolo, fu
proprio ciò che contribuì a renderlo particolarmente interessante per il
pubblico colto.
Il tema della nazione si sganciò del tutto dall’ambito dell’ingegneria
costituzionale, che aveva dominato il dibattito politico nei sei anni precedenti
il 1802, e si proiettò nello spazio della produzione poetica, narrativa,
melodrammatica, pittorica.
Insomma, una tragedia, una poesia, un romanzo, o un’opera lirica potevano
facilmente toccare corde profonde nell’animo di un numero
incomparabilmente maggiore di fruitori, di quanto non fosse mai stato
possibile per un freddo e distaccato saggio analitico.
Il Risorgimento è, secondo Banti, un fenomeno generazionale, eversivo.
È quando si è giovani che si “scopre” la nazione, che si abbraccia l’idea di
battersi per essa.
Dunque il Risorgimento si può anche definire un fenomeno di ribellione
giovanile. Ma non di ribellione contro l’autorità della famiglia. Da essa
vengono, invece, i primi insegnamenti etico- politici che predispongono ad
atteggiamenti politicamente eversivi.
Il ruolo della famiglia, e del vincolo che lega una generazione all’altra, risulta
infatti fondamentale nel discorso nazionale del Risorgimento.
Né la famiglia, né gli istitutori, né la scuola sono i vettori attraverso i quali
passa, per la prima generazione di patrioti, l’iniziazione al credo nazionale,
alimentata piuttosto dalla lettura di testi appartenenti alla produzione letteraria
nazional- patriottica.
Qualcosa cambia per la generazione successiva, quella composta da
individui nati dopo il1815.
Ecco che ora i familiari cominciano a diventare le fonti dei primi messaggi di
carattere nazional- patriottico.
La lettura di testi poetici o narrativi non era l’unico modo per “scoprire” la
nazione italiana. È perfettamente nota l’importanza della costituzione o della
partecipazione a gruppi settari, o ad iniziative politiche clandestine, di un tipo
o di un altro: attività ampiamente descritte anche nella stessa memorialistica
risorgimentale.
Occorre, così, ricordare il rilievo speciale che alcuni di questi testi
attribuiscono al pensiero di Mazzini, e alla propaganda della Giovine Italia.
L’azione propagandistica svolta da quest’ultima nei primi anni “30 e “40 è
fatto molto noto, ma queste testimonianze pongono però bene in evidenza la
forza comunicativa del pensiero mazziniano, evidentemente ricco di
risonanze e di fascino soprattutto per i giovani, e in particolare per gli studenti
di diverse università italiane.
La storiografia che si è occupata della letteratura e della saggistica
risorgimentale ha, di norma, posto in evidenza le profonde diversità delle
convinzioni ideologiche, delle sensibilità filosofiche, delle aspirazioni politiche,
che animarono intellettuali, letterati e leader politici risorgimentali.
Ma se lasciamo sullo sfondo le loro preferenze politiche, e li ascoltiamo solo
ed esclusivamente mentre parlano della nazione italiana,ebbene, ecco che le
differenze cadono: una lettura riavvicinata dei lavori del “canone
risorgimentale” mostra la ricorrenza piuttosto sistematica di una serie di temi
e di figure, tra loro connessi, che delineano una sorta di narrazione coerente
della nazione italiana, qualcosa che potremmo chiamare la morfologia
elementare del discorso nazionale.
Banti, a questo proposito, esamina con grande attenzione molti testi letterari
che hanno come seguito giuramenti, patti, (immaginati da Manzoni, da
Berchet, da Cammarano , auspicati da Mazzini…) e afferma che sono essi a
dare origine alla nazione.
Quegli atti di volontà non riguardano la costituzione della comunità nazionale.
Siamo, invece, di fronte a qualcosa che va assunto in forma molto più
letterale.
Siamo nel momento del risveglio eroico della nazione, non nella fase della
sua fondazione. I giovani ora “giurano” di spezzare l’oppressione straniera, di
restituire alla madrepatria le terre che le appartengono, di dare uno stato alla
nazione.
Non hanno bisogno di partecipare a un «contratto sociale” fondativo della
nazione, perché la nazione esiste già; essi ne fanno già parte: non sono che
una delle tante generazioni di una immemorabile comunità di destino, la
generazione più fortunata forse, da tanto tempo la più virile, la più
coraggiosa, ma non certo la prima.
La nazione esiste già, e le sue connotazioni sembrano relativamente precise.
Dai testi manzoniani si enuncia come ci siano due forme di aggregazione che
si pongono su piani diversi:'l'appartenenza alla nazione ha il carattere di
un' ontologia naturale che non può essere nascosta; i patti, al contrario,
appartengono alla sfera dell' arbitrario, del transeunte, e possono
dolorosamente contraddire, tanto quanto gloriosamente esaltare, l'ontologia
nazionale.
Dunque una pratica che appartiene all' arbitrario, al politico, quella dei patti, si
giustappone a una realtà più profonda, esclusa dall' ambito della scelta,
quella del sembiante, della discendenza, del linguaggio.
Cosi la nazione non deve essere costituita attraverso un' azione politica,
attraverso un esercizio di volontà. Essa, infatti, appartiene a un' altra
dimensione, quella dei legami stabiliti, una volta per tutte, dalla natura,
secondo alcuni, oppure da una volontà metafisica, da Dio stesso, secondo
altri.
Ascoltando, invece, Vittorio Alfieri si nota come egli enunci il principio che
deve funzionare da soffio animatore per la rinascita della nazione italiana,
ovvero l'odio contro i francesi; dopodiché passa a descrivere i caratteri
fondamentali della nazione, che sono, immancabilmente, un luogo proprio,
una lingua propria e dei costumi propri, tutti elementi che conferiscono
all’Italia una “Unità”. La natura, quindi, per questo autore, è all' origine della
costituzione della comunità nazionale. Mazzini, invece, ricorre a una sorta di
ipotesi poligenica dell’origine delle nazioni, dovuta al diretto intervento di Dio.
Le nazioni, argomenta Mazzini, sono un mezzo per cercare una vera
fratellanza di tutta l’Umanità. Per Mazzini le nazioni esistono ab aeterno,
dunque . l popoli che le animano hanno tratti comuni, hanno “innate
spontanee tendenze” e nel caso dell’Italia addirittura una cornice geografica
fatta apposta per scandire meglio la separatezza dalle nazioni circonvicine.
La nazione sembra assumere dunque i tratti di una comunità etnica, i cui
principali elementi sono, al tempo stesso, naturali e culturali.
Sebbene il riferimento alle componenti culturali (la storia, la lingua, le
tradizioni) abbia una notevole importanza, conviene per ora seguire la pista
aperta del costante richiamo ai tratti naturali, che connoterebbero la comunità
nazionale.
Dal punto di vista letterario questo aspetto viene sottoposto ad un elaborato e
pervasivo trattamento simbolico, che mira a presentare la comunità nazionale
nelle vesti di una comunità parentale allargata, insediata in un luogo fisicogeografico che le appartiene.
L’allegoria originaria immagina la patria come una donna e una madre; se è
così allora i suoi figli, proprio per questa comune discendenza, sono tutti
legati tra loro da un vincolo di fratellanza.
La sequenza simbolica non si ferma qui poiché viene sviluppata
nell'immagine della nazione come un fitto reticolo di nessi familiari, che lega
una lunga catena di generazioni tra loro in senso longitudinale, in senso
orizzontale, e fisicamente a un luogo, a una terra.
L'aspetto interessante di queste elaborazioni e che in tutti gli esempi in cui ha
corso l’immagine della parentela, essa si accompagna ad una sua precisa
contestualizzazione spaziale: la rete parentale ha un suo spazio,un suo
luogo, una sua terra che la ospita da tempo immemorabile,
La terra, però, non è solo un inerte spazio fisico. La terra è molto di più : è un
ambiente che ha ricchezze di cui si va orgogliosi, risorse di cui si è gelosi, ma
è anche profumi, panorami, colori, cose che strutturano la memoria e
accompagnano la vita di chi vi ha abitato.
La nazione come comunità naturale, fatta di legami parentali e di patrimonio
territoriale, è un retaggio che proviene da tempi immemorabili: questa è,
dunque, l’immagine trasmessa dai testi del “canone”. Ma la storia, in che
modo incide nella strutturazione di questa comunità?
Certo, lo si è già visto, le generazioni della comunità nazionale non sono
legate solo ed esclusivamente da un vincolo di sangue e di terra: non meno
importante è il vincolo della memoria storica.
Questo è il compito che le storie hanno: fare in modo che chi compie nobili
azioni sappia che potranno essere descritte e tramandate come esempi alle
future generazioni. Per questo ç' è necessità di storie delle gesta nazionali,
delle opere nazionali, della letteratura nazionale. Per questo c’è bisogno del
culto delle ceneri dei grandi.
Un popolo decaduto, come quello italiano, ha particolarmente bisogno di
riflettere sulle glorie e sugli esempi dei padri; da quelle e da questi deve trarre
insegnamenti e auspici per rigenerarsi e riconquistare la propria libertà. La
nazione, dunque, ha una storia la cui memoria va tenuta viva perché non
vada persa la coscienza del proprio essere presente.
Nelle opere di Mazzini e Mameli, come, più in generale, nelle opere del
“canone”, colpiscono due aspetti fondamentali: la disinvolta assimilazione di
eventi storici molto diversi tra loro; il trattamento segmentario ed autonomo
rispetto ad una narrazione complessiva della storia nazionale.
Il punto è che, nei testi del canone almeno, i fatti storici di cui si parla
acquistano un senso in quanto figure, ovvero anticipazioni di un evento che
deve ancora compiersi.
Il trattamento della storia, nei testi del canone, sembra procedere in modo
analogo: particolari avvenimenti della storia della penisola acquistano rilievo
solo quando possono essere considerati come prefigurazioni del risveglio
della nazione. E’cosi che eventi talora apparentemente del tutto privi di ogni
esplicita finalità nazionale acquistano significato come momenti specifici di
un'ininterrotta storia della comunità nazionale italiana, che ancora aspetta il
suo compimento.
Un aspetto chiave di questa particolare concezione della storia è il carattere
ripetitivo degli eventi narrati, che rinnovano l’esperienza di sofferenza della
comunità nazionale. Tale carattere ripetitivo deriva dal criterio base con cui gli
autori del canone scelgono gli episodi da trattare.
la scelta cade su eventi che consentano di esplorare tre configurazioni
sincrone, incessantemente, quanto dolorosamente, ricorrenti: a)
l'oppressione della nazione italiana da parte di popoli o di tiranni stranieri b) la
divisione interna degli italiani, che favorisce tate oppressione c) gli eroici,
quanto sfortunati, tentativi di riscatto.
Le divisioni interne producono scompiglio nell’ordinato corso delle cose,
nell’armonia dei rapporti tra mariti e mogli, tra fratello e fratello, tra amico e
amico, insomma nei nessi più intimi che rendono coesa una comunità. Esse
aprono le porte alla debolezza di fronte a quegli stessi stranieri che non
hanno che da sfruttare e alimentare gli odi fratricidi. La minaccia straniera
vuol dire perdita della libertà, della terra, degli averi. Ma ciò non basta. Essa
getta un’ombra ancora più inquietante sulla vita della nazione, poiché ne
minaccia la stessa essenza, attraverso il possibile intreccio di rapporti eroticosessuali impropri. Nella sua forma più diretta e immediata, la minaccia prende
la forma dell’oltraggio violento a uno dei più segreti valori della comunità
nazionale aggredita: la purezza delle donne.
Tuttavia questo tema, pur così presente, ha talvolta un ruolo solo marginale
nella costruzione degli intrecci. La relazione impura è affrontata allora da una
prospettiva diversa, apparentemente meno traumatica.
Tra le opere del canone questo movente narrativo viene sviluppato in quattro
diverse varianti.
A) Nella prima, la donna, attraversata dal pensiero di una relazione con uno
straniero, ma lontanissimo dal volerla, inorridisce fin quasi al delirio. B) In una
seconda variante, la donna finge di assecondare l’amore dello straniero, per
meglio colpirlo. C) Talora l’innamoramento per lo straniero non è finzione, ma
affetto vero e sincero; solo che poi, il rapporto non è consumato, e
l’innamorata si ferma davanti alla riacquistata consapevolezza di esser sul
punto di tradire i più profondi valori del proprio popolo. D) Non sempre chi fa
sedurre è in grado di resistere alla passione d’amore.
Con tutte le possibili varianti narrative che compaiono in diverse storie di
violenza, di amori contrastati, di ostilità fratricide, vi sono alcuni elementi
strutturali che vale la pena mettere in evidenza.
Secondo la maggior parte dei testi del canone, i soggetti più esposti alle
“mesalliances” nazionali sono le donne. Ciò che è in ballo, qui, è uno dei
tesori fondativi dell’onore nazionale, ovvero la loro purezza e la loro castità.
Quelle che tra loro si perdono, con un rapporto impuro, sono accompagnate
dalla prova della loro impurità, ovvero dai figli avuti da stranieri.
Ed è da sottolineare quanto sia grave il fatto che le donne abbiano ceduto ad
“empi amplessi” , ed hanno avuto figli. Per questo devono essere punite
senza pietà, dal momento che ciò che si deve evitare non è soltanto la
contaminazione delle donne,quanto, soprattutto, l’empia mescolanza di
sangue diverso: per questo la colpa della procreazione di meticci è così
grave. La libertà, l’indipendenza, uno stato nazionale, sono tutti obiettivi
fondamentali per qualunque patriota del Risorgimento, Mazzini in testa. Ma
accanto a questi valori ne compare uno più torbido e profondo: l’onore da
difendere, l’onore offeso dalla violenza alla terra, l’onore offeso dalla
violazione della dignità delle persone, l’onore offeso nella violazione della
purezza delle donne.
Questi elementi sono ricomposti in forma diversa nei più complessi
meccanismi narrativi che sono propri dei romanzi storici. Questi romanzi
vivono di un impianto di intrecci multipli, che rende la struttura estremamente
complicata. Tuttavia , all’interno di intrecci apparentemente difficili da
ricondurre gli uni agli altri, ricorrono costantemente tre figure, che strutturano
la narrazione e che sono dotate, tutte, di tratti singolarmente simili.
La prima figura è quella dell’eroe, il protagonista, la guida dell’azione. L’eroe
è un uomo che ha sempre delle qualità militari; è un condottiero o lo è stato in
gioventù, ed ha un riconosciuto ruolo di guida politica o morale all’interno
della sua comunità. È animato da un intenso amor di patria, si batte con
coraggio, ma è destinato inevitabilmente alla morte. Le sue azioni, e in alcuni
casi la sua morte, hanno un valore di testimonianza offerta ai contemporanei
e ai posteri.
Gloria e dolore, eroismo e morte tragica sembrano i marchi distintivi di alcune
figure. E l'ombra del tradimento, anche. Perché il destino dell' eroe è sempre
segnato dal un incontro con un traditore.
ln questi romanzi i traditori hanno un ruolo narrativo cruciale: sono gli attori
che muovono il dramma, che introducono elementi di suspense, che fanno
precipitare la storia verso il suo finale tragico. La loro e un' azione subdola,
destinata a muovere le sue trame nell'ombra. Disprezzati da tutti, com'essi
sono, quando son costretti ad uscire allo scoperto, diventa chiaro a tutti, che
essi agiscano per ambizione, sete di potere, per denaro, o per desiderio di
vendetta. Più pericolosi degli stessi stranieri, i traditori sono la causa della
disfatta della comunità nazionale nella lotta, ed insieme sono la causa della
morte dell’eroe. Diversi tra loro vogliono anche disonorare le donne degli
antagonisti, ad ulteriore ed estrema ingiuria.
L’orrore etico suscitato dalle loro turpi macchinazioni è moltiplicato dalla
perfezione morale delle donne che sono vittime delle loro trame. Le eroine
nazionali sono accumunate agli eroi per la loro fedeltà ai valori patrii. Sono
poi descritte come donne di incontaminata purezza. La minaccia che devono
subire da parte dei traditori è proprio una minaccia alla loro castità, alla loro
purezza sessuale. Quando il loro onore è stato violato esse hanno davanti a
sè un destino di morte; quando il disonore sia nato da un loro colpevole
cedimento, la loro punizione è l’esclusione dalla comunità.
In questi romanzi, dunque, gli intrecci sono strutturati dall’interazione fra le tre
figure degli eroi, dei traditori e delle vergini. Se la morte dell’eroe ha funzione
testimoniale, essa è provocata dalle mene di qualche bieco traditore; quanto
alle donne, esse, sono la posta intorno al quale si gioca la difesa dell’onore
della patria.
Per difendere l’onore della patria è necessario agire. E, nei testi del canone,
capita talvolta che siano proprio le donne le prime ad incitare gli uomini
all’azione. Consapevoli della posta in gioco, queste donne, sono spettatrici e
trepidanti nell’azione patriottica.
Le vie dell’azione possono essere la congiura, o la ribellione, ma anche il
duello, ed infine la guerra. Tra questi, il più rilevante, è il ruolo dei duelli. Ve
ne sono di due tipi: contro i traditori, e contro gli stranieri.
Quando gli scontri hanno un carattere rituale, e non l’aspetto di una zuffa,
essi non hanno mai soltanto il carattere per la difesa dell’onore individuale;
sono, infatti, anche uno scontro per la difesa dei valori e della dignità della
comunità. Quando poi i duelli contrappongono combattenti di due nazioni
diverse essi acquistano il carattere di stilizzazioni spirituali dello scontro
bellico. Il parallelo tra duello e guerra palesa uno dei caratteri fondanti dello
scontro per la nazione: essa deve difendere valori etici, riscattare la nazione
dalla sua caduta, oltre a liberare il territorio nazionale dai nemici
Tuttavia, il fatto che la guerra persegua l’obbiettivo della liberazione effettiva
ne fa un momento di livello superiore al duello. Ed è proprio questa sua
superiorità che fa della guerra un evento con caratteri di sacralità e di santità
che al duello non sono attribuiti.
“Il risorgimento non è solo il risveglio alla coscienza di un soggetto collettivo
dimentico di sé,ma è vera e propria“risurrezione”,cancellazione della colpa
originale,riscatto dalla caduta politica ed etica”. Alberto Mario Banti
Banti prosegue la sua indagine nei caratteri del “canone risorgimentale”
attraverso lo studio di alcuni autori che contribuirono a definire”l’idea di
nazione” durante il risorgimento. Il primo ad essere citato è Berchet che, con
la lettera “Agli amici d’Italia” vuole risvegliare gli italiani “alla consapevolezza
della propria italianità” tramite la costruzione di immagini che potessero
evocare valori ed ideali. Non era importante che queste fossero vere o false,
ma che fossero efficaci e che riuscissero a produrre”quel
sentimento,quell’affetto”.Nella descrizione contenuta nei testi,la nazione
appare con i tratti di una comunità etnica dotata di aspetti biologici e culturali
condivisi da tutti i suoi membri. Il secondo autore citato è Cuoco che,nel
“Platone in Italia”,tematizza l’idea di un’origine preromana della nazione
italiana. Anche per lui le immagini simboliche assumono un’estrema
importanza e,in questo caso,vengono tratte dalla storia della penisola
compresa tra tarda antichità ed epoca moderna. Tali immagini non dovevano
essere caratterizzate da alcuna elaborazione ma dovevano “essere sentite”
dalla popolazione e,quindi,condivise da tutti. Secondo Cuoco la nazione è
l’insieme dei soggetti dotati di un proprio spirito e di un proprio carattere
fondamentale,fissato “ab origine” e condizionato dall’azione della storia.
L’unità fondamentale è garantita,secondo lui, dal possesso di una serie di
caratteri originari e condivisi da tutti i suoi membri. E’ quindi necessario
evitare di imporre alla nazione apparati istituzionali e normativi ad essa del
tutto estranei. Secondo Cuoco la parte di società più vicina ai caratteri
originari era quella popolare. Inoltre nel “Saggio storico sulla rivoluzione
napoletana”,formula della ipotesi che tracciavano i contorni di un progetto
politico-costituzionale che conciliava nazione,elitismo e autonomie territoriali.
Possiamo concludere dicendo che per Cuoco, la nazione è come la
famiglia,ovvero come non si sceglie la famiglia,a cui si appartiene per vincoli
di carattere naturale,allo stesso modo non si sceglie la nazione.
Successivamente troviamo citato Mazzini che collega i testi patriottici alla
tradizione religiosa,ovvero sostiene che gli uomini siano una sola famiglia
“d’eguali in Dio”, e che il simbolo di questa fratellanza sia la comunione. Era
necessario,dunque,secondo Mazzini,ampliare e sviluppare la verità nascosta
in questo simbolo. Secondo l’autore dunque la santità dell’associazione
originaria si trasmette alle associazioni di natura non strettamente religiosa,in
questo caso la “Nazione”:forma associativa che unisce tutti i membri. La
Nazione si propone come una comunità di fratelli dotata di un respiro etico
che la trasforma in una cosa sacra. Così se da una parte abbiamo la natura
biologica che accomuna tutti i membri,d’altra parte si pone l’accento sulla
natura sacra e spirituale dei legami. Questa concezione sacra della Nazione
risulta ancor più sottolineata dalla metafora che vede paragona la triade
figurale della narrazione nazionale(eroi, traditori, vergini) alla storia della
redenzione(Gesù,Giuda,la Vergine).Infatti si riteneva necessario seguire
l’esempio di Cristo e dei suoi santi:come essi sacrificarono la loro vita per gli
altri cristiani,anche gli eroi,con la loro morte tragica,in onore della loro
nazione,svolgono un ruolo testimoniale,poiché morendo possono liberare
l’intera comunità dallo stato di disunione e di disonore nel quale essa è
caduta. La figura dell’eroe-martire assume notevole rilievo in un articolo del
1832 di Mazzini,dove egli scrive:”Que” martiri equilibrano a poco a poco la
bilancia tra le creature e il creatore“.Infatti la loro azione comporta che venga
ricomposta la frattura che ha separato i fratelli dai fratelli e inoltre comporta
che sia cancellata la traccia degli innumerevoli tradimenti che hanno
macchiato la storia della nazione. Le altre due figure della triade sopra citata
sono i traditori, visti come gli antagonisti degli eroi, e le eroine,per le quali la
morte è espressione di una fede e di una purezza che non è mai veramente
vinta dall’aggressione sessuale. Dunque in questo periodo si cerca di
ottenere ciò che la nazione aveva perso,ovvero la sua identità,il suo onore;ed
ecco che in questo punto eroi ed eroine assumono un’importanza
fondamentale:hanno la missione di testimoniare,attraverso le loro gesta e le
loro morti,il valore e la qualità della comunità nazionale. I valori fondamentali
che questi eroi vogliono difendere sono:la ”valentia militare”,la concordia,la
purezza della donne. Per questo motivo,come già detto,è importante,in
questo periodo,il duello,pratica strettamente legata al codice dell’onore. Le
categorie che risultano impegnate nei duelli sono i militari ma anche
borghesi,giornalisti,avvocati...In questi casi il duello non è più un
appannaggio esclusivo di uno specifico status sociale,ma ha un carattere
rigorosamente individuale. Le qualità fondamentali divengono il
coraggio,accompagnato da fermezza e sangue freddo. I duelli narrati sono
combattuti per reagire ad insulti rivolti alla purezza della italiane o al valore
militare degli italiani. Del comportamento degli eroi italiani si sottolinea sia il
carattere reattivo-difensivo,sia la leale generosità;ancora una volta la nazione
è rappresentata come comunità che tenta di riscattare l’onore perduto. Il tema
del sacrificio in onore della nazione,viene trattato da Banti in modo da far
emergere il fatto che la nazione viene narrata attraverso un calcolo operato
sulla storia di Cristo,in modo tale che gli eroi venivano trasformati in soggetti
consapevolmente destinati ad un sacrificio espiatorio e testimoniale. Questo
nesso tra martiri della patria e martiri cristiani viene presentato da Vannucci
nell’introduzione de “I martiri della libertà italiana”,infatti così scrive:”I frutti
della libertà che ora da noi si cominciano a cogliere furono seminati e coltivati
con lunghi dolori dai nostri padri e dai nostri fratelli…In Italia non vi è palmo di
terra che non fosse bagnato dal sangue dei martiri della libertà…come i
martiri della religione,erano dappertutto e combattevano strenuamente per lo
stesso principio e confermavano l’ardente fede col sangue”.Perciò era
disprezzato colui che,tradendo la sua patria, ne infangava l’onore e la dignità
nazionale. E,se dunque la nazione era vista come una comunità compatta
per i suoi caratteri naturali,etnici,culturali,storici-politici,niente poteva esserci
di peggio delle divisioni e niente poteva essere più abominevole del
tradimento. Ovunque la nazione avesse subito un insuccesso la causa non
poteva essere che un tradimento;persino la morte naturale di un patriota
era,senza dubbio,considerata il frutto di un avvelenamento. La figura del
martire era al centro del discorso nazionale tanto che,alla morte di un
combattente per la patria,si pubblicavano elogi funebri,odi,canzoni e poesie
tendenti a celebrare il martire ed esaltarne il sacrificio. I patrioti e i martiri
della libertà erano coloro che garantivano la compattezza nazionale,contro gli
stranieri che potevano arrecare oltraggi alla dignità della nazione. Il soggetto
che più minacciava la popolazione italiana era il soldato
austriaco,responsabile di battiture pubbliche di donne nude,di mutilazioni,di
violenze gratuite e di molte altre umiliazioni .Di questo parla Correnti
nell’opuscolo pubblicato a Torino nel 1849,esaltando l’eroismo sacrificale e
l’etica cavalleresca dei nobili patrioti bresciani contro i gesti umilianti che i
selvaggi austriaci avevano cercato di mettere in atto per insultare l’onore
della città e dell’Italia.Assumevano estrema importanza anche le donne,di cui
si esaltava la purezza e la castità,poiché la minaccia alla purezza della donne
era una minaccia all’onore della nazione. La guerra dunque doveva apparire
come una dimostrazione di coraggio,di valore,di vigore,di unità,una smentita
a tutti coloro che,fuori dalla penisola,da secoli si erano ostinati a presentare
gli italiani come codardi. Se la guerra e la lotta assumevano un carattere
religioso,le stesse vicende militari nei primi mesi del “48 nel caso della guerra
per l’indipendenza della nazione,vennero vista attraverso tutti quei riferimenti
simbolici che ne enfatizzavano il carattere sacro,un aspetto che sembrava
suggellato dall’esplicita benedizione di Pio IX al movimento nazionale. Ma
ben presto la fitta serie di rimandi alla santità della guerra cominciarono a
sbiadire;all’immagine della crociata cominciò a sovrapporsi quella della
falange eroica in lotta per il riscatto. Infine,Banti prende in considerazione
alcune figure femminili che presero parte alle varie guerre,diventando così
eroine per la salvezza della nazione. Si citano la contessa Martini Salasco
che partecipò all’impresa garibaldina in Sicilia;la principessa Cristina di
Belgiojoso la quale,allo scoppio delle cinque giornate a Napoli,noleggiò a sue
spese un vapore per raccogliere il maggior numero di volontari disposti a
combattere. Possiamo concludere dicendo che,in questo periodo,forte era lo
spirito nazionale,ogni singolo individuo si sentiva parte di un tutto fino al
punto di sacrificare la vita per la sua nazione,difendendone così anche tutti i
valori che,ovviamente venivano condivisi dall’intera comunità.
(Roberta Cattaruzza
Giada Martini)
4. L’ANTI RISORGIMENTO
1. UN ESEMPIO DI REVISIONISMO STORICO SUL RISORGIMENTO
Nel suo saggio, Angela Pellicciari offre un’ interpretazione del Risorgimento in
chiave molto critica e negativa e fornisce una nuova prospettiva per un’analisi
degli avvenimenti da un punto di vista meno filo liberale, più vicino alle ragioni
della Chiesa di allora.
LE RAGIONI DI PRINCIPIO DI UNO STATO LIBERALE
Regno di Sardegna: una monarchia costituzionale
Il Regno di Sardegna, che si dichiara legittimamente libero, visto il
mantenimento da parte di questo Stato (unico esempio in Italia) della
Costituzione, si trova ad affrontare una situazione di aperto conflitto contro gli
ordini religiosi, per difendere i princìpi liberali in opposizione al clima di
oscurantismo che vige in tutti gli altri Stati della penisola.
Fine del privilegio: uguaglianza davanti alla legge
Il Parlamento del Regno di Sardegna si oppone categoricamente al principio
della disuguaglianza fra i cittadini che vige invece, per definizione, all’interno
di una monarchia assoluta. Tutti i cittadini devono, quindi, essere
perfettamente uguali di fronte alla legge ed occorre sancire la fine dei privilegi
e delle discriminazioni. Lo Stato applica tali principi nel proclamare pari
opportunità per gli ebrei e piena libertà di culto per i protestanti. Tuttavia, si
mette ora in discussione la legittimità dell’abolizione delle pari libertà e dignità
per gli ordini religiosi, che sono inoltre investiti dal consenso della quasi
totalità della popolazione. Il deputato Palluel fa proprio leva sulla concezione
delle libertà viste come una catena, della quale non si può rompere nemmeno
un anello senza che essa risulti spezzata nella sua interezza. Jacquemond e
Benso dichiarano, ancora, incostituzionali tali restrizioni contro gli ordini
religiosi. I deputati contrari al mantenimento di questi ultimi devono dunque
ribattere alle obiezioni, e lo fanno affidandosi alla stessa definizione di Stato,
“poiché il Regno di Sardegna, prima di essere liberale, è uno Stato”. SiottoPintor, a partire da questa definizione, parla di una condizione essenziale per
la sopravvivenza degli ordini religiosi nei termini di uno Stato, ovvero il
benestare del Governo. Lo Stato liberale dimostra ora, in realtà, di
conservare un ampissimo margine di controllo sulla popolazione e sulle
istituzioni. Secondo il deputato Bottone, non si può parlare di dispotismo, ma
di uno Stato che istruisce la popolazione ai princìpi liberali; contemplando,
però, anche la possibile approvazione di provvedimenti, giustificati da “solidi
motivi”, che appaiono “leggi d’eccezione, contrarie alla libertà generale”.
Risulta necessario, continua Bottone, proteggere le “neonate” istituzioni del
Regno di Sardegna dai loro nemici; anche Cheval e Sulis proseguono sulla
strada della legittimità del provvedimento “in nome della libertà”. Oltre a ciò, i
deputati liberali sono convinti che i loro princìpi siano validi solamente per
coloro che fanno parte del partito liberale, mentre tutti gli altri, per definizione
non liberali, devono essere lasciati in un clima di oscurantismo (al quale,
secondo i liberali, essi sono certamente favorevoli). Benedetto Croce, nella
Storia d’Europa nel secolo XIX del 1932, affermerà che, in merito “all’assunto
principio di libertà, la violenza è esclusa dalla vita politica, ma che non è
escluso, in certi casi particolari, il procedere rigoroso e radicale”.
Diritti acquisiti
I liberali quarantottini sostengono la necessità di una trasformazione profonda
della società, oscurantista e reazionaria. In questo contesto perdono di valore
anche i trattati internazionali stipulati durante il governo di sovrani assoluti,
poiché lo stesso ruolo di questi ultimi contribuisce a compromettere la validità
di tali trattati. Nel periodo storico in esame, pregno di velocissimi
cambiamenti, il solo tempo che si considera è il futuro, che rappresenta
l’occasione di un grande e generalizzato rinnovamento. Il Concordato
stipulato fra la Santa Sede e il Regno di Sardegna nel 1817 sancisce
l’illegittimità di ogni intromissione da parte del potere temporale nei confronti
di questioni riguardanti il potere spirituale. La sopravvivenza degli ordini
religiosi è dunque garantita da questo trattato internazionale, nel quale si fa
riferimento al divieto ai i governi di modificare qualsiasi aspetto nelle
istituzioni ecclesiastiche senza che vi sia un accordo bilaterale con la Santa
Sede. Stando a tale trattato, quindi, l’abolizione di alcuni ordini religiosi che si
è verificata risulta una vera e propria violazione del Concordato. I liberali
ribattono alle difficoltà sottolineate dai deputati contrari al provvedimento
sostenendo che l’unico problema che ancora sussiste è quello dei beni degli
istituti soppressi. In realtà questi beni risultano intoccabili in quanto
“ecclesiastici”, e dunque per risolvere la questione viene proposta una
soluzione da parte del deputato Pescatore: se la Camera decretasse che non
si tratta di beni ecclesiastici, il problema potrebbe considerarsi già risolto.
Proprietà privata: un diritto. Per tutti?
In base all’articolo 29 dello Statuto, che assicura il diritto di proprietà, la
confisca dei beni degli ordini religiosi viola una norma essenziale della
Costituzione. I deputati che appoggiano la conservazione degli ordini parlano
dunque di una ferita che si sta aprendo nel corpo sociale, la quale lascia
intravedere conseguenze soltanto negative. Il pericolo che ne deriva consiste
nella possibilità che, in futuro, avvalendosi delle stesse motivazioni che
vengono utilizzate in questa circostanza, il Governo estenda l’esproprio “a
tutti i tipi di proprietà”.
Emendamento Pescatore: respinto
Nonostante il progetto di legge elaborato in quest’occasione chiarisca,
all’interno dell’articolo 3, che debbano essere espropriati tutti i beni degli
ordini religiosi, “a qualsivoglia titolo posseduti”, secondo il deputato Pescatore
è necessario specificare che essi dovranno venire devoluti allo Stato “non
ostante la clausola di reversibilità od altra qualunque in contrario che si fosse
apposta negli atti di donazione e di testamento”. Tutti i beni della Chiesa
derivano dal considerevole numero di donazioni da parte dei fedeli. Il bisogno
di chiarimento deriva, per Pescatore, dal fatto che, benché le donazioni
dovessero essere fortemente tutelate e riservate allo scopo per cui esse
erano destinate, in passato lo Stato e numerosi componenti delle classi al
potere le hanno usurpate. Al termine di questa fase, allorché viene di nuovo
riconosciuta personalità giuridica agli ordini religiosi, i fedeli che si apprestano
a compiere donazioni specificano nei loro testamenti la volontà che, qualora
si verifichi una nuova ondata di oppressioni e violenze, i beni devoluti
debbano ritornare nelle mani degli originari proprietari. In realtà sono
effettivamente questi i possedimenti che i liberali intendono confiscare alla
Chiesa. Tuttavia, in seguito ad una lunga discussione in Parlamento,
l’emendamento viene rigettato, ma ciò non altera la posizione dei deputati,
che non mettono in discussione il principio che tali beni debbano essere
incamerati, “a qualsivoglia titolo posseduti”.
Emendamento Demarchi: respinto
Il deputato Martinet solleva ora una significativa questione: cosa fare delle
ricchezze possedute solo “a titolo precario, di usufrutto, di locazione, di
semplice uso, di amministrazione e simili”? Egli pensa che essi non debbano
essere equiparati a quelli legittimamente detenuti e, a tal proposito, il
deputato Demarchi suggerisce di adottare l’espressione “salvi i diritti dei
terzi”. Ma l’emendamento viene respinto dal Parlamento e nel progetto di
legge si leggerà: “Tutti i beni e ragioni di qualsivoglia sorta per le dette
corporazioni a qualsivoglia titolo posseduti, s’intenderanno e si dichiarano
irrevocabilmente devoluti in piena disponibilità dello Stato”.
Cosa decidere a riguardo delle donazioni future?
In merito ai provvedimenti da prendere nei riguardi delle donazioni future,
viene approvata dalla Camera una parte dell’articolo 7, che sancisce che “Le
donazioni, le istituzioni di eredi, od i legati che verranno fatti alle corporazioni
religiose, secolari o regolari, non avranno effetto se non saranno approvati
dal Governo”.
Esproprio di tutti i beni degli ordini religiosi. Perché?
Il deputato Pescatore pensa che sottrarre i beni agli ordini religiosi sia
assolutamente necessario in quanto si augura che in tal modo non potrà
essere ripetuto una seconda volta l’errore commesso nel 1778, quando ci “si
servì dei beni della corporazione gesuitica… per arricchire altri stabilimenti
ecclesiastici”. I deputati liberali ritengono preferibile, a questo proposito,
penalizzare l’istruzione a patto di eludere il pericolo del ritorno di insegnanti di
ispirazione “gesuitica”.
1848: i nemici I Gesuiti ed i Gesuitanti di cui parla Bixio sono ordini religiosi
appartenenti alla Chiesa cattolica, che però non viene mai attaccata né da
Bixio né dagli altri deputati, e anzi viene difesa. Ma, in realtà, la religione e la
morale che stanno a cuore ai liberali sono opposte, secondo Pellicciari,
rispetto a quelle dei Gesuiti e degli ordini religiosi in generale, poiché
nettamente contrapposte alla morale e alla religione cattoliche. Come è
possibile che i deputati dello Stato di Sardegna (il cui articolo 1 dello Statuto
recita che “la religione cattolica, apostolica e romana” è la “sola religione dello
Stato”) si oppongano ad essa, adottando un atteggiamento chiaramente
incostituzionale?
Carlo Alberto e Massimo D’Azeglio
Massimo D’Azeglio rappresenta, nelle vicende del Risorgimento, l‟uomo che i
massoni utilizzano per indurre i Savoia ad intraprendere e condurre la
battaglia per la libertà e l’indipendenza italiane. La Massoneria sceglie
D’Azeglio poiché egli rappresenta una personalità dotata di imparzialità, e
diplomazia. Bisogna che egli lavori su due fronti: deve, infatti, convincere il
Re Carlo Alberto a farsi portavoce della causa italiana e, allo stesso tempo,
persuadere i “fratelli” di tutta la penisola a fidarsi del Sovrano. Carlo Alberto si
presenta come una figura controversa, poiché nei moti del 1821 aveva
aderito, ma poi aveva ritirato il suo consenso. Tuttavia D’Azeglio riscuote un
completo successo, convincendo il Re con la prospettiva che otterrà, almeno,
risultati materiali, cioè un regno più esteso.
La Chiesa e l’uso della forza
Dopo che Lutero aveva definito la città di Roma come “rossa puttana di
Babilonia”, si diffonde la “leggenda della Roma cattolica, capitale della
superstizione, della barbarie e del potere tenuto con la forza”. I liberali, per
poter portare a termine il loro progetto di unificazione dell’Italia, devono prima
convincere i fedeli che lo Stato della Chiesa non tutela più la loro fede, in
modo da provocarne la fine. Per fare ciò essi si avvalgono della motivazione
che la Chiesa diverrà sicuramente più pura senza le ricchezze che detiene.
Bisogna, dunque, riuscire ad annientare questo Stato, “sanguinario,
retrogrado e mal amministrato” tramite un’azione propagandistica che parte
proprio dai governanti sardi. D’Azeglio si rivolge ai cattolici da cattolico, in
modo da non provocare in loro diffidenza, per realizzare uno dei postulati
fondamentali nell’ambito della massoneria: occorre privare la Chiesa tutte le
sue proprietà e sottrarre al Papa il potere temporale.
Regno di Sardegna
Lo Stato di Sardegna mira a realizzare il progetto di indipendenza dell‟ Italia
sia dall’Austria che contro la Chiesa cattolica. Il primo Parlamento elettivo del
Regno di Sardegna si occupa, infatti, inizialmente, della lotta agli ordini
religiosi, visti come reali nemici, contro i quali è necessario costruire una
morale ed una religione nuove e differenti da quelle cattoliche. Pur non
essendo lo stato più rappresentativo della penisola, è proprio il Regno di
Sardegna che diviene promotore della battaglia per il Risorgimento italiano. I
Savoia, fautori di uno Stato costituzionale, renderanno il Piemonte lo “Stato
guida” e considereranno Torino capitale “morale” dell’Italia. Essi offriranno
accoglienza ai liberal-massoni, di cui appoggiano l’ideologia, e ai “fratelli”. La
caratteristica vantaggiosa della loro politica sta nella diversità culturale e
religiosa rispetto agli altri Stati della penisola, che permette loro di contrastare
l’idea di una compagine unita solamente dalla massiccia adesione alla
Chiesa cattolica, di promuovere la diffusione della fede e della cultura
protestanti.
COME REAGISCE LA CHIESA?
Pio IX
Nell‟1848 Papa Pio IX riceve la conferma di essere stato “utilizzato dai liberali
che lo hanno mitizzato per sfruttarne la nota simpatia per la causa nazionale”,
poiché i liberali lo abbandonano per occuparsi del trionfo repubblicano. Il 20
aprile 1849 il Papa, in esilio presso Gaeta, parla ai fedeli in modo che essi
conoscano il vero scopo dei rivoluzionari. Questi ultimi non intendono,
togliendole il potere temporale, rendere migliore la situazione della Chiesa
cattolica, ma invero mirano ad annientarla.
1852: RELAZIONE MELEGARI
Arturo Carlo Jemolo
Arturo Carlo Jemolo, storico di fama, analizza in molti lavori le vicende del
Parlamento subalpino. Egli trae dal Risorgimento, nonché dai suoi
protagonisti, un giudizio positivo, poiché considera innovativi i valori per cui si
battono i liberali e contesta, quindi, le ragioni opposte della Chiesa. Il giudizio
di Jemolo riguarda anche la relazione Meleagri, che viene caratterizzata
come “ottima relazione, ricca di buone considerazioni giuridiche, e di accurati
dati statistici”. Tali valutazioni sembrano soprattutto dovute alle “simpatie”
dello storico per il pensiero liberale, dato che non contengono nemmeno una
sintesi dell’influenza che la massoneria ha avuto “sul pensiero liberale e
socialista dell’Ottocento, mancanza che rende la posizione della Chiesa
completamente ingiustificata.
1854: UN PROGETTO DI LEGGE CONTRO GLI ORDINI RELIGIOSI
1853: anno di crisi
Il governo Cavour, nato nel 1852, cerca subito di realizzare una “liberale”
riforma dell’economia. I provvedimenti adottati dal Governo causano, però, un
repentino peggioramento delle condizioni di vita dello strato povero della
popolazione che, il 18 ottobre, avvia una ribellione. Ma Cavour tenta di
perseverare nella radicalizzazione della sua linea politica, pur sapendo che
incrementerà lo scontento del popolo. Egli opta, inoltre, per la riapertura delle
ostilità anticattoliche.
928.412 lire Durante la seduta alla Camera del 6 marzo 1854 si solleva la
questione della spesa per la congrue per il mantenimento dei parroci poveri.
Per i deputati questa risulta eccessiva e viene proposta, di conseguenza, la
cancellazione di questa voce di bilancio. Tuttavia si pone ora il problema di
come assicurare in ogni caso la sopravvivenza dei parroci. A questo punto,
comunque, appare chiaro che quello in merito alle congrue per i parroci
poveri è solamente uno dei numerosi attacchi che il Governo intende sferrare
nei confronti della Chiesa. “È evidente l’esistenza di un piano premeditato per
combattere la Chiesa e incamerarne i beni; è evidente l’esistenza di una
strategia complessiva messa in opera per tappe secondo le opportunità dei
tempi”. “Dato questo contesto, il termine «anticlericalismo», comunemente
utilizzato per descrivere l’atteggiamento dei liberali nei confronti della Chiesa
in questo periodo, è decisamente inappropriato”. Secondo Pellicciari “qui non
si osteggia né il clero, né una parte del clero: si combatte la Chiesa cattolica
in quanto tale”.
21.130 lire: la Sardegna come la Savoia
Il deputato Gustavo Cavour mette in luce un ulteriore problema: quello delle
21.130 lire che lo Stato assegna ai “parroci poverissimi” della Sardegna per il
loro sostentamento. Cavour si oppone alla richiesta di Rattazzi, ministro di
Grazia e Giustizia, di eliminare questi pagamenti, ma al termine del dibattito
in Parlamento viene effettuata la votazione. Il risultato di quest’ultima sarà la
soppressione dell’assegnazione delle 21.130 lire ai parroci, primo passo delle
innumerevoli misure che verranno prese per affondare gradualmente la
Chiesa.
28 novembre 1854: una proposta di legge
Il presidente del Consiglio Cavour e il Guardasigilli Rattazzi presentano un
progetto di legge volto alla Soppressione di comunità e stabilimenti religiosi
ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più
bisognosi, nel quale figurano i due obiettivi fondamentali della loro azione:
rendere giustizia alla parte più povera del clero (considerata anche la più
utile) e aprire la strada ai valori della modernità, andando incontro ai reali
interessi della popolazione. La prima mossa da considerare è quella di
“togliere la personalità giuridica alla maggioranza degli ordini religiosi, i
quali… ormai non possono che essere guardati con sospetto… in
considerazione dello spreco di risorse umane ed economiche che
comportano”. Lo scopo di fondo di Cavour è continuare l’opera di
inasprimento delle ostilità contro la Chiesa iniziata da D’Azeglio. La politica
anticattolica accomuna svariati gruppi politici, quali monarchici, repubblicani,
socialisti, liberali di destra e di sinistra, massoni nazionali ed internazionali e,
sebbene nel contesto italiano essa non sia assolutamente agevole, i liberali
avranno successo.
Rosario Romeo
Lo storico Rosario Romeo, analizzando la politica ecclesiastica di Cavour,
riscontra l’estrema contrarietà del popolo nei confronti della legge contro i
conventi presentata dal conte e da Rattazzi.
Tuttavia, essendosi evidenziata la “stretta parentela fra queste idee liberali e
il programma comunista”, egli scrive: “I conflitti del Novecento hanno indotto a
chiedersi se nel nazionalismo ottocentesco non fosse già presente una
nascosta carica illiberale, quale sarebbe poi esplosa nel secolo successivo.
Ma la questione è priva di fondamento”, poiché nel Regno di Sardegna “già in
forza della mera emanazione dello Statuto, garanzie personali e diritti di
libertà erano diventati una realtà per una parte considerevole della società
piemontese […]. Lo Stato subalpino del decennio fu dunque uno Stato
certamente liberale”. Ma, a giudicare da queste parole, secondo Pellicciari
“come Jemolo, anche Romeo dà eccessivo credito alla propaganda liberale”.
Niccolò Machiavelli
Niccolò Machiavelli aveva espresso la convinzione che l’Italia risentiva
negativamente dell’influenza del papato e tale idea viene ripresa da La Farina
nella seconda metà dell’Ottocento. Egli afferma infatti che l’unità nazionale
non è stata raggiunta proprio a causa della Santa Sede, mentre per l’Italia
sarebbe fondamentale essere una nazione potente e competitiva sul piano
europeo. Questo è ciò che vogliono i liberali, poiché, sostiene Pellicciari, “il
pensiero liberale è fin dall’inizio indirizzato all’espansionismo e il primo frutto
è proprio l’unificazione della penisola sotto il Piemonte”.
Paternità del progetto di legge
L’opinione di molti storici è quella che il progetto di legge Cavour-Rattazzi sia
da attribuire solo al Guardasigilli e alla sua politica antiecclesiastica. Tuttavia
è assurdo pensare che il conte abbia adottato una linea politica tanto
impopolare senza essere completamente convinto della sua importanza e
appare dunque chiaro che Cavour abbia agito seguendo le proprie personali
convinzioni nei confronti della Chiesa.
27 DICEMBRE 1854: UNA LEZIONE DI DIRITTO
Relazione Cadorna
La Camera, trascorso un mese dalla presentazione della legge CavourRattazzi, deve ascoltare la relazione elaborata da una Commissione, che ha
l’incarico di verificare i “fondamenti giuridici” della legge, che viene infine
giudicata perfettamente costituzionale. La discussione si focalizza sul
significato di “comunità religiosa”, definita come “un ente che non esiste in
natura e che non può pertanto arrogarsi la pretesa di possedere dei diritti
naturali”. Il padre delle comunità religiose è lo Stato, che dunque ha facoltà di
revocare i diritti che ha loro conferito. Un altro punto da chiarire riguarda il
concetto di “vita spirituale”. Con tale espressione i deputati intendono
l’esperienza che ognuno vive nel privato o con altri individui, i quali però non
sono mai concepiti come una collettività, da sé legittimata ad esistere. Il
progetto di legge, allora, esprime idee opposte a quelle del diritto romano, e
rappresenta un punto di rottura con la tradizione cattolica. L’uomo è diviso tra
la sfera spirituale e quella corporea, terrena, che ha il sopravvento sull’altra.
Egli, secondo Pellicciari, appare “tutt’altro che spirituale, tutt’altro che libero…
un uomo schiavo dello Stato”.
Libera Chiesa in libero Stato
Con la separazione tra campo spirituale e campo temporale Chiesa e Stato
non devono interferire l’una nelle questioni dell’altro (“Libera Chiesa in libero
Stato”). Tuttavia i deputati, non riferendosi in alcuna circostanza alla Chiesa
come “corpo”, ma prettamente all’individuo, stabiliscono in realtà la
scomparsa di uno dei poli del binomio Chiesa-Stato. Di conseguenza, “lo
Stato perde l’unico interlocutore che poteva limitarne le pretese e cede
inevitabilmente alla tentazione di credere nella propria onnipotenza”.
«Lungi dallo spingere sino alle ultime conseguenze...»
Stabilendo che i beni della Chiesa sono quelli che “appartengono ai singoli
benefizi ad altri stabilimenti ecclesiastici”, la Commissione, dando per
scontato che la diffusione dei provvedimenti riguardi anche vescovadi e
parrocchie, delibera che “tutti i beni dei corpi morali appartengono
legittimamente allo Stato”. Per coloro che vivono grazie a tali beni viene
creata una pensione il cui ammontare cambia al variare dell’età. I membri
della commissione concludono quindi il loro intervento affermando di aver
lavorato in modo giusto e rigoroso: “ Lungi dallo spingere sino alle ultime loro
conseguenze giuridiche i principii sopra stabiliti”.
Liberali e libertà
Il concetto di libertà di cui parlano i deputati liberali risente profondamente
dell’influenza della Rivoluzione Francese: “Per libertà si intende ora la
possibilità di scelta fra diverse opzioni tutte equivalenti e che stanno, da un
punto di vista oggettivo, tutte sullo stesso piano”. Questa equivalenza delle
scelte rischia, in realtà, di far risultare indifferenti l‟uomo e le sue decisioni.
Egli rimane infatti “solo con la propria irrilevanza esistenziale”. La concezione
di libertà presa ora in considerazione si adatta ottimamente allo Stato liberale,
nel quale “l’unico soggetto veramente “libero” è lo Stato medesimo”.
1855: DIBATTITO IN PARLAMENTO
9 gennaio-28 maggio
La discussione della legge Cavour-Rattazzi coinvolge il Parlamento per un
intero anno parlamentare, segno dell‟estrema importanza che ha la
questione religiosa per i deputati. Il Senato ne riscrive successivamente quasi
l’intero testo, per modificarlo in chiave più garantista, e Cavour deve presto
accettare necessariamente i cambiamenti apportati.
Il 9 gennaio 1855 il presidente della Camera Boncompagni apre la
discussione sul “progetto di legge per la soppressione di comunità religiose”,
che segue alla diffusione di due petizioni da parte dei vescovi del Piemonte e
della Savoia, che definiscono il provvedimento “ingiusto, illegale, anticattolico
e antisociale”. Il dibattito che si tiene in Parlamento è durissimo ed i toni sono
molto aspri. Si stabilisce, così, l’effettiva esistenza di una condizione di
“rottura con il passato della classe dirigente piemontese”.
Libertà di stampa
Durante l‟estate del 1852, Carlo Boncompagni è ministro di Grazia e
Giustizia, dunque detiene l’incarico di vigilare sulla libertà di stampa. Ma non
appena il conte Ignazio della Costa fa pubblicare il testo Della giurisdizione
della Chiesa cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici, nel quale
egli si opponeva al progetto di legge per il matrimonio civile proposto dai
liberali, il Guardasigilli ne ordina il sequestro e della Costa viene condannato
a un anno di carcere e tremila franchi di multa. È dunque evidente che la
libertà di stampa vale solo per la stampa liberale e che è in atto, secondo
Pellicciari, una vera e propria “pratica sistematicamente discriminatoria nei
confronti della stampa cattolica”.
«Rancida imitazione della Rivoluzione Francese»
Mentre la sinistra guarda con grande ammirazione ai Paesi che durante e
dopo la Rivoluzione Francese sono stati protagonisti di un rinnovamento
ideologico, la destra non vuole prenderli a modello per l’assetto dello Stato
italiano. Assieme agli esponenti della destra, però, vi sono alcuni membri del
centro-sinistra, come Domenico Buffa, che disapprovano i risultati ottenuti dal
movimento rivoluzionario. Lo stesso Buffa affermerà che i provvedimenti per
la soppressione degli ordini religiosi sono una “rancida imitazione della
Rivoluzione Francese”.
Che cos’è il bene morale?
Quando si parla del concetto di “bene morale” non si può non fare riferimento
alla ricerca degli affiliati alla massoneria. Nelle “Istruzioni” si afferma che “La
massoneria è una scienza perfetta e positiva, fondata su una dottrina
emanata dalla ragione umana perfezionata” e i massoni si considerano “i
depositari della “vera” morale… riassunto della saggezza divina e umana,
vale a dire di tutte le perfezioni che avvicinano quanto più possibile l‟uomo
alla divinità”. Osserva Pellicciari che sul rifiuto della Rivelazione si sviluppano
anche le dottrine morali comunista, fascista e nazista, che si basano
sull’indiscutibile fondatezza della fede “scientifica” della propria ragione”.
«Questo progetto di legge subì una varietà di fasi»
Nonostante il lungo dibattito sorto dalla questione della soppressione degli
ordini religiosi, dalla discussione in Parlamento si evidenzia “una notevole
dose di approssimazione e di pressapochismo, una grande faciloneria
nell’accordare con i fini previsti i mezzi per conseguirli, un perenne
ondeggiamento nella valutazione dei princìpi considerati come irrinunciabili,
un’estrema approssimazione nella valutazione dell’asse ecclesiastico”.
Elementi, questi, del tutto inaspettati, che fanno emergere “tutto
l’opportunismo del governo Cavour, unito a una non comune mancanza di
scrupoli”.
OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI
Obiettivi dichiarati
A: legge di dilapidazione del patrimonio nazionale Le conseguenze
dell’attuazione del progetto di legge vengono considerate, dal punto di vista
economico, assolutamente catastrofiche da tutti i deputati della destra, che
sostengono che lo Stato è destinato soltanto a perdere risorse. Quest’ultimo
dovrà pagare un grandissimo numero di pensioni in favore di coloro che
risiedono nei conventi, finanziare tutte quelle attività socialmente utili di cui
prima si facevano carico le comunità religiose, rinunciare alle tasse che
provenivano dalla manomorta e, da ultimo, occuparsi dell’edificazione di
nuove parrocchie. Ma non è solo lo Stato a trovarsi in una posizione
svantaggiata, bensì anche i cittadini stessi, che vedono i propri beni immobili
deprezzati e difficilmente commerciabili. A perderci, inoltre, sono i ceti umili:
aspetto che porterà i vescovi a definire il provvedimento come antisociale, in
quanto “ha portato solo alla povertà generalizzata”.
Le provincie faranno un buonissimo affare
Il provvedimento ministeriale, dunque, sembra essere svantaggioso per lo
Stato, per i privati e per i poveri. Al contrario, chi ci guadagna, secondo i
deputati cattolici, sono gli speculatori, che non avranno nessun problema ad
acquistare beni finora appartenuti alla Chiesa, e i comuni e le province a cui
verranno assegnati le proprietà espropriate. Tra le intenzioni di Cavour c’era
anche quella di abolire gli ordini religiosi per permettere alle amministrazioni
locali di soppiantare la Chiesa nella gestione delle attività socialmente utili,
creando dunque concorrenza tra le due istituzioni, mettendole su un “piano di
parità”. Revel, deputato dell’Opposizione, schernisce il progetto del Governo
Cavour, dichiarando che le provincie ne trarranno un indubbio vantaggio,
mentre lo Stato ci perderà soltanto.
Istruzione laica e religiosa
Lo scopo più importante di Cavour è quello di subentrare alla Chiesa
nell’esercizio dell’istruzione. L’esigenza di formare nuove generazioni di idee
liberali va assecondata basando la scelta degli insegnanti sulla decisione dei
sindaci, di nomina del potere centrale. I deputati (in particolare quelli dell’ala
di sinistra) sono convinti che sia necessario mettere l’istruzione laica in una
situazione di parità rispetto a quella religiosa, poiché, come sostiene Valerio,
questa “non può lottare con queste corporazioni, che hanno nella loro mani
ricchezze accumulate nei secoli, ed hanno degli appoggi potenti dappertutto”.
Bisogna “liberalizzare” la concorrenza fra comuni e enti religiosi e la battaglia
per una scuola gratuita e obbligatoria in mano allo Stato viene estesa anche
fuori dal Parlamento.
“Ma quella della scuola costituisce la più vistosa eccezione al credo liberale:
libertà di stampa, libertà di culto, libertà di coscienza, divieto di libertà di
insegnamento. I liberali favoriscono solo quelle libertà che possono
danneggiare la Chiesa”. Anche la massoneria si interessa dell’argomento,
prendendo le difese del pensiero liberale più volte sul Bollettino dell’ordine e
sulla Rivista della Massoneria Italiana.
Ottavio Thaon di Revel
I discorsi più critici contro il progetto di legge provengono dal deputato
dell’Opposizione conte di Revel, che contesterà Cavour sui dati e le analisi
forniti dal Ministero e, soprattutto, sulle finalità dichiarate dal presidente del
Consiglio. Durante la tornata del 22 febbraio alla Camera si assiste ad un
accesissimo botta e risposta tra Cavour e Revel, durante il quale Cavour è
costretto ad ammettere che i liberali cominceranno “dal sopprimere gli ordini
più ricchi” e che tale soppressione “sortirà un effetto economico-morale
immediato, di cui è impossibile calcolare in cifra il benefizio, ma che sarà
grandissimo se la soppressione degli ordini religiosi in questo Stato produrrà
conseguenze non dissimili da quelle che arrecò negli altri Stati civili
d’Europa”. Revel ribatte che le dichiarazioni di Cavour lasciano ben intendere
le discutibili intenzioni del Governo, offrendo, nel complesso, “il più lucido
contributo contrario alla legge che sia dato di ascoltare alla Camera”.
B: tassazione di tutti i beni della Chiesa
L’articolo 15 del progetto ministeriale dichiara che si devono tassare in modo
progressivo quasi tutti i possedimenti ecclesiastici. Tuttavia Cavour ha
sempre affermato di essere contrario alla tassazione progressiva. È egli
stesso, però, che spiegherà al Senato le ragioni per cui essa avrà effetti
positivi se applicata ai beni della Chiesa. Il conte asserisce che, “se
quest’imposta deve avere sulla proprietà delle manimorte delle conseguenze
identiche a quelle che si avrebbe certamente sulle proprietà private, cioè
d’impedire l’aumento di queste proprietà, io credo che tutti se ne
consoleranno”.
Emendamento Michelini: accolto
L’emendamento presentato alla Camera dal deputato Michelini prevede di
attuare una tassazione un po’ superiore sui beni di arcivescovadi e vescovadi
che, secondo Michelini, non ne risentiranno assolutamente nell’esercizio delle
loro funzioni spirituali. Il Governo si manifesta contrario alla proposta del
deputato, ma l’emendamento viene ugualmente accolto dalla Camera, poiché
i membri del Parlamento sono convinti che la beneficenza, di cui si
occupavano vescovi e arcivescovi, debba diventare prerogativa dello Stato.
«Vorremmo noi avere due pesi e due misure?» In seguito all’emendamento
Michelini, ne viene approvato un altro alla Camera, questa volta presentato
dal marchese Gustavo Cavour. Egli chiede che i religiosi stranieri, ai quali
venivano finora assegnate solo 300 lire per rimandarli nei Paesi d’origine,
possano ricevere lo stesso trattamento adottato per i religiosi italiani dopo
dieci anni di residenza nel Regno di Sardegna. Il deputato, inoltre propone di
non respingere le religiose lombarde giunte in Piemonte per farsi monache.
Inizialmente, l’emendamento viene accolto senza incontrare opposizioni. Il
giorno seguente, tuttavia, il deputato Mellana sottolinea che la Camera l’ha
approvato per “un sentimento di generosità”, visto che l’emigrazione delle
suore lombarde (“chi per dividere le nostre italiane speranze e i nostri dolori
fu astretto a esulare dalla sua terra nativa”) e quella dei religiosi stranieri
(“generosa emigrazione italiana, che ci gloriamo di vedere assisa ai nostri
focolari”) non stanno sullo stesso piano. Appare chiaro, quindi, che la Camera
adotta sistematicamente “due pesi e due misure”.
C: creazione di un’apposita cassa ecclesiastica
L’articolo 6 del provvedimento ministeriale sancisce l’istituzione di una cassa
ecclesiastica separata dall’ordinario bilancio dello Stato. Il conte di Revel
critica aspramente questa proposta unitamente alla scioltezza con cui il
Governo tratta le questioni finanziarie. Egli sostiene, inoltre, la necessità di
una discussione pubblica prima dell’approvazione dei progetti di legge,
perché il Parlamento è atto principalmente proprio al controllo sulle tasse e
sul loro utilizzo. Cavour e Rattazzi, contrariamente a ciò che sostiene Ravel,
considerano positivamente il fatto che a deputati e sanatori venga risparmiata
“la perdita di tempo in inutili e defatiganti discussioni”.
«Lo scioglimento... aggraverebbe di nuovi pesi...»
Una delle componenti dell‟ufficio centrale del Senato, che ha ricevuto
l’incarico di analizzare il progetto di legge, suggerisce una modifica del testo
elaborato dal governo Cavour, per cui i religiosi che hanno già pronunciato i
voti sono legittimati a rimanere negli edifici nei quali vivono. È il senatore Di
Collegno che presenta il provvedimento alla Camera, che lo accoglierà. Ma,
con l’approvazione dell’emendamento, il Governo non potrà disporre in tempi
brevi dei fondi che aveva destinato alla guerra di Crimea.
26 aprile 1855: crisi Calabiana Il 26 aprile del 1855 i vescovi subalpini,
supportati dal Papa, dichiarano all’ Assemblea dei senatori, tramite il discorso
del vescovo di Calabiana, di essere disposti a provvedere autonomamente al
pagamento delle 928.000 lire (ovvero la somma che occorre al pagamento
delle congrue a sostegno dei parroci poveri).
La proposta dei vescovi determina, però, una profonda crisi, che porta
Cavour a rassegnare le dimissioni lo stesso 26 aprile. Il Re dà
successivamente l’incarico di formare un nuovo Governo a Durando, di noto
orientamento liberale. Egli, però, il 3 di maggio si presenta in Senato per
presentare la rinuncia all’incarico, che viene dunque affidato nuovamente a
Cavour. La crisi, iniziata il 26 di aprile e conclusasi il 2 di maggio (nello spazio
di una settimana), determina la definitiva sconfitta della destra parlamentare,
nonché il distacco del Re dagli ambienti cattolici del Regno di Sardegna.
Cavour, invece, si avvia ad entrare nel “periodo della sua egemonia
parlamentare, che più tardi farà parlare di dittatura”.
Se le rendite della Cassa non bastano?
Il deputato Di Vesme, dopo il rifiuto di Cavour alla proposta di Calabiana,
chiede al Governo “se, nel caso che le rendite della Cassa ecclesiastica non
bastino a coprire i pesi […] i parroci non avranno l’intiera loro congrua, o se
alla deficienza sarà supplito dalle finanze”. Il conte assicura che, qualora
dovesse verificarsi un evento così inatteso, “in questo caso certamente il
Governo proporrebbe al Parlamento l’adozione di quelle misure atta a non
lasciare in condizioni peggiori quella parte del sacerdozio”. Risulta quindi
evidente che dietro misure di natura finanziaria si cela “una questione di
principio politico, religioso, economico”.
I PRINCÌPI DA SANCIRE
«Il Papa non dovrebbe essere principe temporale»
La conclusione della discussione parlamentare sulla soppressione dei
conventi (o separatismo) risulta essere che “ Il Papa non dovrebbe essere
principe temporale, ché, se non lo fosse, sarebbe meglio per la religione e
per l’Italia”. In realtà, da tale principio, secondo Pellicciari, scaturisce un
grande disordine, poiché esso non assicura l’esistenza di due autorità
separate, ognuna con il proprio ambito di competenza, ma le confonde,
facendo convergere il potere spirituale in quello temporale.
Una questione contingente è quella della “funzione profetica” che viene
attribuita dalla maggioranza alla sinistra, che deve assolvere un incarico
molto importante: è necessario che continui a guidare il Parlamento nella
“direzione di marcia in cui si sta faticosamente avanzando”. In questo
contesto si può dire che destra e sinistra concordino sul fatto che la strada da
percorrere debba rappresentare necessariamente il proseguimento di quella
già intrapresa. Tuttavia, mentre per la sinistra la via scelta è un punto di
orgoglio, la destra la pensa all’opposto.
CONCLUSIONI
1856: i frutti della legge
Il trionfo di Cavour nella lotta ai conventi “allinea” il Regno di Sardegna alle
altre nazioni “civili” ed è dovuta alle mirate azioni propagandistiche condotte
dal conte sia sul fronte internazionale che su quello interno. Per Cavour è
necessario persuadere l’opinione pubblica che nello Stato della Chiesa regna
il malgoverno, e che, al contrario, il Regno di Sardegna è uno Stato modello,
“democratico, liberale, rispettoso dei diritti individuali”. Alla Conferenza di
pace di Parigi egli segnala inoltre al mondo “il disastroso e tirannico operato
della Santa Sede”. In Italia, invece, affiancato da La Farina, il conte darà vita
alla Società Nazionale, allestendo poi sul piano diplomatico, economico e
militare la Spedizione dei Mille.
Pio IX
Il 18 marzo 1861, dopo altri interventi salienti, Papa Pio IX decide di mettere
al corrente i fedeli della vera e propria guerra che è in atto fra Chiesa e Stato:
“Da una parte ci sono alcuni che difendono i princìpi di quella che chiamano
moderna civiltà, dall’altra ci sono altri che sostengono i diritti della giustizia e
della nostra santissima religione. I primi chiedono che il Romano Pontefice si
riconcili col Progresso e col Liberalismo, come li chiamano, e con la moderna
civiltà”. Pio IX intende asserire che la battaglia intrapresa dai Savoia
(appoggiata naturalmente anche dalla massoneria e dalle potenze nemiche
del cattolicesimo) non è volta soltanto a “sconfiggere l’oscurantismo
cattolico”, ma anche ad “impossessarsi…delle proprietà che la carità dei
fedeli ha nel corso dei secoli regalato alla Chiesa di Roma”, e a determinare
la definitiva fine della fede cattolica.
(Elena Rossi)
2. UN ITALIANO CONTRO L’UNITA’ D’ITALIA
Giacinto De’ Sivo è uno dei più noti scrittori dell‟Antirisorgimento. Il suo
scritto, I napolitani al cospetto delle nazioni civili, pubblicato nel 1861, svolge
un resoconto approssimato e polemico della disfatta del Regno di Napoli.
Dopo il 1860, crollato il Regno delle Due Sicilie, la corte di Francesco II
(composta da militari, burocrati, nobili ed ecclesiastici) emigrò alla volta di
Roma, ancora per poco capitale dello Stato della Chiesa.
Ciò che accomuna costoro è la speranza di recuperare il regno. In tale fase si
distinguono opinioni politiche diverse: innanzitutto è possibile individuare un
gruppo moderato (sostenitore di un regime costituzionale) contrapposto ai
cosiddetti “ puri”
(sostenitori dell’assolutismo monarchico).
I moderati speravano, inoltre, di recuperare il regno attraverso un intervento
di riassestamento degli equilibri europei. Altri, invece, confidavano nella
ribellione che dilagava nel sud ( brigantaggio).
Ma quale forma politica avrebbe dovuto avere l’Italia?
Sul punto si sono delineate opinioni diverse: c’è chi propone posizioni
separatiste (il semplice distacco del Regno di Napoli da quello d’Italia), chi,
invece, sostiene soluzioni federaliste.
In tale scenario, Giacinto De’Sivo, pur essendo un controrivoluzionario,
legittimista ed intransigente fu inviso sia ai moderati che ai più radicali.
La sua posizione è presente in numerosi scritti, fra cui emerge la “ Storia
delle Due Sicilie dal 1847 al 1861”. In quest’opera domina l’idea che gli eventi
storici non siano il frutto di un preciso piano razionale necessario, ma l’esito
delle passioni umane. Nell’opera intitilata “ i Napolitani al cospetto delle
nazioni civili” la difesa dell’Indipendenza Napoletana non si traduce in un
semplice municipalismo. L’autore, considerandolo la “Diversità” una ricchezza
per l’Italia indica come via maestra da seguire la “ libera unione” che rispetti
le tradizioni di ciascuno.
I temi fulcro dell’opera riguardano la questione della “ setta”, la polemica sulle
condizioni del Regno, gli orientamenti politici.
All’origine di ogni rivoluzione, secondo De’ Sivo vi è sempre la “setta”
(massoni, filosofi, illuminati, giacobini, carbonari, mazziniani, unitari) e non
condizioni specifiche dei singoli stati come il malgoverno, l’oppressione: si
tratta piuttosto “ di trame generali premeditate da un concetto”.
La setta, secondo De’ Sivo, strumentalizza il popolo fabbricando le opinioni.
Inoltre l’autore ribadisce la convinzione secondo la quale per i Napolitani la
monarchia è religione.
Oltre a ciò confuta l’idea emersa nella storiografia savoiarda che ritrae il sud
come un territorio depresso, caratterizzato da un’agricoltura arretrata
destinato ad ostacolare lo sviluppo del nord.
La tesi Desivana è che il Napoletano fosse una nazione civile dotata di un
autonomo sviluppo, ritenendo pertanto inattendibile il programma piemontese
del riscatto del mezzogiorno da pretese condizioni di arretratezza attraverso
l’unificazione della penisola. Dal punto di vista dell’orientamento politico
De’Sivo ritiene che l’affermazione di una nazionalità ideale, non solo
comprime le realtà locali ma sfocia nel nazionalismo e nello sciovinismo. Ben
diversa è la sua concezione della comunità internazionale, dell’Europa e
dell’Italia.
Per quanto riguarda la comunità internazionale, egli pensa che tutti gli stai
dovrebbero essere uguali e uniti in un congresso permanente, capace di
dirimere le; l’Europa dovrebbe unirsi in federazione e l’Italia configurarsi come
una lega finalizzata a garantire l’unità nella diversità.
Napoli non avversa l’Italia, con la lega resterebbero sacri e rispettati tutti i
diritti preesistenti, le autonomie , le leggi, le tradizioni, le consuetudini e i
desideri di ciascun popolo.
De’Sivo dunque rifiuta ogni forma di accentramento verticistico, di uniformità
normativa. Sul piano giuridico si potrebbe dire che De’Sivo propugni una
confederazione piuttosto che una federazione; sul piano politico si può
collocare invece fra i grandi pensatori tradizionalisti, difensori della libertà e
dei privilegi locali.
In questo primo paragrafo di apertura del breve saggio viene affrontata la
tematica dei cruenti moti indipendentisti che scuotevano l’Italia, specialmente
nel reame delle Due Sicilie in cui si verificarono atrocissime lotte.
Ma “ quella fazion che vuol parer d’essere di italica nazione […] versa torrenti
di sangue dal seno stesso della patria, per farla povera e serva”.
Tali conflitti scaturiti dal sogno di libertà non avrebbero portato altro che
sofferenze agli Italiani, minando ogni speranza d’unione, provocavano odi
civili inestinguibili e guerre fratricide: “l’Italia combatte l’Italia”.
Non solamente le risorse materiali vengono deturpate ma la stessa morale, il
diritto e la religione di cui il popolo italiano faceva tanto vanto: “ il suo primato
civile”.
Secondo la visione provvidenziale dell’autore (proprio con il fuoco si purifica
l’oro) solamente le sventure potranno purificare la società perché soltanto
dalle ceneri e dal fuoco “ sorgerà una società italiana moderna e splendida
per ragione e virtù”.
Ma “ la guerra rappresenta il ritorno della società ad uno stato brutale”. Il
mondo raggiungerà la civiltà tanto agognata solamente quando tutti i popoli
saranno uniti in Cristo nel comune interesse dell’amore e della pace”.
Contrariamente a quanto auspicato dal messaggio di Dio invece i popoli non
fanno altro, secondo De’Sivo che incrementare le differenze che li separano
rendendole sempre più profonde, tanto che sembra risorgere l’antico
paganesimo che appellava barbaro lo straniero e lo voleva morto o servo”. Se
invece esistesse un congresso permanente capace di giudicare con un
codice internazionale e che avesse una comune forza per l’esecuzione dei
suoi decreti allora anche la piccola Norvegia dovrebbe essere uguale
all’ampia Russia innanzi al magistrato delle nazioni.
Tale concetto non è destino che rimanga inadempiuto, in quanto è proprio il
bisogno di coesione e di unità che anima da secoli l’uomo, il comune
desiderio di pace e di prosperità, i vincoli sempre più estesi del commercio,
“l’elettrecismo , il vapore, montagne forate, gli istmi tagliati, son tutti passi
verso una civiltà piena e non lontana, che uguaglierà le potenze e farà tacere
le ambizioni e le vanità. Pienamente allora Cristo avrà regno”.
In queste righe è chiaramente espressa la concezione desivana relativa alla
configurazione politica che l’Italia e l’intera Europa sono destinate ad
assumere in quanto solo tale “ perfezione sociale assicurerebbe davvero
l’uguaglianza, la fraternità e la libertà con l’esaltamento della religione”.
Proprio in tale contesto la “setta” rappresenterebbe il nemico per
antonomasia dei valori sopracitati, essa “va gridando le nazionalità per
subissare le nazioni e derubarle e far poi di tutte una famiglia sociale senza
legge”.
La setta rappresenta l’incarnazione del male , una forza diabolica che agisce
nell’ombra andando a minare e compromettere l’unità e la stabilità degli stati.
Essa corrompe la popolazione inventando la storia, si impone nella letteratura
e nella scuola, insinuandosi nelle menti dei giovani studenti animandoli con
illusorie promesse di libertà, giustizia ed indipendenza e trasformandoli in
suoi principali emissari ed esecutori.
Essa impera come Satana ed ha schiere infinite di dèmoni ubbidienti. “La
setta è il rovescio del Cristianesimo. Cristo unisce le nazioni in un amore di
Dio. La setta disunisce bensì le famiglie e aspira all’isolamento dell’ateismo”.
Secondo l’autore l’unico, solo, successo di cui tanto vaneggia tale
organizzazione fu la rivoluzione francese, che si configura come il mezzo
identificatore della setta. Essa fu responsabile di numerosi e sanguinosi
eventi.
Decapitò Luigi XVI, fece incoronare Napoleone e fu responsabile della sua
caduta, congiurò contro la Repubblica del 1848, dilagò in Spagna con Perez,
divise l’America nella sua originaria unità politica e territoriale, portò alla
nascita di stati plebiscitari in Italia.
La setta mondiale è sempre esistita fin dalla epoche più remote ed ha
assunto nomi e si è fatta portatrice di valori di volta in volta diversi ma
fondamentalmente il suo principale obiettivo era quello di rovesciare l’ordine
presente del mondo, di suscitare una qualsiasi mutazione allo scopo di
“pigliarsi il mondo”. Essa è la guerra di quelli che non hanno a quelli che
hanno.” Ma nonostante tutte le battaglie , i morti e le sofferenze, arriva
spietata la domanda dell’autore: si è poi raggiunta la libertà tanto
propagandata?! La risposta è che ogni rivolta che è stata compiuta allo scopo
di ottenere la libertà non è stata altro che una mera menzogna.
La libertà tanto acclamata dalla setta, quella che affiora dalle labbra ed è
impressa sui vessilli non è la vera libertà, quella che è sommo concetto,
quella che il Signore ha racchiuso nei nostri cuori. Ma la setta non vuole la
libertà, la strumentalizza per il raggiungimento dei suoi obiettivi (l’anarchia, la
guerra, le imposte forzate, l’abolizione degli altari e delle leggi, il comunismo ,
la tirannia) la invoca a gran voce ma solo per accogliere un numero sempre
maggiore di adepti nelle proprie schiere, poi senza pietà li lascia cadere sui
patiboli.
La vera libertà è quella dell’uomo onesto: egli non ha alcun vincolo , non
prova alcuna invidia né agogna i beni altrui . Egli è libero in quanto vive sotto
l’esempio di Cristo: sopporta, combattendo per la patria e muore per gli altari
e per la religione.
La forza rivale della setta è la società, ultimo baluardo di giustizia perché
quando è sconfitta dalla setta le carceri vengono abolite ed introdotte illegali
fucilazioni, esili, vendette, persecuzioni…
Giunge allora una preghiera di De’Sivo che intima al popolo di risvegliarsi,
poiché questo non può appellarsi al Risorgimento, in quanto la rinascita tanto
agognata non può condurre a tali inenarrabili crudeltà. Solo l’unione delle
nazioni e la virtù cristiana possono guidare il popolo alla ribellione, al trionfo,
alla liberazione dalla setta, alla vera libertà.
Dopo aver fornito una dettagliata trattazione sulla setta, nel secondo capitolo
del saggio, l’autore effettua un minuzioso panegirico della peculiarità del
Regno delle due Sicilie celebrandolo quale esempio di primato edile e
sociale. I “rigeneratori” torinesi invece dopo tante sperticate lodi di tutto dare,
tutto ne han tolto: e solo han potuto creare la miseria e il nulla”.
Nel terzo capitolo De’Sivo ribadisce la grandezza del Sud ( “Era in cima di
fatto, perché esso aveva, in proporzione de’ suoi abitanti, più templi, più
teatri, più oratori, più poeti, più filosofi, più artisti, più opificii, più reggie, più
commercio, più capitali, più scienze, più arti, più uomini d’ingegno che non il
resto della penisola.”) ammettendo come unico errore il fatto che il governo
non si sia adeguatamente difeso dalle “infamie” che i giornali avevano
contribuito a diffondere ed , inoltre, commettendo l’ulteriore errore di
sospettare di ogni scrittore in quanto tale (“ fe parere che tutti gli uomini di
ingegno vi fossero contrari”). Inoltre una parte pur minima, corrotta ed insana
della popolazione contribuì a diffondere la calunnia, non contradetta, sorretta
e divulgata da mercatanti di rivoluzioni e così preparò il palco sul quale era da
immolarsi la nostra felicità”.
Sventati i moti del “48, fu usata eccessiva clemenza nei confronti dei
congiuranti e “non fu sol perdonata la colpa, talvolta premiata. Della
rivoluzione rimasero gli uomini ed essi han preparato il 1860”. Proprio coloro
che avrebbero dovuto esser grati al re per averli “ perdonati, tollerati e
promossi “ furono tra i primi tra le file dei cospiratori”.
Quanto all’atteggiamento dei piemontesi ne viene evidenziata l’ambiguità in
quanto da un lato asseconda le “vittime illustri del despotismo”, dall’altro però
sostiene gli “operatori del dispotismo” e cospira ai danni della monarchia
borbonica servendosi dei collaboratori più vicina ad essa, che di fatto hanno
circuito il sovrano. Nell’ottica desiviana, il Piemonte fu a dir poco “impudente”
quando giustificò come atto di politica dell’ “intervento” andare in aiuto “d’un
assalito Papa” e del “non intervento” […] accorrere a pro di un assalitore
pirata.” Il riferimento va a Garibaldi che, pur venendo dichiarato “un pirata”,
quando riuscì a trionfare nel Napoletano, venne considerato da Cavour in
Parlamento un suo inviato per far risorgere l’Italia.
De’ Sivo mette in guardia dalla rivoluzione considerata una “nuova e favorita
potenza”, che ha la facoltà, a differenza delle altre nazioni di “aver diritti
senza doveri, assumendo così essa sola il compito di portare libertà,
indipendenza e guai a chi senza di lei osi esser felice”. Il regno delle due
Sicilie era libero e indipendente fin dal 1734, ma ciò “era a seconda del dritto
antico, del dritto divino; esso invece doveva essere felice pel dritto nuovo, pel
dritto infernale”, pertanto si rivelava necessaria la rivoluzione. Fu così che si
attuò l’impresa garibaldina che indusse “cavalleresca pieghevolezza” [!] del re
Francesco di Borbone a promettere vanamente una costituzione per fermare i
Piemontesi. A condurre alla fine il regno piemontese fu, secondo De’ Sivo , la
camorra, che insinuatasi nei luoghi centrali del potere indusse il re a lasciare
Napoli, rimpiazzandolo con Garibaldi, accolto con esultanza, “ma non per la
gioia, ma per il timore”. L’esercito garibaldino “lurido, bieco, famelico,
disordinato […] entra nella città di Napoli che i vandali mai non vide, vide i
garibaldini”. Un’ultima resistenza fu tentata a Capua, mettendo in luce l’onore
napoletano, ma sopraggiunse i aiuto dei garibaldini il “re galantuomo” [Vittorio
Emanuele II] che, in modo meschino, non si curò nemmeno di far
dichiarazione di guerra, bensì schiacciò un esercito sfinito, che combatté con
onore.Il capitolo sesto si chiude con una serie di domande emblematiche.
De’Sivo si interroga se questo rovesciamento totale del diritto sia giustificabile
in nome dell’“Italia una” e soprattutto se il Piemonte realmente voglia un’Italia
unita, se l’Italia possa “essere una” e se sia conveniente esserlo. Inoltre i
“Napolitani consentono? Di questo è da ragionare.”
Il titolo con cui si conclude il saggio è inequivocabile: “Il Piemonte non vuole
un’Italia unita”.
Il De’ Sivo parte dal definire il diritto di nazionalità in base al quale si tende ad
unire le genti nel nome della lingua; in base a tale principio l‟Italia unita non
può mancare di Venezia, Corsica, Malta e Trieste ma per le simpatie nei
confronti di Francia e Inghilterra e per il timore dei Tedeschi, tutto ciò non
risulta possibile, ma sembra inoltre che manchi la volontà, dal momento che
cedendo Nizza e Savoia alla Francia, è stato reso più vulnerabile il territorio
italiano. In realtà il Piemonte “non vuol fare l‟Italia, ma vuol mangiar l‟Italia”
secondo De Sivo. Il Tedesco veniva accusato di dominare l‟Italia, in realtà
controllava la sedizione e per questa ragione “anzi che dominatore ne era
benefattore”. Il Piemonte invece non esita addirittura a calpestare il primato
morale che l’ Italia può vantare per la presenza a Roma della sede del vicario
di Cristo, pur di asservire l’Italia, ma “l’usurpazione in tempi civili non riesce a
grandezza”.
(Valentina Sari)
5.CONCLUSIONE
IL RISORGIMENTO ITALIANO E’ FINITO?
Che cosa è avvenuto con il Risorgimento? Per usare le parole dello storico
A. M. Banti nel corso del Risorgimento ”…è successo che si è costruito in
Italia uno Stato di tipo nuovo, uno Stato- nazione ; ovvero uno Stato fondato
sul principio secondo il quale la sovranità appartiene non ad un singolo (re), o
a gruppi ristretti (nobili), ma all’intera collettività identificata con il termine
“Nazione.” Banti aggiunge poi che questa appena descritta non è una
dinamica che riguardi solo l’Italia. Il nazionalismo, infatti, così come si forma
nel primo Ottocento, è un fenomeno europeo, ed è strutturato dovunque
intorno ad un’ideologia che è materiata, essenzialmente, dei medesimi
elementi.”
Banti conclude affermando peraltro che oggi siamo ben distanti dalla
sensibilità e dai valori di allora: “il Risorgimento è un Paese lontano.”
Si può concordare sulla lontananza ma a noi sembra che riflettere, anche in
modo critico, su quel passato serva per comprendere molte difficoltà del
nostro presente.
Partiamo dalle considerazioni riportate sopra dalle quali emerge con
chiarezza che il Risorgimento è stato la nostra “rivoluzione”, il passaggio cioè
dall’Ancien regime alla sovranità popolare, che ha permesso al nostro Paese
di aprirsi al mondo della libertà e della modernità.
Qui c’è un primo aspetto critico: se è vero che attraverso il Risorgimento il
popolo italiano “si è fatto Stato” dando vita ad un patto politico, va detto che
esso però ha assunto allora la forma dell’adesione passiva (rivoluzione
passiva), del plebiscito. Il popolo italiano fu chiamato ad avallare un assetto
politico che era stato creato da altri.
Il fallimento del progetto mazziniano, nel 1848-1849, di dar vita ad una
Costituente democratica ha avuto come conseguenza che il patto tra gli
italiani e lo Stato abbia assunto all’inizio un carattere più formale che
sostanziale, più subito che consensuale.
Erano limiti a cui si sarebbe potuto rimediare nei decenni successivi ma a cui
non fu posto rimedio per responsabilità delle classi di governo ma anche delle
opposizioni.
Un vero Patto Costituente si è potuto realizzare, in Italia, solo a cento anni di
distanza e dopo la caduta rovinosa del regime fascista, la sconfitta nella
seconda guerra mondiale e la lotta di Resistenza. Negli anni 1945-1948
l’Italia risorgeva,questa volta non dalla dominazione straniera ma dai disastri
di una guerra voluta da Mussolini e dal suo regime. Prendeva così forma il
nuovo Stato italiano, la Repubblica, la Costituzione democratica. Finalmente
c’era una base comune, condivisibile da tutti, su cui costruire il futuro. L’Italia,
grazie alla Costituzione è cresciuta, si è sviluppata, è diventata una delle
principali potenze economiche nel mondo e, tuttavia, anche l’esperienza
repubblicana fino ad oggi non ha sanato del tutto l’estraneità tra Stato e
cittadini per cui il patto costituzionale resta ancora fragile e instabile.
Ciò è accaduto soprattutto perché la democrazia repubblicana, nel nostro
Paese, è stata a lungo una democrazia incompiuta, senza alternanza, a
causa della guerra fredda e dell’impossibilita per l’opposizione di legittimarsi
alla guida del governo. Le divisioni politiche e ideologiche hanno impedito
finora una completa maturazione democratica per cui facciamo fatica come
comunità nazionale a identificarci tutti in un sistema di regole giusto ed
efficace che precisi i diritti e i doveri e garantisca, al di là dei governi e delle
maggioranze contingenti, una convivenza civile, lontana dalle
contrapposizioni feroci proprie di una guerra civile strisciante. Fenomeni
come la criminalità organizzata, che spadroneggia su intere regioni, oppure
come la diffusa evasione fiscale, che per quantità non ha paragoni negli altri
paesi sviluppati, sono problemi che stanno di fronte all’intera comunità
nazionale che dovrebbero unire tutte le forze politiche in un compito comune
per debellarli. Un paese senza regole condivise e rispettate da tutti non può
avere un futuro, ma è destinato a frantumarsi in una molteplicità di
corporazioni o di gruppi sociali contrapposti gli uni agli altri senza rimedio.
La volontà da parte di tutti di ispirarsi ai principi di un “patriottismo
costituzionale”, inteso come sentimento comune di legalità e giustizia
potrebbe rappresentare la vera realizzazione del Risorgimento italiano.
INTRODUZIONE:
Il testo seguente intitolato “il Risorgimento italiano è finito?” è il risultato di
una ricerca collettiva condotta dagli allievi della IID classico nel corso di
quest’anno scolastico. Ciascun allievo ha letto e riassunto un saggio sulla
storiografia nel Risorgimento, da quello meno recente a quello più attuale,
allo scopo di approfondire un tema di studio che resta importante al di là delle
celebrazioni di quest’anno.