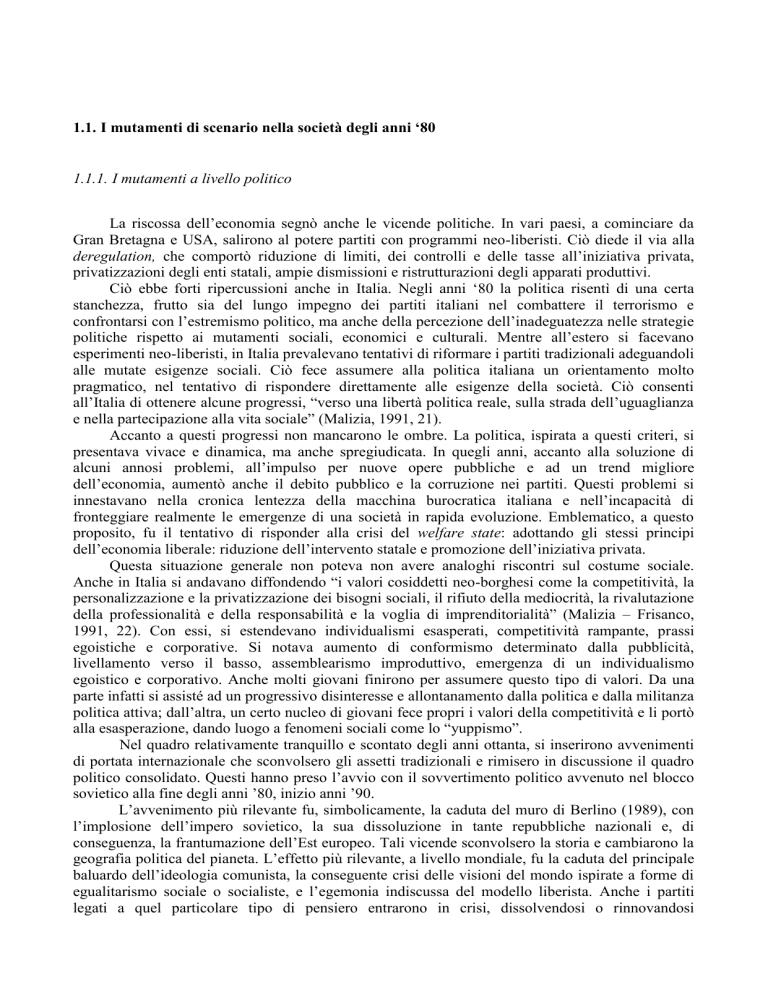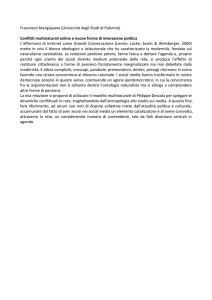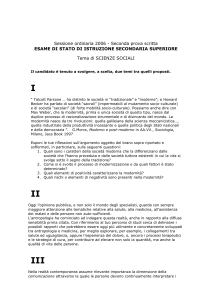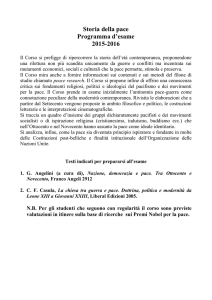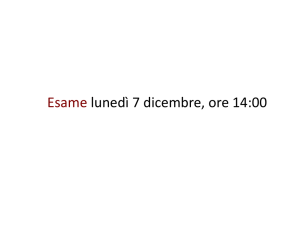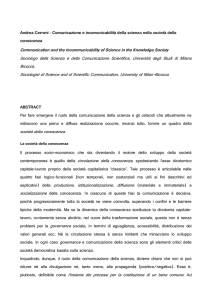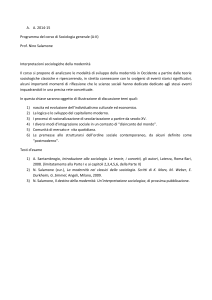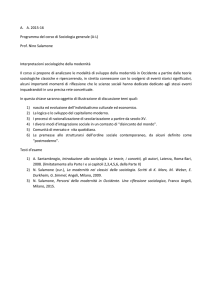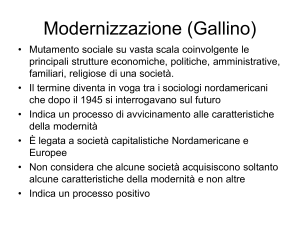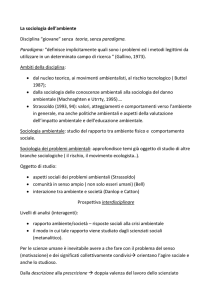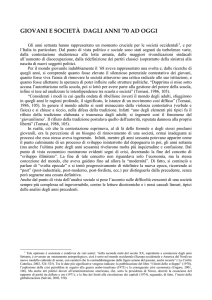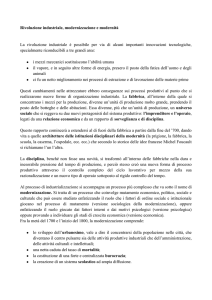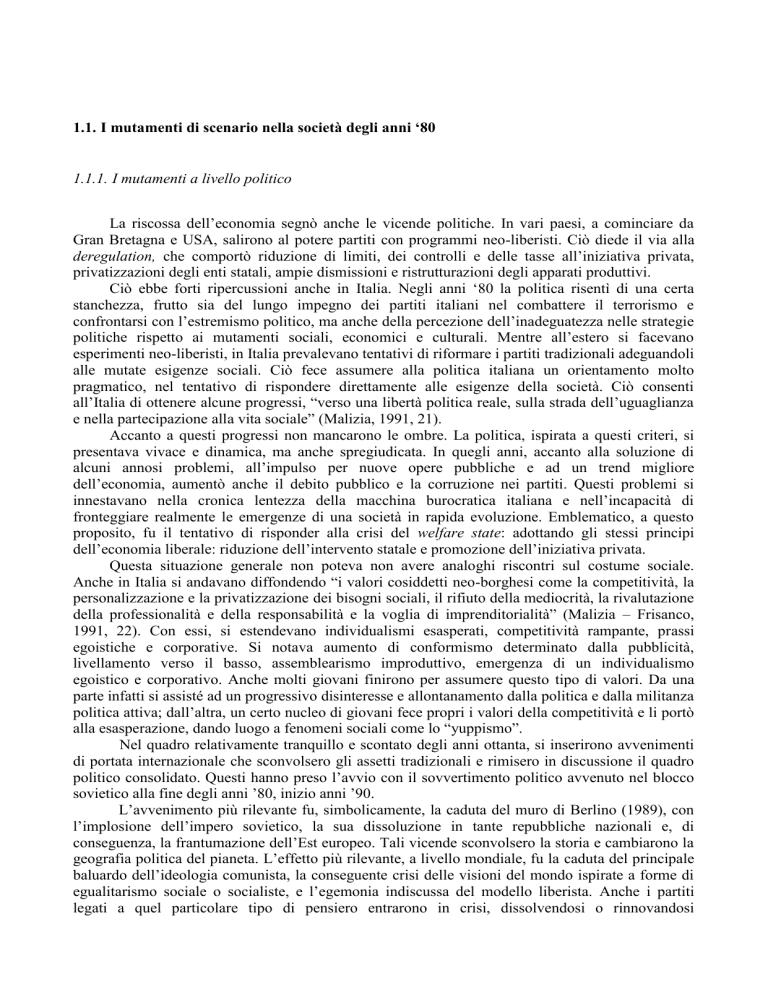
1.1. I mutamenti di scenario nella società degli anni ‘80
1.1.1. I mutamenti a livello politico
La riscossa dell’economia segnò anche le vicende politiche. In vari paesi, a cominciare da
Gran Bretagna e USA, salirono al potere partiti con programmi neo-liberisti. Ciò diede il via alla
deregulation, che comportò riduzione di limiti, dei controlli e delle tasse all’iniziativa privata,
privatizzazioni degli enti statali, ampie dismissioni e ristrutturazioni degli apparati produttivi.
Ciò ebbe forti ripercussioni anche in Italia. Negli anni ‘80 la politica risentì di una certa
stanchezza, frutto sia del lungo impegno dei partiti italiani nel combattere il terrorismo e
confrontarsi con l’estremismo politico, ma anche della percezione dell’inadeguatezza nelle strategie
politiche rispetto ai mutamenti sociali, economici e culturali. Mentre all’estero si facevano
esperimenti neo-liberisti, in Italia prevalevano tentativi di riformare i partiti tradizionali adeguandoli
alle mutate esigenze sociali. Ciò fece assumere alla politica italiana un orientamento molto
pragmatico, nel tentativo di rispondere direttamente alle esigenze della società. Ciò consenti
all’Italia di ottenere alcune progressi, “verso una libertà politica reale, sulla strada dell’uguaglianza
e nella partecipazione alla vita sociale” (Malizia, 1991, 21).
Accanto a questi progressi non mancarono le ombre. La politica, ispirata a questi criteri, si
presentava vivace e dinamica, ma anche spregiudicata. In quegli anni, accanto alla soluzione di
alcuni annosi problemi, all’impulso per nuove opere pubbliche e ad un trend migliore
dell’economia, aumentò anche il debito pubblico e la corruzione nei partiti. Questi problemi si
innestavano nella cronica lentezza della macchina burocratica italiana e nell’incapacità di
fronteggiare realmente le emergenze di una società in rapida evoluzione. Emblematico, a questo
proposito, fu il tentativo di risponder alla crisi del welfare state: adottando gli stessi principi
dell’economia liberale: riduzione dell’intervento statale e promozione dell’iniziativa privata.
Questa situazione generale non poteva non avere analoghi riscontri sul costume sociale.
Anche in Italia si andavano diffondendo “i valori cosiddetti neo-borghesi come la competitività, la
personalizzazione e la privatizzazione dei bisogni sociali, il rifiuto della mediocrità, la rivalutazione
della professionalità e della responsabilità e la voglia di imprenditorialità” (Malizia – Frisanco,
1991, 22). Con essi, si estendevano individualismi esasperati, competitività rampante, prassi
egoistiche e corporative. Si notava aumento di conformismo determinato dalla pubblicità,
livellamento verso il basso, assemblearismo improduttivo, emergenza di un individualismo
egoistico e corporativo. Anche molti giovani finirono per assumere questo tipo di valori. Da una
parte infatti si assisté ad un progressivo disinteresse e allontanamento dalla politica e dalla militanza
politica attiva; dall’altra, un certo nucleo di giovani fece propri i valori della competitività e li portò
alla esasperazione, dando luogo a fenomeni sociali come lo “yuppismo”.
Nel quadro relativamente tranquillo e scontato degli anni ottanta, si inserirono avvenimenti
di portata internazionale che sconvolsero gli assetti tradizionali e rimisero in discussione il quadro
politico consolidato. Questi hanno preso l’avvio con il sovvertimento politico avvenuto nel blocco
sovietico alla fine degli anni ’80, inizio anni ’90.
L’avvenimento più rilevante fu, simbolicamente, la caduta del muro di Berlino (1989), con
l’implosione dell’impero sovietico, la sua dissoluzione in tante repubbliche nazionali e, di
conseguenza, la frantumazione dell’Est europeo. Tali vicende sconvolsero la storia e cambiarono la
geografia politica del pianeta. L’effetto più rilevante, a livello mondiale, fu la caduta del principale
baluardo dell’ideologia comunista, la conseguente crisi delle visioni del mondo ispirate a forme di
egualitarismo sociale o socialiste, e l’egemonia indiscussa del modello liberista. Anche i partiti
legati a quel particolare tipo di pensiero entrarono in crisi, dissolvendosi o rinnovandosi
profondamente.
1.2. La politica italiana dopo l’89
Con la caduta del muro di Berlino e gli avvenimenti dell’Est europeo risultò non più così
essenziale il baluardo della democrazia eretto dalla DC e dagli altri partiti che dal dopoguerra
avevano, con formule diverse, governato l’Italia e assicurato la sua permanenza nell’area
occidentale. Così si ritenne che fosse giunto il momento di cambiare. La corruzione che aveva
caratterizzato in maniera più marcata l’ultimo decennio divenne l’occasione per dare una spallata al
sistema. Attraverso una serie di processi ad amministratori dei partiti di governo, avviata da un pool
di giudici di Milano, si diede inizio alla stagione di “Tangentopoli” che raccolse e condensò la
voglia di pulizia morale e di onestà dei cittadini, insieme alla volontà di riscossa dei partiti rimasti
da sempre all’opposizione. Ciò portò alla progressiva dissoluzione o cambiamento dei vecchi partiti
che avevano per cinquant’anni governato l’Italia: DC, PSI, PSDI, PRI, PLI.
Nello stesso tempo nuove istanze politiche e nuovi partiti nascevano dalla frantumazione del
vecchio quadro politico. Già prima dell’89 in Italia erano emerse forti spinte particolaristiche, con
manifestazioni di xenofobia ed esaltazione delle tradizioni locali. La nascita del movimento politico
della “Lega Nord”, fornì una base ideologica ed un’organizzazione politica a queste istanze,
provenienti soprattutto da ambienti dell’artigianato, proprietà terriera, media e piccola industria
delle aree pedemontane e rurali del Nord Italia.
Anche l’esperimento politico di “Forza Italia”, promosso da un imprenditore milanese,
Silvio Berlusconi, fu in qualche modo una conseguenza del caduta del muro di Berlino. Esso, con
alcuni principi del neoliberismo economico, ma soprattutto con un elevato senso di pragmatismo,
raccolse parte delle istanze dell’elettorato moderato, rimasto orfano di punti di riferimento dopo la
dissoluzione della DC e del PSI.
Anche i giovani seguirono, in qualche modo, tali andamenti politici. Secondo lo IARD, nel
1996 si ebbe un’ulteriore polarizzazione delle posizioni giovanili verso gli estremi, e, nelle
preferenze elettorali, un consistente spostamento verso destra con propensione per i partiti di nuova
fondazione (Buzzi – Cavalli - de Lillo, 1997, 108-109). Soprattutto la Lega Nord, all’inizio, registrò
una notevole crescita di consensi tra l’elettorato giovanile. Tuttavia, dagli approfondimenti condotti
dallo IARD, non risultò che ciò significasse un aumento del pericolo separatista contro le tendenze
universalistiche, tradizionalmente retaggio dei giovani. Anzi apparve chiaro che i giovani italiani,
pur interessati alle vicende politiche, reagivano di fronte alla minaccia separatista recuperando il
valore della patria, fino ad allora poco considerato. Conseguenza di ciò fu la rivalutazione
dell’istanza localista senza perdere il senso di un’appartenenza più vasta. La cosa apparve così
chiara che l’estensore, che pur aveva intitolato il capitolo “l’Italia: un puzzle di piccole patrie”
(Buzzi – Cavalli - de Lillo, 1997, 145), concludeva definendo i giovani “localisti, italiani e
cosmopoliti, senza contraddizioni” (Buzzi – Cavalli - de Lillo, 1997, 168).
1.2.1. Mutamenti a livello economico
Negli anni ’80 l’economia riprese il sopravvento sulla politica, che negli anni ’70 aveva
avuto un ruolo egemone. L’economia risolse le sue crisi cambiando radicalmente il modo di
produzione e di distribuzione delle merci, e le stesse concezioni che l’avevano guidata per tutta la
fase dell’espansione industriale. Per questo motivo questo periodo fu denominato “post-industriale”.
A livello industriale la tendenza prevalente fu la “deverticalizzazione” dei grandi
stabilimenti, con l’attribuzione all’esterno (piccole imprese) di parte del ciclo produttivo. Iniziò in
quegli anni la rivoluzione microelettronica ed informatica. Il modello produttivo che s’impose fu
quello della “Toyota”, che rese obsoleta l’organizzazione “fordista” o “taylorista” del lavoro. I
termini emergenti furono “flessibilità”, “creatività”, “qualità”, “piccolo è bello”, superando le
logiche disumanizzanti della catena di montaggio. La nuova industrializzazione comportò la
dislocazione degli stabilimenti in aree più convenienti per il costo della manodopera. Nacquero i
fenomeni della “delocalizzazione” delle industrie e della “globalizzazione” dei mercati.
La terziarizzazione dell’economia si estese sempre più. L’intreccio tra terziario e cultura
comportò una razionalizzazione dei comportamenti ed una ristrutturazione dei processi decisionali,
un allargamento delle capacità conoscitive. Crebbe la domanda di qualità nella produzione. La
scienza e la tecnologia ebbero un ruolo sempre più rilevante nei processi produttivi.
Vennero incrementati i consumi. Per poter reggere all’aumento di produzione necessitavano
nuovi bisogni che potevano essere soddisfatti solo da prodotti sempre più sofisticati. La spinta ai
consumi fu sostenuta dalla pubblicità e dall’opera suadente dei mass-media. La nascita di tante
radio e TV private si reggeva su questo presupposto.
Il modello di vita occidentale e consumista venne diffuso capillarmente in tutti i continenti,
creando un’omogeneizzazione della cultura e dei consumi, funzionale alla grande distribuzione, ma
con effetti distruttivi sulle culture locali e disgregativi sul tessuto sociale.
Un altro effetto di questa rivoluzione fu il problema occupazionale. La rivoluzione
microelettronica e informatica, la “deverticalizzazione” e la “delocalizzazione” consentirono di
ridurre notevolmente la manodopera o di avvalersi di manodopera a basso costo. La nuova fase
espansiva creò lavoro in attività interstiziali, con proliferazione di tante piccole attività produttive
precarie, si diffuse il lavoro occasionale, part-time, ecc. Tutto ciò permetteva di sfuggire più
facilmente al controllo dei sindacati e degli ispettori del lavoro, con aumento del lavoro nero,
sottopagato, senza protezione sociale. Questo tipo di produzione comportò, infatti, oltre
all’espansione industriale, un aumento significativo di incidenti e i morti sul lavoro.
La crisi occupazionale segnò significativamente la condizione giovanile di quegli anni. Se
gli anni di transizione (1979-80) furono di ripresa economica, ciò non durò, perché legato a fattori
effimeri (lavoro nero, economia sommersa, dilatazione spesa pubblica). Il resto dei primi anni ‘80
registrò un aggravamento del problema. Da una parte c’era l’urgenza di reinserire nel lavoro i
disoccupati, prevalentemente adulti; dall’altra di accogliere i giovani alla ricerca del primo posto.
Le misure legislative adottate per risolvere i problemi occupazionali dei giovani, pur lodevoli nelle
intenzioni, non riuscirono a determinare una vera inversione di tendenza a causa della consistenza
quantitativa del fenomeno. Così il tasso di disoccupazione continuò a crescere nella prima parte del
decennio, con allungamento dei tempi di ricerca della prima occupazione. Ciò favorì anche, tra i
giovani, l'interesse per il lavoro indipendente, benché, l'occupazione dipendente conservasse una
forte attrazione. Insieme ne venne una notevole flessibilità e mobilità, la disponibilità a "provare"
professioni diverse, a "crearne" di nuove, a passare dal ruolo di studenti a quello di lavoratori a
quello di inoccupati con notevole disinvoltura. In genere prevaleva un atteggiamento pragmatico,
dove convivevano esigenze espressive accanto a quelle strumentali.
Le difficoltà occupazionali, insieme all’allungamento del tempo di formazione e la
procrastinazione del momento d’entrata nella vita adulta fece parlare della condizione giovanile
come di un periodo di obiettiva “emarginazione”. Nel rilevare tale situazione Cavalli parlò di una
trasformazione della fase giovanile da “processo” a “condizione”, con effetto macroscopico di
allungamento della fase di socializzazione, ma anche di mutamento nei modi di vivere la giovinezza
e nell’evoluzione verso la maturazione personale e sociale.
1.3. L’economia
Gli avvenimenti a livello nazionale e internazionale ebbero notevoli ripercussioni a livello
economico. La caduta del regime sovietico comportò l’oblio delle teorie interventiste dello stato e
l’adozione a raggio universale dell’economia di mercato. L’indirizzo neo-liberista dalla Gran
Bretagna e dagli Stati si estese a tutta l’Europa, occidentale prima e poi orientale, con non
indifferenti problemi a livello sociale.
Ma, nonostante l’entusiasmo suscitato da questi avvenimenti e la fiducia incondizionata
nelle regole del mercato e nel capitalismo, dopo qualche anno la situazione economica non fu così
brillante come ci si era illusi. “L’Occidente, finita la grande contrapposizione [con l’impero
sovietico], ha conosciuto una lunga congiuntura negativa, con alti tassi di disoccupazione”
(Detragiache, 1996, 107). ).
Tutto questo ebbe notevoli ripercussioni anche in Italia. In un primo momento (fine degli
anni ’80, inizio anni ’90) la situazione economica sembrò migliorare, ma dopo il ’93 essa cominciò
a deteriorarsi e a peggiorare notevolmente. Al grande sforzo per una nuova fase di espansione e
sviluppo degli anni ’80, succedette una certa stanchezza, anche per effetto della depressione
internazionale. Si notò con preoccupazione che era “entrata in crisi la tensione ad innovare e a fare
qualità”; in particolare che si erano “appannate fantasia e creatività” (Malizia, 1997, 10). Anche lo
stato non era più in grado di sostenere e pilotare l’espansione economica.
Ciò influì sull’andamento dei tassi di disoccupazione. La ricerca IARD del ‘92 aveva
registrato, infatti, una bassissima percentuale di giovani in cerca di prima occupazione (3.7%) e il
numero più basso da quando erano cominciate le ricerche IARD di giovani in cerca di lavoro (26%
sotto i 25 anni, 28.8% sotto i 30). Ma qualche anno dopo (’93) la situazione precipitò nuovamente e
le condizioni lavorative peggiorano di molto. La ricerca IARD del ‘96 registrò un debole aumento
della ricerca di prima occupazione (5.4%) e uno più marcato di lavoro in genere (33.3% sotto i 25
anni, 36.8% sotto i 30), con un aumento complessivo di 6-7 punti percentuali di giovani con
problemi occupazionali. A questo si aggiunse l’aumento delle disuguaglianze territoriali (favorito il
Nord-Est, sfavorito il Sud e le Isole), dando luogo a differenti opportunità d’impiego per i giovani,
disparità nella qualità del lavoro e nella retribuzione, maggiori discriminazioni per sesso e cultura.
Una leggera inversione di rotta si registrò alla fine degli anni ’90 non per effetto del miglioramento
del quadro economico, ma per la maggior flessibilità del mercato e la capacità dei giovani di
adattarsi alle nuove situazioni.
Queste alternanze economiche ebbero effetti anche sulla percezione dei bisogni da parte
giovanile. Fino al ‘92, gli andamenti furono in sintonia con le previsioni di Inglehart: diminuiva
l’importanza del lavoro nella gerarchia dei valori (cedendo il posto agli affetti), crescevano le attese
di autorealizzazione e autonomizzazione, con notevole disponibilità alla flessibilità. Ma dopo il ‘92
le attese rispetto al lavoro si invertirono: aumentavano le domande in merito allo stipendio e al
reddito, mentre diminuivano rispetto all’ambiente, ai rapporti, all’autoespressione.
Le diverse situazioni sociali e culturali influirono a loro volta nella tipologia delle risposte. I
giovani più scolarizzati tendevano ad essere relativamente più soddisfatti del lavoro, lo concepivano
più in termini autorealizzativi, ma anche di carriera, mentre i meno scolarizzati mostravano maggior
apprezzamento per la dimensione relazionale ma anche per quella retributiva. Pertanto elementi
espressivi (o postmaterialisti) si intrecciavano con quelli strumentali (o materialisti) in entrambi i
casi, rendendo difficile una lettura lineare dell’evoluzione dei bisogni e dei valori giovanili in
merito al lavoro.
1.3.1. Il paradigma della complessità
Negli anni ‘80 divenne sempre più frequente da parte dei sociologi applicare all’analisi della
società la categoria della complessità1. Con tale termine si volle sottolineare la forte
differenziazione funzionale dei vari sistemi tra di loro e dei singoli sottosistemi al loro interno e la
moltiplicazione delle relazioni tra loro2. Pertanto la complessità non era una caratteristica delle cose
o delle persone, piuttosto una modalità di descrizione di situazioni o problemi caratterizzati da
numerose interdipendenze relazionali. Di questa configurazione della società c'era chi sottolineava
di più la moltiplicazione di possibilità, la crescita di opportunità, di organizzazione, ma non
mancarono alcuni che fecero notare la progressiva ingovernabilità dei sistemi, la mancanza di un
centro organizzatore, la crescita di entropia e la moltiplicazione di codici incommensurabili3.
In quegli anni si registrò un’accelerazione nella pluralizzazione dei centri di potere e dei
sistemi di riferimento e di significato, con effetti di frammentazione e disgregazione della realtà
sociale. Questo comportava per gli individui un aumento di opportunità ed una diminuzione del
controllo sociale. Mentre ciò accresceva le possibilità per il singolo, aumentava anche il carico di
responsabilità personale e la probabilità di non riuscire a far fronte alle richieste della società4.
Perciò tale assetto della società poneva notevoli problemi di integrazione, di adattamento e di
identità5. Queste problematiche investirono soprattutto i giovani, alle prese con problemi ad inserirsi
ed integrarsi nella società. L’adattamento divenne la strategia vincente in tale contesto, che, se
permetteva di far fronte ai problemi immediati, diventava problematico rispetto all’assunzione di
un’identità matura. Infatti l’adattamento si presentava come “una strategia di basso profilo,
sommersa, senza differimenti di bisogni ed aspettative, portata avanti da una soggetto debole che in
ultima istanza costruisce la sua identità quasi per differenza” (Cipolla, 1989, 19).
La capacità di adeguarsi di fronte alle molteplici richieste della società e la rinuncia alla
difesa di principi precostituiti rese questa generazione molto più flessibile e adattata alla realtà, ma
ebbe come prezzo l’incoerenza, che stava diventando, insieme alla soggettivizzazione dell’etica,
uno degli aspetti più caratteristici della cultura giovanile. Il mondo giovanile si frantumò in
innumerevoli rivoli e la ricerca di autorealizzazione assunse l’aspetto della ricerca di percorsi
individuali di maturazione. Era la complessità ad esigere frantumazione e comportamenti
1 "Nella tradizione sociologica (da Durkheim a Simmel a Parsons) quando si parla di complessità del sistema sociale in
riferimento alle moderne società industriali si istituiscono fondamentalmente due tipi di correlazioni. La prima riguarda il numero e
la varietà degli elementi del sistema, la seconda il numero delle relazioni di interdipendenza tra questi stessi elementi. [...] E'
quest'ultima - la densità dinamica e morale della società - la caratteristica saliente in senso sociologico che si sviluppa solo con la
differenziazione e con l'affermarsi della logica della divisione del lavoro" (Sciolla, 1983, 45).
Bisogna però riconoscere che sovente tale situazione viene percepita per le difficoltà che comporta. in effetti, il concetto di
"società complessa" ha cominciato a diffondersi con la crisi socio-economica degli inizi degli anni '80, nel momento in cui
"l'attenzione non va più alla dinamica di sviluppo delle nostre società, ma all'arresto di questa dinamica, agli imprevisti effetti disgregatori: ingovernabilità, instabilità, differenziazione e disarticolazione dei processi produttivi, dilatazione dei settori distributivi e
dell'amministrazione, espansione dell'interventismo statale, disgregazione e moltiplicazione dei gruppi sociali, circolarità tra
aspettative e frustrazioni collettive" (Montesperelli, 1984, 25).
2 Secondo Donati (1985) quattro sarebbero le accezioni relative al termine "complessità" applicato alla società:
1) Complicazione, cioè "crescita quanto-qualitativa di elementi, relazioni e interazioni in un sistema sociale dato" (p. 6).
2) Moltiplicazione di codici incommensurabili, "derivante dall'operare di più e diverse logiche fra loro incompatibili, o,
incommensurabili" (p. 6).
3) Variety pool, cioè "una situazione che consente di mantenere sempre aperte un numero sempre maggiore di possibilità
alternative (più di quante possano essere effettivamente realizzate in un dato momento)" (p. 7).
4) Entropia, "ordine (sociale) probabilistico (casuale), anziché normato, fondato sulla variabilità (differenza)" (p. 7).
3 "Col termine di società complessa si intende descrivere una realtà composta da tendenze ambivalenti, che risultano tra loro
incompatibili e irriducibili; una realtà in cui uno stato di integrazione precaria orienta, ma meglio sarebbe dire costringe a scelte
parziali e di medio termine, caratterizzate da scarsa capacità previsiva, e il cui esito sociale appare nel segno della non risolubilità"
(Garelli, 1991, 540).
4 - "A livello dei soggetti la complessità assume il carattere di differenziazione sociale. Nel tempo presente gli individui e i gruppi
sociali hanno a disposizione possibilità, occasioni, opportunità di scelta e di orientamento, di un livello e di una quantità
inimmaginabili nel recente passato" (Garelli, 1991, 540).
5 - "Il principio di differenziazione e di complessificazione dei rapporti sociali così inteso definisce anche il quadro sociale entro
cui si opera una radicale trasformazione del rapporto individuo/società. Il principio di individuazione, la possibilità stessa da parte
dell'individuo di costruirsi un'immagine di sé ricca di contenuto e fortemente individualizzata, di non essere più assorbito dal gruppo,
identificato in esso, sorge solo in un contesto sociale in cui molte e diversificate siano le forze in gioco" (Sciolla 1983, 45).
“incoerenti” 6. Essa poi, interiorizzata, divenne condizione esistenziale: segno della flessibilità e
dell’adattabilità ai mutamenti richiesti dal contesto, ma anche di debolezza ed insicurezza personale.
1.3.2. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale
Accanto alla differenziazione funzionale, che sarebbe alla base della complessificazione
della vita, l’affermazione della modernità si è avuto attraverso la sviluppo dei mezzi di
comunicazione sociale, che permette l’incremento della comunicazione di notizie e la possibilità di
interagire tra vari soggetti, indipendentemente dal potere politico costituito (Ungaro, 2001, 10-12).
Negli anni ’80 si ebbe una accelerazione di tale sviluppo, con la nascita di nuovi mezzi di
comunicazione e con la proliferazione degli stessi o di altri, fino ad allora riservati a pochi
privilegiati.
In quegli anni si ebbe la diffusione delle radio e televisioni private, l’introduzione dei
videogiochi e dei primi computer, la comparsa dei primi CD e la diffusione di sistemi digitali e
miniaturizzati di lettura/diffusione musicale (CD, cuffiette, lettori compressi) o video.
La diffusione di tali mezzi contribuì all’evoluzione di un nuovo tipo di uomo, molto più
digitale, dove la realtà virtuale si confondeva e a volte superava quella reale. Al linguaggio
concettuale, logico, geometrico del passato (concentrato sulla parte sinistra dell’emisfero cerebrale)
si sostituisce, per effetto del rapporto privilegiato con i “media” il linguaggio analogico, simbolico,
emotivo, intuitivo, creativo della parte destra. Di conseguenza, anche il tipo di cultura della società,
soprattutto delle giovani generazioni, divenne più “visivo”. Si privilegiò un approccio emotivo e
concreto alla realtà a scapito di quello analitico, ma freddo e distaccato, della logica scientifica,
libresca.
Il linguaggio giovanile si modificò, uniformandosi alla logica degli “spot” e dei “flash”. Le
parole vennero usate come slogan, atte a colpire più per la loro capacità evocativa, che per il
contenuto verbale. La grammatica ed il vocabolario si impoverirono, con preferenza per una
comunicazione sintatticamente scorretta, ma efficace sul piano emotivo. Il linguaggio giovanile, in
seguito a questi mutamenti, stava discostandosi notevolmente dalla tradizione.
L’uso di tali mezzi contribuì ulteriormente al distacco dai valori tradizionali, alla
superficialità, al sensazionalismo, al presentismo, alla prevalenza del principio del piacere su quello
della realtà. Rispetto alla storia e alla complessità sociale essi hanno operato in termini di
“semplificazione, manicheizzazione, attualizzazione” (Cavalli 1985).
Da ciò seguì tutta una serie di atteggiamenti e di comportamenti nuovi, primo fra tutti
l’enorme importanza attribuita al look (Battellini, 1986, 86). La moda c’era sempre stata, il nuovo
era costituito dalla velocità del cambiamento. Il fast-food può costituire il simbolo di quella
generazione7. Consumare i fretta, essere sempre sulla cresta dell’onda, essere “in” divennero gli
imperativi di quel tempo. Ciò poteva dipendere dai ritmi di una società che andava sempre più di
corsa, dai rapporti umani sempre più frettolosi: da qui l’esigenza di comunicare al primo impatto, il
proprio modo d’essere, o per lo meno, di voler sembrare, anche la cura dell’estetica in generale, del
viso, del corpo, fatta per rispondere a questa logica che privilegiava ciò che si vede (Battellini,
1986, 86-87).
Vivere alla ricerca indiscriminata del look, della «politica dello stile»,
all'inseguimento di un'identità fittizia da reinventare continuamente portava alla frammentazione in
diversi stili di vita. Tale uomo poteva considerare il mondo un dato labile, manipolabile. Il suo
6 "La contingenza stessa, che per Luhmann è una proprietà dell'ordine temporale degli eventi esterni, diventa, per così dire una
proprietà della percezione interna degli eventi, la matrice psicologica di quella sindrome complessa - destrutturazione,
sperimentazione, paradigma della reversibilità - che tante ricerche sulla condizione giovanile hanno messo in luce” (Ricolfi Scamuzzi – Sciolla, 1988, 111).
7 “Il ritmo di vita [é] sempre più frenetico sia in senso materiale che non: la frenesia la si riscontra anche a livello della modalità di
consumo, inteso in senso globale del termine: oggetti, mode, culture, soggetti a rapida obsolescenza, connessa a questa logica da fastfood, causata a sua volta dalla sovrabbondanza e quindi inflazione di stimoli e possibilità, diventano meteore in un universo regolato
essenzialmente dal principio dell’autogratificazione, del piacere” (Battellini, 1986, 88).
imperativo era l'autorealizzazione personale, ma il suo cammino si prospettava instabile, fondato
come è su scelte pragmatiche, edonistiche e relative.
Di qui L'evoluzione dall'etica protestante a stili di vita più tipicamente edonistici, che Bell ha analizzato
[Bell 1976], implica quindi una svolta verso valori espressivi, meno legati al dato utilitaristico e più centrati sui
bisogni di autorealizzazione. L'avanzata delle classi medie, la terziarizzazione della popolazione attiva,
l'aumento del potere d'acquisto e la maggiore dispersione dei redditi nelle categorie socio-professionali (che
le rende delle variabili esplicative poco rilevanti) comportano un'evoluzione sociale verso una società in cui
sono gli stili di vita a contare sempre più.
Il continuo susseguirsi di mode e di stili di consumo favoriva in loro il consolidarsi di una
cultura dell’immediatezza.
1.4. La cultura post-moderna
Le trasformazioni a livello strutturale ebbero notevoli ripercussioni a livello culturale con
andamento circolare e interattivo: la cultura risente delle trasformazioni sociali e si adegua; ma è
anche vero l’incontrario: la società sceglie il tipo di cultura che le fornisce gli strumenti migliori per
interpretare la situazione e adattarsi. Ovviamente, con effetti di feed-back continui, per cui è
difficile decidere “cosa influenzi chi”. Ciò risultò particolarmente vero in quegli anni.
Le accelerazioni che aveva assunto negli ultimi anni la modernità, assunsero un ritmo così
rapido e vorticoso da far pensare di trovarsi in un altro tipo di civiltà, affatto diversa da quella che
l’aveva preceduta. Tale mutamento fu etichettato come “postmoderno”. Con tale termine, inventato
dall’architettura ma preso a prestito anche dalla filosofia e sociologia, si volle dare un nome alle
caratteristiche che andava assumendo la modernità. Anche se il conio del termine risale agli anni
’70, la sua applicazione sociologica su larga scala avvenne proprio in quegli anni, come si può
evincere da varie pubblicazioni dell’epoca: segno che solo allora si cominciò prendere coscienza di
trovarsi non solo di fronte ad un diverso modo di produrre (postindustriale), o di organizzarsi della
società (più complesso), ma anche ad una vera svolta epocale.
In realtà è questione dibattuta tra i teorici se si tratti di un mutamento radicale, oppure
semplicemente un’accelerazione della modernità. C’è chi pensa che la modernità sia un periodo non
ancora concluso, per cui la interpreta come un progetto incompiuto (Habermas), una modernità
radicale (Giddens e Luhmann), una modernità esplosa (Touraine)8.
Altri invece intendono con il termine “postmodernità” una rottura radicale rispetto al
passato. Gli elementi assolutamente nuovi sarebbero: “l’assenza di una descrizione unitaria del
mondo, di una razionalità valida per tutti, di un concetto di giustizia condiviso, ma anche la
riscoperta dei limiti delle azioni umane, la tolleranza della diversità, il rifiuto di basarsi
esclusivamente su valori materialistici” (Ungaro, 2001, 20).
Alla forza delle ideologie o delle “grandi narrazioni” che avevano caratterizzato la
“modernità”, succederebbe un atteggiamento più rinunciatario e insicuro. E’ di quei tempi “la
scoperta che nulla è dato conoscere con certezza, dal momento che tutti i precedenti fondamenti
dell’epistemologia si sono rivelati inattendibili; il fatto che la storia è priva di ogni teleologia e che
di conseguenza non si può difendere plausibilmente alcuna versione di progresso; e infine la nascita
di un nuovo programma sociale e politico in cui assumono crescente importanza le preoccupazione
ecologiche e forse i nuovi movimenti sociali in genere” (Giddens, 1994, 53). Prendeva così corpo
una forma mentale che metteva radicalmente in dubbio la stessa possibilità di un fondamento non
illusorio per le convinzioni che fino ad allora avevano guidato la cultura moderna.
8 Con tali termini si indica che il progetto illuministico non è stato portato adeguatamente a termine, oppure che è stato talmente
estremizzato da comportare più conseguenze dannose del previsto: “libertà che diventa licenza, scienza che si diventa anti-umana,
ecc.” (Ungaro, 2001, 16).
Entrò così in dubbio la validità del ragionamento umano9, i valori e le convenzioni sociali e
soprattutto l'idea stessa di uomo e di società10.
Il tipo di pensiero a cui ci si faceva riferimento era piuttosto quello di Nietszche o di
Heidegger, di Gadamer, di Derida, di Lyotard. Sul versante scientifico il “principio di
indeterminazione” di Eisenberg diventò la pietra di confronto per tutte le teorie.
1.4.1. Postmaterialismo e postmodernità
I valori postmaterialisti vennero da vari autori e dallo stesso Inglehart, associati alla nuova
cultura. Fu lo stesso autore a trattare la cosa in maniera sistematica nel suo libro: “Modernization
and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies” (1996), uscito in
Italia col titolo “La società postmoderna” (1998). In essa affrontò il rapporto tra “posmaterialismo”
e “postmodernizzazione”, affermando che il postmaterialismo è un processo che contribuisce in
maniera cospicua alla “postmodernizzazione” e ne definisce contenuti e prospettive. Per dimostrarlo
indicò le convergenze tra le sue ricerche sul postmaterialismo e i tratti della società postmoderna.
1.4.1.1. Correlazione tra sviluppo economico e culturale
I risultati delle ricerche condotte in 43 paesi, da quelli più avanzati a quelli più arretrati, gli
avevano fornito conferme convincenti all’ipotesi materialismo/postmaterialismo. Oltre a registrare
una costante aumento del postmaterialismo tra le società avanzate dell’Occidente, in particolare tra i
giovani ed i settori più benestanti e colti della popolazione, egli andava scoprendo che i paesi più
poveri si trovavano ancora alle prese con i bisogni materiali di sopravvivenza, mentre nei paesi più
ricchi il processo di “postmaterializzazione” si andava affermando sempre più, pur con alterne
vicende.
Il lavoro più interessante fu di accostare i tassi di sviluppo al tipo di cultura. Apparve
evidente che, a seconda del livello economico raggiunto, ogni società riproduceva un pattern
culturale preciso. Le società che vivevano in un’economia di sussistenza, riproducevano anche una
cultura in cui la tradizione aveva un ruolo molto importante, e le norme erano ancorate ad
un’autorità trascendente. Mentre le società in via di modernizzazione tendevano ad attribuire molta
importanza alla scienza-teconologia, al successo, ad avere un’autorità di tipo razional-secolare, e
quindi ad interessarsi di più della politica e a darsi norme che derivavano dal consenso sociale.
Infine, le società che avevano superato il livello di sopravvivenza e vivevano
nell’abbondanza, tendevano a mutare i loro criteri in base ai nuovi bisogni che la loro condizione
evidenziava: meno importanza alla scienza-tecnologia, preferenza per i temi ecologici e per la
qualità della vita, depotenziamento dello stato e della burocrazia, più libertà, più fantasia ed
9 Il pensiero postmoderno, comprende tutte quelle filosofie e posizioni teoriche che, fin dalla fine del secolo scorso, hanno
espresso una forte critica alla ragione, intesa come "capacità progettuale di una soggettività che si dispiega verso un orizzonte di fini
di cui ritiene di possedere la chiave" (Villani, 1985, 5-6). Esso reagisce ad un'impostazione classica della razionalità, non
riconoscendole più la validità di cui aveva goduto fino ad allora, ponendo con ciò in crisi i fondamenti stessi su cui poggiava,
particolarmente quello epistemologico e quello ontologico. Nello stesso tempo rinuncia, per principio, a cercare un proprio
fondamento, in quanto ritiene che la ragione umana non sia, di per sé in grado di raggiungere la verità e di trovare un fondamento ad
una forma di pensiero che non sia ideologica.
10 "L'idea forza della modernità è il progresso, inteso come orientamento a un modello di vita e di azione, come aspirazione ai
valori ultimi, fondati sulla capacità dell'uomo di esercitare la ragione per un'opera di chiarificazione, di illuminazione (di qui il nome
di illuminismo come tratto qualificante la modernità) nei confronti del mondo e di se stesso. Ora - come hanno puntualizzato, sia pur
da angolazioni contrapposte, J. F. Lyotard e J. Habermas -, ciò che definisce l'essenza della condizione postmoderna è proprio la
negazione della capacità umana di chiarificazione: questa condizione si impernia sul disconoscimento dei valori ultimi, in grado
appunto di chiarire, cioè di fondare, giustificare, legittimare un qualsiasi ordinamento della società (fosse anche rivoluzionario o
riformatore), di motivare e orientare comportamenti, di conferire un senso unitario e quindi un'effettiva intelligibilità alla vita umana
e alla società" (Vaccarini, 1990, 128-129).
autoespressione11. Ma nello stesso tempo continuava il processo di secolarizzazione messo in atto
dalla modernizzazione: la riduzione dell’importanza della famiglia, la maggior tolleranza verso il
diverso, la parità di diritti tra uomo e donna, ecc. Cioè, il carattere postmaterialista sembrava
correlarsi più probabilmente con le tendenze postmoderne che con quelle tipiche della modernità
(secondo il modello weberiano).
Pertanto, concludeva, “il postmaterialismo costituisce una componente centrale dei valori
postmoderni” (Inglehart 1998, 126).
1.4.1.2. Correlazione tra postmaterialismo e postmodernizzazione
Sulla postmodernizzazione Inglehart aveva avanzato alcune osservazioni, distinguendo tra
aspetti che erano, a suo avviso, accettabili ed altri che non condivideva.
a) Riconosceva, con i tanti autori postmoderni, che fosse in atto una “deenfatizzazione” della:
i. efficienza economica;
ii. autorità burocratica;
iii. razionalità strumentale, scientifica.
b) Condivideva la richiesta di una società più umana, in cui ci fosse:
i. più spazio per l’autonomia personale, per la cultura;
ii. maggior tolleranza per la diversità, contro l’uniformità e la gerarchizzazione
precedente;
iii. maggior spazio per l’autoespressione e l’autoaffermazione;
iv. più spazio all’estetica;
v. recupero selettivo del passato;
vi. ricerca della qualità della vita.
a) Condivideva anche una certa critica alle “metanarrazioni” (ideologiche, politiche, religiose),
ma rifiutava posizioni estreme come quelle di Lyotard e Braudillard che tendevano ad
assolutizzare il ruolo della cultura. Per lui postmodernità voleva dire aumento dell’influenza
della cultura sulla vita sociale, ma non riduzione alla sola cultura. La realtà rimaneva con la
sua componente oggettiva, non riducibile a solo pensiero. Natura e cultura erano egualmente
presenti e solo dal loro rapporto è possibile la vita dell’uomo e della società. Come già
aveva sostenuto in un’opera precedente (1990) egli concepiva la società come
un’interazione continua tra fattori economici, politici e culturali. Ciò che caratterizzava la
società postmoderna era l’importanza che stava acquisendo la dimensione culturale rispetto
a quella economica e politica.
b) Respingeva anche il radicalismo estremo che negava ogni fondamento sul quale fondare
criteri morali universali. Egli invece condivideva con Habermas la convinzione che fosse
11 “L’importanza attribuita alla scienza e alla tecnologia era stato l’elemento centrale della modernità. Ma le popolazioni di paesi
con alte percentuali di postmaterialisti (alla fine del continuum postmoderno) tendono ad avere poca fiducia che i progressi scientifici
aiuteranno piuttosto che ledere l’umanità […]; analogamente tendono a mettere in dubbio che assegnare una maggiore importanza
alla «tecnologia» sarebbe una buona cosa. Al contrario, le stesse società hanno alti livelli di consenso nei confronti dei movimenti per
l’«ecologia». Il fatto che le società informate alla sicurezza tendano a rifiutare la scienza e la tecnologia è il punto principale di
allontanamento dalla fiducia fondamentale della modernizzazione - un’altra ragione del perché questa dimensione riflette un
cambiamento nella direzione postmoderna” (Inglehart, 1998, 124).
“Oltre all’importanza attribuita alla scienza e alla tecnologia, un’altra caratteristica chiave della modernizzazione è stata la
tendenza a burocratizzare tutti gli aspetti della vita. Ma i valori postmoderni sono connessi con il declino del consenso per un
governo grande: credere che lo Stato (piuttosto che l’individuo) possa assumersi più responsabilità per assicurare che ciascuno
«provveda a» («responsabilità dello Stato»), è legato ai valori di sopravvivenza, e non ai valori di benessere; lo stesso accade per la
«gestione pubblica/dei dipendenti» piuttosto che per la gestione privata. Il consenso per un governo grande era la componente
principale per la modernizzazione. Il fatto che non sia connesso con i valori postmoderni è un’altra indicazione che la
postmodernizzazíone rappresenta un fondamentale mutamento di direzione” (Inglehart, 1998, 126).
possibile “una base razionale per la vita collettiva […] quando le relazioni sociali sono
organizzate in modo tale che la validità di ogni norma dipende al consenso raggiunto in una
comunicazione libera dal dominio” (Inglehart, 1998, 45).
c) Come pure rifiutava il pregiudizio anti-occidentale di Derida. Egli sosteneva che, se è vero
che la società industriale e moderna è nata in occidente, essa non è solo occidentale. Gli
elementi fondamentali della “modernizzazione” sono stati l’industrializzazione,
l’urbanizzazione, la secolarizzazione, la burocratizzazione e una cultura basata sulla
burocrazia: “una cultura che richiedeva il passaggio da una status ascritto ad uno status
acquisito, da forme diffuse a forme specifiche di autorità, da obbligazioni personalistiche a
ruoli impersonali e da leggi particolaristiche a leggi universali” (Inglehart, 1998, 50). Tali
aspetti non sono esclusivi della società occidentale. Se hanno preso l’avvio in occidente fu
per merito dell’etica protestante che cambiò il sistema di valori: l’accumulazione economica
non più osteggiata o tollerata, ma incoraggiata. Tale mutamento culturale aprì la strada al
capitalismo e all’industrializzazione. Ma laddove si danno gli stessi mutamenti culturali,
come per esempio in Estremo Oriente dove prevale la cultura confuciana, avviene lo stesso
processo. E l’industrializzazione è perseguita come una meta desiderabile da tutte le nazioni,
indipendentemente dalla loro posizione geografica o culturale.
1.4.1.3. Cambio epocale
Ciononostante, egli sosteneva di trovarsi di fronte ad un cambiamento culturale senza
precedenti. Il cambiamento dalla società moderna a quella postmoderna veniva fatto risalire ai limiti
raggiunti dalla società moderna, che egli spiegava con la tesi dell’“utilità marginale decrescente dei
profitti economici”. Questa motiverebbe il fatto che, una volta raggiunti certi livelli di vita, non
interessa più accumulare ricchezza, ma invece accedere ad una maggior qualità di vita. Quindi,
anche per lui, come per Habermas, la società postmoderna si presentava come un “progetto
incompiuto”, che richiede di essere rivisto, ma non ripudiato. La postmodernizzazione doveva
rappresentare il completamento del processo di modernizzazione, non la sua negazione.
Tuttavia i benefici della modernizzazione non andavano dimenticati o sottovalutati, anche se
era ormai giunto il momento di cambiare corso, perché essa aveva imposto costi non più necessari: i
sacrifici per il successo e l’eccessiva diffusione dell’organizzazione burocratica12.
Così ecco emergere nuovi valori e stili di vita, più funzionali alla situazione determinatasi in
seguito al raggiungimento di una notevole sicurezza materiale. Ma il “postmaterialismo” implicava
il superamento del “materialismo”, ma non il suo rinnegamento: “i postmaterialisti non sono non
materialisti, e neppure antimaterialisti. Il termine «postmaterialista» indica un set di fini che sono
ritenuti importanti dopo che le persone hanno ottenuto la sicurezza materiale e proprio perché
l’hanno ottenuta. […] L’emergere del postmaterialismo non riflette un capovolgimento delle
preferenze, ma un mutamento delle priorità: i postmaterialisti non attribuiscono un valore negativo
alla sicurezza economica e fisica – la valutano positiva come tutti – ma, diversamente dai
materialisti, danno priorità all’autoespressione e alla qualità della vita” (Inglehart 1998, 57).
La società postmoderna attribuisce molta più importanza ai problemi della qualità della vita
ed esige livelli molto più alti di prestazioni sociali. Le attese sono per un lavoro sicuro, un aumento
degli standard di vita, guide illuminate, un governo generoso, un’assistenza sanitaria d’alta qualità,
l’armonia razziale, un ambiente pulito, città sane, un lavoro soddisfacente e soddisfazione
personale.
Questi elementi costituiscono per la società moderna «entitlements», “titoli” o diritti espressi
con una convinzione nuova, una maggiore sensibilità che definisce gli atteggiamenti degli
12 La loro obsolescenza era decretata da due motivi: “primo, hanno raggiunto i limiti della loro efficienza funzionale; secondo,
stanno raggiungendo i limiti della loro accettabilità di massa” (Inglehart, 1998, 48)
occidentali nei confronti delle condizioni sociali, delle istituzioni nazionali e anche del mondo.
Sempre più si crede che certe cose sono (o dovrebbero essere) garantite. Non è che la gente non si
preoccupi, ma si preoccupa di cose diverse.
Questi atteggiamenti sarebbero destinati, sempre a giudizio dell’autore, a diffondersi
progressivamente e a diventare patrimonio comune di quote sempre maggiori di popolazione, non
solo nelle nazioni occidentali, ma in tutti quegli stati che intendono intraprendere la strada verso la
modernizzazione. Perciò il pattern culturale postmoderno e/o postmaterialista starebbe per
affermarsi come un modello culturale universale verso cui tutto il mondo sarebbe incamminato.
Ovviamente se perduravano le condizioni economiche e politiche.
1.4.2. L’Italia fra tradizione e postmodernità
Il problema se ci si trovasse di fronte ad un cambio epocale o solo ad un mutamento di
valori venne affrontato anche dalla versione italiana della ricerca europea EVSSG (Gubert, 1992).
Si trattava di capire dove stesse andando la società, se verso un riequilibrio dei valori, come
sosteneva il coordinatore italiano della ricerca, dopo le accelerazione dei decenni precedenti, oppure
verso una nuovo civiltà, dai contorni ancora poco definiti. L’analisi dei valori divenne allora la
cartina di tornasole per verificare l’ipotesi più probabile.
1.4.2.1. I valori degli italiani
Per quanto riguarda i valori della famiglia, della sessualità e della coppia negli anni ’90, si
rilevarono comportamenti e valori contraddittori: si era assistito ad un calo di accordo tra le coppie,
era aumentata la disponibilità alla libertà nei comportamenti sessuali; ma nel contempo era aumento
il consenso al matrimonio come istituzione (auto-fondata sulla relazione), l’amore incondizionato
dei figli per i genitori, la soddisfazione per la vita di famiglia.
Per i valori del lavoro: era aumento il peso, già elevato, delle motivazioni strumentali, come
il guadagno, ma anche le motivazioni di tipo espressivo-comunicativo, specie tra i giovani.
Era ulteriormente calata la partecipazione ad associazioni, specie in quelle religiose,
sindacali, politiche, di volontariato sociale, ma per alcuni tipi (associazioni culturali, associazioni
che si occupano del “Terzo Mondo”) essa era cresciuta.
Si voleva che la società assegnasse meno peso al denaro, al lavoro, all’acquisizione di beni
materiali a favore, invece, di una maggiore attenzione alla crescita della persona, alla vita di
famiglia, alla qualità all’ambiente, ma a livello concreto si dava più importanza a mete di natura
economica, anche se cresceva pure la preoccupazione per garantire i diritti di libertà di parola e di
partecipazione sociale e politica.
Era calata la fiducia nello Stato, nelle sue istituzioni, l’impegno nei partiti e nei sindacati,
ma era cresciuto l’interesse e la partecipazione politica. C’era stata una perdita delle posizioni
politicamente conservatrici, ma era aumentato di molto il favore per l’autonomia dell’imprenditore
e la fiducia nel grande padronato.
Era cresciuta la convinzione che dovessero esserci dei criteri validi in ogni circostanza per
decidere ciò che è bene e ciò che è male, ma nel contempo era aumentano il permissivismo e
l’incertezza di giudizio etico su azioni un tempo ritenute sicuramente immorali.
Era aumentata la riflessione sul senso della vita e della morte, l’importanza del riferimento
religioso per sé e nell’educazione dei bambini, la pratica religiosa, ma era diminuita l’affiliazione
alla chiesa e la credenza nelle “verità”, specie di tipo escatologico, che tradizionalmente avevano
fatto da supporto all’esperienza religiosa e che costituivano parte importante del patrimonio di fede
cristiano.
Era aumentato il senso di soddisfazione per la vita che si conduceva, ci si sentiva meno
annoiati e meno soli, meno tesi ed insoddisfatti, era aumentato il senso di fiducia nella gente, ma si
era rilevato più desiderio di star lontani da categorie o gruppi che potevano portare disturbo, più
desiderio di cambiare la società.
1.4.2.2. Postmaterialismo o riequilibrio? Modernità e tradizione nel caso italiano
Di fronte a questi dati Gubert propose alcune riflessioni conclusive. Ponendosi il problema se questi
fossero indicatori di progresso o di ritorno al passato, di postmaterialismo o di materialismo, di
postmoderno o di pre-moderno, egli suggerì un’altra ipotesi, quella del riequilibrio. Con tale
termine intedeva dire che, di fronte all’incertezza se cultura post-materialistica stesse crescendo o si
se stessero recuperando i valori tradizionali, si stava delineando un duplice andamento: “aspetti
trascurati della tradizione riemergerebbero, ristabilendo così un equilibrio più accettabile tra
soddisfacimento di bisogni di tipo prevalentemente materiale ed altri di tipo prevalentemente
spirituale, tra una socialità da ‘soci in affari’, come la chiamava F. Toennies, ed una socialità più
comunitaria ed attenta alla solidarietà (a cominciare dalla famiglia per arrivare allo Stato ed alle
organizzazioni internazionali), tra lo sviluppo della razionalità strumentale e l’attenzione, anche
razionale, ai valori, alla dimensione del ‘senso’ della vita e dell’universo” (Gubert, 1992, 571). Egli
concludeva, sottolineando come “per alcuni aspetti l'ipotesi del riequilibrio può senz'altro sostituire
quella evolutiva, ma a patto che essa non interpreti il riequilibrio come riproposizione tali e quali di
elementi della tradizione. E proprio le apparenti contraddizioni mettono in evidenza le diversità
rispetto al passato” (Gubert, 1992, 572).
Tra le principali contraddizioni rilevò quella della famiglia, dove il recupero era fondato
solo (per la gran parte delle persone) “sulla gratificazione derivante dalle relazioni tra i suoi
membri” (Gubert, 1992, 572); del lavoro, con la compresenza di motivazioni strumentali e autorealizzative; del modello di sviluppo, con richieste di attenzione alle dimensioni umanistica ed
ambientale, ma con modi di intervento diversi dall’azione politica classica: l’individuo “vuole
mantenere senza deleghe il controllo della sua quota di potere politico” (Gubert, 1992, 573). Ma era
soprattutto nel recupero dei criteri per stabilire ciò che è bene e ciò che è male che appariva un
cambiamento di rotta in relazione al passato: l’atteggiamento morale sembrava meno intransigente
per i valori materiali e le convenzioni sociali, mentre era assai più esigente quando entravano in
gioco le persone, il rispetto per esse (Gubert, 1992, 573).
A questo punto egli avanzò ipotesi che, per quanto attiene l’etica, la “transizione postmoderna rappresenti solo un ulteriore sviluppo della modernità” (Gubert, 1992, 574). E che i
cambiamenti in atto segnassero, per molti aspetti, un recupero di dimensioni che agli inizi degli anni
Ottanta sembravano meno rilevanti (Dio e famiglia). Arrivò così a suggerire di utilizzare il termine
“postmaterialista” piuttosto che “postmoderno” per interpretare il momento storico-culturale13, in
quanto la tendenza prevalente sembrava indicare un aumento di individualismo e di edonismo,
“secondo una dinamica dei bisogni ben illustrata da Maslow” (Gubert, 1992, 575).
13 “In un certo senso […] il termine post-moderno sembrerebbe meno adatto del termine post-materialista: questo sottolinea il
passaggio dall’accentuazione posta su oggetti e valori di tipo materiale ad altri, ma potrebbe lasciare impregiudicati sia il grado di
individualismo, sia quello di edonismo, sia quello di secolarizzazione, in base ai quali si misurerebbe, secondo Thomas e Znaniecki,
la modernità in termini socio-culturali. Ed in effetti risulta aumentare l’individualismo, ma neppure l’edonismo sembra conoscere
battute d’arresto. […] E’ quindi rischioso ritenere suffragata dai dati l’ipotesi del cambio epocale o dell’esaurimento della spinta
culturale della modernità; si è piuttosto di fronte ad un suo sviluppo secondo una dinamica dei bisogni ben illustrata da Maslow, ma
nei termini essenziali già nota a psicologi, sociologi ed economisti: la disponibilità di un “bene” in dosi crescenti ne diminuisce
l’utilità marginale, diminuisce la desiderabilità di quote aggiuntive e quindi le preferenze si orientano verso “beni” relativamente
trascurati. Se a ciò si aggiunge l’altra dinamica, del resto assai simile, per cui allo stesso bisogno si tende a dare risposte con
“varianti” sempre più ricche e pregiate, si comprende almeno in parte la crescente attenzione verso la “qualità” relazionale della vita,
verso la “qualità” del lavoro, verso la “qualità” dell’ambiente; si comprende come le mete per le quali valga la pena “combattere”,
mettendo a rischio la propria integrità ed il proprio benessere, siano sempre meno (o siano inesistenti) e come tali scelte siano
riservate esclusivamente al proprio personale convincimento” (Gubert, 1992, 575-576).
L’Italia, poi, nel contesto europeo, sembrava caratterizzarsi per una maggior tendenza postmaterialista: maggior peso alla famiglia, alla religione, e valori socio-politici più aperti alla
dimensione umanistica. Ma anche per un minor permissivismo etico, per una più forte appartenenza
alla Chiesa ed una maggiore fiducia in essa, per una più elevata condivisione di valori di giustizia
sociale. Questi, egli notava, erano elementi propri della tradizione, che si mescolavano con elementi
nuovi. Per questo avanzava l’ipotesi “che la caratterizzazione dell’Italia rispetto alla media europea
derivi dal congiungersi di due fenomeni, il permanere più forte di valori tradizionali e l’emergere di
valori secondo una prospettiva post-materialista” (Gubert, 1992, 576).
1.4.3. La scuola
La scuola non rappresentò più, negli anni ottanta, un banco di prova e di scontro sociale,
come nel decennio precedente. Nonostante alcune manifestazioni di protesta, rigorosamente “apolitiche”, nel complesso la maggior parte degli studenti (4/5) sembrò soddisfatta dell'istruzione
ricevuta. La percentuale variava a seconda della percorso scolastico e lavorativo (Cavalli - de Lillo,
1988, 25).
Si profilava ormai sempre più la convinzione che la scuola, anche se non obbligatoria oltre i
14 anni, lo fosse nella pratica. Chi la evitava sapeva di precludersi molte opportunità d’inserimento
sociale e professionale. La condizione di studente divenne un passaggio obbligato dell’essere
giovane, un referente ordinario dell’identità giovanile14.
Ciò non voleva dire però che la scuola fosse amata: la pretesa di trasmettere il sapere a senso
unico, lo sforzo che richiedeva, l'obsolescenza dei metodi didattici, l'incapacità di preparare
effettivamente ad affrontare la vita, la professione la rendevano poco attraente. Però il giovane anni
‘80, molto realisticamente, aveva capito che, se la scuola non pagava più, non essere istruiti era
oggettivamente un fattore di penalizzazione (Franchi, 1988, 11). Per cui era indispensabile rimanere
nella condizione di studente, per approfittare delle opportunità offerte dal sistema scolastico,
insieme a quelle offerte dall’extra-scolastico. In effetti in quegli anni ci si trovò di fronte ad un
duplice andamento della domanda formativa: da un lato la crescita del numero di coloro che
passavano dalla scuola media inferiore alla superiore, dall’altro il calo di chi proseguiva gli studi
con l’università15. Apparivano privilegiati gli studi “brevi” finalizzati all’inserimento immediato nel
mercato del lavoro (Bobba – Nicoli, 1988, 51).
Va però riconosciuto che la scuola si trovava di fronte a problemi enormi, che superavano la
sua portata: un mercato del lavoro sostanzialmente bloccato, la mancanza di strumenti adeguati per
un effettivo coordinamento tra esperienze scolastiche e sistema occupazionale, compiti impropri di
parcheggio della forza-lavoro. Tutto ciò rendeva difficile il rapporto scuola - società.
Ecco allora il duplice sentimento di amore-odio che essa suscitava: si avrebbe voluto farne a
meno, ma non se poteva. Scomparsa la conflittualità delle generazioni precedenti, c’era stato un
ritorno all'impegno scolastico, pur in senso strumentale. “Visto che comunque a scuola bisogna
andarci è meglio starci bene” – poteva essere il ragionamento di molti. Infatti la scuola era
apprezzata per le possibilità di stabilire buoni rapporti con i compagni; anche con i professori si
cercava, per quanto possibile, di stabilire relazioni accettabili (Cavalli - de Lillo, 1988, 26).
Accanto a questo modello di adattamento positivo, si registravano quote minori di giovani
che vivevano un rapporto conflittuale o fallimentare con la scuola. Erano i cosiddetti "drop-out",
che avevano interrotto il loro rapporto con la scuola. Il fenomeno delle uscite dal sistema scolastico
“Essere giovani e essere studenti sta diventando (e certamente lo diventerà) un sinonimo” (Franchi 1988, 12).
Da uno studio del Censis sui flussi di passaggio nei cicli e tra i cicli e di abbandono relativamente all'anno 1987-88, si ricava
che “su 100 giovani che partono in prima media, 6 si perdono prima di arrivare alla licenza media, 18 escono con la licenza e 76 si
iscrivono alla scuola secondaria. Qui avviene una nuova massiccia selezione, e solo 45 arrivano al diploma. 16 giovani si fermano a
questo punto, mentre 29 si iscrivono all'università. Tuttavia, di questi, 19 abbandonano e solamente 10 arrivano alla sospirata meta
finale” (Malizia, 1991, ).
14
15
si intensificò tra i 15 ed i 18 anni, “in parte da attribuirsi al ritardato completamento del ciclo
dell'obbligo o alla frequenza di cicli brevi post-obbligo, in parte a veri e propri abbandoni delle
scuole medie superiori” (Cavalli - de Lillo, 1988, 20). A questi andavano aggiunti coloro che
avevano subito gli effetti negativi della selezione scolastica. A fronte di un 54% che non aveva
subito interruzioni nel ciclo di studi, un 30% aveva avuto percorsi “irregolari” ed un 16% “molto
irregolari”. Questi dati risultavano correlati con condizioni sociali e culturali svantaggiate.
1.5. La scuola
La scuola italiana negli anni novanta registrò da una parte l’accentuazione di fenomeni già
emersi negli anni precedenti; dall’altra la comparsa di fenomeni nuovi, alcuni di segno positivo altri
negativo.
Sul versante positivo si registrò in quegli anni:
a) Una sostenuta domanda di formazione e qualificazione: dagli anni Ottanta, infatti si notò
“un costante incremento dei tassi di scolarizzazione a livello di scuola secondaria
superiore e di immatricolazione all'università” (Besozzi, 1998, 21). Crebbe il tasso di
passaggio dalla SSS all'università e aumentarono gli iscritti in valore assoluto. Ad
incrementare in qualche misura la domanda di qualificazione contribuì anche la
formazione professionale regionale con una prevalenza del settore di attività
commerciale e la formazione in azienda. Questo indicava una diffusa e sostenuta
domanda di istruzione che, tuttavia, si perdeva lungo il percorso (Besozzi, 1998, 21).
b) La domanda di formazione continua: i Rapporti CENSIS e ISFOL registrarono negli
ultimi anni del decennio la crescita di un fenomeno nuovo, in decisa controtendenza
rispetto alla situazione precedente: lo “sviluppo della domanda di formazione continua e
di consumi culturali, indice dello sviluppo di un orientamento verso la formazione per
tutta la vita” (Besozzi, 1996, 22). Questa domanda trovò accoglienza soprattutto negli
accordi sul lavoro e nelle circolari del ministero del Lavoro, che gettarono le basi per lo
sviluppo di strategie in ordine alla rimotivazione, riqualificazione, riconversione degli
adulti e all'attivazione delle imprese nella forma di reti interaziendali per la
predisposizione di iniziative formative (ISFOL, 1997, 445-446).
c) L’asse legislativo e l’impegno di soggetti istituzionali e non. Nella seconda metà degli
anni ‘90 furono avviati o conclusi iter legislativi fondamentali per il riordino
complessivo del sistema della formazione e per il governo delle varie modalità di
transizione tra formazione e mondo del lavoro. La più importante fu senza dubbio la
“legge quadro sul riordino dei cicli dell'istruzione” presentata dal ministro Berlinguer
nel 1997. In essa si sottolineava la centralità del soggetto in formazione delle differenze
interindividuali, valorizzando la personalizzazione dei percorsi, ma in stretto legame
con la crescita della società. All'art. 2 (sistema di istruzione e formazione), si faceva
riferimento ad un sistema che andasse oltre quello scolastico, includendo anche la
formazione professionale e la formazione continua. Il diritto alla formazione si
realizzava “attraverso la progressiva espansione dell'offerta di formazione professionale e dell'integrazione tra questa e l'istruzione”. Ne conseguiva la necessità di
flessibilità dei percorsi, di un rapporto stretto tra le diverse agenzie formative e non e
l'importanza della formazione continua lungo tutto l’arco della vita, all'interno della
quale diventavano importanti i crediti formativi acquisiti nel corso di esperienze
scolastiche o nell'ambito della formazione professionale, crediti che consentivano di
riprendere un percorso formativo interrotto facendoli valere nell'ambito nel quale si
intendeva proseguire. La legge sul riordino dei cicli dell'istruzione faceva quindi
riferimento ad un sistema formativo allargato (policentrico) ma anche integrato e
regolato. Ad un asse legislativo che si rinnovava corrispondeva una mobilitazione di
vari soggetti istituzionali e anche non istituzionali, per concorrere a predisporre il
cosiddetto "patto formativo" che richiedeva il decentramento istituzionale e
l'autonomia decisionale ed amministrativa (Besozzi, 1998, 20-21).
d) Il sostegno economico e culturale dell'Europa. L'Europa rappresentò una risorsa
fondamentale per la messa a punto e la realizzazione di una riforma globale del sistema
della formazione nel nostro paese. Una risorsa prima di tutto culturale, quale interfaccia
e ambito globale delle tendenze in atto nei diversi paesi europei e nel contesto
internazionale. Ma la Comunità Europea rappresentò anche una risorsa dal punto di
vista economico, attraverso l'erogazione di contributi a sostegno delle diverse iniziative
e dei progetti che hanno rilevanza per la formazione e istruzione dei giovani,
soprattutto a livello regionale (Besozzi, 1998, 21).
Gli elementi problematici erano, invece:
e) Il ritardo rispetto all'Europa. Malgrado il progressivo aumento della domanda di
istruzione e l'innalzamento del numero di licenziati, diplomati e laureati, il nostro paese
presentava nel corso degli anni ‘90 gravi ritardi rispetto all’Europa e ai paesi
industrializzati per quanto riguarda il livello complessivo di istruzione raggiunto dalla
popolazione adulta. Anche sugli altri livelli di scolarità si evidenziava una distanza
considerevole. Il confronto con i tassi di formazione e scolarizzazione con le altre
nazioni europeee evidenziavano un "deficit" formativo non indifferente, anche se in
progressiva riduzione (Besozzi, 1998, 22-23).
f) Il basso grado di efficienza ed efficacia del sistema scolastico. Ancora negli anni
Novanta, i dati su ripetenze e abbandoni nella scuola media inferiore e superiore e i
tassi di abbandono universitario mostravano che l’efficacia e l’efficienza del sistema
scolastico italiano non erano obiettivi realizzati. Il quadro della dispersione scolastica si
presentava in termini molto problematici, a partire dalla scuola media inferiore dove,
ancora negli anni Novanta, su 1.000 ragazzi che iniziavano la prima media, 47 lasciano
senza conseguire il titolo di licenza media inferiore (ISFOL, 1997, 266). Ma anche la
dispersione nella scuola secondaria superiore e all'università evidenziava le
contraddizioni presenti nel sistema: infatti, a fronte di tassi elevati di passaggio dalla
scuola media alla scuola secondaria superiore e dalla secondaria superiore all'università
si verificava un tasso di caduta elevato che portava a diplomarsi solo circa il 70% degli
iscritti 5 anni prima e a laurearsi solo uno studente su tre. Questo faceva sì che ancora
negli anni Novanta, l’Italia nel confronto europeo figurasse fra i paesi con il più basso
tasso di diplomati. L’anomalia più evidente era evidenziata dalla mancata
corrispondenza tra la propensione a prolungare e quindi permanere nel sistema
d'istruzione e il corrispondente conseguimento del titolo finale. Un altro fenomeno
importante era mostrato dai percorsi discontinui, irregolari e dai rientri in formazione
(Besozzi, 1998, 23-24).
g) Le disparità territoriali, di genere, di classe sociale. In Italia permanevano all'interno
del sistema di istruzione forti disparità in relazione alla classe sociale d'origine, al
genere, alla zona geografica. Si trattava di disparità che mostravano una diversa
fruizione della formazione e quindi l’esistenza di profonde disuguaglianze che il
sistema non era ancora riuscito a fronteggiare. Una specie di "segregazione formativa"
in ordine alla forza di attrazione che il sistema esercitava verso canali o indirizzi più
deboli o di minor prestigio o consistenza: era il caso per esempio delle femmine che
frequentavano quasi solo certi indirizzi di scuola secondaria superiore o della fruizione
da parte delle classi sociali basse soprattutto di canali formativi professionalizzanti. La
frequenza ai licei e di certe facoltà più prestigiose era ancora appannaggio delle classi
sociali medie e alte. Evidente anche la disparità di fruizione e di esiti al Sud e nelle
Isole (Besozzi, 1998, 24).
La domanda di personale qualificato. In Italia si continuò a registrare una forte disparità di
situazioni, per cui per esempio era solo la grande industria a richiedere personale altamente istruito.
Le piccole imprese tendevano ancora ad assumere personale con basse qualifiche e quindi ad
esprimere una domanda di forza-lavoro istruita molto contenuta. Le medie e grandi imprese
richiedevano invece personale istruito, ma la loro capacità di assorbimento di giovani con elevata
scolarità era limitata sia dagli oneri fiscali sia dalla regolazione istituzionale del mercato del lavoro
(Schizzerotto, 1997, 357-8) L'analisi del rapporto tra domanda e offerta di lavoro mostrava pertanto
come il mercato del lavoro in Italia investisse in maniera insufficiente nelle risorse umane.
1.5.1. L’importanza strategica del tempo libero
Lo sviluppo del tempo libero16, ottenuto sia con la riduzione o modifica dei tempi di lavoro,
sia con la scolarizzazione prolungata, stava diventando una realtà molto importante negli anni ‘80,
tale da far credere imminente il compimento del vaticinio marcusiano di una società senza lavoro. Il
tempo libero divenne un tempo strategico, su cui si concentrarono conflitti decisivi per il controllo
del potere17, soprattutto attraverso i “media” e l’industria del tempo libero.
16 Non vogliamo in questa sede entrare nel merito della definizione di tempo libero, che è ancora oggetto di dibattito tra gli
studiosi, e che le stesse ricerche IARD non chiariscono. Ricordiamo solo che esso può essere inteso come il tempo non occupato dai
tempi sociali, oppure come tempo lasciato libero dal lavoro, o da altri impegni. Ma lo si può anche intendere come il contenitore
delle attività, o delle attese, o degli atteggiamenti che si assumono in tale tempo.
17 Secondo Lalive d'Epinay sarebbero stati trasferiti nel tempo libero i rapporti di forza che prima erano agiti nel mondo del
lavoro. I conflitti che caratterizzano la società sarebbero giocati “nella pratica delle attività di tempo libero, concepite come pratiche
di consumo culturale” (Lalive d'Epinay, 1980, 87).