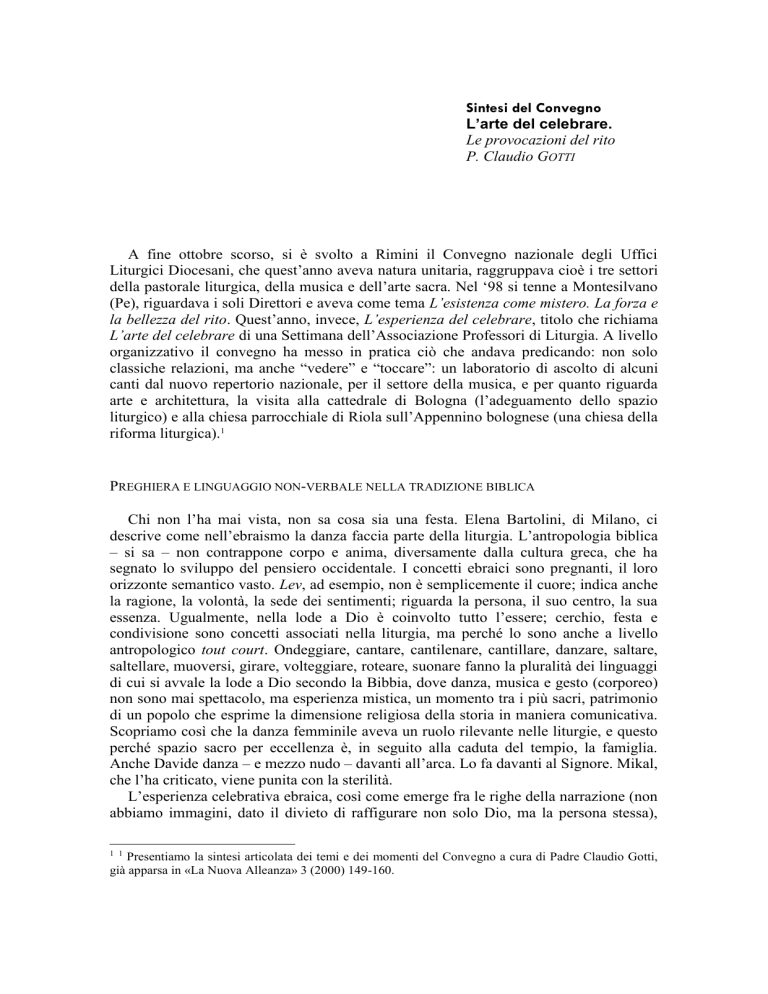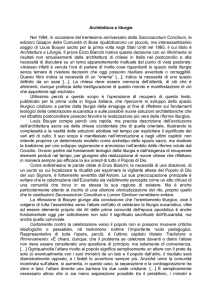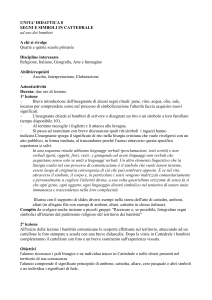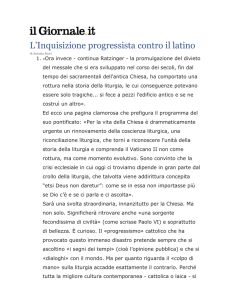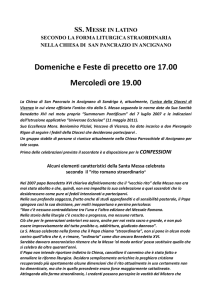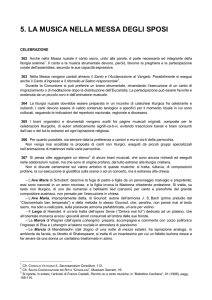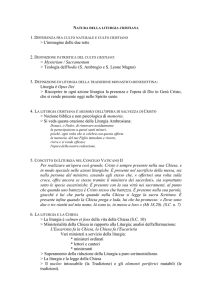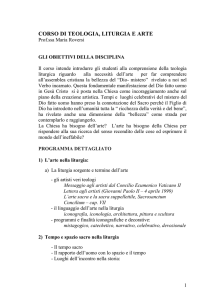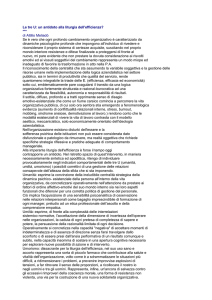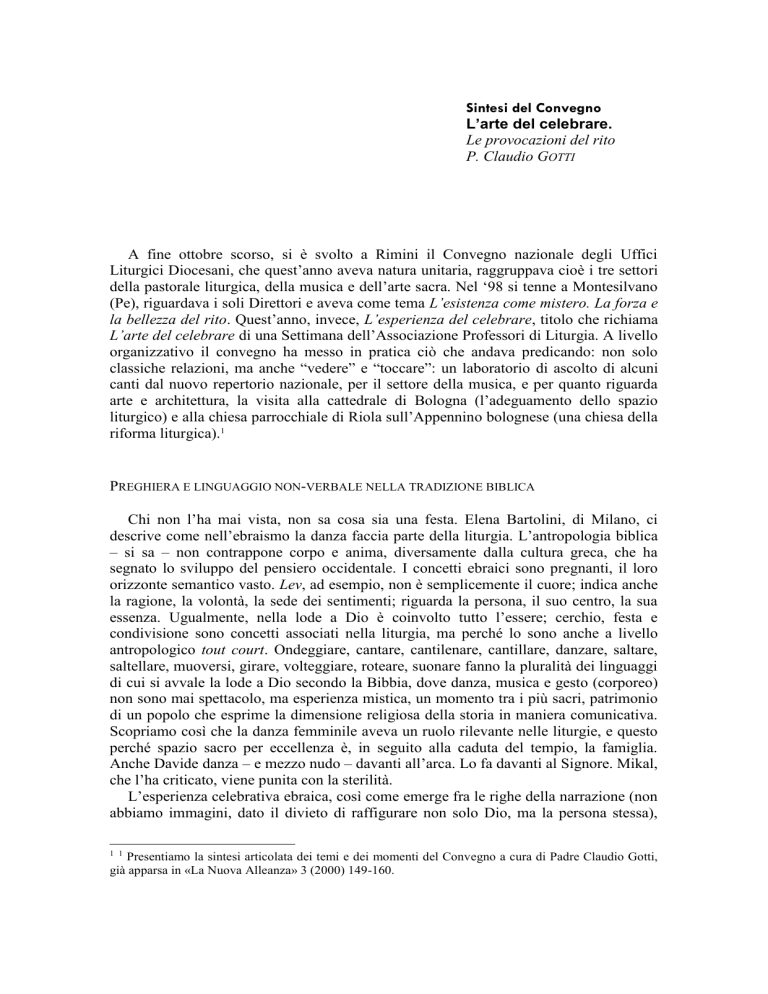
Sintesi del Convegno
L’arte del celebrare.
Le provocazioni del rito
P. Claudio GOTTI
A fine ottobre scorso, si è svolto a Rimini il Convegno nazionale degli Uffici
Liturgici Diocesani, che quest’anno aveva natura unitaria, raggruppava cioè i tre settori
della pastorale liturgica, della musica e dell’arte sacra. Nel ‘98 si tenne a Montesilvano
(Pe), riguardava i soli Direttori e aveva come tema L’esistenza come mistero. La forza e
la bellezza del rito. Quest’anno, invece, L’esperienza del celebrare, titolo che richiama
L’arte del celebrare di una Settimana dell’Associazione Professori di Liturgia. A livello
organizzativo il convegno ha messo in pratica ciò che andava predicando: non solo
classiche relazioni, ma anche “vedere” e “toccare”: un laboratorio di ascolto di alcuni
canti dal nuovo repertorio nazionale, per il settore della musica, e per quanto riguarda
arte e architettura, la visita alla cattedrale di Bologna (l’adeguamento dello spazio
liturgico) e alla chiesa parrocchiale di Riola sull’Appennino bolognese (una chiesa della
riforma liturgica).1
PREGHIERA E LINGUAGGIO NON-VERBALE NELLA TRADIZIONE BIBLICA
Chi non l’ha mai vista, non sa cosa sia una festa. Elena Bartolini, di Milano, ci
descrive come nell’ebraismo la danza faccia parte della liturgia. L’antropologia biblica
– si sa – non contrappone corpo e anima, diversamente dalla cultura greca, che ha
segnato lo sviluppo del pensiero occidentale. I concetti ebraici sono pregnanti, il loro
orizzonte semantico vasto. Lev, ad esempio, non è semplicemente il cuore; indica anche
la ragione, la volontà, la sede dei sentimenti; riguarda la persona, il suo centro, la sua
essenza. Ugualmente, nella lode a Dio è coinvolto tutto l’essere; cerchio, festa e
condivisione sono concetti associati nella liturgia, ma perché lo sono anche a livello
antropologico tout court. Ondeggiare, cantare, cantilenare, cantillare, danzare, saltare,
saltellare, muoversi, girare, volteggiare, roteare, suonare fanno la pluralità dei linguaggi
di cui si avvale la lode a Dio secondo la Bibbia, dove danza, musica e gesto (corporeo)
non sono mai spettacolo, ma esperienza mistica, un momento tra i più sacri, patrimonio
di un popolo che esprime la dimensione religiosa della storia in maniera comunicativa.
Scopriamo così che la danza femminile aveva un ruolo rilevante nelle liturgie, e questo
perché spazio sacro per eccellenza è, in seguito alla caduta del tempio, la famiglia.
Anche Davide danza – e mezzo nudo – davanti all’arca. Lo fa davanti al Signore. Mikal,
che l’ha criticato, viene punita con la sterilità.
L’esperienza celebrativa ebraica, così come emerge fra le righe della narrazione (non
abbiamo immagini, dato il divieto di raffigurare non solo Dio, ma la persona stessa),
1 1
Presentiamo la sintesi articolata dei temi e dei momenti del Convegno a cura di Padre Claudio Gotti,
già apparsa in «La Nuova Alleanza» 3 (2000) 149-160.
costituisce una provocazione positiva per il cristianesimo: per l’antropologia unitaria
che vi è sottesa, per la sua forte componente relazionale e per il vivo senso di
appartenenza a un popolo. La celebrazione non è mai un fatto individuale, ma
comunicativo: ci si scopre in relazione a Dio, ma attraverso la relazione uomo-uomo.
Da segnalare è l’esperienza di scambio vitale fra ebrei e cristiani ai seminari organizzati
annualmente sull’Appennino di Reggio Emilia, inerenti la danza e la preghiera ebraica.
LA CELEBRAZIONE TRA CORPO E TRASCENDENZA
La relazione di Giorgio Bonaccorso ha “toccato” il corpo.
Il primato della mente nel pensiero occidentale, o dell’interiorità rispetto al corpo,
porta a una chiusura immanentistica, nonostante continui a mantenere tensione alla
trascendenza. Ne risulta una spiritualità debole. Plotino si è anche vergognato di avere
un corpo, mentre secondo Agostino i corpi non sono quello che noi siamo. Eppure il
pensiero cristiano ne fa largo uso: la chiesa come un corpo (san Paolo), l’onore al corpo
dei defunti, le reliquie dei santi. Perché il corpo è ora denigrato, ora onorato?
Da una parte esso è un’immagine di cui si serve la mente, dall’altra una realtà
tangibile, soggetto attivo nella convivenza umana, con un ruolo decisivo nelle relazioni
intersoggettive e nelle istituzioni. Senza di esso non vi sono emozioni, comunicazione,
comportamento. Il corpo, semmai, è un agente che condiziona il pensiero.
Quando tutto gravita attorno all’anima o alla mente, l’attitudine alla trascendenza
viene gravemente offuscata e si produce una nuova immanenza. Un marcato
razionalismo riduce tutto al mentale, e si sconta così il peccato di aver abbandonato la
materia e il corpo. Si arriva, attraverso un’identificazione ambigua, a un supremo atto di
ateismo: l’altro viene assorbito dall’io, da un pensiero concentrato in se stesso, sicuro di
sé, luogo in cui sostare prima di ogni contatto con l’esterno. L’insistenza su anima e
mente può sorprendentemente fuorviare dall’attitudine all’immanenza, conducendo a un
luogo isolato, o meglio a un isolamento privo di luogo. Le conseguenze sono gravi.
L’attitudine alla trascendenza si fa strada nell’esteriorità, mentre l’interiorità dell’anima
è troppo compromessa con l’autonomia della mente, dell’“io penso”, che all’occasione
si trasforma in “io voglio”.
LE PROVOCAZIONI DEL CORPO COME MATERIA, COME AZIONE E COME LINGUAGGIO
Il corpo premunisce dall’assorbimento nell’immanenza e abilita alla trascendenza. Il
primato della mente diventa primato della necessità logico-matematica, che fa del
mondo un meccanismo immutabile con leggi rigide, impoverendo le possibilità
dell’esistente. In quanto materia, il corpo riapre le porte a queste possibilità. Secondo
Bloch, è la materia il principio e l’ambito della possibilità, il gioco tra qualcosa e ciò
che potrebbe essere. È il divenire che predispone alla trascendenza, all’imprevedibile,
all’altro da ciò che si pensa di essere e avere. Subendo le dinamiche della materia, il
corpo opera il decentramento dell’io. La morte ne è l’evento più evidente. Ma qualsiasi
evento decentra da sé.
Il corpo è soggetto percepiente e agente, anzi percepisce agendo. Secondo MerleauPonty, è un attore che si muove verso la realtà, sostanzialmente secondo sue operazioni:
la mimesi e l’eros, azioni originarie mediante le quali mostriamo le nostre attitudini alla
trascendenza. Il corpo ci ricorda che non solo sappiamo, conosciamo o pensiamo, ma
facciamo, possiamo, vogliamo, desideriamo. Tramite il corpo incontriamo la vita, e le
sue azioni non sono semplicemente portatrici di senso, ma corrispondono all’avvento
dell’altro, anch’egli in azione e in movimento, come ci ha ricordato Lévinas parlando
del volto. Lo stesso linguaggio è corpo (e, per questo, rivelazione), ossia pensiero
consegnato alla dimensione somatica, reso da questa possibile, esprimibile,
tramandabile. Se impariamo a pensare è perché, grazie al linguaggio, gli altri ci
comunicano le trame del pensiero. Il corpo è un prodotto sociale: sta alla base delle
condizioni sociali e culturali. Ma anche la società è un prodotto del corpo:
comprendiamo in quanto corpi che comunicano. Se con l’azione si ha l’avvento
dell’altro, con il linguaggio si ha la sua rivelazione. Condizione inalienabile, il corpo
rimanda alla natura esodale dell’esistenza, luogo di rivelazione dell’esistenza intesa
come esodo, quindi trascendenza.
LE PROVOCAZIONI DEL RITO
Se la materia è un atto di trascendimento di Dio verso l’uomo, la fede è l’atto di
trascendimento dell’uomo verso Dio. Tutto, dunque, avviene nel corpo fisico, reale, non
metaforico, immaginato, pensato. Ma il corpo va orientato. È il rito che organizza
materia, azione e linguaggio, orientandoli al religioso. Tra rito e corpo è stretto il
legame nella liturgia cristiana, dove la trascendenza non è pensata, ma vissuta (benché
noiosamente).
Il rito e la materia: la vita ricevuta (prospettiva ecologica). Lì la fede non
corrisponde a contenuti dottrinali, ma è esperienza in seno alla quale quei contenuti
hanno senso. La liturgia stessa e i diversi elementi rituali ricorrono all’esteriorità della
materia. La vita è una possibilità ambientale. La liturgia mantiene fede a ciò ricorrendo
all’acqua, alla vite, al fuoco, al sole, alle stagioni, al ciclo annuale. L’ambiente rituale
permette appartenenza alla fede, ma anche presenza all’uomo: gli elementi naturali sono
tutti in funzione del bene dell’uomo. Presenza si oppone a indifferenza. Il cosmo non è
indifferente all’esistenza umana: la rende possibile. Ci sono infiniti posti in cui non
potremmo vivere.
Il rito e l’azione: la vita trasmessa (prospettiva etologica). Non esiste la vita, ma
qualcuno che si sviluppa fino ad un certo punto. Quella che chiamiamo vita è
movimento con cui passiamo da una condizione all’altra; è fatta di momenti che il corpo
in parte subisce, in parte realizza. Ma non gli basta. Ricorre così ad altre azioni: le
azioni simboliche. Il rito, potenza che rende possibile la vita, è efficace, in quanto non è
solo un simbolo, come il mito, ma è azione, attuazione, e non senza il corpo. Non solo.
È azione di un’assemblea celebrante. In ciò che ha di inedito e di strano, il rito è aperto
alla più radicale delle differenze: Dio, il trascendente, il totalmente altro. Ed è efficace
perché stabilisce una comunità, il corpo mistico, che è sia il corpo di Cristo che il corpo
ecclesiale. L’Eucaristia è entrambi.
Il rito e il linguaggio: la vita espressa (prospettiva semiologia). Il linguaggio rituale
esprime l’accoglienza della fede secondo tutti i linguaggi umani, non solo quello
verbale, quindi il corpo in tutte le sue qualità espressive. La fede stessa riguarda e
coinvolge tutto l’uomo, il quale è colto di sorpresa: non può difendersi rifugiandosi
nella sola parola. È tutto preso o tutto escluso dalla fede. È come la differenza tra il
descrivere una foresta e l’esservi dentro: la senti, la vedi, la tocchi, vi sei immerso. Nel
rito è in gioco la vita con Dio, non una disquisizione su di lui.
Ridotta a uno solo o pochi linguaggi, la liturgia sarebbe pura rappresentazione; nel
coinvolgimento globale di più linguaggi e di tutto il corpo, anche se per poco (non
sediamo a un grasso banchetto, basta un’ostia; non veniamo immersi per intero nella
vasca battesimale, basta poca acqua), ci pone, invece, nell’impossibilità di sottrarci a
quanto ci trascende. Così ci è possibile esprimere la fede. È l’aspetto pragmatico del
rito, dove tutto è scambio relazionale e ogni linguaggio è un significante che consente il
contatto, prima di contenere o veicolare concetti, norme, dottrine, significati.
Ugualmente, preghiere e letture non sono mezzi, ma anzitutto suoni, forme espressive;
non pretendono di contenere, ma invocano, realizzano, indicano. Nella liturgia non si
parla di Dio e della Chiesa, ma se ne fa l’esperienza. Niente e nessuno può contenere la
parola di Dio, che è incontenibile.
Il Dio di Gesù Cristo non è un pacchetto di informazioni teologiche, ma sorprende
l’uomo e la sua stessa fede.
IL MISTERO DELLA NOSTRA VOCE
La teologia ha dunque bisogno del rito, che le conferisce un significato
antropologico-religioso. Musica e canto, invece – avverte Alceste Catella, preside
dell’Istituto di Teologia Pastorale di Santa Giustina di Padova – sembrano valere ancora
e solo come ornamenti. L’assenza di un pensiero teologico circa la loro presenza nella
liturgia è un difetto di attenzione ai valori della ritualità e all’esercizio della simbolica.
Anche al Vaticano II è mancata una riflessione profetica sul rapporto fra teologia e
liturgia.
Secondo Felice Rainoldi, che ha dedicato al tema numerosi scritti, soprattutto
un’esperienza sul campo, punto di partenza non è più la “musica sacra”, ma il mistero
liturgico celebrato dalla Chiesa come evento pasquale; non il repertorio o gli strumenti,
ma le persone che si esprimono ritualmente. Insomma, canto e musica non sono
un’opera, ma un gesto, uno dei gesti della Chiesa, resa visibile e presente dall’assemblea
articolata del popolo di Dio, nell’atto memoriale e vivo di attingere la storia della
salvezza in dimensione celebrativa. Canto e musica hanno valenza “sacramentale”
qualora siano “veri”, cioè facciano parlare o parlino all’interno di un’assemblea, qui e
ora radunata. L’autenticità del coinvolgimento, a partire dalla base antropologica, e la
verità delle espressioni, a partire dai mondi culturali delle assemblee credenti
(omogenee o pluralistiche), non fa che arricchire la celebrazione viva e anche quel
thesaurus musicae che, codificandosi, testimonia i cammini del Vangelo.
Dalla categoria di riforma a quella di iniziazione, anche Catella insiste – in sintonia
con Bonaccorso, che di Santa Giustina è vicepreside – che è il corpo la forma con cui
entriamo nella liturgia, la quale è azione rituale, più che un discorso su Dio, pena una
ricaduta ideologica del cristianesimo. È stato Sequeri ad aprirci a dimensioni quali lo
sguardo, l’ascolto, lo spazio, la percezione, l’assimilazione, la prossemica, il contatto, il
silenzio, il suono; alle molte figure dell’esistenza quotidiana e dei sensi, evocati nella
liturgia con volumi rarefatti, perché vengano all’evidenza come mistero, trascendenza.
Il canto, ad esempio, strappa il testo dal mero valore informativo e concettuale, e lo
trasporta verso il poetico, l’emotivo. Tra suonare e risuonare vi è un gioco che educa
all’ascolto per poter sostare nei pressi della parola e del gesto. La stessa professio fidei
christiana è radicalmente innodica; segue una dinamica che coinvolge bocca, orecchio,
cuore, ascolto e risposta. Così vuole anche la lirica salmica, fatta contemporaneamente
di tenerezza e violenza. Non basta un canto ben scritto. Deve passare attraverso una
voce, perché sia efficace e significativo.
Tre sono le situazioni liturgiche inerenti il canto: l’acclamazione e la supplica; la
meditazione (il lavorare la parola e il lavorìo di essa in noi); la professione di fede. Chi
supplica si volge verso qualcuno, esce da sé, lascia il suo universo e ne cerca un altro. È
la traduzione vocale di uno spaesamento. Pregare appartiene al vocativo, all’evocativo,
a quanto di più primigenio vi è nell’essere umano; la voce sfugge a chi la emette, si
perde senza ripiegamento e precauzione, non si ascolta. La meditazione è una lotta con
il testo letterario e musicale, spesso una sconfitta. Il testo viene anzitutto verso di noi:
occorre lasciarsi raggiungere. La professione di fede rimanda all’essere assemblea con
sonorità corposa. La dinamica responsoriale, al pari del salmo interlezionale, giocato sul
rapporto tra iniziativa del salmista e risposta dell’assemblea, funziona da icona e
riassunto delle tre situazioni.
QUESTIONE DI FEED-BACK
È stato presentato il nuovo “Repertorio nazionale di canti per la liturgia”.
Giustamente non può che dichiararsi non esaustivo. Più interessante è stata l’esperienza
del laboratorio: all’esecuzione di alcuni canti della raccolta da parte del Coro
dell’Istituto di Musica per la Liturgia di Reggio Emilia, i convegnisti dovevano cogliere
e analizzare ciò che avviene nell’ascoltatore e, pensando alla liturgia, al rapporto fra
musica, canto, esecuzione e assemblea. Una fenomenologia dell’ascolto che va dal
prestare orecchio al crescendo del coinvolgimento emotivo, all’affinamento del gusto,
all’ascesi dell’apprendimento. Una dimostrazione coinvolgente sul valore del canto
nella liturgia, ponendo attenzione alla varietà, alle possibilità e varianti dei temi, dei
ritmi, delle forme, delle melodie, degli stili, dei generi, dei differenti rapporti e giochi
fra testo e musica. Non tutto va bene per ogni tipo di assemblea, e poi si sente se questa
ha voglia di cantare.
Significativa è stata la presenza al convegno di studenti del Co.Per.Li.M, il corso di
perfezionamento in musica per la liturgia, istituito dalla Cei nel 1994 e gestito
dall’Ufficio Liturgico Nazionale, della durata di due estati e un inverno, per un totale di
200 ore distribuite tra lezioni, seminari di ricerca e dibattiti. Scopo del corso è preparare
i responsabili, nonché direttori e docenti di Scuole e Istituti diocesani della “musica per
la liturgia” (e non più, finalmente, “musica sacra”). Alle diocesi è infatti destinato il
repertorio, ormai pubblicato, preceduto dalla premessa della Commissione Episcopale
per la Liturgia.
VISITA ALLA CATTEDRALE DI BOLOGNA: L’ARCHITETTO
Il progetto di adeguamento degli arredi dell’altare maggiore, realizzato nel 1997, in
occasione del 23° Congresso Eucaristico Nazionale e nel contesto del restauro
conservativo della Cattedrale, ha riguardato esclusivamente i tre principali elementi
dell’apparato celebrativo: l’altare, la cattedra e l’ambone, prima costituiti da strutture
mobili e dalle caratteristiche formali e costruttive eterogenee.
Dopo alcune note sull’evoluzione storica della cappella maggiore, l’architetto
Roberto Terra ci informa che presupposto del progetto, ideato da Lello Scorzelli, è stato
l’inserimento, in sostituzione degli elementi preesistenti, di strutture di arredo non fisse
e in qualsiasi momento asportabili, concepite, pur nelle diverse funzioni, secondo
un’unità di disegno, di colori e di materiali, che gli arredi precedenti non possedevano.
La mensa dell’altare è costituita da un’unica lastra di marmo sostenuta da un
basamento parallelepipedo, con le facciate contraddistinte alternativamente da una o tre
specchiature ripartite da piedritti. I materiali prescelti vanno dai bianchi di Carrara
(statuario, ordinario e venatino) ai travertini di Rapolano, chiaro e scuro. Le
specchiature del palio frontale, come pure dei fianchi e del fronte posteriore, sono
intarsiate da mandorle concave di marmo giallo di Siena che fungono da sfondo alle
figure in bronzo realizzate da Scorzelli: san Vitale, san Pietro e sant’Agricola sul fronte;
san Petronio e santa Clelia Barbieri sui lati; Abramo, Abele e Melchisedek sul retro.
L’apparato decorativo dell’altare è completato da pietre dure immesse negli angoli
arrotondati, realizzati in marmo nero del Belgio, e da inserti di bronzo rappresentanti
scene di martirio sui rombi di travertino chiaro di Siena.
Gli stessi materiali ed elementi decorativi sono stati ripresi nella costruzione della
cattedra arcivescovile e dell’ambone, dove è completato il programma iconografico. La
cattedra reca, ai lati, gli stemmi in bronzo di Papa Giovanni Paolo II e del Cardinale
Giacomo Biffi, Arcivescovo della città, oltre alla croce greca inscritta nel cerchio sullo
schienale. Sull’ambone compaiono invece gli evangelisti in bronzo, inscritti in quattro
mandorle dorate poste sul fronte.
Il nuovo altare è stato realizzato nelle identiche dimensioni e collocato nella
medesima posizione di quello preesistente, avendo cura di predisporre uno strato di
protezione a salvaguardia delle zone di pavimento a contatto con la nuova struttura, che
è quindi semplicemente appoggiata. Le stesse precauzioni sono state mantenute per il
collocamento di cattedra e ambone.
A sinistra dell’altare, avanzata rispetto ad esso sul lato dell’evangelo, la cattedra ha
subìto, nel posizionamento, una significativa modifica rispetto alla preesistente,
ruotando di 45° e traslando leggermente verso il centro per consentire una migliore
visibilità. La struttura fa perno sul piedistallo della grande colonna dell’arco trionfale,
raccordandosi ad esso attraverso un taglio nello sviluppo dei gradoni di sostegno del
seggio.
A destra dell’altare, l’ambone è stato collocato in prossimità della scalinata, per
consentire il massimo avvicinamento all’assemblea dei fedeli.
VISITA ALLA CATTEDRALE DI BOLOGNA: IL LITURGISTA
Ci troviamo in una fase di rodaggio e ricerca circa l’adeguamento dello spazio
liturgico in seguito alla riforma voluta dal Concilio. La soluzione adottata – maturata,
sofferta, ma accettabilissima, secondo Crispino Valenziano – coinvolge tutto lo spazio
celebrativo: non solo il presbiterio, ma anche l’aula. Dal presbiterio si ha l’impressione
di un’esperienza diretta con l’assemblea, di uno spazio davvero abitabile, accogliente.
L’idea è quella di una longitudinalità allargata, con lo spazio statico della navata
centrale e dinamico di quelle laterali. Questo non è arredo, ma struttura!
Due cose hanno coinvolto l’aula nella sua spazialità: la presenza dell’organo e della
schola al suo centro, spia molto forte del coinvolgimento sonoro assembleare (ciò ha
comportato un lavorìo serio degli organari), e la permanenza squilibrante del pulpito, in
quanto non liturgico: non rappresenta la Parola, ma la parenesi didattico-esortativa.
Circa la cattedra, si vede che non è la cattedra dell’arcivescovo, ma di Cristo. A volte
si cade in un’illusione pneumatologica, maggiorando indebitamente il vescovo come
depositario dell’ispirazione. La cattedra, invece, ha per natura una struttura cristologia,
per cui gli stemmi episcopali devono essere discreti, senza creare squilibrio. Quella di
Bologna è una cattedra sobria, indovinata dal punto di vista iconologico. Un errore di
grammatica, forse inevitabile, c’è semmai nel non aver creato la pedana tutt’attorno
all’altare, come è prescritto, mentre la si è creata attorno alla cattedra. Non basta dire:
qui si celebra bene, ma anche: qui significa bene. Non conta solo la funzione, ma anche
il simbolo, dato dalla natura e struttura dell’oggetto. L’altare è troppo lungo in rapporto
alla larghezza, quando invece non dovrebbe mai toccare il rettangolo perfetto, bensì un
quadrato o tendere al quadrato. Il nostro immaginario è influenzato dall’altare di schiena
del barocco. Oggi dobbiamo cercare un altro immaginario. E non basta giustificare con
la concelebrazione, poiché all’altare devono stare solo il presidente e il diacono.
I santi rappresentati sui lati dell’altare seguono un’iconografia perfetta, secondo il
dettato di Ambrogio, anche se l’aspetto tipologico (Abramo, Isacco e Melchisedech)
andava davanti, dove invece troviamo quattro santi locali. L’altare presenta un ritmo
ansimante, scazonte. Se così fosse anche in facciata, il respiro sarebbe più sintattico.
L’ambone. Si chiama così perché ha due scale o da anabáino. La “pedana plenaria”,
che contiene in sé ambone, altare e cattedra, oggi non è più accettabile. Anche il
“messale plenario” era spuntato perché i ministeri si erano affievoliti, faceva tutto il
presidente. Quando la riforma ha voluto più libri, gli anziani si sono sentiti disorientati,
pensando di dover andare a dire messa con una biblioteca! Non così è capitato con gli
spazi. Ci portiamo ancora dentro un immaginario indotto da tre secoli di decadenza (la
parentesi occidentale), non attribuibile né a Trento né a Carlo Borromeo. La funzione
dell’ambone è oggi pressoché finita. Non serve più porlo in alto per far sentire la voce,
oggi ci sono i microfoni. Non serve nemmeno un monumento. Anche qui, l’attenzione
va rivolta, più che alla funzione, al simbolo: la tomba vuota, quindi la risurrezione. Per
questo motivo, semmai, va posizionato in alto. Il Cristo risorto è, per i Padri, la chiave
musicale per leggere il rigo della Scrittura. Inoltre, l’ambone appartiene all’aula, non al
presbiterio. Il progetto di adeguamento doveva avere il coraggio di mettere anche
l’ambone, al pari dell’organo, più a contatto con l’assemblea, così che fosse evidente il
suo costituirsi attorno alla parola, per poi, da lì, passare attorno all’altare. Questa è la
grande tradizione della chiesa. Quanto all’iconologia dell’ambone, gli evangelisti non
c’entrano, ci sono già le statue poste a chiasmo sull’arco trionfale. Essi vanno semmai
all’altare. Occorre attenzione nel porre i simboli al posto giusto e a non doppiarli.
L’immagine penetra molto più della parola e lavora dentro, fruttificando alla fine il
cento per uno.
La vasca battesimale non deve venire sulla “pedana plenaria”, essendo la
partecipazione non un concetto di tipo visivo, ma ambientale, spaziale. Per questo
l’assemblea rimane nell’aula, da dove gode sì una visione, ma globale. Se la vasca va
bene ovunque, a seconda dell’aspetto da evidenziare – l’iniziazione o la remissione dei
peccati o altro – non così l’altare.Quanto al sacramento della penitenza, la remissione
dei peccati appartiene per tradizione al nartece, ossia fuori. Solo successivamente è
venuta in chiesa per motivi etici. Oggi è meglio una cappella o una saletta, o altro luogo
collegato ma distinto rispetto all’aula assembleare. Il problema del luogo della penitenza
non si risolverà finché non si adotta il rito della penitenza, perciò non si pone.
LA CHIESA DI ALVAR AALTO A RIOLA
La chiesa parrocchiale dedicata a Maria Santissima Assunta in Riola (Bo), opera
dell’architetto Alvar Aalto, ha respirato sin dall’inizio la riforma liturgica. È figlia
primogenita del Vaticano II, benché “settimina”. Mira, più che alla conclusione del
concilio, alle provocazioni della Lumen Gentium. Insieme a questa, a Dei Verbum e a
Gaudium et Spes è infatti da leggersi la Sacrosanctum Concilium, e non da sola.
L’incarico ad Aalto fu conferito il 19 novembre 1965 dall’arcivescovo di Bologna,
Giacomo Lercaro, alla serata conclusiva del Concilio, ove il cardinale svolse il ruolo di
coordinatore dei lavori della Commissione liturgica.
Indimenticabile rimane, secondo la diretta testimonianza dell’architetto Giorgio
Trebbi, quel 10 gennaio 1966 in cui Aalto scese a Riola insieme alla moglie, architetto
Elissa, ricevendo calorosa accoglienza dalla popolazione, con l’offerta – beneaugurante
secondo la tradizione locale – di un canestro con pane e sale, segni dell’ospitalità, e
l’ascolto, sulla spianata erbosa, dell’inno nazionale finlandese allo sventolio, da parte
delle scolaresche locali, di decine di bandierine dei due paesi. Aalto si commosse,
percependo i segni di una partecipazione espansiva tale da apparirgli inattesa.
Nell’estate dello stesso anno, Aalto visita nuovamente Riola per verificare il progetto
in elaborazione e che, anche grazie all’ausilio di due plastici di studio, avvia a stesura
definitiva. Al riolese Mario Tamburini, direttore della Grandi Lavori S.p.A, si deve
l’impegno imprenditoriale qualificato per una traduzione fedele dell’importante
progetto.
Aalto ha saputo interpretare lo spazio sacro, rispondendo alle attese di un luogo che
offrisse un centro focale corrispondente allo spazio celebrativo e, nel contempo,
polarizzasse la partecipazione dei fedeli nell’aula. L’insieme diviene pertanto spazio per
eccellenza comunitario, vale a dire concepito per facilitare una partecipazione viva e
corale. Le feritoie aperte verso il cielo, per catturarne la luce orientata, così come quelle
dell’aula battesimale, dalle quali si intravede il fiume, inseriscono lo spazio dell’edificio
in una liturgia cosmica. Gli spazi liturgici sono disegnati con grande sensibilità. La
cantoria, ad esempio, che si origina dal presbiterio, iniziando da esso a salire a fianco
dell’aula, ne diviene luogo naturale di dialogo col celebrante, ma anche di guida del
canto affidato all’assemblea stessa che popola la chiesa. Per la maggior parte, le diverse
azioni, alle quali è assegnato uno spazio confacente, risultano spontaneamente
sollecitate, così da dar vita a una chiesa vivente, partecipe in modo ordinato, vivo e
conforme ai ruoli.
Tra i ricordi di Trebbi, il lavoro con Aalto è stato cordiale, amichevole. Uomo
d’ascolto e desideroso di imparare, il grande architetto ha saputo dare lezione di umiltà,
illuminando sul modo di collaborare.
Nel progetto di Riola i cardinali Lercaro e Poma furono anticipatori, artefici, profeti,
ma non si possono mitizzare troppo in fretta persone e concili. Quando questa chiesa
nasce, non ci sono ancora i Praenotanda del Messale. Perciò – avverte Crispino
Valenziano – essa non è un modello, sia perché niente va ripetuto, sia perché ogni
modello è dinamico. Non ci sono tipologie. Diversamente dalla cattedrale di Bologna,
dove l’adeguamento arriva dopo trent’anni dalla fine del Concilio, a Riola si ha
un’anticipazione. Nel punto più remoto della diocesi, il card. Lercaro chiama un
architetto di fama internazionale, chiedendo un’interpretazione; non una
miniaturizzazione della cattedrale, ossia una costruzione “in diminuendo”, ma qualcosa
per una comunità ideale di 500 persone (è la cattedrale, semmai, che richiede un
costruire “in aumentando”).
Da allora molto è cambiato. Quanto c’è da apprendere sta nel germe seminato: la
grande idea, il seme sepolto. Si possono ritrovare i legami, l’ispirazione, ma non
copiare. L’operazione ebbe valore ecumenico – e in questo fu profetica – essendo Aalto
protestante.
Circa la forma dell’edificio, non richiama la tenda, troppo allegorica per l’epoca. Si
cercava una forma che potesse trascrivere il meglio possibile l’idea generale
all’orizzonte: quella di partecipazione, assemblea, ministerialità. Per il resto, ogni chiesa
è un caso a sé. Riola non si può toccare, solo perché significa, nell’evoluzione dell’arte
cattolica, ciò che è stata in quella fase, e basta. Non si possono istoriare le vetrate (la
Biblia pauperum è tutt’altra cosa) né sostituire l’altare. In quanto tale, la stessa
architettura e struttura è immagine. Non si va a Riola per vedere come si costruisce una
chiesa. Oggi abbiamo il senno di poi, certe cose non le rifaremmo così. L’importante è
che il simbolo svolga dalla natura della cosa liturgica.
L’ARTE DEL PRESIEDERE
Presiedere: verbo fondamentale in liturgia, che favorisce ma non esaurisce la
celebrazione. Favorisce precisamente “l’accesso all’eccesso”, impresa importante e
irrinunciabile del celebrare cristiano.
Secondo Franco Brovelli occorre riguadagnare dall’interno il senso
dell’appartenenza al Signore; lasciarsi condurre ed educare dalla verità del rito, per
poterlo adeguatamente presiedere. Come, al dire di Heidegger, la via fa parte della
contrada, così le condizioni per l’accesso al rito non sono altro dal rito stesso. È il
celebrare che evoca e suscita senso, non noi o le nostre premesse. Perciò dobbiamo
amare la contrada, ossia lo scenario complessivo del rito. I riti d’ingresso, ad esempio,
sono un invito, un’attrazione a varcare la soglia, la quale trattiene, impedisce, costringe
ad una sosta, crea un’attesa e l’incremento del desiderio del volto del Signore. La
liturgia è spazio e vigilia, come la luce dell’aurora. Non si trova già fatta: la trova chi
l’ha invocata e attesa.
Parlando di presidenza occorre considerare anche il contesto di comunità e di
cammino. È in gioco la rifondazione del senso di appartenenza a un popolo, come nella
vocazione di Mosè. Come presiedere nel cammino storico-religioso della nostra gente?
Servire non è svendere la presidenza, dal momento che un’arte non è solo competenza
linguistica, ma esperienza spirituale. Dobbiamo lasciar esplodere la verità del rito per
portare oltre, permettere il ritorno a casa, ma allo stesso tempo uscire dal recinto rituale;
seguendo una pluralità di sentieri, ma senza rinunciare a qualche “zampata” decisiva.
LA SEQUENZA RITUALE
Silvano Maggiani ha invitato a salvaguardare la celebrazione nella sua struttura, nella
sua dinamica, nei suoi elementi, sintassi, grammatica ecc. Come ogni linguaggio,
occorre conoscerne le regole, i codici, la sequenza. Elementi e momenti di una sequenza
rituale sono: la struttura celebrativa simbolico-rituale; gli attori (assemblea, presidente,
ministri); il dispositivo ecologico (regolamentazione del tempo e dello spazio); il
dispositivo etologico (regolamentazione degli atteggiamenti e degli oggetti); gli atti di
linguaggio (rapporto gesto/parola, musica/canto); i testi eucologici.
Quanto allo spazio rituale, gli architetti, nonché le chiese, ci insegnano che esso
viene percepito grazie al gioco cromatico della luce, all’alternanza luce/ombra,
lodi/vespri, ora media/compieta. Celebrare è ritrovare la luce abitandola in uno spazio.
Di essa la memoria ecclesiale è miniera principale. Il corpo interrompe la luce e allo
stesso tempo è da essa illuminato, come in un’apparizione. Così è la trascendenza:
nascosta e insieme manifesta; Dio rimane nascosto anche quando si rivela; è vicino, ma
da lontano. Giorno e notte, alba e tramonto: nella liturgia delle ore l’orario è più
importante dei salmi.