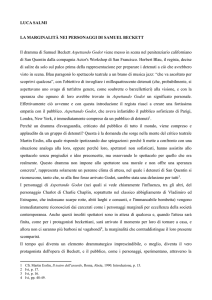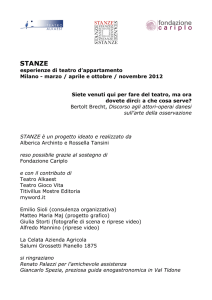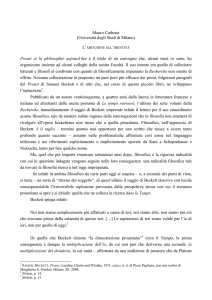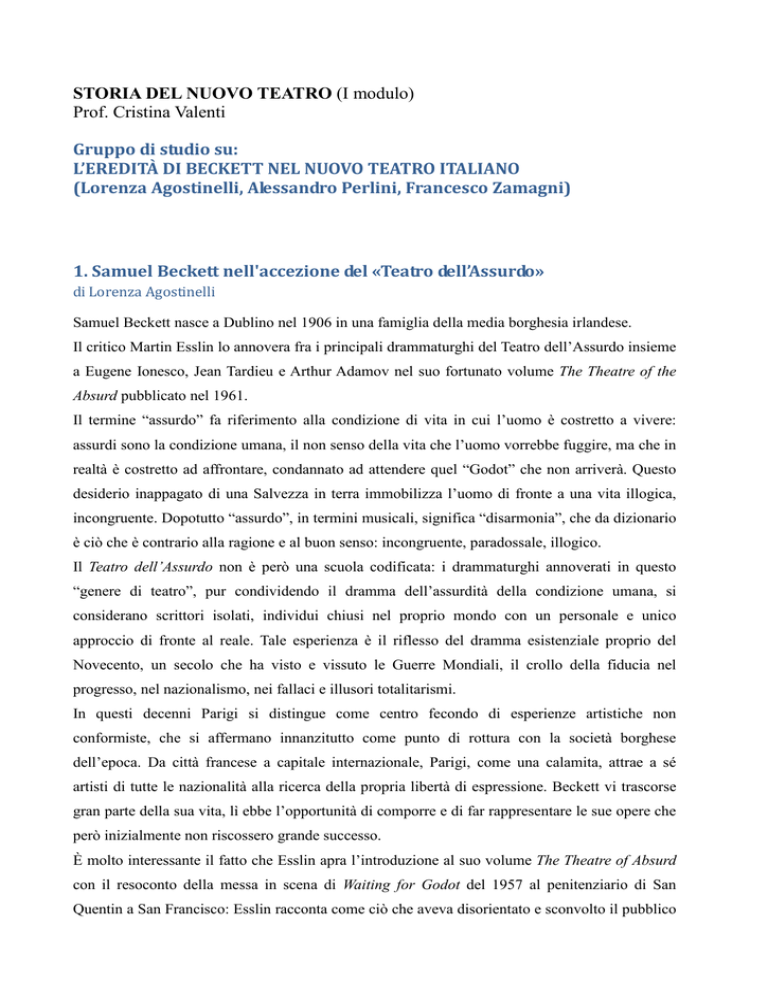
STORIA DEL NUOVO TEATRO (I modulo)
Prof. Cristina Valenti
Gruppo di studio su:
L’EREDITÀ DI BECKETT NEL NUOVO TEATRO ITALIANO
(Lorenza Agostinelli, Alessandro Perlini, Francesco Zamagni)
1. Samuel Beckett nell'accezione del «Teatro dell’Assurdo»
di Lorenza Agostinelli
Samuel Beckett nasce a Dublino nel 1906 in una famiglia della media borghesia irlandese.
Il critico Martin Esslin lo annovera fra i principali drammaturghi del Teatro dell’Assurdo insieme
a Eugene Ionesco, Jean Tardieu e Arthur Adamov nel suo fortunato volume The Theatre of the
Absurd pubblicato nel 1961.
Il termine “assurdo” fa riferimento alla condizione di vita in cui l’uomo è costretto a vivere:
assurdi sono la condizione umana, il non senso della vita che l’uomo vorrebbe fuggire, ma che in
realtà è costretto ad affrontare, condannato ad attendere quel “Godot” che non arriverà. Questo
desiderio inappagato di una Salvezza in terra immobilizza l’uomo di fronte a una vita illogica,
incongruente. Dopotutto “assurdo”, in termini musicali, significa “disarmonia”, che da dizionario
è ciò che è contrario alla ragione e al buon senso: incongruente, paradossale, illogico.
Il Teatro dell’Assurdo non è però una scuola codificata: i drammaturghi annoverati in questo
“genere di teatro”, pur condividendo il dramma dell’assurdità della condizione umana, si
considerano scrittori isolati, individui chiusi nel proprio mondo con un personale e unico
approccio di fronte al reale. Tale esperienza è il riflesso del dramma esistenziale proprio del
Novecento, un secolo che ha visto e vissuto le Guerre Mondiali, il crollo della fiducia nel
progresso, nel nazionalismo, nei fallaci e illusori totalitarismi.
In questi decenni Parigi si distingue come centro fecondo di esperienze artistiche non
conformiste, che si affermano innanzitutto come punto di rottura con la società borghese
dell’epoca. Da città francese a capitale internazionale, Parigi, come una calamita, attrae a sé
artisti di tutte le nazionalità alla ricerca della propria libertà di espressione. Beckett vi trascorse
gran parte della sua vita, lì ebbe l’opportunità di comporre e di far rappresentare le sue opere che
però inizialmente non riscossero grande successo.
È molto interessante il fatto che Esslin apra l’introduzione al suo volume The Theatre of Absurd
con il resoconto della messa in scena di Waiting for Godot del 1957 al penitenziario di San
Quentin a San Francisco: Esslin racconta come ciò che aveva disorientato e sconvolto il pubblico
sofisticato e borghese di Parigi, Londra e New York, nelle precedenti rappresentazioni, fosse
stato subito compreso e recepito da un pubblico di millequattrocento detenuti che condivideva
con Vladimir ed Estragon (protagonisti di Waiting for Godot) la stessa attesa, la stessa
condizione “assurda” di vita.
Questa condizione di attesa può essere compresa dall’uomo perché appartiene al suo essere, al
suo io. Beckett allora denuda l’uomo fino a fare emergere la sua più intima e personale domanda
di significato e di senso, mettendolo di fronte al suo bisogno più urgente. Da qui nasce la
profonda angoscia esistenziale che caratterizza la sua intera opera teatrale.
Ma Beckett, più che disquisire sull’assurdità della condizione umana, preferisce usare il mezzo
teatrale per farla riaccadere ogni qualvolta si apra il sipario. Il drammaturgo sperimenta forme
espressive che Esslin considera omologhe all'oggetto da rappresentare, ossia all'illogicità e
all'insensatezza della condizione umana. Se l'intenzione di
Beckett
è comunicare
l’incomunicabile, anche il mezzo espressivo che utilizza si conforma a tale contenuto: il
linguaggio utilizzato è infatti pregno di malintesi, doppi sensi, ripetizioni (ad esempio Happy
Days e Not I) fino ad arrivare a un non senso della comunicazione e del linguaggio stesso che
dovrebbe veicolarla. Allo stesso modo anche il dialogo decade, crolla perché le parole non hanno
più significato e lo spettatore, assieme al protagonista del dramma, è come travolto da sillabe,
balbettii, singulti (come in Not I) fluttuanti nell’aria.
A questo proposito Keir Elam mette in luce la potenzialità della parola beckettiana che in
qualche modo colma l’apparente illogicità. La parola infatti veicola il suo significato diventando
più iconica che lessicale, più agita che detta; nel “teatro di parola” di Beckett non c’è nulla di
astratto, ma piuttosto la parola prende forma e carne nell’hic et nunc della scena. Una parola
quindi incompiuta che solo la performance può compensare anche se mai completare.
Solo così la parola contribuisce a creare quelle immagini spesso dure, spietate e cruente che sono
diventate le icone oggi più riconoscibili sia nella scena contemporanea sia nel nostro
immaginario teatrale. La distanza fra scena e testo è azzerata, e la parola da forma così ad una
scrittura scenica o scena scritturale.
2. Beckett in Italia
2.1. Il Teatrostudio, Carlo Quartucci e Rino Sudano
di Alessandro Perlini
Il teatro di Beckett è strettamente legato alla nascita del Nuovo Teatro in Italia. Una delle messe in
scena più rappresentative in tal senso è quella di Aspettando Godot realizzata dalla compagnia
Teatrostudio nel 1964 per il Teatro Stabile di Genova, con la regia di Carlo Quartucci e
l'interpretazione di Rino Sudano, Leo de Berardinis, Carlo Remondi e Maria Grazia Grassini.
Ancora prima di questo spettacolo, tuttavia, sia Carlo Quartucci che Rino Sudano avevano già
affrontato l’opera beckettinana in altre occasioni minori.
Aspettando Godot è la prima opera teatrale scritta da Samuel Beckett, preparata in soli tre mesi, tra
l’ottobre del 1948 e il gennaio del 1949, e andata in scena per la prima volta nel 1953. Da molti è
considerata come un capolavoro assoluto del teatro contemporaneo e ad essa si legano il nome
stesso e la notorietà del drammaturgo irlandese. Beckett scrisse questo testo per «distaccarsi dalla
prosa di quel periodo» e dalla sregolatezza dei romanzi. I limiti spaziali e temporali del teatro
rappresentarono per lui un'occasione di libertà, la possibilità di esprimersi senza restrizioni,
attraverso mondi che parlano direttamente al nostro mondo, una realtà che ha ragion d’essere di per
se stessa, personaggi precostruiti che non nascono sulla scena. Aspettando Godot è costituito, per la
massima parte, da una conversazione tra due clown vagabondi, Vladimir e Estragon, e in questa
conversazione consta tutto il dramma: sono dialoghi vuoti, a volte nati da pretesti forzati, interrotti
solo da alcune scenette, il tutto nell’attesa di questo Godot che nessuno dei due conosce: questa
attesa diventa la forma attraverso cui si rivela il significato dell’esistenza dell’uomo. Non mancano i
riferimenti meta teatrali, con i personaggi che si richiedono vicendevolmente la possibilità di parlare
e che obbligano il pubblico a rendersi conto di essere in un teatro, e momenti di comicità grottesca e
infelice; Beckett propone in questo spettacolo la sua convinzione che la vita è una colpa che si
sconta per essere nati, «la morte si sconta vivendo», la condizione umana stessa è segnata dalla
sofferenza e dall’assenza di senso. Si tratta di una negatività che combatte il materialismo
dell’uomo, nel ripensare al senso senza il successo e l’egoismo.
È proprio da questa esperienza teatrale che prende il via la strada di Carlo Quartucci e Rino Sudano,
una strada segnata dal rapporto con la figura di Samuel Beckett.
Carlo Quartucci, studente di architettura, esordisce nel 1959 proprio con Aspettando Godot,
rappresentato all’interno di una chiesa, spettacolo che egli affronta senza una piena conoscenza
dell’opera e della filosofia di Beckett: lo vedeva come un testo dove, per due ore, nessuno degli
attori in scena diceva nulla, e proprio per questo lo sentiva come molto vicino a sé.
Successivamente, nel 1961, Quartucci incontrò Rino Sudano e Leo de Berardinis e iniziarono a
lavorare insieme. I tre crearono il Teatro della ripresa, una compagnia teatrale che non voleva creare
una avanguardia, un teatro nuovo, ma che voleva «riprendersi il teatro» attraverso la responsabilità
di ogni dettaglio di scena portando avanti una critica al teatro contemporaneo basata sulla
sperimentazione linguistica. Nel 1962, nel gruppo di spettacoli Me e me, Quartucci interpretò Atto
senza parole I, con uno stile di recitazione che è stato definito esasperato, grottesco e concreto,
molto diverso da quello realistico della scena ufficiale. Nel 1963 lavorò a Finale di partita, dove
interpretò la parte di Nagg. È proprio in questa occasione che il gruppo incontrò il regista Luigi
Squarzina, il quale, interpellato Leo de Berardinis, accettò di prendere con sé l’intero gruppo e di
portarlo al Teatro Stabile di Genova, di cui era Direttore artistico. In questo momento Quartucci era
insieme attore, regista, docente della scuola di recitazione di Genova e direttore della compagnia
Teatrostudio, il nuovo nome del loro gruppo. Forte di tutti i ruoli che copriva, decise di affrontare
Aspettando Godot come regista e non come attore. Quartucci parla di Aspettando Godot come di
uno spettacolo impossibile da tenere in piedi senza che vi fosse una piena amicizia fra gli attori che
lo interpretavano e riusciva a vedere il rapporto tra i due personaggi, Vladimir ed Estragon, proprio
nelle due figure di Leo de Berardinis e Rino Sudano (Beckett stesso affermava che i discorsi tra i
due clown non erano molto dissimili da quelli tra lui e sua moglie, quindi era davvero necessaria
una certa familiarità). Gli studi di architettura, oltretutto, finirono per aiutare Quartucci, in quanto le
didascalie di scena sembravano applicarsi a precise regole di “teorie della forma”: tutto lo spazio è
disegnato e vissuto, ha una importanza estremamente rilevante, come spesso accade nelle opere di
Beckett. Da regista dello spettacolo, Quartucci era molto esigente rispetto alla gestualità, alla voce ,
al movimento. Ispirandosi alle arti visive, diede a Rino Sudano un'inquadratura di tipo razionale,
legata alla sua etica teatrale, e affidò a Leo de Berardinis una formalizzazione di tipo processuale.
Tutto il pensiero di Beckett era da intendersi come una problematica dell’esistenza sganciata dalla
significazione storica: si trattava di un'interpretazione nata da Rino Sudano e che Quartucci fece
propria, riportandola anche sul libretto dello spettacolo. Beckett, nella lettura che ne diedero,
prescindeva da una cognizione storica della realtà, mettendo al centro il male del nascere in
assoluto: «nascere fu la sua morte»; e la parola beckettiana non diceva altro che quello che diceva,
non c’era nulla di nascosto dietro di essa. Quartucci continuò successivamente ad occuparsi di
Beckett, con il suo festival a Prima Porta nel 1965, e nel corso degli anni imparò a conoscerne tutti i
tratti, fino a un cambiamento di rotta che gli fece mutare interessi e cambiare autore di riferimento,
di volta in volta.
Rino Sudano è un attore spesso dimenticato dalla storia del nuovo teatro italiano: egli era
pienamente consapevole di andare contro quello che era lo spirito del suo tempo, e che questo non
sarebbe stato comunque il mezzo per raggiungere alte vette artistiche. Vedeva in Samuel Beckett il
suo ispiratore, come lui stesso afferma in una intervista documentata nel cortometraggio L’alieno, il
pieno rappresentante della sua visione etica del teatro. Sudano intendeva infatti realizzare un teatro
ideologico, etico, eliminando l’estetica a favore dell’istanza etica stessa, come motore
dell’espressione artistica. «Beckett ci ha fatto capire come, quale era e come poteva essere il nuovo
modo di comportarsi in teatro», «La nostra lettura di Beckett ti poneva fuori, dicevi ‘cos’è ‘sta
roba? Cos’è ‘sto teatro?». A detta di Sudano, Beckett riusciva ad esprimere un pensiero sul teatro
con la sua scrittura, e attraverso la scrittura esponeva il suo pensiero sul mondo. Sudano costruisce
quella che può essere definita una poetica dell’assenza del soggetto nel mondo dei rapporti
amministrati. L’assenza del soggetto è appunto la base di tutto il teatro di Sudano, che segue
l’insieme di influssi del teatro beckettiano, e questo lo si evince specie dal suo ultimo spettacolo,
Assenza: Le banane della Norvegia, che Sudano ha scritto e concepito perché potesse essere
rappresentato infinite volte dopo la sua morte. La presenza dell’attore è eliminata in favore di una
registrazione su stereo; una completa spersonalizzazione dell’attore e del personaggio che può
ricordare la bocca di Non io, dove è proprio l’annullamento del pronome personale, e con esso della
personalità e della personificazione stessa dell’attore, il fulcro da cui si dipana per tutto il breve
dramma. Da Beckett, Sudano recupera anche le scenografie semplici e suggestive, proponendo una
recitazione astratta che non intendeva garantire a Beckett l’accesso al mercato teatrale, come altri
avevano tentato di fare. Dopo aver recitato insieme a Quartucci in Finale di partita nel 1963, Rino
Sudano si unisce al Teatrostudio e prende parte, appunto, all’allestimento di Aspettando Godot per il
Teatro Stabile di Genova nel 1964. L’idea della messinscena di Aspettando Godot, nata
dall’esigenza di continuare ad occuparsi di Beckett, nasce dalle discussioni sullo spazio scenico tra
Sudano e De Berardinis, i quali riuscivano, come affermava Quartucci, ad intendersi con una
facilità tale che i loro personaggi riuscivano a nascere con facilità, in maniera quasi inspiegabile
(anche se Sudano riteneva che in Quartucci ci fosse sempre un eccesso di formalismo estetico, forse
poco adatto per interpretare Beckett). Sudano ha lavorato sui cambi di voce, sui passaggi tra i
sussurri e le grida, come richiesto dal personaggio di Estragon, in uno spettacolo che per lui si
rivelò estremamente faticoso: un modo di recitare che l'attore aveva ripreso dalla precedente
interpretazione di Finale di partita. L’idea che stava alla base di Aspettando Godot e degli altri
spettacoli beckettiani appartenenti alla successiva rassegna di Prima Porta, era quella di educare il
pubblico, pubblico che prima andava «violentato», messo di fronte ad un oggetto che lo ponesse in
difficoltà e lo spiazzasse, tanto che gli spettatori del normale teatro di prosa trovavano il tutto assai
anomalo.«Tramite Beckett noi abbiamo scoperto un nuovo modo di fare teatro, ma chi aveva capito
ancora Beckett? Nessuno…», molti lo inserivano nel teatro di avanguardia, ma Sudano non riesce a
vedere o a parlare di avanguardia pensando a quell’Aspettando Godot, al massimo preferiva
definirsi come rappresentante di un «teatro contro». Per lui quello spettacolo è un ricordo pieno di
gioia, lo interpretava con grande piacere e convinzione, con grande amore.
Successivamente, insieme alla sua compagnia Quattro Cantoni, Rino Sudano riprese l’opera del
drammaturgo irlandese nel primo percorso di Mors II, un lungo laboratorio che voleva
accompagnare il pubblico in varie azioni teatrali, dal titolo Il testo da scrivere, un testo che
esprimeva l’impossibilità di dare una forma definitiva alla struttura scenica. In questo percorso,
Sudano leggeva frammenti del racconto Da un’opera abbandonata, opera dove Beckett lasciava
spazio a una voce che cercava di rievocare il passato nel tentativo, inutile, di fare il punto sulla sua
esistenza. Anche qui il testo non voleva avere nessun particolare significato nascosto, come il testo
di Aspettando Godot, e la presentazione dei dettagli li assimilava e discioglieva nel procedere della
lettura di Sudano. L’attore intendeva porre la domanda sul significato di essere attore qui e ora, e la
risposta si doveva confrontare con il linguaggio della scena, attraverso il quale l’attore si negava
progressvamente.
2.2. Beckett visto da Adriatico
di Francesco Zamagni
Il titolo del ciclo di spettacoli di Andrea Adriatico, Non io nei giorni felici, è programmatico di una
serie di riletture che il regista italiano ha operato sul grande maestro irlandese. Analizzandolo
emergono immediatamente gli elementi fondamentali della poetica di Adriatico: l’infelicità (il
«non» che nega qualsiasi lieto fine), l’individualità («io») e la quotidianità ( i «giorni»). A
fondamento di questo profondo dolore non sono più dunque l’isolamento e l’incomunicabilità
beckettiane, bensì la dipendenza dall’altro come evoluzione del desiderio. Un rapporto
indubbiamente vissuto come scomodo e infido, essendo necessario all’uomo in quanto essere
sociale, e perché l’individuo, mosso dal desiderio, si lega all’oggetto del desiderio stesso, viene da
questo condizionato e ne diventa subalterno, fino allo schiacciamento ultimo della propria
individualità. E quando questa dimensione diventa quotidiana, ecco subentrare l’infelicità, e, come
per Beckett, si prospetta un’unica via di fuga: la rimozione del desiderio.
Su questo binario si articola dunque la rilettura di Beckett da parte di Adriatico, che individua la
vera natura dell’infelicità umana: non più condizione intrinseca dell’uomo, ma conseguenza dei
rapporti sociali, in special modo di quelli di coppia, che impediscono all’uomo di indagare la
propria individualità.
«Non io»: erosione e ricostruzione.
Il dramaticule Non io, del 1974, nasce in seguito a un’esperienza vissuta da Beckett stesso durante
un suo viaggio in Irlanda: «Conoscevo quella donna in Irlanda… Sapevo chi era: non “lei”
specificamente, una singola donna, ma c’erano così tante di quelle vecchie befane, che andavano
barcollando per i vicoli, nei fossi, oltre le siepi. L’Irlanda ne è piena. E io ho sentito “lei” dire quel
che ho scritto in Non io. L’ho sentito davvero». E proprio come una vecchia decrepita e vagabonda
si descrive la protagonista del dramma, dal nome programmatico di Bocca.
Nell’originale beckettiano, Bocca è esattamente quello che il suo nome suggerisce: una bocca
fluttuante, ultimo residuo di una donna colpita fin dall’infanzia dall’afasia, che ha pregiudicato ogni
suo rapporto sociale fino alla base della comunicazione stessa. Questa incomunicabilità è il suo più
grande dramma, e periodicamente la sofferenza che la sua condizione le causa esplode:
le lunghe sere… ore di buio… improvviso bisogno di… dire… e poi precipitarsi fuori… fermare la
prima persona… al cesso più vicino… cominciare a sputar fuori… fiume continuo… roba da pazzi…
metà delle vocali sbagliate… nessuno riusciva a seguire… finché lei vide come la fissavano… poi
morire di vergogna…
Come quelle «vecchie befane» irlandesi, Bocca è vittima di una forte disparità rispetto agli altri che
quindi la guardano con condiscendenza o pietà, non prestando attenzione alla sofferenza che lei
vive nell’abisso della sua incomunicabilità. E quando finalmente ritrova la capacità di esprimersi, la
parola, repressa così a lungo, esplode ed esonda inarrestabile come un fiume in piena che trascina
con sé tutta la sua vita. Quella a cui assistiamo in effetti può sembrare, sotto certi aspetti, una seduta
psicanalitica fra Bocca (la paziente) e l’anonimo Auditore (l’analista), avvolto da capo a piedi in
una djellabah che ne nasconde l’identità, rendendolo potenzialmente ciascuno di noi, che evidenzia
attraverso alcuni moti di sorpresa sempre più deboli i momenti topici dell’esposizione della
protagonista. E questa inarrestabile confessione di sé da parte di Bocca ricorda quel fenomeno che,
psicanaliticamente, si definisce «abreazione», ossia «una scarica emotiva nella quale il soggetto si
libera dall’attaccamento alla memoria di un evento traumatico in modo tale che il suo attaccamento
non può più diventare (o rimanere) patogeno». Ma cosa succederebbe se l’evento traumatico da
rimuovere fosse un’intera vita? Ecco sopraggiungere allora la negazione di sé, perché in questi
termini la memoria non può essere vissuta in altra maniera se non come un continuo ritorno alla
sofferenza, e il conseguente fenomeno di erosione dell’io è qui talmente potente da diventare
concreto anche sul piano fisico: rimane solo la Bocca, che, dopo anni di inattività, ora racconta
inarrestabile la sua vita al silenzioso Auditore, e con un misto di tormento ed euforia sputa e rigetta i
ricordi del suo passato, spersonalizzandoli proprio perché riviverli come suoi le provocherebbe solo
nuovo dolore. E in questo sta il vero dramma della Bocca di Beckett: non il rivivere i suoi ricordi,
ma il suo tentativo di raccontarli come fossero altrui, che non può portare ad altro che al periodico e
continuo fallimento di questo sforzo («Cosa?... chi?... no!... Lei! LEI!...»), e allora l’unica speranza
resta ogni volta quella di riprovarci, di ricominciare da capo, come nella battuta conclusiva della
piece, «ripartire da lì», in una ciclicità continua e inesorabile come quella dei dannati della Divina
Commedia dantesca, opera molto cara al drammaturgo irlandese.
Pur rispettando fedelmente il testo, si rivela invece molto diversa la Bocca di Adriatico, come pure
il suo intento. Non solo ha una sua corporeità molto concreta, in quanto l’attrice esiste e si muove in
scena, ma la utilizza appieno attraverso diversi espedienti costumistici, scenici e interpretativi:
Innanzitutto il costume. Bocca si presenta inizialmente vestita di una djellabah, proprio in
richiamo dell’originale Auditore, che lascia scoperta solo la bocca, riferimento chiaro alla
versione beckettiana. Ma circa al tredicesimo minuto un filo invisibile, al quale la
protagonista è legata dall’inizio come una marionetta, le sfila di dosso il pesante vestito,
rivelandola come una donna in carne e ossa. In mano porta dei candidi fiori virginali, che
probabilmente si rifanno all’episodio vissuto da bambina, quando vagava «per un campo…
cercando a caso delle primule…».
Altro riferimento a questo episodio ricorrente nel dramma è il palcoscenico circolare,
ricoperto per l’appunto di un prato verde, in cui lei ricorda spesso di essere stata «una
mattina di aprile… con la faccia nell’erba». Non più dunque un palco buio con una sola
Bocca illuminata a mezz’aria insieme al solo Auditore, ma un palcoscenico ben illuminato.
La circolarità permette inoltre una visione dell’attrice stessa a 360 gradi, rivelandone tutta la
corporeità allo spettatore. Senza dimenticare, soprattutto, il sipario circolare largo quanto il
palco, che sarà parte attiva nell’economia del dramma.
Molto diversi dall’originale soprattutto gli espedienti drammatici. Bocca non solo è una
donna in carne e ossa, ma si muove sul palco, seguendo prevalentemente i percorsi
geometrici dei due diametri ortogonali e della circonferenza, che durante il dramma saranno
evidenziati dai petali dei fiori che sfoglierà. È questo probabilmente un richiamo a una regia
televisiva di Beckett, Quad, in cui quattro figure incappucciate camminano all’interno di un
quadrato di luce in maniera regolare. seguendo le diagonali e il perimetro, movimenti che in
questo contesto Adriatico interpreta come una costante ricerca di sé. E proprio questa è la
più grande differenza fra Adriatico e Beckett: l’obiettivo di Bocca non è più la dissoluzione,
la disintegrazione di sé per evitare la sofferenza, bensì la ricerca di sé attraverso proprio la
ricostruzione del suo passato. Ecco allora che la parola, da inarrestabile, nevrotica e
ululante, si fa fievole, misurata, il ritmo rallenta radicalmente, diventa meditativo, come se
ogni ricordo avesse appunto un suo peso, dilatando quasi del quintuplo la lunghezza della
pièce. Tuttavia Adriatico non rinuncia a uno degli elementi più importanti dell’originale,
ovvero la negazione dell’io. L’originale «Chi? No! Lei! LEI!» sopravvive anche in questa
rivisitazione, e l’attrice lo interpreta eseguendolo al di fuori del palco nell’atto di indicare il
palco stesso. È questa sopravvivenza del desiderio di negazione di sé il principale
antagonista di questo processo, invece, di riscoperta di sé; ma non è l’unico deterrente:
anche il sipario, azionato dal secondo invisibile protagonista del dramma (l’Auditore? Dio?),
è un elemento attivo della pièce, e ostacola Bocca proprio nei suoi momenti di maggiore
consapevolezza. È indicativo un episodio in particolare, il momento in cui, alla battuta «si
rese conto che le parole stavano arrivando», il sipario improvvisamente cala a metà altezza,
come a ristabilire in un certo senso l’ordine delle cose, l’intima dipendenza che la lega fin
dall’inizio a questo misterioso “secondo” (si pensi, ad esempio, alla corda legata alla
djellabah).
Sintetizzando, se il fallimento della Bocca beckettiana consiste nella doppia impossibilità di
relazionarsi normalmente con gli altri, uscendo così dalla solitudine, e nel tentativo vano di
raccontare in terza persona la propria storia negando la propria identità, il fallimento di quella di
Adriatico si svolge viceversa nel suo inutile tentativo di autocoscienza, contrastato prima dalla
negazione di sé che permane, poi dalla dipendenza dal misterioso “secondo” che tiene letteralmente
le fila della narrazione e che la mantiene nel suo stato di infelicità. Unico elemento comune fra due
opere sviluppate così diversamente è proprio il fallimento dei loro protagonisti e la loro incapacità
di sfuggire alla sofferenza.
«Atto senza parole»: Senzaparole
Atto senza parole I e II rappresentano il tentativo sicuramente più forte di rinuncia alla parola del
teatro beckettiano. Nel primo in particolare il drammaturgo irlandese esplora le dinamiche del
rapporto di dipendenza di coppia: un uomo apparentemente solo, nel deserto, abbagliato da una luce
accecante e incapace di sfuggire dalla scena, riceve di volta in volta, al suono di un fischietto, vari
oggetti da un’entità misteriosa che si colloca sopra il palcoscenico e che si rivela mossa da ambigue
intenzioni. Se inizialmente pare infatti rispondere alle necessità espresse dalla mimica dell’uomo,
calandogli con una corda una palma per ripararsi dal sole e delle forbici per tagliarsi le unghie, di lì
a poco proprio le foglie della palma si chiudono, lasciando solo un lungo ramo spoglio e l’uomo
sotto il sole cocente. Paradigmatico è l’episodio della brocca d’acqua: calata dall’alto, rimane
sempre presente, ma a un’altezza irraggiungibile per il protagonista, a cui porge in sequenza prima
dei cubi e poi una corda a nodi per tentare di raggiungerla, senza però mai permetterglielo. Discorso
analogo per il suo tentativo di suicidio attraverso i vari oggetti ricevuti, di cui l’entità lo priva
regolarmente. Si verifica qui esattamente quel fenomeno che Segre definiva come schema del
«doppio legame»: nella coppia uno dei due impone all’altro regole contraddittorie per non
consentire vie di fuga. La conseguenza di questo schema è la sostanziale e masochistica rinuncia
dello stesso desiderio iniziale e la completa sottrazione della volontà, nell’illusione che ciò comporti
anche lo scioglimento da questa scomoda dipendenza. Ecco allora che anche l’uomo di Atto senza
parole I si arrende e nulla vale alla misteriosa entità lo sventolargli davanti alla faccia la brocca
d’acqua per riscuoterlo dal torpore a cui si è voluto abbandonare.
Fedele a questo schema del «doppio legame» è anche Adriatico nella sua personale rilettura
dell’opera di Beckett, Senzaparole. Su un palcoscenico buio, in cui 6 riflettori creano a turno 6
quadrati di luce, mette in scena un altro rapporto di coppia, stavolta di uomo e donna, in cui la
donna, col fischietto, invita di volta in volta l’uomo a raggiungerla da un’altra “casa”. Questo
termine, scelto azzeccatamente da Stefano Casi, riassume in sé una doppia valenza:
È la “casa” della scacchiera, ovvero la singola casella. È un richiamo a una teoria di Beckett,
che «sosteneva, e tentava poi di dimostrare, che una volta disposti i pezzi sulla scacchiera,
qualsiasi loro mossa poteva solo indebolire la posizione del giocatore e che la forza
consisteva solo nell’immobilità». Tradotta nel nostro caso, nuovamente, qualsiasi
movimento di desiderio innesca dipendenza, quindi è meglio l’immobilità, che però, qui, per
lungo tempo non accade.
È anche la “casa” domestica, il palcoscenico in cui si svolge ogni vita di coppia e di cui
Adriatico inserisce due degli elementi fondamentali: la quotidianità (rappresentata dai piatti
da cucina che l’uomo di volta in volta apparecchia nelle diverse caselle che attraversa) e la
sessualità (rappresentata dai materassi della parte finale del dramma). Totalmente assente
l’amore, il terzo vertice di questo triangolo, che viene sostituito dalle dinamiche del
fischietto della donna che rompe così la parità del rapporto instaurando la dipendenza.
Nella prima parte, durante l’alternanza tra buio e luce, regolata dal fischietto, l’uomo cerca di volta
in volta di raggiungere la donna nella sua “casa”, per poi scoprire, al ritorno della luce, che nel
frattempo lei si è già spostata, mantenendo vivo il suo desiderio di raggiungerla. Nella seconda,
analogamente, la donna, nuda, invita l’uomo, nudo anche lui, a raggiungerla nel suo materasso, un
po’ come la brocca d’acqua nell’originale beckettiano, per poi alzarsi e spostarsi in un altro. Il
dramma dunque si gioca tutto in questo inseguimento continuo, che trova il suo termine solo
quando l’uomo, ormai estenuato, rinuncia a cambiare materasso e il meccanismo si inceppa. Allora
l’apparizione negli altri letti di altre figure umane nude immerse nella stessa immobilità non fa altro
che potenziare ulteriormente la portata della frustrazione di questo desiderio represso. Anche la
scelta di sovrapporre alla colonna sonora la canzone Give peace a chance scritta da John Lennon e
Yoko Ono dentro un letto matrimoniale non è casuale: il messaggio di armonia, pace e amore
originale qui diventa ironicamente una beffa, una denuncia della sconfitta dell’umanità, che per la
sua incapacità di relazione è naufragata nella deriva in cui viviamo oggi.
«Happy Days»: il corpo e il kitsch
di Lorenza Agostinelli
Beckett compone la tragicommedia Happy Days tra l’ottobre 1960 e il maggio 1961.
All’apertura del sipario la protagonista Winnie dorme conficcata nel terreno dalla vita in giù,
quando, allo squillo stridente della sveglia e alla luce accecante del sole, si sveglia, grata per la
vita vissuta e piena di entusiasmo per i giorni felici che verranno; proprio «un altro giorno
felice» è la frase (da cui il titolo dell’opera) che ripete più volte a se stessa come se dovesse
ricordarselo.
Accanto a lei si trova tutto ciò che le occorre per sopravvivere ancora un altro giorno: la sua
borsetta con i suoi oggetti personali come lo spazzolino da denti, il dentifricio, lo specchietto, la
spazzola, l’ombrellino parasole, mentre dietro a lei, lontano dalla sua vista, spunta il marito,
strisciante come un verme, la cui sola presenza, sia pur silenziosa, garantisce a Winnie il fatto di
non parlare inutilmente e insensatamente da sola. Beckett sintetizza in lei l’essenza della donna
borghese del suo tempo che, pur convincendosi di essere felice, si trova alla fine come il suo
tubetto di dentifricio: «…è quasi alla fine…». Ma Winnie preferisce non cedere al declino della
sua esistenza, preferisce ingannare il tempo che scorre drammaticamente curando la parte del
corpo che è rimasta scoperta, e che nel secondo atto sarà seppellita fino alla testa. Winnie
chiacchiera instancabilmente del niente come se volesse colmare l’arido deserto che le è attorno,
si racconta in una condizione idilliaca e felice piuttosto che infernale.
Nel suo testo L’elisione del corpo in Samuel Beckett, Lorenzo Orlandini individua in Happy
Days l’emblema della dialettica tra l’affermarsi del corpo, che si impone con i suoi istinti e le sue
pulsioni, e lo sforzo teso a sopprimere quella stessa spinta. La scena di apertura dell’opera, che
permane per tutto il primo atto, descritta fin nel dettaglio nelle didascalie, mostra brutalmente il
corpo inabissato in un arido monticello in contrasto con il seno prosperoso chiuso in un corpetto
nero elegante che lascia scoperte le nude spalle. L’immagine iconica della desolazione del corpo
eliso, insieme alla sensualità del busto fiorito è emblema dell’inesauribile dialettica tra il
tentativo di cancellare il corpo e le forze che ad esso si associano, e il continuo riaffermarsi del
corpo stesso (Winnie cerca infatti di controllare e reprimere gli istinti del corpo, in particolare il
desiderio sessuale). La protagonista si è costruita un’immagine di sé integra, composta e ben
educata, anche se, per quel che può sapere lo spettatore, potrebbe anche non avere mai usato la
sua sessualità, dal momento che il dramma inizia che è già seppellita nel monticello. Emergono
tuttavia in più occasioni alcune allusioni, più o meno esplicite, alla sfera erotico-sessuale: ad
esempio, il racconto di Winnie di un topolino che sale su per la gonna della ragazzina Mildred
potrebbe essere considerato una metafora fallica, l’espressione di un disagio con il sesso, lo
sfogo indiretto di desideri e paure.
In un altro passo dell’opera Winnie sembra inorridire alla vista della cartolina pornografica che si
fa passare da Willie, ma allo stesso tempo si può cogliere un suo malcelato interesse: si serve
infatti della lente di ingrandimento per scrutare nel dettaglio la cartolina, cosa che, in realtà,
potrebbe anche alludere sarcasticamente allo scarso vigore sessuale di Willie.
Alla fine del secondo atto Winnie chiede: «È un bacio che vuoi Willie… o è qualcos’altro?»; il
riferimento a ciò che Winnie non può dargli dal momento che è ormai sepolta fin sopra le spalle
è cinico e amaro.
Winnie vorrebbe cancellare i ricordi di quel corpo che un tempo era suo, ma questo sforzo è
inane perché il corpo, seppur sottoterra, continua a farsi sentire anche nei suoi desideri.
Il passo che più riecheggia l’atto sessuale è nel primo atto: Winnie, nell’indicare la strada a
Willie per rientrare nella sua tana, sembra dargli le istruzioni per il suo godimento guidandolo
fino alla soddisfazione finale.
Il marito Willie, d’altro canto, sembra invece godersi liberamente i suoi istinti e le sue pulsioni.
In più di un’occasione fa emergere infatti il suo aspetto più animalesco: l’andatura strisciante e le
sue risposte alla moglie fatte spesso di piccoli versi lo connotano come animale. Inoltre scruta
piacevolmente la cartolina porno, obbedisce alle indicazioni per il rientro nella sua tana e,
quando Winnie gli chiede da che animale siano ricavate le setole del suo spazzolino, le risponde
non a caso: «porco».
È molto interessante come Stefano Casi evidenzi nell’originale beckettiano la costruzione di
Winnie secondo la categoria etico-estetica del kitsch. Citando il concetto di Kitsch-Mensch di
Hermann Broch:
Se il Kitsch è menzogna (esso viene spesso, e a ragione, definito così), questa menzogna ricade su
colui che ne ha bisogno, e cioè su chi si serve di questo specchio destinato a imbellettare e
falsificare le cose per riconoscersi nell’immagine contraffatta che gli rimanda e per assumersi (con
un piacere, entro certi limiti, sincero) la responsabilità delle proprie bugie.
Winnie è essenzialmente il ritratto della donna-Kitsch. Le sue interminabili chiacchiere, la sua
attenzione quasi maniacale per la cura del proprio corpo, i suoi plateali atteggiamenti di ostentata
carineria sono tutti elementi volti, sia pur ingenuamente, ad autoilludersi.
Beckett stesso, già nella didascalia iniziale, dichiara di voler contraffare la scenografia con un
fondale a trompe-l’oeil (effetto di illusione ottica) molto pompier, permeato dai caratteri
dell’artificiosità e della falsità ai quali va aggiunto anche un gusto esagerato e sproporzionato,
congruo con il dramma che deve avere atto. In virtù di questo, come la scenografia, anche la
filosofia di vita di Winnie è inscrivibile nell’etica dell’inganno e dell’auto-inganno.
Winnie sostituisce all’essenza profondamente appagante delle cose, che è il livello etico, la
superficie di un atteggiamento che si accontenta delle piccole cose fino al punto da considerarle
fonte della sua felicità, che è il livello estetico. Si serve dunque della categoria estetica del bello,
del meraviglioso per etichettare le sue esperienze esistenziali fino all’autoriflessività più estrema
e inutile; «Questo è davvero un giorno felice! Questo sarà un altro giorno felice!»: l’insistente
ripetizione del concetto della felicità è proprio la spia del kitsch come arte creativa della felicità.
La sua percezione della realtà risulta così totalmente alterata, tanto da non accorgersi della sua
condizione: preferisce piuttosto far prevalere l’immaginazione sulla realtà, illudendosi e
convincendosi così di essere felice.
L’elemento del kitsch ricorre anche nelle sue continue citazioni di versi banali, che peraltro non
ricorda bene, ma che giudica comunque belli, quindi opportuni: «…com’è più che dicono quei
versi così belli […] ai miei occhi non credo […] vedendo ciò che vedo», o ancora: «…come dice
più quel verso così bello…il cuore ride…coso coso il cuore ride nel tormento e nel dolor…».
Questi classici permettono a Winnie di dilazionare la sua agonia, l’aiutano a passare il giorno.
Secondo Broch la funzione primaria del kitsch è proprio l’essere un passatempo: non potendo
evadere dalla sua condizione di vita (emblema del genere umano) la protagonista non può far
altro che riempire la sua giornata di passatempi («È questo che trovo meraviglioso, una parte
resta, dei classici, ad aiutarci a passare il giorno»).
Ma Winnie non si limita a ricercare nelle sue cose la distrazione futile, giudica infatti le sue
esperienze «meravigliose» proprio perché le ritiene istruttive, cariche di valore. Così anche
l’acquisizione di un oggetto kitsch (come può essere la riproduzione di un quadro famoso) indica
il desiderio di possedere una cosa giudicata bella ma anche importante ed emancipante.
Nonostante l’atteggiamento squisitamente piccolo borghese di Winnie sia sempre lo stesso
dall’inizio del dramma, il suo corpo invece sta palesemente sprofondando; Beckett però non
offre allo spettatore la possibilità di assistere alla sua fine, perché il suo intento è quello di
mettere in scena una beffa o una parodia della catarsi che Adorno legge come il più caratteristico
prodotto del kitsch.
Winnie finisce quindi per rappresentare la borghesia (vera protagonista della commedia) legata
indissolubilmente allo sviluppo e alla diffusione del kitsch, a una religione sentita solo
superficialmente, al rispetto formale delle convenzioni sociali, all’idea dell’amore, ottimista
nell’oggi e nel domani privo di speranza.
Nella regia di Adriatico di Giorni felici la componente corporeo-sessuale dell’opera si fa ancora
più intensa: qui l’ambientazione scenica, formata da una distesa non quantificabile di mele rosse,
è fin da subito una chiara allusione ad un Giardino delle delizie, un’oasi edenica proibita al
genere umano e concessa esclusivamente alla coppia Winnie (il transessuale Eva Robins),
conficcata tra le mele, e Willie, che vi galleggia pacificamente sopra. Entrambi sono nudi a
contatto con l’oggetto del peccato originale, quella mela che è infatti simbolo per eccellenza
della colpa dell’uomo e che lo ha costretto irrimediabilmente alla condizione terrestre.
Se quindi Happy Days per Beckett è la denuncia amara di un mondo che cerca di convincersi di
essere felice circondandosi ed aggrappandosi ai beni materiali e superficiali che gli regalano una
fallace soddisfazione, l’attacco di Adriatico invece non è diretto nello specifico alla società
borghese del Novecento, ma bensì all’intera società di oggi: questa Winnie transessuale è nuda,
scomposta, spettinata e volgare, la sua borsa è un enorme sacco dell’immondizia nero, la
cartolina pornografica è un I-pod. L’accanimento quasi violento del regista sugli oggetti è qui
una vera e propria denuncia dei mali causati dal consumismo del ventunesimo secolo.
«Dondolo»
di Alessandro Perlini
Dondolo è un’altra delle opere di Samuel Beckett proposte da Andrea Adriatico all’interno del suo
ciclo di spettacoli; l’opera originale vede protagonistica una vecchia donna (chiamata
semplicemente Donna), vestita di un elegante abito nero, la quale si lascia cullare meccanicamente e
senza partecipazione da una sedia a dondolo mentre ascolta una voce registrata (nel testo Voce) che,
di volta in volta, ripete sempre le stesse parole come in una cantilena in espansione continua, fino a
sfociare in un finale rifiuto della vita, con un «la vita si fotta» che prefigura un abbandono
dell’esistenza da parte della donna e una riflessione della sua stessa vita nel racconto registrato.
Adriatico riscrive scenicamente il testo proponendo un’attrice seduta, unica voce di tutto lo
spettacolo, senza alcun vestito e posta su una comune sedia ferma posta su un carrello; il diverso
utilizzo delle luci scelto dal regista, che preferisce dei momenti di buio completo tra un passaggio e
l’altro del racconto di Voce, gli permette di avvicinare la donna al pubblico tramite una corda legata
al carrello. Nel testo originale, Donna sembra assorbire quanto viene detto dalla Voce, come a
dipendere dalle sue parole, una dipendenza e un desiderio che sono ribaditi da «Ancora», unica
parola pronunciata dalla Donna, che porta Voce a riprendere il suo racconto; la ripresa del tema
della dipendenza e del desiderio risulta, quindi, evidente come nel rapporto tra Bocca e Auditore in
Non io. Adriatico, nella sua decisione di eliminare la voce registrata, recupera questa dipendenza
nella sola corda che traina la Donna, una entità che la avvicina al pubblico, la tira a sé senza mai
farsi raggiungere, senza portare a una conclusione, come spesso avviene per altri personaggi di
Beckett, i quali pur speranzosi sono inesorabilmente protratti verso il fallimento. In questo modo,
Adriatico riesce a recuperare i temi del testo di Beckett senza sconvolgerli eccessivamente: tuttavia,
l’espediente della corda per ricreare la situazione di dipendenza potrebbe risultare leggermente più
debole della “assenza” di Voce. Adriatico trasforma una dipendenza e un desiderio profondi in una
sorta di strana follia, un rapporto più etereo, come se l’«Ancora», recitato nel buio più completo,
appartenesse a un’altra voce, interessata alle parole della donna sulla sedia e forse da esse
dipendente. E quale potere potrebbe avere questa stessa corda se non quello di mostrare sempre più
da vicino il corpo nudo dell’attrice, come a voler trasferire questa dipendenza nella vergogna di
questo corpo? Una vergogna comunque che risulta slegata dalla vera dipendenza di Donna da Voce.
Bibliografia
Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1975.
Samuel Beckett, Teatro, a cura di Paolo Bertinetti, Torino, Einaudi, 2003.
Samuel Beckett, Teatro completo: drammi, sceneggiature, radiodrammi, pièces televisive, a cura di
Paolo Bertinetti, Einaudi-Gallimard, 1994.
Hermann Broch, Note sul problema del Kitsch, in Id., Il Kitsch, Torino, Einaudi, 1990, pp. 179-180.
Stefano Casi, Beckett-kitsch o i giorni felici di pessimo gusto, in Id. (a cura di), Non io nei giorni
felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio, Corazzano, Titivillus, 2010, pp. 64-73.
Stefano Casi, Il desiderio tra identità e dipendenza. Ipotesi sul teatro di Beckett e di Adriatico, in
Id. (a cura di), Non io nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio, Corazzano,
Titivillus, 2010, pp. 151-169.
Stefano Casi (a cura di), Non io nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio,
Corazzano, Titivillus, 2010.
Keir Elam, Beckett tra scena e testo, ossia quando la parola prende/perde corpo, in Stefano Casi (a
cura di), Non io nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio, Corazzano, Titivillus,
2010, pp. 7- 9.
Martin Esslin, Il teatro dell'assurdo, Roma, Abete, 1975.
Donatella Orecchia e Armando Petrini (a cura di), Materiali per una storia del teatro italiano di
contraddizione. «Aspettando Godot», Teatrostudio, Genova 1964, «L’Asino di B. Quaderni di
ricerca su teatro e altro», a. V ( 2001), n. 5.
Donatella Orecchia e Armando Petrini (a cura di), «Aspettando Godot», Teatrostudio, Genova 1964
- parte seconda, «L’Asino di B. Quaderni di ricerca su teatro e altro», a. VI ( 2002), n. 6.
Lorenzo Orlandini, L’elisione del corpo in Samuel Beckett e la noluntas schopenhaueriana, Tesi di
Dottorato in Anglistica e Americanistica, Università di Firenze, 2009.
Lorenzo Orlandini, La carne visibile, nei secoli dei secoli: il corpo di Winnie in Giorni felici, in
Stefano Casi (a cura di), Non io nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio,
Corazzano, Titivillus, 2010, pp. 35- 49.
Dina Sherzer, Ritratto di donna. L’esperienza della marginalità in Non io, in Stefano Casi (a cura
di), Non io nei giorni felici. Beckett, Adriatico e il teatro del desiderio, Corazzano, Titivillus, 2010,
pp. 74-81.
Videografia on line
Samuel Beckett, Not I, regia di Samuel Beckett: http://www.ubu.com/film/beckett_not.html
Samuel Beckett, Film, regia di Samuel Beckett: http://www.ubu.com/film/beckett_film.html
Samuel Beckett, Quad, regia di Samuel Beckett: http://www.ubu.com/film/beckett_quad.html
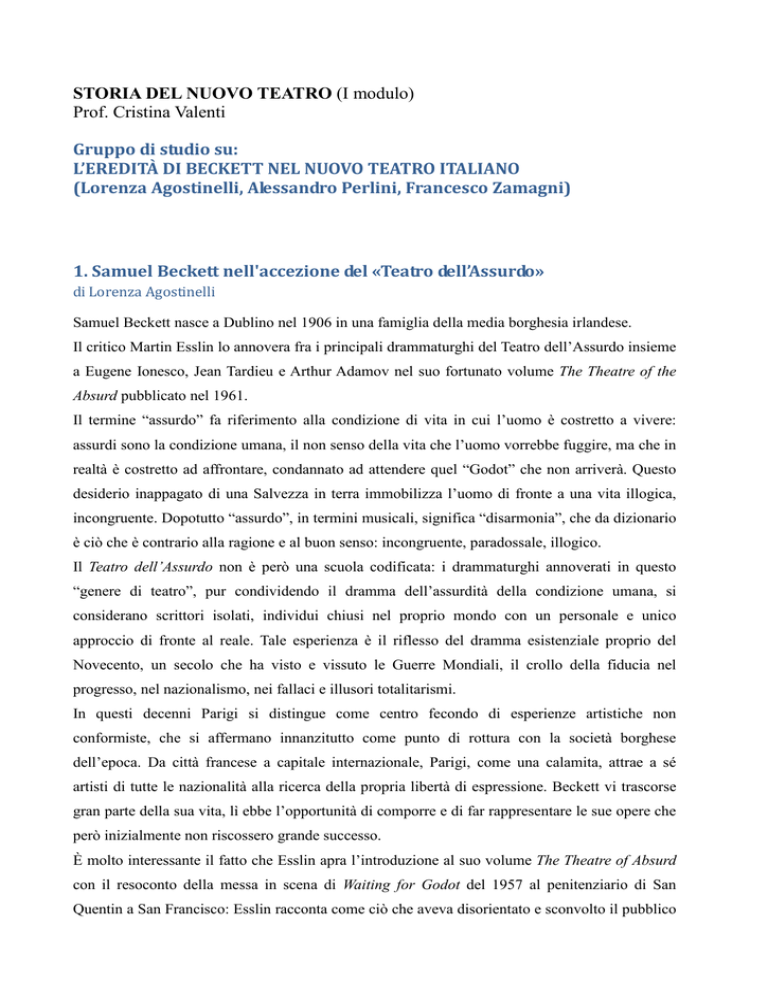
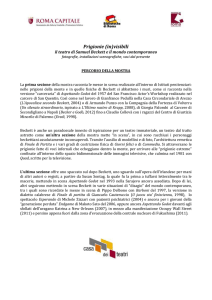

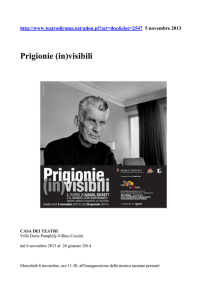
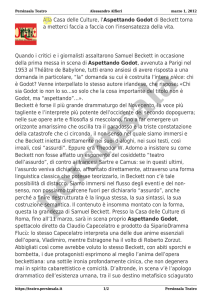
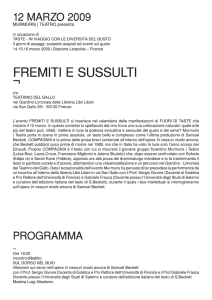


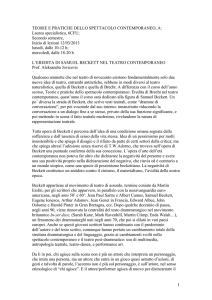
![a place. [that again] Una performance di Motus dedicata a Samuel](http://s1.studylibit.com/store/data/002417554_1-b97a80305b479405430abf4905d880f0-300x300.png)