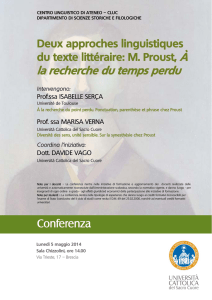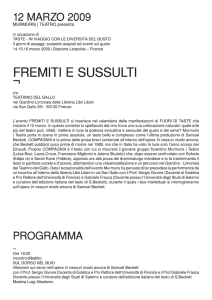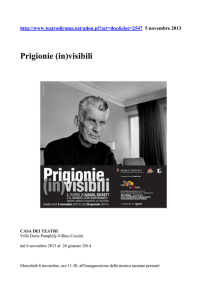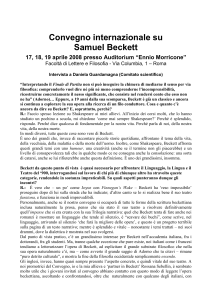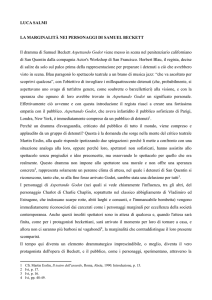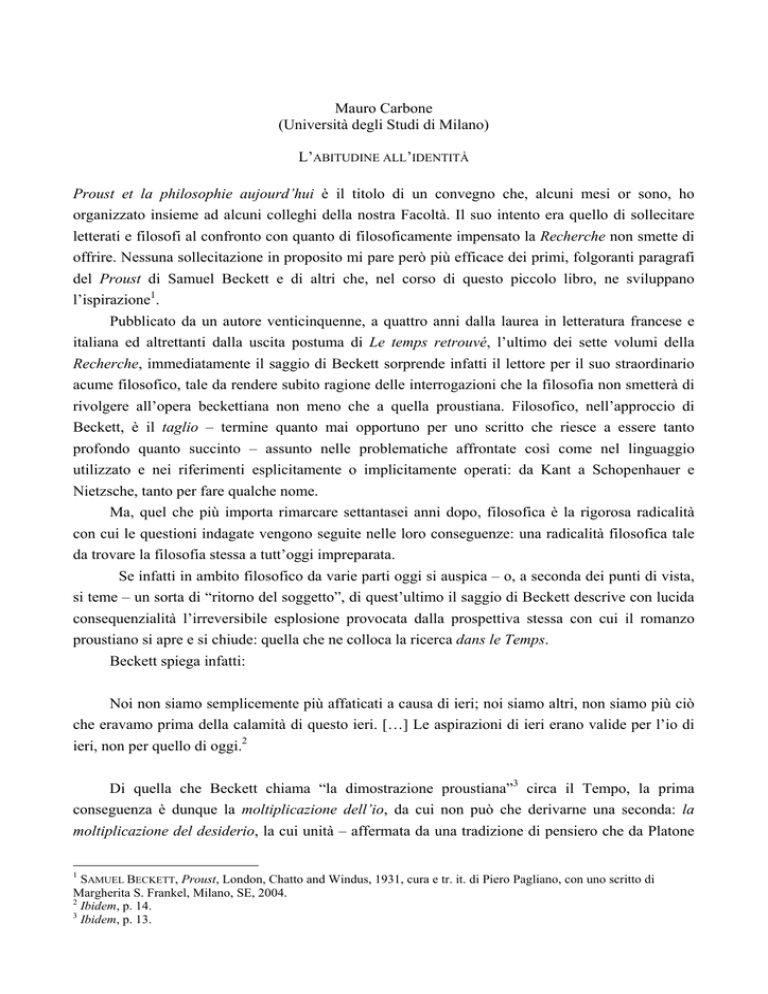
Mauro Carbone
(Università degli Studi di Milano)
L’ABITUDINE ALL’IDENTITÀ
Proust et la philosophie aujourd’hui è il titolo di un convegno che, alcuni mesi or sono, ho
organizzato insieme ad alcuni colleghi della nostra Facoltà. Il suo intento era quello di sollecitare
letterati e filosofi al confronto con quanto di filosoficamente impensato la Recherche non smette di
offrire. Nessuna sollecitazione in proposito mi pare però più efficace dei primi, folgoranti paragrafi
del Proust di Samuel Beckett e di altri che, nel corso di questo piccolo libro, ne sviluppano
l’ispirazione1.
Pubblicato da un autore venticinquenne, a quattro anni dalla laurea in letteratura francese e
italiana ed altrettanti dalla uscita postuma di Le temps retrouvé, l’ultimo dei sette volumi della
Recherche, immediatamente il saggio di Beckett sorprende infatti il lettore per il suo straordinario
acume filosofico, tale da rendere subito ragione delle interrogazioni che la filosofia non smetterà di
rivolgere all’opera beckettiana non meno che a quella proustiana. Filosofico, nell’approccio di
Beckett, è il taglio – termine quanto mai opportuno per uno scritto che riesce a essere tanto
profondo quanto succinto – assunto nelle problematiche affrontate così come nel linguaggio
utilizzato e nei riferimenti esplicitamente o implicitamente operati: da Kant a Schopenhauer e
Nietzsche, tanto per fare qualche nome.
Ma, quel che più importa rimarcare settantasei anni dopo, filosofica è la rigorosa radicalità
con cui le questioni indagate vengono seguite nelle loro conseguenze: una radicalità filosofica tale
da trovare la filosofia stessa a tutt’oggi impreparata.
Se infatti in ambito filosofico da varie parti oggi si auspica – o, a seconda dei punti di vista,
si teme – un sorta di “ritorno del soggetto”, di quest’ultimo il saggio di Beckett descrive con lucida
consequenzialità l’irreversibile esplosione provocata dalla prospettiva stessa con cui il romanzo
proustiano si apre e si chiude: quella che ne colloca la ricerca dans le Temps.
Beckett spiega infatti:
Noi non siamo semplicemente più affaticati a causa di ieri; noi siamo altri, non siamo più ciò
che eravamo prima della calamità di questo ieri. […] Le aspirazioni di ieri erano valide per l’io di
ieri, non per quello di oggi.2
Di quella che Beckett chiama “la dimostrazione proustiana”3 circa il Tempo, la prima
conseguenza è dunque la moltiplicazione dell’io, da cui non può che derivarne una seconda: la
moltiplicazione del desiderio, la cui unità – affermata da una tradizione di pensiero che da Platone
1
SAMUEL BECKETT, Proust, London, Chatto and Windus, 1931, cura e tr. it. di Piero Pagliano, con uno scritto di
Margherita S. Frankel, Milano, SE, 2004.
2
Ibidem, p. 14.
3
Ibidem, p. 13.
arriva alla psicoanalisi – risulta inevitabilmente infranta una volta esplosa quella del soggetto che ne
è animato.
Se infatti, come abbiamo appena sentito, “le aspirazioni di ieri erano valide per l’io di ieri,
non per quello di oggi”, per quest’ultimo – spiega ancora Beckett – ossia
[p]er il soggetto B, essere deluso dalla banalità di un oggetto scelto dal soggetto A [sc.: “l’io
di ieri”] è illogico come aspettarsi che a un tale passi la fame guardando pranzare suo zio.4
Ecco allora queste conseguenze abbattersi su quella stessa tradizione di pensiero, detta anche
“metafisica”, che si rifà a Platone e afferma il valore positivo di quanto permane, qualificandolo
“essere”, nonché il negativo di quanto si trasforma secondo il tempo e il caso, definendolo
“divenire”:
[L]’azione che esso [sc.: il Tempo] esercita sul soggetto […] determina […] un’incessante
modificazione della personalità, la cui realtà permanente, ammesso che ci sia, può soltanto essere
percepita come un’ipotesi retrospettiva.5
E’ proprio in questo passo che l’esplorazione filosofica condotta da Beckett nell’opera di
Proust mi pare trovare la sua formulazione più radicale: “la […] realtà permanente [della
personalità], ammesso che ci sia, può soltanto essere percepita come un’ipotesi retrospettiva”.
Andata in frantumi la pretesa unità dell’ente che il pensiero filosofico moderno aveva posto sotto
tutti gli altri quale loro misura e verità, il sub-jectum, si può ancora ammettere una qualche “realtà
permanente” della personalità umana? E se sì, in che farla consistere? E quale che sia la sua
eventuale consistenza, se quella “realtà permanente” si profila come tale solo retrospettivamente,
come descrivere e che valore riconoscere alla dinamica – del tutto opposta alla legge
dell’irreversibilità temporale – per cui quanto emerso dopo risignifica ciò che lo ha preceduto?
Una delle più riconosciute specialiste italiane dell’opera di Proust, Mariolina Bongiovanni
Bertini, ha scritto che, rispetto a quella proposta da Walter Benjamin due anni prima,
“l’interpretazione di Beckett ci offre una immagine della Recherche più unilaterale ma altrettanto
lontana, nella sua crudele lucidità, dai cliché ancorati alla ‘poesia della memoria’ o alla ‘mistica
dell’arte’. […] Gli stessi momenti privilegiati della memoria involontaria vi sono descritti senza gli
accenti melensi e trionfalistici che contraddistinguono buona parte della critica proustiana sino alle
soglie degli anni ’60”6.
Ciò è senz’altro vero anche per quanto riguarda il côté filosofico di tale critica: occorrerà
aspettare gli anni Sessanta per vedere finalmente messe a tema le questioni sollevate da Beckett che
prima elencavo. Possiamo incontrarle, assunte con crescente consapevolezza, nelle due edizioni del
libro su Proust che Gilles Deleuze, di Beckett lettore attento e consonante, pubblica rispettivamente
4
Ibidem, p. 15.
Ibidem.
6
MARIOLINA BONGIOVANNI BERTINI, Guida a Proust, Milano, Mondadori 1981, pp. 395-396.
5
nel 1964 e nel 19707. Ma ciò detto, occorre ribadire che in quelle questioni la filosofia si sta ancora
oggi dibattendo. E ovviamente non solo rispetto all’interpretazione dell’opera proustiana.
Forse uno dei più radicali tentativi operati da parte filosofica per consuonare con tali
questioni è quello concentrato nelle righe con cui, nel 1980, si apre Mille piani, il secondo volume
scritto da Deleuze insieme con Félix Guattari:
Abbiamo scritto L’anti-Edipo in due. Poiché ciascuno di noi era parecchi, si trattava
già di molta gente. […] Perché abbiamo conservato i nostri nomi? Per abitudine, unicamente per
abitudine. Per renderci a nostra volta irriconoscibili.8
Ecco dunque, riecheggiando Proust e Beckett, l’abitudine trovarsi opposta all’incessante
modificarsi, allo scoprirsi dividuo dell’individuo, termine che sappiamo significare, spavaldamente,
“indivisibile”. Alla questione se si possa ancora ammettere una qualche “realtà permanente” della
personalità umana, il saggio di Beckett su Proust suggerisce infatti di cercare risposta indagando
quanto nella Recherche si trova descritto appunto alla voce “abitudine”. Non l’essere, insomma, ma
proprio l’abitudine sembra a Beckett garantire alla personalità umana una qualche “realtà
permanente”:
Abitudine è allora il termine generico per indicare gli innumerevoli accordi conclusi tra gli
innumerevoli soggetti che costituiscono l’individuo e gli innumerevoli oggetti a loro correlati.9
Più in generale, Beckett suggerisce che la nostra stessa (presunta) identità, a rigore, non sia
se non un’abitudine dalla quale ciascuno di noi viene rassicurato, svegliandosi, “che la sua
personalità non si è dissolta insieme con la sua stanchezza”.10 Se insomma la nostra “realtà
permanente, ammesso che ci sia, può soltanto essere percepita come un’ipotesi retrospettiva” – così
lo abbiamo sentito avvertirci – ciò accade in quanto la nostra identità, sempre ricercata in quanto
sempre evocata, risulta sempre trovata dall’abitudine quando già siamo mutati e divenuti “altro”.
Certo, quell’identità è ora riconoscibile, ma se nel frattempo, appunto, siamo mutati e divenuti
“altro”, possiamo ammettere davvero che una nostra “realtà permanente” ci sia? E’ la vertigine di
questa domanda che Beckett ha scorto nella Recherche e mai più dimenticato: il soggetto è sempre
al passato, un effetto, un risultato, proustianamente ritrovato come perduto. Per questo l’abitudine
all’identità ci rende, nel bene o nel male, irriconoscibili.
7
GILLES DELEUZE, Marcel Proust et les signes, Paris, P.U.F., 1964, éd. augmentée, Proust et les signes, 1970, 1976, tr.
it. di C. Lusignoli e D. De Agostini, Marcel Proust e i segni, Torino, Einaudi, 1967, ed. aumentata 1986 e 2001.
8
GILLES DELEUZE, FÉLIX GUATTARI, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit, 1980, tr. it. di G.
Passerone, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1987, 2 voll., poi Roma,
Castelvecchi, 1996 (in 4 sezioni), 20032 (in volume unico), p. 35.
9
BECKETT, Proust, tr. it. cit., p. 18.
10
Ibidem, p. 26.
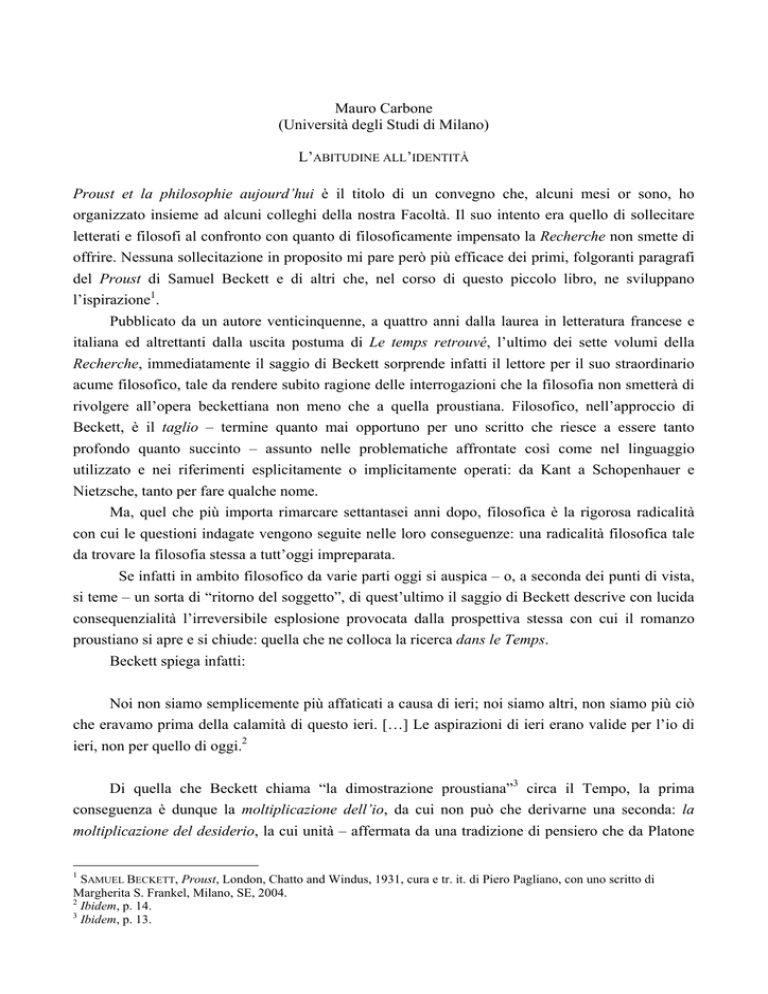

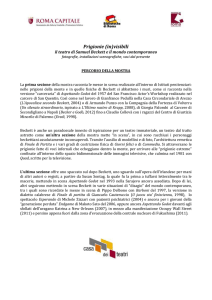
![a place. [that again] Una performance di Motus dedicata a Samuel](http://s1.studylibit.com/store/data/002417554_1-b97a80305b479405430abf4905d880f0-300x300.png)