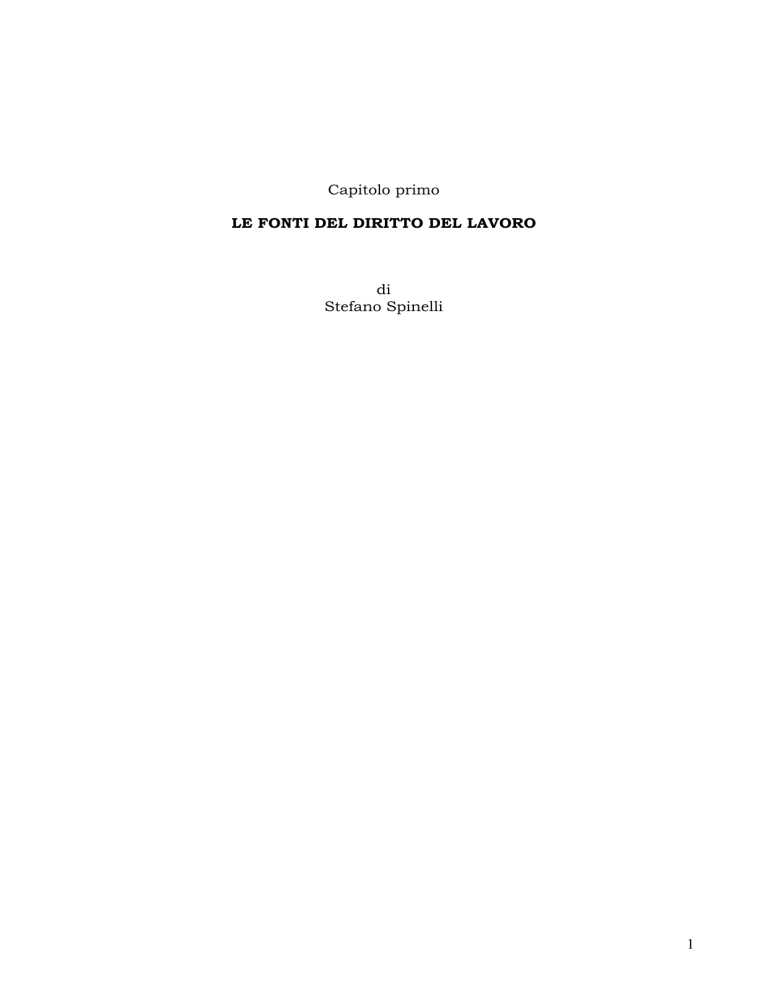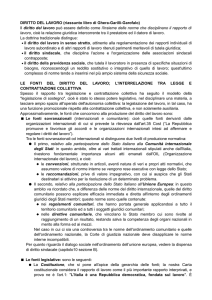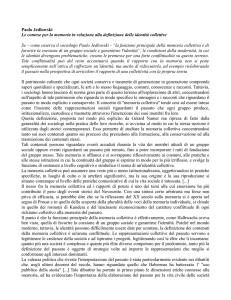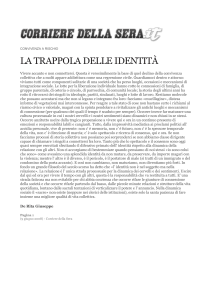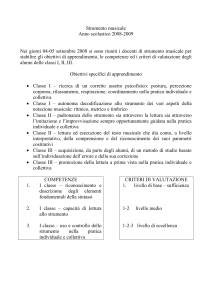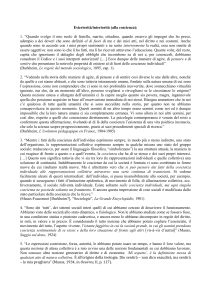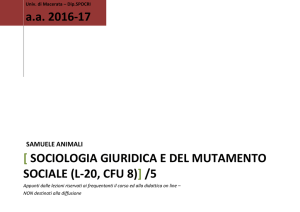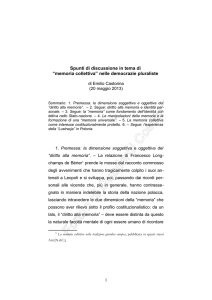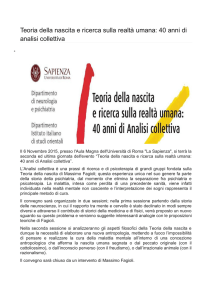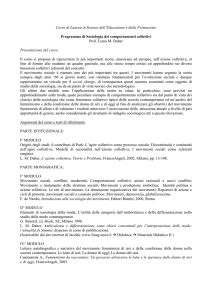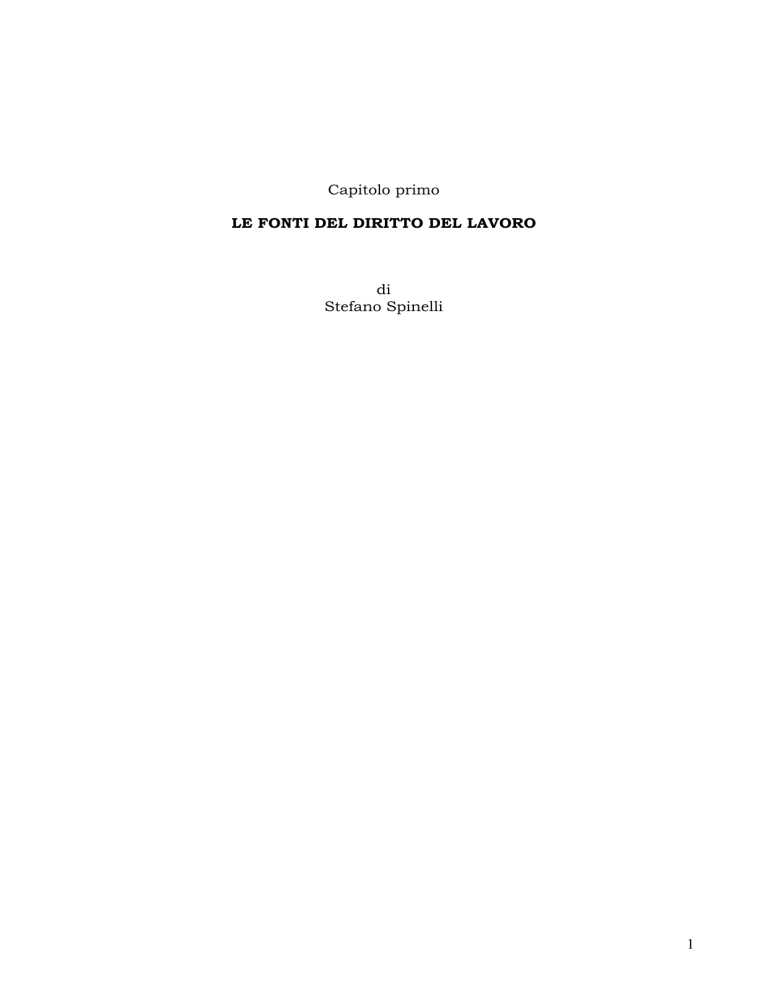
Capitolo primo
LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
di
Stefano Spinelli
1
CAPITOLO I
Le fonti del diritto del lavoro
Sommario 1. Premessa: pluralità ed eterogeneità delle fonti di diritto del lavoro; 1.1. Incompletezza dell’art. 1 disp. prel. c.c.: fonti tipiche e fonti
“extra ordinem”; 2. Fonti tipiche: la fonte statuale non codificata; 2.1. Produzioni “base” di fonte statuale; 2.2. Produzioni “aggiuntive” di fonte
statuale; 2.2.1. Diverse “fasi” di produzione del diritto del lavoro; 2.3. La “nuova” fonte regionale in materia di lavoro; 3. La giurisprudenza: fonte
“atipica” di diritto del lavoro?; 4. Fonti internazionali e comunitarie: rinvio; 5. Fonti eteronome ed autonome: la fonte collettiva; 5.1. La fonte
collettiva nel diritto del lavoro pubblico; 5.2. Produzioni di fonte collettiva; 5.3. Diversi “livelli” e “categorie” di fonte collettiva; 5.3.1.
L’“individuazione” della fonte collettiva: il criterio di libertà di scelta; 5.3.2. La “gerarchia” tra fonti collettive: il criterio di prossimità; 5.3.3. La
“successione” tra fonti collettive: il criterio di ultrattività convenzionale; 5.4. Gli “usi aziendali”; 6. I rapporti fra le fonti del diritto del lavoro.
Legislazione Cost. 4, 10, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80, 87, 117 – l. cost. 18.10.2001, n. 3 – disp. prel. c.c. 1, 8 – c.c. 1321, 1340, 1372, 1374, 2069,
2070, 2074, 2077, 2078, 2099, 2113 – d.lg.luog. 23.11.1944, n. 369; d.p.r. 10.01.1957, n. 3; l. 20.05.1970, 300 (Statuto dei lavoratori); d.lg.
03.02.1993, n. 29; d.lg. 31.03.1998, n. 80; d.lg. 30.03.2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego); l . 14.02.2003, n. 30 (legge “Biagi”); d.lg.
10.09.2003, n. 276, modificato dal d.lg. 06.10.2004, n. 251; art. 189, Trattato di Roma 25.03.1957, ed ora art. 249 nella versione cd. “consolidata”,
Trattato di Amsterdam 02.10.1997.
Bibliografia Pera 1961 – Santoro Passarelli 1973 – Mortati 1975 – Amato-Barbera 1986 – Mazzoni 1988 – Pera 1990 – Nicolini 1996 – Galantino
1997 – Biagi 2003 – Ichino 2003 – Chieppa 2006 – Corso-Lopilato 2006 – Scognamiglio 2006 – Cester-Miscione-Zoli 2007 – Nogler 2007 –
Carinci 2007.
1. Premessa: pluralità ed eterogeneità delle fonti di diritto del lavoro.
Parlando di “fonti” del diritto del lavoro, ci si riferisce ai diversi modi attraverso i quali il
diritto del lavoro ottiene una sua propria autonoma configurazione, non fotografata in un preciso
momento, bensì considerata nel suo divenire e rinnovarsi.
Ciò che viene in luce, quando si parla di fonti del diritto, non è tanto la regolamentazione in
concreto della materia, quanto la potenzialità produttiva da cui scaturisce la suddetta
regolamentazione.
Si tratta, in sostanza, di stabilire “che cosa un dato ordinamento qualifica come diritto e
quali sono i fatti che, alla stregua di quell’ordinamento, sono reputati idonei a costituirlo” (Amato Barbera 1986, 119).
E’ stato efficacemente detto che la “fonte” e il “diritto” si trovano tra loro nel rapporto di
“producente” e di “prodotto”, “analogo a quello che sussiste tra la sorgente e l’acqua che da essa
sgorga” (Mortati 1975, I, 300).
Possono pertanto distinguersi – in conformità di quanto assunto nella prospettiva della teoria
generale del diritto – due significati alla locuzione “fonti del diritto del lavoro”.
Il primo può essere individuato in ciò che l’ordinamento giuridico considera valida fonte
idonea a produrre una valida disciplina regolamentante il rapporto di lavoro; il secondo, consiste
2
nell’insieme di queste discipline (i singoli fatti o atti costitutivi del diritto del lavoro) e quindi in ciò
attraverso cui il diritto del lavoro si sviluppa e si modifica nel corso del tempo.
« Possono pertanto distinguersi due categorie di fonti: la prima comprende le fonti sulla produzione,
determinative di ciò che deve considerarsi valido fattore di disciplina normativa di situazioni concrete, e che si concreta
o in fatti materiali o in atti volontari; la seconda, riguardante le fonti di produzione, racchiude l’insieme di tali
discipline »
(Mortati 1975, I, 300)
La distinzione richiamata serve a porre in rilievo la diversa funzione della fonti sulla
produzione rispetto alle fonti di produzione: che è “organizzativa-strumentale” nelle prime, e
“materiale” nelle seconde, così definita in quanto “regolatrice del contenuto dei rapporti fra i
soggetti diversi”.
Ciò premesso, va evidenziata la peculiarità dello studio delle fonti in ambito laburistico, in
ragione di una evidenziata “specialità” del diritto del lavoro, sviluppatosi storicamente alla stregua
di un ramo autonomo dell’ordinamento giuridico; e ciò, per la semplice considerazione garantistica
che il rapporto di lavoro non si esprime su un terreno di parità contrattuale ed abbisogna quindi di
“correttivi” rispetto agli analoghi istituti di diritto comune (si parla, in tal senso, di “legislazione
speciale” in materia di lavoro).
Un esempio classico, che incide peraltro sul rapporto tra fonti, è il cd. principio generale del
favor lavoratoris, che nella regolamentazione concreta del rapporto di lavoro assegna un valore
tendenzialmente preminente alla disposizione più favorevole al lavoratore; sia in deroga alla
gerarchia formale delle fonti, come nel caso dell’uso più favorevole al lavoratore che prevale di
fronte ad una norma di rango superiore quale è la legge (pur con efficacia dispositiva, posto che
l’uso rimane derogabile dalla autonomia negoziale), ai sensi dell’art. 2078, 1° co., c.c., a dispetto di
quanto previsto in generale dall’art. 8, 1° co., disp. prel. c.c.; sia in deroga all’autonomia
contrattuale privata, che non può spingersi sino a derogare in pejus le norme contrattuali collettive e
di legge inderogabili, bensì solo per ottenere condizioni più favorevoli alla parte più debole del
rapporto (art. 2077 c.c.).
La ragione della suddetta specialità sta “nell’implicazione della persona del lavoratore nel
lavoro prestato ad altri”.
« La persona del lavoratore è implicata nell’attività prestata ad altri sia per la subordinazione del lavoratore
all’imprenditore e la sua immissione nell’impresa, sia per la dipendenza della vita del lavoratore e della sua famiglia
dalla retribuzione,che è il suo solo mezzo di sostentamento. Tutto il diritto del lavoro è ordinato caratteristicamente a
questo fine, alla tutela della libertà, anzi della stessa personalità umana del lavoratore, legato da un vincolo, che, fra tutti
i vincoli di contenuto patrimoniale, è il solo a porre, sia pure per necessità istituzionale, un soggetto alle dipendenze di
un altro soggetto. Quella tutela segna il limite del rispetto dell’interesse dell’imprenditore. A realizzarla non bastano i
comuni presìdi del diritto privato, informati al concetto dell’eguaglianza dei singoli, che qui non trova corrispondenza
nella realtà economica e sociale, ma soccorrono istituti peculiari, senza applicazione né riscontro per nessuno degli altri
rapporti patrimoniali, ed occorrono anche i presìdi di diritto pubblico ».
(Santoro Passarelli 1973, 13-14)
3
Ne consegue che anche la teoria generale delle fonti del diritto non appare del tutto
sovrapponibile al diritto del lavoro, venendo qui in rilievo fatti o atti disciplinanti peculiari rispetto
a quelli generali.
In particolare, occorre evidenziare come le regole preposte alla disciplina dei rapporti di
lavoro siano il frutto di una “complessa interazione tra norme statuali, principi giurisprudenziali e
accordi tra gruppi sociali organizzati e contrapposti dei datori di lavoro e dei lavoratori (i contratti
collettivi)” (Biagi 2003, 5).
Tra i fattori di complessità dell’attuale diritto del lavoro (oltre alla dimensione che ha
assunto nel tempo ed in maniera un po’ incoerente la legislazione lavoristica, che ha fatto perdere
centralità all’unica fonte originariamente rappresentata dal codice civile) vi è sicuramente anche il
fenomeno della pluralità ed eterogeneità delle stesse fonti, alcune delle quali (come le pronunce
giurisprudenziali cd. “creative” o il dinamismo conflittuale dell’autonomia collettiva) sono definite
“atipiche” o extra ordinem, proprio in considerazione del fatto che non possono essere considerate
propriamente tali alla luce del diritto positivo e della teoria generale delle fonti.
« In altre parole, il dinamismo del diritto del lavoro non attiene soltanto alla continua evoluzione dei suoi
contenuti, ma concerne anche la mutevole interazione e il diverso atteggiarsi dei rapporti fra le sue fonti e/o formanti,
dai quali è altresì in buona misura causato. Nel corso dei decenni tale dinamismo di è ulteriormente accentuato ».
(Cester, Miscione, Zoli 2007, 3)
La teoria delle fonti del diritto del lavoro è spesso caratterizzata dall’osservazione del
mutamento del bilanciamento delle medesime fonti, dovuto al loro diverso rapportarsi in relazione
ai singoli mutamenti di politica economico-sociale perseguiti (per esempio, da una storica
legislazione statuale “centralistica” si è passati più di recente ad una legislazione di “rinvio”
all’autonomia collettiva, in particolare mediante il percorso legislativo che va sotto il nome di
“legge Biagi”, costituito dalla l. 14.02.2003, n. 30 e dal d.lg. 10.09.2003, n. 276, modificato dal
d.lg. 06.10.2004, n. 251; con una recente novità introdotta dalla legge cost. 18.10.2001, n. 3, che ha
modificato il Titolo V della Costituzione, dando spazio all’ampliamento di competenze legislative
regionali in materia lavoristica, seppure in quadro ancora abbastanza impreciso ed incerto).
1.1. Incompletezza dell’art. 1 disp. prel. c.c.: fonti tipiche e fonti “extra ordinem”.
Quindi, sotto un primo aspetto (cosa debba riconoscersi per valido fattore disciplinante), le
fonti del diritto del lavoro sogliono distinguersi tra “tipiche” ed “atipiche”.
Dal punto di vista della teoria generale delle fonti, come noto, l’art. 1 disp. prel. c.c. indica
quali fonti (tipiche) del diritto dell’ordinamento giuridico italiano “1) la legge; 2) i regolamenti; 3)
le norme corporative; 4) gli usi”.
4
Deve peraltro tenersi presente, in primo luogo, che la soppressione dell’ordinamento
corporativo, disposto dal d.lg. luog. 23.11.1944, n. 369, ha in sostanza fatto perdere di efficacia alla
fonte di cui al n. 3 dell’elenco (salvo quanto si dirà successivamente sulla fonte collettiva atipica).
In secondo luogo, l’avvento della carta costituzionale ha profondamente inciso sul sistema
delle fonti in generale, sia dal punto di vista dei rapporti tra le stesse (e specie della mutata
gerarchia tra le fonti, con subordinazione della legge a principi generali dell’ordinamento ed a fonti
superprimarie); sia con riguardo alla nuova tipologie delle fonti riconosciute dall’ordinamento (con
riguardo per esempio alle autonomie territoriali produttive di diritto oppure alla definizione di altri
atti aventi forza di legge).
Ora, l’analisi delle fonti del diritto del lavoro può ritenersi sovrapponibile al predetto
schema generale.
Tale classificazione, però, risulta del tutto insufficiente a rappresentare l’attuale complessità
degli atti e dei fatti produttivi di diritto in materia lavoristica. Questi ultimi si presentano infatti
molto più variegati e non riconducibili esclusivamente all’ordinamento giuridico statuale.
Vengono qui in considerazione, per esempio, non solo un livello regionale di fonti
dell’ordinamento giuridico (a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione); ma altresì un
livello di autonomia riguardante le stesse parti private, sia pur collettive, comunque produttive di
disciplina del rapporto lavorativo pur attraverso accordi di diritto comune, in modo quindi del tutto
“atipico” e non riconducibile ad una accezione tecnica di fonte del diritto.
Peraltro, pur non potendosi inquadrare neppure la giurisprudenza tra le fonti del diritto – in
senso tecnico – e pur essendo considerata, da alcuni, anch’essa fonte “atipica”, non può non
sottolinearsi, nella materia lavoristica, il compito determinante svolto da quest’ultima: sia dalla
giurisprudenza di costituzionalità (con l’adozione, per esempio, di sentenze interpretative di rigetto,
che indirettamente offrono il vero significato da attribuirsi alla norma di legge oggetto di sindacato;
oppure di sentenze additive, che aggiungono indirettamente contenuto normativo alla norma,
dichiarando l’incostituzionalità della stessa nella parte in cui non dice qualcosa); sia dalla
giurisprudenza di legittimità, spesso operante in funzione (più che interpretativa) “creativa” di
diritto.
A ciò va aggiunta l’importanza sempre crescente delle fonti internazionali e soprattutto
comunitarie, in relazione all’evoluzione quali-quantitativa della comunità europea ed alla sempre
maggior incidenza (anche di efficacia giuridica) delle determinazioni comunitarie nell’ambito dei
singoli Stati membri. Ne discende che il diritto del lavoro viene in qualche modo “condizionato” da
questa compartecipazione alla comunità europea e dagli indirizzi programmatici ivi assunti (si pensi
alle questioni inerenti all’età lavorativa ed alla cd. flessibilità del mercato del lavoro).
5
Per tutti questi motivi, l’analisi delle fonti del diritto in materia lavoristica deve ritenersi
caratterizzata da forte peculiarità, rispetto alla teoria generale delle fonti.
2. Fonti tipiche: la fonte statuale non codificata.
Non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, un “codice di diritto del lavoro” (Mazzoni
1988, 161-162), ossia un testo organico di codificazione di tutta la normativa attinente al rapporto di
lavoro (una sorta di codex juris giustinianeo).
Esistono – è vero – codici che riuniscono – allineandole una di seguito all’altra – le
numerose e poco coordinate leggi stratificatesi nel tempo, caratterizzate da disorganicità e
difficilmente riconducibili ad un unico disegno sistematico, essendo invece volte per lo più –
ciascuna – a dare specifica soluzione alle diverse emergenze proposte dal mercato del lavoro (e
procedendo, spesso, in direzioni contrapposte).
E’ stata sottolineata, da più parti, l’ipertrofia della legislazione lavoristica del secondo
dopoguerra, che ha determinato la perdita dell’assetto normativo originariamente incentrato sul
codice civile. Per tale ragione, ci si interroga oggi anche sulla opportunità di una nuova opera
codificatrice che superi la disarmonia dei singoli interventi normativi riconducendoli ad unitarietà
(il già citato Libro Bianco del 2001 propone uno Statuto dei lavori, volto a superare la stessa
contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, mediante la ridefinizione degli assetti
complessivi di tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni).
Per contro, il rapporto di lavoro pubblico – anche sotto tale aspetto, come in materia di
efficacia della fonte collettiva, su cui infra – si discosta dal trend generale frammentato del diritto
del lavoro privato, in quanto (dopo essere stato regolamentato dal t.u. sugli impiegati civili dello
Stato, di cui al d.p.r. 10.01.1957, n. 3), ora, a seguito della disposta privatizzazione del rapporto di
pubblico impiego, è stato regolamentato ex novo, con uno sforzo codificatorio non indifferente,
passato dal d.lg. 03.02.1993, n. 29, attraverso il d.lg. 31.03.1998, n. 80, ed infine codificato nel t.u.
delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
di cui al d.lg. 30.03.2001, n. 165, una sorta di nuovo Statuto del lavoro pubblico.
2.1. Produzioni “base” di fonte statuale.
Per quanto riguarda il lavoro privato, invece, esiste un “nucleo base” normativo, costituito
da una duplice fonte, di cui la prima, cronologicamente anteriore (codice civile), è però
gerarchicamente subordinata alla seconda (costituzione) e ciò ha determinato qualche – anche non
lieve – disconnessione interna al sistema.
6
a) In primo luogo, viene in rilievo il Libro V del codice civile del 1942, espressamente
dedicato al lavoro e contenente: al Titolo I, la disciplina delle attività professionali e degli accordi e
contratti collettivi (come visto, secondo una visione corporativa dei rapporti di lavoro, il cui sistema
peraltro è stato pressoché contestualmente soppresso); al Titolo II, la disciplina del rapporto di
lavoro subordinato nell’impresa, con una chiara definizione del datore di lavoro-imprenditore (art.
2088 c.c.), del prestatore di lavoro quale collaboratore dell’imprenditore (art. 2094 c.c.) e dei
corrispondenti e reciproci diritti ed obblighi (artt. 2099-2113 c.c.), e con un abbozzo di
regolamentazione del rapporto nelle sue linee essenziali, ossia costituzione (artt. 2096-2098 c.c.),
profili previdenziali e assistenziali (artt. 2114-2117 c.c.), estinzione (artt. 2118-2125 c.c.), oppure
con la trattazione di fattispecie particolari come la prestazione di fatto in violazione di legge (art.
2126 c.c.), il divieto di interposizione (art. 2127 c.c., materia oggetto altresì di apposita legislazione
ad hoc, la l. 1369/1960, ed ora completamente riscritta, dalla l. 30/2003 e dal d.lg. 276/2003), il
lavoro a domicilio (art. 2128 c.c., anch’esso oggetto di regolamentazione ad hoc, la l. 877/1973), o
ancora il lavoro presso gli enti pubblici (art. 2129 c.c., materia integralmente riformulata dal d. lg.
165/2001) ed il cd. tirocinio (artt. 2130-2134 c.c., ora definito apprendistato e regolamentato da
ultimo dal d.lg. 276/2003); il Libro V si occupa poi del lavoro agricolo, del lavoro autonomo al
Titolo III e di quello domestico al Titolo IV.
b) Eppure può dirsi che il vero “incipit e la fonte principale del nuovo diritto del lavoro”
siano contenuti nei principi formulati dalla carta costituzionale del 1948 (Scognamiglio 2006, § 4).
Pur avendo natura in gran parte “programmatica” e costituendo fonte di ispirazione e di
direzione per le altre fonti statuali, le norme costituzionali disegnano, a monte, un nuovo diritto del
lavoro che chiede (tuttora) di essere attuato secondo gli affermati principi.
La filosofia costituzionale che sottostà alle norme in materia di lavoro può essere ricondotta
al principio “personalistico”, secondo il quale
« componente fondamentale dell’attività economica è quella costituita dal fattore umano quale si estrinseca nel
lavoro subordinato. La posizione di subordinazione dei lavoratori importa che lo stato, per assolvere gli obblighi
espressi nei termini più generali dal 2° co. dell’art. 3, rivolga le proprie cure in due direzioni: per assicurare, da una
parte, la libertà dei lavoratori, dall’altra per correggerne, con una serie di misure di particolare protezione, le condizioni
di inferiorità in cui si trovano ».
(Mortati 1976, II, 1130-1131).
Così, ad esempio, l’art. 4 Cost. da una parte sancisce il principio che riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro, con correlativo impegno della repubblica a promuovere tutte le
condizioni per renderlo effettivo (diritto cd. sociale, dal quale non è ricavabile alcuna situazione
giuridica soggettiva all’ottenimento di un posto di lavoro, Corte cost. 45/1965; né un diritto al
mantenimento del posto di lavoro, Corte cost. 9/1973; ma al quale viene assegnata funzione di
7
criterio generale ed interpretativo anche delle altre clausole generali della costituzione); dall’altro,
sancisce la pretesa alla libera scelta del lavoro secondo le proprie possibilità (diritto cd. di libertà).
Gli artt. da 35 a 38 dettano le linee essenziali della nuova disciplina del lavoro, tutelato “in
tutte le sue forme ed applicazioni” (il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ad una
durata massima della giornata lavorativa, al riposo settimanale ed alle ferie retribuite; la tutela del
lavoro delle donne e dei minori; il diritto alla previdenza ed all’assistenza sociale).
La libertà di organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero sono oggetto degli artt. 39
(inattuato) e 40 (dei quali si parlerà in tema di fonti collettive).
La legislazione speciale che ne è seguita non rappresenta altro che lo strumento per
l’attuazione di questo “nuovo” programma di promozione e tutela del lavoro, da considerarsi
assieme al vaglio di costituzionalità, anche additivo e/o interpretativo, esercitato dalla corte
costituzionale sulla normazione del lavoro via via assunta, la quale – spesso – vige attualmente
proprio nella formulazione derivata e desumibile dall’esercitato sindacato di costituzionalità.
« L’erosione della centralità dell’impianto del codice civile da parte della carta costituzionale è dunque dipesa
– principalmente – dalla legislazione che ad essa ha fatto seguito, per dare attuazione al dettato costituzionale, che ha
largamente modificato il quadro del diritto del lavoro ».
(Biagi 2003, 22).
Peraltro, va anche ricordato che l’impianto “base” del diritto del lavoro (e non solo quello
codici stico, ma anche quello programmatico costituzionale) risultava collegato – per il suo
funzionamento e completamento – alla contrattazione collettiva obbligatoria con efficacia generale.
La produzione statuale successiva ha dovuto quindi “correggere” questo vulnus originario
del sistema, mediante un processo – a livello centralizzato – di permanente produzione
decodificante riguardante anche aspetti già contenuti nel codice.
2.2. Produzioni “aggiuntive” di fonte statuale.
Ne consegue che, attorno al citato nucleo normativo costitutivo del diritto del lavoro, si è
“aggiunta” tutta una produzione normativa speciale, assai frammentata e disomogenea, pur nel
solco dei principi programmatici costituzionali.
L’esempio più emblematico di questa normativa successiva è rappresentato dal cd. Statuto
dei lavoratori, di cui alla l. 300/1970, che dalla denominazione rappresenterebbe una specie di
tentativo di organizzare in qualche modo organicamente la materia lavoristica, ma che all’atto
pratico introduce e disciplina alcuni aspetti salienti del rapporto di lavoro.
Esso introduce: una tutela garantistica di libertà, di riservatezza, di dignità, di salute ed
integrità fisica dei lavoratori sul luogo di lavoro (artt. 1-6, 8 e 9); la fissazione di limiti rigorosi
all’esercizio del potere datoriale di irrogazione di sanzioni disciplinari (art. 7) nonché del potere di
8
mutamento delle mansioni e di trasferimento (art. 13); l’introduzione, nei confronti degli
imprenditori con un maggior numero di dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato, del
nuovo regime della tutela reale, consistente nella reintegrazione ex tunc del prestatore nel posto di
lavoro e nella corresponsione di un indennizzo (art. 18), così completando – in senso più rigoroso
per i casi ivi previsti – la disciplina generale sui licenziamenti, già stabilita con la l. 604/1966, che,
per prima, sopprime la regola della libera recedibilità con preavviso dal rapporto di lavoro ed
introduce il principio della giustificatezza del licenziamento individuale, con conseguente tutela
obbligatoria e previsione del pagamento di una indennità compresa tra un minimo ed un massimo;
e, soprattutto, la previsione di istituti e diritti volti a rafforzare l’attività sindacale degli organismi
rappresentativi dei lavoratori (artt. 19-27), attribuendo ai sindacati un rimedio processuale ad hoc
per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28); pur continuando però
ad omettere l’attuazione della previsione costituzionale riguardante la registrazione delle
associazioni sindacali in grado di stipulare contratti collettivi ad efficacia obbligatoria.
2.2.1. Diverse “fasi” di produzione del diritto del lavoro.
Peraltro, per tale normativa “aggiuntiva” si distinguono, storicamente, diverse fasi di distinta
caratterizzazione, dal punto di vista contenutistico, della produzione.
Si distingue, in genere, tra un periodo costituzionale, profondamente segnato dalla novità
della carta fondamentale e dalla sua attuazione garantista/promozionale; un periodo dell’emergenza
e della crisi; ed una stagione della razionalizzazione (Carinci 2007, prefazione alla prima edizione,
XLVII e ss.). In altri termini (ma il prodotto non cambia), si parla anche di un diritto del lavoro post
costituzionale, uno promozionale, un diritto della crisi, un diritto della flessibilità ed infine uno
della comunitarizzazione (Biagi 2003, 23-24).
Sta di fatto che un primo periodo di produzione del diritto del lavoro da parte della fonte
statuale è caratterizzato (oltre che da un evidente sforzo interpretativo della giurisprudenza,
soprattutto di quella costituzionale, volto a superare le antinomie del cortocircuito
codice/costituzione) dall’esigenza di promuovere ed agevolare l’accesso – in condizioni di
eguaglianza – dei lavoratori alle occasioni di lavoro, in funzione del principio di cui all’art. 4 Cost.
(attraverso la disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla l. 264/1949, ora in gran parte
abrogato dal d.lg. 297/2002, che ha fatto seguito al d.lg. 181/2000, con i quali si è sostanzialmente
riformulato il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro); assieme al contestuale obiettivo
protezionistico dell’aspirante occupato, mediante l’assegnazione della funzione di collocamento a
pubblici uffici ed il conseguente divieto, penalmente sanzionato, di qualsivoglia mediazione privata
e decentramento produttivo (l. 1369/1960, ora abrogata dalla l. 30/2003); nonché alla
9
predisposizione di standard minimi di tutela inderogabile del lavoro, in funzione di un rapporto
modellato su quello a tempo indeterminato, con conseguente limitazione al ricorso a prestazioni di
lavoro temporaneo (l. 230/1962, ora abrogata dal d.lg. 368/2001) e progressiva riduzione dell’area
di libera recedibilità (l. 604/1966).
Gran parte della produzione normativa è però “promozionale”, sia in funzione della cd.
autotutela collettiva nei luoghi di lavoro, di cui è espressione lo Statuto dei lavoratori, sia in
funzione della dignità del lavoro, tra l’altro, con la realizzazione del principio di parità tra uomo e
donna (l. 903/1977), sia in funzione di una diversa regolamentazione del processo del lavoro al fine
di renderlo più rapido ed efficace (l. 533/1973).
Altra parte della produzione del diritto del lavoro è invece finalizzata ad arginare l’impatto
della recessione economica, in periodi di crisi, con ricorso alla legislazione cd. dell’emergenza (per
esempio, mediante un allentamento dei vincoli del contratto a termine, tra cui l’art. 23 della l.
56/1987, e la tipizzazione di nuove ipotesi di lavoro: part-time, l. 863/1984, contratto di formazione
e lavoro, l. 285/1977 rinsaldata dall’art. 3 della l. 863/1984, oppure ancora la predisposizione di
strumenti volti a governare la crisi aziendale, come la cassa integrazione); e con il perseguimento di
una maggiore flessibilità, che ridisegna in parte il regime generale di tutela del primo diritto del
lavoro, in funzione anche della tutela dell’occupazione (la l. 223/1991 ridisegna la disciplina dei
licenziamenti collettivi ed introduce il meccanismo della assunzione con richiesta normativa; la l.
608/1996 estende il meccanismo dell’assunzione diretta; la l. 196/1997 introduce il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo a mezzo di imprese private autorizzate ed il d.lg. 469/1997 abolisce
il principio del monopolio pubblico del collocamento; in funzione protezionistica, invece, si segnala
la l. 626/1994 che stabilisce misure generali e speciali da adottare per la salute e la sicurezza dei
lavoratori a carico dei datori).
Sempre al perseguimento del principio di flessibilità va ricondotta anche l’odierna
evoluzione del diritto del lavoro, che si riferisce anche alla necessità di una modernizzazione delle
regole di governo dei rapporti di lavoro in conformità con gli obblighi di appartenenza del paese
all’Unione Europea.
Vengono qui in rilievo i già richiamati percorsi normativi di “privatizzazione” del rapporto
di pubblico impiego (iniziato con il d.lg. 29/93 ed ora confluito nel t.u. di cui al d.lg. 165/2001), e di
“riforma” del mercato del lavoro (che fa capo alla l. 14.02.2003, n. 30, ed al d.lg. attuativo
276/2003, modificato dal d.lg. 251/2004).
In particolare, l’art. 1 del d.lg. 276/2003 indica le finalità della nuova disciplina.
« Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi
contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla
libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
10
parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle
pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di
occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e
contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori ».
(Art. 1, d.lg. 10.10.2003, n. 276)
In tale ottica, si dispone l’integrale privatizzazione del collocamento, attribuendosi la
funzione di avviamento dei lavoratori ad agenzie in possesso di determinati requisiti ed idonee a
garantire le attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale; nel solco segnato dall’art.
4 Cost., sul diritto al lavoro, che, non azionabile nei confronti dei singoli operatori del mondo del
lavoro, va riferito, per constante orientamento, alla promozione delle condizioni che ne rendano
possibile l’effettività.
Si dà regolamentazione ad istituti di decentramento produttivo, distinguendosi i fenomeni
anomali e patologici da quelli fisiologici e connessi ad esigenze aziendali (ad esempio, la nuova
figura della somministrazione di lavoro mediante apposite agenzie); si istituiscono nuove tipologie
contrattuali caratterizzate da un particolare grado di elasticità, che tolgono centralità al modello
tipico e rigido del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (lavoro
intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, nuova disciplina dell’apprendistato, lavoro a
progetto).
Allo stesso modo, il d.lg. 368/2001 riformula la disciplina del lavoro a tempo determinato,
abrogando la l. 230/1962 e le fattispecie esclusive di ammissibilità della clausola del termine,
sostituite dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo; pur richiedendosi
a pena di inefficacia la stipula per iscritto della clausola con il richiamo delle ragioni che richiedono
il termine; e con rinvio alla contrattazione collettiva del compito di stabilire limiti quantitativi di
utilizzazione di lavoratori a termine (al fine di contenere possibili abusi datoriali).
Sempre il d.lg. 276/2003 riformula anche il contratto di lavoro part-time, già regolamentato
dal d.lg. 61/2000, ed ora modificato ulteriormente dall’art. 1, 44° co., l. 247/2007; anche in tal caso
prevedendosi il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni comparativamente più
rappresentative al fine di determinare condizioni e modalità di svolgimento del lavoro parziale,
nonché di stabilire clausole flessibili di variazione della collocazione temporale della prestazione
lavorativa o – per il lavoro parziale di tipo verticale – clausole elastiche di variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa (prima dell’ultima riforma tale possibilità era riservata al
contratto individuale); e con contratto di lavoro da stipularsi per iscritto a fini probatori.
Per il part-time nel pubblico impiego, l’art. 1, 58° e 59° co., l. 662/1996, è stato modificato
dall’art. 73, 1° e 2° co., d.l. 112/2008, convertito in l. 06.08.2008, n. 133, a seguito del quale la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – che, prima, avveniva
“automaticamente” – ora “può essere concessa dall’amministrazione”.
11
Come si vede dal breve excursus delle diverse fasi di produzione di fonte statuale, la
descritta disomogeneità finalistica è tesa verso gli opposti poli attrattivi, da una parte, del
“protezionismo” rispetto alla fissazione degli standard minimi inderogabili del rapporto di lavoro
tipico, e dall’altra, della “flessibilità” rispetto all’esigenza di adeguare detti standard in ragione delle
concrete condizioni di lavoro, anche atipiche e/o decentrate, in funzione dell’attuazione del diritto
costituzionale al lavoro per il maggior numero possibile di persone.
D’altra parte, va anche rilevato come – pur nella nuova tendenza alla flessibilizzazione della
tutela dei lavoratori, rispetto a quella apprestata all’originario ed unico, ma rigido, modello di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno – “le recenti innovazioni legislative non
conducono all’abbandono dei principi essenziali di tutela dei lavoratori, bensì alla loro revisione, e a
limitate modifiche, al fine di stemperare gli eccessi di un apparato garantistico, apparso
incompatibile con gli obiettivi primari dello sviluppo dell’economia e dell’incremento
dell’occupazione”.
In tal senso, resta sempre valida la “considerazione primaria della persona umana in sé
presa, e del lavoratore in quanto impegnato personalmente nell’esecuzione della prestazione
lavorativa”, quale obiettivo costituzionale da perseguire (Scognamiglio 2006, § 11, lett. b e c).
2.3. La “nuova” fonte regionale in materia di lavoro.
Una profonda novità nel quadro legale delle fonti del diritto del lavoro è rappresentata dalla
riforma del Titolo V della Costituzione, realizzata con l. cost. 18.10.2001, n. 3, che ha determinato –
secondo una formulazione che lascia però margini di incertezza interpretativa – una nuova
ripartizione di competenze tra la fonte statuale e quella regionale, con un ampliamento di
competenze legislative regionali ed un nuovo decentramento normativo, anche in materia di lavoro.
Anche in tal caso, la ratio dell’intervento a livello costituzionale è il perseguimento di un
“modello flessibile di sussidiarietà” (Chieppa 2006, prefazione, XIV).
« La riforma costituzionale del 2001, anche se circoscritta al Titolo V, valica i confini di questo Titolo.
Redistribuendo le competenze legislative tra Stato e Regioni, comprese le materie e le finalità interessate da
disposizioni contenute nella prima parte della Costituzione (istruzione, sanità, lavoro, etc.), non può non influire sulla
organizzazione e sull’attività ».
(Corso – Lopilato 2006, introduzione, XVIII)
Deve dirsi che – prima di detta riforma – non si poneva un problema di produzione di diritto
del lavoro da parte delle Regioni a statuto ordinario, e l’utilizzo di tecniche di decentramento, in
materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, riguardava la devoluzione di poteri dalla fonte
statuale direttamente all’attività amministrativa od alla contrattazione collettiva; oppure, concerneva
12
i rari casi di delega “diretta” di funzioni normative alle Regioni da parte della legge nazionale (e
salvo il caso della formazione professionale, oggetto di conferimento da parte della l. 845/1978).
La modifica del Titolo V della Costituzione, in via generale, rovescia il precedente sistema
costituzionale di riparto di competenze legislative, individuando una serie di materie “riservate” alla
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 2° co., Cost.); elencando, poi, tassativamente le materie
di competenza legislativa “concorrente”, ossia ripartita tra Stato e Regioni, secondo la distinzione
tra “determinazione dei principi fondamentali” (ancora riservata allo Stato) e titolarità della potestà
legislativa cd. “di dettaglio” (spettante alle Regioni) (art. 117, 3° co., Cost.); ed infine, riconoscendo
potestà legislativa regionale esclusiva “per ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato” (art. 117, 4° co., Cost.).
In particolare, quest’ultimo aspetto, attribuendo alle Regioni, e non più allo Stato, la
competenza legislativa “residuale”, sarebbe idoneo a modificare la stessa forma di Stato, d
regionale a tendenzialmente federale (anche se la Corte Costituzionale, in più riprese, con le
sentenze 370/2003, 380 e 424 /2004, ha ridimensionato detta clausola, escludendo che una materia
ricada nella potestà regionale “per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad
una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost.”: con l’utilizzo di una
tecnica combinatoria, dalla correlazione di una serie di competenze numerate, la Corte ne ricava una
che non viene espressamente menzionata, con l’effetto di sottrarla all’ambito della competenza
legislativa regionale residuale).
Orbene, in detto quadro di riferimento, per quanto riguarda la materia del diritto del lavoro,
deve evidenziarsi che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia afferente
all’“ordinamento civile dello Stato” (art. 117, 2° co., lett. l, Cost.); nonché la “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale” (art. 117, 2° co., lett. m, Cost.).
Spetta pur sempre allo Stato la statuizione dei principi fondamentali, entro i quali deve
esplicarsi la potestà legislativa concorrente delle Regioni, in materia di “professioni”, di
“previdenza complementare ed integrativa” e di “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, 3° co.,
Cost).
Non pare dubbia la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e
formazione professionale.
A fronte di tal variegato nuovo sistema di ripartizione delle competenze legislative, non
poche incertezze sono sorte in merito a quale dei tre gruppi di materie sia da ricondurre il diritto del
lavoro, genericamente inteso come disciplina del rapporto tra prestatore e datore, sia pubblico che
privato.
13
Il dibattito (pur in presenza di conclusioni anche in favore di una nuova ed integrale potestà
legislativa concorrente, sub specie “tutela e sicurezza del lavoro”) pare orientato verso una
interpretazione riduttiva, volta ad escludere il diritto del lavoro e la sua disciplina dalla competenza
concorrente Stato/Regioni, in virtù della riferibilità della materia a quella generale
dell’“ordinamento civile” propria della competenza legislativa esclusiva statale.
Sicché si è prospettata in dottrina la esigenza di “scindere la materia giuslavoristica
collocandola, in proporzioni variabili, parte nell’area della competenza esclusiva statuale, parte in
quella di competenza concorrente Stato/Regioni”.
« Secondo la tesi maggioritaria (Carinci 2003, 17; Napoli 2002, 13; Magnani 2002, 652), la linea di confine
dovrebbe attestarsi sulla distinzione fra disciplina del rapporto di lavoro (e diritto sindacale) da una parte, e disciplina
del mercato del lavoro dall’altra: la prima dovrebbe ricadere nella competenza esclusiva dello Stato, in quanto
appartenente all’“ordinamento civile”, la seconda invece nella competenza legislativa ripartita ».
(Cester-Miscione-Zoli 2007, 7)
D’altra parte, la materia dell’“ordinamento civile” non pare alludere ad altro che al diritto
civile stesso, ossia alla “disciplina delle relazioni fra privati”, ed alle materie ivi comprese, tra le
quali è fuor di dubbio che rientri anche la materia del contratto di lavoro e la disciplina del rapporto
di lavoro.
Sotto altro aspetto, la questione è già stata oggetto di appropriazione di competenza da parte
del legislatore nazionale che, con la riforma del mercato del lavoro delineata con la l. 30/2003 e
successivo d.lg. attuativo 276/2003, ha mostrato di recepire in pieno la suddetta impostazione
centralista nella regolamentazione del rapporto di lavoro.
Detta competenza è stata avvallata anche dalla Corte Costituzionale che (peraltro in sintonia
con il precedente orientamento sul cd. “limite del diritto privato” invalicabile per il legislatore
regionale, per il quale gli artt. 2 e 3 Cost. imponendo una uniformità di regolazione dei rapporti
intercorrenti tra soggetti privati, porterebbero al riconoscimento della competenza statale in materia
di lavoro) ha rigettato le censure sollevate dalle Regioni sul d.lg. 276/2003, confermando le scelte
del legislatore nazionale regionale proprio sulla base della riconducibilità della materia a quella
dell’“ordinamento civile” (Corte Cost. 50/2005).
Significativa, sotto questo aspetto, è anche la sentenza sempre della medesima Corte Cost.
359/2003, che ha infatti dichiarato, sui medesimi presupposti, la illegittimità costituzionale
dell’intera legge della Regione Lazio che aveva fornito una autonoma definizione della fattispecie
di mobbing, con ciò invadendo l’area di competenza statuale.
3. La giurisprudenza: fonte “atipica” di diritto del lavoro?
14
Non v’è dubbio che il diritto del lavoro sia quello che attualmente è, non solo in virtù della
produzione di fonte normativa riguardante detta materia, bensì anche dell’interpretazione che di
detta produzione venga data, in concreto e con riguardo ai singoli casi decisi, dalla giurisprudenza.
Non si può disconoscere l’enorme rilevanza assunta di fatto dalle decisioni dei giudici nel
far vivere la disciplina del rapporto di lavoro, mediante adattamenti alle circostanze concrete dei
principi esistenti e/o mediante un’opera di affermazione ex novo di detti principi – nel silenzio delle
norme – che è stata da più parti riconosciuta come una vera e propria “attività creativa” di diritto.
Detta azione “conformativa” della giurisprudenza (che sussiste per tutti i rami del diritto)
assume particolare importanza nella materia della regolamentazione del rapporto di lavoro: sia
perché favorita dalla complessità delle normative, ispirate spesso – come detto – a finalità
divergenti; sia per il sovrapporsi di fonti eterogenee ed anche atipiche, con frequenti conflitti da
risolvere sulla base dei diversi criteri gerarchico, cronologico, di specialità, di favor, di sussidiarietà,
di prevalenza, di competenza, etc.; sia per la rapidità dei mutamenti economico-sociali ai quali sono
strettamente connesse le discipline del rapporto di lavoro, con frequenti revirements normativi e
gestione dei cd. periodi transitori; sia, infine, ma soprattutto, per il gradito utilizzo, da parte della
fonte statuale, di clausole generali e per il rinvio a principi e regole formulati con termini
indeterminati, che spetta poi alla giurisprudenza (ed alla dottrina) specificare nel loro contenuto
concreto. Basti pensare, per esempio, allo stesso concetto di dipendenza dall’imprenditore al fine
della configurabilità di un rapporto di subordinazione, oppure a quello di diligenza nella prestazione
del lavoro, alle nozioni generiche di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, al criterio
di sufficienza e proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., al concetto di mansioni
equivalenti quale limite allo jus variandi datoriale, etc.
Non v’è dubbio che tutti questi fattori aumentino il tasso di discrezionalità dell’azione
giurisprudenziale, sino alla conseguenza di rendere possibile l’introduzione di vere e proprie
innovazioni allo stesso ordinamento giuridico, con l’affermazione di principi esistenti solo ed
esclusivamente per creazione da parte dei giudici (tipico il caso del principio del favor lavoratoris,
oppure della configurabilità della fattispecie di mobbing, oppure ancora dell’applicabilità generale
ed erga omnes della giusta retribuzione determinata collettivamente, etc.; tipiche sono anche alcune
tipologie di sentenze della Corte Costituzionale, da quelle più soft cd. interpretative di rigetto, alla
cui stregua la norma impugnata viene salvata in ragione di una data interpretazione fornita, a quelle
più incisive, cd. di accoglimento manipolative, che estrapolano dalla norma impugnata un
significato che deve possedere, pena l’incostituzionalità della stessa).
La giurisprudenza finisce allora per creare diritto, oltre che interpretarlo.
15
In tal senso, è spesso proposta una qualifica della giurisprudenza come vera e propria fonte
del diritto, seppur atipica, in quanto essa sarebbe chiamata – soprattutto in periodi di crisi o di
rapida evoluzione sociale – a fungere da “sostituto” del legislatore, ossia a svolgere compiti
sostanzialmente de jure condendo, al posto della legge in continua e tradiva rincorsa della realtà
sociale.
« Una conclusione può dunque trarsi: sono norme giuridiche non solo quelle che vengono poste dalle leggi o
da altra fonte formalmente qualificata, ma anche quelle che derivano da una norma di produzione semplicemente
effettiva. In altre parole, il legislatore non ha il monopolio delle fonti del diritto, le quali possono sorgere anche nel
silenzio o nell’ostilità della legge ».
(Galantino 1997, 34)
Deve peraltro considerarsi che – pur rilevandosi l’attività creatrice della giurisprudenza
come dato di fatto – non se ne può non cogliere altresì l’incongruità rispetto ad un corretto sistema
di bilanciamento di poteri costituzionali, comportando – nei casi di abuso e di utilizzo più improprio
– delle distonie e degli squilibri funzionali che hanno come risvolto (opposto a quello perseguito)
l’incertezza giuridica e – più in generale – l’alterazione del principio di rappresentanza democratica.
Il problema, infatti, è che la “norma giurisprudenziale” non è formulata per fattispecie
generali ed astratte, ma per casi concreti, ed è imprecisa, perché deve essere desunta dal contenuto
delle singole sentenze dalle quali possa ricavarsi il principio non scritto.
Essa è peraltro volubile, mutevole e variabile nel tempo e nello spazio (da qui l’incertezza).
I principi giurisprudenziali, che a volte si presentano formulati come veri e propri commi di
legge e trovano applicazione al di là ed oltre la legge, a volte non sono supportati da alcuna
presunzione di condivisione generale, essendo il frutto della singola espressione decisionale non
rappresentativa (da qui il vulnus di democraticità).
Più l’attività giurisprudenziale cessa di essere interpretativa, per essere creativa, maggiore
sono i pericoli citati a cui può esporsi.
In questo senso, più che parlare di giurisprudenza come fonte del diritto, pare maggiormente
corretto rilevare l’importanza dell’apporto che essa dà all’ordinamento giuridico, in funzione della
manifestazione di quel “diritto vivente” e/o “diritto effettivo”, che costituisce – alla fin fine – il
diritto (nella fattispecie, del lavoro) così come riguardante la vita delle persone (nella fattispecie,
delle parti del rapporto di lavoro).
Si preferisce parlare, a tal proposito, della giurisprudenza come di attività che contribuisce
alla produzione della norma (di lavoro) finale.
« Seguendo autorevoli opinioni, si può dunque distinguere tra disposizione, intesa come proposizione
normativa (Rechtssatz, enunciato linguistico, statuizione o frammento di testo esprimente una proposizione normativa) e
norma, intesa come risultato del processo interpretativo della disposizione medesima. Tale distinzione è
scientificamente molto importante in quanto consente di distinguere l’attività propriamente normativa da quella
interpretativa: l’una risolvendosi nella creazione delle disposizioni, l’altra nell’enucleazione da queste delle norme ».
(Amato-Barbera 1986, 120)
16
4. Fonti internazionali e comunitarie: rinvio.
Non par dubbio che una importanza sempre maggiore debba riconnettersi, nel campo della
produzione del diritto del lavoro alle cd. fonti sovranazionali, soprattutto dovute alla partecipazione
del nostro Paese all’Unione Europea (in particolare, per quest’ultimo aspetto si rinvia alla
trattazione contenuta nel successivo cap. 7 del presente primo volume).
Qui basti dire che l’ordinamento italiano consente “limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art. 11 Cost.) e che esistono
particolari meccanismi che consentono la recezione nell’ordinamento interno di norme
internazionali e/o sovranazionali: sia in via automatica, mediante il richiamo di queste ultime (come
espressamente previsto dall’art. 10 Cost., che impegna l’ordinamento italiano a “conformarsi alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”); sia mediante appositi meccanismi di
ratifica (ex artt. 80 e 87 Cost.).
E’ una tendenza diffusa dei moderni ordinamenti statuali quella di cercare soluzioni
giuridiche condivise, ai complessi e comuni problemi della odierna società affetta di cd.
globalizzazione, su scala sovranazionale.
Peraltro, un importante appiglio normativo e istituzionale a tale esigenza, specie in materia
di lavoro, lo si ritrova nel risalente, ma ancora attuale, art. 35, 3° co., Cost., che assegna alla
Repubblica il compito di promuovere e favorire “gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi
ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.
Sicuramente, un primo ambito sovranazionale di disciplina uniforme dei rapporti di lavoro è
rappresentato dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che si esprime ed incide sulla
regolamentazione della materia, mediante “raccomandazioni” o “convenzioni”, e quindi mediante la
predisposizione di atti normativi solo potenzialmente suscettibili di divenire norme effettivamente
operanti, peraltro indipendentemente dalla volontà dell’OIL, bensì in conseguenza dell’azione dei
singoli Stati membri. Le convenzioni divengono vincolanti per gli Stati membri solo in
conseguenza di tecniche di “recepimento” della normativa internazionale da parte dei singoli
ordinamenti nazionali, nelle forme costituzionalmente previste e quindi, generalmente, per mezzo di
ratifica. Le raccomandazioni esercitano solo un’azione di stimolo e di sollecitazione all’adozione di
determinate normative.
Se alle origini degli interventi internazionali si trattava di ricercare soprattutto standards
comuni di trattamento normativo dei rapporti di lavoro, specie con la ricerca del cd. “trattamento
economico minimo”, ora, a seguito della internazionalizzazione dei mercati e della economia, e
della conseguente progressiva incidenza interna ai singoli Stati delle decisioni sovranazionali, il
17
dibattito sembra spostarsi sulle modalità di applicazione di detti standards minimi di tutela, nei
paesi in via di sviluppo, in quelli dall’equilibrio economico precario, oppure caratterizzati da uno
sviluppo economico senza regole.
Tale attività si è cioè indirizzata sempre più verso un’opera di sostegno allo sviluppo
economico e sociale.
« Si è cioè avvertita in maniera sempre più pressante, la necessità che l’attività normativa dell’OIL “andasse
oltre la disciplina dello stesso rapporto di obbligazione tra lavoratore e datore di lavoro, per estendersi ai più diversi
aspetti che incidono sulla dinamica dei rapporti sociali” (Adam 1993, 44). Ciò ha giustificato l’adozione di norme che
riguardano “i lavoratori indipendenti, i proprietari di piccole imprese e, ancor più genericamente, tout le persone
économiquement actives, se non addirittura i résidents nello Stato” oppure di “norme che tendono a regolare le
condizioni abitative dei lavoratori o la modernizzazione des techniques et méthodes de travai” oppure finanche il
sistema sanitario generale e il regime della proprietà terriera (Adam 1993, 45). Ma soprattutto sono state sviluppate vere
e proprie politiche sociali e della piena occupazione (Conetti 1984, 596) ».
(Nogler 2007, 26)
Per esemplificare, uno degli aspetti originari ove le norme OIL hanno svolto maggior
incidenza è stato il trattamento economico cd. minimo, che ha trovato effettiva espressione, nel
nostro paese, a livello costituzionale.
L’art. 36 Cost., sull’introduzione di un “correttivo” a livello di retribuzioni, rispetto
all’equilibrio spontaneo del mercato, nella prospettiva del perseguimento della cd. “giusta
retribuzione”, si inserisce nell’ambito di una serie di norme internazionali, sulla fissazione di un
“saggio minimo di salario”. La prima convenzione di carattere generale in materia di livelli
retributivi è quella dell’OIL n. 26 del 1928, ratificata dall’Italia con legge 877/1930, che impone a
ogni Stato membro di “istituire o mantenere metodi che consentano di fissare saggi minimi di
salario… qualora non esistano norme efficaci per la fissazione dei salari mediante contratto
collettivo o altrimenti e laddove i salari siano eccezionalmente bassi” ed enuncia anche il principio
di inderogabilità in pejus del minimo salariale; ad essa è ricollegabile la successiva convenzione
OIL n. 117 del 1962, in particolare l’art. 10 (ratificata dall’Italia con la legge 13 luglio 1966 n. 657),
che individua nei contratti collettivi gli strumenti più adeguati per la determinazione dei minimi
salariali; la successiva convenzione OIL n. 131 del 1970 non è stata ratificata dall’Italia.
A livello europeo, invece, il diritto alla retribuzione equa e sufficiente è stato innanzitutto
sancito dalla Carta sociale europea del 1961, ratificata in Italia con legge 3 luglio 1965 n. 929 (va
altresì rammentata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata a Nizza in data
14 novembre 2000).
Per citare un altro aspetto, affrontato espressamente dalle norme internazionali, che invece
non pare aver trovato recepimento nella nostra carta costituzionale, basti far riferimento a quello
della cd. “parità retributiva”.
18
Esiste infatti questo principio generale a livello internazionale, che si desume da tutta una
serie di disposizioni di origine internazionale contenenti affermazioni a sua tutela.
La convenzione OIL n. 117/1962, all’art. 14, prevede che le retribuzioni siano stabilite in
conformità del principio “a lavoro eguale, uguale retribuzione”, sia nella stessa impresa che “nello
stesso settore”, e vieta qualsiasi differenza di trattamento basata sulla “appartenenza a un
raggruppamento tradizionale o sulla affiliazione sindacale”. L’art. 22 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, approvata dall’assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984, stabilisce il
principio secondo cui “ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
uguale lavoro”. Viene qui in rilievo anche il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1866 e reso
esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977 n. 881, il cui art. 7 sancisce il principio dell’ “equo
salario” (salaire equitable) che assicuri ai lavoratori ed alle loro famiglie un’ “esistenza decorosa”;
nonché quello della “parità di trattamento retributivo” (une rèmunèration ègale pour un travail de
valeur ègale).
Ora, tutte queste affermazioni possono essere intese come riconducibili, parallelamente, al
principio di “proporzionalità” (retribuzione adeguata alle caratteristiche intrinseche del lavoro)
stabilito nella nostra carta costituzionale all’art. 36 Cost. Ma, a ben vedere, le affermazioni presenti
a livello internazionale paiono assumere una “ulteriore” valenza di parità di trattamento in termini
assoluti (ad un certo tipo di lavoro corrisponde sempre una stessa retribuzione), che non pare
rinvenibile nell’art. 36 Cost., neppure interpretato in combinato disposto con l’art. 3 Cost. (la
giurisprudenza della Suprema Corte ha comunque negato l’esistenza nel nostro ordinamento di un
principio assoluto di parità di retribuzione, in particolare con la pronuncia a Sezioni Unite
6030/1993, secondo la quale non esistono precetti costituzionali idonei a fondare un principio di
comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni
debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento”).
Tutt’altro discorso, invece, va fatto per l’ambito di regolamentazione sovranazionale
rappresentato dalla Unione Europea, anche in considerazione del diverso peso e della diversa
incidenza sul sistema “interno” delle fonti del diritto del lavoro che assume la fonte “esterna”
comunitaria.
L’art. 189 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, ed ora l’art. 249 nella versione cd.
“consolidata” del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, dispone: “per l’assolvimento dei loro
compiti e delle condizioni contemplate dal presente trattato, il Consiglio e la Commissione
stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri”. Poi
stabilisce: “il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
19
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.
Ben diversa, quindi, è la operatività della fonte comunitaria all’interno dell’ordinamento
giuridico, concorrendo essa (nel caso di fonte regolamentare comunitaria) a disciplinare
direttamente, assieme alla fonte statuale, i rapporti tra soggetti privati, ed anzi potendo il giudice
disapplicare all’occorrenza le norme interne contrastanti.
La funzione della fonte comunitaria appare incentrata non tanto sull’individuazione di regole
uniformi inderogabili, quanto sul perseguimento di un miglioramento progressivo delle condizioni
di lavoro, nonché della promozione e del coordinamento delle politiche dell’occupazione (dalle
quali discendono le norme di fonte statuale, sopra viste, sulla flessibilizzazione del rapporto di
lavoro).
In particolare, l’art. 117 del Trattato (ed ora l’art. 136 nella versione consolidata),
riconoscono espressamente tra le finalità dell’Unione Europea, quella di “promuovere il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro
parificazione nel progresso”.
Ma su questi aspetti si rinvia, come detto, al successivo capitolo 7.
5. Fonti eteronome ed autonome: la fonte collettiva.
Sotto altro profilo, le fonti del diritto del lavoro sogliono anche distinguersi tra “eteronome”
ed “autonome”.
Accanto alle fonti che si esprimono – come le fonti statuali interne ex art. 1 disp. prel. c.c. –
in comandi esterni rispetto alle parti del rapporto di lavoro, ed alle quali lavoratori e datori di lavoro
sono egualmente soggetti (ma, in tale ambito, rilevano anche le fonti regionali, ed altresì le fonti
non statuali, internazionali e comunitarie), esistono fonti che scaturiscono da libere manifestazioni
di volontà e di autonomia privata collettiva (come i contratti collettivi nazionali ed aziendali), che
rappresentano forme di autodeterminazione regolamentativa, poste in essere dalle stesse parti
private e dai loro rappresentanti sindacali (trattasi quindi di fonti “interne” allo stesso rapporto di
lavoro da regolamentare, che nascono in via di autotutela).
La questione del contratto collettivo come fonte del diritto sui generis nasce a causa della
mancata attuazione dell’art. 39 Cost. e del sistema ivi previsto di registrazione delle organizzazioni
sindacali; con conseguente inapplicabilità dell’art. 39, 4° co., Cost., sulla possibilità per i sindacati
registrati di “stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie ai quali il contratto si riferisce”.
20
La norma costituzionale ricrea in fieri (quanto meno con riguardo agli effetti giuridici della
contrattazione collettiva) la medesima situazione già prevista dal codice civile per il soppresso
contratto collettivo corporativo, espressamente qualificato “fonte del diritto”, seppure di rango
secondario, dall’art. 1 disp. prel. c.c.: in entrambi i casi, i contratti (quello costituzionalmente
tipizzato e quello corporativo) risultano dotati di efficacia obbligatoria erga omnes.
La soppressione del sistema corporativo e l’inattuazione dell’art. 39 Cost. non permettono di
citare, nel sistema formale delle fonti del diritto, il contratto collettivo tra le fonti statuali
dell’ordinamento giuridico vigente; almeno, in senso tecnico. Esso è quindi ricondotto da dottrina e
giurisprudenza nell’ambito delle manifestazioni della autonomia negoziale privata collettiva, come
“contratto di diritto comune” e fonte di obbligazioni di natura negoziale, ex art. 1321 c.c.,
vincolante esclusivamente per i soggetti stipulanti, secondo il principio di cui all’art. 1372 c.c., in
base al quale “il contratto ha forza di legge tra le parti… non produce effetto rispetto ai terzi che nei
casi previsti dalla legge”
Quindi, la fonte collettiva vincola solo i soggetti sindacalmente affiliati e non chi non è
rappresentato dalle associazioni stipulanti: o meglio, vincola le imprese sindacalmente affiliate (per
adesione datoriale) e vincola – si ritiene – rispetto alla generalità dei lavoratori, senza distinguere tra
iscritti o meno ai sindacati stipulanti.
In tal senso, trattasi di fonte del diritto del tutto “atipica”.
Eppure, in pratica e per varie vie, va segnalata una “estensione di fatto” della operatività
della disciplina negoziale collettiva; sicché l’area di applicabilità del contratto collettivo acquista
tendenzialmente una efficacia obbligatoria generalizzata (quasi per attrazione costitutiva).
In tale direzione opera, per esempio, una norma di legge, l’art. 2113 c.c., che invalida
“rinunzie e transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (non si tratta di una
obbligatorietà generale ex lege delle disposizioni negoziali collettive, che anzi possono entro certi
limiti essere rinunciate e le rinunce non impugnate in termini; ma certo la norma dà una grossa
spinta all’impegnatività degli accordi collettivi).
Sempre nella direzione di una estensione, questa volta dottrinale, dell’efficacia delle norme
contrattuali, si ritiene ormai concordemente che debba ritenersi impegnato dalla fonte collettiva
anche quel datore di lavoro non aderente ad alcuna associazione sindacale che, per prassi costante,
applichi al rapporto di lavoro dei propri dipendenti una data contrattazione sindacale (attuandosi
una sorta di adesione implicita ad un determinato contratto collettivo).
21
La norma costituzionale sull’efficacia obbligatoria della fonte collettiva, poi, pur nella sua
generale inattuazione, ha trovato una sua sostanziale applicazione, in via esclusivamente
giurisprudenziale, anche se solo per quanto riguarda la parte economico-retributiva degli accordi.
Infatti – mai affermatosi il carattere automatico dell’efficacia erga omnes dei contratti
collettivi previsto dall’art. 39 Cost. – il principio contenuto nell’art. 36 Cost., sull’esigenza di una
misura retributiva proporzionata e sufficiente (norma di per sé “programmatica”, avente come
destinatari il legislatore ed i contraenti collettivi, nel perseguimento dell’obiettivo del giusto
minimo retributivo) è venuto ad assumere, quasi sin dalla prima giurisprudenza formatasi sul punto
(Cass. 18.07.1961, n. 1745, con nota critica di Pera, MGL, 1961, 412), valore immediatamente
“precettivo”, ossia di immediata applicabilità ai rapporti contrattuali (anche privati) per via
giudiziale.
In tal modo, anche quando il contratto collettivo di diritto comune non risulti applicabile
inter partes (in quanto le parti non sono iscritte alle associazioni stipulanti né hanno accettato
consensualmente l’adesione alla disciplina collettiva), quest’ultimo si ritiene comunque applicabile,
nella parte riguardante il trattamento retributivo, al rapporto di lavoro individuale, per via
giudiziale, come parametro per la giusta retribuzione.
« Il contratto collettivo di settore può essere applicato anche in assenza della formale iscrizione del datore di
lavoro alle organizzazioni stipulanti. Esso è applicabile direttamente e integralmente come tale ove vi sia stata tacita
adesione del datore, che può essere dedotta anche dall’andamento dei livelli contrattuali, dall’inquadramento
effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione effettivamente corrisposta; in mancanza di adesione, il
contratto è applicabile solo come parametro per la giusta retribuzione, ai sensi dell’art. 36 cost. ».
(Cass., sez. lav., 19.01.2006, n. 955, Gdir 2006, 1877)
Viene cioè a ripristinarsi il disegno originario (probabilmente pensato dai costituenti) di
applicazione generalizzata dei contratti collettivi ai singoli rapporti di lavoro, almeno per quanto
concerne l’aspetto retributivo, in quanto il medesimo risultato di una retribuzione che “deve essere
corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative” ex art. 2099 c.c. – invece di essere
perseguito mediante l’attuazione dell’art. 39 Cost., ossia automaticamente – lo si persegue infine
mediante la forza precettiva dell’art. 36 Cost., equiparando tariffa minima a tariffa collettiva, e
sostituendo quest’ultima alla prima, ossia per via giudiziale.
Infine, un ulteriore spinta verso l’applicabilità erga omnes dei contratti collettivi è data da
quelle norme volte a condizionare il riconoscimento di finanziamenti e/o di benefici contrattuali e
sgravi contributivi, all’integrale rispetto degli accordi stipulati “dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi” (di recente, art. 10, l. 30/2003, ma
anche art. 36 St. lav.).
Per questi motivi, taluna dottrina ritiene esistente già oggi il principio di efficacia
obbligatoria complessiva della fonte sindacale.
22
« Ritengo che già oggi, a prescindere dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost. (ma in applicazione del
principio sostanziale quivi dettato) il contratto collettivo stipulato dai sindacati di cui si possa comprovare la
maggioranza nel totale di tutto il complesso sindacalmente organizzato, sia generalmente obbligatorio ».
(Pera 1990, 48)
5.1. La fonte collettiva nel diritto del lavoro pubblico.
Un particolare passo in avanti in tale direzione lo si ha con riguardo alla disciplina del
pubblico impiego cd. privatizzato. Il lavoro pubblico (diverso per natura e regolamentazione, così
come storicamente consolidatasi, da quello privato) rischia di fungere da laboratorio per nuove
sperimentazioni di soluzioni estensibili anche al settore privato.
L’odierno legislatore, con il d.lg. 31.03.2001, n. 165, ha colmato il vuoto normativo in
ordine ai criteri di individuazione delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative (in quanto
“rappresentative”) e di quelle con cui è legittima la stipulazione dell’accordo (mediante indici di
misurazione quantitativi, assemblanti dato associativo e dato elettorale, e quindi in base a dati
concretamente accertabili), che attribuiscono rilevanza all’espressione del consenso anche dei
lavoratori non iscritti.
Su tale aspetto è intervenuto di recente il Consiglio di Stato, con il parere del 3 dicembre
2008, n. 4108, secondo il quale l’art. 43, 3° co., del d.lg. 165/2001 va interpretato nel senso meno
restrittivo, e la soglia minima di rappresentanza del 50% richiesta per la sottoscrizione del contratto
va riferita non alla somma di tutte le associazioni sindacali, ma solo a quelle maggiormente
rappresentative (con percentuale di adesioni superiore al 5%). In tal modo, si legittimano anche solo
alcune delle grandi sigle sindacali unitarie – ferma restando la necessità di raggiungere la
percentuale della media delle deleghe e dei voti – a procedere alla stipula di validi contratti con il
pubblico impiego (la problematica si è presentata di recente, da quando – in diverse trattative – si è
rotta l’unità sindacale dei sindacati maggiormente rappresentativi e la CGIL ha assunto posizioni
autonome rispetto a CISL e UIL).
Dette norme giustificano l’estensione erga omnes del contratto collettivo nel settore del
pubblico impiego, in quanto – a dispetto delle previsioni inattuate dell’art. 39 Cost. – la citata
efficacia obbligatoria si verifica ugualmente quale conseguenza del vincolo ex lege gravante sulle
amministrazioni di conformarsi agli impegni assunti con i contratti stipulati con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e con le modalità stabilite (art. 45, 2° co., d.lg. 165/2001).
Proprio per queste considerazioni, atteso che la contrattazione collettiva nel settore del
lavoro pubblico è disciplinata, sia quanto a protagonisti, sia quanto ad effetti, dalla legge, in questo
caso è preferibile parlare della fonte collettiva non come fonte autonoma, bensì “eteronoma”,
proponendosi, a sua volta, con comandi esterni che si impongono obbligatoriamente alle parti del
rapporto lavorativo.
23
5.2. Produzioni di fonte collettiva.
La fonte di produzione cd. “interna” e di tipologia collettiva agisce nell’ordinamento
giuridico lavoristico sostanzialmente in più modi.
a) Innanzitutto, l’autonomia collettiva produce un costante processo di integrazione e di
estensione delle fonti dell’ordinamento statuale, mediante il libero estrinsecarsi dei rapporti di forza
delle parti private collettive, nel quadro delineato dalle norme costituzionali sulla libertà sindacale
(art. 39, 1° co., Cost., secondo cui “l’organizzazione sindacale è libera” e si esprime secondo scelte
del tutto insindacabili, in un quadro di “reciproco riconoscimento” delle parti; art. 40 Cost.,
sull’utilizzo dello sciopero, quale strumento di pressione sulla controparte datoriale per
rivendicazioni di carattere lavorativo, “nell’ambito delle leggi che lo regolano”).
E’ questo il carattere peculiare della fonte collettiva, qualificabile come autonoma perché le
stesse parti private sono al tempo stesso i soggetti creatori ed i destinatari delle regole prodotte.
La produzione di diritto nell’ambito di un ordinamento giuridico “originario”, in tal caso, si
pone a volte in funzione sussidiaria-integrativa rispetto all’attività produttiva statuale, in materia di
rapporti di lavoro, a volte addirittura in funzione alternativa rispetto ad un intervento diretto
statuale.
Sotto questo aspetto, la regolamentazione del rapporto di lavoro e la soluzione dei conflitti
tra le parti non necessariamente trovano risposta esclusiva attraverso regole generali ed astratte
predeterminate dall’ordinamento giuridico ed imposte dall’esterno; ma la regolamentazione del
rapporto ed il superamento del conflitto sono dovuti anche al mutevole equilibrio raggiunto dalle
stesse parti sociali contrapposte, che via via contribuiscono così a definire nel tempo e nello spazio
lo stesso contenuto del diritto del lavoro, per così dire, dall’interno.
« Quanto detto spiega perché il contratto di lavoro sia stato opportunamente definito come uno strumento di
composizione temporanea di un conflitto, libere, dal canto loro, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro di riaprire il conflitto ogni qualvolta mutate condizioni dei rapporti di forza tra le parti o anche soltanto semplici
ragioni di opportunità suggeriscano modifiche radicali o anche soltanto semplici aggiustamenti dell’intesa
precedentemente raggiunta ».
(Biagi 2003, 8)
In sostanza, pur nell’inattuazione del dettato costituzionale, la contrattazione collettiva
esprime una vocazione connaturale di normazione e regolamentazione concreta dei rapporti di
lavoro, sia a livello di categoria professionale (mediante l’adesione datoriale all’associazione
sindacale di riferimento), sia a livello di singola azienda (mediante la stipulazione di accordi
decentrati), che si manifesta nell’esercizio di potere contrattuale.
24
b) Sotto altro aspetto, va detto che l’autonomia collettiva in qualche modo condiziona la
stessa fonte di produzione eteronoma, in quanto le parti sociali spesso incidono direttamente sulla
stessa genesi produttiva della norma giuridica statuale, mediante quel metodo (a dire il vero più
seguito qualche tempo fa) cd. della “concertazione sociale”, istituzionalizzato a partire dal
protocollo “Giugni” sul costo del lavoro del 23 luglio 2003, e fondato sulla partecipazione delle
parti sociali alle scelte di politica del lavoro e di politica economica generale assunte dal Governo.
Oggi, da più parti se ne depreca l’uso eccessivo acquisito nel tempo, sino a divenire
processo utilizzato per lo svolgimento di compiti spesso sostanzialmente di esclusiva competenza
del Governo, con assunzione di funzioni ultronee rispetto all’originario obiettivo di sviluppare una
corretta interazione tra ordinamento intersindacale ed ordinamento statuale (il cd. Libro Bianco sul
mercato del lavoro, presentato dal Governo nell’ottobre del 2001, evidenzia l’opportunità di avviare
un nuovo modello di “dialogo sociale”, così come regolamentato e sperimentato a livello
comunitario, che attui “un metodo di confronto più agile e duttile, tale in ogni caso da consentire
una chiara distinzione delle reciproche responsabilità tra Governo e parti sociali”) (Biagi 2003, 910).
c) Infine, in un numero significativo di casi, l’autonomia collettiva completa la stessa fonte
eteronoma, attuando un intervento produttivo di pari grado e livello rispetto a quest’ultima. La fonte
collettiva viene per così dire “chiamata” dallo stesso ordinamento giuridico statuale al
“riempimento” della normativa di cornice; entro quest’ultima si estrinseca, così, la disciplina in
autotutela delle parti sociali, con pari dignità della fonte “chiamante”. E’ la norma stessa, in tal
caso, che “rinvia” all’autonomia collettiva il compito di specificarne i contenuti e gli ambiti di
applicazione (la suddetta modalità di coinvolgimento dell’atipica fonte collettiva è assai presente
nell’ultima produzione legislativa, la quale spesso rinvia alla contrattazione collettiva, per esempio,
l’individuazione di talune ipotesi che legittimano il ricorso al contratto di lavoro intermittente o alla
somministrazione di lavoro, ovvero la particolare modulazione flessibile del lavoro a part-time).
E’ stato notato che non emerge un quadro coerente di coinvolgimento della fonte collettiva,
in quanto “a volte si rinvia indifferentemente a qualunque livello negoziale, altre volte soltanto agli
accordi nazionali di categoria”. Anzi, l’impulso allo sviluppo della negoziazione decentrata ed
aziendale nella regolamentazione delle forme di lavoro flessibile comporta che, da ultimo, nella
maggior parte dei casi, i rinvii alla fonte collettiva vengano compiuti in modo indifferenziato con
riguardo a tutti i livelli contrattuali.
« Se tale soluzione non è riscontrabile nella riforma del contratto a termine, che continua a rinviare in
prevalenza agli accordi nazionali di categoria (cfr. artt. 7, 2° co., 9, 1° e 2° co., 10, 9° co., d.lg. 368/2001), lo stesso non
può dirsi appunto per i contratti flessibili (in particolare part time, job sharing, lavoro intermittente, contratti di
inserimento) (v. d.lg. 276/2003) e per la materia dell’orario di lavoro (v. d.lg. 66/2003) ».
(Cester, Miscione, Zoli 2007, 11)
25
5.3. Diversi “livelli” e “categorie” di fonte collettiva.
D’altra parte, l’utilizzo del rinvio sic et simpliciter alla contrattazione collettiva va
ricondotto alla complessiva esigenza attuale di rendere maggiormente dinamico un mercato del
lavoro eccessivamente ingabbiato, imponendo di considerare come rilevanti le diverse condizioni
ambientali; ciò che ha determinato una nuova spinta verso la valorizzazione della contrattazione
decentrata (pur in una situazione in cui il contratto aziendale rimane ancora sconosciuto alla
maggior parte delle piccole imprese).
Nel già ricordato Protocollo Giugni sul costo del lavoro del 1993, alla contrattazione
nazionale di categoria viene affiancata una contrattazione collettiva di secondo livello territoriale o
aziendale (cd. contratto decentrato integrativo o aziendale).
Il CCNL ha durata quadriennale per la cd. “parte normativa”, relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, e biennale per la cd. “parte economica”, relativa ai trattamenti retributivi. Il
CCDI ha anch’esso durata quadriennale e può intervenire su materie e/o istituti specifici, spesso
individuati dalla stessa contrattazione nazionale, nella cd. “parte obbligatoria” (relativa alla gestione
dello stesso contratto collettivo e che ha per destinatarie non le parti individuali ma quelle collettive
stipulanti), ed elencati espressamente quali oggetto di contrattazione decentrata (ad esempio, un
istituto tipico di quest’ultima è la determinazione di una parte variabile della retribuzione, legata
alla concreta mansione lavorativa ed organizzazione aziendale).
Spesso, infatti, proprio per risolvere in anticipo possibili contrasti tra norme collettive, le
stesse parti stipulanti predispongono meccanismi di raccordo tra livelli diversi, per esempio
stabilendo in concreto le rispettive aree di competenza dei diversi livelli.
Anche sotto questo aspetto deve rilevarsi la peculiarità del rapporto di lavoro nel settore
pubblico: l’art. 40, l. 165/2001, prevede infatti che la contrattazione collettiva integrativa, di livello
inferiore, si svolga “sulle materie e nei limiti stabiliti dai CCNL, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono”; e che le parti “non possono sottoscrivere in sede decentrata
CCI in contrasto con vincoli risultanti dai CCNL”, e che “le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate”.
Nel pubblico impiego, vige quindi per legge il criterio cd. di “prevalenza” della fonte
collettiva centrale, su quella decentrata e territoriale (diversamente dal lavoro privato, come si vedrà
al § 5.3.2., ove si ritiene che viga il criterio cd. di “prossimità”).
Comunque, i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione sono da considerarsi sia in senso
“orizzontale”, ossia nel loro rapporto con altre “categorie” di contrattazione analoghe o affini
(sempre posizionate su più livelli); sia in senso “verticale”, ossia nel loro rapporto reciproco (tra
26
livello nazionale e locale di una medesima categoria di contrattazione collettiva); sia in senso
“cronologico”, ossia nel loro rapporto di successione nel tempo.
La prima analisi dà un problema di “individuazione” della fonte collettiva, ossia di quale
contrattazione collettiva di riferimento (indipendentemente dal livello) applicare al singolo rapporto
di lavoro.
La seconda analisi dà un problema di “gerarchia” delle fonti collettive, ossia di quale tra i
diversi livelli – in caso di contrasti contenutistici – applicare al caso concreto.
La terza analisi dà un problema di “transitorietà” delle norme collettive, in caso di
successione discontinua di contratti.
5.3.1. L’“individuazione” della fonte collettiva: il criterio di libertà di scelta.
Per quanto riguarda l’individuazione del contratto collettivo applicabile (indipendentemente
dal livello), gli artt. 2069 e 2070 c.c. fanno riferimento all’applicabilità “automatica” della
contrattazione relativa alla “categoria professionale” che “si determina secondo l’attività
effettivamente esercitata dall’imprenditore”. Tali norme sono state dettate per l’ordinamento
corporativo e la Suprema Corte ne ha sancito la non riferibilità con riguardo alla contrattazione
collettiva di diritto comune (Cass., Sez. U., 26.03.1997, n. 2665, GI, 1998, 915).
Per quest’ultima, in virtù del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. (per il quale
le associazioni sindacali sono libere di scegliere l’ambito della contrattazione di riferimento),
l’individuazione della contrattazione applicabile è rimessa – come già detto – alla libertà di scelta
delle parti e/o all’adesione datoriale (esplicita, mediante iscrizione; o implicita, mediante prassi) ad
una data organizzazione sindacale (che può essere diversa da quella propria del settore di attività
dell’impresa).
Ciò nonostante l’art. 2070 c.c. ha mantenuto una residuale applicabilità in ipotesi di rinvio
recettizio alla contrattazione collettiva da parte di norme, come ad esempio nel caso di cui all’art. 36
St. lav., con riguardo all’ottenimento di finanziamenti pubblici da parte di appaltatori di opere
pubbliche, che ha per condizione l’obbligo per l’appaltatore “di far applicare nei confronti dei
lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona” (sulla materia è intervenuto anche l’art. 10, l. 30/2003, stabilendo il
medesimo principio per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, con riguardo al
riconoscimento di benefici normativi e contributivi, subordinato all’integrale rispetto degli accordi
stipulati “dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentativi”).
27
Altra ipotesi di riferimento alla categoria di appartenenza è quella della individuazione, per
via giudiziale, del contratto collettivo applicabile al fine di determinare la giusta retribuzione ex art.
36 Cost.
A ben vedere, anche qui deve registrarsi un mutamento di orientamento, ritenendosi, da una
parte, che – se il criterio di “appartenenza alla categoria” secondo l’attività esercitata
dall’imprenditore ex art. 2070 c.c. è stato ormai abbandonato ai fini dell’individuazione del
contratto collettivo applicabile al singolo rapporto di lavoro, che può essere anche quello di un
settore diverso liberamente scelto dalle parti (per cui il lavoratore non può richiedere l’applicabilità
del diverso contratto di categoria) – pur tuttavia il medesimo criterio sarebbe rimasto, nella
giurisprudenza, ai diversi fini del controllo di congruità del trattamento economico ex art. 36 Cost
(per cui il lavoratore potrebbe però richiedere l’applicabilità di un diverso trattamento retributivo, se
più favorevole, corrispondente a quello di categoria) (Cass., sez. lav., 3687/1990, secondo la quale
“in caso di richiesto adeguamento retributivo ex art. 36 Cost., occorre far riferimento al CCNL
applicabile al settore in cui si colloca l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore, a nulla
rilevando l’iscrizione o meno del datore di lavoro alle associazioni stipulanti”).
Da ultimo, però, si registra un diverso orientamento della Suprema Corte che richiama il
principio per il quale l’applicabilità del contratto collettivo scelto dalle parti esclude comunque la
possibilità di riferimento ad un contratto collettivo diverso, oggettivamente applicabile ex art. 2070
c.c., anche in sede di valutazione giudiziale della sufficiente retribuzione. Ne risulta che il rinvio al
trattamento economico di cui al contratto categoriale riguarda il solo e residuale caso di non
adesione datoriale ad alcuna organizzazione collettiva: “il ricorso al criterio della categoria
economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 c.c., è consentito al solo fine
di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 cost., quando non risulti applicato
alcun contratto collettivo, e sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36
cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass., sez. lav., 29.07.2000, n. 100002,
10002, MGC, 2000, 1661; RIDL, 2001, II, 395).
Naturalmente, resta assegnata al giudice la individuazione della tariffa collettiva cui
parametrare la giusta retribuzione, in caso di settore non coperto da contrattazione collettiva. In tal
caso, nella sua opera di adeguamento, il giudice può fare riferimento a un contratto collettivo
stipulato per una categoria affine (Cass., sez. lav., 17 marzo 2000, n. 3184, MGC, 2000, 595,
DPLav, 2000, 2015).
5.3.2. La “gerarchia” tra fonti collettive: il criterio di prossimità.
28
Per quanto riguarda il rapporto tra i diversi livelli della medesima fonte collettiva, deve
rilevarsi una rinnovata attenzione della legislazione e delle stesse parti collettive per il livello
territoriale. Il trend pare rafforzato anche sul versante giurisprudenziale.
La nuova attenzione alla flessibilità – soprattutto economica – pare trovare riscontro, per
esempio, nella giurisprudenza determinativa della giusta retribuzione.
Si va affermando infatti un orientamento che assume alcune “circostanze particolari” (il
minor costo della vita nella regione, o il livello più basso delle retribuzioni normalmente praticate
nella zona, le dimensioni dell’azienda o la sua importanza) quali possibili motivi legittimanti una
determinazione giudiziale della retribuzione in misura anche inferiore rispetto allo standard
collettivo di settore (Cass., sez. lav., 26.07.2001, n. 10260, FI, 2001, I, 3088; Cass., sez. lav.,
28.08.2004, n. 17250, RCDL, 2004, 961).
Un interessante indirizzo (in parte divergente) è quello espresso da Cass., sez. lav.,
17.03.2000, n. 3184, MGC, 2000, 595; DPLav, 2000, 2015, dalle cui conclusioni pare desumersi
che, mentre al giudice non sarebbe consentito valutare le condizioni aziendali ai fini della riduzione
della tariffa collettiva, tuttavia quando tale operazione sia compiuta dalla stessa contrattazione
locale e/o aziendale, quest’ultima può essere assunta a parametro della giusta retribuzione pur se
peggiorativa rispetto alla tariffa negoziata nazionale.
In tal ipotesi, pare ormai principio giurisprudenziale acquisito quello in base al quale, in
presenza di contrattazione locale o aziendale con standard inferiori rispetto a quelli nazionali, viene
considerata adeguata e sufficiente la retribuzione che faccia riferimento, sempre in via parametrica,
a quegli importi ridotti, rispetto allo standard nazionale di categoria, per i rapporti di lavoro
territorialmente circoscritti nell’ambito di quell’area economicamente più in difficoltà (Cass., sez.
lav., 26.03.1998, n. 3218, GCMA, 1998, 672; NgiL, 1998, 299; FI, 1998, I, 3227).
Infatti, con riguardo alla sovrapposizione di clausole collettive di diverso livello, la
giurisprudenza ha adottato recentemente il “criterio di prossimità” agli interessi disciplinati, che
favorisce la contrattazione decentrata integrativa. E’ stato infatti stabilito che – fatti salvi i diritto
quesiti – “il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello deve essere risolto in base non già al
principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale (salva l’espressa
previsione di disposizioni di rinvio), né di quello cronologico (della prevalenza del contratto
posteriore nel tempo), ma alla stregua dell’effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina
agli interessi disciplinati” (Cass., sez. lav., 19.04.2006, n. 9052 , MGC, 2006, 4).
Si è parlato, in relazione a tale ultima evoluzione della tendenza giurisprudenziale, recettiva
delle condizioni ambientali e territoriali di svolgimento del rapporto di lavoro, di possibile rischio di
“disarticolazione del sistema della contrattazione collettiva” (Cester-Miscione-Zoli 2007, 11); di
29
ritorno per via giudiziale alle cd. “gabbie salariali” (un tempo infatti la contrattazione collettiva
prevedeva retribuzioni determinate in ragione di una previa fissazione di “zone territoriali”,
partendosi dal presupposto del diverso costo della vita tra zona e zona, assetto ormai cessato da
quasi un quarantennio; si è pertanto paventato, da taluni, e/o auspicato, da altri, l’introduzione –
nuovamente – del predetto assetto, per via giudiziale, laddove e se le decisioni dei giudici
comincino a tenere in considerazione le diverse situazioni ambientali e/o territoriali di svolgimento
dei singoli rapporti di lavoro, ai fini della determinazione della giusta retribuzione).
Da altri, si è invece parlato di standard territorialmente differenziati in ragione dell’esigenza
di tutela dei cd. outsiders, fuori mercato del lavoro, in zone a forte tasso di disoccupazione o di
lavoro irregolare: ne sono esempio i cd. contratti di riallineamento (di cui all’art. 5 del d.l.
1.10.1996, n. 510, convertito in l. 28.11.1996, n. 608, poi novellato dall’art. 23 della l. 24.06.1997,
n. 196), con i quali è stata esplicitamente prevista “la negoziazione collettiva di deroghe transitorie
in pejus rispetto (alla disciplina contributiva previdenziale e) agli standard retributivi nazionali, in
funzione della lotta contro il lavoro irregolare e contro la disoccupazione nelle regioni meridionali”
(su tali aspetti, Ichino 2003, 137-138).
5.3.3. La “successione” tra fonti collettive: il criterio di ultrattività convenzionale.
Anche nel diritto del lavoro trova applicazione il cd. criterio cronologico, in virtù del quale –
ovviamente tra fonti di pari natura e livello e fatti salvi, laddove applicabili, i diversi principi di
specialità o competenza – prevale la disciplina successiva nel tempo.
I contratti collettivi hanno durata determinata nel tempo, che consente un flessibile
adeguamento delle previsioni, soprattutto retributive, alle mutate esigenze contrattuali o di
condizioni economiche, e che permette di gestire a ritmi periodici il rapporto tra le opposte parti
collettive, ricontrattando alle scadenze le negoziazioni in essere.
Anche in mancanza di previsione di termine, comunque, è pur sempre possibile per le parti
collettive determinare l’efficacia nel tempo del contratto, mediante disdetta o recesso unilaterale, ed
aprire una nuova fase negoziale.
Il problema che si riscontra in questa successione nel tempo di fonti collettive è determinato
dal fatto che il sistema negoziale cristallizzato per un certo periodo non viene quasi mai sostituito
immediatamente da quello nuovo alla scadenza del primo, in quanto le trattative di rinegoziazione si
protraggono a lungo e la sottoscrizione del nuovo contratto interviene quando il precedente è già
ampiamente scaduto, determinando un problema di discontinuità temporale e di gestione della “fase
transitoria” (di non più vigenza della vecchia negoziazione e di non ancora vigenza di quella
nuova).
30
I contratti collettivi in genere, proprio per evitare interruzioni di regolamentazione,
prevedono nel nuovo accordo sottoscritto la clausola cd. di “retroattività”, in modo da estendere a
ritroso nel tempo le nuove clausole contrattuali, sino a saldarle con le precedenti; ma questo,
ovviamente, a far data dalla nuova sottoscrizione. Permane quindi un problema di gestione del
rapporto di lavoro nel periodo che va dalla scadenza o dalla denunzia del precedente contratto, sino
all’entrata in vigore del nuovo.
In detto periodo, non può parlarsi di “ultrattività” legale del contratto, pur prevista dall’art.
2074 c.c., il quale dispone che “il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a
produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento
collettivo”.
Anche detta disposizione è stata ritenuta inapplicabile ai contratti post-corporativi di diritto
comune: essi, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale privata, sono regolati dalla
libera volontà delle parti, cui soltanto spetta di stabilire se l’efficacia di un accordo possa
sopravvivere alla sua scadenza (Cass., sez. lav., 17.01.2004, n. 668, MGC, 2004, 1).
Occorre pertanto che una clausola cd. di ultrattività sia espressamente contenuta
nell’accordo collettivo per consentire la perdurante vigenza degli effetti giuridici del contratto
scaduto o denunciato. Diversamente, gli effetti del contratto di diritto comune dipendono dalla
scadenza del termine pattuito o dall’esercizio della facoltà di recesso o di disdetta (anche se deve
dirsi che poi il contratto in essere continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, per
mero fatto concludente, ossia nella sostanziale e tacita accettazione delle parti collettive; mentre,
sotto l’aspetto economico, è invalso l’uso di riconoscere ai lavoratori una somma una tantum per il
periodo di vacanza contrattuale).
5.4. Gli “usi aziendali”.
Ai contratti collettivi aziendali devono affiancarsi anche i cd. usi aziendali. Trattasi di
comportamenti costanti e ripetuti nel tempo, tenuti spontaneamente dal datore di lavoro nei
confronti di tutti o di una parte, gruppo o categoria, di dipendenti, che si concretizzano in una serie
di trattamenti economici o normativi differenti rispetto a quelli previsti per legge o per contratto
collettivo (per lo più, concessioni di gratifiche, di premi, di indennità, etc. non riconosciuti
occasionalmente).
Si ritiene che essi non siano riconducibili agli usi normativi previsti dall’art. 1, disp. prel.
c.c. (questi ultimi agiscono sul piano delle fonti dell’ordinamento giuridico; gli altri sul contenuto
del contratto).
31
Si discute se essi rientrino nella disciplina di cui all’art. 1340 c.c. (“le clausole d’uso di
intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti”) e siano quindi
norme proprie dell’autonomia individuale; oppure se siano prassi contrattuali collettive da
inquadrarsi nell’ambito delle fonti dell’autonomia collettiva e rilevanti in sede di contratto
individuale in virtù del richiamo operato dall’art. 1374 c.c. (“il contratto obbliga le parti non solo a
quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge
o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”).
Nel primo caso, gli usi, incorporandosi nel contratto individuale, non sono suscettibili di
essere modificati in senso peggiorativo né dalla successiva contrattazione collettiva, né
unilateralmente dal datore di lavoro (rilevando per essi i criteri di soluzione del conflitto tra
contratto individuale e quello collettivo, ai sensi dell’art. 2077 c.c.).
Nel secondo caso, agendo sul contratto individuale dall’esterno, come qualunque accordo
collettivo, trattandosi in sostanza di norme collettive sussistenti in via di prassi, sono modificabili
da qualsiasi altra fonte collettiva successiva (rilevando per essi i criteri di soluzione del conflitto tra
fonti collettive).
A norma dell’art. 2078 c.c. la disposizione d’uso più favorevole al lavoratore prevale anche
di fronte ad una norma di rango superiore quale è la legge, se dispositiva.
Ma anche lo stesso uso ha efficacia dispositiva, posto che quest’ultimo rimane derogabile
dalla autonomia negoziale individuale (gli usi non prevalgono sui contratti individuali, anche se più
favorevoli) (Nicolini 1996, 17).
6. I rapporti fra le fonti del diritto del lavoro.
Molteplici sono i criteri che possono regolamentare i casi di conflitto tra fonti del diritto di
diversa specie e natura.
In via generale, oltre al criterio cronologico (di successione nel tempo di fonti dello stesso
genere), si distinguono il criterio gerarchico e quello di competenza: il primo postula una diversa
posizione tra le fonti in termini di sovra e sotto ordinazione, ai sensi del quale l’una prevale
sull’altra; il secondo richiede una posizione di pari ordinazione delle fonti, sebbene in ambiti
diversi, e si estrinseca in un sindacato di sconfinamento dell’una sull’altra.
A ciò si può aggiungere un criterio di specialità, il quale – indipendentemente dalla
posizione delle fonti nell’ordinamento giuridico – risolve il conflitto sulla base di un dato specifico,
come quello della disposizione più favorevole al lavoratore.
32
Sulla base di detti criteri, sono stati esaminati i singoli rapporti tra le fonti del diritto del
lavoro.
Ad esempio, tra le fonti sovranazionali si distingue tra fonti internazionali e comunitarie.
Le prime (raccomandazioni e convenzioni) assumono valore vincolante nei singoli
ordinamenti nazionali solo a seguito di una apposita procedura di recepimento (nel nostro
ordinamento, una volta che siano ratificate secondo le procedure indicate negli artt. 80 e 87 Cost.),
per effetto della quale assumono valore formale di legge ordinaria dello Stato.
Esse quindi non sono idonee ad alterare la gerarchia interna delle fonti.
Le discipline di derivazione comunitaria, invece, sono atte ad incidere nell’ordinamento
dello Stato dell’Unione Europea, anche qualora non siano oggetto di un vero e proprio atto formale
di recepimento con legge ordinaria: se atti self-executing, si ritengono suscettibili di immediata
applicazione comportando la disapplicazione, all’occorrenza, delle norme interne contrastanti,
anche successive; in ogni caso, condizionando l’interpretazione delle norme interne alla luce della
fonte comunitaria.
Tra fonti eteronome e fonti autonome si ritiene applicabile il criterio di prevalenza delle
prime sulle seconde. Si parla peraltro di inderogabilità in pejus della fonte eteronoma rispetto a
quella autonoma (che in base al più volte richiamato principio del favor lavoratoris può prevedere
condizioni o trattamenti migliorativi per quest’ultimo.
Deve considerarsi peraltro che in sempre più istituti è la stessa fonte eteronoma che rinvia
alla fonte autonoma la regolamentazione di date materia, riservando ad essa la competenza su di un
piano sostanziale di parità di posizione, in termini quindi di fonti “concorrenti”.
Infine, anche tra pattuizioni poste in essere a livello collettivo e pattuizioni poste in essere a
livello individuale, si applica, in via generale, il principio della inderogabilità in pejus delle seconde
rispetto alle prime.
Il principio è espressamente stabilito nell’art. 2077 c.c., secondo il quale “i contratti
individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo
devono uniformarsi alle disposizioni di questo”; e “le clausole difformi dei contratti individuali,
preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo salvo che contengano disposizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
Stante l’inapplicabilità della norma prevista per l’ordinamento corporativo (anche se in tal
caso la giurisprudenza, a differenza di altre norme corporative, ha comunque applicato di fatto tale
principio), il riferimento può ora considerarsi l’art. 2113 c.c., che espressamente stabilisce la non
derogabilità in senso peggiorativo per il prestatore di lavoro delle disposizioni contenute nel
contratto collettivo di lavoro.
33
Avv. Stefano Spinelli
Bibliografia
CARINCI F. (diretto da), Diritto del lavoro, vol. I, UTET, Torino, 2007;
CESTER, MISCIONE, ZOLI, Le fonti interne, in Diritto del lavoro (diretto da CARINCI), vol. I, UTET,
Torino, 2007;
NOGLER, , Le fonti internazionali, in Diritto del lavoro (diretto da CARINCI), vol. I, UTET, Torino, 2007;
SCOGNAMIGLIO, Intorno alla storicità del diritto del lavoro, in RIDL, 2006, 4, 375;
CORSO, LOPILATO (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte Generale,
Giuffrè, Milano, 2006;
CHIEPPA R., Prefazione, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali (a cura di CORSO,
LOPILATO), Parte Generale, Giuffrè, Milano, 2006;
BIAGI, Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2003;
ICHINO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale (diretto da MESSINEO e
SCHLESINGER), vol II, Giuffrè, 2003;
GALANTINO, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1997;
NICOLINI, Manuale di diritto del lavoro, Giuffrè, 1996;
PERA, Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1990;
MAZZONI, Manuale di diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1988;
AMATO, BARBERA, Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1986;
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1975;
SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1973;
PERA, Nota a Cass. 18.07.1961, n. 1745, in MGL, 1961, 412.
34