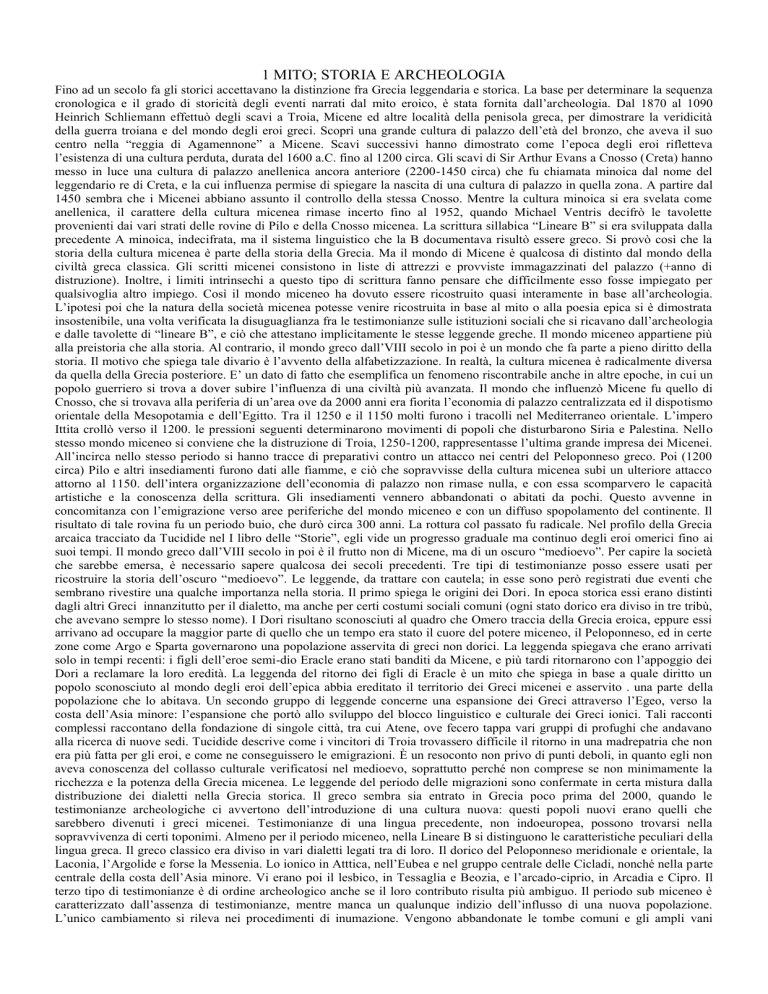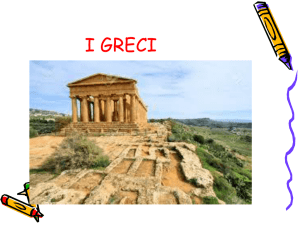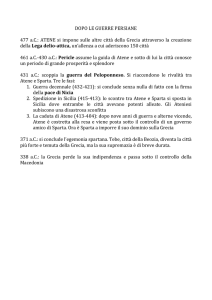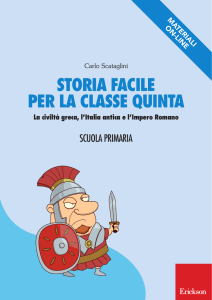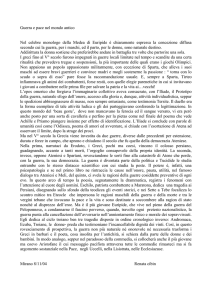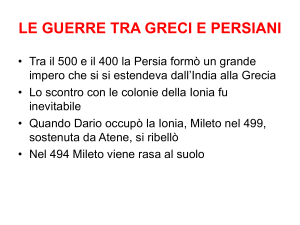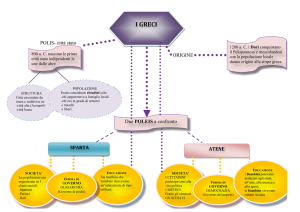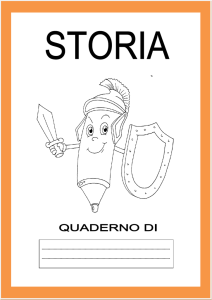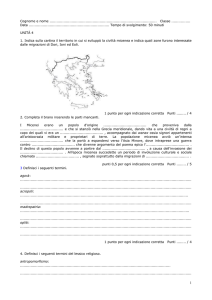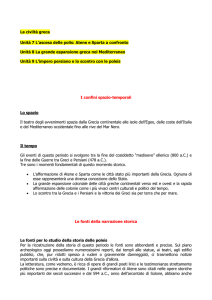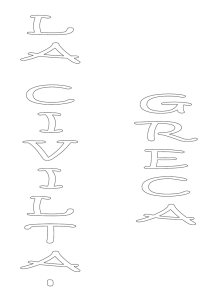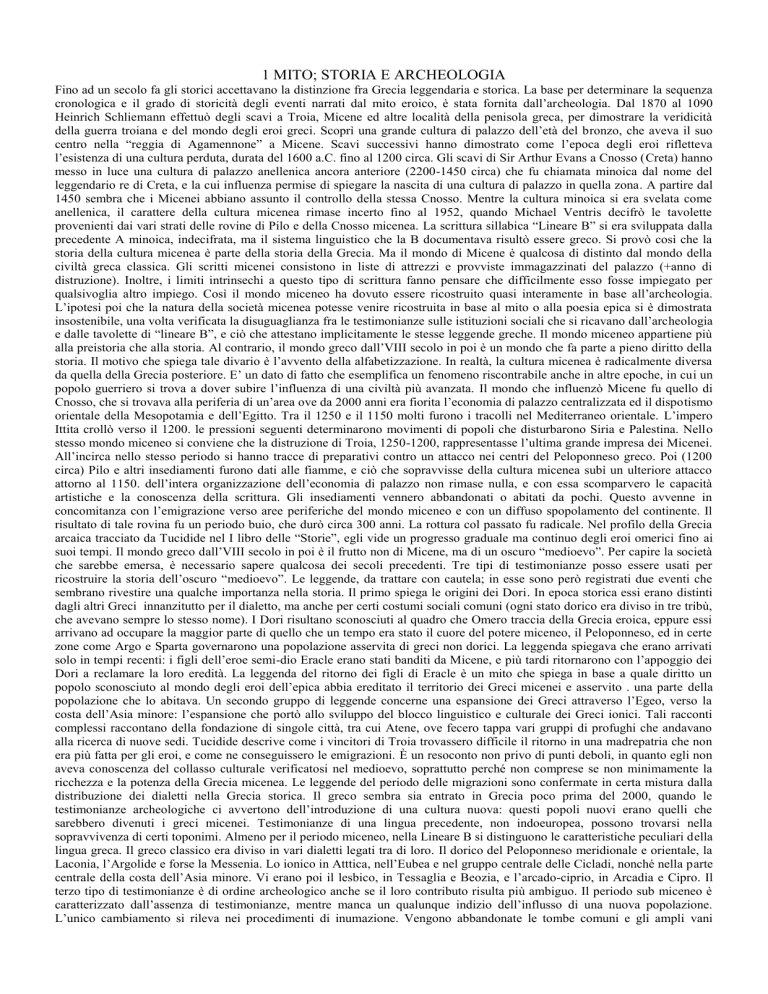
1 MITO; STORIA E ARCHEOLOGIA
Fino ad un secolo fa gli storici accettavano la distinzione fra Grecia leggendaria e storica. La base per determinare la sequenza
cronologica e il grado di storicità degli eventi narrati dal mito eroico, è stata fornita dall’archeologia. Dal 1870 al 1090
Heinrich Schliemann effettuò degli scavi a Troia, Micene ed altre località della penisola greca, per dimostrare la veridicità
della guerra troiana e del mondo degli eroi greci. Scoprì una grande cultura di palazzo dell’età del bronzo, che aveva il suo
centro nella “reggia di Agamennone” a Micene. Scavi successivi hanno dimostrato come l’epoca degli eroi rifletteva
l’esistenza di una cultura perduta, durata del 1600 a.C. fino al 1200 circa. Gli scavi di Sir Arthur Evans a Cnosso (Creta) hanno
messo in luce una cultura di palazzo anellenica ancora anteriore (2200-1450 circa) che fu chiamata minoica dal nome del
leggendario re di Creta, e la cui influenza permise di spiegare la nascita di una cultura di palazzo in quella zona. A partire dal
1450 sembra che i Micenei abbiano assunto il controllo della stessa Cnosso. Mentre la cultura minoica si era svelata come
anellenica, il carattere della cultura micenea rimase incerto fino al 1952, quando Michael Ventris decifrò le tavolette
provenienti dai vari strati delle rovine di Pilo e della Cnosso micenea. La scrittura sillabica “Lineare B” si era sviluppata dalla
precedente A minoica, indecifrata, ma il sistema linguistico che la B documentava risultò essere greco. Si provò così che la
storia della cultura micenea è parte della storia della Grecia. Ma il mondo di Micene è qualcosa di distinto dal mondo della
civiltà greca classica. Gli scritti micenei consistono in liste di attrezzi e provviste immagazzinati del palazzo (+anno di
distruzione). Inoltre, i limiti intrinsechi a questo tipo di scrittura fanno pensare che difficilmente esso fosse impiegato per
qualsivoglia altro impiego. Così il mondo miceneo ha dovuto essere ricostruito quasi interamente in base all’archeologia.
L’ipotesi poi che la natura della società micenea potesse venire ricostruita in base al mito o alla poesia epica si è dimostrata
insostenibile, una volta verificata la disuguaglianza fra le testimonianze sulle istituzioni sociali che si ricavano dall’archeologia
e dalle tavolette di “lineare B”, e ciò che attestano implicitamente le stesse leggende greche. Il mondo miceneo appartiene più
alla preistoria che alla storia. Al contrario, il mondo greco dall’VIII secolo in poi è un mondo che fa parte a pieno diritto della
storia. Il motivo che spiega tale divario è l’avvento della alfabetizzazione. In realtà, la cultura micenea è radicalmente diversa
da quella della Grecia posteriore. E’ un dato di fatto che esemplifica un fenomeno riscontrabile anche in altre epoche, in cui un
popolo guerriero si trova a dover subire l’influenza di una civiltà più avanzata. Il mondo che influenzò Micene fu quello di
Cnosso, che si trovava alla periferia di un’area ove da 2000 anni era fiorita l’economia di palazzo centralizzata ed il dispotismo
orientale della Mesopotamia e dell’Egitto. Tra il 1250 e il 1150 molti furono i tracolli nel Mediterraneo orientale. L’impero
Ittita crollò verso il 1200. le pressioni seguenti determinarono movimenti di popoli che disturbarono Siria e Palestina. Nello
stesso mondo miceneo si conviene che la distruzione di Troia, 1250-1200, rappresentasse l’ultima grande impresa dei Micenei.
All’incirca nello stesso periodo si hanno tracce di preparativi contro un attacco nei centri del Peloponneso greco. Poi (1200
circa) Pilo e altri insediamenti furono dati alle fiamme, e ciò che sopravvisse della cultura micenea subì un ulteriore attacco
attorno al 1150. dell’intera organizzazione dell’economia di palazzo non rimase nulla, e con essa scomparvero le capacità
artistiche e la conoscenza della scrittura. Gli insediamenti vennero abbandonati o abitati da pochi. Questo avvenne in
concomitanza con l’emigrazione verso aree periferiche del mondo miceneo e con un diffuso spopolamento del continente. Il
risultato di tale rovina fu un periodo buio, che durò circa 300 anni. La rottura col passato fu radicale. Nel profilo della Grecia
arcaica tracciato da Tucidide nel I libro delle “Storie”, egli vide un progresso graduale ma continuo degli eroi omerici fino ai
suoi tempi. Il mondo greco dall’VIII secolo in poi è il frutto non di Micene, ma di un oscuro “medioevo”. Per capire la società
che sarebbe emersa, è necessario sapere qualcosa dei secoli precedenti. Tre tipi di testimonianze posso essere usati per
ricostruire la storia dell’oscuro “medioevo”. Le leggende, da trattare con cautela; in esse sono però registrati due eventi che
sembrano rivestire una qualche importanza nella storia. Il primo spiega le origini dei Dori. In epoca storica essi erano distinti
dagli altri Greci innanzitutto per il dialetto, ma anche per certi costumi sociali comuni (ogni stato dorico era diviso in tre tribù,
che avevano sempre lo stesso nome). I Dori risultano sconosciuti al quadro che Omero traccia della Grecia eroica, eppure essi
arrivano ad occupare la maggior parte di quello che un tempo era stato il cuore del potere miceneo, il Peloponneso, ed in certe
zone come Argo e Sparta governarono una popolazione asservita di greci non dorici. La leggenda spiegava che erano arrivati
solo in tempi recenti: i figli dell’eroe semi-dio Eracle erano stati banditi da Micene, e più tardi ritornarono con l’appoggio dei
Dori a reclamare la loro eredità. La leggenda del ritorno dei figli di Eracle è un mito che spiega in base a quale diritto un
popolo sconosciuto al mondo degli eroi dell’epica abbia ereditato il territorio dei Greci micenei e asservito . una parte della
popolazione che lo abitava. Un secondo gruppo di leggende concerne una espansione dei Greci attraverso l’Egeo, verso la
costa dell’Asia minore: l’espansione che portò allo sviluppo del blocco linguistico e culturale dei Greci ionici. Tali racconti
complessi raccontano della fondazione di singole città, tra cui Atene, ove fecero tappa vari gruppi di profughi che andavano
alla ricerca di nuove sedi. Tucidide descrive come i vincitori di Troia trovassero difficile il ritorno in una madrepatria che non
era più fatta per gli eroi, e come ne conseguissero le emigrazioni. È un resoconto non privo di punti deboli, in quanto egli non
aveva conoscenza del collasso culturale verificatosi nel medioevo, soprattutto perché non comprese se non minimamente la
ricchezza e la potenza della Grecia micenea. Le leggende del periodo delle migrazioni sono confermate in certa mistura dalla
distribuzione dei dialetti nella Grecia storica. Il greco sembra sia entrato in Grecia poco prima del 2000, quando le
testimonianze archeologiche ci avvertono dell’introduzione di una cultura nuova: questi popoli nuovi erano quelli che
sarebbero divenuti i greci micenei. Testimonianze di una lingua precedente, non indoeuropea, possono trovarsi nella
sopravvivenza di certi toponimi. Almeno per il periodo miceneo, nella Lineare B si distinguono le caratteristiche peculiari della
lingua greca. Il greco classico era diviso in vari dialetti legati tra di loro. Il dorico del Peloponneso meridionale e orientale, la
Laconia, l’Argolide e forse la Messenia. Lo ionico in Atttica, nell’Eubea e nel gruppo centrale delle Cicladi, nonché nella parte
centrale della costa dell’Asia minore. Vi erano poi il lesbico, in Tessaglia e Beozia, e l’arcado-ciprio, in Arcadia e Cipro. Il
terzo tipo di testimonianze è di ordine archeologico anche se il loro contributo risulta più ambiguo. Il periodo sub miceneo è
caratterizzato dall’assenza di testimonianze, mentre manca un qualunque indizio dell’influsso di una nuova popolazione.
L’unico cambiamento si rileva nei procedimenti di inumazione. Vengono abbandonate le tombe comuni e gli ampli vani
sepolcrali, per ritornare alla vetusta pratica dell’inumazione individuale in tombe a cista, e gradualmente l’inumazione stessa è
soppiantata dalla cremazione. Circa un secolo dopo il tracollo della cultura micenea, baluginano le prime avvisaglie di una
rinascita. I rinnovati contatti fra Atene e Cipro premisero l’importazione dall’Asia minore del sud di una innovazione
tecnologica quale l’estrazione del ferro tramite fusione: dal 1050 circa il ferrò iniziò a sostituire il bronzo come metallo di
impiego quotidiano. Circa nello stesso periodo cominciò ad emergere ad Atene un nuovo stile di decorazione vascolare, il
proto-geometrico (1050-950 circa), le cui decorazioni consistevano in semplici schemi geometrici ripetuti ed in larghe strisce
di colori scuri oppure chiari. È poi a questo periodo che può essere dato il movimento di Ioni da Atene alla costa dell’Asia
minore, attraverso l’Egeo. Dalla documentazione archeologica sono confermate sia la migrazione ionica, sia l’importanza di
Atene, ma il periodo precedente rimane molto oscuro. Il cambiamento nelle pratiche inumatorie potrebbe rivelare l’arrivo di
una popolazione nuova (Dori), o il ritorno a precedenti costumanze, e le modalità di inumazione non sono sempre documenti di
un avvicendamento degli abitanti. Alcuni archeologi hanno perciò preferito non credere in una invasione dorica, ed affermare
che i diversi raggruppamenti etnici del continente greco vi erano stati presenti fin dall’inizio della cultura micenea. Tuttavia la
più diffusa impressione di discontinuità, lì’abbandono dei vecchi modelli di inumazione, suggeriscono l’influsso di una nuova
popolazione. Sebbene non si possa provare che i Dori abbiano distrutto la cultura micenea , sembra probabile che essi
approfittassero del vuoto che si era venuto a creare.
2 LEFONTI
Le società che non possiedono la scrittura dipendono dalla memoria umana per la trasmissione della conoscenza del passato e
delle informazioni del presente, spesso in forma melodica e metrica. Coloro che raggiungono un’abilità particolare nel
comporre un metro, acquisiscono lo status di portavoce della comunità. Le più antiche testimonianze letterarie della storia
greca sono in versi. L’avvento della scrittura nell’VIII secolo mutò la situazione solo di poco. Una letteratura in prosa
cominciò a svilupparsi solo a metà del VI secolo. Lo “aoidos”, cantore dell’epica, era un poeta orale professionista, che
componeva e recitava prendendo le mosse da un repertorio di materiale tradizionale. L’argomento di cui trattava consisteva
nelle imprese degli eroi di un passato lontano, che si collocava alla fine dell’età micenea. Quest’epica orale fiorì per lo più
nella Ionia, e la sua natura può essere illustrata attraverso le peculiarità linguistiche che essa mostra. Il dialetto dell’epica è
artificiale: ad una base ionica si aggiungono numerosi elementi tratti dall’eolico e da altri dialetti orientali, e il risultato è un
linguaggio le cui forme sono particolarmente idonee al verso esametrico. Il poeta epico si fonda su un lessico interamente
costituito di formule. L’economicità del sistema è tale, che un nome ha raramente più di un epiteto per rendere un particolare
valore metrico. Dunque un poeta orale greco subiva considerevoli limitazioni dalla tradizione. In realtà lo scopo della lingua
formulare dell’epica greca sarebbe quello di agevolare la composizione, non la ripetizione. Non c’è quindi nulla di strano
nell’ipotesi che al termine di una tradizione epica orale stia la figura di un grande artista, il quale continua a richiamarsi alle
realizzazioni dei suoi predecessori, ma ne trasforma l’arte: l’Iliade e l’Odissea attribuite ad Omero. Il secondo poeta epico
greco è Esiodo; operò intorno al 700, ed è il primo poeta che chiama se stesso per nome. All’inizio della Teogonia descrive
come le Muse andassero a trovarlo sul monte Elicona, mentre stava pascolando le pecore, gli dessero la corona d’alloro da
aoidos, ed infondessero in lui una voce divina. L’opera Opere e giorni è invece concepito come indirizzato alla volta di suo
fratello Perse in una contingenza reale: la disputa fra i due sulla spartizione del fondo paterno. Non sembra perciò che Esiodo
appartenga ad una tradizione epica orale allo stresso titolo che Omero. Certamente Esiodo si considerò un aioidos omerico,
tuttavia la sua tecnica non è identificata a quella di un poeta operante all’interno di una tradizione fissa. Dialetto, metro e
lessico sono appresi dall’epica, ma vengono impiegati con una libertà ed una improprietà tali da suggerire che Esiodo abbia
capito solo per metà gli artifici della composizione orale: questo avviene in parte poiché non disponeva di un insieme di
formule adatte alla sua tematica, ed in parte poiché gran parte dei suoi argomenti, dovette riplasmarli partendo dai semplici
ritmi discorsivi dei motti popolari.
Le testimonianze delle iscrizioni vascolari dimostrano che al termine dell’VIII secolo la scrittura alfabetica veniva impiegata
come il medium più ovvio per registrare poesie occasionali e di basso livello. La poesia continuò ad essere un importante
veicolo grazie al quale esprimersi in pubblico nel VII e nel Vi secolo, ma fu influenzata in vari modi dall’introduzione della
scrittura. I riferimenti che si trovano in Omero mostrano come altri tipi di poesia erano già esistiti all’interno dell’epica, anche
se parrebbe che non ci fossero corporazioni di cantori professionisti in grado di assicurare loro sopravvivenza. Assieme alla
scrittura, vari tipi di poesia emersero a determinare identità distinte, e l’esistenza di tradizioni diverse incoraggiò da quel
momento in poi uno sviluppo continuo. La scrittura permise anche la registrazione di ritmi più complessi, e poté fungere quasi
da notazione musicale. Dopo Esiodo, il concetto di poeta come individuo raggiunse la supremazia. Con poche eccezioni, la
poesia lirica non sopravvisse alla fine del mondo antico. Il primo poeta lirico, Archiloco, esemplifica molte tendenze. La sua
poesia, la cui lingua è forse omerica, ma i cui metri sono sia popolari, sia epici, riguarda fatti della sua esistenza. Poesia lirica
vera e propria è prodotta da Alceo (620) e da Saffo (610): entrambi provenienti da Lesbo, ed entrambi membri di famiglie
aristocratiche. Alceo era implicato in lotte politiche contro dei capipopolo e peculiari ne risultano le attitudini politiche,
l’esilio, i viaggi, e le descrizioni della vita militare; Saffo offre uno scorcio non abituale sulla società femminile. Più importanti
per la funzione sociale della poesia sono i poeti didattici quali: Callino di Efeso all’inizio del VII secolo, e Mimnermo di
Clolofone intorno al 600, spronarono i loro concittadini contro i nomadi invasori Cimmeri provenienti dalla Russia meridionale
contro la potenza dilagante della Lidia. Tireo, verso la fine del VII secolo, scrisse per gli spartani che combattevano contro i
vicini Messeni, ed esaltò l’etica sociale dei nuovi eserciti di massa con truppe di armamento pesante, ed il loro ideale governo,
l’eunomia (giusto ordinamento). Cospicua risultò ka sua influenza poetica su Solone di Atene. L’opera poetica attribuita a
Teognide di Megara descrive (540) l’insoddisfazione di un aristocratico per il condizionamento esercitato dei suoi nuovi ricchi
e per il tramonto dei valori tradizionali, e ci fornisce inoltre un quadro della omosessualità delle classi elevate. Senofane invece
scrisse su temi filosofici e scientifici ed attaccò le preferenze dei suoi contemporanei per le virtù atletiche e marziali. La lirica
corale era eseguita normalmente durante le feste religiose o altre grandi occasioni tramite cori di uomini e ragazze istruiti
all’uopo, che cantavano e danzavano con l’accompagnamento musicale. Alcmane ci fornisce con i suoi inni un ‘immagine di
Sparta in contrasto con quella abituale militaresca. Simonide di Ceo (556-468) fu poeta di corte del tiranno ateniese Ipparco e
più tardi commemorò i morti ed i vincitori delle guerre persiane. Per finire, il più grande lirico corale, Pindaro, scrisse nel V
secolo per gli aristocratici ed i sovrani greci che partecipavano ai vari giochi internazionali. La poesia lirica presenta un quadro
complesso e variegato del mondo greco arcaico. La composizione in prosa è connessa a una nuova esigenza, quella di una
precisa analisi critica, ed è un prodotto dell’illuminismo ionico. La prima opera in prosa, il libro di Anassimandro Sulla natura
(550 circa), condusse uno sforzo di formulare una teoria critica e scientifica sulla materia, che cominciò a Mileto con Talete
all’inizio del Vi secolo. Anassimandro cercò di spiegare sia la struttura recondita del mondo fisico, sia lo sviluppo fino alla
creazione dell’uomo: vi fu la sostituzione della scienza al mito. Fu anche il primo geografo ed astronomo greco. I filosofi
continuarono i suoi gli interessi scientifici, ma un fu Ecateo di Mileto che iniziò l’analisi delle società umane. Aveva
un’accurata descrizione geografica. Egli comprese l’importanza del viaggiare e dell’osservare personalmente per la
comprensione del mondo umano. Può inoltre attribuirsi a lui l’eliminazione degli dei dall’ambito della storia.
Per il mondo antico Erodoto fu il padre della storia, ma ebbe anche la reputazione di bugiardo, ed il giudizio generalmente
sfavorevole sulla sua inattendibilità continuò fino al XVI secolo. A patire dal XIX secolo si è ormai accumulata una
conoscenza precisa sulle maggiori civiltà di cui Erodoto aveva scritto, e possiamo cominciare a comprendere l’effettivo
progresso realizzato da Erodoto. La sua opera, che mira a ricordare quanto gli uomini hanno compiuto nel tempo affinché non
fosse dimenticato, è fatta di un susseguirsi di descrizioni dei vari popoli del Mediterraneo e del Vicino Oriente,r accolte attorno
al tema delle guerre fra Greci e Persiani. Nell’ambito di questa struttura di base le digressioni sono di carattere geografico,
etnografico e storico, e spaziano in tutto il mondo conosciuto, fino ai suoi margini misteriosi ed all’oceano che lo circonda. E
Tucidide pensava proprio ad Erodoto, quando asserì che i suoi lettori dovevano aver fiducia nelle sue conclusioni, piuttosto che
in quelle di quei “recitatori” professionisti attenti a presentare le sue storie o logoi in pubblico come pezzi recitativi destinati ad
una fruizione caduca. La raccolta definitiva di queste storie nella struttura narrativa che noi abbiamo fu pubblicata introno al
425, quando il resoconto erodoteo delle cause della guerra persiana venne parodiato dal poeta comico Aristofane. Erodoto
dovette molto ad Ecateo, che aveva senz’alto letto, e che attaccò sia nel suo rapporto con l’Egitto, sia come cartografo: le
prime parti del suo lavoro devono aver trattato gli stessi temi di Ecateo. La costruzione complessa e la tecnica della digressione
erodotee sono poi simili a quelle di Omero, così come lo sono molti dei vari elementi fantasiosi della sua opera. Pochissime
delle fonti di informazione di Erodoto erano scritte, tuttavia sappiamo che era escluso dalla conoscenza delle testimonianze
letterarie e documentarie del vicino Oriente, data la sua ignoranza delle lingue straniere. Il suo lavoro si basava primariamente
su due tipi di testimonianze: ciò che aveva visto, e ciò che aveva sentito dire. È interessante come le informazioni di Erodoto
risultino quantitativamente e qualitativamente molto migliori a partire dalla metà del VII secolo in poi,. Nel continente greco
gran parte delle informazioni di Erodoto provenivano dalle grandi famiglie aristocratiche delle varie città: la tradizione
aristocratica è ovviamente quella più esposta alla distorsione politica. Ad esempio, la storia spartana quale ci è narrata dagli
aristocratici minimizzava le riforme all’epoca di Tirteo, nonché l’importanza del più grande re spartano, Cleomene. Un altro
gruppo di dati della tradizione è molto diverso. Nel loro ambito è importante il santuario di Delfi: la tradizione delfica di solito
è piuttosto filo-popolare e moralizzante. L’ovvia presenza di motivi legati alla tradizione popolare potrebbe suggerire la
presenza di un cantore professionista, anche se la tendenza più chiara è quella di fornire al passato una dimensione morale. I
fatti sono presentati in uno schema in cui l’eroe passa dalla fortuna alla presunzione e ad un rivolgimento della sorte, dovuto al
destino. È uno schema che non fa parte dell’etica aristocratica. Le tradizioni dei greci orientali sono molto più vicine
formalmente alle storie delfiche, che alle tradizioni aristocratiche del continente. Anche in queste non manca certo la
documentazione di una deformazione da addebitarsi a particolari gruppi politici, ma bisogna tener presente che anche nella
storia a noi più prossima vi sono indizi di strutture narrative ricorrenti, motivi folcloristici e distorsioni fondate su esigenze
morali. Risulta così che la sua storia della grecità orientale risulta in pratica meno attendibile della sua storia del continente.
Questa curiosa caratteristica della tradizione nei greci d’Oriente concorda con la struttura generale della storia erodotea (per lo
più moraleggiante). Questo legame tra il modello di Erodoto e quello della grecità orientale ci suggerisce che sussiste nella
Ionia una tradizione moraleggiante di narrativa storica, che sul continente si ritrova solo a Delfi, una tradizione di cui è
rappresentante lo stesso Erodoto: egli avrebbe quindi raccolto insieme i risultati di una tradizione prosastica di racconti
popolari. I suoi contemporanei ateniesi comprendevano in misura scarsa la tradizione ionica all’interno della quale lavoravano,
e trovavano curiosamente antiquati i suoi metodi e le sue attitudini. Aristofane nella sua commedia “Acarnesi” produsse una
parodia della concezione erodotea delle cause del conflitto persiano, mentre Tucidide si fondò su di una reazione contro le
tecniche storiografiche di Erodoto.
La storia tucididea della guerra del Peloponneso, composta ad Atene e nell’esilio durante e poco dopo la guerra stessa (432404), contiene un certo numero di digressioni sulla storia passata, per correggere o rilevare errori. Egli mise in rilievo molte
debolezze della storia del passato composta in base ad una tradizione orale, ma non riuscì ad offrire alcuna alternativa seria:
furono i suoi contemporanei che fecero un passo avanti, volgendosi dalla storia generale a quella locale. La scoperta degli
archivi locali aggiunse una dimensione nuova alla storia del passato. I documenti che sopravvivevano negli archivi locali erano
di interesse primariamente cronologico: elenchi di sacerdoti, vincitori ai giochi e magistrati annuali. Intorno alla fine del V
secolo, Ippia di Elide pubblicò un catalogo dei vincitori olimpici, a partire dal 776. Ellano di Lesbo pubblicò alla fine del V
secolo un’intera serie di storie locali; ne sono esempio “Le sacerdotesse di Era”, una storia che si fondava sui documenti del
famoso tempio di Argo, e una storia locale dell’Attica, che ruotava quasi certamente attorno all’elenco dei magistrati annuali
risalente al 683/682. Nessuno di questi lavori sopravvisse, ma essi furono impiegati dagli autori successivi. Sono
contrassegnati da un interesse antiquario per il mito o le origini, nonché l’importanza che diedero alla cronologia, e i loro
autori provengono spesso da famiglie di sacerdoti, di politici o di politici-sacerdoti. L’influenza degli storici locali più antichi
si può osservare bene nella Costituzione degli ateniesi di Aristotele (l’unica rimasta fra le 158 da lui scritte). Le due parti delle
80 pagine rimaste espongono, una la storia costituzionale fino al 404, l’altra le funzioni specifiche ed il funzionamento della
costituzione stessa al tempo dell’autore. La parte politica contiene una grande quantità di materiale sulla storia politica ed
istituzionale. Vari autori successivi (Strabone, Pausania, Plutarco,…) forniscono occasionalmente ulteriori informazioni, cha
hanno valore per noi soltanto quando derivino da una fonte fededegna. La Biblioteca storica di Diodoro (30 a.C. a Roma) ci
trasmette, nella storia della Grecia arcaica, una sintesi di alcune parti della storia generale del IV secolo di cui fu autore Eforo.
Le prime iscrizioni lunghe più di poche parole sono in versi, ma la scrittura venne ben presto e diffusamente impiegata per
registrare una qualsiasi cosa (incisioni su bronzo, piombo, vasi e pietre, per lo più documenti religiosi o commemorativi o
politici. Le regione mediterranea è stata terreno di caccia per gli archeologi europei da un secolo a questa parte. Le località
meno fruttuose sono quelle ancora abitate, quali Tebe, Siracusa primitiva e Marsiglia greca, mentre maggior successo ebbe il
trasferimento materiale di Delfi in una località più amena ed archeologicamente infruttuosa. Particolarmente fruttuose sono
invece località che vennero abbandonate, oppure abitate in modo discontinuo. Spesso il saccheggio e la successiva
ricostruzione di una città può anche avere un effetto conservativo (arte tardo arcaica = Atene saccheggiata dai Persiani nel 480
e ricostruita da Pericle; le statue dell’Atene dei Pisistrati furono interrate nelle nuove fondamenta). Scavi furono condotti a
Sparta, Egina, Olimpia, Samo, in Argolide, nelle colonie siciliane,…Aree marginali come le tombe regali degli Sciiti o la
Gallia celtica arrecano spesso testimonianze di rilievo per le loro diverse prassi inumatorie, mentre i cimiteri e alcune località
etrusche ci hanno fornito vasellame greco in quantità tale, che nel XVIII secolo si ritennero etruschi i vasi greci. Per fissare
rapporti fra le varie località e le testimonianze archeologiche , bisogna precisare un quadro cronologico; questo quadro per la
Grecia arcaica è determinato dal vasellame: qui la decorazione vascolare era la forma d’arte maggiore, i cui stili variavano da
città a città, e subivano alterazioni continue. Gli stili di varie zone hanno un’estensione non vasta, anche se due città
conquistarono in successione una mercato più ampio: i loro stili ci forniscono una cronologia relativa per le località
archeologiche in generale. Così, le date di fondazione delle colonie siciliane fornite da Tucidide fissano gli inizi dello stile
protocorinzio arcaico, ed il sacco di Atene nel 480 garantisce un altro punto di riferimento fisso alla fine dell’epoca arcaica. Il
vasellame di Corinto fu il primo ad acquisire un’ampia circolazione, e fu l’unico ad essere esportato ampiamente per circa un
secolo: nel VI secolo vennero soppiantati da quelli ateniesi. La decorazione attica a figure nere iniziò sotto l’influenza di
Corinto (610-550), ma in breve tempo acquisì il predominio e la perfezione artistica (570-525). Attorno al 530 era stata
escogitata ad Atene una nuova tecnica di decorazione, la tecnica delle figure rosse, in cui è lo sfondo ad essere colorato di nero.
In termini più generali, il contributo dell’archeologia allo studio della storia greca arcaica è enormemente più cospicuo che per
quasi tutte le altre epoche della storia.
3 LA FINE DELL’OSCURO MEDIOEVO: L’ARISTOCRAZIA
Verso la fine dell’VIII secolo, con Omero ed Esiodo, comincia a rendersi disponibile anche la testimonianza letteraria. Per certi
riguardi la società omerica corrisponde a una tradizione letteraria artificiale. Analogamente si conviene che l’epica omerica
presenta vari elementi secondari provenienti da quasi ogni epoca. La tradizione epica orale esclude consciamente o
inconsapevolmente interi settori dell’esperienza come irrilevanti, oppure come posteriori all’età eroica. Esiste però, per la
società descritta in Omero una base storica, cioè la proiezione nel passato delle istituzioni proprie dell’epoca dell’autore. Lo
suggeriscono le testimonianze archeologiche. La Lineare B ha messo in luce una società completamente diversa da quella
descritta in Omero. Solo verso la fine del medioevo le testimonianze archeologiche e quelle letterarie cominciano a collimare
per una cospicua serie di fenomeni. L’organizzazione architettonica della casa omerica trova i suoi paralleli più stringenti nella
stessa epoca. La fune razione omerica ha luogo tramite la cremazione, il che allontana dall’inumazione micenea, e porta verso
il tardo medioevo ed oltre. Gli esempi più antichi e significativi sono stati reperiti a Salamina di Cipro, i cui governanti a
partire dalla seconda metà dell’VIII secolo praticavano complessi riti funebri omerici. Per generale ammissione, alcuni aspetti
centrali della società omerica si pensa mostrino una confusione di base. Nelle descrizioni di combattimenti, ad esempio, il
cocchio rimane ancora un ingrediente essenziale dell’equipaggiamento aristocratico, anche se scomparve come strumento
bellico alla fine del periodo miceneo, ma la tradizione epica non ne comprende più l’impiego militare, ma è divenuto solo un
mezzo di trasporto per i combattenti. Inoltre il guerriero omerico combatte con un guazzabuglio di armi di epoche differenti.
Tutti i suoi elementi presi singolarmente sembrano appartenere a delle società reali, e quando i differenti elementi possono
essere datati, mostrano la tendenza a dividersi in due categorie: quella degli opachi riflessi degli usi micenei, e quella del più
nitido ritratto del mondo del tardo Medioevo. C’è poi una chiara linea di sviluppo dalle istituzioni descritte da Omero a quelle
che sussistettero nella Grecia più tarda. Le differenze fra il mondo in cui Omero ed Esiodo rappresentano la società non vanno
quindi spiegate su una base cronologica: la società omerica è naturalmente idealizzata, e per risalire indietro nel passato deve
valicare l’ostacolo di generazioni di predecessori, mentre Esiodo è tutto calato nella contemporaneità. Omero descrive anche le
società dall’alto, mentre la visuale esiodea è quella delle classi inferiori, ossessionate dalle meschine ingiustizie del sistema
sociale delle realtà dell’esistenza agricola. Risulta comunque che le deduzioni tratte da Esiodo sono più sicure di quelle tratte
dall’epica eroica. Tema dell’epica omerica sono le attività di grandi personaggi, ed è il loro ambiente ad essere rappresentato
con chiarezza. Il termine basileus, che indica l’eroe omerico, nel greco successivo passa a designare il re, ma nelle tavolette
della Lineare B il re viene a sua volta appellato con il titolo di wanax (citato anche da Omero). In qualche punto della piramide
gerarchica, ma più in basso, è il gruppo di individui che a livello sociale viene designato con quel nome, che sarebbe equivalso
al basileus greco dell’epoca successiva: probabilmente quando scomparve l’economia di palazzo, furono loto ad essere lascati
a capo delle loro comunità. In Omero ed Esiodo basileus viene infatti impiegato in un’accezione più vicina al concetto di
nobiltà: una classe di aristocratici. I basilees ai quali Esiodo fa appello per chiedere sono un gruppo di nobili. La monarchia
cessò di essere un fenomeno di larga diffusione in Grecia all’inizio del medioevo. I basilees della Grecia arcaica sono un
gruppo di aristocratici di nobiltà ereditaria, distinti dal resto della comunità in virtù del loro stile di vita e delle loro ricchezze.
Ognuno è capo di un clan (genos/famiglia/oikos). La famiglia omerica comprende: capofamiglia, moglie e figli adulti con
mogli e prole, assieme a parenti più stretti; alla sua morte i beni vengono divisi in parti uguali fra i suoi figli, che vanno poi a
formare case distinte. I figli maschi avuti da schiave hanno quasi sempre una certa posizione sociale, sebbene inferiore a quella
dei figli della moglie. Il termine kleros individua il possedimento fondiario: i suoi possessi più cari sono la sua famiglia, il suo
oikos e il suo kleros. È sui dettagli della lottizzazione dell’eredità paterna che Esiodo e suo fratello contendono. Al di là di uno
stretto parentado, il genos pare avere scarsa importanza. In generale è la parentela familiare più immediata che conta. Per
l’uccisione di un uomo si parla di tassa di sangue, che va pagata a suo fratello o a suo padre. La struttura patriarcale della
famiglia è provata anche dal fatto che i matrimoni sono combinati dai capi del genos, spesso per ragioni di amicizia politica: la
moglie viene dalla stessa classe sociale. La stipula del matrimonio pare implicasse sia una dota da parte della famiglia dello
sposo a quella della sposa (per buona impressione), sia una dote per la sposa da parte dei suoi parenti. La moglie si aggrega al
genos del marito. La tragedia più grave è la morte prematura del capofamiglia, se la scia dei figli troppo giovani per imporre i
loro diritti. Più in basso nella scala sociale il matrimonio era un problema più pratico, strettamente connesso all’eredità. Esiodo
considera le donne una dannazione mandata da Zeus all’uomo. Un uomo dovrà sposare a trent’anni una vergine che abbia
valicato la pubertà da cinque. L’età suggerita per la donna è avanzata, ed avrà se possibile un figlio solo; nel caso viva più a
lungo, si renderanno disponibili rendite per più di un figlio. L’endogamia rappresentava la norma in Grecia,e serviva a
preservare le strutture vigenti della proprietà: nell’Atene classica una erede poteva venire chiamata a termini di legge come
sposa del parente maschio più prossimo del fratello. Per tutto il periodo arcaico contrarre matrimoni con persone estranee alla
comunità fu un fatto comune fra gli aristocratici, e contribuì notevolmente alla loro potenza politica e allo sviluppo delle
relazioni fra stati. Quando , a metà del V secolo fu promulgata ad Atene una legge per cui in futuro i cittadini avrebbero dovuto
avere parenti ateniesi da parte di entrambi i genitori, si trattò di una mossa populistica ed anti-aristocratica. Una tensione
analoga fra aristocratici e contadini spiega forse lo sviluppo della condizione femminile nella Grecia arcaica. Esiodo riflette
quello che era l’atteggiamento più diffuso nei riguardi delle donne, mentre Omero suggerisce esserci stata un’epoca in cui le
donne dell’aristocrazia disponevano di un’elevata condizione sociale e di una considerevole libertà e potevano: muoversi senza
seguito, discutere da pari coi mariti, presenziare ai banchetti nel megaron, essere responsabili di molte attività economiche
della casa. Nella società greca posteriore, le donne rispettabili stavano confinate per lo più nelle loro stanze. Tale cambiamento
è probabilmente connesso con il passaggio da una vita concentrata sul possedimento fondiario, ad una che aveva il suo centro
nella città. L’esclusiva maschile sulle varie attività (atletica, politica, incontri intellettuali) di gruppo risulta peraltro anche
dall’incremento dell’omosessualità maschile. Scompaiono poi le dori da parte della moglie, e rimangono attestate nella Grecia
classica quelle di parte maritale. Lo spazio immediatamente circostante alla famiglia è quello dell’oikos. Il basileus della
Grecia arcaica lavorava le sue terre con l’aiuto di schiavi ed occasionalmente di salariati. La condizione del lavoratore slariato
(thes) è la peggiore di questo mondo. La vita del bracciante è poco diversa da quella del mendicante, in quanto entrambi sono
uomini liberi che hanno perduto integralmente la loro posizione sociale, e finiscono per dipendere dalla carità di un’altra
persona, ma dei due solo il mendicante è salvato dalla fame grazie alla protezione di Zeus. Questo atteggiamento verso il
lavoro salariato come ventura personale e disonore nella sfera pubblica sarebbe divenuto largamente prevalente in seguito, e
contribuì radicalmente a far dipendere l’economia dal lavoro schiavile. Lo schiavo aveva un suo valore ed una sua ben precisa
posizione nella società, e non era responsabile per la sua sventura. Nelle scorrerie o in azioni di guerra, la prassi abituale era
quella di uccidere i maschi di tutte le città conquistate, e di ridurre in schiavitù donne e bambini; altre forme di
approvvigionamento erano razzie, pirateria e commercio. Le donne erano quindi relativamente frequenti come schiave
domestiche, pochi gli uomini, cresciuti fin dall’infanzia, e tenuti in grande considerazione: venivano preposti a delle fattorie,
ed era loro riconosciuto il diritto di formarsi una famiglia. La fonte primaria della ricchezza nella Grecia arcaica era
l’agricoltura, con lenti cambiamenti (orzo e grano). Anche i lino era coltivato. Esiodo descrive, nell’anno dell’agricoltore, il
momento della semina e dell’aratura (ottobre, quando le Pleiadi sono sopra noi e volano le gru). L’autunno e l’inverno sono
stagioni in cui si intaglia il legno per gli attrezzi. Al sorgere di Arturo (febbraio-marzo) ricomincia il lavoro. L’estate avanzata
è l’unica stagione che Esiodo raccomanda di destinare per il riposo, fino alla vendemmia, che si svolge quando Orione e la
stella del Cane sono al centro del cielo (settembre). Erano poi coltivate diverse qualità di ortaggi e di legumi,e non mancavano
frutteti; poca attenzione era data all’olio d’oliva nell’alimentazione e nell’illuminazione. La Grecia classica si alimentava in
larga misura di cereali, e derivava le proteine dai legumi, , dal pesce e dai latticini. La carne si consumava prevalentemente
durante le festività religiose, tuttavia gli studiosi rilevano che gli eroi omerici ebbero un’alimentazione fondata soprattutto sulla
carne. Per di più la ricchezza era misurata in capi di bestiame,e gli aggettivi che designano la ricchezza fanno talora riferimento
alla disponibilità di armenti. Esiodo non fornisce precetti sull’allevamento del bestiame; tutto ciò riflette il trapasso
dell’agricoltura greca dalla fase ove l’allevamento del bestiame era stato prevalente: problematica rimane la datazione di tale
trapasso, che alcuni studiosi hanno collocato all’inizio del medioevo. Sembra però più probabile che si tratti di un fenomeno
più tardo, probabilmente contemporaneo ad Esiodo. Quando la popolazione cominciò ad aumentare, e ci si spostò verso la
collina, l’allevamento del bestiame fu soppiantato da una cultura del suolo fondata sulla fattoria. A ricordare comunque questa
transizione restano Omero ed Esiodo. La struttura materiale della dimora dei nobili fornisce la chiave per spiegare il rapporto
fra produzione della ricchezza e suo impiego alla base dello stato sociale del basileus. Consiste essenzialmente di una corte, di
stalle, di un portico ove gli ospiti potevano dormire, di camere private ove si depositavano ricchezze ed armi, e risiedevano le
donne, nonché della sala grande, il megaron, una stanza profonda con dei seggi tutt’attorno alle pareti, ed il focolare al centro.
Il padrone di casa poteva disporre di una stanza per sé, oppure dormire nella sala. La scarsità archeologica di case più ampie o
più complesse, ha costituito un problema per gli archeologi, e condotto molti a mettere in rapporto la casa omerica con il
palazzo miceneo. L’economia dell’oikos è però fondata sul possedimento fondiario e suggerisce che ci sia stato un periodo in
cui gli aristocratici vivevano separati dalla comunità. La transizione alla vita urbana rientrava nello stesso sviluppo. Non tutti i
basilees vivevano in campagna. A Zagora di Andro, un complesso abitativo della fine dell’VIII secolo sembra costituisse un
tutto unitario; è collocato nel mezzo dello stanziamento urbano.
La società greca arcaica non era feudale: non sussistevano obbligazioni di classe dovuto all’aristocrazia in cambio della
possibilità di sfruttare il suolo, né vi fu una parte della popolazione distinta nel suo complesso dagli schiavi, ma asservita. La
Grecia arcaica era per lo più una terra di contadini liberi, fra cui la distinzione in aristocrazia e popolo era una distinzione di
sangue e di stile di vita che non risultava confermata da una strutturazione sociale complessa. In assenza di legami permanenti
di fedeltà, e nonostante il carattere ereditario dell’aristocrazia, lo sforzo per raggiungere un proprio status personale portava ad
una società competitiva: lo status era qualcosa di importante, perché attività come la guerra, il fare scorrerie e la pirateria
richiedevano la capacità di procurarsi sostenitori dall’esterno del proprio genos. A tale funzione di far acquisire prestigio
attraverso banchetti di riguardo ottemperava la grande sala del megaron, in cui confluiva una cospicua porzione del surplus di
produzione dell’oikos. Quelli che banchettavano insieme nel megaron erano individui della stessa classe cui apparteneva colui
che li ospitava. Invitarsi a un banchetto era uno scambio reciproco. L’attenzione che i poemi omerici prestano alle descrizioni
dei banchetti non è solo una convenzione letteraria, ma risponde ad una caratteristica fondamentale dello stile di vita
aristocratico. D’latra parte per Esiodo il banchetto ha un significato molto diverso: ognuno porta il proprio contributo a quello
che è un pasto comune. Altre due caratteristiche della società omerica ci hanno soccorso a definire la trama di vincoli, che
sostenne il potere della nobiltà: l’istituzione del rapporto ospitalità-amicizia ed il ruolo del dono all’interno di essa. Anche al di
là della zona geografica circostante il suo dominio nei suoi il basileus poteva aspettarsi di essere il benvenuto, fra gli individui
della sua stessa classe. Lo straniero viaggiava a mani vuote, ma a lui non erano tributati solo il vitto e l’alloggio, ma anche dei
doni, ovunque lo chiedessero. È chiaro che questo era l’obbiettivo ed il guadagno principale di un viaggio in tempo di pace.
Odisseo mostra che tali doni consistevano sempre in oggetti di lusso, e soprattutto in manufatti di metallo, prelevati dal tesoro
delle varie case. Potevano essere doni ricevuti in precedenza. Il contraccambio immediato è costituito dal piacere che l’ospite
dà con i suoi racconti e le sue notizie, ma a formarsi è un rapporto che durerà anche per il futuro. Nel mondo omerico la loro
finalità non è collegata in prima istanza al profitto o ad un eventuale, lontano beneficio, bensì all’acquisto di un titolo d’onore,
e all’istituzione di una trama di obbligazioni. Tali rapporti, da una parte miglioravano la posizione del basileus all’interno della
comunità, dall’altra originavano una schiera di hetanoi che potevano essere reclutati dal basileus stesso, permettendogli di
impegnarsi nelle tradizionali attività della razzia di bestiame e della pirateria. La prima delle due deve avere causato disordini
considerevoli. Le scorrerie sulla terraferma erano considerate faccende in secondo piano, di cui non si parlava; altra cosa erano
le scorrerie per mare. Veniva esercitata a bordo di lunghi vascelli che avevano fino a cinque ordini di remi e una sola vela
primitiva. Sembra che la pirateria sia stata esercitata originariamente contro dei forestieri, non contro i greci. Veniva
generalmente considerata un’attività onorevole. La preda veniva spartita tra i partecipanti in base alla loro posizione nella
bande. Anche se erano in rapporto con gli interessi dell’aristocrazia, queste bande di guerrieri avevano veri modi di beneficare
la comunità. Vi sono vari indizi del fatto che Omero abbia pesato alla spedizione di Troia come un’impresa pubblica. Per
coloro che si sono rifiutati di partecipar, si dà notizia di un’ammenda pubblica, ed anche il banchetto della partenza era a spese
pubbliche e non private. La guerra come istituzione era l’attività per cui la comunità aveva interesse a mantenere la sua
aristocrazie e le sue bande armate. Gli eroi erano i soli ad avere le risorse per comprare il metallo per il loro equipaggiamento.
L’epica orale creò un passato eroico per un particolare gruppo sociale, di cui esaltò il sistema di valori: l’etica che essi
rappresentano ebbe un’influenza permanente sulla morale dei Greci stessi. È un’etica sostanzialmente competitiva, e il suo
lessico concerne principalmente fatti come il successo o l’abilità. Si tratta anche di un’etica individualistica, con eccezione del
dovere di correre in ricorso dell’amico. Le penalità pubbliche consistevano nell’esproprio dei beni, poiché essi erano uno degli
aspetti dell’onore. Gli eroi omerici non negano la propria responsabilità per le loro azioni, ma spesso dichiarano anche che
responsabile è stata una forza divina al loro esterno,e non trovano la cosa compatibile.
Lo stile di vita aristocratico affondava le sue radici nel passato lontano delle bande di guerrieri nomadi, e non scomparve mai
in Grecia. La sua continuità può spiegarsi a partire dalla storia della parola greca phratra, in rapporto di parentela con il termine
che designa fratello, che è comune a quasi tutte le lingue indoeuropee. In greco la parola viene impiegata per designare non una
parentela di sangue, ma piuttosto una fratellanza, cioè un gruppo sociale: ricorre due volte in Omero. Le tribù furono
originariamente divisioni militari, e forse anche le fratrie. Successivamente pare che fratria si sia diffuso per designare una
entità politica inferiore alla tribù. Il potere del genos aristocratico in molte città e fino alle guerre persiane dipese dalla
continuità di questi raggruppamenti politici e sociali, che attorniavano il genos. Queste famiglie aristocratiche ricevevano dalla
tradizione un appoggio di gran lunga più ampio di quelle che potevano vantare la discendenza da un genos. Ne continuarono
altresì anche attitudini meno tangibili: unico era il codice morale. Un terzo elemento di continuità era il ruolo del dono o del
beneficio nell’ambito dei rapporti sociali.
4 LA FINE DEL MEDIOEVO: LA COMUNITA’
L di là del mondo aristocratico dello oikos si trova la comunità nel suo complesso. La distinzione di fondo è tra aristocrazia e
popolo, costituito in primo luogo dalla classe dei contadini liberi. L’artigiano o demiurgos deteneva una posizione ambigua.
Questa classe include sicuramente anche i lavoratori del metallo, mentre gli araldi erano demiurgoi di tipo diverso. La presenza
di outsiders tra gli artigiani è uno dei motivi che spiega la loro ambigua posizione sociale; un altro è che possedevano capacità
assai apprezzate dall’aristocrazia, senza essere aristocratici. Le forme fondamentali dell’organizzazione rimasero invariate
lungo tutto il corso della storia della città-stato. A variare nei diversi periodi furono i poteri che ebbero i vari elementi, nonché i
criteri della partecipazione a ciascuno di essi. Nella Grecia primitiva l’assemblea dei membri maschi adulti della comunità
(agora) era subordinata alla boule (consiglio) degli anziani, che pare consistesse nei capi delle famiglie nobili, i basilees. Le
testimonianze sull’esistenza di un potere esecutivo o di un potere della magistratura, sia che fosse ereditario, che elettivo,
vengono oscurate in Omero dai residui della monarchia micenea. La documentazione di poco successiva mostra molte
variazioni di forma. Il dibattito nell’ambito del consiglio oppure di fronte al popolo era fondamentale nella fase deliberativa,
anche se non c’era alcuna procedura di voto formale. La coppia di attività tradizionali del basileus era costituita dalla guerra e
dal dibattito assembleare, che avevano la stessa importanza. Ci sono in Omero svariate descrizioni dettagliate del momento
della deliberazione e da cui risultano i momenti essenziali della prassi. Gli affari venivano normalmente discussi innanzitutto
in un consiglio di anziani, quindi presentati all’assemblea del popolo. In entrambe le fasi c’era un dibattito, e la possibilità di
dissentire: il ruolo dell’assemblea era piuttosto quello di ascoltare le decisioni del consiglio e di ratificarle. Venivano quindi
riconosciuti il potere e l’importanza dell’opinione pubblica. È il demos che fissa il geras per i nobili. Puntualmente fissati
risultavano anche i rituali e le procedure essenziali nella gestione ordinaria delle assemblee di massa. Essi mostrano notevoli
analogie con i rituali delle sole assemblee posteriori di cui si conoscano in dettaglio le modalità di svolgimento: quelle
dell’Atene aristocratica. Continuità e sviluppo coesistono infatti nella crescita dei meccanismi di governo, dalle primitiva
assemblee di guerrieri d’età omerica fino alla città-stato classica. Al di fuori della sfera politico-militare, la funzione più
importante dei basilees era quella di comporre i contrasti fra singoli cittadini, secondo modalità che stanno alla base della
prassi legislativa e legale della Grecia. La caratteristica del diritto greco consiste nell’essere stato in origine un sistema
concepito dai cittadini per regolare le multe cui si assolveva per i danni arrecati. In Omero il lessico giuridico è concreto, e si
riferisce a casi individuali ed a regole specifiche. Le decisioni prese (dikai) sono diritte o storte nella misura in cui sono
conformi ai costumi (themistes), alle leggi non scritte, ed ai precedenti, che giustificano le decisioni. Un passo omerico ci
descrive l’andamento di un arbitrario formale. I procedimenti erano pubblici, con tutte le cerimonie proprie di un’assemblea in
piena regola. Gli anziani operano come mediatori individuali, e non come giudici; nessuna decisione può essere imposta con la
forza, e l’anziano di cui si accoglie la sentenza riceve un compenso per la mediazione, che viene offerto da una o da tutte e due
le parti implicate nell’arbitrario. L’unica sanzione in grado di raggiungere una soluzione, è rappresentata dalla pressione
dell’opinione pubblica. Non dovettero mancare altre situazioni più o meno anomale. L’omicidio più o meno volontario
costituisce un elemento di tensione nei sistemi di arbitrato, in quanto l’alternativa alla regolazione è una faida di sangue,
dannosa per la comunità. L’opinione pubblica dovrà perciò essere favorevole ad una regolazione e se il prezzo da pagare è
troppo alto, l’uccisore dovrà andare in esilio. Il basileus aveva tra i suoi doveri quello di conciliare le dispute: che però erano
anche una fonte di profitto, in quanto il mediatore del quale veniva colta l’opinione riceveva un premio per la mediazione. Era
questo sistema, che angustiava Esiodo: come egli faceva presente a suo fratello, le uniche due persone che forse si sarebbero
avvantaggiate dalla loro contesa erano i basilees divoratori di doni. Nutriva poi serissimi dubbi sul fatto che il verdetto sarebbe
stato giusto. Fu cos’ che Esiodo calcò quell’importante gradino del pensiero politico, che consistette nel rammentare ai
legislatori l’esistenza della giustizia. In Esiodo dike (giustizia) ha preso il posto di virtù cardinale per la comunità ed i suoi
capi. Il suo interesse per la giustizia sociale lo portò a creare un vocabolario politico. Fa ricorso alla manipolazione del mito,
riplasmandolo in modo da far cadere l’involamento della giustizia della terra nella quinta e peggiore età, quella del ferro.
Anche le strutture dell’argomentazione politica, e i rapporti fra i concetti, vengono formulati secondo modalità che risultano
specificamente greche, e che hanno avuto effetti duraturi sulla tradizione culturale della personificazione del mondo orientale. I
concetti che derivano da istituzioni concrete divengono astratti, acquistando lao statuto di divinità, e le connessioni fra queste
astrazioni sono espresse in termini di rapporti familiari. La forma caratteristica di organizzazione sociale dei Greci era la polis
o città-stato, la piccola comunità indipendente che si autogovernava e si circoscriveva nei confini di un territorio urbano e della
campagna circostante. Motivo centrale della storia greca è lo sviluppo che portò la città-stato a divenire forma di governo
predominante nel mondo di lingua greca per circa un millennio. Tale sviluppo permise agli abitanti della città di controllare
direttamente e completamente il loro governo, e di raggiungere una leale partecipazione allo stato locale che non sarebbe stata
eguagliata da nessuna società moderna. Quando e dove sorse la polis? La polis mostra di esistere in tutti i suoi aspetti
fondamentali già verso la fine del medioevo. Anche se Omero conobbe l’esistenza della polis, fu Esiodo a conferire ad essa il
linguaggio dell’autocoscienza, ergendosi ai primordi della speculazione greca sulla politica, sulla scienza e sulla teologia.
Le caratteristiche fisiche della polis dal tardo medioevo sono descritte in Omero: le mura sono la caratteristica comune (es.
Smirne, identificata come la città descritta da Nausicaa in Omero, le cui mura furono più volte ricostruite). I centri urbani
fortificati devono essere stati comuni intorno all’VIII secolo. Se si prescinde dalla cinta muraria, la testimonianza più antica
delle istituzioni civiche è quasi sempre il tempio, in quanto luogo deputato all’assemblea (agora). I più antichi risalgono alla
metà dell’VIII secolo,ed intorno al 700 cominciano a comparire in quasi tutti i centri urbani. La crescente importanza della vita
urbana e delle istituzioni urbane è in rapporto con altri mutamenti: il passaggio alla coltivazione stanziale del suolo tramite
aratura, il declino dell’importanza dell’oikos come fenomeno sociale, l’incremento demografico. Fra 800 e 700 si calcola,
anche in base alle inumazioni, che la popolazione dell’Attica sia aumentata di circa sei volte.
La religione dei greci non deve mai essere stata troppo unitaria, in quanto fu politeista e differenziata dia cronicamente. Gli
elementi indoeuropei si fusero con elementi cicladici pre-greci e con altri derivati da culti minoici ed anatolici. L’unità che la
religione greca avrebbe avuto, subentrò più tardi, come osserva Erodoto, ed era prima caratterizzata da miti, rituali e credenze
variegate. Interessante risulta la considerazione che la religione greca avrebbe avuto inizio con Omero ed Esiodo, anche se le
pratiche effettive di culto potevano variare rispetto alla situazione che essi descrivevano. La consistente tendenza
all’antropomorfismo e all’organizzazione del mondo degli dei in termini di rapporti sociali e politici è una peculiarità che
deriva dall’epica la forza d’inerzia che la fece conservare. Un’uniformità come quella posseduta dalla religione greca deriva
molto dalla rappresentazione che degli dei olimpici ed inferiori avevano lasciato Omero ed Esiodo. D’altra parte c’è un’intera
area dell’esperienza religiosa, quella dei culti della fertilità, dei riti orgiastici,d ella propiziazione dei morti e del culto degli
eroi, che risulta ignorata dai due poeti epici e dalle fonti letterarie posteriori, eppure sopravvisse al silenzio che su esse fu
stesso da Omero ed Esiodo. La maggior parte delle pratiche fondamentali della religione greca risalgono indietro fino al
medioevo. È peculiare della Grecia arcaica che la nobiltà celebrasse da sola la maggior parte dei riti religiosi della città, in virtù
di un’investitura sacerdotale. I santuari degli oracoli erano altrettanto largamente noti. Le testimonianze che si ricavano
dall’epica greca possono essere fuorvianti, ma possono essere messe in relazione con lo sviluppo successivo della società
greca.
5 SOCIETA’ E COMMERCIO IN EUBEA
Uno dei fattori di maggior rilievo che condussero al rinnovamento nella Grecia primitiva fu il mare. Il mondo dopo le
migrazioni del medioevo fu ben presto più un’unità di spazi marittimi che terrestri. Il commercio di piccolo cabotaggio non
sarebbe mai stato un’attività in grado di conferire un alto rango sociale. I precetti esiodei sulla navigazione riguardano
soprattutto i periodi in cui non si deve andare per mare e i motivi di ciò: la sua cupa valutazione del commercio è fondata
sull’esperienza del padre, e riflette gli scarsi profitti ed i seri rischi. Questa non era la sola forma di commercio. Nel il periodo
arcaico non si è riusciti a distinguere fra commercio locale e commercio a lunga distanza, ed hanno fatto proprio un modello di
attività commerciale che risulta appropriata in effetti solo per le condizioni economiche più evolute del periodo tardo-arcaico e
classico. Si tende quindi a sottovalutare l’importanza dell’attività di scambio nella Grecia primitiva. Fu l’aristocrazia a
conferire lo slancio iniziale ad una esplorazione più ampia, oltre i confini dell’Egeo, quando determinò la domanda per il
consumo di metalli (per lo più ferro) e di beni di lusso, necessari allo stile di vita di un’aristocrazia sempre più agiata. Una
delle aree che potevano rifornire di entrambe le merci era il Vicino Oriente. I primi contatti si instaurarono con i Cananiti delle
costa levantina, che i greci conobbero come Fenici (da porpora, phoinix, estratta dal mollusco murex). Le città costiere della
Fenicia controllavano le grandi foreste di pini e di abeti del Libano (per l’Egitto e re Salomone), e dovevano la loro prosperità
a ciò e alla loro posizione centrale fra Mesopotamia ed Egitto. Il crollo ittita ed egizio all’inizio del medioevo diede loro
indipendenza, fino alla conquista di Alessandro il Grande. La cultura fenicia era a base urbana: le città erano di solito
indipendenti tra loro, ed arroccate su isole e penisole fortificate. La loro arte mostra le caratteristiche di una civiltà dedita al
commercio. Secondo Odisseo, i Fenici sarebbero stati mercanti che dai greci erano considerati dei benvenuti, ma anche
persone non degne di fede. Il commercio occasionale va dal X all’VIII secolo, mentre è dal IX che iniziarono rapporti più
stabili, quando i Fenici fondarono Kition a Cipro. Molti aspetti della cultura e dello sviluppo sono tanto simili nei Fenici e nelle
città greche di questo periodo: città-stato in fase di rapida espansione, con simili aree di abitazione fortificate. Almeno
all’inizio i contatti avvennero su un piano amichevole. La cultura fenicia era più avanzata ed alfabetizzata. I Fenici possono
aver giocato un ruolo pioneristico nell’apertura al commercio del Mediterraneo occidentale, e alla fondazione di colonie in
quella zone: la fondazione di Cartagine (814/813) precede di un paio di generazioni qualsiasi sorta di espansione greca. Ai
Fenici va riconosciuto il passaggio all’uso alla nave a tre ordini di remi, nonché l’aver mostrato ai greci l’importanza ed i
vantaggi potenziali del commercio e della potenza marittima. Conseguenza finale di questi contatti sempre maggiori fu una
conflittualità sempre maggiore su Cipro, e la rivalità per il controllo dell’Occidente, che dal VII secolo in poi portò alla
definizione di sfere di interesse esclusive nel Mediterraneo orientale, nell’Africa del Nord, in Sicilia e in Spagna. La seconda
fase dei contatti dei greci con l’Est si ebbe con l’insediamento di stazioni commerciali greche permanenti. Gli scavi di Leonard
Woolley, dal 1936 al 1949, lo portarono ad asserire che la linea di contatto fra Grecia ed Oriente, sia in epoca micenea che nel
periodo arcaico della storia greca, doveva correre tra le sfere dell’influenza ittita ed egiziana, e quindi su per la valle
dell’Oronte, e sui confini della Turchia e della Siria: in una serie di scavi programmatici egli arrivò a fissare la storia di questi
commerci. La vallata dell’Oronte era ben nota ai Micenei, ma non si hanno tracce di una presenza greca durante il medioevo,
fin tanto che, poco prima dell’800, si ebbe lì’insediamento presso Al mina alla foce del fiume di quella che sarebbe diventata
una stazione commerciale di prima grandezza. Gli scavi hanno svelato i quartieri commerciali di un grande porto in tutta una
serie di strati che contengono magazzini, uffici e negozi. Non mancano in alcuni casi testimonianze di un commercio
specializzato (ceramica, avorio, argento). Questo rimase il più importante porto degli scambi commerciali con l’Oriente fino
almeno al 600. i reperti vascolari dimostrano che la località fu occupata fin dall’inizio da Fenici, Ciprioti e Greci. La
produzione vascolare greco-arcaica che ci si riscontra si può dividere in due fasi, una dall’800 al 700, quando avvenne
un’interruzione nell’occupazione dalla località (conquistata dall’assiro Sargon); forme e decorazioni dei reperti vascolari greci
in questa fase arcaica sono caratterizzati peculiarmente e gli scavi più recenti hanno dimostrato che provengono dall’Eubea. Il
luogo il luogo in cui questi coloni dell’Eubea stabilirono i loro insediamenti mostra i segni tipici di una stazione di posta. Esso
si trova ai margini di un’area altamente civilizzata, sui quali risultava ridotto il controllo del potere politico, e dai quali si
poteva avere adito ai beni di lusso della Mesopotamia, della Fenicia e dell’Egitto. Venivano inoltre sfruttati di lì i metalli
dell’Anatolia sud-orientale. Mentre Tarso era abitata dai greci come una città pienamente loro, Al Mina era un empoiron o
stazione commerciale abitata da una comunità mista, la cui mistione deve essersi riflessa nell’organizzazione politica e
religiosa. I Greci vi acquistavano ferro, manufatti metallici, tessuti, oggetti in avorio ed altri monili preziosi. Nell’area egea è
relativamente comune l’argento, e l’interesse che le città euboiche ebbero per regioni arretrate come quelle occidentali e
settentrionali della Grecia, suggerisce che si siano dedicati alle razzie di schiavi per finanziare il loro traffico commerciale con
l’Oriente.
La stessa struttura degli scambi sta cominciando a chiarirsi per l’Occidente. La colonia occidentale più antica dei greci rimase
quella dislocata sulla baia di Napoli, fondata originariamente per iniziativa congiunta delle due maggiori città dell’Eubea,
Calcide er Eretria, sull’isola di Pitecusa (attorno al 775); un insediamento si ebbe ben presto anche sull’adiacente penisola. In
un secondo momento, in seguito a disordini politici la maggioranza degli abitanti si trasferì sulla terraferma, ove fondò Cuma. I
primi reperti vascolari sono euboici e corinzi; una delle principali attività era l’estrazione del ferro per fusione. I sepolcri più
antichi mostrano un elevato grado di raffinatezza e contengono un gran numero di manufatti orientali, forse portati tramite la
via commerciale che passava per Al Mina. La storia dello stanziamento greco nella baia di Napoli è parallela allo storia di Al
Mina. Il primo può essere stato una colonia di Calcide ed Eretri, e più difficilmente sarà sorto come stazione commerciale.
Ancora una volta, lo stanziamento era avvenuto sul margine della sfera d’influenza di una nazione molto potente, gli etruschi.
Di etruschi non si parla in Omero; essi compaiono per la prima volta in Esiodo, nonché nell’arcaico inno a Dioniso (che fu
rapito da essi). Il processo di urbanizzazione dei centri etruschi a partire dall’VIII secolo può essere stato un naturale sviluppo,
ma è un dato di fatto che il contatto con i Greci trasformò la cultura etrusca per moltissimi aspetti. I primordi della cultura
etrusca sono contrassegnati da una fase orientalizzante: i primi inizi dell’attività di importazioni dall’Oriente cominciarono
intorno al 750. tuttavia i manufatti orientali che l’Etruria ci ha lasciato non sono di provenienza lidia, e non presentano alcuna
differenza rispetto a quelli ritrovati nei centri greci dello stesso periodo. Sembra quindi improbabile che il commercio di queste
merci non fosse in mano agli Etruschi o ai Fenici, bensì ai Greci: a Vei in Etriuria si hanno reperti vascolari anche anteriori al
750. è un’illazione, questa, confortata dal dato di fatto cha alla fase orientalizzante fa seguito a partire dal 600 un periodo in cui
la cultura etrusca viene inondata da merci e tecniche artistiche di importazione greca, mentre l’adeguazione al modello etrusco
dell’alfabeto e della tattica di fanteria dei greci è indizio ulteriore dell’importanza delle relazioni fra questi ultimi e l’Etruria. I
successivi contrasti sono la conseguenza dei precedenti stretti contatti. Ha così inizio l’ellenizzazione dell’Italia.
La via commerciale che è dato seguire dal Vicino Oriente fino all’Etruria, attraverso Al Mina e Pitecusa, fu in prima istanza
prodotto della necessità di metalli e di beni di lusso da parte dell’aristocrazia euboica. Il periodo dal 750 al 700 fu quello in cui
si costruirono i templi di dimensioni maggiori, e nel secolo successivo si realizzarono numerose opere pubbliche di
fortificazione e di controllo del corso del fiume (dagli scavi di Eretria, Clacide non è ancora stata riportata alla luce). La
mancanza di resti anteriori si può spiegare forse rammentando la presenza di una località che costituiva la sede primitiva di
Eretria (Lefkandi) e che vi sia stato uno spostamento verso il tarso IX secolo verso l’attuale Eretria. L’importanza del centro
vicino a Lefkantdi viene suffragata dalla quantità relativamente cospicua di ornamenti d’oro e di manufatti d’importazione
orientale, che è dato trovare nelle tombe, mentre l’esercizio della metallurgia è documentato dalla presenza di una fonderia per
il bronzo databile al IX secolo. Un pallido riflesso degli ultimi tempi di questa società sopravvive nelle fonti letterarie, che ci
ricordano un grave conflitto fra Calcide ed Eretria per il possesso della pianura lelantina. Una breve frase di Tucidide lo
confronta con le precedenti guerre di frontiera. Le testimonianze non delineano il quadro di spedizioni congiunte o di grandi
alleanze, bensì piuttosto di una serie di limitati scontri di frontiera, che avevano il loro epicentro nella pianura lelatina.
L’originaria cooperazione fra Calcide ed Eretria terminò bruscamente (questo spiega la fondazione di Cuma). I Corinzi
cacciarono da Corcia i coloni eretriesi nel 733, ed i Calcidesi di Sicilia espulsero da Lentini i coloni megaresi, mentre Corinto e
Samo aiutarono Sparta contro i Messeni. Tutti questi vari episodi sembrano riferirsi all’ultimo trentennio dell’VIII secolo, e la
conseguenza di tale serie di conflitti fu un sistema di allineamenti che rimase notevolmente stabile nel secolo successivo, ed
ebbe grande influenza sulla geografia politica ed economica dell’espansione coloniale greca. Gli eretriesi ed i loro alleati
vennero tagliati fuori dell’Occidente ad opera di Calcide e Corinto, e l’oracolo di Delfi stabilì stretti legami con la
colonizzazione dell’Occidente e con gli alleati di Corinto. D’altra parte la posizione di Eritrea e Mileto era più forte nella zona
del Mar Nero. Sono due i fattori che trasformarono una guerra di confine in un conflitto di maggiori proporzioni: le due città
implicate si trovavano al centro di un reticolo di traffici commerciali intrapresi dalla aristocrazia; nel nuovo mondo della polis
l’istituzionalizzazione sempre più diffusa del rango di questi aristocratici comportò il fatto che essi finirono per poter parlare
come magistrati a nome delle loro comunità, e per implicarle così per la prima volta nell’ambito delle relazioni politiche
internazionali. Il trapasso dalla famiglia aristocratica alla città-stato ha preso corpo nel campo dei rapporti internazionali. Nella
Grecia classica uno stato doveva nominare suo rappresentane all’estero un individuo nativo di uno stato straniero ed
appartenente ad una famiglia in vista di quest’ultimo, che fosse legato alla città che rappresentava da un vincolo di proxenia
ereditaria, oppure se fosse egli stesso ospite-amico. La guerra lelatina fu inoltra l’ultima ad essere combattuta secondo il
vecchio stile, e dagli esponenti di punta di questo stile. Si trattò di una vera e propria battaglia epica; ad uno ad uno cadono i
campioni. Gli scavi di Eretria (oltre alle fonti letterarie) hanno messo in luce un santuario con molte offerte votive e resti di
sacrifici databili al VII secolo e collocati al di sopra di sei cremazioni di guerrieri che risalgono al periodo 720-680. È incerto
quale sia stata la durata della guerra, e quale l’esito. I Calcidesi ebbero la meglio in uno scontro con l’aiuto dei Tessali, ma la
documentazione archeologica eretriese suggerisce che quest’ultima non abbia subito una sconfitta di grande rilievo. Lefkandi,
a metà strada, venne abbandonata del tutto. Ad Al Mina paiono essersi sostanzialmente esauriti gli interessi euboici: dopo
l’epoca di trapasso (700), i reperti vascolari dal VI secolo sono per lo più corinzi, oppure della Grecia orientale. Pare che
nessuno dei due abbia tratto profitto dalla guerra. Il loro potere passò nelle mani di altri.
6 IL PERIODO ORIENTALIZZANTE
Il contatto con il Vicino Oriente introdusse molti cambiamenti nella società greca durante il secolo 750-650. Alcuni furono
esclusivamente pratici, come l’introduzione dell’allevamento del pollo, assente in Omero ed Esiodo. Non mancano altre
innovazioni nei costumi sociali, come l’abitudine di distendersi su lettini durante i banchetti, piuttosto che stare seduti. La
trasformazione del banchetto dei guerrieri omerici nel simposio aristocratico con i suoi elaborati rituali che regolavano le
bevute, i suoi giochi, i suoi canti, le sue gare di poesia e di eloquenza, le danzatrici o gli efebi, e la sua sessualità, rappresenta
uno dei mutamenti più significativi nella vita dell’aristocratico greco. Gli stretti rapporti fra greci e fenici sono comprovati da
un gran numero di termini semitici mutuati dal greco, specialmente nel campo della cultura materiale.
Le radici psicologiche del convenzionalismo nell’arte sono state studiate da Ernst Gombrich nella sua opera Arte e illusione,
secondo cui l’artista viene condizionato da una serie di schemi visivi che gli derivano dalla tradizione artistica,ed in rapporto ai
quali egli interpreta il suo lavoro e decidere se creare disegni astratti o rappresentare il mondo esterno o interiore. I
cambiamenti avvengono assieme a pressioni sociali, tecnologiche o estetiche e in risposta al genio individuale, ma in una
società tradizionale, che pone l’accento sul momento artigianale e tradizionale, piuttosto che sull’originalità. Erano gli stessi
artigiani greci che (dalla fine del IX secolo) viaggiavano alla volta dei centri di distribuzione ed installavano i loro laboratori
belle stazioni commerciali, ove entrare in contatto con gli artigiani d’Oriente. Riusciamo a seguire tali spostamenti attraverso i
manufatti. Nonostante l’importanza di tali contatti, l’importazione dei manufatti già elaborati rimase più comune nella storia
dell’arte occidentale. La ceramica non fu oggetto di importazione in Grecia, poiché i greci erano in grado di produrre vasi
superiori a quelli d’Oriente, mentre oggetti di primaria importazione erano i metalli e i tessuti. Lo stile geometrico della
decorazione vascolare fu relativamente omogeneo fra zone diverse, anche se il centro di maggior sviluppo fu Atene. Quando
furono introdotte, le figure naturalistiche comparvero sul bordo o sul collo del vaso (animaletti o scene in un piccolo pannello).
Lo stile orientalizzante della ceramica fa la sua prima comparsa a Corinto intorno al 725, nella forma proto-corinzio; qualche
tempo dopo le stesse tendenze compaiono anche nella ceramica ateniese. Ben presto affiorano altri stili locali orientalizzanti, e
nel giro di un cinquantennio la trasformazione fu completa. I cambiamenti riguardarono il repertorio dei motivi e le tecniche
per tracciarli. Le figure a contorno del geometrico vennero rimpiazzate da una combinazione flessibile di figure sagomate nere
con i dettagli dipinti sopra e di disegni di linee ed ulteriori colori. La nuova libertà di cui disponeva nel tracciare le linee
permetteva varie fogge di disegni incurvati, di spirali e di riccioli. La tendenza ad un relativo naturalismo (piante, boccioli,…)
è rivelata dal gusto per la raffigurazione di animali e per l’ideazione di fregi di cui gli animali fossero componente essenziale
(veri, sentiti o inventati). Risultato di tale rappresentazione orientalizzante degli animali non fu ovviamente un’attenzione più
diligente al mondo reale, quanto piuttosto uno spazio maggiore per l’immaginazione: naturalismo quindi, non realismo. Nella
raffigurazione della figura umana si dà corpo alle astratte proporzioni del geometrico, in modo da produrre una libertà di
movimento e di espressione, che incoraggia a rappresentare le emozioni ed a svolgere narrativamente le azioni (es. vaso di
Chigi, 650). Le fonti di alcune nuove tecniche sono identificabili con facilità: l’incisione dei dettagli deve derivare
dall’imitazione dei manufatti metallici a sbalzo. Ci sfugge l’influenza delle stoffe. Stili decorativi o motivi particolari
sembrerebbero riprendere da vicino tessuti ricamati, orditi o stampati. Lo stile orientalizzante durò circa un secolo, sino a
quando lo stile a figure nere non ebbe esaurito le sue manifestazioni più esuberanti. La sua importanza è stata spesso
sottovalutata dagli storici dell’arte.
La trasmissione delle idee religiose non è mai un tema facile: quando un’idea, un insegnamento o un rituale oltrepassa una
frontiera culturale, risente di un cambiamento radicale, che se il passaggio avviene fra due zone contigue non è sempre facile
marcare. Ogni fenomeno straniero viene frainteso e reinterpretato fino a quando non si è adeguato agli schemi religiosi e
sociali preesistenti. Non dimeno, ideologie nuove contribuiscono ad istituire un nuovo ordinamento religioso, e perciò
influenzano le basi della società. Ne è esempio il culto di Adone, di origine medio-orientale, il cui mito penetrò in Grecia e che
qui conservò molti elementi connessi al suo ruolo originale di dio mortale della vegetazione. I Greci erano coscienti di questo
aspetto. I rituali ad esso relativi hanno subito mutamenti corrispondenti. Il culto greco di Adone era opposto per vari aspetti ai
riti indigeni della fertilità: a differenza di questi ultimi, era un culto piuttosto privato che pubblico, praticato dalle donne di
ogni classe, comprese straniere e prostitute, e veniva considerato un periodo di disordine femminile. Caratteristica essenziale
del culto presso i greci fu il lamento rituale per la morte di Adone, ma anche questo non coincideva con una celebrazione della
morte e della rinascita della vegetazione. Le litanie delle donne compiangono in Adone piuttosto il frutto proibito,
quell’amante fantastico di cui la società le ha private, nonché quelle frontiere del desiderio. Saffo fornisce la prima
testimonianza sul culto di Adone presso i greci. Le trasformazioni che si verificarono nella versione occidentale agirono più sul
mito che sul rito culturale. Esiodo mostra come la sistematizzazione del pensiero teologico greco venisse ispirata a modelli
dell’Occidente. Il principio centrale che organizza la Teogonia è un mito di successione, che strutturalmente e nei dettagli
mostra un’affinità stratta con i miti di successione orientali. Tra di essi ci sono noti con ricchezza nei particolari: il mito
babilonese della creazione (1000 a.C. circa); il secondo mito di successione è quello di Kumarbi (Urriti); un’opera scritta in
greco da un certo Erennio Filone di Biblo. Alcuni particolari del mito che troviamoin Esiodo presentano riscontri nei testi
babilonesi. Non ci deve aspettare una corrispondenza esatta tra miti di questo genere. L’influenza dell’Oriente sulle strutture di
base del sistema teogonico esiodeo è chiara, ma rimane controversa l’epoca in cui tale influenza cominciò ad operare sul mito
greco: dalla datazione dell’inizio di essa dipende il problema dell’originalità e dell’indipendenza di Esiodo come pensatore. Un
certo numero di studiosi pensa che il mito di successione greco sia più antico di Esiodo, e debba perciò risalire al tempo dei
contatti fra Est e mondo miceneo, sopravvissuto al medioevo, collateralmente o dentro la tradizione epica omerica. Un lessico
specifico indipendente dall’epica di Omero non è documentato in Esiodo: quel lessico specifico che ci aspetteremmo invece, se
ci fosse stata una tradizione teogonica alternativa saldamente fondata e dotata di un proprio linguaggio formulare. Per di più,
non c’è traccia nei poemi omerici di quegli elementi orientali che hanno tanta importanza in Esiodo. Un certo numero di tratti
orientali penetrò nella religione greca certamente già in tempi remoti, e soprattutto dall’Asia minore: Apollo, Artemide, Efesto
ed Afrodite. Inoltre la soluzione di continuità rappresentata dal medioevo rende assai improbabile che corrispondenze di questo
genere potessero sopravvivere in assenza di uno specifico contesto linguistico, o di un clero o di un complesso di riti specifici.
In alternativa, Esiodo va accettato come istitutore della poesia teogonica greca. Dopo aver portato ordine nel mondo degli dei,
nelle Opere e giorni Ediodo cercò di raggiungere lo stesso scopo per il mondo degli uomini. Per spiegare i motivi della durezza
della vita umana egli ci narra due miti: il mito di Prometeo (e del vaso di Pandora); il mito che narra come abbiano abitato la
terra cinque razze umane; dell’oro, dell’argento, del bronzo, degli eroi e del ferro (deterioramento progressivo). Tale mito trova
in Oriente parecchi paralleli analoghi. Nonostante il suo debito a modelli forestieri, il pensiero esiodeo ha una sua propria
coerenza e gode di uno spicco suo proprio. Abbiamo visto come le preoccupazioni sociali portassero Esiodo a mettere in
relazione mondo divino e mondo umano tramite una serie di genealogie che facevano derivare da divinità i concetti politici
astratti; ciò non trova parallelo in Omero. L’esempio di Esiodo ha per altri due aspetti importanti implicazioni nello sviluppo
del pensiero greco. La separazione di mito e rituale non può essergli attribuita per intero, poiché si trova anche in Omero,
tuttavia le origini straniere di tanta parte del suo sistema teogonico devono aver portato ad una scissione netta fra mito e rituale.
In secondo luogo egli fondò la tradizione greca della speculazione teogonica sul collocamento degli dei nell’ambito
dell’universo, ed in particolare sul ruolo nella creazione del mondo. Inoltre le sue idee trovano paralleli orientali nel mito della
creazione babilonese e nel libro della genesi.
Omero ci descrive una società che non conosceva la scrittura. L’impegno di vari termini successivamente connessi con la
scrittura, suggerisce che il poeta abbia sì potuto conoscerne la tecnica, ma l’abbia considerata come non eroica. I greci avevano
ben chiaro che il loro sistema di scrittura derivava di Fenici (lettere/phoinikeia = cose fenice). Erodoto narra come i Fenici
durante il regno di Cadmo si stanziassero a Tebe e introducessero in Grecia rudimenti tecnici quali la scrittura. Alla base dei
sistemi di scrittura del Vicino Oriente e dell’Egitto stavano due principi: pittografico, con ideogrammi; astratto, e comporta la
rappresentazione sistematica delle sillabe. Le scritture semitiche che si svilupparono durante il secondo millennio a.C. devono
derivare in qualche modo da questi metodi primitivi, anche se rimane oscuro il modo in cui ne trassero origine. Il sistema di
scrittura che si venne perfezionando nella Fenicia, non è altro che una semplificazione del principio sillabico in cui si ignorano
i cambiamenti di vocale. Ne risultò un sistema di scrittura che fissava in primo luogo le consonanti. Le conseguenze
dell’enorme vantaggio comportato dalla semplificazione sono ben esposte da Giuseppe Flavio. Il rapporto di scrittura greco e
fenicio è molto stretto. La forma delle lettere greche nasce da un adattamento di quelle fenicie; il loro ordine è sostanzialmente
lo stesso. L’adattamento del greco al fenicio è per lo più meccanico, tranne che per l’invenzione delle vocali che la trasformò
in una scrittura alfabetica vera e propria. Eppure, la forma della maggior parte delle vocali greche deriva da quelle delle lettere
consonantiche o semi-consonantiche che i greci non adottarono,e ne conserva anche la posizione all’interno dell’alfabeto.
L’invenzione dell’alfabeto greco deve essere stato opera di un gruppo ristretto o di un singolo sconosciuto. I prestiti mutuati
dal fenicio hanno probabilmente avuto luogo in una comunità mista fenicio-greca, o in un ambiente con stretti contatti tra i
due. Si ritiene poi che presero le mosse da un centro al quale si poteva avere rapida e facile diffusione. L’ipotesi più probabile
è che dei mercanti greci abbiano adottato la tecnica della scrittura dai mercanti fenici in una stazione commerciale come Al
Mina. A complicare l’enigma intervengono altri problemi. La prima testimonianza databile sull’esistenza dell’alfabeto greco ci
proviene dalla ceramica, ed è del periodo 750-700: un vaso geometrico ateniese su cui è inciso un verso esametrico, o
dell’iscrizione in alfabeto calci dense su di una coppa greco-orientale che è stata rinvenuta on un sepolcro di Ischia. Fu
probabilmente da questi coloni euboici della baia di Napoli, che l’alfabeto passò agli etruschi all’inizio del VII secolo,
conservando per le lettere fogge connesse con quelle dell’alfabeto calcidense. Altri documenti ci suggeriscono che nel periodo
750-650 la scrittura acquisì un’ampia diffusione in Grecia (poemti quali Esiodo ed Archiloco e lo stesso Omero, elenchi di
magistrati ateniesi nel 683, le date di fonazione delle colonie greche in Sicilia dopo il 734, leggi scritte del VII secolo…). Non
si è mancato di dibattere se quelli che noi possediamo sono veramente gli esempi più antichi della scrittura in Grecia. Questi
problemi cesserebbero una volta che si sia accolta l’ipotesi di un’invenzione e diffusione della scrittura stessa in ambito
mercantile. L’alfabetizzazione avrà allora seguito le stessa strade commerciali che a metà dell’VIII secolo erano percorse dai
manufatti dell’Oriente. La velocità di diffusione del nuovo medium sarà misurata in termini di decenni, piuttosto che di
generazioni. L’esistenza di varianti locali dell’alfabeto può continuare ad attestare una conseguenza del fatto che la
trasmissione si sia attuata per l’iniziativa inesperta dei mercanti locali. Questo spiega perché in Grecia l’alfabetizzazione non
sia mai rimasta confinata ad un gruppo o ad una classe particolari. L’ampia gamma di soggetti che si ritrova nelle iscrizioni
arcaiche suggerisce un’ampia diffusione dell’impiego della scrittura. La scrittura pare poi che sia stata adottata frequentemente
come medium della composizione poetica. Risultano forse ancora più significativi i numerosi esempi di scrittura di livello
scolastico o semi alfabetizzato. Vi erano poi i messaggi lasciati da dei mercenari greci. Ciò che questi documenti occasionali
mettono in evidenza è che nelle culture primitive il concetto di forma corrente delle lettere, di corretta ortografia o di
grammatica emerge solo quando si verificano le circostanze di una alfabetizzazione ristretta ad un certo circolo. In media
quindi qualunque individuo di sesso maschile sapeva sia leggere che scrivere. È pertanto errato postulare il professionismo di
una cerchi ristretta di addetti alla scrittura nel corso del VII e del VI secolo. La Grecia arcaica era una società alfabetizzata in
senso moderno. La Grecia rimase però in linea generale ad uno stadio di cultura orale. I testi letterari avevano una circolazione
ristretta ed erano letti solo da una minoranza, mentre la scrittura era solo raramente il medium preferito. Nonostante ciò non si
può sottovalutare le conseguenze che l’alfabetizzazione ebbe per la Grecia arcaica. Goody e Watt hanno provato che l’avvento
dell’alfabetizzazione è l’unica autentica rivoluzione nell’ambito della storia della scrittura, in quanto è l’unica occasione in cui
una tecnica sia stata trasmessa allo stato puro, imponendosi alle strutture sociali che dovettero adeguarsi per accoglierla. Il caso
della Grecia acquista così un’importanza primaria. Asseriscono che l’alfabetizzazione in Grecia sarebbe stata responsabile
della maggior parte dei cambiamenti avvenuti in età arcaica. Fattore fondamentale risulta il modo in cui l’alfabetizzazione fissò
permanentemente e rese accessibili ad un pubblico più ampio descrizioni che erano rimaste fino ad allora fluide. Comportò
certamente un cospicuo numero di cambiamenti radicali: la redazione scritta della poesia, da Esiodo in poi, una fossilizzazione
della tradizione orale, lo sviluppo di nuovi metri e di una lirica personale. Anche la storiografia mostra un processo analogo,
che porta dalla mitologia critica alla storia vera e propria. La codificazione delle leggi .0attraverso la scrittura venne
riconosciuta dai greci come il primo gradino verso la caduta delle aristocrazie tradizionali e lo sviluppo delle complesse
costituzioni del V secolo, democratiche o oligarchiche. Il rilievo che la scrittura ebbe in relazione ad altri fatti culturali risulta
perciò un problema di importanza centrale per la comprensione della Grecia arcaica. A differenza dei sistemi di scrittura
orientali, in Grecia l’alfabetizzazione si era sviluppata in un’atmosfera secolarizzata, e fin dall’inizio era stata impiegata per
scopi secolari; la scrittura non fece altro che rafforzare tendenze già presenti nella società greca, senza riuscire a spiegarle
completamente.
7 LA COLONIZZAZIONE
Il numero delle nuove città che si fondarono nel Mediterraneo tra il 734 e il 580 può essere confrontato con quello dei centri
urbani che esistevano nell’area egea prima dell’inizio del movimento di colonizzazione. La prima fase ha però un rilievo
maggiore rispetto alla conquista compatta che sarà attuata da Alessandro il Grande, nella misura in cui essa venne organizzata
indipendentemente da molti stati diversi e fu il risultato di fattori di diversa natura. La prima area che si aprì ai loro
stanziamenti fu la Sicilia e le più antiche colonie vennero dedotte dai Calcidesi e dai Corinzi. Il lieve spostamento verso Sud
dalla prima colonia calcidese a Nasso sullo stretto di Messina (734)fino alla ben più amena regione della corinzia Siracusa,
dimostra l’attrazione esercitata dalla via commerciale che portava ad Ischia. Varie colonie presero le mosse da queste e da altre
città, costeggiando tale via commerciale: le promossero soprattutto entità peloponnesiache, con un gruppo di città achee sul
golfo ionico, con colonie megaresi, ed infine con la fondazione di Taranto. Poco più tardi sorsero degli insediamenti sulle isole
e sui promontori dell’Egeo settentrionale, lungo le coste della Macedonia e della Tracia, su spinta delle città euboiche. Gli
stretti che introducevano al Mar Nero vennero colonizzati all’inizio del VII secolo, in particolare da Megara; non abbiamo
notizie sull’inizio della colonizzazione di questo entroterra. Per passare ad altre zone, Cirene venne fondata nell’Africa del
Nord introno al 630 dall’isola di Tera, e dal 600 circa i Focesi dell’Asia Minore fondarono un gruppo di colonie, che facevano
perno su Marsiglia e andavano da Nicea ad Antipoli, fino ad Empoiron nella Spagna settentrionale. Introno al 580 tale
movimento ebbe fine. Parte della fascia adriatica rimase libera per i pochi approdi e i forti venti; solo con lo stato di guerra
contro gli Etruschi venne fondata Spina, nei pressi di Ravenna. La competizione dei greci con altri greci era stata attiva fin
dall’inizio. Al di là di questi alterchi fra i Greci stessi, non mancano pressioni più ampie: il successo della colonizzazione greca
provocò di rimando l’espansione coloniale fenicia. I Fenici arrivarono a dominare le vie commerciali che costeggiando le coste
africane portavano a Cartagine e in Spagna, ed inoltre tennero lontani i greci dalla Sicilia occidentale di fronte a Cartagine,
dalla Sardegna e dalle isole Baleari. D’altra parte quando l’Etruria cominciò a difendere i propri interessi, ben presto anche la
Corsica si fece zona contesa. La località ideale per una fondazione era quella di sempre, facilmente difendibile, con buoni porti
e nell’entroterra un suolo fertile.
I primi insediamenti che si realizzarono in una zona vergine tendevano ad attribuire una notevole priorità a fattori come la
difesa e la comunicazione. L’importanza del fattore difendibilità predomina in molti aspetti della colonizzazione. I greci
preferivano le aree disabitate, o le aree i cui abitanti fossero ancora primitivi e male organizzati. Gli stessi coloni costituivano
gruppi non numerosi, di uomini comunque in grado di combattere. Una poesia di Archiloco ci offre un chiaro quadro degli
aspetti militari della colonizzazione, mostrando un aristocratico disdegno per la città che protegge, ed un orgoglio caparbio per
se stesso come guerriero. Nonostante ciò, senza guerrieri come questi, i greci non avrebbero mai fondato colonie. Furono le
informazioni derivate dai mercanti, a determinare l’insediamento di parecchie delle colonie più antiche ed appunto lungo le vie
commerciali esse tendevano a disporsi. Il commercio esercitò la sua funzione sulle colonie anche per questi aspetti diversi della
dislocazione. Le città che esercitarono il ruolo più notevole nelle imprese coloniali sembra abbiano avuto tutte forti interessi
commerciali. Si distingue la colonia dalla stazione commerciale, abitata per lo più da comunità miste di mercanti, anche se la
distinzione non è netta. Offrono gli esempi più chiari quelle colonie che risultano connesse in tutto o in parte alla protezione
delle vie commerciali (es. Corcia e Znacle). È ovvio che queste colonie sfruttavano le risorse naturali della zona in cui si
trovavano, sia a beneficio loro, sia nell’interesse della loro città d’origine. All’importazione nelle colonie di beni di consumo,
deve essere corrisposta da parte delle colonie un’esportazione dei prodotti locali. Questo tipo di commercio fu più una
conseguenza, che una causa della colonizzazione. Così, in Sicilia non si ha nessuna testimonianza archeologica di scambi o di
insediamenti commerciali, prima della fonazione delle colonie più antiche, in quanto in sé per sé la cultura indigena, sia le
risorse naturali locali non rappresentavano una forte attrazione. Un’altra eccezione di questo tipo sarebbe la collaborazione fra
i capi tribù sciti e colonie greche che pare essersi concretata nella vendita di schiavi e di grano da parte degli sciti, e
nell’esportazione di manufatti metallici da parte dei Greci. I focesi si lasciarono alle spalle tutte le colonie precedenti , e
batterono pioneristicamente percorsi più remoti e pericolosi alla ricerca di mercati ancora vergini (Marsiglia serviva a
controllare le vie commerciali che affiancavano le coste del Rodano), con conseguente ellenizzazione delle aree, testimoniata
dei reperti archeologici. Lo sforzo mercantile dei focesi ebbe uno sviluppo tale che, quando vollero sottrarsi dalla pressione
persiana, si trasferirono in massa, nel 545, nella loro colonia di Alalia in Corsica. Ma a sua volta questo rafforzamento della
loro posizione in Occidente determinò di rimando un attacco congiunto di Etruschi e Cartaginesi e, nonostante la vittoria di
Alalia del 540, furono costretti a ritirarsi da Elea (Velia), che era il più meridionale degli stanziamenti greci nella baia di
Napoli, mentre i cartaginesi estesero ben presto il loro dominio su Tarsesso, e sia la Spagna settentrionale, sia la Corsica
rimasero zone interdette ai Greci. L’impero commerciale che i focesi riuscirono a costruire sulle coste forse non restò isolato.
Il fattore economico più importante che influenzò la colonizzazione greca risulta senz’altro la ricerca di nuovi territori, e spiega
la sestuplificazione dell’incremento demografico che parrebbe attestata dalle tombe attiche del VI secolo. Anche se non si
dispone di testimonianze di una crescita demografica al di fuori dell’Attica, si può intuire che ciò avvenne in tutto il mondo
greco. Molte guerre di frontiera che avvennero in questo periodo possono essere giustificate dalla crescente fame di territorio
all’interno della Grecia. Atene, che aveva un territorio molto ampio non sentì il bisogno di fondare colonie per il momento (lo
stesso vale per entità statali con vasti territori a disposizione). All’inizio del VII secolo Sparta conquistò e colonizzò, attorno a
sé, il territorio dei Messeni, mentre coloro che si insediarono nella sua unica colonia oltremare, Taranto, furono chiamati figli
di vergini, cioè i figli che le donne spartane avevano avuto mentre i loro mariti combattevano in Messenia, e risultavano perciò
illegittimi. Quello della terra è un problema a cui in tutte le colonie si presentava un’attenzione particolare. Il principio che
regolava l’eredità presso i greci fondava su una divisione in parti uguali fra tutti i figli, limitandone i concepimenti. Quando
invece la mentalità nuova introdotta dai mercanti ebbe vanificato tali limitazioni, ogni ulteriore crescita venne a porre un
problema sociale, fin tanto che non si fosse trovata altra terra: la città doveva perciò organizzare stanziamenti all’estero per
evitare lacerazioni domestiche. Proprio la scoperta del fatto che terra nuova se ne poteva sempre avere fondando colonie, si
ritiene fu un fattore importante per l’incremento della popolazione. È però difficile calcolare in che misura questo movimento
di colonizzazione poté essere attiva adesione alle opportunità offerte dall’ambiente esterno: ricchezza, uguaglianza e libertà da
vincoli sociali.
L’importanza che si attribuì al problema del suolo emerge dai dettagli dell’organizzazione di un insediamento coloniale. Non è
facile tracciare un quadro dell’effettiva prassi seguita nella fondazione. Nonostante le variegate e scarse informazioni a noi
giunte, possiamo affermare che nel movimento coloniale sussistette una certa base comune a livello di ideologie, nonché di
procedure, e di più recenti lavori di scavo hanno messo in luce alcune tendenze diffuse con una certa ampiezza. I primi capitoli
del sesto libro di Tucidide descrivono la colonizzazione della Sicilia, fornendoci l’unico resoconto che abbiamo
sull’occupazione di un’intera zona. Certi fatti essenziali erano memorizzati di norma: nome del fondatore, luogo di
provenienza dei coloni originari, data di deduzione. Il fondatore era un capo, aristocratico, che veniva nominato dalla città
madre: era lui che organizzava e comandava i coloni, progettava il piano regolatore dell’insediamento, sovrintendeva alla
distribuzione della terra e legiferava sulle istituzioni politiche, legali e religiose della colonia. I culti delle nuove entità statali
riflettevano l’origine dei coloni (anche se Apollo era molto diffuso per chi, prima di partire, consultava l’oracolo di Delfi, a
metà dello stretto di Corinto ). Il numero dei coloni dovette essere basso in quasi tutte le spedizioni. A partecipare a queste
imprese saranno stati maschi non sposati ed in grado di combattere, che venivano probabilmente da famiglie con più di un
erede. Le prime opere di una colonizzazione dovettero essere la fortificazione e la divisione della terra, che costituiva la base
della nuova società coloniale la cui successione avveniva come in madrepatria. La terra statale parrebbe sia stata riservata ai
templi ed altri fabbricati. Nel suo complesso i piano non aveva una regolarità assoluta, ma sembrava piuttosto plasmarsi sul
principio dell’uguaglianza nella forma dei lotti. Al di fuori della cinta urbana si trova il territorio immediatamente circostante,
che dovette venire anch’esso diviso fra i primi coloni. Si evince da ciò che i coloni originari avrebbero costituito una sorta di
aristocrazia che deteneva i terreni migliori e più vicini alla città. Il governo sarebbe stato quello di un’aristocrazia di cavalieri a
larga base. Sorgono però altri due problemi per cui abbiamo scarse informazioni: le donne (si ritiene fossero per lo più
indigene); il tipo di forza lavoro impiegata dai fondatori (anche qui l’ipotesi degli indigeni è la più probabile; infatti alcuni dei
loro centri furono distrutti). Nelle colonie più antiche l’esistenza di una classe di individui in condizione servile è documentata
con sicurezza in due casi: a Siracusa e ad Eraclea (qui la popolazione locale si era auto asservita). In seno agli stessi greci il
principio di uguaglianza che animava le nuove fondazioni, non poté essersi conservato a lungo, in quanto interessava soltanto i
coloni che alla fondazione avevano originariamente partecipato. Si ristabiliva così ben presto una struttura sociale per classi.
La maggioranza delle neonate città ebbe prospero successo.
Né alcun documento scritto, né le tradizioni orali registrate da Erodoto vano al di là del 650, e quindi alle fondazioni più
antiche. Tre sono le versioni a noi giunte sulla fondazione di Cirene da parte di Tera (pp. 132-135): due ci derivano da Erodoto,
e ci narrano i fatti come li videro i terensi e i cirenaici; una terza si può invece ricostruire in base alla documentazione offerta
dal decreto del IV secolo, che riporta il giuramento originario dei coloni. Il fattore più importante nell’indurre Tera
all’espansione coloniale fu certamente la siccità, che portò con sé la carestia: nient’altro avrebbe potuto costringere una
comunità agricola ad inviare coloni al di là del mare (Libia), in base ad ordini che andavano palesemente contro la loro
volontà. Deve comunque aver cooperato un qualche agente a lungo termine, probabilmente il fatto che il suolo non fosse più in
grado di alimentare tuta la popolazione, se non negli anni di più ricco raccolto. I coloni di tale spedizione vengono scelti per
sorteggio nell’ambito di famiglie con più eredi. Chi non seguisse tale obbligo sarebbe stato punito e/o ucciso. Molti altri fattori
sono peculiari in questo episodio coloniale. Lo guida un aristocratico al quale la società può rinunciare, e che forse aveva attriti
con le autorità. A Tera non ci sono poi mercanti che siano arrivati fino all’Africa, ma a Creta se ne trova uno che fa poi da
guida: poiché tratta in porpora può darsi che a Creta sostasse, facendo alla volta della colonia fenicia di Cartagine. La località
originariamente prescelta è un’isola, sicura in quanto tale dagli attacchi ad opera delle tribù dell’interno. Poi l’isola risulta
troppo piccola e gli indigeni si rivelano meno ostili di quanto fossero apparsi in un primo momento. La partenza dei coloni è
organizzata in base al principio della più assoluta uguaglianza. Fanno il viaggio in due pentecontere (quindi da 100 1 150). In
ogni caso sono uomini in grado di combattere, ed i loro prerequisiti sono giovinezza ed attitudine all’impresa. Nelle varie
versioni ci sono particolari interessanti (es. l’importanza attribuita a Delfi e al culto di Apollo-guida). Erodoto continua a
descrivere la storia successiva della colonia. Rimase una piccola entità statuale, fino a quando non ascese al trono il nipote del
fondatore, e Delfi avallò un’ulteriore distribuzione di terre nuove ai coloni. L’accresciuta potenza segnò l’inizio di attriti sia
all’interno della città, che fra la città e i libici. Di questa nuova situazione si venne a capo nella generazione successiva, con la
fondazione della colonia sussidiaria di Barca. Il disordine politico cui tale sconfitta portò (Platea 479 vs Sparta, Corinto e
Atene), rese necessaria un’altra consultazione dell’oracolo di Delfi, che nominò un paciere arcade, Demonatte di Mantinea, che
risolse la situazione, dividendo in tre tribù gli abitanti. Egli definì anche le prerogative della monarchia, che sarebbe durata fino
al 460. Fatto sta che Cirene divenne un centro prospero e rinomato per il grano, gli ossidi, la lana e i cavalli.
8 LA GUERRA E L’ETICA NUOVA
Alla fine dell’VIII secolo la base economica per la fabbricazione delle armi era abbastanza consolidata da permetter ai greci
una decisiva innovazione militare; la creazione di eserciti di massa costituiti di truppe armate alla pesante (che sarebbero state
imbattute fino a Cinoscefale contro i romani nel 197 a.C.). ma anche i cambiamenti avvenuti nel VII secolo sul piano
dell’armamento, della tattica e del personale militare, comportarono militare, comportarono mutamenti ancora più profondi
nelle strutture politiche ed in quelle dell’etica sociale. La città stato della Grecia del VI secolo si era organizzata a più riprese in
modo tale da produrre un corpo il più cospicuo possibile di combattenti addestrati, che esercitava il suo predominio sulla vita
della città. Gli onori politici venivano affidati in base alle referenze censita rie e distribuiti in certa misura fra coloro che
potevano portare le armi, cioè permettersele (erano molti); comprendeva tutti quegli agricoltori indipendenti. Quando si fu
sviluppato, l’esercito oplitico consistette in uomini armati con un equipaggiamento standard: gambali e corsetti in bronzo, elmo
in bronzo, scudo convesso e circolare in legno. Le armi erano una lancia lunga e una corta spada. La visibilità e mobilità scarse
che ne derivavano erano compensate dal fatto che si combatteva in formazioni compatte; lo scudo di ogni soldato copriva il
compagno sulla sinistra, tanto quanto se stesso. Tucidide, nella descrizione della battaglia di Mantinea del 418 descrive la
saldezza di tale struttura. I ranghi degli opliti erano schierati in profondità, in base ad un principio che combinava un massimo
di forza d’urto con la necessità di impedire l’aggiramento. Risultavano indispensabili ordine, disciplina e autocontrollo. La
battaglia si ingaggiava per lo più su un terreno piano. Los contro vero e proprio si esplicava in una pressione incalzante
esercitata attraverso gli scudi, mentre dal basso o dall’alto si cercava di colpire l’avversario con la lancia o la spada. Quando i
combattenti nella prima fila cadevano, venivano calpestati e rimpiazzati da quelli che seguivano. Per finire, quasi tutti gli
eserciti vittoriosi affermavano la loro pretesa di possesso del campo di battaglia spogliando i cadaveri, uccidendo o facendo
prigionieri i nemici feriti, seppellendo i loro morti ed elevando un trofeo. Spesso ci si dava alla fuga. Risultava brutale e
pericolosa nel caso di scontro fra due fronti oplitici. Questo nuovo stile ebbe conseguenze radicali sulla società greca, ma non è
facile seguire i cambiamenti che esso portò nel loro svolgersi. Armamento e tattica devono essere stati due fatti almeno in certa
misura interdipendenti, dato che l’armamento pesante tende ad incoraggiare formazioni di battaglia più statiche e tali
formazioni a loro volta spingono al combattimento corpo a corpo ed alla necessità di un più solido armamento difensivo. La
storia dell’armamento greco è sicuramente una storia ove prevale il mutamento graduale. La spada e la lancia erano conosciute
fin dall’XI secolo e nessuna svolta decisiva intervenne nell’evoluzione delle due armi durante il medioevo. la spada divenne
più corta e larga, mentre la lancia alla fine del medioevo pare fosse impiegata soprattutto come arma da lancio (es. vaso Chigi
mostra opliti con due lance). Il corsetto di bronzo era slogato su cardini su di un lato, e rimaneva invece fisso dall’alto e sulle
spalle. Era foggiato con cura in modo da adattarsi perfettamente al soldato che lo indossava, ed aveva uno slargo attorno alla
vita per agevolare la massima libertà di movimento (es. di guerriero ad Argo, 725). Le corazze atte a coprire tutto il petto non
trovarono impiego in Oriente a causa del clima caldo. Le ginocchiere di tipo politico, che aderivano automaticamente alle
ginocchia, non trovano precursori evidenti, e pare siano state inventate in Grecia durante il VII secolo. I due capi tipici sono
l’elmetto e lo scudo. Le varie fogge più antiche dell’elmo greco ci suggeriscono che l’impulso alla sua adozione venne forse
dal Vicino Oriente, mentre orientale è il suo pennacchio di criniera equina. I greci pensarono che a contribuire allo sviluppo
dell’elmetto e dello scudo oplitici fossero stati i Cari dell’Asia Minore sud-occidentale. La forma più comune dell’elmo
oplitico è quella corinzia, ottenuta sbalzando una lastra di bronzo tutta d’un pezzo in modo da coprire l’intero capo (dal 700
rappresentato sui vasi). Lo scudo era di legno con un bordo di bronzo. Spesso era decorato di un blasone a disegni geometrici o
altre figure. La sua differenza maggiore da quelli precedenti era la coppia di impugnature, per l’avambraccio e la mano (più
grande e saldo; mostrava caratteristiche sfavorevoli). Alcuni di questi capi dell’equipaggiamento trovarono impiego già prima
che si fosse sviluppata la formazione oplitica, altri invece la seguono. Furono introdotti gradualmente. Almeno due di questi
nuovi capi, elmo e scudo, devono essere stati strettamente connessi con l’introduzione della tattica oplitica (fine VIII secolo).
Per la prima metà del VII secolo disponiamo di numerose raffigurazioni di soldati che combattono in tenuta oplitica o semioplitica, ma mai raffigurati a combattere in formazione; questo forse deriva anche da un gusto artistico squisitamente tecnico.
Dai tre vasi del “maestro Macmillan” deduciamo che, attorno al 650, la falange oplitica era già abbastanza definita da costituire
un problema raffigurativo per il nostro pittore. Attorno al 650 cominciano ad apparire delle statuine di opliti in piombo ridotte
in serie ed a poco prezzo. La documentazione archeologica al proposito ci suggerisce un’evoluzione protratta nel tempo nel
corso della quale, dal 750, l’armamento divenne sempre più pesante. L’introduzione sostanziale di tale formazione avvenne tra
il 700 e il 650. La poesia guerresca la prima forma di poesia che ebbe come genere letterario dotato di un suo sistema specifico
di caratteristiche e di risposte alle richieste del pubblico. Tale poesia si propone di stabilire un rapporto fra il nuovo stile della
guerra ed il passato degli eroi, e raggiunge tale scopo riecheggiando ed adattando il linguaggio all’epica (elementi di continuità
con il mondo omerico). È con Tireo, di cui abbiamo un importante passo che ne ricorda uno tratto dall’Iliade, che la nuova
etica dell’età oplitica emerge con chiarezza. Ai guerrieri ci si rivolge come ad un’entità plurima. “Arete” in Tireo sta a
significare il coraggio risoluto e fermo che era necessario nelle battaglie oplitiche. Una poesia a noi pevenuta critica
verosimilmente le altre, tradizionali rivendicazioni aristocratiche d’eccellenza quali forza, velocità,…. La poesia dell’epoca
successiva ad Omero ci mostra un quadro diverso, in cui il patriottismo è la virtù più grande. La gloria che deriva dal
combattere per la famiglia, il concetto che la morte verrà quando dovrà venire, e che i prodi riceveranno onori per le loro
imprese sia che muoiano, sia che vivano, sono motivi che si trovano tutti in Omero: è la sintesi di tutte quelle diverse idee in un
medesimo breve passo, che implica il concetto di una morte al servizio della comunità come qualcosa di grandioso in sé. È
Tireo ad esplicare per primo questo atteggiamento; in lui la comunità gode dello stesso rilievo che hanno la terra e la famiglia.
Nell’età di Tireo si era oramai fissato un nuovo principio etico, che determinava il complesso dei doveri dell’individuo nei
confronti dello stato. La nuova moralità viene formulata secondo la terminologia già esperita dall’etica competitiva dei tempi
di Omero verso l’etica cooperativa della Grecia posteriore.
9 LA TIRANNIDE
Ippia di Elide, studioso del v secolo, rilevò giustamente come Omero non conoscesse il termine tiranno, introdotto più tardi ai
tempi di Archiloco. È a partire dalla metà del VII secolo, che una serie di usurpatori cominciarono ad imporre il loro potere
autocratico nelle città più progredite, e fondarono dinastie che normalmente ebbero la durata di due generazioni, prima di
essere detronizzate e sostituite da governi ove sarebbe stato predominante l’elemento oplitico. Questa prima fase della
tirannide sembra aver esordito a Corinto, in cui dal 655 al 585 esercitarono il loro potere Cipselo e suo figlio Periandro.
Teagene assunse il controllo di Megara attorno al 640, e circa un decennio dopo appoggiò un colpo di stato, che fallì, ad Atene
da parte del nipote Cilone. Anche Atene fu comunque sottoposta per breve al potere di Pisistrato (dal 560) e dopo di lui i figli
Ippia ed Ipparco (546-510). Un’altra frale più grandi città del Peloponneso, Sicione, venne dominata da Ortagora e dal suo
successore Clistene per circa un secolo (fino al 560-550), e ci furono varie altre tirannidi in città minori. Esempi sono anche
insulari, quali Mitilene e Mileto. Solo Sparta ed Egina sembrano esserne state immuni. L’esperienza della tirannide lasciò
dietro di sé un fascino e un’ostilità che avrebbero permanentemente condizionato l’atteggiamento politico dei Greci nei
confronti dei regimi monarchici. Nella speculazione politica posteriore, la tirannide viene definita come un governo assoluto,
esercitato in contrasto con la legislazione ordinaria o comunque ad arbitrio di chi lo gestisce; è la peggiore forma di governo
che esista Il punto di vista che ci da Aristotele fa risultare ben chiari tre punti: il tiranno pretendeva il potere in modo
incostituzionale e governava mantenendosi al di fuori delle leggi; era un leader popolare che proteggeva le classi inferiori; era
membro del ceto stesso da cui difendeva le classi inferiori. Nella sua fase iniziale la tirannide fu dunque una forma i governo
filo-popolare instaurata per fare fronte all’aristocrazie: per circa un secolo gli interessi del popolo e quelli dei suoi tiranni
aristocratici seppero coincidere. Quando tuttavia il popolo acquisì coscienza di sé, venne meno il suo appoggio al tiranno, non
appena avesse trovato un accordo con l’aristocrazia. La caratteristica della seconda generazione di tiranni sarebbe stata una
conduzione del potere sempre più arbitraria. Alla fine vennero rovesciati da rivoluzioni interne o da attacchi esterni.
Secondo Tucidide lo sviluppo economico della Grecia del VII secolo minò alle radici la posizione dell’aristocrazia, che oramai
si distingueva per privilegi di nascita e funzioni militari. All’inizio del VI secolo, Solone di Atene rivela un’economia urbana
complessa e ad alto grado di sviluppo, in cui agricoltura, commercio e artigianato sono modalità di acquisizione della ricchezza
accettabili allo stesso titolo. Solone stesso nelle sue riforme sostituì al criterio della nascita quello della ricchezza nella
distribuzione degli onori pubblici. Uno dei temi ricorrenti nella poesia greca arcaica è il conflitto fra diritti di nascita e
ricchezza, anche se la maggior parte dei poeti dello stesso periodo continuano a vedere le cose in un’ottica aristocratica ch è
opposta a quella di Solone. Anche se gran parte delle testimonianze sulla nuova definizione dello status sociale in termini
economici ci proviene dal VI secolo, le riforme di Solone mostrano che in alcune città il processo era già profondamente
maturato verso la fine del VII secolo,e d ha un significato di grande rilievo il fatto che una delle più antiche tirannidi sorgesse
nella città commercialmente più avanzata: Corinto. Qui si può ipotizzare un gruppo di ricchi insoddisfatti ed esclusi dal potere,
ma questo stato di cose risulterebbe da una flessibilità dell’aristocrazia di nascita che sarebbe affatto eccezionale. È più
plausibile mettere genericamente in rapporto il fenomeno della tirannide con l’emergenza di una maggiore libertà di pensiero e
nei rapporti sociali in conseguenza dei mutamenti che avvenivano all’interno dell’economia. Aristotele vede una connessione
fra una certa arma dell’esercito e l’organizzazione costituzionale di una città. Inoltre tale fenomeno emerse nella fase di
transizione alla costituzione oplitica. La poesia contemporanea attribuì al demos un rilievo nuovo, ed un’indagine sulla parola
in sé contribuisce non poco al problema dell’entità dell’appoggio che il popolo diede ai tiranni. Il termine viene spesso riferito
alla massa come totalità, ed in particolare alla massa in quanto opposta all’aristocrazia; qualche volta si riferisce alle sole classi
inferiori. È improbabile che esistesse una distinzione chiara fra gli opliti ed il resto dei ceti inferiori, dato che in sé lo stesso
gruppo degli opliti erano un fatto nuovo. I tiranni fecero ricorso pertanto a individui ben al di sotto del ceto degli opliti.
Aristotele era comunque nel giusto a ritenere i primi tiranni leaders del demos contro il potere dell’aristocrazia. La nuova
tattica militare comportava che una parte di esso si ritrovasse armato ed addestrato al fianco degli aristocratici: in una prima
fase avrebbe nominato un suo campione che ne difendesse i diritti, per poi divenire protagonista nell’intento di ottenere per la
propria organizzazione un ruolo centrale nello stato. Gli politi finivano comunque per operare nell’interesse del demos nella
sua globalità. L’instabilità che si venne a creare derivò dall’incrinatura dell’unità dell’aristocrazia, che si trovò a non essere più
compatta nella difesa nelle sue tradizionali prerogative. Una volta che la possibilità della tirannide fu divenuta un dato di fatto,
incominciarono ad operare altri due fattori: la moda e il mutuo soccorso dei tiranni. I tiranni ebbero sempre e comunque un
vasto appoggio popolare, che presuppone un’attenzione per i motivi di scontento locali; sociale, economico, etnico, frutto delle
lotte fra aristocratici per il potere. L’esempio di Corinto, la cui economia fiorì in particolare per la sua posizione, mostra come
il genos aristocratico dei Bacchiadi costituì un gruppo chiuso ed orgoglioso della propria individualità, che ostacolava i
matrimoni dei suoi membri con persone che non ne facessero parte. Questa chiusura esclusiva fu senza dubbio uno dei motivi
per cui poi sarebbero stati spodestati. Verso la fine del loro predominio i Bacchiadi possono aver riportato qualche insuccesso
militare. Le guerre di confine fra Megara e Corinto potrebbero senz’altro aver facilitato l’introduzione della tattica oplitica
nella zona, intaccando il potere dei Bacchiadi. Della rivoluzione che ebbe luogo a Corinto sopravvivono due resoconti, uno di
Erodoto, uno di Nicola di Damasco. Entrambi narrano del potere che Cipselo (salvatosi miracolosamente dalla morte da
fanciullo) e Periandro instaurarono a Corinto; il primo fu leader favorevole al popolo. Questi racconti si legano a un gruppo di
leggende la cui funzione è quella di spiegare l’affermarsi di un nuovo capo in una città, stabilendo un rapporto almeno parziale
fra l’usurpatore ed il vecchio regime, ed un rapporto tra questo e gli dei e fra questo le sue origini popolari. Elementi tipici
risultano l’esposizione del fanciullo, la sua sopravvivenza miracolosa, la sua educazione ad opera di genitori adottivi di
estrazione popolare, nonché il suo finale ascendere al popolo. La leggenda di Cipselo documenta la sua condizione di leader
filo-popolare e che fosse un uomo nuovo. Il predominio commerciale ed artistico di Corinto, iniziato con i Bacchiadi, continuò
con i tiranni. Cipselo e il figlio fondarono numerose colonie nella zona circostante all’accesso meridionale dell’Adriatico. Ma
il commercio penetrò molto più nell’interno. Nel Nord-Est fondarono inoltre Potidea, che si aggiunse alle precedenti città
euboiche della penisola calcida e sarebbe diventata una delle più ricche e potenti della zona. Pare che le colonie corinzie siano
state controllate molto più strettamente che in precedenza; lo dimostra la moneta perfettamente corinzia di Pegaso alato. Inoltre
fino al V secolo le colonie stesse continuarono a ricevere magistrati da Corinto. Il vasellame corinzio rimase quello più diffuso
nel Mediterraneo fino alla metà del VI secolo; questo sia per la manifattura avanzata, che per la marineria corinzia. I tiranni
aprirono anche nuovi mercati, verso il Mediterraneo orientale, grazie all’amicizia con Trasibulo di Mileto, e alle materie prime
del Nord-Est, grazie a Potidea. Periandro fece scavare un percorso più agevole per trascinare le navi lungo l’istmo, ed intesse
rapporti con il più importante dei dinasti panellenici, Aliatte di Lidia, mentre il suo interesse per il mercato egiziano viene
dimostrato dal fatto che suo nipote Psammetico, ricevette un nome che deriva da quello del faraone Psamtico. Sia qui, che
altrove, Corinto fu in competizione con Egina; per questo intesse amicizia con Atene. La sua influenza sul tipo di decorazione
vascolare ateniese è notevole; inoltre Periandro fu arbitro di una contesa fra Atene e Mitilene per il controllo del Sigeo e risultò
poi favorevole ad Atene. Delfi rimase favorevole a Corinto e Cipeselo vi costruì il primo tesoro, che doveva custodire le
offerte votive. Quando però la tirannide dei Cipselidi era sul finire, Apollo si rivolse contro di loro: permise ai Corinzi di
cancellare dal palazzo del tesoro il nome dei Cipselidi, e fu aggiunto: lui e i suoi figli, ma no più i figli dei suoi figli. Il
saccheggio di Corinto ad opera dei romani nel 146 fu l’episodio di vandalismo artistico meglio noto al mondo antico: si fece in
modo che della Corinto di un tempo non rimanesse più niente. Fu tuttavia solo nell’età delle tirannidi che emerse l’architettura
monumentale della città (tegola in terracotta e colonnati ai fianchi dell’edificio intero; lo stesso vale per le decorazioni
architettoniche in terracotta). Di tutta la produzione artigianale che da Corinto prese le mosse, nella città stessa di Corinto è
rimasto solo un esempi: le sette colonne del tempio di Apollo. Non mancano altri documenti della ricchezza e della
magnificenza che Corinto raggiunse durante la dominazione dei tiranni (statua di Zeus ad Olimpia). Le vicende sulla fine del
governo periandreo, come descritte da Erodoto narrano che egli avrebbe ucciso sua moglie, deposto dal potere suo suocero
Procle, tiranno di Epidauro e finito per altercare con l’unico suo figlio di talento. Nel tentativo di placare lo spirito della
moglie, avrebbe costretto tutte le donne di Corinto a riunirsi in assemblea ed a spogliarsi completamente, poi ne avrebbe fatto
bruciare gli abiti in un sacrificio propiziatorio alla moglie. Quando suo figlio fu ucciso a Corcira, Periandro si sarebbe
impadronito dell’isola ed avrebbe inviato 300 giovani nobili corciresi a prestare servizio all’amico suo Aliatte di Lidia. I
Bacchiadi erano effettivamente fuggiti a Corcira, e probabilmente con questa spedizione Periandro cerò di ricondurre sotto il
controllo corinzio la potente famiglia. Salvando i giovani Bacchiadi, i Sami vollero forse ricordare l’antica amicizia che legò
Samo a Corinto nel periodo dell’egemonia euboica. La tirannide era destinata a scomparire da Corinto dopo la morte di
Periandro.
I vari strati etnici della popolazione greca erano sufficientemente differenziati nei dialetti e nei costumi religiosi e sociali da
produrre in prosieguo di tempo vari conflitti. La tensione etnica rimase tuttavia un fatto più serio e più costante nel
Peloponneso, ove pare che l’invasione dei Dori abbia istituito varie forme di asservimento dei Greci achei che erano già
stanziati in loco: gli iloti di Sparta sono probabilmente uno dei tanti gruppi etnici ridotti in schiavitù, un altro sono i gymnetes
(nudi) di Argo; entrambi non mancarono di provocare disordini. Le origini del potere della dinastia degli Ortagoridi rimangono
oscure. Si narra che Ortagora fosse figlio di un cuoco: distintosi come guardia di frontiera, sarebbe divenuto comandante delle
sentinelle, e poi eletto polemarchos. Più degno di fede pare Aristotele, quando attribuisce il successo degli Ortagoridi come
tiranni alla popolarità che seppero acquistare ed alla mitezza che dimostrarono, nonché all’abilità militare del successore
Clistene (600-570 circa). Sono le stesse azioni di Clistene a suggerire una ben precisa fonte etnica per l’appoggio che il suo
potere ricevette. Erodoto gli attribuisce vari tentativi di liberarsi dell’influenza argiva, nonché una vera e propria guerra contro
Argo. Arrivò ad impedire la recitazione dei poemi omerici, che avrebbero glorificato gli argivi, e cercò di far trasportare il
cadavere di Adrasto dal suo santuario nella piazza dell’assemblea, ma venne bloccato dall’oracolo di Delfi. Tutto ciò in
funzione anti argiva. Inoltre rinominò le tre tribù doriche di Sicione con dei nomi ingiuriosi.
La città di Mitilene a Lesbo venne governata da un genos analogo a quello dei Bacchiadi, i Pentilidi, che proclamano di
discendere dagli eroi omerici attraverso Pentilo, figlio di Oreste e leader dell’insediamento originario. Secondo Aristotele fu la
loro usanza di far percuotere ingiustamente i cittadine, che ne portò lo spodestamento. La caduta dei Pentilidi portò alla
spartizione del potere fra gruppi feudali di aristocratici, profondamente divisi tra di loro (es. Alceo; una sua descrizione mostra
come l’aristocrazia di Lesbo fosse vicina ancora al mondo omerico). Appartennero a famiglie aristocratiche come queste ed
altre analoghe vari tiranni che emersero qua e là. Il fatto saliente della vita politica di Lesbo di cui abbiamo notizia consiste
nell’espulsione del tiranno Melancro ad opera di Pittaco e dei fratelli di Alceo intorno al 610. seguì poi la guerra fra Mitilene
ed i coloni ateniesi che si erano stanziati nel Sigeo: entrambi vantavano giustificazioni mitologiche per legittimare le proprie
pretese. Quando il conflitto ebbe termine, il prestigio di Pittaco risultò molto maggiore di quello di Alceo. I due gruppi assieme
organizzarono una cospirazione per abbattere il tiranno al potere, Mirsilo, ma PIttaco ad un certo punto passò dall’altra parte,
così che Alceo e chi con lui aveva cospirato dovettero prendere la via dell’Esilio. Chiesero vendetta agli dei di Lesbo (come
descritto da Alceo). La congiura si presenta qundi come la tipica impresa aristocratica organizzata da soldati legati l’uno
all’altro dal vincolo del giuramento, a cui Pittaco ad un certo punto venne meno. Alceo non desistette dai suoi attacchi contro
Mirsilo e Pittaco e dai suoi ammonimenti al popolo. Fu disposto ad accettare 2000 stateri dal vicino re di Libia per poter
riconquistare d’assalto la città. Il partito di Alceo non incontrò tuttavia nessun favore della città; i tempi delle fazioni
aristocratiche erano finiti, ed il popolo era ormai compatto su un altro versante. Alla morte di Mirsilo, il popolo elesse Pittaco
come guida allo scopo di difendersi per un periodo di dieci anni dal pericolo degli aristocratici in esilio. Al termine del periodo
nel quale rivestì la magistratura cui era stato eletto (590-580), Pittaco rassegnò il potere e si ritirò a vita privata. Aveva varato
leggi intese a frenare la competizione sociale fra gli aristocratici e ne aveva regolamentato le attività.
10 SPARTA E LO STATO OPLITICO
Sparta risulta lo stato oplitico per eccellenza della Grecia classica. Dopo la sua fondazione ad opera dei Dori, dovette subire il
più lungo periodo di lotte interne da essa conosciuto, ma ebbe fin dai tempi antichi un buon ordinamento interno. È da questa
guerra (404 a.C.) che gli spartani hanno la stesa costituzione, ed è per questo che sono diventati potenti e sono intervenuti
anche a sistemare i problemi interni di molte città (Tucidide, Erodoto: usano entrambi il termine eunomia = buon
ordinamento). Il successo del sistema nel far fronte al cambiamento e nel conservare il potere alla classe politica portò
all’idealizzazione del sistema stesso e tale reinterpretazione idealizzante della storia agì in modo tanto capillare da indurre
alcuni storici all’affermazione che non si potrà mai conoscere la verità sulla Sparta arcaica. Dovrebbe invece portare a: uno
scetticismo estremo circa la tradizione antica, e la determinazione a rintracciare gli scopi che il mito di Sparta dovette
perseguire. Il mito di sé sorge in una società che sopravvaluta il proprio passato e che cerca anche di usarlo per giustificare il
presente. Proclamarono prima i meriti della loro eunomia e il loro odio per la tirannide, e si ostinarono poi ad evitare il
cambiamento in un mondo che cambiava tutt’attorno,e della loro immutabile società fecero una virtù. Anche quando
l’innovazione istituzionale vi si insinuò, la giustificarono come un ritorno all’ancestrale costituzione di Licurgo. I successi
monarchici della Sparta ellenistica del tardo III secolo continuarono a legittimare quelle che erano in effetti radicalissime
riforme sociali come un necessario ritorno alla costituzione originaria. Al di fuori di Sparta, il mito dell’immutabilità ebbe altre
funzioni: nell’epoca classica Sparta fu un rifugio per gli oligarchi esuli delle più varie città ed il modello dei conservatori sul
piano dei costumi e della politica. Platone basò la sua idealistica Repubblica su un’interpretazione critica delle istituzioni
spartane, ed un ruolo notevole Sparta continua a giocare nella sua ultima opera, le Leggi. Aristotele pensò poi a Sparta come al
più importante modello storico per una città ideale. Entrambi ritengono che fossero però sbagliati gli scopi di Sparta, che
mirava a produrre cittadini capaci di eccellere solo nel coraggio, e questo non poteva bastare: dal metodo spartano i cittadini
avrebbero dovuto essere educati a tutte le virtù. Resta possibile, nonostante la reticenza degli spartani, ricostruire nelle sue
linee essenziali la storia militare e costituzionale dello stato spartano arcaico ed il carattere della sua cultura in base alle fonti
ad essi coeve: la poesia di Tireo e di Alcmane, composta a Sparta tra il 650 e il 590, nonché la documentazione archeologica.
I Dori di Sparta arrivarono prima del 1000 a.C. nella concava Lacedemone, la fertile pianura che affianca le rive del fiume
Eurota. La loro costituzione si adeguava alla norma nel prevedere l’assemblea dei guerrieri (apella) ed il consiglio degli anziani
(gerousia): più tardi il consiglio sarebbe stato composto dai due re e da altri 28 membri eletti a vita dal popolo fra i cittadini
che avessero più di 60 anni. L’unico fatto peculiare del sistema politico spartano non ha trovato ancora una spiegazione
soddisfacente. Due famiglie, Agiadi ed Euripontidi, facevano risalire la loro discendenza indietro nel tempo fino ai figli di
Eracle ed a spiegare la biforcazione della dinastia adducevano il motivo che l’eredità originaria era stata divisa in parti uguali
fra i due figli. I due esponenti di maggior rilievo di tali famiglie, i re, possedevano privilegi uguali, che ci vengono descritti da
Erodoto: sacerdoti di Zeus, capi dell’esercito, potevano dirigere campagne militari, ricevevano onori cospicui, avevano il
diritto di nominare i proxeni (i rappresentanti di Sparta all’estero), erano seguiti da una scorta di guardie del corpo, avevano a
loro servizio ciascuno due pythioi (funzionari responsabili della consultazione dell’oracolo di Delfi e della conservazione dei
suoi responsi), esercitavano il potere giuridico in tema di diritto familiare sorteggiando mariti per le eredi nubili e dando corso
ad adozioni, erano poi membri permanenti dalla gerousia, le loro esequie erano complesse e pubbliche. La successione era
ereditaria, e toccava al primo figlio maschio avuto dal re quando già esercitava le sue funzioni, e gli eredi legittimi della
monarchia erano gli unici giovani che si sottraevano alla tradizionale educazione spartana. Nel caso che l’erede fosse di minore
età, diventava reggenti il parente prossimo più anziano. Gli spartani conservano sempre una grande libertà di critica nei
riguardi dei re, e ricorrendo a motivi come l’ambiguità dei natali o l’irregolarità del comportamento erano capaci di deporli
dalla carica o mandarli in esilio. È un atteggiamento che venne istituzionalizzato in un rito, in virtù del quale ogni otto anni egli
ephoroi (coloro che super vedono) scrutavano il cielo di notte; se compariva loro una stella cadente, i re venivano sospesi fin
tanto che non fosse stato consultato l’oracolo di Delfi. C’erano poi altri poteri di supervisione degli efori sui re. In parte il
paradosso della duplice monarchia può essere forse spiegato tenendo conto che i due re non furono mai monarchi nel senso
convenzionale del termine. Le loro funzioni erano state primariamente militari che propriamente regali. Anche quest’ipotesi
crea dei problemi, perché né l’una, né l’altra delle due dinastie erano connesse con l’organizzazione tribale originaria, che in
ogni caso risultava tripartita. All’epoca di Tireo, lgi spartani combattevano ancora coscritti nelle tre tribù doriche ancestrali.
Bisogna poi tenere conto che gli spartani erano poi organizzati anche secondo criteri territoriali, in quanto obai o villaggi, ed
una delle meno fantasiose fra le varie ipotesi formulate in età moderna suggerisce, per il dualismo al vertice del potere militare,
un’origine territoriale. L’attività bellica ebbe certamente un ruolo centrale nella comunità spartana arcaica, ed è facile
ricostruire lo sviluppo in base alle conquiste cui si pervenne. In qualche momento di tale sviluppo venne incorporato un nuovo
villaggio, Amiclai, e da allora in poi si procedette a creare vari gruppi-satellite. Il primo di questi comprese alcuni insediamenti
dorici della pianura, abitati dai perioikoi (coloro che abitano intorno): alla fine ci furono circa trenta di queste comunità, che
avevano autonomia locale, ma che non disponevano di un’organizzazione militare individuale e non potevano gestire una
politica estera indipendente: dovevano essere disponibili al servizio militare, ma fino al V secolo prestarono tale servizio in
corpi separati. Quando gli spartani fecero di sé un’elitè militare e si impedirono attività produttive, furono i perioikoi che
cominciarono ad attendere alle attività manifatturiere e a tutte quelle attività ausiliarie, che sono indispensabili al
funzionamento dello stato. Vennero così ad occupare un posizione privilegiata. Iniziò poi la conquista al di fuori della pianura,
in direzione del mare e delle paludi costiere. Durante questa espansione si costituì un nuovo gruppo di comunità soggette,
quelle degli iloti. Il loro status originario non chiaro, perché più tardi essi non si distinsero affatto dai Messeni. Fu tuttavia con
la conquista della Messenia, che costituì le basi economiche e sociali su cui lo stato classico spartano si sarebbe fondato.
Questa guerra fu essenzialmente un movimento coloniale con cui, conquistando tutto il Peloponneso sud-occidentale, gli
spartani si assicurarono la terra di cui avevano bisogno senza doversi andare ad insediare oltremare (tra il 730 e il 710). Di ciò
abbiamo notizie sia nelle liste dei vincitori dei giochi di Olimpia, si dagli scritti di tirteo. La terra che era stata dei messeni
venne spartita fra gli spartani, tranne che per i suoi membri dubbi (i partheniai = figli di vergini). I partheniai se ne andarono
via a fondare l’unica colonia di Sparta: Taranto (706). Sparta stessa a questo punto divenne una città pienamente coloniale, in
cui ogni cittadino maschio venne a possedere un kleros di terra uguale per ciascuno: la condizione coloniale in cui la città si
trovò non presentava che leggere differenze rispetto alle nuove colonie dedotte oltremare. Probabilmente il sistema del
métayage, che avrebbe trovato una larga diffusione successiva, venne introdotto subito, in quanto già preesisteva come
modello il sistema degli iloti, ed inoltre i nuovi territori erano troppo distanti per poter essere gestiti in modo diretto da Sparta.
Nell’ambito di tale sistema i Messeni furono lasciati sulle loro terre come contadini che avrebbero dovuto pagare la metà del
loro prodotto ai lontani padroni (Tirteo ne descrive la condizione). In questa prima fase gli spartani erano già pochi, come lo
sarebbero stati più tardi. La prima guerra messenica venne probabilmente combattuta secondo la vecchia maniera: la
schiacciante vittoria degli Argivi ad Hysiai nel 669 può essere stata un fattore catalizzatore del rinnovamento in direzione dei
metodi oplitici. Le statuine di piombo raffiguranti opliti offerte come doni votivi al tempio di Artemide Orthia, documentano
che intorno al 650 Sparta possedeva una classe oplitica pienamente cosciente di sé. La combinazione di fattori economici e
militari può aver qui determinato una transizione più decisiva che altrove. La classe degli opliti comprese infatti l’intero corpo
della cittadinanza spartana.
È questo il periodo in cui va collocata la prima costituzione greca scritta che sia giunta fino a noi: ci è conservata nella vita i
Licurgo plutarchea, e a Licurgo ovviamente Platone la attribuisce: Licurgo si preoccupò tanto di questo organo di governo, da
portare al proposito da Delfi un oracolo, che chiamano rhetra (decreto). Qui Licurgo fa risalire al dio pitico, Apollo, l’origine
della sua costituzione. Aristotele ritiene che gli spartani tenessero le loro riunioni durante la apella tra il Babyka (un ponte) e lo
Knakion Oinoo (un fiume); il popolo poteva solo rifiutare o approvare le proposte fatte dagli anziani e dai re. Quando in
seguito il popolo cominciò ad alterare e a distorcere le mozioni presentategli, i re Polidoro e Teopompo aggiunsero una rhetra,
che affermava che gli anziani e i re devono essere pronti a non ratificare la decisione, bensì ad allontanarsi e a togliere la
seduta. Essi riuscirono a convincere la città che ad ordinare questo erano stati gli dei (come racconta Tirteo). Un passo
plutarcheo consiste di un documento, di una serie di commenti su di esso, e di un frammento tratto dalla poesia di Tirteo nota
con il nome di Eunomia. È un tipo di scrittura che esula dallo stile consueto di Plutarco. Il passo plutarcheo deriva
probabilmente direttamente dalla Costituzione degli spartani: da ciò dobbiamo definire i limiti sia della fiducia, sia della
diffidenza che dobbiamo avere per tale resoconto. Datare la rhetra implica definire il contesto storico. Precede Tirteo, e viene
varata probabilmente mentre Teopompo è ancora vivo. La tradizione antica ci porta verso una datazione molto alta per Licurgo
(IX secolo). Questa fu un documento scritto in prosa. In effetti una legge scritta e di questa complessità venne difficilmente
concepita prima del 700. l’argomento di maggior peso per collocare la rhetra nella prima metà del VII secolo ci deriva dal suo
contenuto. In primo luogo le adunanze avrebbero dovuto essere regolari e svolgersi in un luogo a ciò destinato. In secondo
luogo è a questo organo che devono essere proposte tutte le mozioni, e anche essere discusse. Terzo punto, il potere decisionale
deve restare al popolo. La rhetra originaria servì in sé e per sé ad un’affermazione di predomino all’interno dello stato da parte
di un’assemblea di “Eguali”: costituisce quindi la prima costituzione oplitica. Il che basta a spiegare perché fosse necessario
fare un documento scritto semplicemente per affermare i poteri di un’assemblea. Certo è che in rapporto ad un mutamento così
radicale deve essersi sviluppato uno stato di tensione. Ad un’epoca di agitazione nella Sparta arcaica ne fanno riferimento
Erodoto e Tucidide. Va presa in considerazione l’esegesi critica della rhetra ad opera di Tirteo, che ne altera i momenti di
maggior interesse: per lui importanti divengono innanzitutto i re, ed i l consiglio finisce in un secondo piano, mentre al popolo
non spetta che replicare correttamente alle mozioni. Aristotele asserisce che alcuni disordini sarebbero avvenuti durante la
guerra messenica, come si ricava facilmente dalla poesia di Tirteo che si intitola Eunomia, e questo avvenne perché certuni,
impoveriti dalla guerra, si misero a reclamare che fossero loro distribuite delle terre. Testimonianze come queste fanno pensare
che il quadro tracciato da Aristotele, con la sua distinzione fra rhetra e successiva integrazione, sia corretto. Chiaro è almeno il
fatto della tensione politica. Erodoto dice che Licurgo, dopo aver legiferato, definì il sistema militare, le enomotiai, le triekades
ed i syssitia, ed istituì poi egli efori ed il gruppo degli Anziani. Diviso originariamente in tre brigate che corrispondevano alle
tre tribù doriche, l’esercito spartano fu organizzato su una base territoriale. Eppure Tirteo, che viene dopo, fa riferimento ad
una formazione organizzata attorno allo schema tribale primitivo, ed è chiaro che ad un livello inferiore dell’organizzazione
dell’esercito spartano conservò i nomi di coscrizioni collegate alle schiere di guerrieri aristocratici di vecchio stile. Il secondo
problema è che nella rhetra non compare l’eforato. Ogni anno venivano eletti dall’assemblea cinque ephori, ed uno di essi dava
il suo nome all’anno. I loro poteri erano cospicui: potevano proporre l’ordine del giorno sia al consiglio degli Anziani, si
all’Assemblea. Erano i funzionari pubblici di più alto rango,e potevano punire chiunque volessero, comminare ammende,
deporre magistrati in carica, incarcerarli e sottoporli a processi capitali. La loro posizione nei confronti dei re è esemplificata
nel rituale dell’ispezione del cielo. Non sorprende che uno dei temi centrali nella storia di Sparta sia la conflittualità fra efori e
re, ma l’origine dell’eforato rimane tutt’ora oscura. Fattore catalizzante definitivo nella creazione dello stato spartano fu la
seconda guerra messenica. Scoppiò probabilmente in conseguenza della sconfitta spartana di Hysiai nel 669, anche se tutto ciò
che la riguarda risulta confuso, tranne che per ciò che evinciamo dalle parole di Tirteo: la sua descrizione chiarisce che si trattò
di una lotta accanita, che agitò la nuova costituzione, se non ne comportò addirittura alterazioni profonde. Fu tale conflitto che
creò l’ideale del patriottismo e della morte al servizio della comunità. L’assoggettamento definitivo della Messenia era
destinato ad avere effetti a lungo termine, ma anche conseguenze immediate: quella prosperità che vediamo riflessa nella
cultura spartana coeva. Manca ogni senso di tensione nelle poesie di Alcmane (di Sardi in Lidia), scritte per essere cantate dai
cori di giovani durante le festività religiose. La sua poesia riflette una società di alto livello culturale, aperta alle influenze
orientali ed affascinata dall’esotico. Le coriste-danzatrici di Saffo possiedono nomi aristocratici; i loro attributi sono
peculiarmente aristocratici e richiamano un’età precedente, in cui Sparta era famosa soltanto per le sue donne. Gli scavi sul
luogo di Artemide Orthia hanno mostrato che oggetti orientali o di altra provenienza cominciarono ad essere importati dal 700
circa. L’artigianato laconico venne forse esercitato materialmente dai perioiki, ma patroni ne furono gli Spartani. Lo stile
vascolare laconico raggiunse il suo apice in un periodo che va dal 590 al 550, in cui operò il pittore Arcesila. La qualità della
distribuzione di questo vasellame mostra che esso rimase un lusso prestigioso. Gli spartani produssero anche raffinate statuette
il legno e manufatti di bronzo (bacili bronzi per mescolare il vino e coppe). Il vasellame continuò ad essere prodotto su larga
scala a Sparta per tutto il VI secolo, in un’attività manifatturiera probabilmente collaterale a quella degli armamenti. In tutti gli
altri suoi aspetti la cultura spartana verso la metà del secolo cominciò a declinare. Sintomo della decadenza fu la conservazione
da parte di Sparta della primitiva monetazione in ferro anche quanto altre città cominciarono a battere moneta in argento. Ma
questo fu il colpo di grazia. Fu così che la costituzione di Licurgo raggiunse l’ultimo stadio della sua malattia.
La parola costituzione è una traduzione inadeguata del greco politeia, che indica l’organizzazione della politica, della società e
dell’educazione nel loro complesso all’interno dello stato: fu l’insieme delle istituzioni spartane, a determinare l’immagine di
Sparta. Le nostre due fonti principali sul carattere di tali istituzioni risultano alterate per vari aspetti dalla tendenza
idealizzante: l’opuscolo Costituzione degli spartani dell’ateniese in esilio Senofonte, che non fornisce dettagli ed è privo di
utilità per l’analisi dello svolgimento diacronico del regime spartano; la plutarchea Vita di Licurgo (5 secoli dopo) fornisce poi
un resoconto dettagliato del “sistema di Licurgo”, del quale però il tessuto di base rimane la descrizione senofontea. Anche sa
fonti degradate come queste, risulta comunque chiara la natura del sistema spartano all’apice del suo sviluppo: il cittadino era
pienamente al servizio dello stato. Alla sua nascita erano gli anziani della tribù a decidere se il neonato dovesse essere
cresciuto oppure gettato giù per un dirupo destinato a questo uso. Dall’età di sette anni tutti i fanciulli tranne gli eredi legittimi
delle due dinastie regnanti erano iniziati ad una educazione organizzata dallo stato (agoge). I maschi erano arruolati in
manipoli sottoposti agli ordini di un capo manipolo, nonché alla supervisione dei ragazzi più anziani e del magistrato.
Attraversavano poi una complessa serie di stadi di età, definiti con nomi oscuri e suono arcaico,ed a vent’anni iniziavano la
loro vita in comune: dovevano farsi da soli i giacigli di giunchi, evitare forma di lusso, non portare scarpe ed indossare un solo
abito per tutta la durata dell’anno,ed infine sostentarsi con una dieta che era deliberatamente insufficiente, perché rubarsi cibo
in più era titolo di merito e quelli che erano sorpresi in flagrante venivano bastonati solo allo scopo di stimolare la loro astuzia.
L’educazione formale comprendeva la musica, attività militari e ginniche. Inoltre i giovani più anziani dovevano esercitare un
controllo pressoché assoluto sui loro concittadini inferiori d’età. Si promuoveva la disciplina, l’autocontrollo, la coesione
sociale, la lealtà, l’obbedienza e lì uniformità. Produceva da solo la complessità dei propri rituali, nonché la propria specifica
terminologia. A vent’anni, coloro che avessero superato l’agoge diventavano eleggibili ai circoli dei syssitia o degli andreia,
sorta di clubs ove ci si raccoglieva per i pasti: il concetto di piena cittadinanza era collegato all’appartenenza ad uno di questi,
che formavano il centro focale dell’educazione militare. Ogni maschio spartano viveva nell’ambito di essi fino ai trent’anni, e
da quest’età in poi era comunque tenuto a recarvisi per consumare il suo pasto giornaliero standard, costituito da pane d’orzo,
salsiccia bollita, vino, ed un po’ di fichi o di formaggio. Ad ogni cittadini si richiedeva perciò un contributo mensile. I cittadini
di pieno diritto erano considerati tutti eguali (homoioi = uniformi, simili); la loro uguaglianza implicava parità ideologica a
livello di natali e di beni. È chiaro che comunque un’aristocrazia di qualche tipo continuò a sopravvivere, e che in ogni epoca
della storia spartana si verificarono delle sperequazioni censita rie, dato che il possesso della terra era privato e soggetto alle
regolari norme sull’eredità. Coloro che non erano riusciti a completare l’agoge, o che erano stati sconfitti in guerra, ma erano
sopravvissuti, nonché coloro la cui eredità era sospetta, saranno esclusi dall’entrata in questa condizione di homoioi. La
svalutazione della famiglia condizionò molto la posizione della donna. In sostanza le permise di costituire una società che
copiava quella dei maschi, ne imitava il sistema di educazione ed i riti iniziatori e nelle cerimonie culturali come nella vita
sociale trovava uno collocazione collaterale a quella degli uomini. Le donne erano allevate ad attività che nella danza e
nell’atletica trovavano il loro centro; potevano stare liberamente in mezzo ai ragazzi, e come loro facevano gli esercizi ginnici
nude. Anche adulte, le donne continuavano a godere di diritti legittimi e di stato sociale più cospicui che da qualsiasi altra
parte. I costumi matrimoniali dimostrano che alla base di questa libertà femminile stava la svalutazione della famiglia e la
soggezione delle donne all’etica maschile. A Sparta le mogli potevano essere prestata a una terza parte, su invito dell’uno, o
dell’altro maschio interessato; i fratelli potevano avere una moglie in comune, e l’adulterio sembra non venisse considerato
un’offesa. La stessa cerimonia del matrimonio esprimeva la subordinazione delle donne alla società maschile: aveva la forma
di un sequestro rituale della donna, che sarebbe poi stata schiava dell’uomo. Vestita di abiti maschili, la sposa doveva aspettare
il marito in una camera buia. Si sono sottolineate le origini doriche di questo sistema sociale, definito come arcaico. Le stesse
fonti greche hanno espresso un atteggiamento analogo in modo leggermente diverso, ipotizzando che la costituzione spartana
fosse in rapporto con quella cretese, alla quale Licurgo avrebbe attinto. Sfortunatamente il confronto con Creta parrebbe essere
fuorviante. La stessa costituzione cretese in sé è forse una costituzione artificiale che doveva servire ad istituire questa serie di
analogie. L’origine dorica del sistema spartano è dunque un mito. La funzione del sistema militare spartano era univoca, e
consisteva nel perpetuare i ranghi di un esercito oplitico: le pressioni che fecero divenire esclusiva tale funzione furono tanto
improvvise quanto permanenti. Una sollecitazione primaria in tal senso poté aversi dall’esperienza del gruppo degli Eguali, che
si era istituito durante la seconda guerra messenica: era necessaria una vigilanza militare continuata. Il problema della
sopravvivenza delle istituzioni è più complicato. A rigor di termini, nessuna società potrebbe considerarsi arcaica. Una società
arcaica può essere considerata tale sia in rapporto alla sua struttura interna, sia, esternamente, in rapporto al contesto: cioè
come una società le cui istituzioni sono più primitive di quelle dei popoli che la circondano. Da entrambi i punti di vista, è
chiaro che Sparta cambiò, e cambiò più radicalmente di ogni altra città greca nello stesso periodo. Sorge un altro problema:
dato che gli spartani continuarono sempre ad esprimere i cambiamenti che avvenivano nell’epoca loro in termini di ritorno alle
istituzioni del passato, in che senso possiamo distinguere Sparta dalla società spartana arcaica vera e propria? Ne sono da
esempio la contesa per i formaggi del santuario di Artemide e la Krypteia (uccisione di iloti di notte nelle campagne) risultano
sì riti primitivi, eppure entrambi hanno assunto una funzionalità diversa dall’originaria: divennero prove di forza e di resistenza
vere e propri. Sparta è dunque una società pseudo-arcaica.
11 ATENE E LA GIUSTIZIA SOCIALE
Tutto il diritto greco ha una fonte comune, che consiste nella presa di coscienza da parte dell’uomo che i giudizi individuali
dovrebbero attenersi ad uno schema unitario: la legge è cos’ un tentativo di imitare l’arbitrio del giudice, e come tale esprime
l’insoddisfazione per lo stato vigente delle cose. Con il diffondersi dell’alfabetizzazione divenne possibile fissare per iscritto le
norme che gli Anziani avevano potuto applicare, invece di fare affidamento nelle loro variabili interpretazioni del diritto
abitudinario. Gli scopi soggiacenti a questa iniziativa sono illustrati dal fatto che in parecchi casi essa coincise con altre
limitazioni al potere degli Anziani, nonché l’affermazione dell’uguaglianza davanti alla legge. La stessa esigenza venne
avvertita anche nei nuovi possedimenti coloniali. La figura del legislatore (nomothetes) rappresenta una risposta a questa
duplice esigenza di limitare i poteri dell’aristocrazia e di mantenere l’autorità del diritto abitudinario. Il legislatore poteva poi
ricevere anche un potere assoluto. La libertà di cui godeva rispetto alle richieste popolari e al condizionamento esercitato dalla
condizione legislativa precedente poteva ingenerare nel legislatore una notevole sicurezza di sé. Fu nel mondo coloniale che
emersero i più antichi: Zaleuco di Locri e Caronda di Catania ne sono esempio (metà VII secolo). Solo all’inizio del VI secolo,
e ad Atene divennero chiari i principi direttivi ed i metodi del legislatore. Il primo codice costituzionale ateniese venne redatto
da Dracone nel 621-620, dopo il fallimento di instaurare una dittatura da parte di Cilone. La serialià di tali eventi dimostrano
l’atmosfera di malcontento. Il codice draconiano, di origine aristocratica, contemplava sia multe che pena di morte. Tale codice
venne rimpiazzato una generazione dopo dalla costituzione soloniana (primo magistrato nel 594-593). Della produzione
poetica di Solone sopravvive una parte cospicua. Le sue erano poesie espressamente politiche, il che spiega il legame con una
tradizione ancora orale. Comunque, in queste poesie prima della legislazione si ribadivano i mali a cui andava posto rimedio.
Le leggi di Solone vennero registrate su tavolette di legno, poi raccolte in un’intelaiatura parimenti lignea, costruita in modo da
permettere di girare le tavolette stesse; i termini kyrbeis ed axones (assi), con cui venivano designate, riflettono probabilmente
le loro due caratteristiche materiali più evidenti: la forma e la possibilità divenir girate. Molti storici, come Plutarco e
Aristotele, citano queste leggi. Per di più, dato che il codice veniva conservato per ragioni pratiche, è quanto meno probabile
che molte copie di esso finissero più o meno modernizzate dall’integrazione delle più recenti multe in danaro e dall’aggiunta di
leggi o procedure nuove: integrazioni da cui anche uno storico coscienzioso avrebbe potuto essere tratto in inganno. Ciò si
collega a un problema più ampio. Solone fu il fondatore della democrazia ateniese, ed il suo codice di leggi rimase l’unico
corpus giuridico codificato fin tanto che non venne ufficialmente rivisto verso la fine del V secolo. Si ritiene quindi che il
termine “leggi di Solone” e “leggi di Atene” divennero per lo più due termini simili; da ciò deriva il fatto che ad esso vengano
spesso attribuite anche leggi posteriori. Lo stesso scetticismo va applicato quando si considera l’esposizione e l’interpretazione
dei fatti fornite dalle nostre due principali fonti: la Costituzione degli Ateniesi aristotelica e la Vita di Solone plutarchea. Agli
ateniesi piacque distinguersi per contrasto dai Dori, che sarebbero arrivati in Grecia solo più tardi, e la loro aristocrazia si
proclamava autoctona, quanto dire generata sullo stesso suolo greco. L’Attica era stata tuttavia anche la via attraverso la quale
vari gruppi di esuli cacciati dai Dori erano arrivati alle isole dell’Egeo ed all’Asia Minore durante la migrazione ionica del
primo medioevo: di qui derivò la possibilità per molte famiglie ateniesi di far risalire le loro generazioni fino ad eroi omerici
delle più diverse zone della Grecia. Il quadro di continuità che tale tradizione genealogica intendeva instaurare con il mondo
miceneo trova oggi conforto nelle testimonianze archeologiche. La città di Atene rimase per tutto il medioevo un centro ove
fiorirono varie professioni, ed intorno al 900 risultava la comunità più prospera ed avanzata di tutta la Grecia. L’importazione
dall’Oriente comincia verso l’850, mentre le sue ceramiche risultano presenti già negli strati più antichi di Al Mina. Per finire,
all’inizio dell’VIII secolo, degli orafi orientali esercitavano la loro professione nella città. Fu in questo periodo che la
prosperità di Atene subì un tracollo; gli storici vi collocano la tirannide di Filone di Argo. Il declino dello spazio urbano di
Atene coincise con una rivalutazione della zona rurale circostante. Fino al 750 nella città si erano concentrate ricchezza e
popolazione, ma a partire dal 740 vennero occupati di nuovo molti dei centri micenei dell’Attica che qualche secolo prima
erano stati abbandonati, e tornarono a comparire anche nelle campagne tombe di una certa ricchezza. L’aristocrazia di Atene
consistette di una serie di famiglie che non avevano rapporti di discendenza reciproci (note come Eupatridai = uomini di illustri
natali); costituirono una classe chiusa a nuove immissioni, che riservò a sé le magistrature e il diritto di partecipazione al
consiglio noto come Areopago (collina di Ares). Il loro potere, tratto anche da sostenitori di particolari zone dell’Attica, non
poté essere affossato se non verso la fine del VI secolo, grazie alle riforme clisteniche. Fu solo dalla metà dell’VIII secolo che
tali signorie vennero consolidate. Il movimento di ritorno alla zona rurale coincise con il forte incremento demografic tra 800 e
700. Atene ebbe la fortuna di possedere un territorio piuttosto ampio. Ne conseguì l’isolamento di Atene nel corso del VII
secolo. La città divenne conservatrice ed ebbe un’economia rurale, anche se conservò grandi dimensioni e rimase
industrialmente progredita, grazie alla sua capacità intrinseca di produrre ricchezza. Questa dicotomia radicale fra zona rurale e
urbana è uno degli agenti che operarono nell’ambito della riforma soloniana. Un altro agente fu l’introduzione della tattica
oplitica, che pure avvenne con qualche ritardo (fine VII secolo; 610, contesa per il Sigeo). Nel periodo fra 595 e 586 truppe
ateniesi presero parte alla prima Guerra Sacra per il controllo di Delfi, al fianco di guerrieri induriti alla battaglia come Clistene
di Sicione ed i Tessali. Fu probabilmente negli anni che intercorsero fra questi due avvenimenti bellici, che Solone cominciò a
fare politica, ed i suoi esordi furono quelli di poeta guerriero attento ad esortare l’esercizio della città alla guerra contro Megara
per il controllo dell’isola di Salamina. Il carattere di tale esordio mostrano le sue influenze da parte di Tireo e di Sparta, in
particolare sul concetto di Eunomia. Nel descrivere la sua versione della euonomia, Solone guarda al di là del modello
spartano, optando per il modello esiodeo delle relazione sociali, in cui figlie di Zeus e di Themis (costume) sono le Horai
(norme), Eunomie, Dike (giustizia) e la beate Eirene (pace). È la visione esiodea delle due città rette dalla giustizia e dalla
violenza (hybis) che viene richiamata da Solone nei versi sugli agi derivanti dall’a eunomie e sulle conseguenze dalla violenza
o del malgoverno (dysnomie): Euonime rende ogni cosa ben ordinata ed opportuna e spesso impone i ceppi ai malvagi.
Impliciti in questa nuova formulazione sono due sviluppi. Il concetto di giustizia era per lo più assente in Tireo: la virtù sociale
che questi esprimeva era il buon ordinamento inteso come senso della disciplina. Solone tornò alla concezione esiodea per cui
il buon ordinamento della città era fondato sulla giustizia sociale, ma poi per certi aspetti andò al di là di Esiodo. Per Solone
benefici o sanzioni non esulano dal corpo umano (non hanno componente divina): dei e natura non compaiono. A controllare il
proprio destino è l’uomo. La poesia critica poi la ricchezza, imputandole i mali che affliggono il governo e la città di
dysonimie. Aristotele conclude che Solone attribuisce in generale le cause del conflitto alla ricchezza. Anche se il desiderio di
ricchezza è connaturato all’uomo, vi sono due modi per raggiungerla: correttamente o tramite l’abuso di potere. Prima delle
riforme si presentò dunque come difensore degli oppressi contro l’aristocrazia, come un radicale, mentre dopo di esse preferì
presentarsi come un moderato ben saldo sulle sue posizioni. Le riforme di Solone andarono sotto il nome complessivo di
seisachteia (alleggerimento dai pesi). I due slogan radicali più importanti del IV secolo e dell’epoca successiva furono
“abolizione dei debiti” e “ridistribuzione delle terre”. Solone seppe fare leva su queste due istanze. In relazione al problema dei
debiti gli furono attribuite due misure: l’eliminazione delle garanzie consistenti nella persona fisica del debitore o di membri
della sua famiglia, cioè l’abolizione della schiavitù per debiti; gli studiosi antichi indagano poi se Solone abbia o meno abolito
tutti gli altri debiti preesistenti la sua riforma, ed alcuni autori tentarono di screditarne l’opera, oppure si provarono a
ridimensionare il significato di una riforma per loro non più che supposta: asserirono che essa sarebbe consistita in una
svalutazione della moneta d’argento, che avrebbe promosso un taglio degli interessi e dei capitali per i debiti arretrati. Da ciò si
evince solo che egli no menzionò mai nelle sue poesie il tema dell’abolizione dei debiti. Si sottolinea poi che il concetto di
valuta ufficiale non emerse ad Atene fino al termine del VII secolo. In ogni caso, l’asservimento per debiti esistette; si tratta
per lo più di una conseguenza del fatto che in una società stratificata come quella di Atene una classe di inferiori deve essere
disponibile a compiere certi servizi agli individui delle classi superiori. La schiavitù per debiti è quindi il livello più infimo di
questo sistema. La terra era chiamata epimortos, i contadini hektemoroi o pelatai, quella che essi pagano è una morte, uno
quota parziaria. Lì interpretazione più ovvia per questo sistema è che lo sfruttamento del suolo fosse inteso come rendita di
grandi proprietari, in cui il tenutario pagava al padrone un sesto di quanto il suolo produceva, ed il padrone aveva il diritto di
ridurre in schiavitù il tenutario inadempiente. È un sistema come questo, che Solone avrebbe abolito. Non si hanno però indizi
per dimostrare che l’Attica sia mai stata terra di ampi possedimenti fondiari; è quindi difficile configurare quella
redistribuzione dei campi in lotti eguali, che ne sarebbe implicata. Inoltre la quota di un sesto è assai bassa per un sistema
agricolo fondato sulla corresponsione ai proprietari di quote del prodotto. Una diffusa interpretazione moderna cerca di
spiegare questi dati della tradizione in termini puramente economici. La sovrappopolazione che condusse al disboscamento,
alla sovrapproduzione e allo sfruttamento eccessivo del suolo, ne avrà ridotto il rendimento a tal punto che i contadini
autonomi si saranno visti costretti ad ipotecarlo con gli aristocratici del luogo per riceverne cibo e nuovo grano per seminare:
gli interessi su tali ipoteche saranno stati fissati a un certo punto nell’ordine di un sesto. Per i contadini sarebbe diventato
sempre più difficoltoso riuscire a vivere sul loro campo ed una volta che, alla fine, non fossero più stati in gado di saldare
l’ipoteca, avrebbero finito con l’emigrare o con l’essere venduti schiavi. Tuttavia le oscillazioni nei rendimenti dei seminati
presupposti da questa teoria, avrebbero reso la quota sulle messi un interesse troppo poco incentivante per gli stessi
aristocratici. La teoria in questione è plausibile solo nella misura in cui evita di collegare i debiti alla valuta, e nella misura in
cui coniuga disagio economico e sovrappopolazione: il cospicuo incremento demografico dei due secoli precedenti doveva far
sentire serie conseguenze verso la metà del VII secolo. L’approccio più produttivo all’instabilità economica dell’epoca
soloniana venne suggerito da Fustel de Coulanges; egli vide che il problema dei debiti era un problema secondario:
l’alleggerimento dei pesi fu innanzitutto una rivoluzione socia, e consistette nell’abolizione dei rapporti clientelari fra contadini
ed aristocratici. Incerte le origini di tale sistema: può essere residuo della vecchia organizzazione fondiaria micenea, con la
“sottomissione ai basirei locali”, oppure derivante da un contatto “feudale” volontario di mutuo aiuto che si sarebbe stipulato
durante il periodo delle migrazioni, oppure si potrebbero rispecchiare in esso le modalità secondo le quali a metà dell’VIII
secolo si ripopolò l’Attica. Il carattere essenziale del sistema all’apice del suo sviluppo si risolve nel concetto si usufrutto
condizionato. In sé non era un sistema economico duro (un sesto del raccolto). Da una parte i contadini avranno sempre più
considerato il pagamento della quota di un sesto ai proprietari come un segno di degradazione di soggezione in un’epoca in cui
altre città, sia recenti, sia antiche, stavano ammettendo il principio dell’uguaglianza politica. Dall’altra parte questo stesso
sistema va studiato anche nella suo dimensione di strumento inteso all’ottenimento della ricchezza, oltre che come una
struttura in cui inquadrare reciproci rapporti sociali: in questi termini, possiamo supporre che, una volta giunta l’epoca oplitica,
diventassero inutili i servizi che l’aristocrazia aveva reso in precedenza. Con la nuova aristocrazia internazionale ,costituita da
tiranni che controllavano le ricchezze, la ricchezza stessa degli aristocratici dovette subire proprio allora un notevole tracollo,
se le città iniziarono a fornirsi del frumento a buon mercato importato da Egitto e Mar Nero ad opera dei mercanti di Egina. Di
fronte a tale stato di cose, il modo più facile di incrementare le entrate poté essere quello di sfruttare il sistema vigente con
abusi tali da produrne forse la crisi. Il complesso reticolo di obbligazioni che abbiamo cercato di ricostruire avrà
indubbiamente ingenerato confusione sull’identità degli autentici possessori della terra. I cippi confinanti divelti da Solone
erano simboliche affermazioni di possesso su questa terra vacante da parte dell’aristocrazia. I più poveri continuarono ad avere
poco potere. La teoria prospettata presuppone quindi l’esistenza di uno status dipendente ed assieme di una schiavitù per debiti,
che spiega le ragioni per cui si arrivò a non approvare più il sistema sociale vigente ed inoltre anche il modo in cui quelli che
erano stati oggetto di oppressione sarebbero diventati abbastanza potenti da scardinare il sistema, trovando la loro guida in un
uomo il cui messaggio sociale più insistente sarebbe stato che la giustizia era più importante della ricchezza. Alla base di tale
costituzione stava un nuovo sistema di distribuzione del potere politico. Solone istituì quattro classi censita rie, basate sulla
quantità dei raccolti che i singoli individui facevano sulle loro terre, computati in un’unità di misura per liquidi o per solidi:
pentqakosiomedimnoi (che producono 500 staia), hippie (soldati a cavallo, almeno 300 medimnoi), zeugitai (quelli cha hanno
un giogo, 200 medimni o più)e i thetes. Istituire gli hippeius al vertice significò una provocazione della vecchia aristocrazia.
Non sappiamo nulla né del modo in cui le classi censita rie vennero istituite, né del sistema in base al quale si passava da un
ceto all’altro, anche se Aristotele cita un’interessante iscrizione su una statua dell’Acropoli, da cui risulta che questi passaggi
di classe avvenivano veramente. Aristotele attribuisce a Solone anche l’introduzione del sorteggio per la scelta degli arconti, e
che cadde in disuso durante la tirannide, per venire poi riesumato nel 487/486. a fianco dell’aristocratico consiglio
dell’Areopago, Solone costituì invece un consiglio popolare costituito da 400 membri, 100 per ogni tribù. Rimane incerto
come ne fossero scelti i componenti, e se fossero eleggibili tutti i cittadini, compresi i chete. Il consiglio più tardo che da
questo derivò possedeva due funzioni: corpo amministrativo più importante dello stato, responsabile di una supervisione
sull’opera di tutti i pubblici ministeri e che preparava tutti gli ordini del giorno per l’assemblea. Nonostante lo scetticismo di
alcuni storici riguardo la sua attribuzione a Solone, gli ateniesi registrarono l’esistenza del consiglio soloniano dei 400 almeno
verso la fine del V secolo. Altre due testimonianze si aggiungono: un complesso di edifici dell’inizio del VI secolo, scoperto
ove più tardi sarebbero sorte le sale consiliari; una iscrizione arcaica che proviene dall’isola di Chio ed attesta una legge
costituzionale databile al periodo 575-550. la parte frontale è difficile da decifrare, ma essa riguarda delle multe e dice
qualcosa di un consiglio popolare come distinto da un consiglio aristocratico, e che esso trattava gli affari del popolo, ed aveva
qualche ruolo negli appelli contro le sentenze magistratuali. Le analogie col sistema soloniano sono tante e tali da presupporre
un modellamento sulla legge soloniana. Solone attuò due importanti cambiamenti procedurali: secondo Aristotele sia la sua
seconda che la terza riforma più democratica riguardavano il fatto che chiunque lo desiderasse poteva intraprendere un’azione
giudiziaria a favore di quelli che erano stati giudicati ingiustamente; prevedeva inoltre l’istituzione del diritto di appello ad una
corte con giuria popolare nei confronti di una sentenza magistratuale. La prima trasformava il sistema giuridico da una struttura
fondata sulle procedure arbitrali, in un sistema nuovo che si basava sulla legge pubblica. La seconda eliminò il potere di
giudizio definitivo che rimaneva al magistrato aristocratico e rimetteva questo stesso potere nelle mani del popolo. Il codice
giuridico di Solone fu poi la sua più importante e duratura riforma; si ritiene che coprisse tutte le aree del diritto: criminale,
politico, diritto familiare, diritto fondiario, offese personali, diritto commerciale e religioso. Essa pare permeata dalla volontà
di applicare la ragione ai problemi sociali e di controllare la libertà che ci si poteva prendere rispetto alla tradizione. Ogni
uomo poteva disporre come voleva dei suoi beni. Vi erano poi un certo numero di disposizioni sull’economia: proibì che
venissero esportati i prodotti del suolo, tranne che l’olio d’oliva, mentre incoraggiò l’industria artigianale nella città. Non
mancano inoltre modifiche nel sistema di pesi e di misure. Gran parte dell’opera politica di Solone fallì. L’elezione
all’arcontado diede origine ad aspre divisioni “feudali”: nel 590 e nel 586 non vennero nominati arconti, mentre quello del 582
ricoprì la sua carica per due anni e due mesi, finché non venne destituito e sostituito da uno staff di dieci arconti. Si formarono
tre partiti: quello della Costa (Megacle, un Alcmeonida), della Pianura (famiglie nobili e ricche di territorio tra Atene ed
Eleusi), delle Colline, con capo Pisistrato. Quest’ultimo nel 561 affermò il suo potere come tiranno, ma gli altri due gruppi lo
spodestarono. Egli allora stipulò un matrimonio di alleanza con la famiglia di Megacle e tornò al potere, per essere una
seconda volta cacciato. Solo più tardi poté instaurare un potere stabile con l’aiuto di Ligdami di Nasso e di mercenari eretriesi
e tessali (546). La liberazione degli hektemoroi e le riforme politiche di Solone erano state troppo avanzate per la società del
tempo, anche se la sua opera ebbe in parte successo grazie alle risvolte di carattere sociale.
12 STILI DI VITA: L’ARISTOCRAZIA
Per tutto il periodo arcaico della cultura greca, nonostante esistesse una classe oplitica dotata di autocoscienza, la gestione al
vertice della politica rimase nelle mani degli aristocratici: il che si riflette nel predominio di forme sociali che son connesse con
il loro stile di vita. La loro funzionalità militare scomparve con l’introduzione della tattica oplitica e ciò causò sia una
trasformazione, sia un adattamento nelle quali tuttavia rimasero molte delle attitudini precedenti. Jacop Burckhardt la chiamò
età dell’uomo agonale (da agon = gara), le cui radici derivavano dall’etica competitiva dell’uomo omerico,ma che in età
arcaica si trasformò in attività culturale, un modo per metter in luce le proprie qualità.
Una volta privato di valore nella sfera militare, lo agon trovò il suo centro nell’attività sportiva, già presente in Omero. Grande
occasione per gare di questo tipo erano le grandi esequie funebri. All’’inizio del VI secolo i giochi funebri vennero rimpiazzati
in questo ruolo dalle feste periodiche in onore di un dio particolare. Le quattro grandi feste religiose in cui si svolgevano i
giochi erano quella di Olimpia (dal 786), quella Istmica (581), quella Nemea (573) e quella Pitica (582, a Delfi). Tutte e
quattro erano connesse con santuari piuttosto che con città specifiche, e per questo motivo avevano un prestigio internazionale
maggiore di festività come le Panatenaiche di Atene. Lo status internazionale di Olimpia veniva garantito da una tregua sacra
di uno o più mesi per tutta la durata dei giochi, e atleti e spettatori potevano passare incolumi attraverso qualsiasi confine
(potevano quindi avvenire anche in tempo di guerra). Venivano riconosciute sei categorie principali di spot. Le gare di corsa
con armatura in tre distanze: lo stadion, cioè 200 iarde, era la più prestigiosa. Il pentathlon era una gara in cui il vincitore
doveva essere risultato il primo in almeno tre di cinque specialità: salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto, corsa
e lotta libera. Il pugilato si volgeva senza guantoni, ma con strisce di cuoi che proteggevano le mani. La lotta rea meno
pericolosa e piaceva agli aristocratici. Il pankraiton era una forma di lotta libera in cui era permessa quasi qualsiasi cosa, tranne
che morsi e ditate negli occhi. L’ultimo sport era la corsa dei carri trainati da quattro cavalli. I premi più importanti in palio
erano corone simboliche di olivo (ad Olimpia), oppure alloro (a Delfi), di pino (Istmici), di sedano selvatico (Nemei). Il premio
maggiore lo riceverà il vincitore nella sua città natale (ingressi trionfali, monumenti, premi in denaro, possibilità di accesso
illimitato ai banchetti). Pindaro, il più grande fra tutti i poeti lirici, appartenne al gruppo di poeti che si mantenne celebrando le
vittorie di questi atleti (egli apparteneva quale aristocratico tebano alla classe di cui celebrò la grandezza. Simonide, nato nel
556, fu il primo a scrivere Odi di celebrazione delle vittorie (epinikia) nei giochi, sia ad iniziare la professione di poeta corale
salariato: proprio questo rapporto professionistico tra poeta e patrono conferisce allo epinicio le sue caratteristiche peculiari (le
Odi sono quindi standardizzate). Non tutti condividevano questo entusiasmo per il successo sportivo; Senofane attaccò la
relazione fra attività sportiva ed attività politica. Il gymnasion, la palaistra e i giochi internazionali rappresentavano dei luoghi
di incontro, nonché i centri in cui l’aristocrazia arcaica poteva dare prova di sé. Una forma di organizzazione della vita di
società molto più antica e più importante fu quella del simposio aristocratico. Se ne possono seguire le origini risalendo fino
alla istituzione del banchetto di prestigio, coltivata dalla élite dei guerrieri omerici. In generale l’influenza della
predisposizione orientale al lusso alterò profondamente ed in molti punti la sua organizzazione e la sua etica. In molte zone
tuttavia l’importanza sociale e politica del simposio rimase inalterata: a Sparta il sistema militare ed il codice sociale trovavano
in ultima analisi il loro fondamento sugli andreia (banchetti degli uomini) e sui phiditia; la poesia di Alceo e Saffo dimostra
che a Mitilene lo stile di vita aristocratico e le attività politiche ad esso collaterali continuavano ad essere basate sul banchetto
nel megaron maschile e nei thiasoi femminili. Così in Atene la phratria rimase il centro dei rapporti di fedeltà politica almeno
fino alle riforme di Clistene, mentre anche dalla fine del V secolo continuarono ad esercitare attività politica le hetaireiai
aristocratiche (club ove ci si incontrava per bere). Da ciò si deduce che il simposio aristocratico era un centro di vita sociale e
culturale le cui pratiche erano regolate da un rituale e da una tradizione ben precisi. Chi presiedeva la riunione aveva il titolo
vetusto di basileus e determinava le fasi di successione del banchetto e la proporzione in cui riteneva opportuno far mescolare
l’acqua ed il vino nel grande krater (il vino non mesciuto si riteneva fosse pericoloso per la salute). Le varie fasi esordivano
con i rituali di abluzione e la distribuzione di ghirlande, nonché con una libagione agli dei. C’erano vari giochi. A ravvivare
l’intrattenimento vi erano poi danzatrici, o si facevano gare di canto accompagnate da una schiava flautista. Di questo simposio
abbiamo testimonianza da Alcmane e da un vaso corinzio. La documentazione più rilevante dei mutamenti che intervennero
nei costumi di vita aristocratici, e che trovano espressione nel simposio, ci deriva dalle rappresentazioni collegate alle
cerimonie funebri: nel richiamare le gioie della vita, si raffiguravano sempre seduti al simposio circondati dai loro compagni a
godere le gioie del banchetto. L’esempio più illustrativo è la scena del simposio raffigurata sulla tomba del tuffatore. Gran
parte della produzione artigianale greco-arcaica è in qualche rapporto con le attività inerenti il simposio, vasellame per lo più.
Non sorprende che un gran numero di temi figurativi dipinti sui vasi arcaici siano connessi al simposio. Per lo più possiamo
fare le stesse considerazioni anche in base alla poesia dell’età arcaica. La poesia stessa era una delle sue principali forme di
intrattenimento, o derivava la sua struttura da quelle che erano le pratiche simposiache. Il raffinamento progressivo dei gusti
degli aristocratici fece fiorire un numero notevole di poeti simposiaci professionisti, dal cui talento potevano nascere poesie di
una eleganza tale da travalicare di molto gli scopi di una creazione estemporanea. Ne conseguì un mutamento nei toni della
poesia, da prima fondata sulla personale esperienza dei poeti, poi con tematiche che erano espressione generalizzate di norme
sociali e di emozioni concepite da parte di tutta una classe, oltre che dal singolo autore. Da ciò deriva la povertà di sensazioni
genuine, nonché del senso di decadenza (es. Anacreonte di Teo). Senofane prese più sul serio il significato del simposio, a tal
punto che si è ipotizzato che parlandone egli avesse in mente una sorta di consorteria filosofica o religiosa, o che comunque
criticasse le opinioni più diffuse presso i suoi contemporanei. I due filo dell’attività sportiva e degli incontri prandiali sono
intrecciati nella storia della contesa ,matrimoniale per la mano di Agariste, figlia di Clistene tiranno di Sicione. Dpopo la
vittoria nella corsa durante i giochi Olimpici, Clistene fece proclamare dall’araldo che chiunque si redesse degno della mano di
sua figlia doveva presentarsi a Sicione nel giro di sei giorni. Egli si era fatto costruire una pista per la corsa ed un fondo per la
lotta libera, ove incontrò i pretendenti più prestigiosi della Grecia e dell’Italia meridionale: tredici uomini di ricchezza e fama
insigni. Furono tenuti come ospiti per un anno intero e studiati con attenzione. In prima fila c’erano due ateniesi e il
pretendente principale si chiamava Ippoclite. Egli ebbe vita facile finché un giorno, dopo aver bevuto un po’ troppo, chiese al
flautista di suonargli una modulazione di danza e fece introdurre nella sala una tavola sulla quale si mise a ballare, continuando
poi con il battere le gambe a ritmo di musica. Clistene cambiò idea sul pretendente; concesse poi un talento d’oro a tutti i
pretendenti che non avevano avuto successo, e fidanzò la figlia a Megacle figlio di Alcmetone, da cui discenderanno Clistene e
Pericle.
Abbiamo fatto anche riferimento al tema del problema sessuale. Il periodo che va dal 570 al 470 circa non è soltanto una delle
epoche più produttive della poesia erotica, ma anche la grande epoca della decorazione vascolare erotica. In epoca arcaica, la
classe sociale e la moda giocarono un ruolo di primo piano nel condizionamento delle risposte sessuali degli individui.
L’atteggiamento arcaico nei confronti del sesso aveva un rapporto stretto con le istituzioni sociali dell’aristocrazia. Il
matrimonio era un’occasione per creare alleanze politiche e sociali e rinforzare la posizione del genos nell’ambito della singola
città-stato, oppure in seno al circolo dell’aristocrazia internazionale. La sposa assumeva una posizione di secondaria
importanza in tutto ciò ed il rapporto principale risultava quello tra suocero e genero. L’orientamento in cui i Greci
concepivano un amore romantico era omosessuale sia maschile che femminile. Atteggiamenti di questo tipo erano stati fondati
dall’aristocrazia arcaica ed anche in seguito sarebbero rimasti caratteristici specialmente dei circoli aristocratici. La relazione
erotica che più comunemente si ammetteva era quella tra un uomo attempato, erastes (innamorato), e un giovane adolescente,
eromenos (amato). Lo erastes corteggia ed assilla l’amato con doni e si comporta in generale come se fosse pazzo, mentre la
famiglia del ragazzo ha un atteggiamento che oscilla tra l’orgoglio e la preoccupazione. Questi ragazzi appartenenti alla stessa
classe sociale dei loro amanti rientrano nello stesso mondo affettivo dominato dagli ideali dello sport e del bere. Una lunga
serie di giovani maschi nudi, noti come kouros, domina la storia della scultura arcaica, anche se non ne conosciamo la funzione
e il significato. Inoltre la maggior parte delle epigrafi di antiche coppe si riferisce a maschi. Inoltre, durante il periodo arcaico
le raffigurazioni sia maschili che femminili richiamano tratti tipici dell’uomo atletico e forte, mentre alla fine del periodo
arcaico c’è una marcata tendenza verso una maggiore effeminatezza nel rappresentare i giovinetti, ed una cura maggiore nel
raffigurare le donne. Ciò suggerisce un tramonto della grande epoca dell’omosessualità. Aristofane attua una giocosa nostalgia
nei confronti della precedente generazione, segnata per l’appunto dall’omosessualità. Ciò è connesso a due fenomeni: il fatto
che verso la metà del V secolo la forma mentis dell’aristocrazia non poteva più plasmare su di sé la cultura, diventata
democratica sotto il patronato dello stato; la reviviscenza di tematiche care all’epoca omerica ed eroica: arte e tragedia.
L’importanza delle preferenze omosessuali può essere messa il luce dalle vicende dell’abbattimento della tirannide ateniese,
come narrato da Tucidide: nel 514 Ipparco venne assassinato da una coppia di amanti aristocratici, Armodio ed Aristogitone; in
precedenza Ipparco aveva disonorato in pubblico la sorella di Armodio. All’inizio del V secolo il mondo aristocratico aveva
perduto la sua ricchezza.
13 STILI DI VITA: L’ECONOMIA
Nella poesia elegiaca attribuita a Teognide di Megara e composta intorno alla metà del Vi secolo, la ricchezza viene
considerata innanzitutto indesiderabile elemento di sisturbo dell’ordine costituito. Da essa risultano incrinature varie
dell’integrità dell’aristocrazia, come il matrimonio interclassista buono oppure cattivo. La base economica della distinzione
che Teognide fa, è innanzitutto quella della ricchezza basata sulla terra o sulle attività: presso tutte le classi la terra
rappresentava la forma di arricchimento socialmente più riconosciuta perché la forma era più permanente, più sicura e più
soggetta ai vincoli imposti dal genos. Tuttavia solo pochi Greci di qualsiasi classe permettevano a questo ordine di
considerazioni di determinare punto per punto il loro comportamento economico. Si cerca di stabilire distinzioni rigide che
rapportano una classe sociale a tipi particolari di attività economiche. L’artigianato e il commercio erano professioni
considerate inferiori. Per molti riguardi, la Grecia e la zona commerciale mediterranea furono economicamente più progredite
nel periodo arcaico che nelle epoche successive. L’artigianato conservò lo status ambivalente che lo aveva caratterizzato nel
mondo omerico. Gli artigiani erano peculiarmente aperti a istanze e incentivi economici (come ricordano Esiodo e Aristotele).
Òa ricchezza e l’orgoglio per il proprio talento trovano testimonianza nelle firme che gli artisti appongono alle loro opere per
tutto il periodo arcaico. Nel VI secolo le firme degli scultori sono abbastanza comuni e a partire dal 570 anche vasai e
decoratori attici cominciano a firmare spesso i loro vasi. In ogni caso l’artigianato non divenne mai un’attività socialmente
rispettata. L’attività commerciale era qualcosa di diverso. La distinzione fra commercio su lunghe distanze e su distanze brevi
era già divenuta una realtà, e non mancavano valide testimonianze del fatto che i governi di alcune città continuavano a
mostrare interesse per attività commerciali su larga scala per tutto il periodo arcaico. La ricchezza di Corinto si fondava
anzitutto sul commercio. Lo stesso è dimostrato dall’attività focese lungo le coste del Mediterraneo occidentale, da Marsiglia
fino alla Spagna. Siamo meno documentati sull’attività di Egina, la più importante rivale di Corinto sul piano commerciale per
tutto il periodo arcaico, per la mancata produzione del vasellame da cui si ricavano solitamente le maggiori informazioni. Fino
all’allestimento della nuova flotta ateniese nel corso delle guerre persiana, quella di Egina rimase la seconda più grande del
continente greco. Egina partecipò al commercio cerealicolo con l’Egitto, e fu probabilmente anche uno dei maggiori
esportatori del vasellame attico a figure nere e a figure rosse. I tentativi con cui a varie riprese gli Ateniesi cercarono di
sottrarsi alla supremazia navale di Egina hanno motivazioni economiche. La tirannia pisistratide parrebbe aver tenuto un
atteggiamento conciliante nei riguardi dell’isola, ma poco tempo dopo la sua caduta iniziò una serie di conflitti in cui Corinto si
schierò con Atene. Alla fine, intorno al 483, Temistocle persuase gli ateniesi a costituire la più grande flotta che si fosse mai
vista in Grecia, concepita specificamente contro Egina, Erodoto dice che fu la guerra contro Egina a salvare la Grecia, poiché
indusse Atene a diventare una potenza navale. L’ostilità non si spense nemmeno dopo le guerre persiane, e solo a metà del V
secolo Atene costrinse l’isola ad entrare a far parte del suo impero. Nella maggior parte delle città l’attività commerciale non
avrebbe avuto nessun rapporto diretto con l’aristocrazia, se non nel senso che questa fungeva da consumatrice di gran part dei
prodotti che il commercio trattava. Si crearono così mercanti professionisti, con istituzioni che servivano a salvaguardare e
limitare la forza di questa classe. Ove l’attività commerciale era legale, si aveva regolarmente la fondazione di scali
commerciali, comunità permanenti di Greci che vi si erano insediati provenendo da città diverse. Abitualmente costretti a
rimettersi alla benevola tolleranza da parte degli abitanti della regione, gli emporia differivano dalle colonie perché erano privi
di legame ufficiale con una città originariamente fondatrice. Le caratteristiche principali di questi emporia sembrano essere
state la sua dislocazione ai margini dell’area di espansione di una civiltà estranea, o la sua funzione di avamposto quanto più
possibile vicino ad una zona di particolare importanza per la produzione di materie prime (Al Mina, Pitecusa e Spina. Diversa
la situazione di Gravisca dove si sviluppò una comunità greca con i propri centri di culto. Con presupposti di questo genere
sorse anche Naucrati in Egitto, il più importante ed il meglio documentato degli emporia arcaici; la città fu un centro greco,
anche se sottoposto ad un certo controllo da parte del faraone. Qui vi si trovano numerosi templi greci, alcuni dei quali
documentati da Erodoto. Avvenne che le istituzioni del governo crescessero a poco a poco dai santuari fondati dai diversi
gruppi residenti. La città rimase il più importante porto dell’Egitto fino alla fondazione di Alessandria, alimentò una fiorente
industria turistica ed infine divenne famosa per le meretrici. Fu però essenzialmente una città commerciale. L’articolo più
importante che vi veniva trattato fu il frumento).
La superiorità bellica oplita era largamente riconosciuta dai monarchi orientali. Costoro impegnarono notevoli contingenti di
greci della Ionia e anche di Cari, ma di ciò mancano per lo più testimonianze. Sappiamo che Antimenida, fratello di Alceo,
trascorse il suo esilio militando presso Nebuchadrezzar babilonese e combatté la campagna di Palestina dei 597, in cui
Gerusalemme venne conquistata. Solo per l’Egitto possiamo ricostruire una storia dettagliata di queste truppe mercenarie.
Dalla fine del XIII secolo e dopo la vittoriosa cacciata dei Popoli del Mare, l’Egitto aveva subito un lento declino. Nel corso
dell’VIII secolo fu sottoposto prima al potere della Nubia, poi divenne territorio conteso fra Nubia e Assiri. La rinascita della
potenza nazionale egiziana si ebbe con Psammetico I, che riuscì a restituire unità all’Egitto. Le Storie di Erodoto mettono in
evidenza il debito che la nuova dinastia ebbe fin dall’inizio nei confronti dei mercenari greci (come cos’ì aveva suggerito un
oracolo). Dopo la conquista dell’Egitto, questi mercenari furono stanziati sulla frontiera orientale come baluardo contro gli
Assiri (città di Elefantina). La dinastia Saite continuò ad appoggiarsi in misura massiccia ai mercenari, prima con Necho e poi
con Psammetico II (nel 591 compì una spedizione contro Nubia, in cui il comandante egiziano Potasimto fu alla guida di un
contingente straniero) e con Apries (per sedar una rivolta guidata da Amasi, arruolò 30000 Cari e Ioni e venne sconfitto solo di
stretta misura)). La rarità in Egitto di reperti archeologici di provenienza greca al di fuori degli accampamenti militari,
dimostra che i greci non possono essersi stanziati nella regione in comunità molto numerose. Una delle ragioni per le quali ci
fu un profluvio di ricche offerte votive e di altri segni di deferenza da parte dei monarchi d’Egitto e di Lidia nei riguardi dei
santuari oracolari della Grecia, può essere stato il fatto che questi stessi santuari diventavano centri di reclutamento durante le
grandi festività religiose internazionali. Con ciò si spiega il significato di Naucrati: il faraone vi aveva stabilito un gruppo di
mercanti che scambiavano frumento con argento, l’argento impiegato per pagare i mercenari, i quali lo rimettevano in
circolazione spendendo le loro paghe nell’ambito del mondo egeo. I greci a loro volta attribuirono agli dei egiziani una sorta di
precedenza cronologica rispetto a quelli greci, ed agli egiziani stessi la scoperta della scrittura e della maggior parte delle arti
figurative. Ciò ovviamente non trova alcun fondamento, anche se un prestito si ebbe sul piano dell’architettura sacra dalla fine
del VII secolo: l’improvviso apparire dei templi di pietra e del monumentale stile dorico; nuova progettazione di complessi
religiosi; nella scultura, la funzione del kouros quale mobile sacro.
Strettamente connessa con il movimento internazionale di uomini e materiali è l’invenzione di un nuovo medium di scambio:
la moneta coniata. La monetazione greca ebbe fin dall’inizio certe peculiarità che esercitarono influssi tanto permanenti sulle
varie forme di monetazione in tutto l’Occidente fino al nostro secolo. Consistette nel fissare quantità uniformi di metallo
prezioso, calibrato nell’ambito di un sistema di multipli e sottomultipli più o meno vasto. Questi pezzetti di metallo erano poi
coniati su di un lato con il sigillo ufficiale della città, sull’altro un marchio punzonato. Questa duplice punzonatura rappresenta
il gradino più importante verso il raggiungimento di una monetazione vera e propria. Quale danaro degno di sicurezza, la
moneta coniata facilita un notevole numero di transazioni economiche. Si ha perciò una differenza di fondo fra quella che in
termini generali si chiama economia monetaria e quella che si chiama economia di scambio (buoi e poi chiodi di ferro, simili a
monete). L’avvento della monetazione coniata non implica da solo l’esistenza di una economia monetaria. Secondo Erodoto i
Lidi furono i primi a noi noti a battere moneta e ad impiegare danaro d’oro e d’argento (fra il 625 ed il 600). Nella tradizione
greca il primo stato greco a battere moneta fu Egina (595 circa) e la città che seguì fu Atene (575 circa), poi Corinto (570
circa), ed infine tutta una lunga serie di altri stati nel corso del VI secolo. Questo notevole esempio dell’attenzione statale per
uno strumento dell’attività economica pone importanti problemi circa gli scopi e gli impieghi che l’istituzione ebbe nella sua
prima fase. Erodoto afferma anche che i Lidi furono anche i primi ad essere commercianti. L’ipostesi per cui la monetazione
coniata sarebbe stata connessa con il commercio su larga scala trova conforto nel ruolo che nella sua diffusione ebbe Egina, ma
in effetti, anche se le sue monete si trovano sparse qua e là per tutto il Mediterraneo orientale, non le si sono trovate in grande
quantità in nessun singolo tesoro. Questo dato di fatto si connette al più generale fenomeno per cui, fino al V secolo, solo le
monete della zona macedonica e tracica trovano larga diffusione al di fuori dell’area in cui sono battute. Se ne deduce che la
moneta battuta non funzionò all’inizio come facilitazione per il commercio a lunga distanza, ma raggiunse la quotazione
maggiore in un’area di diffusione domestica ove viene accettata con la massima facilità e senza problemi. Nel VI secolo il
governo divenne qualcosa di sempre più complicato. La moneta punzonata con il sigillo ufficiale della città semplifica le varie
operazioni standardizzandole: diventa possibile una contabilità pubblica efficiente. La sua diffusa adozione facilitò il
movimento dei beni e dei servizi nel mercato internazionale del VI secolo, perché anche dove non la riconosceva, si introdusse
il concetto dell’argento come medium di scambio.
Verso la metà del Vi secolo si era sviluppata nel Mediterraneo una complessa economia internazionale di mercato, implicante
lo scambio di una notevole varietà di beni e di servizi. Al contrario che nell’età arcaica, l’attività commerciale su larga scala
acquisì quantomeno lo stesso rilievo che lo scambio di articoli di lusso. Esistette un commercio regolare e vantaggioso che si
svolgeva secondo percorsi ben precisi a partire dal Mar Nero e fino al Mediterraneo occidentale (metalli, legno, derrate
alimentari, schiavi,…). L’economia mediterranea fu allora più unitaria e avanzata di quanto non lo sia mai stata in nessun
periodo precedente Alessandro Magno. Il venir meno di questo sistema in seguito all’avanzata persiana tra il 546 e il 480
rappresentò un regresso rilevante ed in qualche misura permanente. Durante il periodo arcaico avvenne nell’economia greca
almeno un mutamento di grande rilievo. La Grecia era sempre stata una società che dovette qualcosa al lavoro degli schiavi,
ma pare che fino al IV secolo gli schiavi stessi non siano stati un fatto importante nell’ambito dell’economia (come testimonia
Teopompo di Chio nel IV secolo). È con l’avvento dello schiavo considerato come bene mobile, che la schiavitù diviene un
fenomeno strettamente economico e conforme alle leggi di domanda e offerta: agli schiavi viene dato un valore di scambio ben
determinato. Vengono venduti e comperati al mercato. Nel VI secolo le vie commerciali del mondo greco avevano già
raggiunto un notevole grado di organizzazione, ed i greci avevano acquisito la ricchezza e la potenza militare sufficienti ad
avere schiavi in gran numero. È probabile che il numero degli schiavi presenti nelle città di maggior rilievo fosse almeno
equivalente a quello che vi si sarebbe ritrovato nella Grecia classica.
Un aspetto caratterizza la prosperità della struttura sociale arcaica: è il surplus di talenti, di forza-lavoro e di ricchezze
disponibili per la realizzazione di opere pubbliche. Il VI secolo fu la grande epoca dell’architettura sacra. Motore del nuovo
movimento fu la volontà di sperimentazione e di competizione. Nell’ultima fase del grande secolo dei templi greci si rilevano
già sintomi di esagerazione, di ostentazione smaccata e di incapacità a portare a compimento i progetti. Uno dei costi più
incisivi era quello del trasporto delle pietre, e perciò nell’Occidente si usava sempre pietra locale. I tiranni instaurarono in
Grecia il patronato statale sulle arti, ed in questa loro prassi lo stile di vita dell’aristocrazia e le ricchezze della città furono
congiunte in una sorta di connubio. Si associarono ai tiranni anche alcuni aristocratici, e la loro opera venne quindi continuata
dai successivi governi non-tirannici. Infine, la nuova importanza acquisita dalle festività religiose e dai santuari determinò un
afflusso di capitali e di offerte votive sia dalle città greche, sia dai sovrani orientali in direzione di templi come quello di Delfi,
Olimpia, Delo, Dodona e Branchidae.
14 L’ARRIVO DEI PERSIANI
I greci della Ionia compresero ben presto il pericolo del loro trovarsi sul continente asiatico. I Cimmeri avevano avuto come
sede le coste settentrionali del Mar Nero dalla Crimea al Caucaso, ma intorno al 700 vennero costretti a spostarsi verso
l’Anatolia attraverso il Caucaso, sotto la pressione dell’avanzata degli Sciiti. Testimonianze del VII secolo dimostrano che
anch’essi crearono pressioni sull’impero assiro stesso, ma ben presto spostarono la loro attenzione verso il regno di Lidia, in
particolare quello guidato da Gige dal 678. nel 652 egli venne ucciso in battaglia e la capitale Sardi spugnata. Subito al di là
della Lidia si trovavano le città greche della costa, anch’esse sotto pressione. Gli dei salvarono la Ionia: Artemide di Efeso
diffuse la peste ed i Cimmeri si ritirarono in Cilicia, cessando di costituire un pericolo. La pressione sulla Iona comunque non
cesso. Il regno di Lidia risorse e ricominciò a incalzare, soprattutto con Aliatte. Il territorio di Mileto venne sottoposto a
continue scorrerie per 11 anni, fintanto che il tiranno Trasibulo non si indusse a trattative intorno al 610. le altre città greche
subirono un trattamento ben diverso: Colofone e Smirne vennero saccheggiate e conquistate; fu poi il turno di Efeso e di tutte
le altre città della costa. Dopo la brutalità iniziale della conquista lidia, verso la fine di essa i greci avevano potuto stipulare
accordi con i loro nuovi padroni. Gli stessi re lidi finirono per ellenizzarsi. Gli scavi di Sardi hanno messo in luce una gran
quantità di vasi greci, ed abbiamo fondati motivi per credere che i benefici reciproci sul piano dei rapporti commerciali
inducessero i due popoli a mutue influenze. La Ionia fu poi madrepatria dell’epica, ma da altri punti di vista il suo sviluppo
culturale rimase lento (vasi orientalizzanti e istituzioni politiche). Geli influssi dell’Oriente vi transitano semplicemente, diretti
verso la Grecia. Comunque verso la fine del VII secolo la ricchezza della Ionia poggiava su salde fondamenta. Sue specifiche
aree di influenza erano il Mar Nero e l’Egitto, ma Focea aveva interessi anche in Occidente, ed ovunque essi erano noti per il
loro tenore di vita sontuoso. Ciò non motiva però l’emergere di quello che è stato chiamato illuminismo ionico. A rigor di
termini questo termine è fuorviante, perché al centro dello sviluppo sul piano speculativo fu una città per molti aspetti
anomala: Mileto. Nel corso del VI secolo Mileto combinò la prosperità economica a situazioni interne che rappresentarono i
più gravi conflitti civili del periodo arcaico. Dopo l’espulsione del tiranno iniziarono a concedersi il controllo della città due
partiti: i Ricchi e gli Operai. Sembra che ci sia stato un conflitto tra nuovi gruppi economici formatisi in seno alla città; dopo
varie atrocità commesse, dei pacieri fati venire da Paro aggiudicarono il potere ai proprietari. Il fenomeno più importante da
indagare è l’emergere del pensiero razionale astratto della filosofia e della teoresi scientifica in quella forma cui nemmeno gli
odierni cultori negano il oro riconoscimento. Ad esso sono associati i nomi di tre milesi: Talete, Anassimandro e Anassimene,
che operarono nel primo settantenario del VI secolo. Talete sbalordì i greci prevedendo l’eclissi di sole del 585, e venne
annoverato nel gruppo dei Sette Sapienti. Avrebbe proposto l’unione politica della Ionia, deviando il corso del fiume Halis per
favorire il re Creso, e naturalmente visitato l’Egitto. Venne reputato il fondatore degli studi astronomici e geometrici greci, e a
lui fu attribuita la prima storia cosmologica universale; componente primaria di tutti gli elementi sarebbe l’acqua. L’esigenza
di astrazione implicata nei suoi obbiettivi di sistematizzazione e di semplificazione teoretica, rende la sua teoria classificabile
come filosofica o scientifica. Anassimandro fu invece autore della prima opera greca redatta per iscritto in forma di libro, di
cui i greci avessero cognizione. Fu dunque autore di un libro, di più libri, nonché inventore delle prime carte geografiche
greche del mondo o dei cieli. La sua teoria del mondo fisico cerca di ovviare alle difficoltà messe in luce dalla speculazione di
Talete: opera dalla concezione di Chaos, che è eterno ed in eterno movimento, da cui si sarebbero separati gli opposti, che
avrebbero costituito dei kosmoi (sistemi ordinati). Quando si tratta di spiegare perché il mondo rimane fermo nella sua
posizione, egli ricorre al concetto di simmetria. Anche della sua speculazione rimangono però dei punti oscuri. Anassimene
continuò nell’ambito della stessa tradizione intellettuale: il suo ruolo più rilevante fu quello di aver sostituito l’aria all’acqua
come componente primario dell’universo.
Nel 609 babilonesi e medi si erano spartiti l’impero assiro; nel 559 Ciro salì al trono di Persia. Dieci anni dopo Ciro ordinò alle
città greche della costa di abbandonare Creso, ma esse non lo fecero. Perciò Ciro, dopo avere sedato una rivolta in Lidia,
provvide ad occuparsi di loro. Mileto fu separata dalle altre con inl trattamento di favore che aveva già ricevuto in passato,
mentre i focesi verificarono che le loro nuove mura, fatte costruire dal re Tartesso a sue spese, non rappresentavano alcuna
protezione contro i terrapieni d’assedio persiani: scapparono in Occidente, prima ad Alaia, poi ad Elea in Italia meridionale.
Gli altri ioni discussero se dovevano prendere anch’essi la via dell’esilio, e si formulò così la proposta di andare ad occupare la
Corsica. In realtà emigrarono poi soltanto i Tei, spostandosi verso Nord e stabilendosi ad Abdera. Gli altri ioni vennero
soggiogati dai persiani. Nel 539 fu la rivolta di Babilonia: i sacerdoti della città ascrissero l’insuccesso bellico alla scarsa
ortodossia religiosa del re di Babilonia, Nabonidus, ed espressero il loro entusiastico appoggio al nuovo conquistatore. Ciro
entrò in Babilonia, accolto da una folla festeggiante. Nel 530 egli morì mentre combatteva sulla frontiera nord-orientale contro
i Messageti. Suo figlio Cambise (530-522) conquistò l’Egitto nel 525, dopo un’aspra battaglia contro i mercenari greci. I greci,
nel corso di una generazione, erano divenuti un popolo inquietante che confinava con il più grande impero mai costruito fino
ad allora. Si ritiene che i persiani siano arrivati come popolo primitivo e ancora nomade all’interno di un mondo ove fiorivano
civiltà culturalmente molto progredite: essi si adattarono alle culture con cui vennero a contatto. Il nuovo re, prima di essere
incoronato, doveva sostenere nell’antica capitale Pasargade un rituale che consisteva nell’indossare gli abiti di Ciro il Grande e
nel pranzare con un simbolico cibo da pastori: così facendo, rinnovava la memoria dell’infanzia di Ciro trovatello esiliato ed
allevato da gente del popolo. Il più notevole tratto distintivo dei persiani fu la loro religione. Non mancano indizi di un
precedente stadio politeistico, nel quale primeggiava la divinità Mitra; questi appunti, e gli animali a lui sacri, sono i
protagonisti della leggenda di Ciro, che sarebbe stato allevato da un pastore di nome Mitridate,e da sua moglie Spako. Le
tacce di politeismo non possono che rifletter egli influssi esercitati in varie epoche dalla religione meda sui persiani. Il
problema è complicato dall’incertezza della datazione di Zoroastro, che fondò e sviluppò la religione persiana: potrebbe essere
sia anteriore, si posteriore rispetto alle nostre testimonianze più antiche, costituite dal linguaggio religioso in cui si esprimono
le iscrizioni imperiali del re Dario. Esser rivelano un monoteismo privo ancora di ogni teologia, in cui Ahuramazda è l’unico
dio dei persiani e protegge il loro re dalle violente insidie Lie. È il dualisimo della lotta sulla terra fra Verità e Lie, fra bene e
male, che risulta centrale nel sistema di Zoroastro. Una delle conseguenze che tale assenza di una cultura individuale ebbe per i
persiani, fu che essi cercarono di intervenire il meno possibile sui sistemi culturali che incontrarono sulla loro strada.
Adottarono le pratiche amministrative delle varie zone, governando con la lingua ufficiale ed attraverso funzionari locali. Il re
afferma di ricevere i suoi poteri dal dio, e l’obbedienza, che gli è dovuta quale rappresentante del dio. Dalla conquista persiana
ricavò vantaggio la minoranza etnica degli Ebrei. Per essa i persiani significarono la liberazione dalla cattività in cui vivevano
a Babilonia e, guidati da Zerrubbabel, fondarono un loro stato, guidato da Nehemiah ed Ezra (secondo il mandato divino di
ricostruire e riconquistare Gerusalemme). Non diverso trattamento fu riservato ai greci, ed anche ad un loro dio bisognava
rendere onore: Apollo, quale divinità dedita all’agricoltura. L’interesse dei persiani per l’agricoltura è ben noto. Il vocabolo
paredeison entrò nella lingua greca dal persiano, ove esso designava grandi parchi coltivati e destinati al diporto. Con i suoi
santuari a Branchidae, Delo e Delfi, Apollo era il dio più importante della Grecia. Può darsi che il favore tributatogli dai
persiani contribuisse a convincere Delfi che Apollo da una conquista persiana avrebbe guadagnato non poco, ma tra questa
classe sacerdotale e l’élite politica delle varie città non c’era nessun rapporto stretto. Come fecero altrove, i persiani
installarono direttamente o appoggiarono nella conquista del potere nelle città costiere gli abitanti locali, per cui i greci
continuarono ad usare il termine di tiranni. Alla fine del regno di Cambise, cercò di prendere il potere un usurpatore medo che
affermava di essere figlio di Ciro, ma con l’aiuto dei nobili persiani, salì al potere Dario. Scoppiarono allora varie rivolte.
Dario eternò la sua ascesa al potere nella grande iscrizione trilingue incisa nel dirupo di fronte a Behistun, e sovrastante da
un’altezza di 68 metri la grande strada carovaniera cha va da Baghdad a Teheran, in una posizione in cui solo dio avrebbe
potuto leggerla, e solo il tempo cancellarla. Introno al 520 Dario aveva già riunito l’Impero ed intrapreso una sua
organizzazione talmente estensiva da pervenire alla creazione di un nuovo sistema imperiale. Vennero fissati i confini delle
varie satrapie o province, ed imposti per la prima volta tributi regolari. I persiani iniziarono allora ad attaccare le isole
dell’Egeo ed abbatterono la tirannide di Policrate di Samo, che dopo la caduta di Sardi era riuscito ad organizzare
un’imponente flotta navale. Infine Dario invase l’Europa, marciando attraverso la Tracia e convocando i suoi vassalli della
Ionia perché lo soccorressero con le loro flotte in un attacco contro la Scizia (514). Secondo Erodoto la campagna non fu un
successo, ed anzi il re sarebbe riuscito a salvarsi soltanto grazie alla lealtà della flotta ionica e che avrebbe continuato a tenere
quel ponte sul Danubio che per Dario era l’unica via di fuga. Gli Ioni vennero anche impiegati in gran numero nella
costruzione dei palazzi imperiali di Pasargade, Susa e Persepoli, in quanto se ne riconosceva la perizia nei lavori in pietra. La
presenza di accorgimenti tecnici ionici in vari particolari della scultura persiana mostra che essa non è altro se non un
amalgama dell’abilità pratica greca e dello stile orientale. Gli operai (come mostrano due tavolette della sala del tesoro di
Persepoli del’inizio del V secolo) ricevevano provvigioni di sussistenza o in alternativa dell’argento, ma non una vera e propria
paga: il lavoro per cui erano ingaggiati sembrerebbe quindi una prestazione d’opera forzata. Perduti i mercati d’impiego
mercenari, anche il commercio aveva dovuto subire una brusca battuta d’arresto (dopo la conquista di Egitto, Tracia e Mar
Nero). Nel 499, in occasione di una spedizione contro Nasso, le città greche della costa si ribellarono e deposero i tiranni. A
loro capo era Aristagora, tiranno di Mileto. L’andamento della rivolta ionica viene descritto dettagliatamente da Erodoto. Gli
ioni di Erodoto ammettono la loro debolezza, e molti si vergognano addirittura di essere Ioni, mentre la successiva insistenza
sul fatto che sarebbero stati un popolo privo di temperamento militare ed incline ad una vita agiata, è un mito che si sono creati
loro stessi, un risultato dopo la sconfitta. Nella realtà delle cose la rivolta ionica fu in notevole misura un successo. I rivoltosi
riuscirono a prendere ed a saccheggiare quassi tutte le città della costa asiatica, dall’Ellesponto fino all’Anatolia meridionale, e
si unirono alla ribellione anche le città greche di Cipro e della Caria. Nella Grecia continentale conquistarono l’aiuto di ateniesi
ed eretriesi; ed affiancati da queste due città arrivarono a mettere a ferro e fuoco Sardi nel corso di una violenta scorreria.
Tuttavia i persiani risultarono poi invincibili per terra, e con l’assistenza della flotta fenicia riconquistarono Cipro. La Caria fu
sottomessa con maggior difficoltà e rese necessario l’intervento della flotta fenicia. Il mare era l’unico elemento sul quale gli
Ioni potevano sperare in un successo, e nel quinto anno della rivolta (494), attorno all’isola di Lade appena fuori Mileto, i
rivoltosi raccolsero per la difesa della città 353 triremi. Le navi persiane si ritiene fossero nell’ordine di 600. la battaglia fu
persa dai greci, suscitando un profluvio di tentativi di giustificazione e di recriminazioni. Mileto cadde, ed i suoi abitanti
vennero uccisi o ridotti in schiavitù. I persiani smisero di appoggiarsi ai tiranni per esercitare il loro controllo sulle città e
compresero il pericolo di un mondo greco libero ai confini del loro impero. Gli ioni invece avevano cercato di creare un
comando unificato, che aveva il suo centro in una lega consacrata dalla religione, ed avevano dimostrato una notevole abilità
nell’organizzare e condurre le operazioni congiunte di varie città. Tuttavia, dopo la morte di Anassagora i rivoltosi non furono
più capaci di risolvere il problema della leadership. I Greci del continente impararono da ciò la sicurezza del pericolo costituita
dall’Impero persiano. Una conseguenza a lungo termine della pressione dei persiani dal 546 in poi sarebbe stata la migrazione
sempre più intensa di comunità o singoli individui dalla Ionia verso il Mediterraneo occidentale.
15 L’EGEMONIA SULLA GRECIA: SPARTA E ATENE
Il Vi secolo fu l’epoca dello stato oplitico: numerose città attraversarono la tirannide per emergere poi alla conquista di una
costituzione controllata dalla classe oplitica. Sparta fu al centro di questo processo, con il suo esercito di eguali. L’alleanza di
re e opliti produsse una città aggressiva e protesa all’espansione. Intorno al 600 i Messeni vennero soggiogati e Sparta cercò di
muoversi verso Nord all’interno dell’Arcadia. Mentre erano re Leone e Agesicle (580-569), Sparta consultò l’oracolo di Delfi
riguardo l’Arcadia, che venne loro negata, con la promessa di Tegea; la campagna fu però fallimentare. Durante il governo dei
due re successivi, Anassandrida e Aristone (560-520), prevalse una politica differente. Ancora una volta su consiglio di Delfi,
Sparta rubò a Tagea le ossa che si riteneva appartenessero all’eroe Oreste, figlio di Agamennone, e diede ad esse esequie
funebri a spese dello stato di Sparta. Assolto questo rito, la città riuscì a vincere Tegea. Gli spartani, in realtà, reclamavano per
sé l’egemonia sul Peloponneso che un tempo era appartenuta ad Agamennone, ed avanzarono queste pretese protestando il loro
diritto a un’egemonia sugli achei, e ponendo in secondo piano le loro discendenze doriche. In tale ideologia rientrò anche il
tentativo di impossessarsi della figura di Agamennone, che il poeta Stesicoro fece emigrare da Micene a Sparta. Questa
presuntuosa affermazione, dell’appartenenza achea, sembra dia inizio al passaggio dalla politica spartana dai principi della
conquista e dell’assoggettamento a quello dell’alleanza. La ricerca di una mitica “patente” razziale achea fu soltanto uno degli
aspetti della nuova politica: è in questo periodo che Sparta cominciò ad acquistare una reputazione particolare per la sua
attività nel cacciare i tiranni. Le liste dei tiranni deposti che ci vengono fornite dalle fonti antiche (Plutarco), ignorano ogni
cronologia e sono poco più che tentativi di riempire le lacune della tradizione che riflettono. Rimane comunque il fatto che
durante il VI secolo la tirannide scomparve del tutto dal Peloponneso, per venire rimpiazzata da una serie di stati collegati fra
loro per difendere la loro costituzione oplitica. Argo fu la sola città di una certa grandezza in grado di tenersi al di fuori da
questa alleanza, anche per la sua conflittualità con Sparta. Verso la metà del VI secolo Sparta si era annessa l’isola di Citera e
si spostava nel cuore del territorio di Tirea attraverso la regione di confine nota con il nome di Cinuria: nel 546 ci fu una
battaglia per la conquista di questa pianura, nota con il nome di “battaglia dei campioni” (300 a testa), e che si concluse quando
solo due argivi e uno spartano erano rimasti vivi. Dato che però gli argivi avevano lasciato gli spartani a controllare il campo di
battaglia, entrambe le parti si proclamarono vincitrici e gli spartani finirono per vincere nella battaglia vera e propria che
succedette al duello. Da questo momento Sparta venne riconosciuta come lo stato più forte della Grecia, cominciò a scambiare
doni con i sovrani orientali, e dovette essere consultata dalle varie, antiche potenze del Mediterraneo, minacciate dalla Persia e
preoccupate anche dagli eserciti greci. Ebbe relazioni con Creso re di Lidia e con Amasi faraone d’Egitto, e nella città
arrivarono perfino ambasciatori degli Sciiti. Sparta non riuscì a venire in aiuto di Creso, ma ebbe il coraggio di mandare una
nave nella Ionia ad avvisare Ciro che doveva lasciare stare le città greche (Erodoto). Poco tempo dopo il 525 la città concepì
addirittura il proposito di organizzare una spedizione oltremare con Corinto e deporre il tiranno Policrate di Samo. La
spedizione fallì. I limiti del potere spartano e le tensioni inerenti alla sua società vennero messi in luce durante il regno del più
grande re, Cleomene. La tradizione orale spartana cercò di minimizzarne l’importanza affermando che egli non sarebbe stato
altro se non pressappoco pazzo. Si desiderava dimenticarlo perché aveva infranto in misura troppo rilevante i principio della
uguaglianza ed era arrivato non lontano dall’instaurare una tirannide personale: alla fine si era ridotto addirittura a cercare di
provocare una rivolta degli iloti. L’inizio del suo regno fu contrassegnato da una disputa sulla successione, conclusa la quale il
suo fratellastro Dorieo diresse una spedizione in grande stile per fondare una nuova città fra Cirene e Cartagine in Africa. La
spedizione suscitò grandi attese ed attrasse partecipanti da tuta la Grecia. Si risolse tuttavia in un nulla di fatto ed i coloni
andarono poi a stanziarsi nell’Italia meridionale e in Sicilia, ove furono decimato dai coloni fenici rivali. Tre episodi possono
permettere di seguire lo sviluppo del potere di Cleomene: i rovesciamento della tirannide dei Pisistratidi ad Atene nel 510
(Erodoto); questo altro non fu che un ulteriore gradino ne l processo che li aveva già portati ad ottenere l’egemonia sul
Peloponneso: era ovvio che la lega da loro capeggiata dovesse venire estesa a nord dell’istmo di Corinto, attraverso i vecchi
sistemi dello spodestamento dei tiranni e dell’instaurazione dell’eunomia. Una spedizione che prendeva le mosse dal mare
fallì, e di in seguito a questa Cleomene si risolse ad invadere l’Africa con un grande esercito. I Pisistratidi erano preparati per
un lungo assedio, ma alcuni loro bambini vennero catturati nelle campagne circostanti la città e la famiglia dei tiranni decise
quindi di ritirarsi, grazie ad una tregua, nel Sigeo. Il nuovo governo fu comunque l’opposto dell’eunomia, e la rivoluzione di
Clistene provocò una seconda invasione da parte di Cleomenealla testa di un piccolo contingente (l’invasione venne respinta).
Questo intervento può essere senz’altro il frutto di una decisione privata: più tardi Cleomene raccolse gli eserciti riuniti del
Peloponneso e della Beozia senza consultare i suoi alleati sugli obbiettivi della spedizione. Proprio poco tempo prima della
battaglia, che stava per avere luogo presso Eleusi, i Corinzi se ne andarono, non disposti a combattere i loro alleati di un
tempo, mentre il re collega di Cleomene, Demarato, si dichiarò favorevole alla spedizione che fece così abortire. In seguito a
questo episodio: fu varata una legge in base alla quale soltanto un re avrebbe potuto dirigere una spedizione, ed inoltre sembra
sia stato riconosciuto allora il diritto dei membri della lega di essere consultati prima che le loro forze venissero schierate in
campo. Infatti l’iniziativa successiva di Cleomene fu convocare un congresso nel corso del quale egli configurò un’alleanza
con il tiranno Ippia, proponendone la restaurazione. Ancora una volta i Corinzi posero veto all’intervento, seguiti dalle altre
città. È il primo episodio da cui si può presumere l’organizzazione in Grecia di una forma di lega. La storia dell’intervento
spartano contro Atene attesta il predominio di Cleomene sulla politica spartana, nonché i limiti che ad esso furono imposti e
che trovarono la loro prima manifestazione nel conflitto con il re collega. A Cleomene venne chiesto da Aristagora di
intervenire nella rivolta ionica, ma mentre gli ateniesi accettarono, lui rifiutò: la sua prossima vittima doveva essere Argo. La
campagna contro questa città viene datata solo attraverso un incerto oracolo delfico: tra il 499 e il 494. nella battaglia di
Sepeia, Cleomene riportò una brillante vittoria e rinchiuse un cospicuo contingente di argivi in un recinto sacro ove essi
avevano trovato protezione (vennero poi in parte attratti fuori e uccisi, in parte bruciati vivi con il boschetto). Da tale sconfitta
derivò l’istituzione di un nuovo regime ad Argo: gli schiavi presero il controllo della città per svariati anni fin tanto che non ne
furono cacciati dai figli degli opliti uccisi a Sepeia. Secondo gli argivi la campagna venne contrassegnata da tutta una serie di
sacrilegi commessi da Cleomene; questo dimostra quanto egli fosse spregiudicato e quanto poco si curasse delle convenzioni
belliche. Grazie all’assoluto controllo che aveva sugli opliti riuscì ad avere la meglio anche sui suoi nemici in patria. Separò
infatti l’assemblea degli opliti dal consiglio aristocratico e dagli efori. Questa guerra inoltre rese il Peloponneso una specie di
roccaforte della resistenza greca contro i persiani. Nel 491 arrivarono in Grecia gli inviati persiani del re Dario, chiedevano la
terra e l’acqua, che simboleggiavano la sottomissione. Atene era già in stato di ostilità ed aveva preso parte alla rivolta ionica:
in questa città i messi persiani vennero gettati giù per il burrone. Sorprende che anche gli spartani abbiano reagito con la stessa
decisione ed abbiano gettato i messi dentro un pozzo. Da altre parti, alcune isole e molte città si sottomisero: tra queste Egina.
Atene si lamentò per questa defezione con Sparta quale guida della lega del Peloponneso. Cleomene cercò di imporre la
consegna di ostaggi da parte delle città ma incontrò l’opposizione di Demarato; allora Cleomene fece dichiarare da Leotichida,
un parente di Demarato, che egli era figlio bastardo e corruppe l’oracolo di Delfi in modo tale che confortasse la pretestuosa
dichiarazione egli aveva estorto. Demarato venne allora depostoed al suo posto subentrò Leotichida. L’intrigo di Cleomene
venne però scoperto ed egli dovette scappare da Sparta in Tessaglia e poi di lì in Arcadia, donde cominciò ad organizzare la
riconquista di Sparta. Gli spartani allora lo riammisero ma i parenti dichiararono che era pazzo. Egli prese allora un pugnale ad
una delle guardie e si fece a pezzi con le proprie mani. Seguì a ruota una guerra fra Atene ed Egina, perché gli ateniesi
rifiutarono di restituire gli ostaggi. L’esito della vicenda ha tuttavia l’apparenza di un assassini camuffato. Il carattere di
Cleomene rivela la tensione tra la fede religiosa dei suoi oppositori e la sacrilega noncuranza delle norme convenzionali da
parte del re. All’interno della stessa Sparta si dispiegò il conflitto fra le ambizioni di un generale vittorioso con poteri regali
alla testa delle truppe ed una struttura statuale che per l’addestramento di queste stesse truppe esigeva l’adeguamento di tutti a
determinate regole.
All’epoca dei Pisistrati Atene era ancora uno stato decisamente aristocratico, ed anche dopo l’affermazione della tirannide altre
famiglie continuarono a conservare un potere notevole. La grande ricchezza dei Filaidi è attestata dal fatto che Cimonevinse in
tre Olimpiadi consecutive la corsa di carri, mentre suo fratello Milziade venen invitato dalla tribù dei Dolonchi nel Chersoneso
tracio a istituire per loro una costituzione di governo. Egli formò colà un principato rotante attorno alla sua famiglia: il potere
passò poi ai figli di Cimone, Stesagora e Milziade. Quest’ultimo governò con l’appoggio dei Pisistratidi e stabilì un legame
matrimoniale con la principessa tracia. Ne nacque il Cimone che fondò l’impero ateniese. Megacle, capo degli Alcmeonidi,
aveva collaborato con il partito che portò al potere Pisistrato. Che Milziade sia stato arconte nel 524-523, lo sappiamo con
certezza ed in base a ciò possiamo datare gli altri nomi. Pisistrato morì nel 528-527; nel 526 fu arconte il nuovo tiranno Ippia e
nei due anni successivi ricoprirono la somma magistratura i capi delle famiglie Alcmeonidi e Filiadi. È chiaro che Ippia seguì
una politica di conciliazione con tutte le altre famiglie nobiliari. A un certo punto l’atmosfera cambiò. Venne ammazzato
Cimone, suo figlio Milziade partì per il Chersoneso e Clistene se ne andò in esilio con gli Alcmeonidi. Gli Alcmeonidi e altre
famiglie tentarono di rovesciare la tirannide prendendo le mosse da un fortilizio a Leipsydrion, sul ponte Pernete. I Pisistratidi
vennero spodestati nel 510 con l’aiuto spartano. Venne instaurata la eunomia, ma quando nel 508 Isagora venen eletto arconte
in contrasto con la volontà dell’alcmeonida Clistene, lo stesso Clistene raccolse il popolo in un partito (Erodoto) e propose
nuove riforme di grande entità, cacciando in esilio Isagora e contenendo negli anni successivi le sortite spartane e dei loro
alleati. Con queste azioni Clistene si era guadagnato l’appoggio popolare. Le sue riforme consistettero in una complicata
revisione della struttura tribale ateniese. In luogo delle quattro tribù ioniche, egli stabilì dieci nuove tribù i cui nomi ed i culti
ricevettero l’autorizzazione di Delfi. Ogni tribù comprendeva tre gruppi di demoi, uno della città, uno dell’interno e uno della
costa, e questi gruppi ternari erano chiamati trittyes. La cosiddetta città includeva l’area del Pireo e la pianura centrale tra il
monte Aigaleos e il monte Imetto. Essi fornivano quote diverse ma fisse di membri per il consiglio centrale, ed erano distribuiti
fra le tribù. È chiaro da ciò che i demoi si fondavano sui villaggi preesistenti nelle campagne, anche se all’interno della città
essi rappresentavano suddivisioni probabilmente più artificiali. Le nuove tribù erano alla base dell’organizzazione militare ed
avevano in sede centrale dei ruoli politici che dovettero implicare un’approssimativa uguaglianza numerica di membri. Ai
demoi erano state certamente assegnate le funzioni del governo locale: c’erano assemblee di demoi presiedute da funzionari
detti demarchoi, e responsabili per l’ordine a livello locale, nonché per l’esecuzione delle disposizioni date dal governo
centrale. I demoi erano anche depositari delle liste anagrafiche ufficiali, e dovevano giudicare in prima istanza sui casi
disputati di cittadinanza. L’appartenenza a un demos era ereditaria, ed il nome del demos di provenienza fece parte, da Clistene
in poi, di qualsiasi designazione ufficiale. Questo aspetto della riforma ebbe senz’altro l’obbiettivo di introdurre la democrazia
ad un livello decentrato. Non possiamo dire con certezza se esistesse una lista completa dei cittadini al tempo della costituzione
soloniana. La prima lista di cittadini di cui siamo informati con certezza venne redatta nel breve periodo di governo
aristocratico che seguì la tirannide, e fu finalizzata ad un’operazione politica che privò un largo numero di abitanti della città
del diritto di cittadinanza. Si trattò di un tentativo di escludere dalla cittadinanza stessa tutti coloro che non facessero parte di
una fratria, e che non erano quindi legati ad alcuna famiglia aristocratica. È ipotizzabile che questo grande gruppo abbia poi
appoggiato Clistene nel raggiungimento del potere. Clistene aveva esteso i diritti di cittadinanza rimuovendo la connessione
necessaria fra essi e l’appartenenza ad una fratria: grazie a quest’ultima legge tutti i cittadini ateniesi cominciarono ad avere
accesso anche agli antichi istituiti, sopravvissuti come organizzazioni religiose o centri d’incontro, dopo aver perso le loro
funzioni politiche ed istituzionali. La trittia consisteva in un gruppo di demoi abitualmente, ma non sempre (magari per
indebolire certi demoi o per evitare blocchi territoriali), contigui tra di loro. Riesce problematico il fatto che le trittie
differissero per dimensioni sia territoriali, sia numeriche. La difficoltà insorge quando si considera che la funzione più ovvia
delle trittie avrebbe dovuto essere quella di permettere il coagulo e la redistribuzione dei 139 demoi di diverse dimensioni nei
ranghi di 10 tribù di dimensioni uguali. Inoltre Aristotele afferma che tale distribuzione veniva effettuata per sorteggio: se
l’osservazione è corretta, questa pratica avrebbe comportato variazioni di grandezza dell’ordine del 42% in più o del 32% in
meno rispetto alle dimensioni standard. Può darsi che la creazione delle trittie abbia preceduto la compilazione degli elenchi
cittadini, o che la prassi del sorteggio trovasse limitazioni intese ad assicurare l’uguaglianza delle tribù. Comunque la
differenza fra le dimensioni delle trittie potrebbe suggerire una certa attenzione per i preesistenti raggruppamenti di base
geografica. Le dieci nuove tribù rappresentano l’impalcatura di base del sistema militare e non mancano di avere effetti sulla
stessa riforma clistenica del governo centrale. Il Consiglio soloniano dei 400 venne ricostituito con un organico di 500 membri
e con una più efficiente organizzazione. Le dieci tribù fornivano 50 consiglieri ciascuna, scelti per sorteggio, e rimanevano in
carica a turno per la decima parte di un anno e fra di loro veniva estratto un presidente che esercitava questa carica per
ventiquattrore. All’incirca in questo periodo fu costruito un edificio permanente destinato a ospitare il consiglio e vennero
ristrutturate le circostanti costruzioni di età pisistratica. Clistene pose le basi essenziali del sistema di governo ateniese che
sarebbe rimasto vigente per i due secoli successivi. Il funzionamento efficiente di un’assemblea di massa diretta e non
rappresentativa richiedeva la presenza di un corpo scelto di funzionari che preparassero gli ordini del giorno, dessero
esecuzione alle decisioni prese e sorvegliassero le azioni dei magistrati. Il consiglio clistenico basato sulle nuove tribù, doveva
risultare altrettanto democratico che l’assemblea: l’incarico era dato ad un gruppo di cittadini scelti per sorteggio. L’aspetto più
significativo delle riforme clisteniche è la loro raffinatezza. Erodoto mette in evidenza che Clistene avrebbe derivato l’idea di
mutare le strutture organizzative tribali dall’attività politica del suo nonno materno Clistene di Sicione, ma anche altri
riformatori avevano concepito provvedimenti analoghi, per esempio Demonatte di Cirene. Tuttavia la serie di espedienti volti
ad assicurare che nessuna istituzione di governo centrale potesse cadere nelle mani di un singolo gruppo politico, nonché a
combinare tale governo centrale con una democrazia localmente decentrata, conferisce alla riforma clistenica un carattere
radicalmente diverso da quello che si può ascrivere agli altri esempi. Al concetto di eunomia si contrappone ora quello di
isonomia, cioè di “ordinamento egualitario” (designò originariamente la democrazia = potere del popolo). La coerenza
intellettuale delle riforme di Clistene e la formulazione di questo nuovo ideale politico suggeriscono che egli abbia avuto un
ideale democratico ben cosciente. Appena varate le riforme, non si sente più parlare di lui: può essere morto , oppure caduto in
disgrazia a causa dell’ambasceria che mandò in Persia nel periodo critico in cui Sparta, Calcide e i Beoti invasero l’Attica,
immediatamente dopo le riforme; può essere stato infine sconfessato per avere concesso in passato acqua e fuoco al gran Re.
Intorno al 490 la sua famiglia non godeva di alcun favore popolare. Nel 501/500 venne introdotto un giuramento per i
consiglieri che sta a dimostrare l’importanza ora attribuita al Consiglio stesso. Nello stesso anno venne eletto uno staff di dieci
generali con poteri eguali, le cui funzioni furono inizialmente quelle di consigliare il polemarchos aristocratico. Tuttavia
attorno al 480 erano divenuti essi stessi le supreme autorità militari dello stato (eletti e non estratti).
Il progresso della democrazia fu contrassegnato, nonché affiancato, dal primo attacco persiano del 490. dal punto di vista dei
persiani, dobbiamo alle indagini di Robert Graves se è rimasto qualcosa da riferire. La battaglia di Salamina rimase un singolo
episodio nel corso dell’inesauribile avanzata decisa da Dario contro la Grecia dopo che la rivolta ionica fu definitivamente
domata nel 494. suo nipote e genero Mardonio aveva assunto il controllo delle operazioni militari in Occidente nel 492,
stabilendo varie “democrazie” nella Ionia ed estendendo l’area di potere persiano tutt’attorno alla costa dell’Egeo settentrionale
fino alla Macedonia ed a Taso. Nel 491 arrivò alla Grecia intera la richiesta della concessione di terra e acqua, che venne
accolta dalle isole e da alcune città del continente ma non da Sparta e da Atene. Furono costruiti mezzi di trasporto speciali
trainati da cavalli ed allestita una cospicua flotta che nel 490, guidata dai generali dati ed Artaferne, attraversò le isole
dell’Egeo oltre Nasso e Delo. I persiani sbarcarono nell’Eubea e conquistarono l’isola, mettendo a fero e fuoco Eretria per
punirla del contributo che aveva dato alla conquista e al saccheggio di Sardi e deportandone gli abitanti. I persiani avevano
riportato con sé ad Atene il tiranno Ippia oramai vecchio, ovviamente con l’intento di ripristinarne il potere, e sbarcarono in
quella pianura che era stata l’antica roccaforte dei Pisistratidi, la pianura di Maratona. Gli ateniesi avevano invece come
comandante in capo Milziade: sfuggito davanti all’avanzata persiana nel Nord intorno al 493, subito dopo il suo arrivo ad
Ateneera stato processato ed assolto dall’accusa di ambire alla tirannide. Entrò comunque a far parte del gruppo dei dieci
generali. Gli spartani avevano promesso aiuto, ma quando arrivò da Atene a chiedere il loro aiuto il corridore Filippide (che
compì la prima maratona) essi, come era loro costume, cominciarono a dire che lo scrupolo religioso impediva che si
mettessero in marcia fin tanto che non ci fosse stato il plenilunio. Atene fu così lasciata sola ad affrontar il nemico, affiancata
soltanto da Platea che le mandò i suoi opliti: un atto di lealtà che non sarebbe più stato dimenticato. Molti dettagli di questa
campagna rimangono oscuri, ma sembra che i persiani desiderassero provocare gli ateniesi ad una battaglia campale in pianura.
Permisero infatti loro di conservare il controllo sul sentiero collinare e sulla strada costiera che portavano ad Atene, e lungo i
quali in effetti avrebbe dovuto muoversi qualsiasi esercito. Gli ateniesi presero posizione sulla zona collinare che incombeva
sulla strada e stettero ad aspettare, probabilmente con l’intenzione di attaccare i persiani in marcia. Il ritardo che ne seguì per
entrambe le parti si può spiegare in termini tattici, ma Erodoto parla anche espressamente di una disputa fra i generali ateniesi
sul piano da seguire, e non mancò un forte sospetto che i persiani stessero ad aspettare la collaborazione di alcuni traditori
ateniesi prima di fare le loro mosse. La ragione per cui alla fine gli ateniesi decisero di attaccare rimane incerta. L’ipotesi più
probabile è che i persiani stessero ritardano la loro cavalleria ed una parte delle altre truppe per impiegarle in un tentativo si
spezzare la empasse a cui si era giunti, circumnavigando l’Attica e prendendo Atene per mare: una fonte tarda cita una frase
con cui gli Ioni alleati dei persiani segnalarono agli ateniesi che la cavalleria si allontanava. Per contrastare la superiorità
numerica persiana gli Ateniesi costituirono un centro molto debole e allungarono la linea del loro schieramento; inoltre, per
evitare gli arcieri, avanzarono di corsa. La battaglia si fece cruenta quando i persiani riuscirono sì a sfondare al centro ma
vennero respinti dalle ali dello schieramento greco. Una parte delle truppe persiane s’imbarcò e cercò di arrivare per mare ad
Atene, ma gli ateniesi li precedettero a marce forzate e li misero in fuga anche dalla città. Gli spartani arrivarono giusto in
tempo a contemplare il campo di battaglia. A Maratona si creò una nuova generazione di eroi. I caduti in battaglia vennero
onorati di un sepolcro nel terrapieno che si erge tuttora in pianura, e che originariamente era alto più di dodici metri. In Atene
stessa la vittoria diede alla democrazia una nuova fiducia in sé e accrebbe la sfiducia nei confronti dei suoi leader aristocratici.
Inoltre gli ateniesi sospettavano seriamente che alcuni concittadini avessero cercato di tradire la città a Maratona: si asserì che
uno scudo era stato fato luccicare al sole per fornire un segnale ai persiani. I Pisistratidi rimasti in città furono i primi ad essere
indiziati, ma sospettati furono anche gli Alcmeonidi: il sospetto in sé dimostra che questa famiglia non doveva più godere di
alcun favore intorno al 490. lo stato di insoddisfazione nei confronti dell’aristocrazia si espresse attraverso l’istituzione
dell’ostracismo. Ogni anno, nell’assemblea principale del sesto fra i periodi conciliari dell’anno, al popolo veniva chiesto se
desiderava votare l’ostracismo: in caso affermativo sarebbe stato esercitato nel corso dell’anno. Ogni cittadino aveva il diritto
di scrivere il nome di un cittadino che desiderava allontanare dalla città su di un pezzo di coccio: il candidato era costretto ad
un esilio decennale. Il primo impiego della legge cadde nel 487, ma già gli studiosi antichi dibattevano se la legge fosse stata
approvata in quell’epoca oppure varata da Clistene e poi inutilizzata per un ventennio. Le testimonianze sull’istituto
dell’ostracismo aumentano in continuazione a mano a mano che si ritrovano nell’agorà, sull’acropoli e nel quartiere dei vasai
sempre nuovi ostraka, gettati via dopo l’uso. Una gran quantità di ostraka si può dimostrare risalente all’epoca che precedette il
saccheggio di Atene da parte dei persiani nel 480; alcuni di essi sono stati trovati isolatamente, o privi di un contesto ben
preciso, altri invece son disposti su strati raccolti in singoli depositi uniformi. Vengono rappresentati in essi le figure politiche
di maggiore spicco, ma si dovrebbe ricordare che per l’individuo il quale sosteneva senza essere esiliato parecchi ostracismi, vi
sono maggiori probabilità che sopravviva un maggior numero totale di voti che per uno il quale fosse in effetti stato
ostracizzato una delle prime volte. Ciò spiega il secondo gruppo più grande di ostraka rinvenuto, che fa riferimento a
Temistocle. Costui fu ripetutamente ostracizzato tra il 490 e il 480, ma lo divenne definitivamente solo tra il 480 e il 470. da
uno dei depositi di cui abbiamo parlato è chiaro che non tutti gli ostraka da noi rinvenuti erano stati usati (quorum di 6000). La
documentazione letteraria e quella che ci proviene dagli ostraka possono essere combinate: 487 Ipparco figlio di Charmos,
arconte nel 496/485; 486 Megacle figlio di Ippocrate da Alopeke, nipote di Clistene e capo degli Alcmeonidi; 485 Callia figlio
di Kratias di Alopeke; 484 Santippo figlio di Arrifrone, cognato di Megacle; 483 Aristide figlio di Lisimaco da Alopeke,
arconte nel 489/488, noto come Aristide il giusto. Dopo Aristide non si ricorse più all’ostracismo, e durante la guerra persiana
vennero richiamati in patria gli stessi ostracizzati: Santippo ed Aristide sarebbero addirittura stati eletti generali. Gli agenti che
spiegano più chiaramente questi ostracismi furono la diffidenza verso le famiglie degli Alcmeonidi e dei Pisistrati, nonché le
loro più o meno pretese collusioni con la Persia. Che rapporti del genere dovessero comunque essercene, è dimostrato
dall’esempio di Callixeno, figlio di Aristonimo di Xypete (uno degli ostraka lo definisce come uno degli Alcmeonidi).
L’ostracismo è visto anche come un semplice piacere da parte del popolo nell’esercitare il proprio potere nel colpire
quell’aristocrazia che un tempo lo aveva terrorizzato. Dagli sviluppi di questi anni un singolo uomo politico trasse tanto
vantaggio, che si è vista la sua influenza appunto alla base di essi. Si tratta di Temistocle figlio di Neocle, che era stato arconte
nel 493/492, ed in quell’occasione aveva dimostrato il suo interesse per il futuro navale di Atene, facendo costruire nuovi
arsenali al Pireo. Nel 483 fu scoperto un filone d’argento di notevole ricchezza nelle miniere del Laurio. Non senza
opposizione, Temistocle propose di impiegare il danaro che se ne sarebbe ricavato per costruire una flotta completamente
nuova di triremi (contro Egina e, più ancora, la Persia). Nei tre anni che seguirono vennero armate 200 triremi, che conferirono
ad Atene la flotta più grande di tutta la Grecia.
16 LA GRANDE GUERRA PERSIANA
Dario morì nel 486. suo figlio Serse ebbe bisogno di un po’ di tempo per affermare il proprio potere. Nel 482 Babilonia si
ribellò. Già nel 484 erano iniziati i preparativi per l’invasione della Grecia, che richiesero quattro anni. Per permettere il
transito verso la Grecia, venne scavato un canale che tagliava il promontorio del monte Athos; vennero poi congiunte da un
ponte le rive del fiume Strimone e si provvide ad ammassare nei depositi lungo la costa una grande quantità di provvigioni.
L’avvenimento più spettacolare fu la costruzione di un duplice ponte di barche che attraversò il Bosforo (360 e 314 navi); i due
passatoi erano ormeggiati e resi stabili da funi di corda tutte di un pezzo lunghe un miglio, ciascuna delle quali era in grado di
sopportare il peso di circa cento tonnellate. Singole navi potevano venire rimosse per permettere il passaggio di vascelli di
piccole dimensioni, e ai fianchi del pontile vennero fissate frasche e transenne destinate ad impedire che gli animali si
spaventassero mentre attraversavano. Il primo paio di ponti venne spezzato da un fortunale; la seconda coppia di ponti fu
invece costruita da un ingegnere greco. Nel 481 Serse svernò a Sardi e nella primavera del 480 diede inizio alla sua grande
spedizione.
Il resoconto erodoteo dell’invasione persiana è uno dei più grandi romanzi nella storia della letteratura mondiale. Questo tema
fu per i greci l’avvenimento più importante del loro passato, in quanto rappresentava la vittoria della libertà delle città-stato
contro il dispotismo orientale. La tradizione orale ha conservato per esso una di quelle relazioni dettagliate tipiche di una
guerra vittoriosa. Anche se le versioni ateniesi, spartana e corinzia presentavano diversi punti di vista, nessuna sembra
contraddire le altre e non abbiamo indizi del fatto che Erodoto fosse costretto a distorcere le versioni di queste tre città nel
costituire per la guerra un resoconto corrente. La partecipazione ad esso dei vari singoli stati sarebbe diventata la base dei
rapporti diplomatici fra i Greci per i due secoli successivi. Da questo materiale Erodoto cercò di derivare una storia in cui ci
fosse spazio per autentici eroi: trasse parecchi elementi della sua tecnica narrativa dall’epica, e in più utilizzò tutti gli artifici
stilistici tradizionali dei logographoi ionici. A tali tecniche si fa ricorso specialmente per conferire una coloritura vivida e
immediata agli eventi di parte persiana, sui quali si avevano poche informazioni. Perciò, all’inizio del VII libro, quando il
giovane re Serse prende la decisione di partire alla conquista della Grecia, compaiono al suo fianco due consiglieri, Mardonio,
che lo incalza, ed Artabano, che si oppone alla campagna. Il dio tuttavia manda a Serse un sogno per adescarlo e porlo quindi
in balia del suo destino, e minaccia Artabano mentre questi dorme nel letto di Serse (e si lascia convincere. Nella realtà il suo
ruolo sarebbe stato di Demarato,, il re spartano in esilio, in contrapposizione allo spirito delatorio ed all’amore per il lusso dei
Persiani). È ovvio che un approccio del genere falsifica quelle che furono le autentiche motivazioni di parte persiana per la
guerra. Ugualmente sospettabile è l’analisi della tattica seguita dai persiani. Parrebbe che Erodoto abbia avuto modo di
accedere a documenti persiani. Fu una fonte di questo tipo o il servizio di spionaggio militare dei greci, che gli fornì la
descrizione dei contingenti dell’esercito persiano, ed una stima più approssimativa della loro forza navale egli ebbe inoltre
accesso alla tradizione orale persiana. Una congettura plausibile suggerisce che molte delle sue informazioni derivino da
Zopiro, il nipote di uno dei generali di Dario, che disertò e scappò ad Atene verso la metà del V secolo. L’uso di tali fonti non
trova però certezza assoluta. Erodoto stesso non poté trovare alcun elenco numerico completo delle forze di Serse,
presentandone soltanto una cifra globale derivata da una storia che presenta vari dubbi. Si sarebbe tattato di 1700000 uomini,
inferiore a quanto dice l’epigramma inciso si una stele posta nel campo di battaglia delle Termopili: 3000 spartani un tempo
qui si batterono con 3000000 di persiani. Erodoto poi attribuisce 1207 triremi ai persiani, anche se si pensa fosse il totale delle
forze navali persiane. Si pensa oggi a 200000 soldati per 600 navi.
La difesa della Grecia fu gestita nei limiti in cui poté essere raggiunta una strategia comune: Erodoto non fa che seguire la
tradizione, quando minimizza le difficoltà che si ebbero a costituire il comando unificato. Due congressi dei greci stabilirono i
principi di base dell’azione. Nel primo, che si svolse nel 481, si accordarono per fare cessare tutte le rivalità interne, per
mandare delle spie in Asia e degli ambasciatori alle potenti città di Argo, Siracusa, Corcira e all’isola di Creta, che non si erano
impegnate nel congresso. Si accordarono inoltre di affidare il comando delle forze greche sia di terra, che di mare a Sparta.
Parrebbe si sia giurato in questa sede che sarebbero state distrutte quelle città le quali fossero passate dalla parte del nemico
senza esservi costrette, e che un decimo del bottino sarebbe stato offerto in dono a Delfi. I tentativi di allargare la base della
lega contro la Persia erano destinati a fallire. Consigliata da Delfi, Argo pose per la sua adesione condizioni pesantemente
insostenibili e sembra che avesse già un accordo in corso con la Persia; anche Creta venne dissuasa da Delfi, e Corcira promise
aiuti ma procurò poi con cura di dare in modo che le sue sessanta navi non arrivassero in tempo. Più interessante è il caso di
Siracusa. Fin dal 505 era sorta nella città di Gela una tirannide di notevole potenza, tenuta da Cleandro e da suo fratello
Ippocrate. Introno al 491 l’impero di Gela si era esteso a quasi tutta la Sicilia orientale e Siracusa fu l’unica città che continuò a
tenere duro. Appunto nel 491 ad Ippocrate era successo il suo comandante della cavalleria Gelone, che si legò con un duplice
vincolo matrimoniale a Terone tiranno di Acragante. Nel 485 Gelone intervenne in una lotta civile scoppiata a Siracusa fra
l’aristocrazia originaria ed i loro schiavi indigeni. Gelone si impadronì così di Siracusa, affidando il controllo di Gela al fratello
Ierone. Gelone si dichairò disposto a garantire ai greci della madrepatria un imponente esercito, a patto di essere investito del
comando supremo, temendo la risposta di Cartagine in seguito all’unificazione della Sicilia greca. Amilcare re di Cartagine
invase infatti l’isola nel 480. Nello stesso anno della battaglia di Salamina, Gelone e Terone inflissero ad Amilcare una
sconfitta decisiva sul fiume Imera, lo uccisero e catturarono l’intero corpo di spedizione. Nel 474 Ierone sconfisse anche gli
etruschi a Cuma, ed allora l’Occidente poté dirsi salvo. Gelone avrebbe tuttavia mandato a Delfi una cospicua somma di
denaro, che avrebbe dovuto essere donata a Serse in caso che questi fosse risultato vincitore. In effetti Delfi può essere
considerato in centro di potere orientato in senso filo-persiano. In effetti il suo oracolo consigliò agli ateniesi di migrare in
massa in Occidente. Temistocle convinse però gli ateniesi che la strage di cui parlò l’oracolo fosse riferita ai persiani, e
decisero così di affrontare il campo di battaglia. Il secondo congresso si svolse sull’istmo di Corinto nell’estate del 480 e decise
la strategia della guerra per l’anno che iniziava. L’importanza della cavalleria tessala indusse gli alleati a meditare in un primo
momento di proteggere la Tessaglia, ed una spedizione di 10000 opliti partì per la valle di Tempe. Il passo poteva però essere
aggirato senza troppi problemi, e una rilevante fazione della classe dirigente tessalica era stata a lungo tempo filo-persiana. Si
riunirono così di nuovo all’istmo e qui probabilmente optarono per lo scontro in contemporanea, sia per mare, che per terra,
all’Artemisio e alle Termopili prima, poi sull’istmo e a Salamina. Il passo delle Termopili era difficile da aggirare, e lo si
poteva tenere sotto controllo con facilità anche contro forze numericamente preponderanti, mentre all’Artemisio la flotta
poteva combattere tenendosi alle spalle l’amica isola dell’Eubea con i suoi porti sicuri e le facili possibilità di scampo che essa
offriva. Il nemico sarebbe stato costretto a manovrare con difficoltà o ad arenarsi nella baia esposta all’offensiva da terra.
Sembra che il piano fosse quello di tenere le Termopili e di adottare una tattica più aggressiva per mare. Per i persiani dovette
sembrare ovvio che, una volta cadute le Termopili, la flotta greca sarebbe stata costretta alla ritirata: il suo sforzo iniziale fu
perciò concentrato sulla terraferma. Sul mare lo scontro dell’Artemisio impegnò i greci completamente: 271 triremi. Più
problematico è stabilire le forze di terra. Le cifre presenti in Erodoto ci parlano di 300 spartani, 2120 arcadi e 400 corinzi; in
più 1100 beoti e 1000 focesi. Questo dato numerico dovrebbe essere confrontato con quello delle forze unificate che si
impegnarono nel 479 per la battaglia di Platea: 38700 soldati, quasi tutti Peloponnesiaci. La discrepanza non si può spiegare
solo adducendo l’assenza degli 8000 ateniesi e forse più che combattevano a bordo delle navi. C’era in più una chiara
riluttanza da parte degli stati peloponnesiaci a spingere le loro truppe così lontane nel Nord: molti rimasero indietro a
fortificare l’istmo, e gli spartani mandarono solo una forza avanzata (il grosso dell’esercito sarebbe stato forzatamente
trattenuto in patria dalla festività delle Carneia). Uno di motivi della caduta delle Termopili fu la povertà numerica delle
truppe: si pensi che il sentiero attraverso le montagne che permise l’aggiramento della posizione spartana era affidato alla
custodia dei soli focesi. Il diverso comportamento delle truppe di mare e di quelle di terra suggerisce che l’unità dei greci
venne meno sulle linee geografiche di difesa e le città peloponnesiache non tennero fede all’appoggio promesso alle posizioni
più avanzate. Se così stanno le cose, soltanto l’eroismo di Leonida salvò la causa dell’unità nel momento in cui da parte degli
ateniesi sarebbe stato veramente facile recriminare. Dopo che gli spartani di Leonida avevano affrontato felicemente un attacco
diretto, un traditore greco rivelò ai persiani il segreto del sentiero tra le montagne. Quando il re spartano sentì che la sua
posizione era stata aggirata, congedò gli alleati, rimanendo sul luogo con i suoi 300 uomini e con i Beoti che si rifiutarono di
abbandonarlo: egli rimase per immolarsi a una morte da eroe. Il suo gesto salvo la Grecia. Vi è poi il “decreto di Temistocle”,
un’iscrizione scoperta nel 1959 a Trezene nel Peloponneso orientale, di fronte all’Attica; la lapide è pressoché completa e ben
conservata. Dati e obbiettivi non sono in discussione. È stata incisa per ricordare l’unità ed il coraggio che i greci avevano
dimostrato di fronte all’invasore straniero. Erodoto descrive poi l’azione come realmente ebbe luogo. Quando si vide che i
persiani non avevano intenzione di tentare un altro sbarco a Maratona, divenne possibile inviare tutte le navi all’Artemisio.
Una traccia di un piano originario di divisione delle forze in questi termini può rivelarsi in Erodoto stesso, là dove si menziona
un contingente di 53 navi ateniesi arrivate nell’ultimo giorno della battaglia, rimaste prima a sorvegliare l’Eubea per impedire
l’accerchiamento persiano. La sconfitta subita nella Grecia centrale non fu una rotta: alla flotta persiana vennero inflitti danni
considerevoli e dall’Artemisio in poi la flotta persiana sarebbe rimasta numericamente di poco superiore a quella greca. Si
resero comunque necessarie la perdita della Beozia e l’evacuazione di Atene che fu saccheggiata. Le modalità dell’evacuazione
finale di Atene mettono in luce la scaltrezza di Temistocle: invece di far arretrare i suoi non-combattenti al di là dell’istmo, il
generale ateniese scelse di tenergli fuori dalla portata degli spartani, perché solo così gli ateniesi avrebbero avuto voce in
capitolo e una certa autonomia nell’ambito delle decisioni sulla strategia da tenere. La flotta ateniese comprendeva più di metà
di tutte le navi greche impegnate nella guerra, e tenendola attorno a Salamina Temistocle costrinse il resto della flotta alleata a
combattere lì. Analogamente pare si debba al suo stratagemma di un falso messaggio segreto al Gran Re, se i persiani
desistettero dai loro tentativi di bloccare la flotta greca all’interno della piccola baia di Salamina e rischiarono uno scontro
aperto negli stretti spazi di essa. La vittoria greca risolse la prima parte della guerra. Metà dell’esercito persiano si ritirò
assieme a Serse, mentre l’altra metà svernò nel Nord sotto il comando di Mardonio. I greci avevano ora il controllo del mare, e
l’inverno assistette a vari tentativi persiani, falliti, di staccare gli ateniesi dalla causa degli altri greci. Nel 479 Temistocle riuscì
ad indurre i peloponnesiaci a spingere le loro truppe a nord dell’istmo. Le battaglia di Platea, con le sue complicate manovre,
attesta ancora una volta la riluttanza spartana ad impegnarsi, nonché l’assenza di una ferma corruzione del comando da parte di
Pausania, nipote di Cleomene e reggente per il figlio ancora infante di Leonisa, ma il coraggio degli opliti si Sparta, Tegea ed
Atene prevalse sui persiani. Le perdite greche furono bassissime (159 uomini). Lo stesso giorno i fanti di marina greci
assalirono la costa di Micale, ad est di Samo, ove distrussero la flotta persiana: era così cominciata la liberazione della Ionia.
Numerosi furono i monumenti eretti (es. a Delfi, poi portato da Costantino a Costantinopoli).