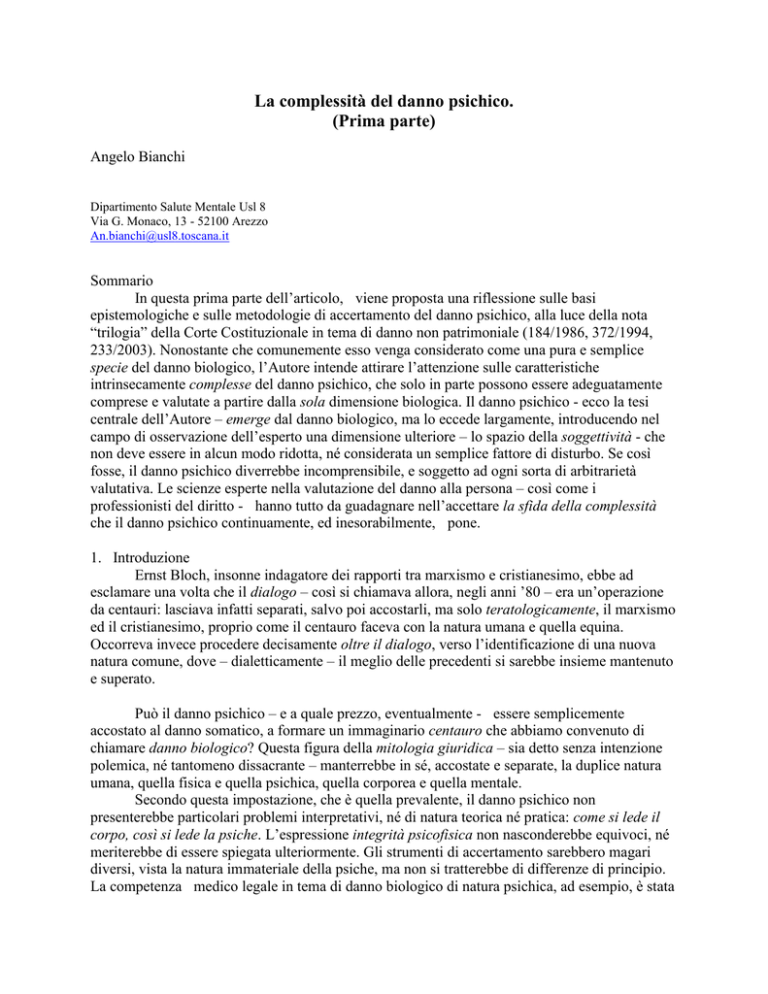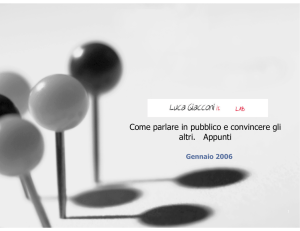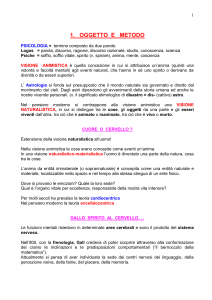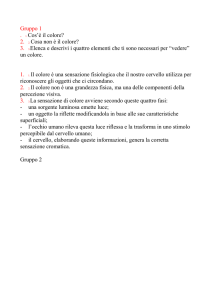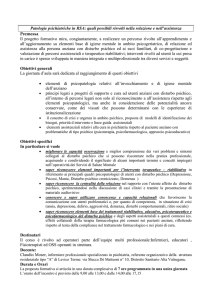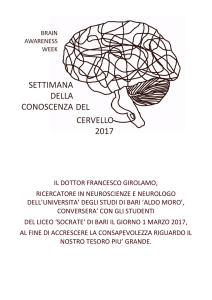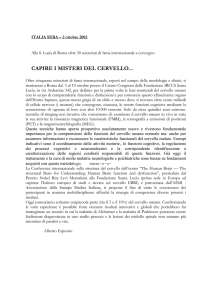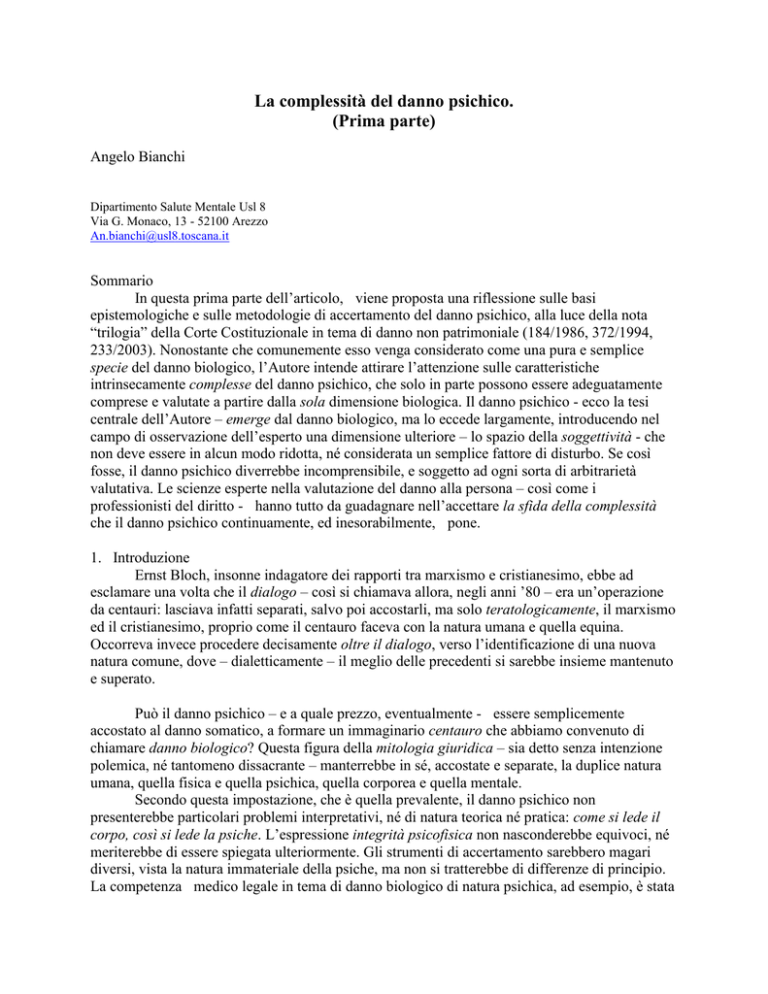
La complessità del danno psichico.
(Prima parte)
Angelo Bianchi
Dipartimento Salute Mentale Usl 8
Via G. Monaco, 13 - 52100 Arezzo
[email protected]
Sommario
In questa prima parte dell’articolo, viene proposta una riflessione sulle basi
epistemologiche e sulle metodologie di accertamento del danno psichico, alla luce della nota
“trilogia” della Corte Costituzionale in tema di danno non patrimoniale (184/1986, 372/1994,
233/2003). Nonostante che comunemente esso venga considerato come una pura e semplice
specie del danno biologico, l’Autore intende attirare l’attenzione sulle caratteristiche
intrinsecamente complesse del danno psichico, che solo in parte possono essere adeguatamente
comprese e valutate a partire dalla sola dimensione biologica. Il danno psichico - ecco la tesi
centrale dell’Autore – emerge dal danno biologico, ma lo eccede largamente, introducendo nel
campo di osservazione dell’esperto una dimensione ulteriore – lo spazio della soggettività - che
non deve essere in alcun modo ridotta, né considerata un semplice fattore di disturbo. Se così
fosse, il danno psichico diverrebbe incomprensibile, e soggetto ad ogni sorta di arbitrarietà
valutativa. Le scienze esperte nella valutazione del danno alla persona – così come i
professionisti del diritto - hanno tutto da guadagnare nell’accettare la sfida della complessità
che il danno psichico continuamente, ed inesorabilmente, pone.
1. Introduzione
Ernst Bloch, insonne indagatore dei rapporti tra marxismo e cristianesimo, ebbe ad
esclamare una volta che il dialogo – così si chiamava allora, negli anni ’80 – era un’operazione
da centauri: lasciava infatti separati, salvo poi accostarli, ma solo teratologicamente, il marxismo
ed il cristianesimo, proprio come il centauro faceva con la natura umana e quella equina.
Occorreva invece procedere decisamente oltre il dialogo, verso l’identificazione di una nuova
natura comune, dove – dialetticamente – il meglio delle precedenti si sarebbe insieme mantenuto
e superato.
Può il danno psichico – e a quale prezzo, eventualmente - essere semplicemente
accostato al danno somatico, a formare un immaginario centauro che abbiamo convenuto di
chiamare danno biologico? Questa figura della mitologia giuridica – sia detto senza intenzione
polemica, né tantomeno dissacrante – manterrebbe in sé, accostate e separate, la duplice natura
umana, quella fisica e quella psichica, quella corporea e quella mentale.
Secondo questa impostazione, che è quella prevalente, il danno psichico non
presenterebbe particolari problemi interpretativi, né di natura teorica né pratica: come si lede il
corpo, così si lede la psiche. L’espressione integrità psicofisica non nasconderebbe equivoci, né
meriterebbe di essere spiegata ulteriormente. Gli strumenti di accertamento sarebbero magari
diversi, vista la natura immateriale della psiche, ma non si tratterebbe di differenze di principio.
La competenza medico legale in tema di danno biologico di natura psichica, ad esempio, è stata
data da tutti per scontata, dal momento che i due tipi di danno – il fisico e lo psichico – non
sarebbero altro che specie distinte appartenenti al comune genere del danno biologico.
A dire il vero qualche perplessità – per non dire riluttanza – l’hanno ben avvertita i più
autorevoli interpreti medicolegali della celebre 184/1986 della Corte Costituzionale, e della
successiva 372/1994, per non parlare della recente 233/2003… Perplessità e riluttanza che a
cascata si sono espresse – ed amplificate – nelle spericolate avventure della metodologia
valutativa del danno psichico. Chi conosce le tabelle, le fasce, le classi, le pesature, i divisori ed
i coefficienti via via proposti nelle varie “guide” alla valutazione del danno biologico di natura
psichica, non può sottrarsi ad un brivido di sgomento…. Lo stesso sgomento che sovente assale
i giudici alle prese con le “forbici” valutative regolarmente a due cifre quando si tratta di danni
psichici diretti od indiretti… Sì, perché la psiche è un sostantivo (ma lo è davvero?) veramente
difficile da integrare nel sapere e nella metodologia medico legale tradizionale, a meno di
arbitrarietà e semplificazioni inaudite, del tutto fuorvianti e prive di fondamenti scientifici.
Eppure, proprio questa riluttanza a parlare della psiche come se fosse un organo
testimonia di una seppur confusa consapevolezza: la consapevolezza che lo “psichico” non è un
oggetto tra gli altri oggetti fisici, ma un altro modo di guardare gli oggetti fisici. Nessuno degli
oggetti fisici – né gli organi né i loro costituenti – possono più essere guardati come semplici
oggetti fisici, se fino in fondo li consideriamo appartenenti ad un soggetto umano concreto, ad un
soggetto animato. Detto in una sola parola, non esiste corpo che non sia intriso di psichismo,
cioè di soggettività. Solo di questo corpo soggettivo si occupano sia il diritto che la medicina che
la psicologia. Gli unici oggetti che possono essere considerati e valutati oggettivamente sono
solo, a rigore, gli oggetti inanimati – quelli dell’anatomia patologica, per intenderci – non gli
oggetti appartenenti ad un organismo vivente. Fingiamo la scomparsa del soggetto cosciente: ciò
che ne resta – il corpo ed il patrimonio – si offrono ad uno sguardo interamente oggettivante,
forse più rigoroso, ma che ha tuttavia irrimediabilmente perduto l’essenziale del fenomeno
osservato. Pian piano si è fatta strada l’evidenza – da sempre sotto gli occhi di tutti, come ogni
evidenza che si rispetti, ma proprio per questo sovente ignorata – che non esiste danno alla salute
che non sia intrinsecamente psichico: la salute è l’integrità della persona vivente, e gli aggettivi
psichico e fisico sono un pleonasmo. Tutta l’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina
degli ultimi venti anni, ma anche anteriore, va letta in questa direzione. E’ stato emozionante
imparare questa lezione dai giudici e dai dottori della legge, invece che dagli scienziati e dai
filosofi!
Il fatto è che quando i giudici costituzionali, a più riprese e con sempre maggiore
intensità, hanno indicato nella vita concreta delle persone (non soltanto nel patrimonio né nel
corpo) il referente ultimo del danno e del suo risarcimento, essi hanno introdotto nel sistema
della responsabilità civile elementi di complessità tali da giustificare – anzi, reclamare a gran
voce – riflessioni epistemologiche preliminari che la sbrigativa assimilazione dello psichico al
biologico non solo non consente, ma impedisce del tutto. Proprio da questa insufficiente
riflessione epistemologica discendono poi, necessariamente, le goffaggini metodologiche che a
loro volta, in un circolo perverso, alimentano lo scetticismo e la diffidenza verso il danno
psichico. La cattiva scienza, si sa, è la migliore alleata della superstizione e del pregiudizio.
Il danno psichico, questa è la mia tesi, non è semplicemente un danno biologico. Il danno
psichico emerge dal biologico, ma lo eccede largamente, nel senso che diventa comprensibile
solo tenendo conto di un’eccedenza di significati che la dimensione biologica, da sola, non è
minimamente in grado di contenere.
La dimensione biologica aiuta a spiegare, ma non basta a comprendere il danno psichico.
2. La riflessione sulla natura dei fenomeni psichici nelle neuroscienze
Occorre ricordare, innanzitutto, che sono proprio le scienze di derivazione biologica che a
gran voce reclamano che i fenomeni psichici cessino, una volta per tutte, di essere considerati
fenomeni senza base biologica, perché questo fraintendimento ha gravemente nuociuto, e nuoce
tuttora, alla comprensione sia dei fenomeni biologici che di quelli psicologici.
Non possono più considerarsi adeguate le rigide contrapposizioni di sapore dualistico,
comprese le più familiari ed usuali, per esempio quella tra fisico e psichico, organico e
funzionale, endogeno ed esogeno, che tanto spazio hanno avuto nel linguaggio scientifico e
giuridico tradizionale. Potranno evidentemente essere ancora accettate ed utilizzate come una
convenzione utile, in attesa di un nuovo linguaggio comune condiviso, ma solo a condizione di
evitarne accuratamente la reificazione. Del resto anche le nomenclature dei disturbi mentali, per
esempio il DSM–IV-TR, hanno già da tempo abbandonato ogni riferimento ai disturbi cosiddetti
organici, proprio per non indurre erroneamente alla convinzione che possano esistere disturbi
mentali senza base organica, cioè senza substrato neurobiologico. Non solo tutti i disturbi
mentali hanno un substrato cerebrale, ma su questo substrato producono effetti.
“Consideriamo per un momento la situazione della psichiatria americana fino al 1968,
quando apparve il DSM–II. A quell’epoca si pensava che i fattori biologici e quelli sociali
agissero su livelli separati della mente: un livello aveva un chiaro correlato empirico,
l’altro restava inspiegato. Come risultato, fino agli anni ’70 le malattie psichiatriche erano
tradizionalmente classificate in due categorie principali: organiche e funzionali. Così, nel
1978, Seltzer e Frazier potevano scrivere: “Sindrome psicorganica è un termine generale
utilizzato per descrivere quelle condizioni di alterato funzionamento del sistema nervoso
che si manifestano attraverso sintomi psichiatrici, a differenza della maggioranza delle
sindromi psichiatriche che sono chiamate funzionali”. (…)
Questa distinzione, oggi chiaramente sorpassata, non deve essere più utilizzata. (…) Oggi
noi dobbiamo domandarci: come i processi biologici cerebrali danno origine ai fenomeni
mentali, e come d’altra parte i fattori mentali e sociali modificano la struttura cerebrale?
Nel tentativo di comprendere una particolare malattia mentale, è più appropriato
domandarsi: in quale misura questo processo biologico è determinato da fattori genetici?
Quanto da fattori legati allo sviluppo? Quanto da fattori ambientali o sociali attuali?
Anche i disturbi mentali che sono considerati maggiormente influenzati da fattori
ambientali devono avere una componente biologica, poiché è comunque l’attività
cerebrale ad essere modificata”.
L’unificazione degli approcci d’indagine ai fenomeni psichici non avviene nella direzione di
un ritorno verso improbabili concezioni olistiche di sapore vitalistico e neoromantico – non nella
direzione del cuore – quanto piuttosto verso l’apertura di campi d’indagine finora inediti, come
le neuroscienze cognitive, emozionali e sociali.
Queste discipline combinano insieme l’approccio neurobiologico proprio di tutte le
neuroscienze all’utilizzo di metodi sofisticati di neuroimmagine funzionale in vivo (PET,
SPECT, RM funzionale). Questi metodi hanno permesso, per la prima volta, di correlare
direttamente fenomeni mentali come la percezione o l’immaginazione al loro substrato neurale.
Si mette un soggetto sotto la RM funzionale e gli si chiede di immaginare il proprio cane mentre
se ne registra l’attività cerebrale, di solito l’emodinamica od il metabolismo locale; poi gli si
mostra la foto del suo cane, e si confronta la differenza tra immaginare e percepire visivamente.
Si ottengono così le immagini che anche il grande pubblico ha ormai avuto la possibilità di
vedere: un cervello con piccole macchie di colore che corrispondono per esempio all’atto di
alzare un braccio, o di ricordare la propria casa natale, o di contare, ecc. In questo modo, si
comprende bene che la distanza tra coloro che si occupano della “psiche” e coloro che si
occupano del cervello si riduce fino a scomparire pressoché del tutto. Lo studio delle funzioni
cognitive – campo d’indagine favorito dalla neuropsicologia classica – ha compiuto enormi
progressi grazie a queste metodiche, ed altrettanto sta accadendo per quanto riguarda il substrato
neurale dei processi emozionali e sociali. Quest’ultimo tipo di studi – peraltro in fase ancora
iniziale – sta gradualmente illuminando aspetti del funzionamento psichico che fino a pochi anni
sarebbero stati ritenuti estranei all’indagine neurobiologica, come i sentimenti privati e le
emozioni sociali.
Proprio questi avanzamenti scientifici hanno riproposto, in una forma del tutto nuova rispetto
al passato, il problema circa la natura dei fenomeni psichici.
3. L’errore di Cartesio
Per molto tempo si è parlato della psiche – o della mente, praticamente un sinonimo – come
se fosse un oggetto accanto al corpo, magari un oggetto fatto di una diversa sostanza –
immateriale, imponderabile –, ma comunque un altro oggetto. Questa visione, direttamente
ereditata dal dualismo filosofico di impronta cartesiana, è tuttora largamente presente nelle
espressioni psicofisico, psicosomatico, ecc. Anche il linguaggio giuridico, ovviamente, non ne è
immune. Quando si dice che il danno psichico è una specie del danno biologico, accanto al
danno biologico di natura fisica o somatica, implicitamente si avvalora questa visione dualistica.
Dal punto di vista scientifico, il dualismo mente–corpo non ha alcuna ragion d’essere:
Cartesio ha certamente commesso un errore, come incisivamente sostiene uno dei più brillanti
neurobiologi contemporanei: un errore non solo comprensibile vista l’epoca, ma perfino
utilissimo allo sviluppo delle scienze successive, avendo reso possibile un’indagine dei fenomeni
naturali del tutto libera da pregiudizi e da preoccupazioni spiritualistiche. Si pensi alla nascita
dell’anatomia, che proprio a partire dal ‘600 conosce un tumultuoso sviluppo. In fondo, solo di
res extensa si trattava, priva di spirito, e come tale poteva essere tranquillamente sezionata,
manipolata ed utilizzata. La psiche – res cogitans – non sarebbe mai stata neppure sfiorata dal
bisturi…
Tutti noi sappiamo, ormai da circa un secolo, che le cose non stanno così: la psiche – o la
mente che dir si voglia – è il prodotto di un organo materiale – il cervello – fatto della stessa
sostanza di tutti gli altri organi del corpo. Quando il cervello è leso, anche la psiche è lesa.
Sebbene qualcuno ancora sembri ignorarlo,
“tutti i processi mentali, anche i più complessi processi psicologici, derivano da
operazioni del cervello.”
Sappiamo tutti che è così, tanto numerose e robuste sono le evidenze scientifiche a
supporto. Quello che ancora non sappiamo bene è come il cervello dia origine ai vari processi
mentali, specialmente a quelli di livello più complesso, che a prima vista appaiono resistere ad
una spiegazione in termini neurobiologici. Mentre infatti quasi nessuno avrebbe qualcosa da
obiettare all’evidenza che il movimento sia controllato dal cervello, molto più difficile da
ammettere è che anche gli aspetti più intimi e personali del nostro mondo interiore, come pure le
forme più complesse di comportamento sociale, dipendano, in ultima analisi, da neuroni e da
sinapsi. Tutto questo suona a molti come un’insopportabile professione di materialismo, che
nega alla radice quanto di più nobile la tradizione occidentale, religiosa e filosofica, ci ha
tramandato: l’unicità e la sacralità della persona umana, considerata nella sua irripetibile
individualità. A molti sembra che far derivare la psiche dal cervello equivalga ad impoverire la
soggettività umana, in qualche modo a negarla. Per questo ritengono che il pensiero
neurobiologico sia socialmente ed eticamente pericoloso, qualcosa di simile ad una ideologia
perversa.
In effetti, bisogna riconoscere che alcune forme radicali del pensiero neurobiologico
mostrano di non aver minimamente compreso che la derivazione della mente dal substrato
cerebrale non equivale affatto ad una semplicistica riduzione del mentale al cerebrale, dello
psichico al biologico. Alcuni neuroscienziati, infiammati di ardore, si sono recentemente lanciati
nell’impresa di trovare i correlati neurali della coscienza (NCC: neural correlates of
consciousness), l’ultimo baluardo della soggettività, che verrebbe così ad essere interamente
spiegata in termini naturalistici. Questa è in effetti l’essenza del programma riduzionistico di una
certa parte delle neuroscienze contemporanee: l’integrale “naturalizzazione” di ciò che da
millenni il pensiero occidentale avrebbe erroneamente considerato come ontologicamente
irriducibile. Di errore in errore: dopo l’errore dualista, ecco avanzare – tracotante e rumoroso –
l’errore opposto. I sentimenti, i valori etici, estetici e perfino religiosi? Nient’altro che neuroni,
sinapsi e neurotrasmettitori.
Le cose, ancora una volta, sono molto più complesse.
4. Psichico e biologico: un rapporto complesso
Il problema della psiche è malposto ed irrisolvibile in una prospettiva riduzionista,
semplicemente perché la psiche non è “nel” cervello, non è “dentro” la testa. Il cervello ne è
ovviamente la condizione di possibilità (enabling condition), ed in quanto tale riveste un ruolo
assolutamente centrale, per certi versi egemonico: niente cervello, niente psiche. Tuttavia, la
soggettività non è in nessun modo riducibile ad una funzione neuronale. Non appartiene cioè allo
stesso ordine di realtà degli oggetti naturali, empiricamente dati.
Ma come: avevamo appena detto basta con i dualismi, ed ecco di nuovo rientrare dalla
finestra una res cogitans rivisitata? Non necessariamente.
La psiche emerge dal substrato cerebrale nel corso dell’interazione tra l’organismo ed il suo
ambiente. Essa non sarebbe mai apparsa nella storia evolutiva, né apparirebbe nella singola storia
individuale, se non in relazione ad almeno tre cicli permanenti di attività:
in primo luogo, in relazione al corpo nella sua interezza. Troppo spesso si dimentica – come
fanno alcuni neuroscienziati – che il cervello non si dà isolatamente, ma solo all’interno di un
organismo vivente essenzialmente impegnato nella propria autoregolazione, conservazione
ed accrescimento vitale. Tutta la vita psichica avviene sullo sfondo, anzi è immersa nel flusso
di questa continua, incessante attività fisiologica. Basta ammalarsi, basta sentire dolore per
diventare bruscamente consapevoli di questa insopprimibile relazione. Per un aspetto
essenziale, quindi, la psiche rappresenta il più sofisticato dei meccanismi di regolazione
omeostatica, anche se questa espressione – introdotta da Bernard e poi da Cannon –
andrebbe più correttamente intesa come omeodinamica, ad indicare la continua ed attiva
ricerca di nuove risposte adattive, piuttosto che la semplice conservazione dell’equilibrio e
della costanza. Sembrerebbe anzi che proprio la capacità di perdere, di abbandonare equilibri
troppo angusti – esplorando e modificando attivamente l’ambiente – sia alla base dello
straordinario successo evolutivo della specie umana.
“Qual è il vantaggio – si chiede uno dei più brillanti neurobiologi contemporanei – di
considerare la mente nella prospettiva del corpo, invece che in quella del solo cervello? Il
vantaggio è che così facendo perveniamo ad una spiegazione razionale della mente che
non otterremmo se la considerassimo unicamente in relazione al cervello. La mente esiste
per il corpo: è impegnata nel raccontare la storia dei molteplici eventi che interessano il
corpo, e si serve di quella storia per ottimizzare la vita dell’organismo nel suo complesso.
Sebbene io detesti le frasi che richiedono un’analisi laboriosa, qui sono tentato di offrirne
una come sommario delle mie idee: la mente del cervello – alimentata dal corpo e al
corpo attenta – è utile al corpo nel suo complesso”.
In secondo luogo, la psiche è in relazione con l’ambiente esterno, nell’interazione continua
che si realizza attraverso l’interfaccia sensoriale e motoria. Percezione ed azione – come la
buona psicologia (Piaget) e, più recentemente, la buona neuroscienza hanno mostrato –
costituiscono un’unità inseparabile nel processo di costruzione del mondo. Nulla di passivo,
di meramente recettivo, nel processo di costruzione della realtà: ogni rappresentazione
mentale – qualunque ne sia la natura: immagini, simboli linguistici, sentimenti – non è
soltanto “là fuori” né “dentro” un circuito neuronale, ma nel ciclo, nell’interazione tra
organismo e mondo esterno. Le ricerche pionieristiche degli psicologi della Gestalt, e più
recentemente i lavori di Hubel e Wiesel sulle basi neurali della visione, avevano già chiarito
in modo inconfutabile questo aspetto intrinsecamente costruttivo dei processi percettivi, ed
altrettanto sta accadendo per tutti gli altri processi cognitivi, in particolare la memoria.
Infine, la psiche è in relazione con gli altri membri della specie, a partire dalle primissime – e
fondamentali – forme di socialità, e poi lungo tutto il corso dell’esistenza. Inizialmente
mediata dalla comunicazione emozionale e dallo scambio degli affetti regolati su base innata,
poi via via arricchita da apprendimenti linguistici e comportamentali sempre più complessi,
la socialità umana – la cultura – ha consentito alla nostra specie di evolvere in modo
spettacolare, molto al di là di quanto consentito dalla sola evoluzione biologica.
“Detto in termini semplici – riassume Eric Kandel – la regolazione
dell’espressione genetica da parte dei fattori sociali rende tutte le funzioni
somatiche, incluse tutte le funzioni cerebrali, suscettibili di influenza ambientale.
Queste influenze sociali saranno biologicamente incorporate nell’alterata
espressione di specifici geni in specifici neuroni di specifiche regioni cerebrali.
Queste alterazioni influenzate dall’ambiente sociale sono trasmesse culturalmente.
Non sono incorporate negli spermatozoi né negli ovociti, e pertanto non sono
trasmissibili per via ereditaria. Negli esseri umani la modificabilità
dell’espressione genetica attraverso l’apprendimento (in una modalità non
trasmissibile) è particolarmente efficace ed ha condotto ad un nuovo tipo di
evoluzione: l’evoluzione culturale. La capacità di apprendimento è così sviluppata
nell’uomo che la specie umana si modifica molto più grazie all’evoluzione
culturale che a quella biologica. Misurazioni dei crani fossili suggeriscono che la
dimensione del cervello umano non è mutata dall’apparizione dell’Homo sapiens,
circa 50.000 anni fa; eppure, la cultura umana si è evoluta in modo spettacolare
nello stesso periodo”.
Proprio quest’ultimo aspetto non viene adeguatamente compreso nella prospettiva
riduzionistica di una parte delle neuroscienze contemporanee, che immagina la psiche come un
semplice prodotto del cervello. In realtà, perché si abbia una mente non basta il solo cervello,
occorre un cervello plasmato dalle continue interazioni con il corpo, con l’ambiente naturale e
con l’ambiente sociale nel quale si trova immerso, dalla nascita alla morte.
Il modo con il quale il cervello è capace di “incorporare” tutte queste influenze esterne è
chiamato, dai neurobiologi, plasticità: significa che tutte le influenze ambientali saranno in grado
di “alterare l’espressione di specifici geni in specifici neuroni di specifiche regioni cerebrali”,
dando luogo a nuove ed inedite modalità di risposta individuale. Questa è la base neurobiologica
dell’unicità di ciascuno di noi: il fatto che tutta la storia individuale, dalla nascita alla morte, lasci
un segno, si imprima e modifichi in modo assolutamente unico l’espressione genetica di quel
tessuto “speciale” che è il tessuto cerebrale, l’unico dei tessuti biologici a possedere questa
capacità di lasciarsi modificare dall’esperienza, di apprendere dall’esperienza. Plasticità
neuronale ed apprendimento sociale, allora, sono due facce della stessa medaglia, sono lo stesso
fenomeno visto da due angolature diverse.
“Tutto l’ambiente (nurture) – conclude incisivamente Eric Kandel – è alla fine
espresso come natura (nature)”.
Aver compreso in termini scientificamente rigorosi il fondamento dell’unicità
dell’individuo, averne indicato nella plasticità neuronale la condizione di possibilità: tutto questo
– contro ogni dualismo sostanziale – equivale forse a svalutare la soggettività umana?
Certamente no. Dal nostro punto di vista, semmai, rende ancor più meritevole di rispetto la
dimensione biologica da cui la soggettività emerge.
D’altra parte – questa volta contro ogni riduzionismo biologistico – aver riconosciuto il
substrato neurobiologico dei fenomeni psichici significa forse proclamare la fine di ogni discorso
scientificamente sensato che pretenda di mantenere l’autonomia e la specificità dei processi
mentali? Ancora una volta, io credo di no.
Non soltanto un discorso scientifico sensato sui fenomeni psichici come tali, cioè non
ridotti ai loro correlati neurali, è possibile, ma è assolutamente necessario al procedere stesso
della conoscenza scientifica. Quello che il riduzionismo impedisce di comprendere, infatti, è
proprio la natura intrinsecamente circolare della relazione tra livello neurobiologico, livello
psichico e livello sociale: una volta emersi dal loro substrato biologico, i fenomeni psichici
esercitano a loro volta un’influenza sul livello biologico, modificandone sia la funzionalità che
la struttura. Questo è vero per tutti i tipi di apprendimento, compresi gli apprendimenti
disfunzionali. Se è vero che tutti – proprio tutti, senza alcuna eccezione – i disturbi mentali sono
disturbi cerebrali, questo non significa affatto che la direzione della causalità vada unicamente
dal livello cerebrale al livello mentale: esistono disturbi – e ne conosciamo molti esempi – in cui
fenomeni di natura psichica vanno ad incidere, modificandolo profondamente ed a volte
irreversibilmente, sul relativo substrato neurobiologico.
La causalità mentale non è un fenomeno misterioso, esoterico, estraneo alla scienza: al
contrario, segue leggi e regole molto precise, ed in buona parte note: il fatto è che i fenomeni
psichici sono – al pari dell’organo che li rende possibili – unici in natura, e pertanto richiedono
uno sforzo conoscitivo assolutamente inedito rispetto ad altri oggetti del sapere scientifico. In
questo senso, le scienze che si occupano dei fenomeni psichici hanno molto in comune con le
scienze giuridiche, nella loro quotidiana frequentazione dell’unicità retta da leggi. Le scienze dei
fenomeni singolari non sono insensate, sono solamente più complesse, e richiedono metodologie
a volte molto più sofisticate, di complessità almeno pari a quella dell’oggetto indagato.
Metodologie complesse che purtroppo la pura e semplice riduzione del danno psichico a specie
del danno biologico non ha consentito, almeno finora, di sviluppare, se non in minima parte.
5. Lo psichico emerge dal biologico
Il concetto di emergenza – a cui si fa riferimento quando si dice che la psiche emerge non
dal solo cervello, ma dall’interazione tra l’intero organismo ed il suo ambiente naturale e sociale
– merita di essere brevemente approfondito.
Si tratta di un concetto derivato dalla fisica, dove è stato introdotto per render ragione dei
bruschi passaggi o transizioni di stato, da un livello locale ad un livello globale. Nell’atmosfera,
per esempio, ci sono innumerevoli particelle di aria e di acqua, che improvvisamente – in
determinate condizioni – diventano un tornado. Il tornado come tale è uno strano oggetto, che
non ha consistenza propria, esiste soltanto nella relazione tra le sue componenti molecolari;
nondimeno esiste, come dimostrato dal fatto che distrugge tutto ciò che incontra, dagli effetti che
produce. La nozione di emergenza, che rappresenta oramai un paradigma unificante per tutte le
scienze – dalla fisica alla sociologia – suggerisce che ci sono in natura processi retti da regole
locali che, messi in condizioni appropriate, danno luogo a fenomeni di maggior complessità,
dotati di caratteristiche e di identità propria. Gli atomi possono diventare molecole, gli insiemi di
molecole possono diventare cellule, gli insiemi di cellule organismi, gli organismi gruppi sociali
e così via. Ogni nuovo livello di organizzazione emerge dal precedente, ed una volta emerso è in
grado a sua volta di influenzare i livelli locali, in un processo di causalità per così dire
“discendente”, dal più complesso al più semplice.
Il valore euristico del concetto di emergenza – assolutamente centrale nel pensiero
scientifico contemporaneo – consiste nella possibilità di pensare la causalità mentale in termini
completamente nuovi, finalmente affrancati dal tradizionale dualismo prescientifico. Una volta
emersi dal loro substrato neurale – nella continua interazione tra l’organismo, il mondo e gli altri
– i fenomeni mentali esercitano un’azione causale sulle loro componenti locali, cioè sugli stati di
connessione sinaptica e perfino sull’architettura strutturale dei circuiti neuronali coinvolti. Il
fatto che ci sia un continuo va–e–vieni, intrinsecamente circolare, tra il livello mentale ed il
substrato cerebrale che ne rende possibile l’emergenza permette finalmente di concepire il ruolo
della mente nella natura in maniera radicalmente diversa dalle tradizionali contrapposizioni
dualistiche, che non portano da nessuna parte.
“Perché mai abbiamo bisogno di un livello mentale delle operazioni cerebrali, e
non possiamo farci bastare il semplice livello delle mappe neurali attualmente
descritto grazie agli strumenti delle neuroscienze? Perché il livello delle mappe
neurali, con le sue attività né mentali né coscienti, dovrebbe rivelarsi meno
efficiente di quello della mente cosciente ai fini della gestione del processo vitale?
In termini ancor più chiari, in armonia con la mia linea di pensiero: perché
dobbiamo invocare il livello neurobiologico che include anche ciò che chiamiamo
mente e coscienza? (…)
La risposta potrebbe essere questa: le immagini mentali consentirebbero una
facilità di manipolazione dell’informazione che il livello delle mappe neurali non
permetterebbe. (…) Occorre ora considerare quale sia il contributo al processo
offerto dal senso del sé. La risposta è: un orientamento. Il senso del sé introduce,
nel livello di elaborazione mentale, la seguente idea, e cioè che tutte le attività
correnti rappresentate nel cervello e nella mente siano attinenti ad un singolo
organismo le cui esigenze di autoconservazione sono la causa fondamentale
della maggior parte degli eventi in corso di rappresentazione. Il senso di sé, allora,
orienta il processo di pianificazione mentale verso la soddisfazione di quelle
esigenze”.
Passando in rassegna le evidenze a favore di una visione unificata dei disturbi mentali e
del loro trattamento, un altro autorevole interprete osserva:
“La crescente consapevolezza che il cervello possiede più plasticità di ogni altro
organo del corpo ci permette di concettualizzare una prospettiva della mente che
riflette la natura dinamica dell’interazione tra geni ed ambiente. (…)
Mentre noi sappiamo che mente e cervello sono inseparabili, la nostra letteratura e
la nostra pratica non sempre riflettono ciò. (…)
I fenomeni mentali emergono dal cervello, ma l’esperienza soggettiva a sua volta
influenza il cervello.
L’ironia della nostra resistenza ad integrare mente e cervello è che oggi noi siamo
sulla soglia di una comprensione sofisticata dell’interazione tra cervello ed
ambiente”.
La complessità del danno psichico.
(Seconda parte)
Sommario
In questa seconda parte dell’articolo, la dimensione complessa del danno psichico viene
esaminata facendo riferimento alle risposte dell’organismo umano al trauma ed allo stress,
eventi costantemente presenti – al di là della fattispecie materiale – nelle casistiche relative al
danno alla persona. Il trauma psichico non è assimilabile ad un semplice trauma fisico, dal
momento che le reazioni emozionali umane, come pure i contesti sociali di appartenenza,
giocano un ruolo determinante ed attivo nell’elaborazione e nella costruzione del significato
dell’evento stesso. Non soltanto la soggettività della vittima, sia anteriore che successiva
all’evento traumatico, ma l’intera rete dei rapporti e delle relazioni sociali sono all’opera nel
modellare ciò che si è convenuto di chiamare danno psichico. Anche gli stessi professionisti –
avvocati e consulenti delle parti in primo luogo – possono giocare un ruolo tutt’altro che
marginale nella costruzione sociale del danno psichico.
1. Cosa accade dopo un evento traumatico?
Vediamo ora come questa visione complessa del rapporto tra biologico e psichico si
applica alla valutazione delle conseguenze di un evento traumatico o stressante, che è poi il
punto di partenza del discorso in tema di danno psichico.
Comunque lo si voglia concettualizzare, infatti, il danno psichico ha a che fare con eventi
in grado di arrecare un pregiudizio – temporaneo o permanente – al benessere soggettivo, alla
salute, o comunque alla realizzazione personale della vittima.
Tutto comincia di solito con un evento singolo, che viene spesso ad assumere il valore di
una vera e propria “pietra miliare” nella biografia personale, qualcosa che ha in qualche modo
“interrotto”, “spezzato”, “alterato” la vita rispetto al prima. Questo tipo di eventi è descritto nella
letteratura scientifica come trauma: qualcosa che lede e ferisce. Fra i traumi, alcuni sono
considerati, per la loro natura intrinseca, estremi: qualcosa che si situa al limite – o al di là del
limite – della comune esperienza umana.
Altre volte, invece, può trattarsi di eventi – singoli o tra loro concatenati, spesso per
lunghi periodi – che hanno disturbato, infastidito, creato disagio o preoccupazione. Questo tipo
di eventi è chiamato solitamente stressante: qualcosa che interferisce, che squilibra, che pesa o
che preme (da to strain: sollecitare, sottoporre a sforzo).
Teniamo presente fin da ora che nel linguaggio scientifico ha da poco fatto il suo ingresso
anche il termine resilienza (resilience), ad indicare il processo di ripristino dell’equilibrio
antecedente. A differenza dei materiali rigidi, come i metalli, che una volta deformati restano
tali, i materiali resilienti, come la gomma, tendono a riprendere la forma originaria, seppur
lentamente. Concettualizzare la patologia post-traumatica come un difetto di resilienza – invece
che come la semplice risultante dell’impatto del trauma – può essere di grande aiuto nel
comprendere meglio la complessità dei meccanismi coinvolti. Si tratta di un campo di ricerca
relativamente recente, ma estremamente importante, al quale dedicheremo in seguito alcune
riflessioni.
L’impatto degli eventi traumatici o stressanti è mediato da sistemi più o meno complessi
in grado di riconoscere, assegnare un valore e rispondere in modo selettivo a ciò che accade nel
mondo là fuori, soprattutto se si tratta di qualcosa che minaccia l’integrità o la stessa
sopravvivenza. In situazioni di pericolo, come tutti sanno, il sistema emozionale assume un ruolo
predominante nel controllo sia della vita psichica che del comportamento, svelando la
fondamentale natura protettiva della totalità dei processi mentali, nessuno escluso. La funzione
principale del sistema emozionale risulta proprio quella di marcare in modo selettivo quegli
eventi e situazioni ai quali è associato un alto valore in termini di sopravvivenza, sia nel senso
della promozione che della minaccia.
Gli organismi più semplici dispongono di sistemi in grado di riconoscere poche classi di
stimoli – quelli strettamente necessari alla sopravvivenza -, di assegnare valori altamente
stereotipati – del tipo utile/dannoso -, ed infine di emettere risposte altrettanto stereotipate – del
tipo avvicinamento/evitamento. La nostra specie dispone di sistemi di riconoscimento altamente
complessi e sofisticati, ma soprattutto dispone della capacità di rappresentare coscientemente
(attraverso immagini mentali ed equivalenti simbolici di vario tipo) una buona parte di questi
processi, che nel mondo animale avvengono per lo più senza alcun intervento della coscienza.
Avere coscienza di ciò che percepiamo, ricordiamo, pensiamo o sentiamo significa avere molti
vantaggi in termini evolutivi, ma comporta anche una più grande vulnerabilità al trauma
emozionale, in tutte le sue molteplici forme.
Da secoli i filosofi ed i poeti avevano insegnato ciò che ognuno di noi deve prima o poi
imparare, che la coscienza comporta sofferenza e dolore. Oggi, anche la scienza mette a nostra
disposizione conoscenze approfondite e sofisticate circa i meccanismi, non solo fenomenologici
ma anche neurobiologici, attraverso i quali gli esseri umani rispondono e sopravvivono ai traumi
emozionali, anche ai più catastrofici, e quali prezzi devono pagare – in termini di sofferenza e di
veri e propri disturbi mentali.
Queste conoscenze sono particolarmente necessarie per coloro che, in àmbito forense,
devono stabilire non solo l’esistenza di una condizione morbosa – l’effetto – ma anche la
relazione con un evento che si ipotizza esserne la causa. Man mano che ci si allontana dalla
causalità lineare di tipo fisico, e ci si incammina lungo i sentieri tortuosi della causalità mentale,
si rischia di smarrire la necessaria lucidità. La causalità – per quanto complessa – resta
comunque un punto di riferimento irrinunciabile, pena lo scadere del ragionamento scientifico a
semplice chiacchiera od opinione in libertà.
2. Le risposte biologiche al trauma e allo stress
1. Quando siamo esposti ad un evento minaccioso per la nostra integrità - o per l'integrità di
qualcuno dei nostri cari - il nostro cervello reagisce in primo luogo con una risposta
immediata di tipo protettivo, sostenuta da importanti modificazioni - sia somatiche che
psicologiche che comportamentali. La finalità di tutte queste modificazioni è comunque
quella di sopravvivere e di adattarsi al cambiamento, spesso sopravvenuto in modo
inaspettato o sorprendente. Le reazioni umane meglio studiate - e più rilevanti in àmbito
clinico - sono quelle legate alla paura - in tutte le sue sfumature - ed alla perdita di una
persona amata. Nei modelli animali, oltre alla paura, è stata particolarmente studiata anche la
forzata sottomissione, una forma di stress sociale che presenta suggestive analogie con
situazioni sovente incontrate nella clinica (si pensi per esempio al mobbing). Direi che quasi
tutta la casistica comunemente incontrata in responsabilità civile rientra in almeno una di
queste categorie.
Semplificando al massimo, sappiamo che le strutture cerebrali maggiormente coinvolte nella
risposta acuta agli eventi stressanti sono l'amigdala, l'ippocampo e l'asse
ipotalamo-ipofisi-surrene, che mette capo alla liberazione dei principali mediatori chimici
dello stress: da una parte le catecolamine, dall'altra i corticosteroidi, entrambi secreti dalle
ghiandole surrenali. Questi ormoni producono importanti modificazioni funzionali sia a
livello periferico che centrale, solitamente di breve durata (dell'ordine di alcune ore) e
completamente reversibili. Il significato biologico di questa cascata di eventi - che
avvengono in modo molto rapido, stereotipato e senza alcun intervento volontario - è quello
di mettere l'organismo in condizioni di affrontare l'emergenza e di conservare una traccia
mnesica dell'evento, che sarà in ogni caso utile in futuro. Questo forte legame tra risposta
emozionale e memoria - che si realizza a livello delle strutture ippocampali - è uno degli
aspetti più importanti per comprendere la patologia umana post-traumatica.
Qualora l'evento traumatico sia estremamente minaccioso può accadere che vengano messe
in atto risposte protettive altrettanto estreme: l'esempio più conosciuto in àmbito clinico è
quello delle reazioni dissociative post-traumatiche, una risposta acuta il cui significato è
verosimilmente quello di prevenire - o perlomeno di attenuare - la formazione di memorie
coscienti del trauma, che si rivelerebbero troppo difficili da integrare, e potenzialmente
distruttive. Mentre l'amigdala registra la memoria emozionale dell'evento, quest'ultimo non
viene registrato dall'ippocampo: il soggetto continua a "sentire" paura (perfino terrore),
magari in circostanze particolari, ma non conserverà dell'episodio originario alcuna traccia
mnesica accessibile alla coscienza. Il pensiero psicoanalitico aveva, da parte sua, descritto
queste reazioni dissociative con il nome di rimozione, uno dei meccanismi di difesa al
servizio dell'integrità del soggetto. Il fatto che le memorie insopportabili non vengano
integrate nella coscienza non significa affatto che non si formino né che non esercitino la loro
influenza: al contrario, i soggetti esposti a traumi molto intensi presentano spesso
conseguenze particolarmente gravi e durature, anche in assenza di una piena consapevolezza
di quanto accaduto. Stanno male, a volte malissimo, senza sapere esattamente perché. I
quadri clinici che insorgono in conseguenza dei traumi estremi sono chiamati, nel
DSM-IV-TR, Disturbo acuto da stress (la risposta acuta) e Disturbo post-traumatico da
stress (la risposta post-acuta, che può cronicizzarsi come tale o sfociare in altri tipi di
disturbi, più o meno gravi). In queste situazioni l'impatto del trauma è così preponderante da
rappresentare il fattore causale sicuramente principale, se non unico, rispetto allo sviluppo
dei disturbi, anche a distanza di anni dall'evento traumatico.
2.
Ancora peggio vanno le cose quando il trauma colpisce in età infantile, o nella prima
adolescenza, nel periodo cioè di maggiore plasticità cerebrale. Con questo termine, proprio
della neurobiologia, si indica la capacità del cervello di modificarsi - transitoriamente o
stabilmente - in risposta agli eventi. La stessa proprietà viene chiamata, in termini
psicologici, apprendimento. La letteratura scientifica sulle conseguenze del trauma infantile
è particolarmente vasta ed autorevole, avendo preso le mosse da osservazioni ed esperimenti
condotti su animali, riguardanti soprattutto le reazioni agli eventi di separazione e perdita, e
successivamente estesi agli effetti delle esperienze negative infantili nell'uomo. L'insieme di
queste ricerche ha chiarito in modo inequivocabile
"che esiste una stretta relazione tra traumi infantili ed il conseguente sviluppo in età
adulta di disturbi psichiatrici maggiori, in particolare disturbi d'ansia e disturbi
depressivi. Gli studi neuroendocrini hanno mostrato che lo stress precoce induce
cambiamenti a lungo termine in vari sistemi neurotramettitoriali, e che l'attività del
fattore di rilascio della corticotropina (CRF) è aumentato in pazienti che soffrono di
disturbi ansiosi e depressivi. Studi preclinici condotti su roditori e primati non umani,
d'altra parte, indicano che gli eventi stressanti durante un periodo critico dello
sviluppo conducono ad un aumento persistente di CRF e ad una sensibilizzazione
dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) in risposta allo stress. Risultati simili in
adulti sopravvissuti ad abusi infantili supportano ulteriormente l'ipotesi ed indicano
che gli individui esposti a traumi infantili diventano maggiormente vulnerabili in età
adulta, anche in risposta a stress di moderata entità, aumentando quindi il rischio di
sviluppare disturbi ansiosi e depressivi."
Queste considerazioni sono particolarmente importanti, perché consentono di gettare
una luce sui meccanismi coinvolti nella vulnerabilità ai disturbi mentali, che proprio nelle
esperienze traumatiche infantili trova una delle sue principali sorgenti.
3. La plasticità cerebrale è comunque all'opera anche nella risposta agli eventi traumatici che
accadono in età adulta. Anche in questo caso, infatti, non basta che un evento minaccioso o
doloroso sia fronteggiato sul momento, occorre anche che venga riconosciuto in seguito:
occorre, in una parola, che venga stabilmente incorporato nella rete di conoscenze che
saranno a disposizione dell'organismo per orientarne le scelte future. Due strutture cerebrali
sono risultate cruciali: l'amigdala e l'ippocampo, entrambe profondamente coinvolte nella
capacità di formare e mantenere nel tempo le memorie sia degli eventi accaduti che dei
contesti in cui gli eventi sono accaduti. Il significato adattivo di questi apprendimenti sembra
evidente: proteggere l'organismo da ulteriori esposizioni ad eventi ed a situazioni che in
passato si sono rivelate minacciose. Evidentemente se ne intravede anche il possibile
significato patogenetico: intrusioni indesiderate di memorie traumatiche, ri-vivere di
continuo gli eventi spaventosi o dolorosi, generalizzazione delle risposte, necessità di evitare
il disagio provocato da questi stessi effetti indesiderati, anticipazione mentale di possibili
nuovi eventi traumatici, e così via. In una parola: la quasi totalità dei sintomi dello spettro
ansioso e depressivo.
4. Il perdurare nel tempo di questo stato di mobilitazione energetica - quasi uno stato di allerta
(arousal) permanente - provoca un effetto deleterio non solo su una quantità di organi
somatici (cosa che già si sapeva fin dagli studi pionieristici di Selye e di Cannon), ma anche
sulle strutture cerebrali coinvolte nell'apprendimento di tali eventi, in particolare amigdala ed
ippocampo. Gli stessi mediatori ormonali che regolano la risposta acuta allo stress
provocano, se troppo a lungo mantenuti, effetti neurotossici: di nuovo semplificando, lo
stress provoca un eccesso di attività dell'amigdala ed una minore funzionalità
dell'ippocampo, dovuta in particolare agli effetti deleteri del cortisolo. Nei modelli animali
(roditori e primati non umani) l'esposizione a periodi prolungati di stress - dell'ordine di
qualche settimana - provoca da una parte una ipertrofia dell'amigdala, e dall'altra una
riduzione significativa sia della neurogenesi che della ramificazione dendritica nelle regioni
ippocampali, che si traduce da una parte in un aumento dell'ansia e dell'aggressività, dall'altra
in una diminuzione delle capacità di apprendimento.
5. Nell'uomo, gli effetti deleteri dello stress prolungato sono stati evidenziati innanzitutto dagli
studi di neuroimmagine, che hanno ripetutamente documentato le modificazioni strutturali e
funzionali di alcune regioni cerebrali "critiche", coerenti con i dati ottenuti negli studi su
animali. L'atrofia strutturale dell'ippocampo, in particolare, è stata osservata sia in soggetti
depressi che in soggetti affetti da disturbo post-traumatico da stress, ed in entrambi i casi è
stata messa in relazione con la prolungata ed eccessiva esposizione ai corticosteroidi.
6. Un'importante conseguenza dello stress prolungato nell'uomo è rappresentata dai deficit
cognitivi, soprattutto a carico della memoria, che già da tempo erano stati osservati sia nei
soggetti depressi che nei soggetti con disturbo post-traumatico da stress, ma che fino a pochi
anni fa erano sbrigativamente liquidati come psicogeni, se non addirittura frutto di
simulazione. Questo tipo di deficit, analoghi a quelli osservabili nei modelli animali, sono
oggi interpretati piuttosto come l'espressione funzionale dell'atrofia dell'ippocampo, la più
importante struttura coinvolta nella formazione di memorie episodiche nell'uomo, e proprio
per questo una delle più vulnerabili agli effetti cronici dello stress.
7. Nonostante che gli effetti degli eventi traumatici e stressanti siano così ampi e documentati,
non deve essere dimenticato che la grande maggioranza dei soggetti - anche dopo
esposizione a traumi estremi - presenta tuttavia ampie capacità di resilienza, in parte da
attribuire alla disponibilità di supporti sociali e di interventi terapeutici precoci, in parte da
attribuire alla preesistenza di tratti di personalità facilitanti valide strategie di coping.
3. Le componenti psicologiche della risposta allo stress
1. Non appena l'evento è stato "incorporato" nella rete di conoscenze proprie del soggetto,
questi inizia a svolgere un ruolo attivo e per certi aspetti decisivo circa gli esiti futuri. Ciò che
ora accade è molto singolare, e probabilmente specifico dell'uomo: in primo piano non è più
la risposta - in gran parte biologicamente determinata - all'evento traumatico, ma la modalità
con la quale il significato dell'evento stesso viene rielaborato ed interpretato. Comprendere
questo aspetto - squisitamente psicologico - è fondamentale: non solo l'evento determina
effetti sul soggetto - questa sarebbe ancora una modalità lineare di comprendere la relazione,
assimilabile in definitiva alla causalità fisica -, ma il soggetto stesso determina circolarmente - non certo l'evento, ma il suo significato. Non sono per niente convinto che il
trauma emozionale sia interamente comprensibile a partire dallo studio delle sue
conseguenze biologiche: ciò che è all'opera nel trauma emozionale - per il bene e per il male
- è l'intera soggettività, che in determinate circostanze assume un ruolo almeno altrettanto
significativo delle conseguenze propriamente biologiche.
2. Questa interazione tra aspetti biologici e psicologici è ben conosciuta in medicina, a
proposito degli effetti dei farmaci - sia positivi che negativi. L'effetto nocebo (letteralmente:
nuocerò, sarò dannoso) si riferisce ai sintomi ed ai cambiamenti indesiderati che seguono la
somministrazione di una sostanza inerte, farmacologicamente inattiva, che il soggetto ritiene
essere attiva. Si tratta di un fenomeno - analogo al più conosciuto effetto placebo - che ha
importanti conseguenze non solo di tipo economico, ma anche propriamente terapeutico, in
quanto è all'origine di un gran numero di interruzioni o di mancate adesioni ai trattamenti
proposti. Si può ipotizzare che qualcosa di simile possa essere all'opera dopo l'esposizione ad
eventi stressanti?
3. Dopo aver sperimentato un evento traumatico o stressante, solitamente il soggetto ne
conserva un vivo ricordo, che è comunque fonte di intensa sofferenza, ansia e disagio. A ciò
si associano, spesso, disturbi come insonnia, fatica, mal di testa, dolore, difficoltà di
concentrazione, vertigini, irritabilità, ecc. Ciò che ora accade è che tutti questi disturbi normalmente presenti nella vita di ogni giorno della maggior parte delle persone - vengono
erroneamente attribuiti all'evento stressante. Si post hoc, propter hoc. L'evento - doloroso,
spaventoso o umiliante - diventa d'un tratto l'elemento esplicativo attorno a cui si condensa
tutto il malessere esistenziale, presente e passato, del soggetto colpito. La sofferenza del
presente induce una sistematica distorsione della propria esperienza passata, che viene
percepita - per contrasto - come totalmente libera da sintomi e difficoltà. La memoria
autobiografica, infatti, è un processo in larga parte costruttivo, in cui le informazioni circa il
passato vengono inferite a partire dalla situazione presente. In certi casi, un'intera vita di
sacrifici e di sofferenze viene re-interpretata alla luce dell'evento. L'attribuzione di tutti i
propri malesseri ad una causa esterna, per di più accaduta senza alcuna responsabilità
soggettiva, costituisce un potente fattore di coerenza narrativa, capace di radicarsi
profondamente nel sistema di convinzioni della vittima. Il processo di erronea attribuzione, si
badi bene, avviene in modo del tutto involontario ed in completa buona fede: nessuna
consapevolezza del processo né tantomeno deliberata volontà di simulazione.
4. Le informazioni di cui il soggetto dispone al momento dell'evento, e quelle che gli vengono
fornite immediatamente dopo, rappresentano un altro fattore cruciale. Queste informazioni unitamente ad eventuali altre esperienze precedenti - formano la base per la formazione di
aspettative circa il decorso futuro. I soggetti che si aspettano di star male tendono a percepire
i propri sintomi in maniera congruente con le proprie aspettative, che diventano così profezie
che si auto-confermano. Ancor più, il solo fatto di nutrire un'aspettativa negativa tende a
concentrare l'attenzione e ad amplificare la percezione del sintomo. Questo meccanismo è
stato abbondantemente studiato sia in soggetti sani, sia in soggetti con patologie somatiche e
mentali di vario tipo. Particolarmente significative sono le aspettative riguardanti le
conseguenze ed il decorso di una malattia diagnosticata, anche in assenza di ogni benché
minimo sintomo o disturbo.
5. Esistono evidenze a sostegno del fatto che tratti di personalità di tipo somatoforme siano
correlati ad una maggiore tendenza ad amplificare i propri sintomi, sia di tipo propriamente
somatico che psicologico. Nonostante che il termine somatizzazione (che comprende
l'ipocondria ed i disturbi di conversione) induca a ritenere che la percezione amplificata
riguardi esclusivamente i sintomi somatici, si tratta in realtà di una tendenza che si applica
alla totalità dei sintomi percepiti, compresi i sintomi ansiosi e depressivi. Questo tratto era
noto, fino a un paio di decenni fa, come nevroticismo, ossia la tendenza a sperimentare una
vasta gamma di sintomi psicologici, somatici e di disagio emozionale. Se della parola si deve
ormai fare a meno, è bene tuttavia che sia mantenuta l'idea di una possibile distorsione
percettiva anche del proprio malessere emozionale. Mentre la somatizzazione viene definita
tale solo dopo l'esclusione di spiegazioni organiche conosciute, l'amplificazione dei sintomi
ansioso-depressivi rappresenta un delicato paradosso epistemologico, in quanto virtualmente
indistinguibile dalla "vera" sintomatologia.
6. Nonostante ciò, i meccanismi descritti - attribuzione erronea ed aspettative negative - vanno
considerati come meccanismi di risposta psicologica in qualche maniera universali, che non
richiedono cioè particolari predisposizioni né vulnerabilità antecedenti. Tutti i soggetti, oltre
alle risposte propriamente biologiche, tendono - in misura maggiore o minore - a presentare
anche queste possibili forme di distorsione cognitiva, che andranno pertanto accuratamente
considerate e valutate. Il disagio percepito su base psicologica - voglio sottolinearlo ancora non è meno doloroso di quello dovuto agli effetti propriamente biologici del trauma subìto.
Certamente andrà da quest'ultimo distinto, probabilmente andrà quantificato (e forse
qualificato) in altra maniera, ma in nessun modo dovrà essere semplicemente liquidato come
irrilevante. D'altra parte, molta attenzione dovrà essere rivolta alla fine discriminazione tra
aspetti biologici e psicologici, per non rischiare - a nostra volta - di fare di tutta l'erba un
fascio. Le attribuzioni e le aspettative erronee - proprio perché meccanismi universali riguardano da vicino, ahimè, anche coloro che valutano.
7. Nella letteratura sulle risposte psicologiche allo stress ed al trauma, si incontra anche la
concettualizzazione riguardante i vantaggi secondari associati al ruolo di malato (sick role).
In estrema sintesi, si sostiene che un soggetto potrebbe essere spinto a comportarsi - seppure
in modo inconsapevole, sulla base di motivazioni inconsce - in modo da fruire dei vantaggi
socialmente accordati a chi è riconosciuto malato. Si tratta di una interpretazione basata su
concezioni speculative in gran parte di derivazione psicodinamica, poco supportate (forse
neppure supportabili in linea di principio) da evidenze empiriche, e che hanno il solo effetto
di introdurre un discutibile elemento di "finalismo" - seppure inconscio - nel comportamento
di malattia. Non c'è niente di più inaccettabile, per chi sta male, quanto l'insinuare che la sua
sofferenza (qualunque ne sia la causa e l'intensità) possa essere un mezzo per ottenere
vantaggi - per di più senza la possibilità di obiettare qualcosa, dal momento che tutto si
svolgerebbe a sua insaputa. Per queste ragioni, raccomando vivamente che questo tipo di
interpretazioni venga quanto più possibile evitato.
4. Fattori sociali e contestuali nella risposta allo stress
1. Il processo di adattamento al trauma o allo stress è mediato anche, in misura considerevole,
dal contesto sociale di appartenenza della persona, che può a sua volta interagire ostacolando o favorendo il recupero - con le componenti biologiche e psicologiche.
Ambienti socialmente e culturalmente deprivati tendono a riattivare maggiormente i vissuti
di frustrazione e di alienazione, soprattutto in presenza di eventi che non implicano alcuna
stigmatizzazione sociale, come l'essere stati oggetto di un torto o di un'ingiustizia. E'
frequente incontrare - nelle cause di risarcimento del danno - un elevato desiderio di
rivendicazione e di riscatto sociale, se non addirittura di vera e propria battaglia per la
giustizia, che a volte mobilita interi gruppi familiari, organi di stampa, perfino istituzioni e
comunità.
2. Particolarmente importante è l'influenza esercitata da tutti coloro che - all'indomani di un
evento traumatico o stressante - entrano in contatto diretto con la vittima nello svolgimento di
un ruolo professionale: sanitari del pronto soccorso, medici di famiglia, specialisti, avvocati,
assicuratori, ecc. Tutti questi soggetti, in modo più o meno consapevole, sono in grado di
esercitare un'influenza profonda e duratura sul sistema di conoscenze e sul comportamento
dei soggetti con i quali entrano in contatto. Particolare attenzione e cautela dovrà essere
rivolta nell'evitare che questo genere di influenzamento avvenga al di fuori del controllo
stesso dei professionisti, che a loro volta - loro malgrado - possono facilmente cadere preda
di sistematiche distorsioni indotte dal ruolo e dall'interesse professionale.
3. I professionisti della salute, in particolare gli specialisti di formazione "organicista", tendono
facilmente ad allearsi con i bisogni dei loro pazienti. Poiché la malattia mentale è
socialmente stigmatizzata, i pazienti hanno bisogno di una "vera" diagnosi di malattia
(meglio ancora se suscettibile di trattamenti complessi, anche di tipo chirurgico) che sia in
grado di "spiegare" i loro sintomi e nello stesso tempo sia socialmente accettabile, non
gravata dall'ombra della colpa, della menzogna o della debolezza di carattere.
4. Un problema particolarmente grave è rappresentato dalle stesse cause di risarcimento, che
per la loro natura e durata inducono di per sé i soggetti ad intensificare e prolungare il loro
stato di malattia. Indurre qualcuno a "provare" ripetutamente che è ancora malato confonde e
distorce la stessa esperienza di malattia, impedisce la guarigione e perpetua l'invalidità.
Quando il mantenimento o la speranza dei benefici economici dipende dal proseguimento dei
sintomi, il soggetto è intrappolato nel ruolo di malato. Quando questo ruolo diventa troppo
esteso e pervasivo, può essere molto difficile abbandonarlo senza mettere in discussione la
sua stessa credibilità e legittimità.
"Il coinvolgimento in cause di risarcimento rende i querelanti (plaintiffs) suscettibili a
fattori stressanti che possono aumentarne il disagio, distorcerne i resoconti e
ritardarne il recupero. Sebbene tratti di personalità preesistenti giochino un ruolo
importante nel definire e modellare la risposta allo stress, tuttavia le cause che si
protraggono nel tempo promuovono distorsioni nella memoria e nel modo di
presentazione di sé, come pure motivazioni coscienti ed inconsce per la ricerca di
guadagni secondari".
4. Conclusioni
La trilogia della Corte Costituzionale – che con cadenza pressoché decennale (1986, 1994
e 2003) ha disegnato i contorni sistematici del danno alla persona – va considerata come lo
snodarsi di un identico cammino verso la complessità. Dal patrimonio alla salute, dalla salute alla
piena realizzazione della persona umana. Ben prima del danno esistenziale, ultima tappa di
questo tragitto, la complessità aveva fatto il suo ingresso nel sistema della responsabilità civile.
La complessità appartiene all’essenza stessa dell’oggetto, non può né deve essere evitata.
Nessuno si scandalizzi, nessuno si spaventi, nessuno tenti di ridurla entro schemi semplicistici,
nessuno soprattutto chiami in causa la cattiva scienza o la pigra scienza per essere esonerato
dalla “fatica del concetto”, cioè dalla ricerca di metodologie d’indagine rigorose ed adeguate
all’oggetto d’indagine.
Il danno psichico, pur essendo comunemente considerato una fattispecie del danno biologico,
in realtà ne differisce in modo sostanziale, nel senso che la dimensione biologica è solo una - e
spesso neppure la più importante - delle componenti del danno: la dimensione psichica introduce
un elemento di complessità ulteriore, dove gli effetti propriamente biologici della lesione
inestricabilmente si confondono con i significati soggettivi che appartengono in modo irripetibile
alla storia di quel singolo individuo, ed alla sua rete di relazioni sociali.
Ciò non ostacola minimamente la possibilità di pervenire ad una metodologia di valutazione
del danno psichico che sia rigorosa e fondata su solide basi scientifiche, come le corti
giustamente pretendono.
Per pervenire a questo, occorre prima di tutto rinunciare ad una visione riduttiva e
banalizzante del danno psichico stesso, visione che ha purtroppo fino ad oggi prevalso, seppure
con significative eccezioni.
Mi piace concludere queste riflessioni con le parole di Aristotele, un uomo ben consapevole
del valore e dei limiti della scienza:
"Non bisogna infatti ricercare la medesima precisione in tutte le opere di pensiero, così
come non si deve ricercarla in tutte le opere manuali. E' proprio dell'uomo preparato
richiedere in ciascun campo tanta precisione quanta ne permette la natura dell'oggetto".