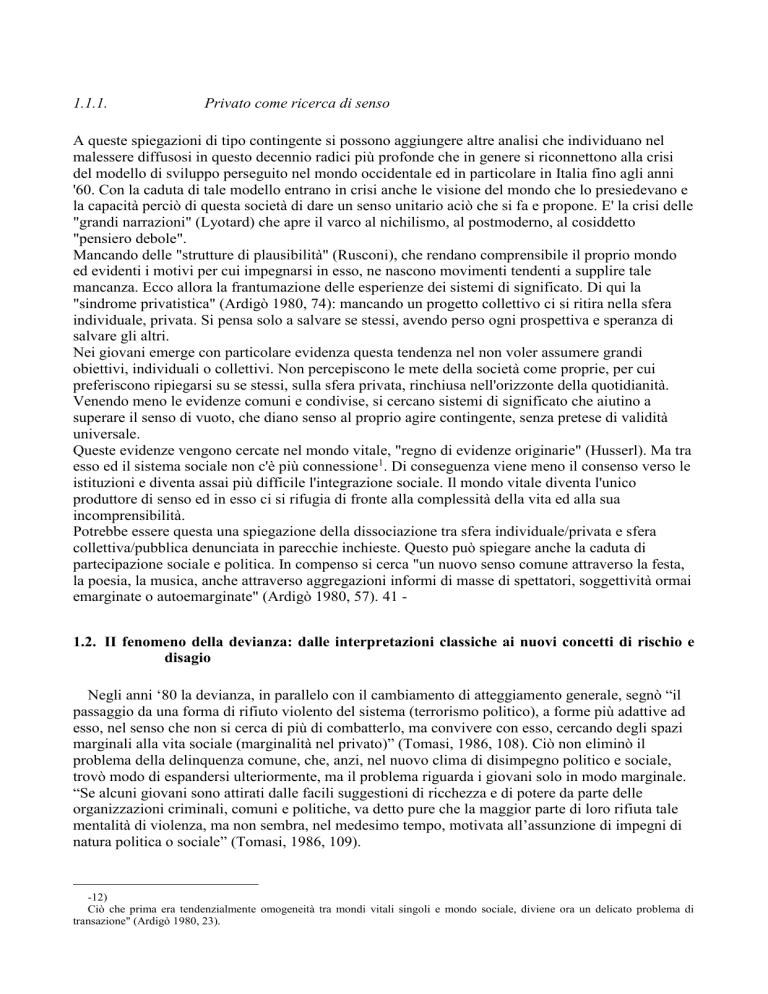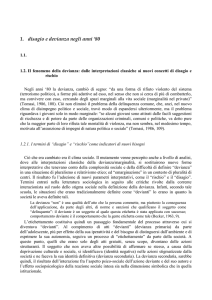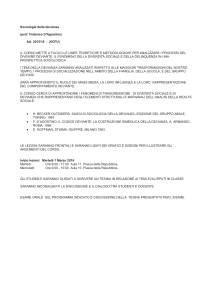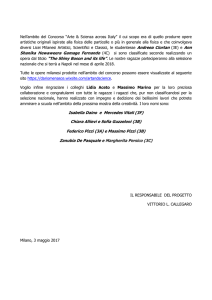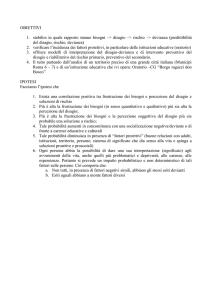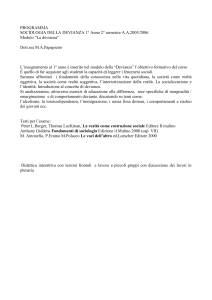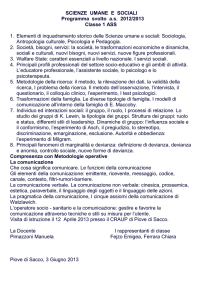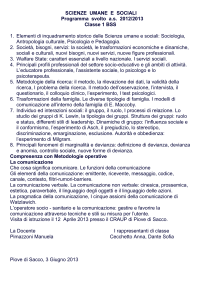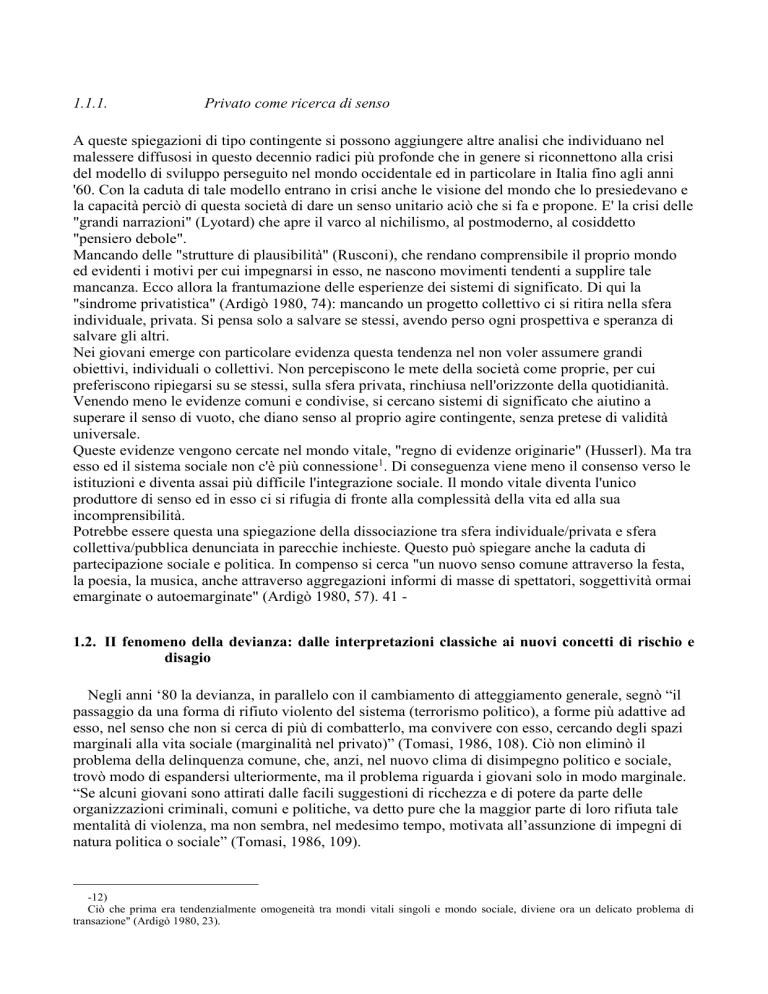
1.1.1.
Privato come ricerca di senso
A queste spiegazioni di tipo contingente si possono aggiungere altre analisi che individuano nel
malessere diffusosi in questo decennio radici più profonde che in genere si riconnettono alla crisi
del modello di sviluppo perseguito nel mondo occidentale ed in particolare in Italia fino agli anni
'60. Con la caduta di tale modello entrano in crisi anche le visione del mondo che lo presiedevano e
la capacità perciò di questa società di dare un senso unitario aciò che si fa e propone. E' la crisi delle
"grandi narrazioni" (Lyotard) che apre il varco al nichilismo, al postmoderno, al cosiddetto
"pensiero debole".
Mancando delle "strutture di plausibilità" (Rusconi), che rendano comprensibile il proprio mondo
ed evidenti i motivi per cui impegnarsi in esso, ne nascono movimenti tendenti a supplire tale
mancanza. Ecco allora la frantumazione delle esperienze dei sistemi di significato. Di qui la
"sindrome privatistica" (Ardigò 1980, 74): mancando un progetto collettivo ci si ritira nella sfera
individuale, privata. Si pensa solo a salvare se stessi, avendo perso ogni prospettiva e speranza di
salvare gli altri.
Nei giovani emerge con particolare evidenza questa tendenza nel non voler assumere grandi
obiettivi, individuali o collettivi. Non percepiscono le mete della società come proprie, per cui
preferiscono ripiegarsi su se stessi, sulla sfera privata, rinchiusa nell'orizzonte della quotidianità.
Venendo meno le evidenze comuni e condivise, si cercano sistemi di significato che aiutino a
superare il senso di vuoto, che diano senso al proprio agire contingente, senza pretese di validità
universale.
Queste evidenze vengono cercate nel mondo vitale, "regno di evidenze originarie" (Husserl). Ma tra
esso ed il sistema sociale non c'è più connessione1. Di conseguenza viene meno il consenso verso le
istituzioni e diventa assai più difficile l'integrazione sociale. Il mondo vitale diventa l'unico
produttore di senso ed in esso ci si rifugia di fronte alla complessità della vita ed alla sua
incomprensibilità.
Potrebbe essere questa una spiegazione della dissociazione tra sfera individuale/privata e sfera
collettiva/pubblica denunciata in parecchie inchieste. Questo può spiegare anche la caduta di
partecipazione sociale e politica. In compenso si cerca "un nuovo senso comune attraverso la festa,
la poesia, la musica, anche attraverso aggregazioni informi di masse di spettatori, soggettività ormai
emarginate o autoemarginate" (Ardigò 1980, 57). 41 1.2. II fenomeno della devianza: dalle interpretazioni classiche ai nuovi concetti di rischio e
disagio
Negli anni ‘80 la devianza, in parallelo con il cambiamento di atteggiamento generale, segnò “il
passaggio da una forma di rifiuto violento del sistema (terrorismo politico), a forme più adattive ad
esso, nel senso che non si cerca di più di combatterlo, ma convivere con esso, cercando degli spazi
marginali alla vita sociale (marginalità nel privato)” (Tomasi, 1986, 108). Ciò non eliminò il
problema della delinquenza comune, che, anzi, nel nuovo clima di disimpegno politico e sociale,
trovò modo di espandersi ulteriormente, ma il problema riguarda i giovani solo in modo marginale.
“Se alcuni giovani sono attirati dalle facili suggestioni di ricchezza e di potere da parte delle
organizzazioni criminali, comuni e politiche, va detto pure che la maggior parte di loro rifiuta tale
mentalità di violenza, ma non sembra, nel medesimo tempo, motivata all’assunzione di impegni di
natura politica o sociale” (Tomasi, 1986, 109).
-12)
Ciò che prima era tendenzialmente omogeneità tra mondi vitali singoli e mondo sociale, diviene ora un delicato problema di
transazione" (Ardigò 1980, 23).
1.2.1. L’introduzione dei termini di “disagio” e “rischio”
Ciò che era cambiato era il clima sociale. Il mutamento venne percepito a livello di analisi, dove
alle interpretazioni classiche della devianza/marginalità, si sostituirono nuove forme interpretative
che tenevano conto della complessità sociale e della difficoltà di definire “devianza” in una
situazione di pluralismo e relativismo etico, ed “emarginazione” in un contesto di pluralità di centri.
Il risultato fu l’adozione di nuovi parametri interpretativi, come il “rischio” e il “disagio”. Termini
entrati nella letteratura sociologica in seguito alle critiche rivolte dalla corrente interazionista sul
ruolo dello stigma sociale nella definizione della devianza. Infatti, secondo tale scuola, le situazioni
che erano tradizionalmente definite come “devianti” lo erano in quanto la società le aveva definite
tali.
La devianza “non” è una qualità dell’atto che la persona commette, ma piuttosto la conseguenza
dell’applicazione, da parte degli altri, di norme e sanzioni che qualificano il soggetto come
“delinquente”: il deviante è un soggetto al quale questa etichetta è stata applicata con successo;
comportamento deviante è il comportamento che la gente etichetta come tale (Becker, 1963, 9)
Questo etichettamento è di fondamentale importanza per capire il processo di costruzione
dell’identità deviante. Al compimento di atti “devianti” (devianza primaria) da parte
dell’adolescente, più per effetto della sua iperattività e del bisogno di distinguersi dall’ambiente e di
esprimere la sua autonomia, segue un processo di “etichettamento” da parte della società. A questo
punto, quelli che erano solo degli atti gratuiti, senza scopo, diventano delle azioni strutturanti. Il
soggetto che non ha altre possibilità di affermare se stesso, a causa della deprivazione culturale e
sociale, si identifica (identità negativa) nelle azioni stigmatizzate dalla società e ne fa la sua identità
definitiva (devianza secondaria). La devianza secondaria, è quindi, il risultato dell’interazione fra
l’aspetto psico-sociale dell’azione deviante e del suo autore e l’effetto sociopsicologico della
reazione sociale intesa sia nella dimensione simbolica che in quella istituzionale. Attraverso
l’adozione dei termini “rischio” e “disagio” si volle evitare di etichettare chi commetteva atti
trasgressivi come “deviante”, contribuendo con ciò al passaggio da una devianza primaria ad una
secondaria e definitiva.
1.2.1.1. L’elaborazione del concetto di rischio in “Giovani e Città” (1984)
Il concetto di rischio venne applicato in maniera sistematica nella ricerca “Giovani e città”
(Milanesi, 1984), che reca come sottotitolo “Percorsi giovanili a rischio”. Tale ricerca, promossa
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Gioventù del Comune di Brescia tra i giovani compresi
tra i 14 e i 19 della città, fu una ricerca che ha contribuito notevolmente alla elaborazione teorica del
concetto di rischio2 e ad una svolta nel modo di trattare il tema della devianza. Questo perché il
lavoro era stato condotto da un gruppo di studio, che comprendeva sociologi, psicologi, pedagogisti,
esperti di politiche sociali, funzionari e operatori sul campo. Quest’ampia rappresentanza di vari
interessi e approcci metodologici offrì la possibilità di elaborare un quadro teorico che tenesse conto
sia delle varie interpretazioni teoriche sulla condizione giovanile e sulla devianza, sia degli aspetti
concreti del problema a livello locale. Tale quadro teorico fu socializzato con altri studiosi, per cui
divenne una base di riferimento in Italia per ulteriori riflessioni su tale tema3.
Infatti l’ipotesi generale suonava in questi termini:
"Esistono effettive possibilità di rischio sociale per gli adolescenti e per i giovani del Comune di
Brescia nelle zone territoriali e negli strati sociali in cui:
a) la condizione degli adolescenti e dei giovani appare più caratterizzata dai processi di
_____2 “Il concetto di ‘rischio’ occupa una posizione centrale nell'impianto generale di questa ricerca (Milanesi, 1984
422).
3 Sembra, sia dall’esame interno dei contenuti che da incerte testimonianze di contemporanei, che la stessa opera di Neresini e
Ranci (1992), che costituisce uno dei più validi lavori a livello di riflessione sistematica sul tema del disagio giovanile in Italia, abbia
recepito alcuni elementi della ricerca di Brescia, forse per qualche forma di interazione tra i due
emarginazione, di negazione del potenziale innovativo, di controllo sociale della
socializzazione;
b) la soggettività degli adolescenti e dei giovani appare inadeguata ai processi di cui essi sono
oggetto" (Milanesi, 1984, 45-46).
Per poter verificare tali ipotesi, fu necessario definire, teoricamente ed operativamente, i termini
impiegati. Tale chiarificazione risultò decisiva per comprendere il concetto di rischio ed i termini ad
esso correlati.
1.2.1.1.1. La definizione di rischio
Innanzitutto venne esclusa la coincidenza del termine “rischio” con “comportamento deviante”
Per rischio sociale si intendevano:
"situazioni obiettive e soggettive in cui vengono rese difficili e, al limite negate, le possibilità e le
capacità (personali e di gruppo) di autorealizzazione e di partecipazione consapevole" (Milanesi,
1984, 47).
Concetto che venne ulteriormente specificato, nel corso della discussione:
"situazione in cui vengono frustrate o negate le opportunità ragionevoli di soddisfazione dei
bisogni fondamentali" (Milanesi, 1984, 422).
A livello operativo vennero precisati i bisogni fondamentali, le possibilità di autorealizzazione e
partecipazione, la cui frustrazione costituisce occasione (o fattore) di rischio.
Siccome si optò per una definizione di autorealizzazione di tipo soggettivo, ne conseguiva che il
concetto di "rischio"
resta condizionato da una intrinseca oscillazione tra una concezione "obiettivistica" (essere in una
situazione in cui mancano certe premesse obiettivamente necessarie alla soddisfazione di bisogni
obiettivamente fondamentali) ed una concezione "soggettivistica" (percepire come soggettivamente
pericolosa una situazione in cui mancano le premesse soggettivamente considerate necessarie alla
soddisfazione di bisogni soggettivamente ritenuti fondamentali) (Milanesi 1984, 425-426).
Anche se non annullata la componente “soggettivistica” del rischio, i ricercatori cercarono di
definire le variabili che costituivano la componente “oggettiva” del rischio.
La ricerca, infatti, era partita dal presupposto che:
una certa disgregazione del territorio (in termini di degrado fisico ed abitativo, di destrutturazione
del tessuto sociale e della partecipazione, di crisi dei processi di produzione collettiva di senso) sia
obiettivamente alla base del rischio giovanile. E, per converso, ritiene che la presenza sul territorio
di fenomeni di segno opposto (nuove forme di aggregazione; movimenti collettivi di tipo reattivo,
adattativo, conflittuale; emergenza di una diversa domanda sociale) siano funzionali a processi di
prevenzione e/o recupero rispetto al rischio (Milanesi, 1984, 426).
Come pure considera fattori di rischio alcune situazioni tipiche della condizione giovanile del
momento.
L'impianto dell'indagine presuppone che certe situazioni obiettive tipiche della condizione
giovanile di questa fase storica possano interagire insieme alle situazioni di disgregazione del
territorio, moltiplicando 1e possibilità di rischio (Milanesi, 1984, 426).
Tra le situazioni tipiche della condizione giovanile che possono diventare fattori di rischio, la
ricerca considerò soprattutto l’emarginazione, “che minaccia tutti i giovani e che colpisce
selettivamente i meno garantiti ed attrezzati tra essi” (Milanesi, 1984, 427).
Gli indicatori dell’emarginazione vengono rintracciati in:
l'espulsione precoce dalle strutture formative, o il prolungato parcheggio in esse,
l'esclusione dal lavoro legale, lo sfruttamento del lavoro nero,
la costrizione a svolgere esclusivi o prevalenti funzioni di consumo,
la manipolazione attraverso la socializzazione coatta dei mass media,
l'esclusione dalle forme di partecipazione scolastica, politica, ecclesiale (Milanesi, 1984,
427).
Un altro fattore di rischio consisteva nella
negazione del potenziale innovativo cioè la frustrazione della "capacità di produrre cultura
relativamente autonoma rispetto ai modelli condivisi dalla società adulta, che a sua volta sembra
collegata con la situazione tipica di frammentazione della condizione giovanile e con l'ambiguità
sostanziale degli atteggiamenti di tolleranza e di permissività adottate dagli adulti nei riguardi dei
comportamenti giovanili (Milanesi 1984, 427-428).
Infine, un ulteriore fattore di rischio consisteva, secondo i ricercatori, in una
situazione di controllo sociale della socializzazione, cioè di una "massificazione dei processi di
socializzazione, attraverso la canalizzazione dei bisogni adolescenziali/giovanili verso
comportamenti stereotipi soprattutto nel tempo libero" (Milanesi, 1984, 428).
Anche questa situazione venne collegata al rischio, in quanto ostacolo serio alla costruzione di
identità individuali e collettive ben strutturate. Tale tipo di socializzazione venne ritenuta dai
ricercatori in grado di impedire
un'autonoma e critica esplorazione delle possibilità originali di soddisfazione dei propri bisogni,
indirizzandoli invece verso mete socialmente e personalmente irrilevanti, ancorché
economicamente redditizie per i gestori del controllo sociale (Milanesi, 1984, 428).
Infine i ricercatori si posero la domanda sul rilievo che potevano assumere questi fattori di
rischio “oggettivi” sulla percezione o valorizzazione soggettiva nel vissuto dei giovani. Sulla base
delle ricerche e degli studi compiuti negli anni immediatamente precedenti, si riconobbe che
la soggettività dei giovani è incessantemente capace di elaborare (individualmente e
collettivamente) risposte adattative, reattive e/o proattive più o meno funzionali al "bisogno di
significato" emergente dalle problematiche condizioni di vita (emarginazione ecc.) in cui sono
chiamati a vivere (Milanesi 1984, 429).
I modi attraverso cui i giovani aumentano, attraverso le loro letture soggettive e adattive, la
probabilità di rischio, già presente i certe situazioni oggettive, sarebbero:
una distorta percezione delle proprie condizioni esistenziali, in particolare dei fattori di rischio; una
cultura del privato, incline a interpretare solo in modo individualistico-consumistico le varie
esperienza di vita; una cultura dell'irrazionalità che denota sia una certa incapacità a utilizzare
realisticamente le risorse disponibili e a destinarle alla realizzazione e all'espansione della socialità,
sia una certa tendenza all'uso di meccanismi di adattamento di tipo evasivo, aggressivo,
supercompensativo (Milanesi, 1984, 431).
Tuttavia l’ipotesi di lavoro cercò di evitare una concezione meccanicistica del rischio. Esso
infatti,
non è concepito come una serie di "affinità" (cioè di predisposizioni, condizioni, caratteristiche) cui
si è esposti e da cui per "contagio" o per altri meccanismi automatici si perviene a comportamenti
peri colosi per la persona del giovane o dell'adolescente. L'affinità non diventa rischio reale se non
è filtrata attraverso una lettura che la trasforma in un fattore soggettivamente disfunzionale, rispetto
alle possibilità di autorealizzazione e partecipazione (Milanesi, 1984, 431).
Per concludere che il tentativo di misurare il rischio giovanile si limitava
a privilegiare alcune "affinità" (cioè obiettive condizioni che più o meno astrattamente possono
esporre al rischio), lasciando però aperte le differenziate possibilità di lettura soggettiva delle
affinità stesse, che non sono prevedibili e misurabili se non ipoteticamente (Milanesi, 1984, 431432).
1.2.1.1.2. Tipi di rischio
Per arrivare ad una operazionalizzazione dei concetti sopra esposti e soprattutto per poter
misurare effettivamente il rischio, il gruppo di lavoro procedette ad una precisazione dei vari tipi di
rischio in cui pensavano di imbattersi e degli indicatori da impiegare per riconoscerlo. Ne emersero
varie tipologie di rischio che, operazionalizzate, diedero luogo a delle scale di rischio.
A. Rischio di devianza
Rispetto alla devianza classica (cfr. Gallino, 1978, 227), il rischio di devianza se ne differenzia
per il carattere relativo, come è relativo il concetto di norma, cui esso si rifà, e i processi di
legittimazione della norma, di tolleranza e di reazione sociale (stigmatizzazione del deviante). Per
cui il vero deviante non è solo quello che ha infranto la norma, ma quello che lo ha fatto in maniera
visibile e ne ha ricevuto una sanzione sociale (stigma). Per questo risulta che il vero deviante è
il deviante "secondario", cioè il deviante strutturato, il deviante che ha interiorizzato lo "stigma",
che è quanto dire il deviante che ha fatto della devianza stessa il motivo e il contenuto essenziale
della propria identità totale; non è invece deviante a pieno titolo colui che ha infranto sì una norma,
ma lo ha fatto solo occasionalmente, o che comunque non è ancora entrato nella spirale della
stigmatizzazione (e che dunque va considerato solo un deviante "primario") (Milanesi, 1984, 438439).
Pertanto, per poter quantificare il rischio di devianza bisognava, tenendo presenti le
considerazioni precedenti, definire: le qualità di soggetti, i comportamenti che costituvano una
predisposizione alla devianza primaria, e quali per una devianza secondaria,.
Un primo livello di analisi cercò di cogliere le affinità (secondo il linguaggio di D. Matza), cioè,
pre-condizioni obiettive (a livello biologico, psicologico, culturale) e soggettive (sentirsi
nell'occasione di "poter" deviare) non meccanicisticamente connesse ad un reale atto o
comportamento deviante (Milanesi, 1984, 439).
Un secondo livello invece cercò di definire l’affiliazione, cioè, i
comportamenti non conformi alla norma a cui si sono già associati in maniera dialettica sia alcuni
atti di "affiliazione" (cioè di considerazioni positive circa l'ipotesi e la possibilità di diventare un
deviante "secondario") sia alcuni atti di stigmatizzazione (cioè di definizioni/significazioni
negative degli atti non conformi alla norma) (Milanesi, 1984, 439-440).
È questo livello che indica la situazione di “rischio”, nel senso che esiste la possibilità che la
devianza primaria possa strutturarsi in una devianza secondaria, cioè in una serie di
atti di affiliazione e di stigmatizzazione, tendenti a provare l'accettazione (almeno iniziale) da parte
del deviante di una definizione negativa degli atti compiuti (Ibidem, 440).
Un terzo livello, corrispondente alla devianza vera e propria, sarebbe invece dato dalla
quantificazione di comportamenti devianti ormai abituali, rafforzati da una strutturata "carriera"
soggettiva nella devianza e da una ripetuta stigmatizzazione di tali comportamenti (anche da parte
di controllori "esterni” e, in certi casi, dalle istituzioni totali). In questo caso il "rischio" di devianza
potrebbe essere considerato come possibilità di strutturazione irreversibile del comportamento
deviante, di fissazione entro una "subcultura deviante", di interiorizzazione profonda dell'identità
negativa (o dello stigma) (Ibidem, 440).
I ricercatori affermarono che la loro ipotesi di rischio riguardava prevalentemente il secondo
aspetto, il che implicava la difficoltà di misurare il grado di “affiliazione”, cioè di interiorizzazione
di un’identità negativa. Ancora più difficile appariva la misurazione della “significazione sociale”
di certi comportamenti, operazione nemmeno presa in considerazione. Invece furono valutate:
1. La frequentazione di ambienti/persone a rischio di devianza;
2. La condivisione di opinioni, atteggiamenti e disponibilità per comportamenti devianti;
3. Alcuni comportamenti devianti tipici (fare bravate, uso di droghe, alcool, ecc.) (cfr.
Milanesi, 1984, 610-611).
B. Rischio fisico
Nell’elaborare il concetto di rischio fisico, l’accento fu posto sulla salute, “come condizione
ottimale di funzionalità bio-fisiologica che permette un armonico sviluppo della personalità
complessiva del giovane” (Milanesi, 1984, 452).
In particolare furono identificati tre livelli:
1. esposizione a comportamenti altrui presumibilmente dannosi alla salute del giovane;
2. situazioni in cui emergono sintomi di salute precaria nel soggetto;
3. comportamenti considerati gravemente dannosi per la salute del soggetto (Milanesi, 1984, 452).
Come fecero notare gli stessi autori, mancavano indicatori “riguardanti le abitudini alimentari, lo
uso controllato di medicinali, la presenza di malattie pregresse nella storia clinica dei famigliari o
del soggetto stesso, ecc.” (Milanesi, 1984, 453). Scelta dovuta a motivi pratici.
Questo tipo di rischio fu collegato, ipoteticamente ma ragionevolmente, con il rischio di
devianza, soprattutto con comportamenti e atteggiamenti che hanno a che fare con la salute
(tossicodipendenza e uso non sporadico di alcolici, alimentazione irregolare, ecc.).
C. Rischio consumistico
Il rischio consumistico venne collegato alle modalità di fruizione del tempo libero.
I1 concetto di rischio consumistico nasce dalla constatazione che una parte del campione interpreta
il tempo libero secondo una modalità di fruizione che implica un certo pericolo di svuotamento
delle opportunità di crescita personale e sociale (Milanesi, 1984, 458).
Prendendo come base la classica distinzione di Dumazedier (1978), si fece notare che il tempo
libero poteva avere sì valenze autorelizzative e promozionali, ma anche ludiche o compensative, e
queste ultime comportavano il rischio di una certa dicotomizzazione del tempo:
il tempo libero viene troppo spesso vissuto come tempo separato dal tempo "occupato", cioè dal
tempo "forte" del vissuto quotidiano (nel caso dei giovani dal tempo dedicato allo studio, al lavoro,
alla famiglia). Si tratta di una separatezza che implica anche una evidente contrapposizione; non è
raro infatti il caso che il tempo libero venga considerato dai giovani come il tempo "vero", quello in
cui è possibile costruire la propria identità (Milanesi, 1984, 458).
Ma spesso questa ipotesi si rivela illusoria, proprio perché il tempo "separato" non può offrire se
non uno spazio di libertà fittizia in cui c'è solo la possibilità di non essere nessuno più che quella di
essere qualcuno o in cui c'è solo l'astratta opportunità di fare tutto, che si tramuta nella vuota
eventualità di non fare nulla. Tutto questo perché i tempi "forti", quelli che dovrebbero assicurare
identità sono a loro volta attraversati da una pro fonda crisi di senso (Milanesi, 1984, 460).
Da questa dicotomia tra tempi e illusione libertaria nasce il rischio consumista, che
si configura quando il tempo libero, vissuto nella separatezza e nella contrapposizione rispetto al
tempo totale dell'esperienza quotidiana offre solo (e necessariamente) occasioni di divertimento e
relax che hanno lo scopo di reintegrare e omologare alla società dei consumi, secondo modelli che
sono appunto funzionali ad essa e da essa elaborati (Milanesi, 1984, 460).
La causa di tale rischio venne ricondotta dagli autori a situazioni di “frammentazione ed
emarginazione che colpisce molti giovani e diventa necessariamente un fattore che ne moltiplica gli
effetti negativi e prepara la strada alla devianza” (Milanesi, 1984, 460).
Fu fatto, a questo punto, un richiamo alla logica dei processi di socializzazione e di canalizzazione
coatta dei bisogni secondo modelli consumistici. In questa logica si annidava una pericolosa
tendenza, perché “il giovane è chiamato solo a consumare cultura, gioco, festa, relax e se fosse
possibile anche tutto lo spazio della sua socialità, senza mai essere stimolato a produrre tutto ciò in
forma più costruttiva” (Milanesi, 1984, 461).
Si aggiunse, in collegamento con le altre forme di rischio, che “probabilmente anche molti
comportamenti devianti (tossicodipendenza ed alcoolismo in primo luogo) rispondono alla stessa
logica emarginante e manipolante” (Milanesi, 1984, 461).
La scala di rischio consumistico teneva conto sostanzialmente di due dimensioni:
la dimensione individualistica del tempo libero (non aggregazione, solitudine);
la dimensione evasiva (frequenza a locali pubblici, mass-media, assenza di interessi culturali)
D. Rischio formativo
Questo tipo di rischio si verifica quando “il ragazzo vive il rapporto con le agenzie di formazione in
modo problematico, cioè sulla base di una generalizzata incertezza, sfiducia, incoerenza di
orientamenti” (Milanesi, 1984, 468).
Questa situazione stava ad indicare uno scollamento con le agenzie di formazione. Le agenzie
formative prese in considerazione furono la scuola e la famiglia. Infatti, gli indicatori utilizzati da
questa scala riguardavano:
atteggiamenti verso l’istituzione scolastica (ripetenze, concezione negativa della scuola);
atteggiamenti verso l’istituzione familiare (discrepanze valoriali, mancanza di sostegno).
1.2.1.1.3. I fattori di rischio
Nel tentativo di capire meglio il rischio giovanile, si cercò di individuare “i fattori di rischio”:
quegli elementi, cioè, che producono o favoriscono una situazione di rischio. La valutazione dei
“testimoni privilegiati” riguardava sia aspetti molto generici (concetto esteso di rischio) oppure altri
più specifici.
Per molti intervistati è da considerare fattore rischio, in termini più estesi, tutto ciò che ostacola la
crescita dei giovani, la loro maturazione individuale (maturazione intellettivo-conoscitiva, controllo
e stabilità emotiva, individuazione stabile e coerente di scopi e valori, ecc.) e sociale (adesione alle
"norme" del vivere civile, inserimento nel mondo del lavoro, assunzione di responsabilità al di là
della propria sfera individuale: famiglia di elezione, partecipazione alla vita politica e sociale).
In termini più specifici è considerato fattore rischio tutto ciò che conduce a forme più o meno
recenti di disadattamento e devianza (droga, prostituzione, delinquenza, antisocialità in genere -il
terrorismo non è stato citato-) (Ferrari, 1984, 509).
A. I fattori di rischio specificamente risultarono:
La crisi economica
Il modo di fare politica
La pluralità di modelli culturali
La crisi delle istituzioni educative: famiglia e scuola
Le cattive compagnie
Il luogo di residenza
L’età (14-16 anni)
La condizione femminile
B. In fase conclusiva, come riflessione del gruppo di studio, si sottolineò il fatto che il rischio aveva
“una rilevante componente esogena. Non nasce dal caso o dalla sfortuna: è prodotto” (Ringhini,
1984, 541). Le condizioni che favorivano l’esposizione al rischio furono individuate nei seguenti
elementi:
1. Frammentazione
Da intendersi come tendenza […] alla frantumazione della condizione giovanile in un variegato
mosaico di situazioni più difficilmente riconducibili ad omogeneità ed affinità. […]
Al primo livello si manifesta con la crisi dell'identità collettiva e la progressiva evanescenza di un
comune atteggiamento di ricerca per una legittimazione propria ed originale (cioè in quanto
"giovani") nel tessuto sociale; con il ripiegamento in esperienze micro (gruppi ristretti, informali,
circoscritti, ecc.) in cui elaborare un presente provvisorio, più immediatamente gratificante a livello
individuale, sostanzialmente di tipo a-progettuale.
A livello soggettivo si manifesta coree un'analoga frantumazione del proprio vissuto, arricchito e
impoverito ad un tempo, della pluralità di tempi, luoghi e situazioni presieduti dallo effimero e dal
"presentiamo" in cui è preponderante l'investimento emotivo su quello progettuale, a lungo
termine.
Le possibilità di sintesi sono rese più difficili e ancor più l'elaborazione di un futuro che appare
oggettivamente condizionato o, per altri aspetti, precostituito quasi coma un "prendere o lasciare" e
che alla fine consente ai giovani solo due vie d'uscita: l'integrazione o l'emarginazione (Ringhini,
1984, 541-542).
2. Marginalità
Esso è riconducibile ad un continuum di progressiva esclusione, provocato o indotto, dalle
opportunità di avvalersi di ruoli attivi, di decisionalità, di peso sociale, di acquisizioni culturali
appropriate alle situazioni di vita, di professionalità realmente spendibili, ecc.
Realisticamente essa minaccia potenzialmente tutti i giovani, ma agisce selettivamente esponendoli
diversamente a situazioni di "rischio" in rapporto alle loro oggettive e soggettive possibilità di
difesa di carattere culturale, familiare, economico, ambientale, ecc.
Le possibilità soggettive di reazione "alternativa", pur essendo teoricamente ipotizzabili a
determinate condizioni in realtà non date, sono di fatto poche.
Si sviluppano piuttosto atteggiamenti di tipo adattivo, e ancora più spesso, di rassegnazione e
passività, talvolta fino al punto da cambiare di segno ma non di significato, attraverso
l'elaborazione di subculture celebrative di un'emarginazione ormai irreversibile (Ringhini, 1984,
542-543).
Questi fenomeni non sono esclusivi dei giovani, ma fan parte del più ampio quadro sociale.
In una società complessa, come quella italiana, in cui la segmentazione appare sempre più come un
processo inarrestabile di frantumazione della struttura sociale e nei comportamenti individuali, in
cui la certificazione dei bisogni è per lo più indotta dai livelli di complessità ed eterogeneità di
gruppi e di singole persone, in cui rappresentarsi è un problema dal quale eludere, in cui elaborare
un futuro vuoi dire fare i conti con vecchie e nuove paure, ecc., dovrebbe essere
(provocatoriamente) più facile per ragioni se non altro "di necessità più di virtù", confrontarsi con
problemi che di fatto sono collettivi.
Alla disgregazione si contrappone invece la sicurezza individuale, alla ricerca l'abdicazione di
responsabilità connesse a funzioni comunque esercitate.
L'intento non vuole essere moralistico, ma cerca esclusivamente di trovare un filo conduttore tra i
diversi segmenti del corpo sociale, quali i giovani, gli adulti, gli anziani, le donne, ecc., che
sembrano celebrare per altre vie, la propria "autonomia", esaltando ma ad un tempo confermando,
la reciproca estraniazione che "rischia" di farsi incomunicabilità e solitudine, quando non già
prevaricazione (Ringhini, 1984, 544).
1.2.1.2. L’elaborazione del concetto di disagio in “il disagio giovanile” (1989)
Nel 1989 veniva pubblicata un’altra opera, “Il disagio giovanile: conoscere per prevenire”
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989), frutto di una ricerca promossa e condotta dalla Comunità dei
Giovani nella Circoscrizione Ovest della città di Verona, cui collaborarono per la parte scientifica
G. Milanesi e V. Pieroni dell’Istituto di Sociologia dell’UPS. Tale inchiesta aveva lo scopo di
individuare le cause del disagio giovanile, con lo scopo di prevenire “l’entrata di non pochi giovani
nel campo della devianza” (p. 15).
Quest’opera è importante perché introduce come categoria fondamentale per la
comprensione e spiegazione della condizione giovanile quella del disagio e lo collega sia i bisogni
che al rischio.
1.2.1.2.1. Definizione del disagio
Per disagio giovanile si intende una particolare situazione di vita in cui si manifestano sintomi di
sofferenza, disadattamento, frustrazione che portano scompiglio e squilibrio nel vissuto personale del
giovane e nella sua vita di relazione (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 31).
Tale situazione di disagio ha una componente soggettiva ed una oggettiva. Dal punto di vista
soggettivo esso dipende dalla frustrazione di alcuni bisogni, con conseguente sofferenza e
malessere.
Soggettivamente il disagio si manifesta, dunque, come un insieme di percezioni, emozioni e
sentimenti, valutazioni, bisogni e domande che denotano uno stato generale di insoddisfazione più
o meno profonda nei riguardi delle condizioni obiettive entro le quali il giovane è chiamato a
vivere ((Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 31).
A fronte una percezione prevalentemente istintiva del bisogno, non c’è, come corrispettivo, la
capacità delle istituzioni e della società a fornire dei criteri validi per la sua interpretazione e
soddisfazione. Pertanto, l’adolescente, lasciato da solo a definire bisogni e percorsi per soddisfarli,
sperimenta ben presto il disagio, cioè la distanza tra il desiderio e le reali possibilità di appagarlo.
Infatti, oltre alla componente soggettiva, il disagio ne ha una di oggettiva:
Oggettivamente il disagio ha le sue radici nella somma di inadempienze, ritardi, tradimenti,
incomprensioni di cui i giovani sono oggetto e che si sintetizzano nell'incapacità della società a
rispondere alle esigenze di crescita, di autorealizzazione e di inserimento dei giovani ((Milanesi Pieroni - Massella, 1989, 31).
Da queste espressioni il disagio risulta avere due cause:
a) una interna (il malessere del soggetto)
b) una esterna (la società).
Le situazioni di tipo oggettivo appaiono essere, in particolare:
1. povertà
2. abbandono
3. marginalità e frammentazione sociale
4. inadeguatezza degli adulti di fronte alle domande giovanili
5. crisi delle agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, associazioni)
6. crisi delle istituzioni (politiche, economiche, giuridiche)
1.2.1.2.2. La dinamica del disagio
A giudizio degli autori,
Le radici del disagio vanno cercate non tanto nelle difficoltà a trovar lavoro e ad integrarsi nella
società; vanno forse identificate nell'inadeguatezza degli atteggiamenti con cui gli adulti si
relazionano alle domande problematiche dei giovani, nell'obiettiva condizione di povertà e
abbandono di alcuni, di marginalità e di frammentarietà del vissuto di molti. Il disagio si nutre, in
sostanza, della diffusa crisi delle principali agenzie di socializzazione; quali la famiglia, la scuola,
la Chiesa, l'associazionismo giovanile.
Più ampiamente risulta incisiva nel disagio là crisi generale delle istituzioni (politiche,
economiche, giuridiche, ecc.) che provoca una situazione diffusa di anomia, cioè di scollamento tra
il sistema dei valori e il grado di sviluppo della società, di insufficiente regolazione generale del
comportamento sociale, di incerta canalizzazione dei bisogni verso mete socialmente accettabili. Di
qui la sensazione soggettiva di angoscia, sfiducia, e bloccaggio, proprio perchè ci si sente frustrati
nella domanda di cambiamento, di partecipazione, di responsaabilità (Milanesi - Pieroni - Massella,
1989, 41).
Il quadro sociale appena delineato provocherebbe una diffusa situazione di “anomia”, “cioè di
scollamento tra il sistema dei valori e il grado di sviluppo della società, di insufficiente regolazione
generale del comportamento sociale, di incerta canalizzazione dei bisogni verso mete socialmente
accettabili” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 41). Situazione già rilevata di E. Durkheim nel
passaggio da una società rurale e conservatrice ad una industriale e progressista. La situazione di
crisi generale dei valori e dei meccanismi sociali di regolazione del comportamento provoca a sua
volta incertezza negli individui che si traduce in un disagio generale.
I giovani percepirebbero la situazione di disagio con sentimenti di sfiducia verso la società e
angoscia nei riguardi del proprio futuro. Sentimenti che produrrebbero un “bloccaggio”, cioè un
senso di inadeguatezza e di incapacità ad esprimere totalmente se stessi, dando retta al proprio
desiderio di trasformazione della società, attraverso una partecipazione responsabile. In pratica gli
autori rileggono il cosiddetto “riflusso”, cioè la concentrazione sul privato e sul quotidiano, come
una tattica di ripiegamento dei giovani di fronte alla insensibilità sociale nei loro confronti.
Quindi, esisterebbe in teoria (o almeno nelle ipotesi) un vivo bisogno di autorealizzazione anche
sociale (partecipazione), ma questo sarebbe frustrato dai meccanismi sociali di esclusione e
immobilizzazione della domanda giovanile. Infatti l’ipotesi fondamentale della ricerca era così
formulata:
esiste nei giovani, compresi tra i 14 e i 18 anni, una condizione di precarietà che impedisce loro di
esprimersi completamente. Ciò dipende da una limitata presenza di valori personali, da limitati
punti di riferimento per una formazione personale, da ben definiti obiettivi personali e dalla
presenza di situazioni sfavorevoli nel contesto familiare (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 46).
1.2.1.2.3. I fattori di disagio
I meccanismi sociali i responsabili del disagio sarebbero:
1. l’irrilevanza sociale della condizioni giovanile;
2. la situazione generale di complessità sociale con il conseguente tentativo giovanile di
ridurla;
3. la mobilità sociale con il rimescolamento delle appartenenze;
4. la moltiplicazione e frantumazione delle appartenenze sociali e delle esperienze
collettive;
5. l’ingovernabilità dei sottosistemi (economico, politico e sociale);
6. la fragilità degli ancoraggi e della legittimazione dei valori;
7. la precarietà dei percorsi dell’identità e dell’autorealizzazione giovanile;
8. l’allungamento dell’età giovanile con aumento della discrepanza tra adolescenza
biopsicologica e adolescenza sociale (cfr. Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 32).
A queste condizioni generali della società, si aggiungono situazioni particolari di povertà e di
abbandono che aggravano la situazione personale o di alcune categorie, favorendo il ricorso a
soluzioni irrazionali ai loro problemi.
In questo gioco di responsabilità tra società e individuo, gli autori non mancano di far notare le
responsabilità anche dei giovani, che, se giustificabili da un verso perché “le radici della loro
inadeguatezza sono obiettivamente consistenti” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42), dall’altra
indulgono facilmente in soluzioni di comodo senza rendersi conto dell’obiettiva pericolosità di certi
comportamenti e ancor più atteggiamenti.
Pertanto gli autori sottolineano anche gli atteggiamenti che favoriscono una “caduta nel rischio”:
la rassegnazione alla mediocrità, cioè l'accettazione quasi fatalistica delle condizioni di marginalità,
frammentarietà, perdita di identità,
la rinuncia consapevole alla progettualità,
l'allergia per le proposte utopiche,
l'inerzia che caratterizza il lungo periodo di parcheggio nelle istituzioni formative,
la propensione verso l'effimero e il superficiale .
la tentazione di adagiarsi in un'ingenua semplificazione della realtà (Milanesi - Pieroni - Massella,
1989, 42).
Questi atteggiamenti, condivisi in misura variabile un po’ da tutti i giovani, minacciano la
qualità della loro vita, “proprio perché contengono i germi di una profonda crisi morale, impastata
di relativizzazione dell'etica, di gregarismo opportunista, di individualismo, di cinismo pragmatista”
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42).
Questa situazione non va accettata solo perché molto diffusa e perché la situazione appare
ingovernabile. Essa contiene degli elementi di rischio che superano l’episodicità di certi
comportamenti antisociali e pregiudicano il futuro stesso della società.
Se é vero che la società complessa evidenzia alti tassi di incomprensibilità e ingovernabilità, é
altrettanto vero che non é sufficiente una "riduzione" della complessità attraverso le scorciatoie
delle formule miracolistiche. Di fronte alla complessità pare del tutto ingenuo rifugiarsi nel mito
della "progettualità di basso profilo", della "gestione quotidiana della precarietà", o peggio ancora
nelle varie forme di integrismo teorico e pratico. Il volontarismo che é implicito in queste
semplificazioni pericolose della realtà non può infatti che sfociare nell'ideologia. Essa costituisce
un sicuro detonatore del rischio, nella misura in cui rappresenta una visione parziale della realtà,
fatta di pregiudizio e di limiti conoscitivi. Il ricorso all'ideologia, tipico dell'esperienza giovanile
degli anni '60 e '70, é sintomo di una certa allergia verso le meditazioni culturali pazienti e
complesse, che richiedono tempo e strumenti di analisi sofisticati e flessibili; é anche segno di una
crisi generale di sfiducia nella ragione scientifica, che del resto é logica nel quadro di diffusa
irrazionalità che abbiamo ipotizzato (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42-43).
Questo avviene perché l’ambiente è impegnato di una cultura “che premia gli atteggiamenti
nichilisti e che é satura di propensioni alla condanna, alla stigmatizzazione ed alla
colpevolizzazione dei giovani” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42). Questa cultura condiziona
il “filtro soggettivo” dei giovani, cioè il loro “modo personale di dare un significato al disagio e ai
suoi sbocchi” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42). Per questo motivo lo sbocco irrazionale
sembra loro quello più conveniente e desiderabile.
1.2.1.2.4. Rapporto tra rischio e disagio
Il ricorso a “soluzioni irrazionali” introduce la specificità del “rischio”, che in quest’opera viene
definito in forma complementare al disagio. Infatti, in quest’opera,
Per rischio intendiamo una situazione in cui, a causa della frustrazione, negazione mortificazione dei
bisogni fondamentali della persona (cioè a causa di una situazione di soggettivo ed obiettivo disagio),
il soggetto è portato a dare soluzioni irrazionali al bisogno fondamentale dell'esistenza (che quello
del senso, del significato esistenziale) e agli altri bisogni correlati (Milanesi - Pieroni - Massella,
1989, 31-32).
Il rischio quindi viene intimamente collegato al disagio, che comporta la frustrazione o
negazione dei bisogni. Il disagio costituisce la situazione di sfondo (= malessere, sofferenza),
mentre il rischio consiste nelle risposte che il soggetto tenta di dare alla situazione disagiata. Queste
soluzioni quando non sono orientate ad un progetto capace di soddisfare il bisogno fondamentale
dell’esistenza (quello di significato), diventa una risposta irrazionale. Essa viene precisata in questi
termini:
L'irrazionalità consiste nel fatto che le decisioni adottate si rivelano obiettivamente distruttive per
l'individuo e per la società e non avviano assolutamente a soluzione i problemi che la persona ha
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 32).
L’irrazionalità quindi è individuata nel comportamento distruttivo (per sé o per altri) e nella non
soluzione ai problemi personali. Questo tipo di comportamenti (irrazionali) carichi di auto ed eterodistruttività, verrebbero percepiti dai giovani come “la risposta conveniente, utile, desiderabile al
loro disagio, sottovalutando gli effetti personali e sociali delle proprie scelte comportamentali”
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42).
Tali tentativi, caratterizzati da una notevole carica distruttiva (auto o etero), si manifestano
sovente con comportamenti violenti, che, facilmente stigmatizzati dalla società, possono indurre ad
assumere un’identità negativa e così entrare nella spirale della devianza.
Pertanto il rischio, in quest’opera, è un aggravamento della situazione, già pericolante o
disagiata, che può evolvere, per una serie di cause concomitanti (endogene ed esogene) in
comportamenti “devianti” (auto o etero distruttivi). In effetti i comportamenti sono già devianti,
solo che per effetto della lezione dell’interazionismo simbolico (abbondantemente citato), si evita di
parlare di devianza tout court per evitare effetti perversi di “etichettamento” che favorirebbero il
consolidamento di una identità deviante (devianza secondaria). Anche la mancanza di progettualità
viene considerato un indicatore di rischio: è sintomatico dell’irrazionalità di base della persona.
1.2.1.2.5. Alternative alla “devianza”
Tuttavia si rifugge da una correlazioni meccanicistica tra queste condotte e l’esito deviante:
Il passaggio dalla situazione di rischio alla devianza, e in genere all'irrazionalità, non è mai
automatico; infatti, insieme ad una serie di "premesse" o "condizionamenti" negativi facilitanti,
agiscono sul soggetto "a rischio" forti spinte provenienti dall'ambiente che "giudicano", o
"colpevolizzano" o "stigmatizzano" il probabile deviante fino a rendergli "conveniente" l'adesione al
modello deviante. Vi è in tutto questo processo, che porta dal rischio alla devianza, un intrico
complesso di ragioni obiettive e soggettive che escludono in ogni caso una spiegazione
meccanicistica del processo stesso e rinviano a fattori di tipo intenzionale che fino ad ora sono stati
poco studiati (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 32).
Si sottolinea la “circolarità” del processo attraverso cui “si diventa devianti”: un processo in cui
intervengono sia fattori soggettivi che oggettivi, anche se si riconosce che quelli soggettivi,
soprattutto dipendenti dalle decisioni del soggetto, non sono stati ancora ben studiati. Invece sono
più facilmente rintracciabili i meccanismi sociali che contribuiscono all’identità deviante:
colpevolizzazione, stigmatizzazione, ecc., che possono indurre un soggetto, in particolari situazioni
di deprivazione, ad aderire ad un modello deviante (affiliazione). In ciò consisterebbe il “rischio di
devianza”.
Tra le condizioni obiettive, viene presa in esame la stessa situazione giovanile che appare
genericamente problematica. Ma tale situazione si configura più come disagio che come rischio.
Pertanto le condizioni sociali in cui versa la condizione giovanile diventano delle “premesse”,
perché il disagio recente, fin qui mantenuto sommerso e quasi privatizzato e neutralizzato entro
un'ampia gamma di comportamenti evasivi e compensativi di chiaro segno consumista, possa
esplodere in comportamenti devianti, carichi di significato eversivo o comunque di conflittualità
sociale (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42).
Ma questo non è l’unico esito possibile. I giovani potrebbero rappresentare una risorsa per la
società, purché valorizzati, invece che emarginati o vezzeggiati.
È possibile, infatti, ipotizzare la nascita di una nuova domanda di partecipazione-appartenenzaresponsabilità a partire dalla coscienza del rischio di marginalità, di una domanda di riflessività,
interiorità, personalizzazione a partire dalla coscienza della frammentarietà, di una domanda di
soddisfazione dei nuovi bisogni, a partire dalla coscienza di una identità espropriata ((Milanesi Pieroni - Massella, 1989, 44).
Per attuare questo è però necessario un atteggiamento diverso da parte della società adulta,
soprattutto se investita di compiti educativi o politici.
Si tratta di ipotesi la cui realizzazione è subordinata ad un'attenzione educativa intelligente e ad
un'operosità politica efficace da parte degli adulti ((Milanesi - Pieroni - Massella, 1989).
Ciò richiede:
La capacità di farsi carico di tutta la domanda educativa dei giovani, lo sforzo di rispondere ad essa
con una proposta il più possibile completa e esauriente, la preoccupazione di offrire una sintesi
operante tra educazione e socializzazione ((Milanesi - Pieroni - Massella, 1989).
Così la creatività giovanile potrebbe esprimersi in forme di protagonismo sociale, piuttosto che
di distruttività irrazionale.
1.2.2. Disagio come forma espressiva
Stando a quanto aveva evidenziato D. Matza4, la devianza può costituire una forma di
comunicazione. Così si può cogliere nel comportamento trasgressivo di un adolescenti un
messaggio, la segnalazione di un bisogno. Mentre un adulto ruba per accumulare ricchezza, la
stessa azione effettuata da un soggetto in età evolutiva potrebbe non avere questa funzione
strumentale ed essere ricollegabile a bisogni legati all’identità, alle relazioni (questo spiegherebbe
perché, sempre secondo l’autore, sono sempre più i bravi figli, di classe-bene, a compiere reati di un
certo spessore).
1.2.2.1. L’indagine del CENSIS5
Stando nell’ottica della devianza intesa come forma di comunicazione, questa
fenomenologia di comportamenti sembrerebbe esprimere da parte dei minori:
1. aggressività verso la società degli adulti, sentita come distante, poco disponibile
all’accoglienza e poco attenta alla loro condizione, dovuto alla mancanza di canali sociali di
espressione/accettazione della propria identità;
2. disorientamento individuale nell’interpretazione dei valori portanti;
avori.
4 Cfr. D. MATZA, Come si diventa devianti, Bologna, Il Mulino
1969.
5 CENSIS, o.c., in “Esperienze di rieducazione”, XXIX(1982), suppl. 2-3,
3. “resilienza”, ovvero lucida determinazione ad adottare comportamenti spericolati per
assecondare un esasperato bisogno di protagonismo/competitività fra compagni e nei
confronti del mondo adulto.
Porsi la domanda, nell’analizzare la devianza minorile, “quali azioni mentali hanno guidato
la scelta dell’azione?” e “quali effetti ha voluto ottenere/comunicare il soggetto attraverso l’azione
deviante?”, significa interrogarsi sulle ipotesi che hanno guidato il suo agire, organizzandolo
cognitivamente ed emozionalmente. “Scegliere la devianza come modalità d’azione” può
rappresentare un’adesione a modelli normativi condivisi nel sistema o nella microcultura di
appartenenza. Di conseguenza, vengono tentate spiegazioni della delinquenza minorile riferentesi
alle problematiche del sé, dell’identità, delle relazioni particolarmente significative e dei contesti di
controllo. Ciò permette, da una parte, di andare oltre i modelli tradizionali di interpretazione,
secondo cui la devianza era figlia di carenze (familiari, affettive, educative, economiche,
culturali…) o di patologie psichiatriche e, dall’altra, di ipotizzare che le azioni devianti producano
funzioni di mantenimento dell’organizzazione soggettiva, relazionale e di controllo: nell’interazione
con l’ambiente il deviante agisce per equilibrare l’organizzazione del proprio sé e della propria
identità con quella del “contesto significativo” di appartenenza.
Questa ricerca di equilibrio si avverte in particolar modo durante la fase del processo
evolutivo, quando il minore è particolarmente impegnato a cercare sempre nuove forme di
equilibrio, di (ri)organizzazione dell’immagine di sé in continua trasformazione, al fine di realizzare
articolate modalità di rapporto con il mondo adulto e le istituzioni. Quindi certi “strani”
comportamenti degli adolescenti in realtà rappresentano complesse forme di organizzazione del
proprio sé per comunicare. Sono funzionali al proprio sistema di interazione.
1.2.2.2. I “gruppi spettacolari”
L’elemento espressivo e comunicativo apparve nettamente in alcune forme di violenza che
caratterizzarono i giovani negli anni ‘80: i “gruppi spettacolari” (Caioli 1986) o “del disimpegno”
(Bajardi, Guglielminotti 1987).
Si trattava di Rockabillies, Mods, Punks, Darks, New-wavers, i cui elementi distintivi
sembravano fare riferimento ad un genere o personaggio musicale e all’abbigliamento (più avanti
nasceranno i “metallari”, le “madonnare”, i “paninari”, ecc.). Li accomunava la passione per la
musica e la voglia di amicizia, nulla più.
Alcuni di questi gruppi esibivano simboli, abbigliamento e gergo tipici dell’estrema destra.
Davano l’impressione d’essere violenti e d’alimentare progetti reazionari. In realtà non si trattava di
gruppi violenti, eccetto gli skinheads, che si sono segnalati per i raid razzisti (più in Germania che
in Italia). In ogni caso mancava loro una vera progettualità politica.
Un fenomeno che destò attenzione, ha sollecitato la fantasia degli osservatori e suscitato le
apprensioni di educatori e politici per le affinità con analoghi movimenti di provenienza
anglosassone, di cui sovente riprendevano i nomi e lo stile. Non sembra però possibile assimilarli,
se non per alcuni elementi folkloristici, con gli omonimi gruppi inglesi, nati in contesti socioculturali e storici ben diversi, che esprimevano, in modo molto più violento e provocatorio, il
malessere della gioventù inglese.
I gruppi nostrani si limitavano ad esprimere l’insofferenza ed il disagio di vivere in una
società che non li accoglieva, che non era adatta a loro. Una contestazione che aveva messo in
soffitta le rivendicazioni sessantottine, che non pensava a rovesciare il sistema, a elaborare
complicate analisi e controproposte politiche, che si limitava ad esprimere simbolicamente la
propria differenziazione, anche se il disagio non era necessariamente inferiore.
“Quando constatiamo che non è possibile cambiare, cerchiamo un altro obiettivo. Però gli obiettivi
sono sempre chiusi...” dirà uno di essi al mensile “Dimensioni Nuove” (Giordani 1984, 14).
La loro protesta ha avuto poca efficacia sul piano strutturale: addirittura sembrò, in alcuni
casi, dar l’idea di una “ultra-integrazione” di tipo consumista modellata sullo “yuppismo” di moda
in quegli anni. Benché non si possano includere tutti nelle stesse categorie interpretative, queste
forme di aggregazione giovanile avevano qualche tratto in comune che li avvicina all’area della
devianza ed erano un’espressione del disagio giovanile.
Il disagio principale che essi esprimevano, a giudizio di Carmen Leccardi e Anna Rita
Calabrò, era quello dell’identità (Caioli 1986). Un’identità sempre più difficile in un mondo che
cambiava rapidamente e non offriva più supporti validi per i percorsi di definizione dell’identità.
Quest’identità, non più ancorata a strutture sociali plausibili e condivise, cercava una sua via di
definizione attraverso l’appartenenza ad un piccolo gruppo, l’adesione ad uno stile, ad un genere
musicale, ad una moda, ecc. Un’identità “spettacolare”, appunto, fatta apposta per sorprendere, per
stupire. Un’identità negativa, nel senso inteso da Erikson, che si afferma rendendo esplicita,
manifesta la propria diversità. Differenziazione che fa parte delle strategie di definizione
dell’identità6.
Diversità manifestata attraverso il simbolismo, l’apparenza7. Simbolismo che costringeva a
prendere posizione, che provocava, che non si prestava a mezze misure, “o sei con noi, o sei
contro”, che rifiutava i compromessi. D’altra parte era una diversità elaborata dal gruppo,
“portatore di un’identità collettiva che allevia e satura le incertezze legate alla definizione
dell’identità personale” (Leccardi 1986, 214). Cosicché lo spazio-tempo dove gestire questa identità
spettacolare era il tempo libero e lo spazio aperto della metropoli.
In casa il comportamento di questi soggetti era probabilmente molto meno anticonformista,
se non addirittura completamente integrato. Sembra esistesse tra i due momenti non solo autonomia,
ma addirittura una “sostanziale impermeabilità” (Leccardi 1986, 206). Anche se sul momento di
gruppo aveva una rilevanza tutta particolare, non è detto che, in realtà, fosse più importante di
quello familiare.
1.2.2.2.1. Destrutturazione temporale (Cavalli 1985)
Il problema dell’identità balzò alla ribalta anche in un’altra ricerca che aveva come tema i
cambiamenti della dimensione temporale dei giovani. Tale dimensione fu studiata su un certo
numero di giovani milanesi dai 18 ai 25 anni agli inizi del decennio ‘80 (autunno ‘80 - primavera
‘81) da un’equipe di ricercatori coordinata da Alessandro Cavalli, per conto della IARD.
L’inchiesta aveva lo scopo di appurare se stesse emergendo una “sindrome di destrutturazione
temporale”
“leggibile in termini di assenza o di frammentazione di memoria storica, labilità dell’orizzonte
temporale dei progetti che coinvolgono la definizione dell’identità personale, assenza di criteri
relativamente persistenti di allocazione del tempo quotidiano” (Cavalli 1985, 39-40).
La ricerca era stata condotta con il metodo delle “storie di vita” in quanto tentava di scoprire
non tanto le “cause” di tale destrutturazione, ma piuttosto “come” essa era vissuta dai giovani.
L’indagine aveva preso le mosse da una serie di osservazioni, compiute anche da altri sociologi 8,
che avevano rilevato significativi mutamenti tra i giovani del modo di percepire e vivere la
dimensione temporale. Ma tale mutamento veniva letto come segno di mutamenti profondi, sia nei
giovani che nella società, e, quindi, dei processi di socializzazione. Di fronte all’allentamento del
rapporto con la società, all’espansione del tempo a disposizione degli individui ne conseguiva una
minor incidenza del tempo sociale sulla formazione dell’identità9. L’attenzione si stava spostando
p. 45.
6 “I giovani si sono trovati costretti ad elaborare nuove strategie di definizione dell’identità operando una selezione tra le diverse
risorse messe a loro disposizione da una società che sembra spingere in direzione dell’anonimità e del conformismo e nella quale
l’appello alla differenza ha un significato dirompente sulla logica dominante” (Calabrò 1986
291)
7 “L’abbigliamento, come è noto è un medium comunicativo di grande efficacia simbolica” (Leccardi 1986
211).
8 Cfr., per es., A. Melucci, L’invenzione del presente (1982), N. Luhmann, The Future Can Not Begin (1976) e P. Berger, The
Homeless Mind (1977). Bisogna tener conto anche di alcune ricerche condotte in quegli anni in Italia, che avevano già rilevato segni
del fenomeno (cfr. Scotti M., Inchiesta sull’avvenire dei giovani, Milano, IULM, 1983; Giuliano L., M. Lepore, Progettualità
personale e progettualità sociale, Convegno AIS, Trento,
985).
dalle grandi prospettive ideali di una certa utopia che aveva catturato le attenzioni dei giovani del
‘68, al quotidiano che diventava, a questo punto, insieme con il presente, il vero senso del tempo.
Alla progettazione a medio-lungo termine, personale e collettiva, si stavano sostituendo percorsi
progettuali a breve e brevissimo termine.
La ricerca riscontrò, di fatto, un certo numero di disturbi della percezione temporale, leggibile
nei termini di una “confusione temporale” e di riluttanza ad abbandonare lo stato di moratoria in cui
l’adolescente era relegato dalla società, ma che gli faceva anche comodo, fino a diagnosticare lo
stato di “destrutturazione temporale”,
“caratterizzata da una forte frammentazione e labilità della memoria storica; da una contrazione
dell’orizzonte temporale dei progetti; dall’assenza di criteri stabili di allocazione del tempo
quotidiano” (Leccardi 1987, 10; cfr. anche Cavalli 1984, 39-40).
La ricerca confermò essere in atto nelle giovani generazioni una loro ridefinizione nei confronti
del tempo, storico e sociale, con evidente enfatizzazione della dimensione del presente e perdita di
spessore storico e di capacità progettuale. Ciò che risultava evidente era il marcato soggettivismo
che contraddistingueva l’uso e il modo di intendere il tempo.
“L’importante non é ciò che si fa [...] ma come interiormente ci si sente, come si vive il tempo: in
altre parole, se il rapporto con se stessi é positivo, anche quello con il tempo necessariamente lo
sarà” (Leccardi 1985, 506).
Questo fenomeno sarebbe stato conseguenza, secondo gli autori, di varie concause, più o meno
riconducibili ad un quadro sociale assai complesso ed in rapida trasformazione che allontana
sempre più dal rapporto con il passato e con le radici storiche del proprio gruppo sociale. La perdita
della memoria storica sarebbe causata dalle accelerazioni continue al cambiamento, dai meccanismi
della storia sempre meno intelleggibili, dalla lontananza della politica, dall’avvento della società di
massa, dall’influenza dei mass-media con effetti di “semplificazione, manicheizzazione,
attualizzazione”10. Ma anche dalla obsolescenza della filosofie della storia e particolarmente dalla
crisi del mito del progresso e della concezione del tempo della società moderna
Infine la scarsa prevedibilità del futuro, più incerto, minaccioso, senza prospettive contribuirebbe
alla perdita della capacità progettuale. Sarebbero gli stessi meccanismi sociali caratterizzati da poca
chiarezza e scarsa prevedibilità ad alimentare in maniera determinante tale fenomeno. Così il
presente diventava l’unica dimensione sperimentabile. Ci si concentra su l presente per esorcizzare
l’ansia che il futuro riserva e per l’impossibilità di stabilire una continuità logica tra passato
presente e futuro11.
1.2.3. La fuga dalla vita: tossicodipendenza e suicidio
Il fenomeno droga sembra essere diventato il "fenomeno" per eccellenza degli anni '80. Non più
assunta come alternativa o protesta al potere, bensi come sostitutiva di un "vuoto" interiore, di una
capacità di affrontare i compiti di sviluppo e di inserimento sociale. Il problema ha assunto
proporzioni allarmanti, tali da indurre i governanti a trovare dei correttivi adeguati, almeno a livello
di legge. Il fenomeno si complica perché ad esso si associa anche la diffusione dell'AIDS.
9 “L’ipotesi […] è che laddove sono più labili i legami istituzionali prevalgono condizioni favorevoli all’insorgere della sindrome
di destrutturazione temporale” (Cavalli 198
, 40).
10 - “L’informazione dei mass-media opera nei confronti della complessità sociale e della storia quegli stessi processi di riduzione
che hanno luogo in occasione della divulgazione, televisiva e cinematografica, delle grandi opere letterarie: semplificazione,
manicheizzazione, attualizzazione. [...] Il giornalismo di informazione resta, secondo Gabel, prigioniero dell’attualità e condiziona la
coscienza collettiva nel senso di non attribuire valore al modo con cui sono maturati gli avvenimenti, al contesto storico che li ha resi
possibili. [...] L’informazione di massa, svalorizzando il passato e sorvolando sul futuro, colloca il suo fruitore fuori dalla storia, fuori
da ogni legame continuo con lo stato, la società, i problemi collettivi” (Tabboni 1985,
2-73).
11 - “Così il presente può diventare il limite della riflessione storica, un limite che è meglio non superare per evitare l’ansia, dato
che non esistono strumenti per controllare il futuro e stabilire una sua coerenza col passato” (Tabboni 1985, 13
Se il fenomeno non è molto diffuso tra i minorenni, non per questo diminuisce la gravità della
situazione. "E' nella fascia d'età tra i 15-18 anni che si affermano le prime esperienze di assunzione
di stupefacenti, esperienze che in questa fase rimangono ancora sul piano episodico e che negli anni
successivi possono comportare un maggior coinvolgimento del giovane nella tossicodipendenza.
[...] Tra i più giovani sembra diffondersi sempre più la tendenza ad usare pscicofarmaci, anfetamine
ed altre sostanze facilmente reperibili e di basso costo. Essi tendono ad usare droghe leggere, come
prima esperienza e con l'idea che non diano assuefazione" (Faccioli 1989, 420). Sembra invece che,
nonostante la conclamata non interdipendenza tra droghe leggere e droghe pesanti, per molti questo
si traduca in un primo passo verso l'assunzione di sostanze più forti.
Sussiste comunque una forma di disagio diffusa che non è certo facile identificare ma che trova
espressione in mille forme. Troppo spesso questo tipo di malessere esistenziale viene portato alle
estreme conseguenze.
Una delle tendenze più significative e preoccupanti di questi ultimi anni è il ricorso al suicidio. Pur
essendo un fenomeno in diminuzione (Faccioli 1989, 423), stupiscono alcuni casi ecclatanti di
sucicido e le motivazione: una bocciatura, un rimprovero o un permesso con accordato. "Segno
evidente di una incapacità a difendersi, da parte di molti teen-agers, dalle frustrazioni anche piccole,
che il vivere contemporaneo comporta. Micro-traumi ingigantiti dall'età tradizionalmente
delicatissima dell'adolescenza e da un bisogno di sensazioni forti e totalizzanti sempre più difficili
da reperirsi nel tran-tran massificante del quotidiano" (Coriasco 1988, 185).
In ogni caso, da parecchie parti viene sottolineato che la caduta di tensione ideale e l'incapacità di
tradurre la protesta in azioni coerenti ed efficaci sia uno degli elementi che meglio spiegano il
diffondersi progressivo del disagio giovanile. Esso si incanala a volte in forme violente distruttive
della società, altre volte (forse le più) in forme autopunitive ed autodistruttive.
tra i giovani
1.3. Le forme della devianza giovanili
Un primo studio per delineare una mappa quali-quantitativa delle varie e più comuni forme
di devianza minorile fu fatto dal CENSIS (1982-83). Secondo questa indagine, i comportamenti
fuori legge più frequenti e diffusi nell’area adolescenziale, riguardavano: forme e modi diversi di
vandalismo, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la
persona (fra i quali i più frequenti legati alla sessualità).
1.3.1. Tossicodipendenza ed alcolismo
La tendenza ad una emarginazione nella sfera del privato è rilevabile anche dalla crescita del
numero di giovani che assumevano sostanze stupefacenti o alcolici. L’indagine Censis evidenzia
come si fosse passati attraverso tre fasi nella diffusione ed uso delle sostanze stupefacenti; nei primi
anni settanta si trattava di un fenomeno di minoranza, legato a giovani che, con la droga, volevano
rompere completamente con il mondo degli adulti; una seconda fase, verso la metà degli anni
settanta, era stata caratterizzata da un uso della droga in gruppi amicali, in aggregazioni giovanili
che ricercavano gratificazione, sicurezza, solidarietà, significati; la terza fase, quella degli ani ‘80,
era caratterizzata da una diffusione a macchia d'olio della droga, da un abbassamento dell' età dei
tossicodipendenti e da una minore carica contestataria nei confronti del mondo degli adulti (13).
La maggior parte dei giovani era esposta al problema della droga e non solo in modo mediato,
attraverso i mass-media (14).
Secondo gli operatori intervistati dal Censis si dovevano tener presenti alcuni fattori che
determinano l'assunzione di stupefacenti; le crisi della convivenza familiare, l'insicurezza circa il
futuro e la mancanza di prospettive, la crisi antropologica legata alla perdita di credibilità di alcuni
valori e mancanza di valori sostitutivi (15).
Se il problema droga è abbastanza studiato, l' alcolismo non ha mai attirato l'attenzione del
pubblico e dei mass-media: probabilmente sono troppi gli interessi economici, generalmente leciti,
legati alla produzione, commercio e consumo di bevande alcoliche. E' certo che è in aumento
l'alcolismo tra i giovani (16), ma si nota poca sensibilità per tale problema: non si fa niente per la
prevenzione e pochissimo per la cura, non risulta, fino ad oggi, che in Italia esistano centri
specializzati per la cura degli alcolisti.
1.3.1.1. Fattori della tossicodipendenza.
Le difficoltà in ambito familiare e, più in generale, le carenze affettive sarebbero tra i fattori
principali del ricorso alla droga.
In una ricerca della seconda metà degli anni ’80 venivano indicati i seguenti “fattori di rischio”
per la tossicodipendenza (cfr. Merlo 1988):
a) Fattori predisponenti (nel periodo dell’infanzia)
- perdita genitori
- paura o speranza di perdere i genitori
- clima familiare insoddisfacente
- sentimento di non essere accolti
- depressione genitori
- etilismo genitori
b) Fattori favorenti (durante la crisi adolescenziale)
- non sentirsi accolti, capiti
- fuga da casa
- caduta drammatica di ideali o di persone di riferimento
c) Indicatori preditori
- influenza del gruppo dei pari
- interruzione scolastica
- aver pensato di rivolgersi allo psicologo
- aver tentato il suicidio prima dei 18 anni
d) Fattori precipitanti: successo in presenza degli altri fattori
- curiosità
- iniziazione
- mercato
Questi dati stanno ad indicare che alla base del ricorso alla droga c’è sovente una cattiva
socializzazione e molto probabilmente problemi affettivi e di adattamento non risolti, di cui la
famiglia sarebbe il punto di snodo decisivo.
1.3.2. La violenza giovanile
Una ricerca sulla violenza giovanile è stata condotta dal Labos (1988) su vari gruppi e realtà
giovanili contigui alla violenza (gruppi a rischio, gruppi di tifosi, gruppi informali, gruppi di
studenti, ecc.). Tale ricerca rappresenta forse il tentativo più compiuto di analisi sistematica della
violenza in Italia. Per quanto non abbia analizzato tutte le forme di violenza (per esempio quella
criminale), essa ha indagato fenomeni emergenti nel campo della devianza e violenza giovanile.
Rispetto alle teorie classiche, il dato che balza agli occhi è la circolarità o interattività dei processi
che conducono alla violenza. L’ipotesi classica, che la violenza abbia una base bio-psichica, cui i
fattori ambientali farebbero da elemento scatenante, viene ridimensionata da questa ricerca. Ci può
essere alla base anche qualche elemento psicologico (personalità irritabile, che ha subito violenza,
con un locus of control esterno, tendente quindi alla ruminazione) ma essa appare molto più
riconducibile a processi di apprendimento, ai meccanismi adattivi e alla dinamiche comunicative,
intra e inter gruppo. Infatti i vari spezzoni della ricerca tendono a ricondurre la genesi del
comportamento violento alle interazioni tra i soggetti e il micro-ambiente, che risulta capace di
spiegare meglio di ogni altro fattore il ricorso alla violenza. Sovente è la violenza subita che diventa
la forma di apprendimento per un comportamento violento. Oppure il clima intriso di violenza in
cui si è vissuti; o le dinamiche di gruppo (ad intra o ad extra). In ogni caso la violenza appare
collegata a dinamiche “normali” senza bisogno di far riferimento a precise patologie personali o
sociali.
Un altro elemento nuovo di questa ricerca è la scomparsa della violenza politica come “reazione
alla violenza del sistema, alla violenza cioè impersonale attribuibile alle strutture sociali, alle
istituzioni, alle forme organizzate della vita sociale, economica, politica” (Labos 1988, 299).
Il modello esplicativo prevalente che emerge dalla ricerca è quello che
spiega diverse forme di violenza giovanile […] come tentativi (inadeguati) di colmare il divario
esistente tra complessità sociale (che prende il volto della società ostile e chiusa) e le ridotte
opportunità individuali e con cui molti giovani devono fare i conti quando si pongono il problema
delle proprie identità e dell'inserimento sociale (Labos 1988, 300).
Pertanto la violenza agita dai giovani di questi anni appare una violenza di tipo espressivo,
utilizzata al fine di manifestare il proprio disagio.
La violenza assume nei diversi campioni una funzione prevalentemente espressiva; diventa
strumento di comunicazione del disagio e allo stesso tempo manifestazione del bisogno di
protagonismo frustrato in diversi modi dalla società e dai micro-ambienti con cui si hanno rapporti
difficili (Labos 1988, 300).
Per questo sua caratteristica fondamentalmente espressiva e simbolica, la violenza giovanile ha
bisogno di accentuare l’elemento spettacolare.
La violenza ha bisogno di un «palco», di una «cassa di risonanza», di un «pubblico»; i veri
destinatari non sono sempre coloro che materialmente subiscono la violenza fisica, ma la più vasta
«audience» sociale che non sembra degnare di attenzione i giovani e i loro problemi (Labos 1988,
3001).
Da questo punto di vista questo tipo di violenza non viene presa molto in considerazione, sia
dalle forze politiche che dall’opinione pubblica, perché s’accorgono che “essa spesso si esaurisce
quando abbia raggiunto il suo scopo dimostrativo” (Labos 1988, 301).
Allo stesso tempo la spettacolarità di certe manifestazioni violente instaura processi circolari di
apprensione sociale, di sopravvalutazione della violenza stessa, di scoperta emotività dell'opinione
pubblica di fronte alle ipotesi di conflittualità sociale presumibilmente ingovernabile.
Infine va sottolineato il fatto che la spettacolarità ha anche una funzione di auto-securizzazione
nei riguardi degli attori stessi della violenza:
quanto più la violenza è dimostrativa tanto più l'attore si convince del proprio potere di
comunicazione, di persuasione e di attivo condizionamento dell'ambiente, l'impressione di un facile
superamento dell'angoscia da impotenza (Labos 1988, 301).
I bersagli di tale violenza sono, in ordine: le persone, la cosa pubblica, le istituzioni, le forze
dell’ordine, i cittadini, la proprietà, ecc. E’ più riprovevole se fatta contro le persone, soprattutto se
inermi, anche se non mancano giovani che approfittano di queste persone. Invece appare più
giustificabile, ai loro occhi, se fatta contro le istituzioni, contro i gruppi “altri” o “ostili”, contro
persone singole percepite come disturbanti il “codice” distintivo della comunicazione intergruppo.
La violenza negli stadi è considerata la meno grave e meno pericolosa. C’è comunque una certa
tendenza a sminuire la gravità dell’azione violenta da parte di chi ne è attore.
Sono anche interessanti le attenuanti addotte per legittimare l’uso della violenza.
Un'attenuante comunemente citata è la difesa della propria incolumità fisica o di quella delle
persone più vicine (familiari, amici); segue con molto rilievo, in più di un'inchiesta, il motivo della
difesa del gruppo, della sua immagine, della sua identità; infine come attenuante importante
emerge, nel giudizio che danno sportivi, ragazzi a rischio e giovani dei gruppi d'interazione la
provocazione altrui (spesso esagerata intenzionalmente per creare un alibi al proprio
comportamento). Lo stato di eccitazione (variamente motivato) è addotto come attenuante dai giovani a rischio, ma è poco valutato dagli altri gruppi (Labos 1988, 314).
Questo modo di giustificare la violenza è legato soprattutto
all'attribuzione di una funzione espressiva/dimostrativa, che accumula valenze reattive e difensive
nei riguardi di situazioni difficili e contraddittorie, se non proprio nei confronti di una situazione
obiettivamente ostile e minacciosa. Questo modo di sottovalutare la propria violenza (agita o
prevista) sembra confortare l'ipotesi secondo cui la violenza giovanile non è oggi principalmente
connessa alla frustrazione di bisogni molto specifici o alla presenza di situazioni particolarmente
punitive nei riguardi dei giovani; si tratta invece di una possibile reazione inadeguata ad una
condizione generalizzata di disagio complessivo e indistinto che è soprattutto percepito come
incapacità di governare la complessità e la contraddizione della vita quotidiana (Labos 1988, 314).
Rispetto agli attori della violenza, scrivevamo poco fa che questa appare come una violenza
“normale” quindi difficile da identificare in certi target sociologici, come quando si parlava della
devianza classica. Essa appare sempre più una violenza frutto del disadattamento a vivere in una
società che non lascia spazio ai giovani e non si cura le sue esigenze. Infatti
il giovane presumibilmente violento è un maschio, caratterizzato da maggiore irritabilità e
ruminazione (introversione?), incline ad attribuire a cause esterne il senso dei propri accadimenti
personali, preoccupato della propria immagine-identità e globalmente più coinvolto nel disagio
socioeconomico-culturale (bassa scolarità, basso reddito familiare, alta esposizione alla violenza
subita, bassa estrazione sociale, ecc.) (Labos 1988, 304).
Da un’altra parte si aggiunge che questi giovani sono:
poco scolarizzati (in gran parte sono drop-outs) vengono da famiglie sradicate (ex-emigranti, di
origine contadina, dal Sud) e in genere anche incapaci di offrire una comunicazione educativa
soddisfacente. […] Hanno a disposizione un eccesso di tempo da spendere in forme estese (e non
intense) di comunicazione; sono infatti ragazzi che in generale né studiano né lavorano (Labos
1988, 305).
Pertanto, se è il “disagio della civiltà” a costituire il dato comune e forse anche l’eziologia della
violenza giovanile, almeno come comportamento, certamente il disagio socio-economico costituisce
un elemento aggravante e più frequente nelle persone con tratti violenti. La ricerca condotta a
Torino sui “gruppi a rischio”, curata da F. Garelli, ha evidenziato nel giovane con i tratti del
“deviante” il fatto
che respira la cultura della violenza nella vita quotidiana; l'indagine sembra sottolineare soprattutto
l'avvenuta interiorizzazione di certi tratti culturali che allo stesso tempo sono connotazioni
permanenti della personalità del giovane a rischio: un atteggiamento generalizzato di diffidenza e
di difesa contro tutto e tutti, una facile disponibilità alla reazione e alla ritorsione, la tendenza a
caricare ogni comportamento con il bisogno dell'autoaffermazione ad ogni costo, come rivalsa
contro la vita precaria (Labos 1988, 305).
Questo tipo di giovane appare particolarmente carente di cure parentali e con scarsa socializzazione,
colpito inoltre da «deprivazione relativa».(De Leo in Dipartimento di giustizia minorile 2001, 3637).
1.3.3. La violenza negli stadi
Un altro fenomeno tipico di questi anni è la violenza negli stadi, in cui gli adolescenti sono una
componente significativa, anche se non esclusiva. Questo fenomeno va compreso all’interno della
funzione che ha lo sport nella società contemporanea e, nello stesso tempo, nelle possibilità che
offre un’aggregazione di massa come il tifo sportivo organizzato.
La ricerca del Labos (1988) sulla violenza ha svolto anche un’indagine su gruppi di tifosi in tre
città rappresentative di altrettante situazioni socio-culturali italiane. Essa ha concluso che il
successo dello sport si gioca nella triade di “uguaglianza, successo individuale all’interno di una
logica collettiva (il gruppo), e visibilità” (Labos 1988, 215). Gli adolescenti che sono impegnati
nella ricerca di soluzione al problema dell’identità, individuale e sociale, trovano nell’aggregazione
sportiva una rappresentazione simbolica di valori e modelli di comportamento che possono
sembrare una risposta al problema dell’identità. Un’identità che si compone anche di un elemento
aggressivo, di cui lo sport, ed il calcio in particolare, è assai ricco.
L’inserimento in un gruppo che accetta nuove presenze senza difficoltà, perché la partecipazione
è prevalentemente di esclusivo tipo fisico e corale; l’assunzione di un ruolo che può essere
considerato quello di un adulto in chi è tutto proteso a bruciare le tappe e ad uscire da una
condizione di forte ambiguità come quella adolescenziale; la sicurezza della impunità che consente
di agire senza timori (e che si sia non punibile è presto trasmesso al ragazzo attraverso il «tamtam»
tra coetanei); la possibilità di nobilitare la guerriglia attraverso l’autoconvincimento che si serve una
fede e si esprime un amore per una realtà che assume quasi connotati metafisici (una squadra, una
bandiera, una maglia); tutto ciò immette il ragazzo - alla ricerca non solo di una identità, di un
ambiente e di un ruolo, ma a anche di una valorizzazione personale stemperata nel collettivo - in un
sistema di violenza, e in realtà in una subcultura deviante, che può profondamente segnare tutta una
esistenza.
Tuttavia, la citata ricerca, afferma che, a parte la spettacolarizzazione della violenza, favorita
certo dai rituali del calcio, per il resto la violenza non è provocata dallo sport, ma è dentro la
società.
Lo sport è un'espressione ritualizzata ed istituzionalizzata dell'aggressività, migliore, per es., della
guerra o di altre forme di violenza sistematica, come una modalità di risoluzione del surplus
aggressivo. Come hanno fatto rilevare Storr e tutti i sociologi e psicanalisti che si sono interessati al
problema dell'aggressività, il pericolo per la società non sta nell'aggressività in sé - peraltro preziosa
alla dinamica psico-biologica - ma nelle forme della sua canalizzazione e repressione,
nell'incapacità di integrarla positivamente nella propria vita in qualche forma rituale e creativa. Lo
sport ha inconsapevolmente la grande funzione sociale di valvola di sfogo e scarica ritualizzata
dell'aggressività, simile al gioco ed alla sfida incruenta presente nelle società animali, in cui
l'aggressione tra individui della stessa specie è rarissima.
Secondo Braudillard, la violenza negli stadi rappresenterebbe
un’esaperazione della partecipazione agli avvenimenti, in una logica di assenza di reali
avvenimenti e di indifferenza generalizzata. La violenza negli stadi […] rappresenterebbe dunque
uno dei disperati tentativi dei giovani di partecipare – senza cogliere compitamente le coordinate e
gli spazi del loro agire – a fatti collettivi di una società che scoraggia, devia, esclude, illude e
allontana dalla reale comprensione del senso generale e specifico dell’agire sociale e che rifugge da
ogni conflitto e ad ogni dialettica (Labos 1988, 219).
II tifoso vive la stessa situazione del protagonista, ne condivide le emozioni e le sensazioni, vive
e si proietta in lui, nell'agire di lui identifica le proprie aspirazioni, si gratifica e si compensa di
quanto la realtà quotidiana gli vieta. Vivere fortemente tali emozioni avrebbe una funzione
catartica: permette al soggetto di esternare le sue contraddizioni, di far esplodere l’aggressività che
ha dentro in modo sostanzialmente rituale e simbolico. Un modo quindi di esprimere l’aggressività
e le tensioni non molto diverso da quello dei “gruppi spettacolari”, cui tra l’altro si avvicinano
anche per il ricco apparato scenico di cui la partecipazione alle partite di calcio si colora (sciarpe,
bandiere, colori, scritte, fumogeni, slogan, suoni, ecc.).
Il calcio è dunque uno spettacolo che suggerisce una logica di battaglia, rafforza l’appartenenza di
gruppo, stimola atteggiamenti di arrogante sicurezza nei confronti degli avversari: tutte
caratteristiche che trovano terreno estremamente favorevole nei giovani che attraversano un
processo di acquisizione e consolidamento dell’identità individuale e sociale, cui si addice il rischio
e l’exploit. Ma […] gran parte di questo potenziale di violenza si stempera in forme di rituale
aggressivo (Labos 1988, 217).