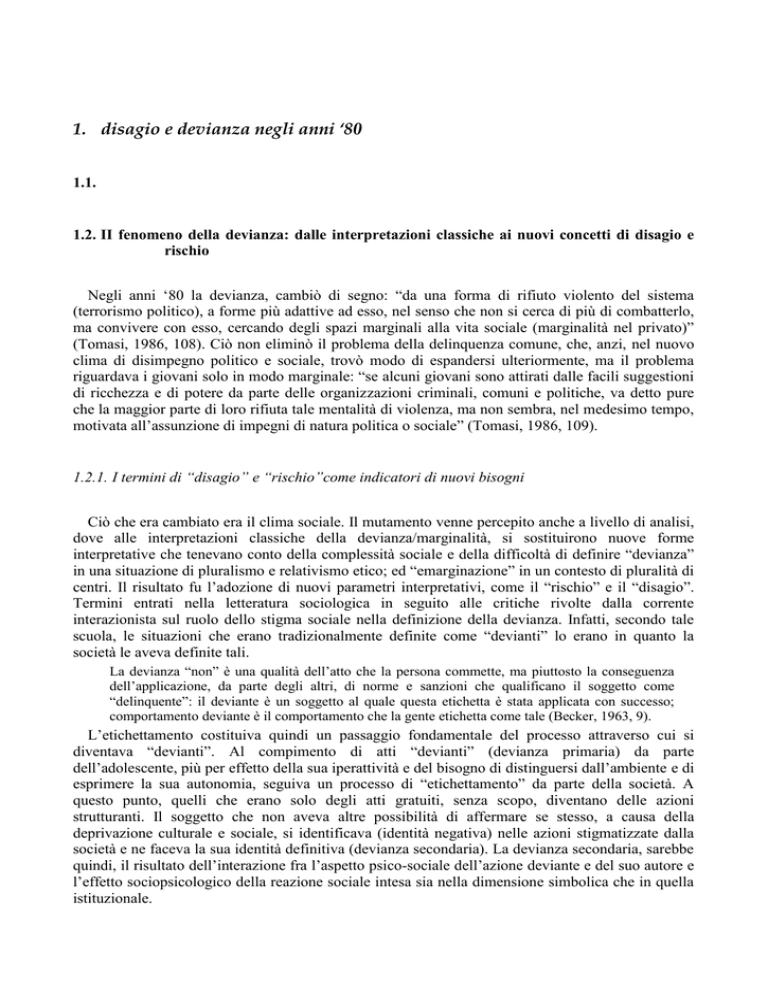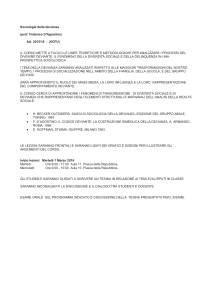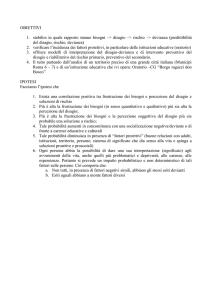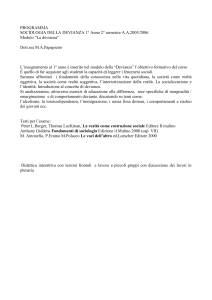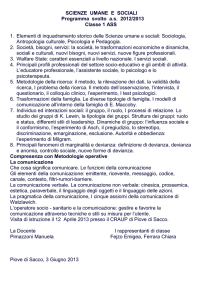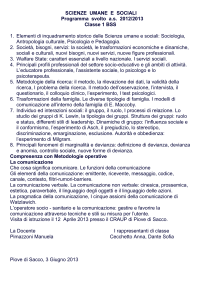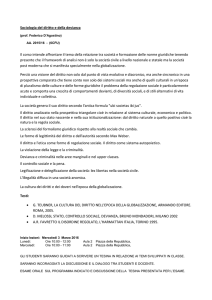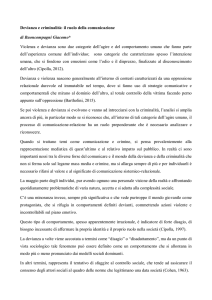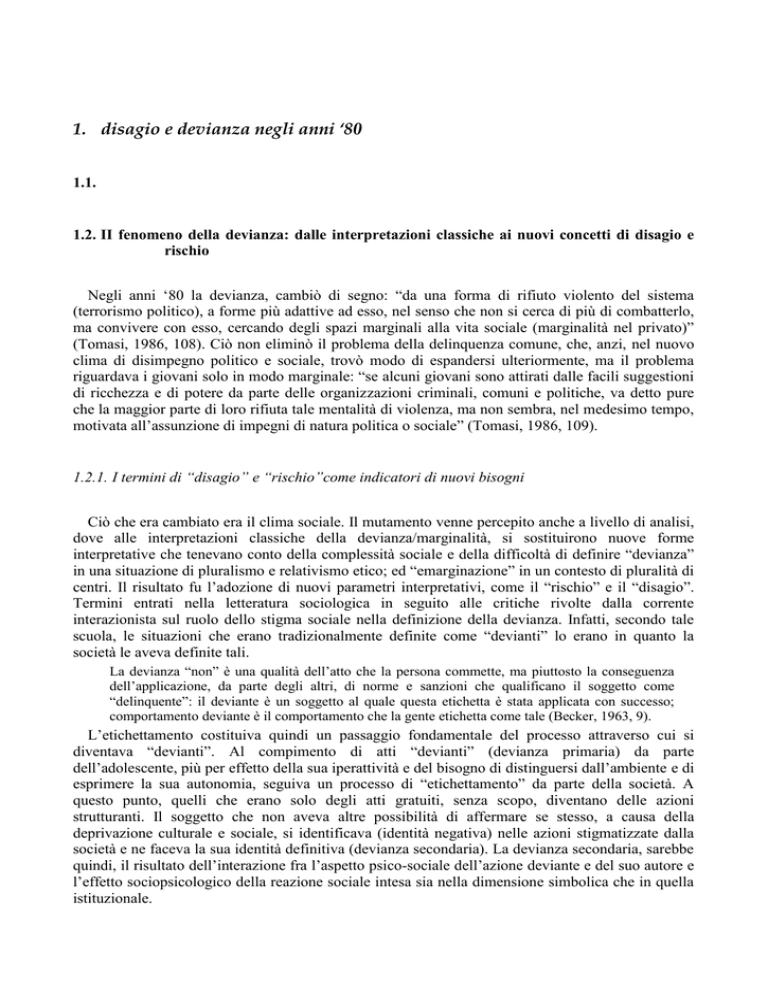
1. disagio e devianza negli anni ‘80
1.1.
1.2. II fenomeno della devianza: dalle interpretazioni classiche ai nuovi concetti di disagio e
rischio
Negli anni ‘80 la devianza, cambiò di segno: “da una forma di rifiuto violento del sistema
(terrorismo politico), a forme più adattive ad esso, nel senso che non si cerca di più di combatterlo,
ma convivere con esso, cercando degli spazi marginali alla vita sociale (marginalità nel privato)”
(Tomasi, 1986, 108). Ciò non eliminò il problema della delinquenza comune, che, anzi, nel nuovo
clima di disimpegno politico e sociale, trovò modo di espandersi ulteriormente, ma il problema
riguardava i giovani solo in modo marginale: “se alcuni giovani sono attirati dalle facili suggestioni
di ricchezza e di potere da parte delle organizzazioni criminali, comuni e politiche, va detto pure
che la maggior parte di loro rifiuta tale mentalità di violenza, ma non sembra, nel medesimo tempo,
motivata all’assunzione di impegni di natura politica o sociale” (Tomasi, 1986, 109).
1.2.1. I termini di “disagio” e “rischio”come indicatori di nuovi bisogni
Ciò che era cambiato era il clima sociale. Il mutamento venne percepito anche a livello di analisi,
dove alle interpretazioni classiche della devianza/marginalità, si sostituirono nuove forme
interpretative che tenevano conto della complessità sociale e della difficoltà di definire “devianza”
in una situazione di pluralismo e relativismo etico; ed “emarginazione” in un contesto di pluralità di
centri. Il risultato fu l’adozione di nuovi parametri interpretativi, come il “rischio” e il “disagio”.
Termini entrati nella letteratura sociologica in seguito alle critiche rivolte dalla corrente
interazionista sul ruolo dello stigma sociale nella definizione della devianza. Infatti, secondo tale
scuola, le situazioni che erano tradizionalmente definite come “devianti” lo erano in quanto la
società le aveva definite tali.
La devianza “non” è una qualità dell’atto che la persona commette, ma piuttosto la conseguenza
dell’applicazione, da parte degli altri, di norme e sanzioni che qualificano il soggetto come
“delinquente”: il deviante è un soggetto al quale questa etichetta è stata applicata con successo;
comportamento deviante è il comportamento che la gente etichetta come tale (Becker, 1963, 9).
L’etichettamento costituiva quindi un passaggio fondamentale del processo attraverso cui si
diventava “devianti”. Al compimento di atti “devianti” (devianza primaria) da parte
dell’adolescente, più per effetto della sua iperattività e del bisogno di distinguersi dall’ambiente e di
esprimere la sua autonomia, seguiva un processo di “etichettamento” da parte della società. A
questo punto, quelli che erano solo degli atti gratuiti, senza scopo, diventano delle azioni
strutturanti. Il soggetto che non aveva altre possibilità di affermare se stesso, a causa della
deprivazione culturale e sociale, si identificava (identità negativa) nelle azioni stigmatizzate dalla
società e ne faceva la sua identità definitiva (devianza secondaria). La devianza secondaria, sarebbe
quindi, il risultato dell’interazione fra l’aspetto psico-sociale dell’azione deviante e del suo autore e
l’effetto sociopsicologico della reazione sociale intesa sia nella dimensione simbolica che in quella
istituzionale.
Attraverso l’adozione dei termini “rischio” e “disagio” si volle evitare di etichettare chi
commetteva atti trasgressivi come “deviante”, contribuendo con ciò al passaggio da una devianza
primaria ad una secondaria e definitiva.
L’introduzione di tali termini e prospettiva di analisi indicava anche che anche la devianza stava
cambiando, manifestando nuovi bisogni. Mentre un tempo essa era indice di povertà, e quindi
manifestazione di bisogni primari, ora essa l’attenzione di concentrò sui processi di costruzione
dell’identità e sui bisogni formativi del soggetto in crescita.
1.2.1.1. L’elaborazione del concetto di “rischio”
Questi nuovi concetti trovarono applicazione progressiva nelle varie indagini sulla realtà
giovanile.
Una delle prime che adottò il concetto di “rischio” per descrivere situazioni giovanili
problematiche, fu una ricerca condotta a Brescia (Milanesi, 1984).
Il rischio fu posto in relazione ai bisogni e definito come:
"situazioni obiettive e soggettive in cui vengono rese difficili e, al limite negate, le possibilità e le
capacità (personali e di gruppo) di autorealizzazione e di partecipazione consapevole" (Milanesi,
1984, 47).
oppure:
"situazione in cui vengono frustrate o negate le opportunità ragionevoli di soddisfazione dei
bisogni fondamentali" (Milanesi, 1984, 422).
Tutta la gioventù, secondo gli autori, si presentava in una condizione “a rischio”, in quanto
sottoposta ai processi “emarginanti” di una società che escludeva “dalle opportunità di avvalersi di
ruoli attivi, di decisionalità, di peso sociale, di acquisizioni culturali appropriate alle situazioni di
vita, di professionalità realmente spendibili, ecc.” (Ringhini, 1984, 542).
Gli indicatori dell’emarginazione venivano individuati in:
1.
2.
3.
4.
5.
l'espulsione precoce dalle strutture formative, o il prolungato parcheggio in esse,
l'esclusione dal lavoro legale, lo sfruttamento del lavoro nero,
la costrizione a svolgere esclusivi o prevalenti funzioni di consumo,
la manipolazione attraverso la socializzazione coatta dei mass media,
l'esclusione dalle forme di partecipazione scolastica, politica, ecclesiale (Milanesi, 1984, 427).
Particolarmente gravi erano alcuni effetti della società complessa che produceva
“frantumazione della condizione giovanile”, “crisi dell’identità collettiva”, “con il ripiegamento in
esperienze micro (gruppi ristretti, informali, circoscritti, ecc.) in cui elaborare un presente
provvisorio, più immediatamente gratificante a livello individuale, sostanzialmente di tipo aprogettuale” (Ringhini, 1984, 541).
Ciò comportava a livello soggettivo “un'analoga frantumazione del proprio vissuto, arricchito
e impoverito ad un tempo, della pluralità di tempi, luoghi e situazioni presieduti dallo effimero e dal
‘presentismo’ in cui è preponderante l'investimento emotivo su quello progettuale, a lungo termine”
(Ringhini, 1984, 542).
Tale condizione, se minacciava tutti i giovani, colpiva “selettivamente i meno garantiti ed
attrezzati tra essi” (Milanesi, 1984, 427). Ciò si verificava quando, alla condizione marginale
dell’essere giovane, si cumulavano condizioni particolari di degrado sociale e culturale.
1.2.1.1.1. Fattori di rischio
Nel tentativo di capire meglio il rischio giovanile, si cercò di individuare “i fattori di rischio”:
quegli elementi, cioè, che producono o favoriscono una situazione di rischio.
Fu considerato fattore di rischio “tutto ciò che ostacola la crescita dei giovani, la loro
maturazione individuale (maturazione intellettivo-conoscitiva, controllo e stabilità emotiva,
individuazione stabile e coerente di scopi e valori, ecc.) e sociale (adesione alle ‘norme’ del vivere
civile, inserimento nel mondo del lavoro, assunzione di responsabilità al di là della propria sfera
individuale: famiglia di elezione, partecipazione alla vita politica e sociale).
In termini più specifici […] tutto ciò che conduce a forme più o meno recenti di disadattamento
e devianza (droga, prostituzione, delinquenza, antisocialità in genere)” (Ferrari, 1984, 509).
Fra i fattori generali furono indicati:
1. La crisi economica
2. Il modo di fare politica
3. La pluralità di modelli culturali
4. La crisi delle istituzioni educative: famiglia e scuola
Più in particolare:
5. Le cattive compagnie
6. Il luogo di residenza (degradato, emarginato)
7. L’età (14-16 anni)
8. La condizione femminile
Soprattutto si puntò il dito contro alcuni processi di socializzazione che avrebbero impedito
“un'autonoma e critica esplorazione delle possibilità originali di soddisfazione dei propri bisogni,
indirizzandoli invece verso mete socialmente e personalmente irrilevanti, ancorché economicamente
redditizie per i gestori del controllo sociale” (Milanesi, 1984, 428). Invece, essi avrebbero prodotto
"massificazione dei processi di socializzazione, attraverso la canalizzazione dei bisogni
adolescenziali/giovanili verso comportamenti stereotipi soprattutto nel tempo libero" (Milanesi,
1984, 428).
Così la soggettività giovanile diventava incapace di “elaborare (individualmente e
collettivamente) risposte adattative, reattive e/o proattive più o meno funzionali al ‘bisogno di
significato’ emergente dalle problematiche condizioni di vita (emarginazione, ecc.)” (Milanesi
1984, 429).
1.2.1.1.2. Tipi di rischio
I tipi di rischio in cui potevano più frequentemente incorrere i giovani erano:
1. Rischio di devianza, intesa come devianza secondaria, quella in cui “il deviante ha
interiorizzato lo "stigma", […] ha fatto della devianza stessa il motivo e il contenuto
essenziale della propria identità totale” (Milanesi, 1984, 438). Cosa diversa da chi aveva
infranto la norma, ma solo occasionalmente, o che comunque non era ancora entrato nella
spirale della stigmatizzazione (deviante "primario").
2. Rischio fisico: quello in cui veniva messa a repentaglio la salute intesa, “come condizione
ottimale di funzionalità bio-fisiologica che permette un armonico sviluppo della
personalità complessiva del giovane” (Milanesi, 1984, 452). Rischio collegabile, per molti
aspetti, con il rischio di devianza (tossicodipendenza e uso non sporadico di alcolici,
alimentazione irregolare, ecc.).
3. Rischio consumistico: collegato alle modalità di fruizione del tempo libero. Come
sostenuto da Dumazedier (1978), il tempo libero poteva avere sì valenze autorealizzative
e promozionali, ma anche ludiche o compensative, e queste ultime comportavano il
rischio di una certa dicotomizzazione del tempo. Da questa dicotomia tra tempi e illusione
libertaria nasceva il rischio consumista, che si configurava come un tempo inteso solo (e
necessariamente) come occasione di divertimento e di relax, con lo “scopo di reintegrare e
omologare alla società dei consumi, secondo modelli […] funzionali ad essa e da essa
elaborati” (Milanesi, 1984, 460).
4. Rischio formativo: che si verificava quando il ragazzo viveva il rapporto con le agenzie di
formazione in modo problematico, “cioè sulla base di una generalizzata incertezza,
sfiducia, incoerenza di orientamenti” (Milanesi, 1984, 468). Situazione che indicava uno
scollamento con le agenzie di formazione.
1.2.1.2. L’elaborazione concetto di disagio
Una ricerca sui giovani a Verona (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989) fu una delle prime
dove il concetto di disagio non solo fu applicato, ma anche concettualmente elaborato. Tale
inchiesta aveva, infatti, lo scopo di individuare le cause del disagio giovanile, con lo scopo di
prevenire “l’entrata di non pochi giovani nel campo della devianza” (p. 15).
Il disagio venne definito come “una particolare situazione di vita in cui si manifestano
sintomi di sofferenza, disadattamento, frustrazione che portano scompiglio e squilibrio nel vissuto
personale del giovane e nella sua vita di relazione” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 31).
Sofferenza dovuta alla frustrazione di alcuni bisogni, che generava insoddisfazione. Pertanto il
disagio risultava avere due componenti:
a) una interna (il malessere del soggetto)
b) una esterna (la società).
Le componente esterna (oggettiva) era data da:
1. povertà
2. abbandono
3. marginalità e frammentazione sociale
4. inadeguatezza degli adulti di fronte alle domande giovanili
5. crisi delle agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, associazioni)
6. crisi delle istituzioni (politiche, economiche, giuridiche)
1.2.1.2.1. La dinamica del disagio
A giudizio degli autori, le radici del disagio non andavano cercate tanto nelle difficoltà a trovar lavoro e ad integrarsi nella società, quanto “nell'inadeguatezza degli atteggiamenti con cui gli
adulti si relazionano alle domande problematiche dei giovani, nell'obiettiva condizione di povertà e
abbandono di alcuni, di marginalità e di frammentarietà del vissuto di molti. Il disagio si nutre, in
sostanza, della diffusa crisi delle principali agenzie di socializzazione; quali la famiglia, la scuola, la
Chiesa, l'associazionismo giovanile” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 41).
Le condizioni sociali provocherebbero una diffusa situazione di “anomia”, “cioè di scollamento
tra il sistema dei valori e il grado di sviluppo della società, di insufficiente regolazione generale del
comportamento sociale, di incerta canalizzazione dei bisogni verso mete socialmente accettabili”
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 41).
I giovani percepirebbero tale situazione con sentimenti di sfiducia verso la società e angoscia nei
riguardi del proprio futuro. Sentimenti che produrrebbero un “bloccaggio”, cioè un senso di
inadeguatezza e di incapacità ad esprimere totalmente se stessi, abdicando così al proprio sogno di
trasformazione della società, attraverso una partecipazione responsabile. La concentrazione sul
privato e sul quotidiano sarebbero frutto di una tattica di ripiegamento dei giovani di fronte alla
insensibilità sociale nei loro confronti.
Quindi, esisterebbe, almeno ipoteticamente, un vivo bisogno di autorealizzazione anche sociale
(partecipazione), frustrato dai meccanismi sociali di esclusione e immobilizzazione della domanda
giovanile.
1.2.1.2.2. I fattori di disagio
I meccanismi sociali i responsabili del disagio sarebbero stati:
1. l’irrilevanza sociale della condizioni giovanile;
2. la situazione generale di complessità sociale con il conseguente tentativo giovanile di
ridurla;
3. la mobilità sociale con il rimescolamento delle appartenenze;
4. la moltiplicazione e frantumazione delle appartenenze sociali e delle esperienze
collettive;
5. l’ingovernabilità dei sottosistemi (economico, politico e sociale);
6. la fragilità degli ancoraggi e della legittimazione dei valori;
7. la precarietà dei percorsi dell’identità e dell’autorealizzazione giovanile;
8. l’allungamento dell’età giovanile con aumento della discrepanza tra adolescenza
biopsicologica e adolescenza sociale (cfr. Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 32).
A queste condizioni generali della società, si aggiungevano situazioni particolari di povertà e di
abbandono che aggravavano la situazione personale o di alcune categorie, favorendo il ricorso a
soluzioni irrazionali ai loro problemi.
1.2.1.2.3. Rapporto tra rischio e disagio
Il ricorso a “soluzioni irrazionali” introduce la specificità del “rischio”, che in quest’opera venne
definito in forma complementare al disagio:
Per rischio intendiamo una situazione in cui, a causa della frustrazione, negazione mortificazione dei
bisogni fondamentali della persona (cioè a causa di una situazione di soggettivo ed obiettivo disagio),
il soggetto è portato a dare soluzioni irrazionali al bisogno fondamentale dell'esistenza (che quello
del senso, del significato esistenziale) e agli altri bisogni correlati (Milanesi - Pieroni - Massella,
1989, 31-32).
Il rischio, quindi, comportava la frustrazione o negazione dei bisogni. Il disagio costituiva la
situazione di sfondo (= malessere, sofferenza), mentre il rischio consisteva nelle risposte che il
soggetto tentava di dare alla situazione disagiata. Queste soluzioni quando non erano orientate ad un
progetto capace di soddisfare il bisogno fondamentale dell’esistenza (quello di significato),
diventavano una risposta irrazionale. Essa fu precisata in questi termini:
L'irrazionalità consiste nel fatto che le decisioni adottate si rivelano obiettivamente distruttive per
l'individuo e per la società e non avviano assolutamente a soluzione i problemi che la persona ha
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 32).
Tali soluzioni, caratterizzate da una notevole carica distruttiva (auto o etero), si manifestavano
sovente con comportamenti violenti, che, facilmente stigmatizzati dalla società, potevano indurre ad
assumere un’identità negativa e così entrare nella spirale della devianza.
Pertanto il rischio rappreenterebbe un aggravamento della situazione, già pericolante o disagiata,
che poteva evolvere, per una serie di cause concomitanti (endogene ed esogene) in comportamenti
“devianti” (auto o etero-distruttivi).
1.2.1.2.4. I fattori di rischio
In questo gioco di responsabilità tra società e individuo, gli autori non mancarono di far notare le
responsabilità anche dei giovani, che, se giustificabili da un verso perché “le radici della loro
inadeguatezza sono obiettivamente consistenti” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42), dall’altra
potevano facilmente indurre a soluzioni di comodo senza rendersi conto dell’obiettiva pericolosità
di certi comportamenti e ancor più atteggiamenti.
Pertanto gli autori sottolinearono anche gli atteggiamenti che favorirebbero una “caduta nel
rischio”:
1. la rassegnazione alla mediocrità, cioè l'accettazione quasi fatalistica delle condizioni di
marginalità, frammentarietà, perdita di identità,
2. la rinuncia consapevole alla progettualità,
3. l'allergia per le proposte utopiche,
4. l'inerzia che caratterizza il lungo periodo di parcheggio nelle istituzioni formative,
5. la propensione verso l'effimero e il superficiale .
6. la tentazione di adagiarsi in un'ingenua semplificazione della realtà (Milanesi - Pieroni Massella, 1989, 42).
Questi atteggiamenti, condivisi in misura variabile un po’ da tutti i giovani, minaccerebbero la
qualità della loro vita, “proprio perché contengono i germi di una profonda crisi morale, impastata
di relativizzazione dell'etica, di gregarismo opportunista, di individualismo, di cinismo pragmatista”
(Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42).
Questo succederebbe perché l’ambiente era impegnato di una cultura “che premia gli
atteggiamenti nichilisti e che é satura di propensioni alla condanna, alla stigmatizzazione ed alla
colpevolizzazione dei giovani” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42).
Questa cultura condizionerebbe il “filtro soggettivo” dei giovani, cioè il loro “modo personale di
dare un significato al disagio e ai suoi sbocchi” (Milanesi - Pieroni - Massella, 1989, 42). Per questo
motivo lo sbocco irrazionale sembrerebbe il più conveniente e desiderabile.
1.2.2. Le forme del disagio
Stando a quanto aveva evidenziato D. Matza1, la devianza può costituire una forma di
comunicazione. Così si può cogliere nel comportamento trasgressivo di un adolescente un
messaggio, la segnalazione di un bisogno. Mentre un adulto ruba per accumulare ricchezza, la
stessa azione effettuata da un soggetto in età evolutiva potrebbe non avere questa funzione
strumentale ed essere ricollegabile a bisogni legati all’identità, alle relazioni.
Di conseguenza, vennero avanzate spiegazioni della delinquenza minorile riferentesi alle
problematiche del sé, dell’identità, delle relazioni significative e dei contesti di controllo. Ciò
permetteva, da una parte, di andare oltre i modelli tradizionali di interpretazione, secondo cui la
devianza era figlia di carenze (familiari, affettive, educative, economiche, culturali…) o di patologie
psichiatriche e, dall’altra, di ipotizzare che le azioni devianti producessero funzioni di
mantenimento dell’organizzazione soggettiva, relazionale e di controllo: nell’interazione con
l’ambiente il deviante agirebbe per equilibrare l’organizzazione del proprio sé e della propria
identità con quella del “contesto significativo” di appartenenza.
Questa ricerca di equilibrio venne considerata particolarmente importante durante la fase del
processo evolutivo, quando il minore è particolarmente impegnato a cercare sempre nuove forme di
equilibrio, di (ri)organizzazione dell’immagine di sé in continua trasformazione, al fine di realizzare
articolate modalità di rapporto con il mondo adulto e le istituzioni. Quindi, certi “strani”
comportamenti degli adolescenti in realtà rappresenterebbero delle complesse forme di
organizzazione del proprio sé per comunicare. Sarebbero funzionali al proprio sistema di
interazione.
L’azione deviante o trasgressiva sarebbe una comunicazione di disagio e la volontà da parte
dell’adolescente di “agire” il disagio e comunicarlo agli altri, alla società.
1.2.2.1. L’indagine del CENSIS
Un primo studio per delineare una mappa quali-quantitativa delle varie e più comuni forme
di devianza minorile fu condotto dal CENSIS (1982). Secondo quest’indagine, i comportamenti
fuori legge più frequenti e diffusi nell’area adolescenziale, riguardavano forme e modi diversi di
vandalismo, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la
persona (fra i quali i più frequenti legati alla sessualità). Stando nell’ottica della devianza intesa
avori.
1 Cfr. D. MATZA, Come si diventa devianti, Bologna, Il Mulino
come forma di comunicazione, questa fenomenologia di comportamenti poteva esprimere da parte
dei minori:
1. aggressività verso la società degli adulti, sentita come distante, poco disponibile
all’accoglienza e poco attenta alla loro condizione, dovuto alla mancanza di canali sociali di
espressione/accettazione della propria identità;
2. disorientamento individuale nell’interpretazione dei valori portanti;
3. “resilienza”, ovvero lucida determinazione ad adottare comportamenti spericolati per
assecondare un esasperato bisogno di protagonismo/competitività fra compagni e nei
confronti del mondo adulto.
“Scegliere la devianza come modalità d’azione” può rappresentare un’adesione a modelli
normativi condivisi nel sistema o nella microcultura di appartenenza. Di conseguenza, vennero
tentate spiegazioni della delinquenza minorile riferentesi alle problematiche del sé, dell’identità,
delle relazioni significative e dei contesti di controllo
Questa ricerca di equilibrio si avverte in particolar modo durante la fase del processo
evolutivo, quando il minore è particolarmente impegnato a cercare sempre nuove forme di
equilibrio, di (ri)organizzazione dell’immagine di sé in continua trasformazione, al fine di realizzare
articolate modalità di rapporto con il mondo adulto e le istituzioni. Quindi certi “strani”
comportamenti degli adolescenti in realtà rappresentano complesse forme di organizzazione del
proprio sé per comunicare. Sono funzionali al proprio sistema di interazione.
1.2.2.2. La tossicodipendenza
La tendenza ad una emarginazione nella sfera del privato è rilevabile anche dalla crescita del
numero di giovani che assumevano sostanze stupefacenti o alcolici. L’indagine Censis del 1982-83
sulle tossicodipendenze mise in evidenza come si fosse passati attraverso tre fasi nella diffusione ed
uso delle sostanze stupefacenti; nei primi anni settanta si trattava di un fenomeno di minoranza,
legato a giovani che, con la droga, volevano rompere completamente con il mondo degli adulti; una
seconda fase, verso la metà degli anni settanta, era stata caratterizzata da un uso della droga in
gruppi amicali, in aggregazioni giovanili che ricercavano gratificazione, sicurezza, solidarietà,
significati; la terza fase, quella degli ani ‘80, era caratterizzata da una diffusione a macchia d'olio
della droga, da un abbassamento dell' età dei tossicodipendenti e da una minore carica contestataria
nei confronti del mondo degli adulti.
Secondo gli operatori intervistati dal Censis si dovevano tener presenti alcuni fattori che
determinano l'assunzione di stupefacenti; le crisi della convivenza familiare, l'insicurezza circa il
futuro e la mancanza di prospettive, la crisi antropologica legata alla perdita di credibilità di alcuni
valori e mancanza di valori sostitutivi.
Se il problema droga è abbastanza studiato, l' alcolismo non ha mai attirato l'attenzione del
pubblico e dei mass-media: probabilmente sono troppi gli interessi economici, generalmente leciti,
legati alla produzione, commercio e consumo di bevande alcoliche. E' certo che è in aumento
l'alcolismo tra i giovani (16), ma si nota poca sensibilità per tale problema: non si fa niente per la
prevenzione e pochissimo per la cura, non risulta, fino ad oggi, che in Italia esistano centri
specializzati per la cura degli alcolisti.
1.2.2.3. Identità spettacolari
La componente espressiva del disagio apparve evidente in alcune forme contigue con l’area della
devianza. Si trattava di Rockabillies, Mods, Punks, Darks, New-wavers, (“gruppi spettacolari” –
Caioli, 1986 - o “del disimpegno” - Bajardi, Guglielminotti, 1987) i cui elementi distintivi
sembravano fare riferimento ad un genere o personaggio musicale e all’abbigliamento (più avanti
nasceranno i “metallari”, le “madonnare”, i “paninari”, ecc.). Alcuni di questi gruppi esibivano
simboli, abbigliamento e gergo tipici dell’estrema destra. Davano l’impressione d’essere violenti e
d’alimentare progetti reazionari. In realtà non si trattava di gruppi violenti, eccetto gli skinheads,
che si sono segnalati per i raid razzisti (più in Germania che in Italia). In ogni caso mancava loro
una vera progettualità politica. Questi gruppi si limitavano ad esprimere l’insofferenza ed il disagio
di vivere in una società che non li accoglieva, che non era adatta a loro.
Il disagio principale che essi esprimevano, a giudizio di Carmen Leccardi e Anna Rita Calabrò,
era quello dell’identità (Caioli, 1986). Un’identità sempre più difficile in un mondo che cambiava
rapidamente e non offriva più supporti validi per i percorsi di definizione dell’identità.
Quest’identità, non più ancorata a strutture sociali plausibili e condivise, cercava una sua via di
definizione attraverso l’appartenenza ad un piccolo gruppo, l’adesione ad uno stile, ad un genere
musicale, ad una moda, ecc. Un’identità “spettacolare”, appunto, fatta apposta per sorprendere, per
stupire. Un’identità negativa, nel senso inteso da Erikson, che si affermava rendendo esplicita,
manifesta la propria diversità. Differenziazione che fa parte delle strategie di definizione
dell’identità2.
Diversità manifestata attraverso il simbolismo, l’apparenza3. Simbolismo che costringeva a
prendere posizione, che provocava, che non si prestava a mezze misure, “o sei con noi, o sei
contro”, che rifiuta i compromessi. D’altra parte era una diversità elaborata dal gruppo, “portatore
di un’identità collettiva che allevia e satura le incertezze legate alla definizione dell’identità
personale” (Leccardi, 1986, 214). Cosicché lo spazio-tempo dove gestire questa identità
spettacolare è il tempo libero e lo spazio aperto della metropoli.
1.2.2.4. Le manifestazioni della violenza
Questa componente espressiva della violenza giovanile apparve anche da un’altra ricerca
promossa dal Labos (1988) su vari gruppi e realtà giovanili contigui alla violenza (gruppi a rischio,
gruppi di tifosi, gruppi informali, gruppi di studenti, ecc.). Questa ricerca capovolse i metodi
tradioznali di interpretare la violenza. I vari spezzoni della ricerca tendevano a ricondurre la genesi
del comportamento violento alle interazioni tra i soggetti e il micro-ambiente. Sovente era la
violenza subita che diventa la forma di apprendimento per un comportamento violento. Oppure il
clima intriso di violenza in cui si era vissuti; o le dinamiche di gruppo (ad intra o ad extra). In ogni
caso la violenza appariva collegata a dinamiche “normali” senza bisogno di far riferimento a precise
patologie personali o sociali.
Le interpretazioni tendevano a spiegare questa violenza ‘normale’ “come tentativi (inadeguati) di
colmare il divario esistente tra complessità sociale (che prende il volto della società ostile e chiusa)
e le ridotte opportunità individuali e con cui molti giovani devono fare i conti quando si pongono il
problema delle proprie identità e dell'inserimento sociale” (Labos 1988, 300).
Pertanto la violenza agita dai giovani di questi anni appare una violenza di tipo espressivo,
utilizzata al fine di manifestare il proprio disagio.
Ciò valeva soprattutto per coloro che erano meno attrezzati di strumenti per la comprensione e il
governo dei rapporti con l'ambiente; e questo rinviava a sua volta “alle carenze dei processi di
socializzazione ed ancora più specificatamente, […] alle carenze dei processi e delle relazioni
educative (cioè degli strumenti che avviano alle opzioni personali e non solo si accontentano
dell'adattamento)” (Labos 1988, 314).
Per questo sua caratteristica fondamentalmente espressiva e simbolica, la violenza giovanile ha
bisogno di accentuare l’elemento spettacolare.
2 “I giovani si sono trovati costretti ad elaborare nuove strategie di definizione dell’identità operando una selezione tra le diverse
risorse messe a loro disposizione da una società che sembra spingere in direzione dell’anonimità e del conformismo e nella quale
l’appello alla differenza ha un significato dirompente sulla logica dominante” (Calabrò 1986, 291)
3 “L’abbigliamento, come è noto è un medium comunicativo di grande efficacia simbolica” (Leccardi 1986, 211).
1.2.2.5. Sport e violenza
La ricerca del Labos (1988) sulla violenza ha svolto anche un’indagine su gruppi di tifosi. Anche
qui l’elemento spettacolare sembrava giovare un ruolo fondamentale. Infatti gli adolescenti, che
sono impegnati nella ricerca di soluzione al problema dell’identità, individuale e sociale, trovano
nell’aggregazione sportiva una rappresentazione simbolica di valori e modelli di comportamento
che possono sembrare una risposta al problema dell’identità. Un’identità che si compone anche di
un elemento aggressivo, di cui lo sport, ed il calcio in particolare, è assai ricco.
L’inserimento in un gruppo che accetta nuove presenze senza difficoltà, perché la partecipazione
è prevalentemente di esclusivo tipo fisico e corale; l’assunzione di un ruolo che può essere
considerato quello di un adulto in chi è tutto proteso a bruciare le tappe e ad uscire da una
condizione di forte ambiguità come quella adolescenziale; la sicurezza della impunità che consente
di agire senza timori (e che si sia non punibile è presto trasmesso al ragazzo attraverso il «tamtam»
tra coetanei); la possibilità di nobilitare la guerriglia attraverso l’autoconvincimento che si serve una
fede e si esprime un amore per una realtà che assume quasi connotati metafisici (una squadra, una
bandiera, una maglia); tutto ciò immette il ragazzo - alla ricerca non solo di una identità, di un
ambiente e di un ruolo, ma a anche di una valorizzazione personale stemperata nel collettivo - in un
sistema di violenza, e in realtà in una subcultura deviante, che può profondamente segnare tutta una
esistenza.
Tuttavia, la citata ricerca, afferma che, a parte la spettacolarizzazione della violenza, favorita
certo dai rituali del calcio, per il resto la violenza non è provocata dallo sport, ma è dentro la
società. Lo sport è un'espressione ritualizzata ed istituzionalizzata dell'aggressività, migliore, per
es., della guerra o di altre forme di violenza sistematica, come una modalità di risoluzione del
surplus aggressivo.
II tifoso vive la stessa situazione del protagonista, ne condivide le emozioni e le sensazioni, vive
e si proietta in lui, nell'agire di lui identifica le proprie aspirazioni, si gratifica e si compensa di
quanto la realtà quotidiana gli vieta. Vivere fortemente tali emozioni avrebbe una funzione
catartica: permette al soggetto di esternare le sue contraddizioni, di far esplodere l’aggressività che
ha dentro in modo sostanzialmente rituale e simbolico. Un modo quindi di esprimere l’aggressività
e le tensioni non molto diverso da quello dei “gruppi spettacolari”, cui tra l’altro si avvicinano
anche per il ricco apparato scenico di cui la partecipazione alle partite di calcio si colora (sciarpe,
bandiere, colori, scritte, fumogeni, slogan, suoni, ecc.).
Il calcio è dunque uno spettacolo che suggerisce una logica di battaglia, rafforza l’appartenenza di
gruppo, stimola atteggiamenti di arrogante sicurezza nei confronti degli avversari: tutte
caratteristiche che trovano terreno estremamente favorevole nei giovani che attraversano un
processo di acquisizione e consolidamento dell’identità individuale e sociale, cui si addice il
rischio e l’exploit. Ma […] gran parte di questo potenziale di violenza si stempera in forme di
rituale aggressivo (Labos, 1988, 217).