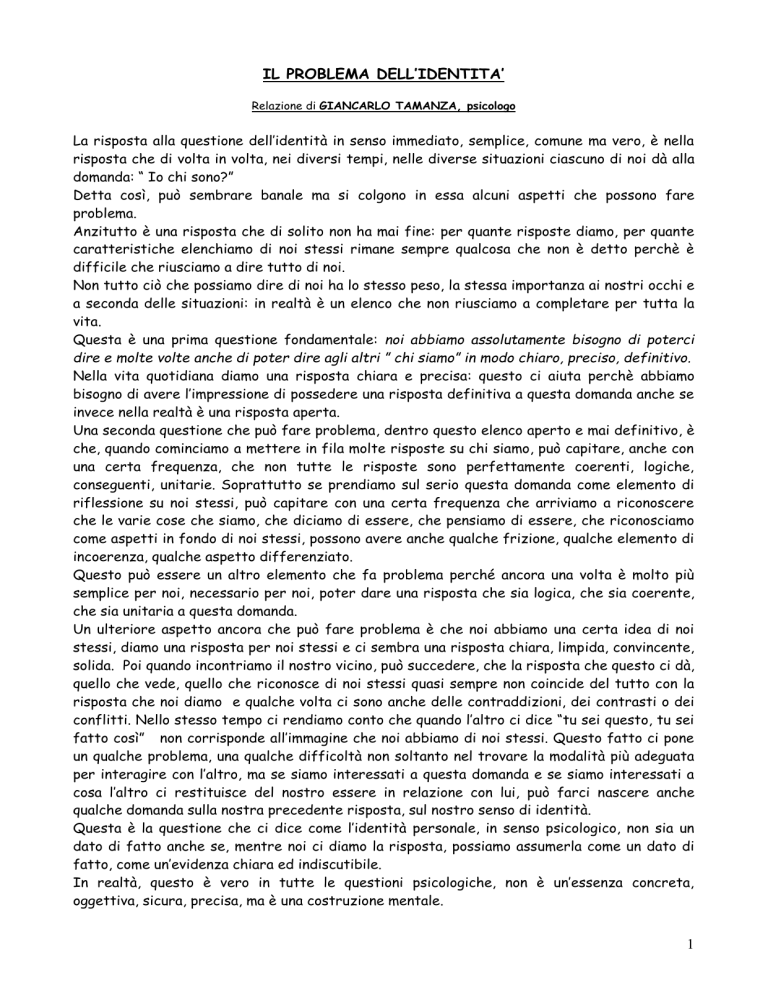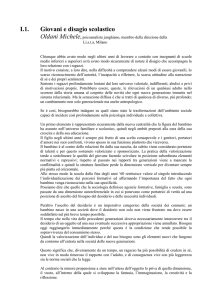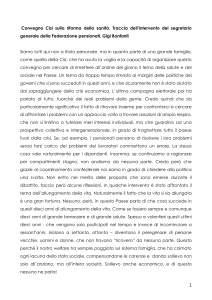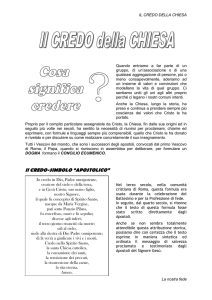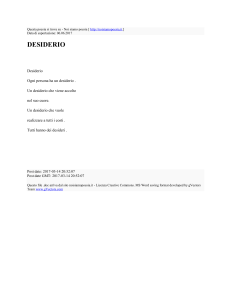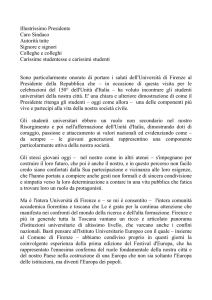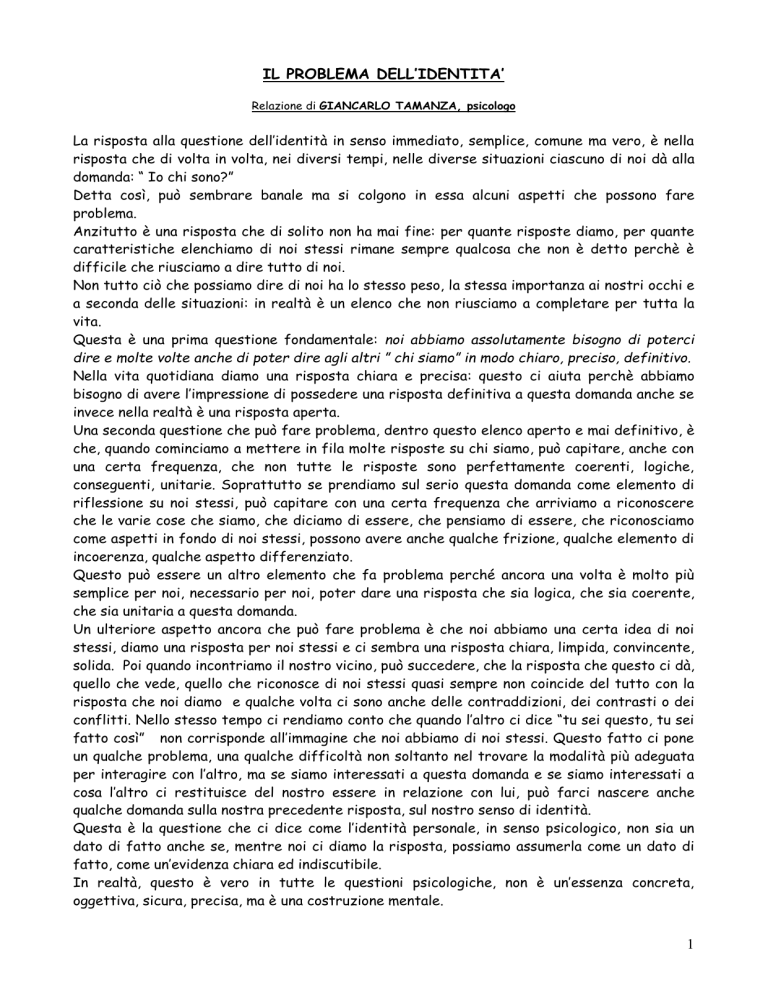
IL PROBLEMA DELL’IDENTITA’
Relazione di GIANCARLO TAMANZA, psicologo
La risposta alla questione dell’identità in senso immediato, semplice, comune ma vero, è nella
risposta che di volta in volta, nei diversi tempi, nelle diverse situazioni ciascuno di noi dà alla
domanda: “ Io chi sono?”
Detta così, può sembrare banale ma si colgono in essa alcuni aspetti che possono fare
problema.
Anzitutto è una risposta che di solito non ha mai fine: per quante risposte diamo, per quante
caratteristiche elenchiamo di noi stessi rimane sempre qualcosa che non è detto perchè è
difficile che riusciamo a dire tutto di noi.
Non tutto ciò che possiamo dire di noi ha lo stesso peso, la stessa importanza ai nostri occhi e
a seconda delle situazioni: in realtà è un elenco che non riusciamo a completare per tutta la
vita.
Questa è una prima questione fondamentale: noi abbiamo assolutamente bisogno di poterci
dire e molte volte anche di poter dire agli altri ” chi siamo” in modo chiaro, preciso, definitivo.
Nella vita quotidiana diamo una risposta chiara e precisa: questo ci aiuta perchè abbiamo
bisogno di avere l’impressione di possedere una risposta definitiva a questa domanda anche se
invece nella realtà è una risposta aperta.
Una seconda questione che può fare problema, dentro questo elenco aperto e mai definitivo, è
che, quando cominciamo a mettere in fila molte risposte su chi siamo, può capitare, anche con
una certa frequenza, che non tutte le risposte sono perfettamente coerenti, logiche,
conseguenti, unitarie. Soprattutto se prendiamo sul serio questa domanda come elemento di
riflessione su noi stessi, può capitare con una certa frequenza che arriviamo a riconoscere
che le varie cose che siamo, che diciamo di essere, che pensiamo di essere, che riconosciamo
come aspetti in fondo di noi stessi, possono avere anche qualche frizione, qualche elemento di
incoerenza, qualche aspetto differenziato.
Questo può essere un altro elemento che fa problema perché ancora una volta è molto più
semplice per noi, necessario per noi, poter dare una risposta che sia logica, che sia coerente,
che sia unitaria a questa domanda.
Un ulteriore aspetto ancora che può fare problema è che noi abbiamo una certa idea di noi
stessi, diamo una risposta per noi stessi e ci sembra una risposta chiara, limpida, convincente,
solida. Poi quando incontriamo il nostro vicino, può succedere, che la risposta che questo ci dà,
quello che vede, quello che riconosce di noi stessi quasi sempre non coincide del tutto con la
risposta che noi diamo e qualche volta ci sono anche delle contraddizioni, dei contrasti o dei
conflitti. Nello stesso tempo ci rendiamo conto che quando l’altro ci dice “tu sei questo, tu sei
fatto così” non corrisponde all’immagine che noi abbiamo di noi stessi. Questo fatto ci pone
un qualche problema, una qualche difficoltà non soltanto nel trovare la modalità più adeguata
per interagire con l’altro, ma se siamo interessati a questa domanda e se siamo interessati a
cosa l’altro ci restituisce del nostro essere in relazione con lui, può farci nascere anche
qualche domanda sulla nostra precedente risposta, sul nostro senso di identità.
Questa è la questione che ci dice come l’identità personale, in senso psicologico, non sia un
dato di fatto anche se, mentre noi ci diamo la risposta, possiamo assumerla come un dato di
fatto, come un’evidenza chiara ed indiscutibile.
In realtà, questo è vero in tutte le questioni psicologiche, non è un’essenza concreta,
oggettiva, sicura, precisa, ma è una costruzione mentale.
1
La risposta che noi diamo alla domanda “chi siamo?” è frutto di un processo molto complicato,
articolato, multiforme prodotto da noi stessi, dai nostri processi di pensiero e in particolare
si alimenta molto dalla nostra memoria: la caratteristica di questa idea psicologica
dell’identità è appunto quella di corrispondere un po’ al senso di noi stessi, al senso che ogni
persona ha del proprio essere in termini di continuità nel tempo, riconoscendo nello stesso
tempo che c’è anche una mutevolezza nel corso del tempo.
È infatti esperienza assolutamente comune il fatto che ciascuno di noi, se ha raggiunto un
minimo di identità e quindi non è in uno stato gassoso mentalmente con quei problemi di
dispersione dell’identità, di non identificazione, intuitivamente, con molta convinzione ed
evidenza, ha l’idea precisa che siamo sempre le stesse persone. E quindi c’è qualcosa che
rimane in modo stabile, continuativo nel tempo che consente per lo meno a noi stessi di
riconoscerci come sempre uguali e nello stesso tempo di riconoscerci come sempre diversi nel
corso del tempo. Da un punto di vista strettamente logico questo è un po’ una contraddizione,
ma è un’esperienza assolutamente reale.
Questa idea di identità è comunque qualcosa di complicato anche se noi la viviamo in termini
assolutamente semplici, banali.
Ancora un altro elemento è legato al fatto che l’aspetto dell’identità è qualcosa che a un certo
livello ci accomuna.
Essere una persona umana, essere un uomo o una donna sono caratteristiche assolutamente
generalissime, vere e comuni rispetto alla definizione di noi stessi: l’identità, almeno in una sua
parte, è proprio quel nucleo stabile che rimane nel corso del tempo, che ci accomuna e che ci
distingue dagli oggetti, dalle altre specie e così via.
Però nello stesso tempo, ancora una volta, quando noi pensiamo alla nostra identità di persone,
pensiamo immediatamente a un qualcosa che ci distingue in un modo unico rispetto agli altri,
pur nel comune riconoscimento di quelle altre caratteristiche che sono generali e universali.
Potremmo andare avanti molto su questa strada perché in effetti queste contrapposizioni si
ripropongono ogni volta che pensiamo a qualche aspetto dell’identità.
L’idea che volevo mettere in partenza per spiegare il problema dell’identità in generale, è
qualcosa di questo tipo: abbiamo a che fare con un’idea che possiamo vivere come
assolutamente naturale per noi stessi, immediata, intuitiva, essenziale, addirittura semplice e
chiara e che però si manifesta sempre in modo molto articolato.
Come si costruisce l’identità, come si mantiene, ecc., è un’altra questione assolutamente
decisiva.
Vale per la associazioni, per le organizzazioni, ma vale anche per gli individui, per le persone
perché altrimenti o finiamo per chiuderci in un mondo totalmente isolato, o pensiamo che
questa nostra identità ha a che fare unicamente con il nostro guardarci allo specchio. Se
invece è qualcosa che definisce dove stiamo nel mondo, i rapporti che intessiamo, il modo con
cui costruiamo la nostra vita concreta, inevitabilmente ci porta al confronto con questa
alterità. Ogni volta che ci confrontiamo nelle relazioni più intime con le persone, dove abbiamo
la sensazione di conoscerci profondamente e di condividere tutta la nostra vita, rimane
sempre uno scarto importante. Ed è essenziale che rimanga la possibilità di riconoscere
questa differenza. Riconoscere che, rispetto al modo con il quale noi possiamo definirci e
possiamo riconoscerci come persone e come soggetti, c’è uno scarto rispetto a quanto di noi
possiamo ritrovare nel rapporto con l’altro. E’ necessario riconoscere che l’altro, che pure ha
bisogno di rapportarsi con noi per potersi orientare e ricostruirsi nell’azione sociale, produca
e restituisca di volta in volta delle immagini, delle rappresentazioni che possono essere
diverse.
2
Il problema quindi sta nel capire come è possibile fare di questa diversità un elemento
costruttivo e non distruttivo, cioè un elemento che va ad alimentare il processo di costruzione
di un senso di sé, di un senso di identità che progressivamente si avvicina alla realtà piuttosto
che ad una rappresentazione che possiamo considerare ideologica o che va verso l’autismo,
cioè verso una costruzione puramente personale, soggettiva, distaccata dal dato reale.
L’altro elemento che rientra in ogni considerazione sull’identità in senso psicologico è il fatto
che per potersi definire in un modo che sia apprezzabile dalla nostra mente, è che la persona
deve riuscire a mettere insieme tanti aspetti diversi in una figura che abbia un minimo di
unitarietà e di coerenza.
Dicevo che il senso di identità non è un fatto, è una costruzione mentale, ma perché questa
costruzione mentale sia apprezzabile, sia utilizzabile e possa esserci una risposta, occorre che
assuma una forma.
L’esempio dei vari stati della materia era molto interessante, però il problema è anche di
capire esattamente quale è la forma, non dico più adeguata in assoluto, che sia
sufficientemente adeguata per corrispondere allo scopo del momento nelle varie circostanze,
nelle varie situazioni.
Il compito dell’identità è quello, di volta in volta, di riuscire a conseguire una forma che non
sarà mai completa, non sarà mai perfetta, ma sarà sufficientemente organizzata e consentirà
al soggetto, alla persona, di avere una intuizione di sé abbastanza precisa senza essere troppo
definitiva, troppo chiusa, troppo solida perché sappiamo che il dato reale, il dato esperienziale
ci avverte della continua indefinitezza della nostra realtà, cioè della impossibilità di chiudere
l’elenco delle risposte che possiamo dare.
La prima direttrice, su cui si sviluppa questa dialettica è il rapporto con l’altro, il rapporto tra
sé e l’altro; l’altra direttrice che in psicologia ha molto peso e che in parte si accompagna a
questa prima è la dialettica tra la parte consapevole della nostra identità e la parte, diciamo
in modo generico, inconsapevole.
Nella psicologia, in gran parte della psicologia, tutte le tematiche che riguardano l’inconscio,
hanno un peso importante; non è interessante in questa sede entrare nel merito di che cosa
sia l’inconscio, di come lo si intenda.
Credo che un dato reale e che corrisponde nella vita quotidiana al fatto che non possiamo mai
mettere fine alla definizione di noi stessi, è che non tutto ciò che noi siamo, che noi
sperimentiamo di noi stessi nella nostra vita, nella nostra realtà, lo possiamo contenere in
modo chiaro e definitivo dentro la consapevolezza che noi abbiamo di noi stessi. Credo non
tutto quello che noi pensiamo, facciamo, siamo nella nostra realtà, lo possiamo tenere dentro
l’idea chiara, precisa e consapevole che noi abbiamo di noi stessi.
Per tornare al punto di partenza, non tutto ciò che noi siamo, riusciamo a metterlo nella
risposta alla domanda “io chi sono?”. C’è qualcosa che sempre va al di là di questo: è un dato
che credo sia difficile negare nell’esperienza concreta.
La questione è di capire che peso ha questa parte che in qualche modo non conosciamo, che
peso ha nella nostra vita quotidiana, che peso ha in ogni nostra decisione, che peso ha e che
spazi occupa in ogni gesto che compiamo, in ogni parola che diciamo, che peso ha anche nella
costruzione della nostra identità, cioè nell’immagine che noi attribuiamo a noi stessi, così come
poi la attribuiamo agli altri.
L’identità, in termini di teoria psicologica ed anche in termini di percezione quotidiana, tende a
spostarsi nei primi due termini di questa doppia antinomia: sulla parte di sé rispetto all’altro e
sulla parte consapevole rispetto alla parte inconsapevole.
Quando noi rispondiamo alla domanda “io chi sono?”, quando noi riflettiamo sul nostro senso di
identità, è più facile che le prime risposte che ci vengono in mente o che le cose che riteniamo
3
più importanti nell’elenco delle risposte che possiamo dare, siano aspetti che riguardano noi
stessi piuttosto che il nostro rapporto con l’altro e che soprattutto, ovviamente quasi
inevitabilmente, riguardano ciò che noi sappiamo di noi stessi o che presumiamo di sapere di
noi stessi, che rientra cioè dentro la nostra consapevolezza anche storica di noi stessi.
Quindi verrebbe da dire, in senso anche logico, che il nostro senso di identità è soprattutto, in
termini di costruzioni mentali, il prodotto della nostra consapevolezza. Se non ci ricordiamo
che la nostra realtà psichica e fattuale non finisce lì, possiamo correre il rischio di
convincerci che noi coincidiamo con quelle risposte che sappiamo dare a quella domanda, che
noi siamo ciò che nella nostra capacità di conoscenza riusciamo a dire di noi stessi: noi siamo
quello che è il nostro senso consapevole di identità.
Questo non si verifica se crediamo e pensiamo che ciò che sta al di fuori della nostra
consapevolezza, può avere un posto importante, può avere una forza significativa nel
determinare ciò che siamo e ciò che facciamo.
È molto difficile tenerne conto, perché è come tener conto di qualcosa che non sappiamo che
cosa è; è come tener conto nella definizione di noi stessi di qualcosa che non vediamo, di
qualcosa che forse possiamo un po’ cogliere nelle risposte che l’altro dà alle nostre azioni, alle
nostre domande; ma sappiamo anche che tendenzialmente siamo portati ad ascoltare e a
riconoscere come vere le risposte che gli altri ci danno nella misura in cui quelle risposte
corrispondono a quello che vogliamo sentirci dire.
È molto difficile accogliere, come spontaneamente e possibilmente vere, come interessanti e
utili, tutte le indicazioni che gli altri ci danno e che sono difformi da quello che vorremmo
sentirci dire.
Non è un rischio se si prende sul serio l’idea che può essere vero anche ciò che sta al di fuori
della rappresentazione consapevole di noi stessi e questo si può esprimere semplicemente nel
tenere aperta una domanda piuttosto che nell’avere una risposta; se ci si ricorda che c’è
anche altro e che c’è qualcosa che sta al di là della nostra possibilità di essere conosciuto,
controllato, deciso. E’ questa una questione che può fare molta differenza nel tipo di identità
che andiamo a costruire e crea la possibilità che questa nostra identità, questo senso di
identità sia qualcosa che ci aiuta nel crescere, ci aiuta nel lavorare con gli altri, ci aiuta nel
sostenere progetti e così via.
In termini ontogenetici questa parte che sta fuori dalla consapevolezza è più importante nel
portarci ad essere quello che siamo. Anche in termini storici è più importante cioè ha un peso
maggiore, proprio in termine di “casualità”. Questo fa parte di come noi veniamo al mondo, di
come noi cresciamo e di come, per quel che riusciamo a capire, funziona la nostra mente.
Ciò che sta fuori di noi è assolutamente decisivo rispetto alla definizione della nostra identità
in termini storici, in termini sociali, perché viene prima. Pensiamo ad uno dei caratteri basilari
di ogni identità, che accomuna davvero tutti, cioè il nostro essere figli: questo segna il punto
di origine della nostra esistenza storica, oltre che mentale e fisica. Questo fatto che ha delle
ripercussioni enormi e che ognuno di noi si porta dietro tutta la vita, nel bene e nel male, è
qualcosa che certamente non è determinato da noi stessi.
È qualcosa che possiamo progressivamente integrare nella nostra consapevolezza, che può
diventare un elemento costitutivo del nostro senso di identità, ma certamente è qualcosa che
sta fuori di noi e sta prima di noi.
Potremmo fare tantissimi altri esempi, soprattutto rispetto a tutto il dato sociale che c’è nel
nostro costituirci come persone. In termini strettamente psichici la capacità di poterci porre
quella domanda non è all’origine della nostra vita mentale, ma è solo quando la nostra mente ha
già sviluppato una notevole capacità di funzionamento che possiamo porci sensatamente e
seriamente quella domanda e tante altre domande.
4
Questo vuol dire che per un lungo tempo ci sono altri aspetti del nostro essere psichico che
possono avere decisamente una forza molto importante: questo lo si capisce bene guardando
anche la prospettiva evolutiva.
Il tema dell’identità è stato al centro di molte ricerche e di molti studi della psicologia dello
sviluppo. Storicamente diventa centrale nella fase adolescenziale, non perché negli altri
elementi della vita non ci si trova a confrontarci con questa questione, ma perché è proprio
nell’adolescenza, o nell’uscire dall’adolescenza, che la questione può essere affrontata e può
essere trattata perchè i requisiti dello sviluppo mentale raggiungano un livello di maturazione
tale per cui anche i processi psichici possono assumere una forma più compiuta.
Da un lato la dimensione dello sviluppo corporeo: vale a dire che il nostro corpo, la base
materiale della nostra esistenza e del nostro essere persona, raggiunge la pienezza della sua
funzionalità soltanto dopo molti anni di vita.
Dall’altro la dimensione dello sviluppo sociale: dal punto di vista sociale e della sua autonomia la
persona può avere quelle condizioni preliminari, perché possa giocarsi in quanto tale, in quanto
individualità specifica ed autonoma, non all’inizio della vita ma solo dopo un lungo
apprendistato. Questi processi nelle nostre società tendono a dilatarsi.
Ebbene, proprio quì ci troviamo di fronte in termini fisiologici alla crisi, nel senso che la
domanda su “chi sono” si fa reale, si fa cruciale e diventa estremamente importante potervi
dare una risposta.
L’esito può essere differente a secondo della qualità della risposta che ciascuno può dare,
quando questi processi di crescita giungono a livello di maturazione e soprattutto in ordine al
grado di integrazione che in quel momento è possibile ottenere dei molteplici aspetti che
costituiscono gli ingredienti di ogni persona.
Osservando un po’ i processi evolutivi in fase adolescenziale, ritorna quello che ai nostri
orecchi può apparire come uno slogan ridicolo perché anche un po’ abusato: è la domanda
tipicamente adolescenziale del “chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo?”. Detta così fa un
po’ sorridere perché è un po’ ridicola ma , se andiamo al di là di questo aspetto, è veramente la
questione che riguarda il definirsi come persona.
Ho richiamato questo slogan un po’ banale perché in questo c’è anche la risposta al processo di
costruzione dell’identità: la risposta al “chi siamo?” in una certa misura deriva proprio dal “da
dove veniamo e dove andiamo”.
Tra le tante cose che dobbiamo cercare di mettere insieme in una organizzazione unitaria e
coerente degli aspetti che ci costituiscono, alla fine, in senso dinamico, ha un peso decisivo, il
“da dove veniamo?”.
Cosa capitalizziamo della nostra storia e quanto possiamo assumere in forma più evoluta, in
forma più matura di ciò che sono state le nostre origini, di ciò che è stato il nostro processo
di crescita nelle fasi precedenti dell’infanzia dove si struttura la nostra organizzazione
emotivo affettiva?
Che cosa possiamo consapevolmente e anche intenzionalmente assumere e riconoscere come
nostro di ciò che è stato il nostro nascere, il nostro crescere, il nostro vivere tutte le
esperienze di crescita e di apprendimento? a che cosa possiamo dare valore? in che cosa
possiamo riconoscerci?
In questo, c’è tutto un precipitato di una storia molto importante, perché nel punto di origine
si àncora un punto assolutamente reale del nostro essere.
Ma anche l’altro termine dello slogan “dove andiamo?”, ripreso al di là della formulazione un po’
logora, dice molto di come noi possiamo costruire delle integrazioni più o meno equilibrate, più
o meno efficaci di noi stessi e della nostra identità.
5
Il “dove andiamo?” rappresenta da un lato l’istanza ideale o comunque l’istanza verso la quale
noi vogliamo orientarci, per quel che ci è possibile, nei limiti della nostra realtà, della nostra
consapevolezza, delle nostre reali possibilità, la nostra stessa identità, la nostra stessa vita.
Il problema dell’identità in termini sociali e evolutivi, in questi anni è un problema che
epidemiologicamente è molto interessante: perché se guardiamo un po’ l’evoluzione delle forme
che assume la patologia mentale negli ultimi decenni, si vede che le forme della patologia
dell’identità nelle sue svariate modalità, è una forma sintomatica in grande crescita rispetto
ad altre forme di patologia tipiche di altri momenti storici e sociali.
Quello che fa problema nel passaggio evolutivo e cruciale del costituirsi di un’identità che sta
appunto nel trovare la misura e l’equilibrio e nel tenere insieme le diverse parti che pure ci
appartengono, che pure ci definiscono, è soprattutto quello di vedere se, in che modo, in che
misura ciascuno di noi riesce a fare sintesi della propria storia e della propria progettualità
verso il futuro e verso l’ideale.
Se riesce cioè a fare sintesi tra il dato di realtà ed il dato del desiderio: cioè tra il dato che
nasce soprattutto in quella parte che sfugge alla nostra consapevolezza e che costituisce il
motore psichico della nostra vita, ossia la parte che si innesta anche su aspetti di bisogno ma
che in termini mentalizzati diventa più una parte di desiderio, e tra quanto è dato dalla realtà
in cui ognuno di noi si trova, dalle caratteristiche che ciascuno di noi ha, dalle doti, dai carismi,
dalle possibilità e dalla storia da cui ciascuno di noi nasce.
A questo proposito è importante ricordarsi che la sintesi che probabilmente è più efficace,
più equilibrata non è quella che elimina lo scarto tra il desiderio e la realtà. Questa la
possiamo incontrare nella vita quotidiana quando abbiamo a che fare con delle persone che si
presentano ai nostri occhi come tutte di un pezzo, come tutte coerenti, come tutte
organizzate, logiche, soddisfatte, precise e che sanno quello che vogliono e che ottengono
quello che vogliono fino in fondo. Agli occhi di uno psicologo questo atteggiamento è piuttosto
preoccupante e sintomatico perché rappresenta con molta probabilità più una maschera che
una reale integrazione delle differenti parti di sé.
Così come è altrettanto preoccupante incontrare persone, e capita nella vita quotidiana, dove
si coglie bene come la dimensione del desiderio di ciò che uno vorrebbe essere è troppo
lontana da ciò che uno può essere, da ciò che uno è nella sua realtà.
Spesso in questi casi può anche succedere che le persone non riconoscano tutto questo scarto:
non si rendono conto della fatica di tenere insieme un desiderio troppo diverso dalla realtà e
credono con convinzione e buona fede di essere esattamente quel desiderio, cioè di essere ciò
che non sono.
Credo che il criterio che fa la differenza tra le diverse identità possibili, tra i diversi stati
della materia possibili, sia un criterio di equilibrio tra queste due tendenze: tra ciò che
riconosciamo di essere e ciò che vorremmo essere.
L’ideale ha un grande valore nell’economia psichica, ma ha valore solo se è riconosciuto come
ideale, cioè come non reale, come termine di una tensione, come termine di un investimento, di
un desiderio che per definizione non è compiutamente raggiungibile ma che ha valore proprio
perché ci consente di continuare ad evolverci, a camminare in quella direzione. Il problema è
verificare la compatibilità e la non contraddittorietà tra ciò che assumiamo come meta ideale,
come desiderio di ciò che vorremmo essere e quelle che sono invece le nostre condizioni reali.
Questo per certi versi credo possa, fatte tutte le opportune analogie, offrire qualche spunto
di riflessione anche sul piano organizzativo.
Un po’ più recentemente rispetto agli studi evolutivi, nella psicologia si sono affermati anche
molti approfondimenti sulle identità organizzative: nascono un po’ dal presupposto che sia
6
possibile leggere una realtà sociale aggregata non esattamente come si legge o si interpreta il
funzionamento psichico di un soggetto individuale, ma con una certa analogia di concetti.
Credo sia vero che tutta una serie di considerazioni sull’identità personale si potrebbero, con
tutti gli aggiustamenti del caso, riproporsi anche rispetto ad una identità organizzativa.
Anche ad una organizzazione come la nostra potremmo porre la domanda del “chi siamo?” e
fare l’elenco di tutto ciò che siamo e chiedere a chi ci sta in parte “secondo te io chi sono?”.
Si capisce subito che se il discorso dell’identità ha già un po’ di complicazioni sul piano
individuale spostato su un piano di una realtà sociale organizzativa, questi aspetti di
complicazione si moltiplicano soprattutto perché l’organizzazione è fatta di una pluralità a
volte anche quantitativamente estesa di soggetti individuali. Ciò può portare ad un ampliarsi
sia degli aspetti di confusione, sia degli aspetti di contraddizione, sia degli elementi che sono
difficili da tenere insieme.
Anche a questo livello, però, credo che la questione decisiva che può fare la differenza tra
una identità associativa piuttosto che un’altra, vada in qualche modo, o possa essere in qualche
modo ricercato avendo in mente che la costituzione di un’idea, di una identità organizzativa è
un processo di costruzione: non è un dato che oscilla e dialoga tra le polarità contrastanti che
abbiamo ricordato sopra. Ancora di più nel caso di una organizzazione, il rapporto tra ciò che
è noto, esplicito, consapevole e ciò che sta al di là della consapevolezza, si fa particolarmente
delicato.
Nel caso dell’organizzazione il criterio più produttivo su cui indirizzare gli sforzi di
interrogazione e di costruzione della propria identità credo sia quello di ricercare un
equilibrio stando attenti a non scivolare troppo sugli estremi.
Qualcuno ad esempio potrebbe pensare che una organizzazione, ha una identità tanto più
forte, più solida, più produttiva quanto più tutti i componenti hanno delle identità simili.
Credo sia un po’ il caso della maschera rigida, precisa, sicura, logica, coerente ma anche molto
poco reale. Nello stesso tempo l’altro grosso rischio è quello di essere troppo dispersi.
L’articolazione delle diverse parti credo sia assolutamente importante dentro un organismo
sociale, dentro una realtà sociale.
È importante anche riconoscere il significato che dentro un’organizzazione può assumere
ciascuna persona, le diverse parti che si possono giocare e assumere; anche il fatto che in
qualche modo questi processi, in una certa misura sicuramente frutto di dinamismi spontanei
ed evolutivi, possono e debbono in qualche modo essere governati.
Quello che voglio dire è che la definizione di un’identità non può essere costruita a tavolino,
non può essere progettata in senso astratto, un po’ illuministico per le ragioni che dicevo
prima. Però va in qualche modo alimentata e costruita seguendo un criterio, seguendo una linea
direttrice. Credo sia proprio il compito cruciale di chi dentro l’organizzazione ha delle
responsabilità di guida: assumersi questo compito avendo in mente che non ci si può aspettare
che tutti nella stessa organizzazione abbiano uno stesso grado di coerenza identitaria. Anzi è
assolutamente fisiologico, proprio perché l’organizzazione è una realtà viva, che ciascuno
possa compiere, anche attraverso l’appartenenza e l’impegno in una organizzazione, un
pezzetto di strada sulla sua costruzione dell’identità.
Quindi credo sia di interesse decisivo per chi appunto più ha a cuore e ha responsabilità nella
gestione di una realtà sociale, avere in mente che l’organizzazione serve anche, e forse prima
di tutto, per le stesse persone che ne fanno parte e che la condizione perché l’associazione sia
produttiva rispetto all’esterno è prima di tutto quello di cercare, nei limiti del possibile, di
costruire un equilibrio che tenga conto dei desideri da un lato ma anche dalla realtà concreta
visibile dall’altro.
7