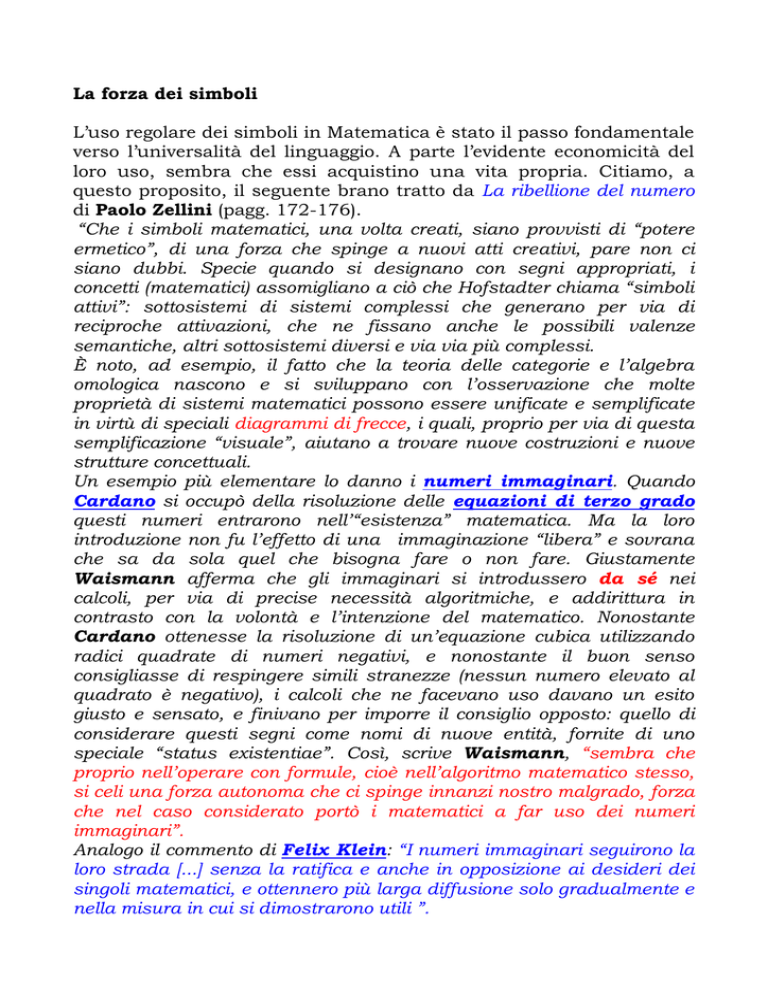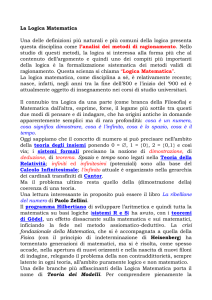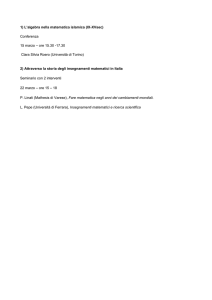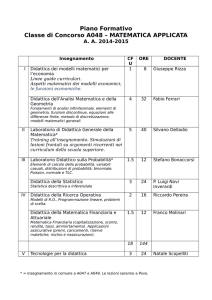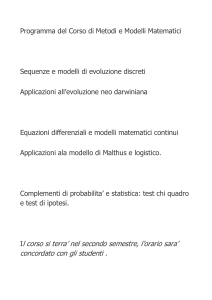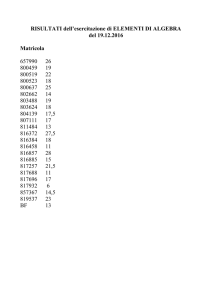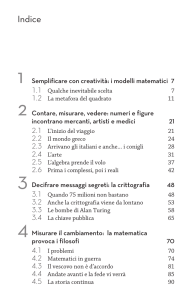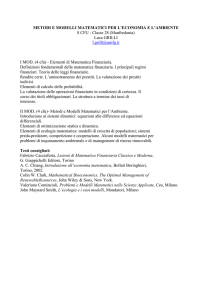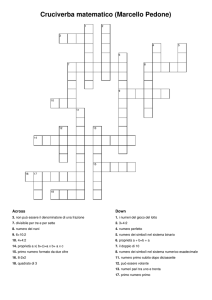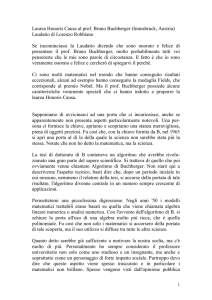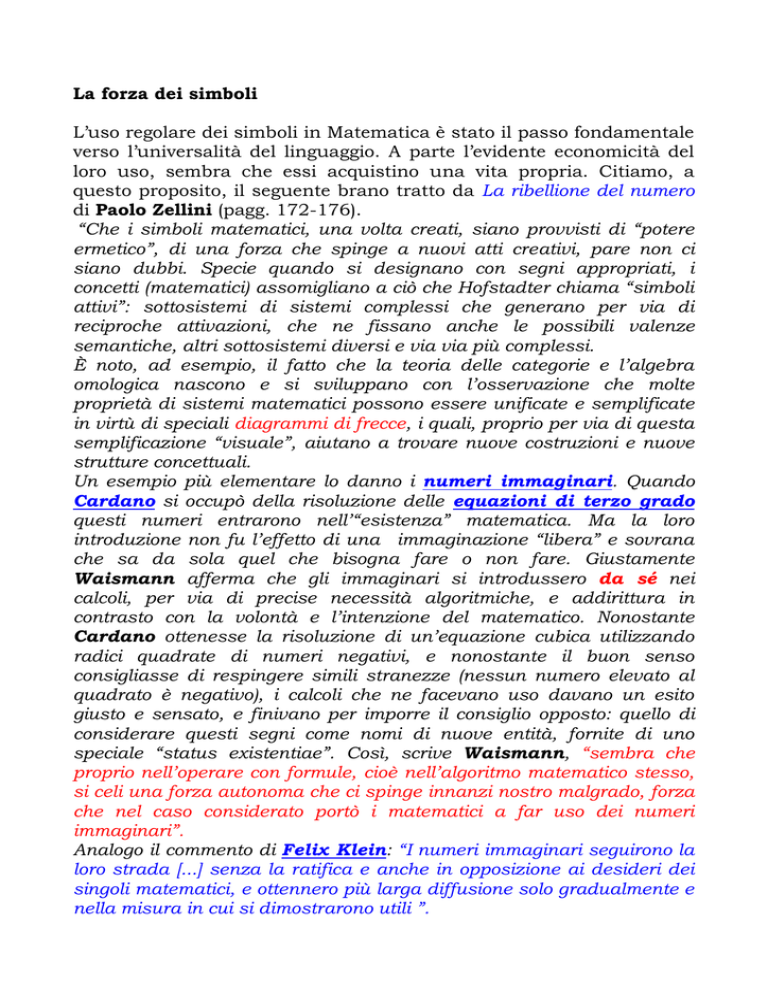
La forza dei simboli
L’uso regolare dei simboli in Matematica è stato il passo fondamentale
verso l’universalità del linguaggio. A parte l’evidente economicità del
loro uso, sembra che essi acquistino una vita propria. Citiamo, a
questo proposito, il seguente brano tratto da La ribellione del numero
di Paolo Zellini (pagg. 172-176).
“Che i simboli matematici, una volta creati, siano provvisti di “potere
ermetico”, di una forza che spinge a nuovi atti creativi, pare non ci
siano dubbi. Specie quando si designano con segni appropriati, i
concetti (matematici) assomigliano a ciò che Hofstadter chiama “simboli
attivi”: sottosistemi di sistemi complessi che generano per via di
reciproche attivazioni, che ne fissano anche le possibili valenze
semantiche, altri sottosistemi diversi e via via più complessi.
È noto, ad esempio, il fatto che la teoria delle categorie e l’algebra
omologica nascono e si sviluppano con l’osservazione che molte
proprietà di sistemi matematici possono essere unificate e semplificate
in virtù di speciali diagrammi di frecce, i quali, proprio per via di questa
semplificazione “visuale”, aiutano a trovare nuove costruzioni e nuove
strutture concettuali.
Un esempio più elementare lo danno i numeri immaginari. Quando
Cardano si occupò della risoluzione delle equazioni di terzo grado
questi numeri entrarono nell’“esistenza” matematica. Ma la loro
introduzione non fu l’effetto di una immaginazione “libera” e sovrana
che sa da sola quel che bisogna fare o non fare. Giustamente
Waismann afferma che gli immaginari si introdussero da sé nei
calcoli, per via di precise necessità algoritmiche, e addirittura in
contrasto con la volontà e l’intenzione del matematico. Nonostante
Cardano ottenesse la risoluzione di un’equazione cubica utilizzando
radici quadrate di numeri negativi, e nonostante il buon senso
consigliasse di respingere simili stranezze (nessun numero elevato al
quadrato è negativo), i calcoli che ne facevano uso davano un esito
giusto e sensato, e finivano per imporre il consiglio opposto: quello di
considerare questi segni come nomi di nuove entità, fornite di uno
speciale “status existentiae”. Così, scrive Waismann, “sembra che
proprio nell’operare con formule, cioè nell’algoritmo matematico stesso,
si celi una forza autonoma che ci spinge innanzi nostro malgrado, forza
che nel caso considerato portò i matematici a far uso dei numeri
immaginari”.
Analogo il commento di Felix Klein: “I numeri immaginari seguirono la
loro strada [...] senza la ratifica e anche in opposizione ai desideri dei
singoli matematici, e ottennero più larga diffusione solo gradualmente e
nella misura in cui si dimostrarono utili ”.
Oltre che essere il risultato di una necessità algoritmica, il numero
immaginario rappresentò anche l’occasione per ulteriori sviluppi
algebrici e geometrici, nel senso di una progressiva astrazione della
matematica. Alla crescita dell’algebra astratta contribuirono non poco,
del resto, la stessa esistenza e le stesse proprietà combinatorie di segni
operazionali della cui potenzialità euristica si poteva essere, sulle
prime, legittimamente ignari. Questo contributo prese origine dall’uso
dei segni introdotti da Leibniz per il calcolo differenziale e integrale, e
dalla scoperta a posteriori che questi segni ubbidivano alle stesse
proprietà combinatorie delle potenze (ad esempio il differenziale
ennesimo di un prodotto era formalmente analogo alla potenza
ennesima di un binomio). Questa sola analogia già portava Lagrange a
concludere che molti nuovi teoremi, che sarebbe stato difficilissimo
scoprire per altre vie, diventavano ora accessibili; e l’opportunità più
conseguente diventava ben presto di considerare i simboli delle
operazioni di derivazione e di differenziazione come quantità
algebriche, alla stessa stregua delle x e delle y cui esse si applicavano.
La tecnica della “separazione dei simboli” introdotta da Louis
François Arbogast nel 1800, le ricerche di Fourier e i lavori di
Cauchy sul calcolo delle operazioni (1827) rafforzarono l’evidenza di
una stretta analogia tra potenze e indici di differenziazione; e questa fu
ben presto in grado di suggerire successive considerazioni sulla natura
dell’algebra, e da ultimo sugli stessi fondamenti della matematica. Il
“salto” speculativo prese spunto dalla scuola inglese di Babbage,
Herschel, Peacock, che videro in tale scoperta il seme di una novità
non sufficientemente riconosciuta dalle scuole continentali. Boole
inventò una pura algebra di segni in base a proprietà combinatorie
finalmente astratte dal particolare significato che i simboli potessero
assumere nell’algebra o nel calcolo differenziale o funzionale. E questo
stile ben si accordava con l’emergente teoria dei gruppi algebrici,
che, spostando l’attenzione dagli oggetti (matematici) alle leggi cui
questi soggiacciono, affrancava il ragionamento dalla necessità di una
particolare interpretazione dei segni.
Quanto questo processo possa addebitarsi a una specie di
automatismo, di crescita spontanea dell’idea per svolte casuali,
impreviste e per successive conquiste mentali imposte dall’analogia e
dall’astrazione, può dedursi da un commento di Robert Woodhouse,
che risale al 1801.- “Sarebbe invero un singolare paradosso o una rara
fortuna se la verità non sempre raggiunta dalla meditazione dovesse
inaspettatamente risultare da operazioni non rispondenti all’idea,
condotte senza principio, senza scopo o regolarità”,
Hermite sarebbe forse stato disposto a vedere in queste “operazioni
senza principio” le mosse di un organismo vivente; proprio come esseri
viventi egli considerava infatti, ci racconta Poincaré, gli enti più
astratti. Nel suo strenuo realismo, anche quando non riusciva a vedere
gli enti matematici in modo chiaro ed esauriente, Hermite percepiva
comunque una loro unità interna, un principio di organizzazione che li
rendeva dissimili da una morta composizione artificiale; o per lo meno
era lecito pensare che lo stesso artificio non potesse essere altro che
vita e movimento.
Perfino Cantor, cui Hermite rimproverava di creare gli oggetti
matematici anziché di limitarsi a scoprirli, doveva presentire una finale
rivincita dell’oggetto sulla presunta “libertà” del matematico. Per un
attimo, è vero, il condizionamento esterno dei fatti non escludeva
un’apparenza di “libertà”, perché si rivolgeva contro il vincolo di
un’abitudine e contro la forza carceraria di certi pregiudizi. (La
“libertà”, si direbbe, è “libertà” di opporsi a una costrizione precedente).
Ma quand’era ormai vicino a scoprire nella successione degli indici di
derivazione una nuova specie di numeri, i numeri transfiniti, Cantor
dovette anche riconoscere la forza autonoma e antagonista dei concetti:
“Qui vediamo una generazione dialettica di concetti, che porta
sempre più innanzi, e rimane libera da ogni arbitrio e insieme
necessaria e logica in sé”.
Ciò che scrisse Ludwig Fleek (in Entstehung und Entwicklung
einer wissenschaftlichen Tatsache, 1935) - che la conoscenza
richiede la massima coazione e la minima arbitrarietà di pensiero - non
è mai così poco evidente come nell’atto dell’invenzione. Ma perfino in
quell’atto la necessità e la “coazione” si aggiungono all’arbitrio, perché
non c'è dubbio che vi prenda corpo, al di là di una parvenza di “libera”
scelta, qualcosa che compete alla stessa unità e strategia dell’oggetto.”