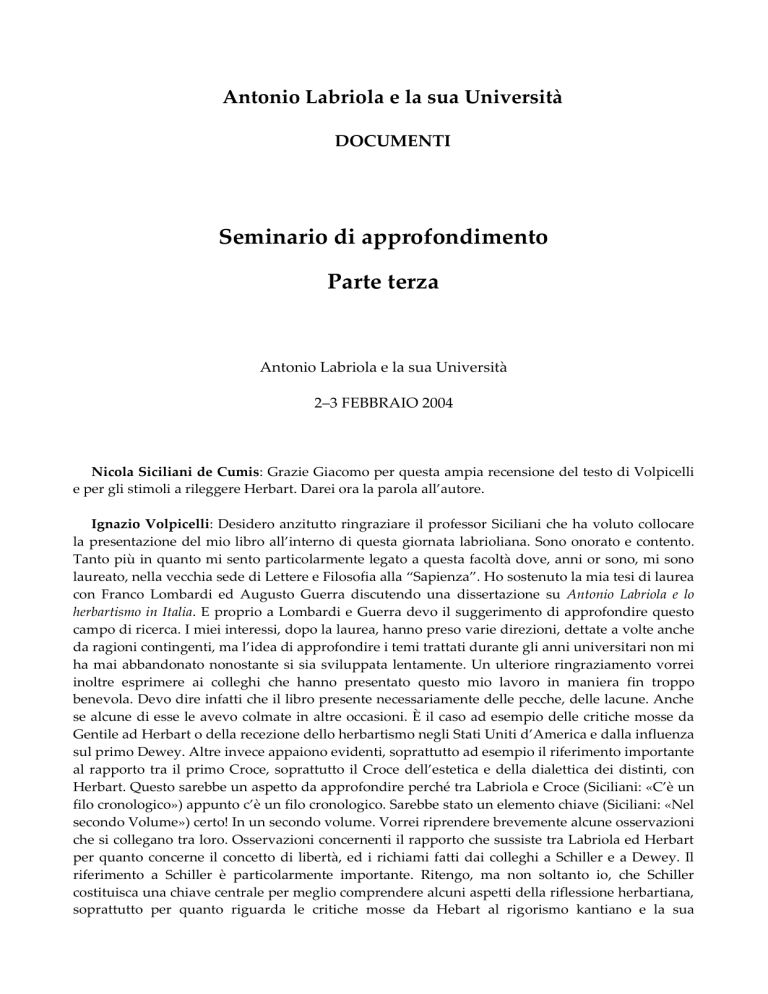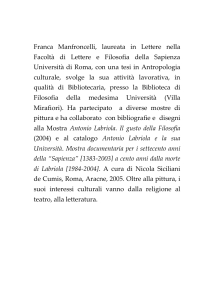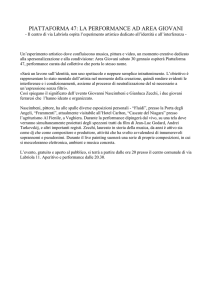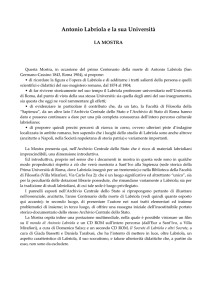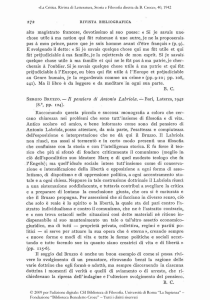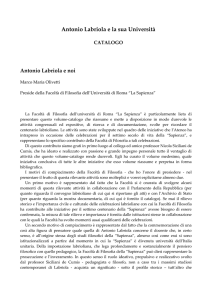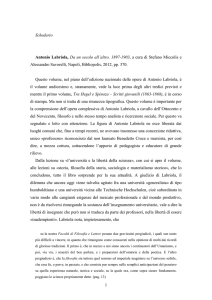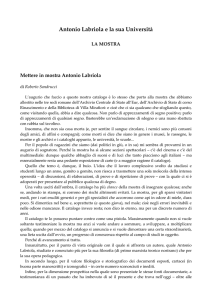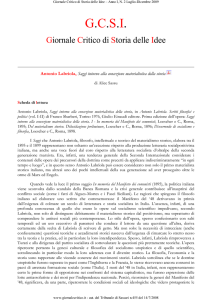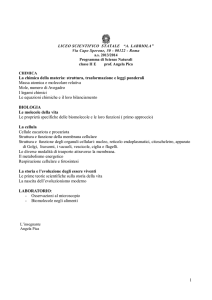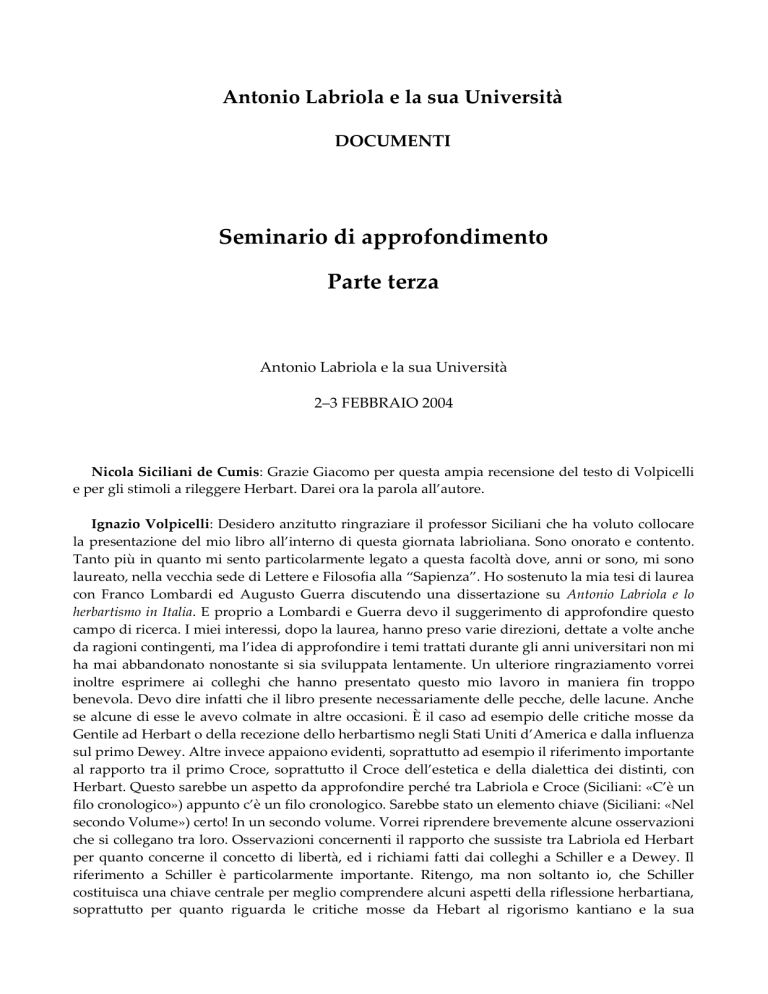
Antonio Labriola e la sua Università
DOCUMENTI
Seminario di approfondimento
Parte terza
Antonio Labriola e la sua Università
2–3 FEBBRAIO 2004
Nicola Siciliani de Cumis: Grazie Giacomo per questa ampia recensione del testo di Volpicelli
e per gli stimoli a rileggere Herbart. Darei ora la parola all’autore.
Ignazio Volpicelli: Desidero anzitutto ringraziare il professor Siciliani che ha voluto collocare
la presentazione del mio libro all’interno di questa giornata labrioliana. Sono onorato e contento.
Tanto più in quanto mi sento particolarmente legato a questa facoltà dove, anni or sono, mi sono
laureato, nella vecchia sede di Lettere e Filosofia alla “Sapienza”. Ho sostenuto la mia tesi di laurea
con Franco Lombardi ed Augusto Guerra discutendo una dissertazione su Antonio Labriola e lo
herbartismo in Italia. E proprio a Lombardi e Guerra devo il suggerimento di approfondire questo
campo di ricerca. I miei interessi, dopo la laurea, hanno preso varie direzioni, dettate a volte anche
da ragioni contingenti, ma l’idea di approfondire i temi trattati durante gli anni universitari non mi
ha mai abbandonato nonostante si sia sviluppata lentamente. Un ulteriore ringraziamento vorrei
inoltre esprimere ai colleghi che hanno presentato questo mio lavoro in maniera fin troppo
benevola. Devo dire infatti che il libro presente necessariamente delle pecche, delle lacune. Anche
se alcune di esse le avevo colmate in altre occasioni. È il caso ad esempio delle critiche mosse da
Gentile ad Herbart o della recezione dello herbartismo negli Stati Uniti d’America e dalla influenza
sul primo Dewey. Altre invece appaiono evidenti, soprattutto ad esempio il riferimento importante
al rapporto tra il primo Croce, soprattutto il Croce dell’estetica e della dialettica dei distinti, con
Herbart. Questo sarebbe un aspetto da approfondire perché tra Labriola e Croce (Siciliani: «C’è un
filo cronologico») appunto c’è un filo cronologico. Sarebbe stato un elemento chiave (Siciliani: «Nel
secondo Volume») certo! In un secondo volume. Vorrei riprendere brevemente alcune osservazioni
che si collegano tra loro. Osservazioni concernenti il rapporto che sussiste tra Labriola ed Herbart
per quanto concerne il concetto di libertà, ed i richiami fatti dai colleghi a Schiller e a Dewey. Il
riferimento a Schiller è particolarmente importante. Ritengo, ma non soltanto io, che Schiller
costituisca una chiave centrale per meglio comprendere alcuni aspetti della riflessione herbartiana,
soprattutto per quanto riguarda le critiche mosse da Hebart al rigorismo kantiano e la sua
particolare impostazione rispetto al problema della libertà. Aspetti che vengono ripresi da Labriola
il quale si mostra profondamente critico, non diversamente da Herbart, nei confronti del concetto
kantiano di libertà trascendentale. La libertà trascendentale, questa è in sostanza la tesi di Herbart
ripresa da un Labriola il quale insiste sul principio che «l’uomo bisogna farlo, bisogna educarlo»,
rende inutile la pedagogia. Se è vero infatti secondo Herbart che la libertà non è un punto di
partenza, ma il punto di arrivo del processo educativo, ogni teoria, come quella kantiana volta a
riporre la libertà nell’essenza nuomenica dell’uomo, per sé inconoscibile, priverebbe di fatto
l’educazione del suo significato più autentico. In Herbart appare evidente l’incidenza della
concezione educativa schilleriana volta a ricercare nell’uomo un armonico accordo tra ragione e
sentimento, ed è un motivo questo che si ripropone anche ad un Labriola il quale volendo dare una
risposta all'interrogativo su come sia possibile «conciliare il concetto psicologico del motivo più
forte, con le esigenze della morale» dava appunto una risposta in tutto e per tutto herbartiana. A
proposito dello herbartismo di Labriola, ritengo estremamente riduttivo confinare questo aspetto
ad un semplice momento, o periodo della sua evoluzione intellettuale. O per dire meglio, è vero, le
posizione filosofiche di Labriola maturo risentono di altre influenze. Ma ciò non significa che egli
abbia voltato interamente le spalle rispetto agli insegnamenti di Herbart. La celebre espressione
che ricorre nel saggio Del materialismo storico che «le idee non cascano dal cielo» ne è una
espressione evidente. Ancora una parola su Dewey il quale sviluppa delle critiche al concetto di
ricapitolazione, di concentrazione così come viene presentato nel neo–herbartismo americano. Lo
herbartismo penetra negli Stati Uniti soprattutto grazie alla mediazione di Charles De Garmo e dei
fratelli McMurrey i quali danno vita un “Herbart Club”. Essi si rifanno in particolare allo
herbartismo di Tuiskon Ziller. Ma occorre osservare che le tesi di Ziller non sono le tesi di Herbart
e che le critiche di Dewey non appaiono pertinenti se riferite ad Herbart. Dewey ad esempio critica
la pedagogia di Herbart in quanto sarebbe una pedagogia del maestro e non dell’allievo. Ma
questa appare una critica che non colpisce la pedagogia di Herbart, quanto piuttosto le sue
caricature. Esiste un ampio spettro di posizioni nell’ambito dello herbartismo non facilmente
conciliabili tra loro. Basti considerare il modo in cui un aspetto fondamentale della pedagogia di
Herbart, e cioè quello della unificazione di istruzione ed educazione nel concetto della istruzione
educativa è stato variamente sviluppato in contesti profondamente divergenti a seconda delle
finalità di volta in volta perseguite dal punto di vista educativo. Da Ziller, ad esempio il quale
privilegia una prospettiva educativa di tipo rigidamente confessionale, o dagli herbartiani del nord
America tesi a consolidare valori più direttamente connessi ad un progetto di armonizzazione
delle profonde differenze presenti nella società americana alla fine dell’Ottocento. Mi fermo qui,
per dare spazio agli altri momenti, non senza ringraziare ancora una volta Nicola Siciliani e tutti i
partecipanti.
Nicola Siciliani De Cumis: Grazie a te. Mi sembra ampiamente confermato il potenziale
euristico del lavoro di Volpicelli. E vorrei ci fossero interventi del pubblico a confermarlo nel
dibattito. Penso anche, però, che la stessa lettura di testi che seguiranno, a cura di Giorgio Spaziani
e di Daria Siciliani de Cumis, potranno fornire utili elementi. Egualmente, il filmato messo assieme
da Domenico Scalzo e Tiziana Pangrazi farà rivivere visivamente il mondo di Labriola. Conviene
quindi dare la parola a chi la chiede.
Bruno Bellerate: Ho accennato incidentalmente al problema e studio delle lingue. Gli autori
vanno affrontati “in lingua” – in questo Volpicelli ci ha dato un ottimo esempio –, perché le
traduzioni sono “tradimenti”. Io direi sempre (ottimisticamente!) non voluti, ma è pressoché
inevitabile che sia così. Non mi riferisco, ovviamente, a Volpicelli, anche perché non ho esaminato
direttamente le sue traduzioni. Posso invece riferirmi a me stresso, che ho preso non pochi
“granchi” o a traduzioni anche più famose: del Dewey, per esempio, in Democrazia e educazione, che
è piena di errori e non indifferenti, di cui si dovrebbe tener conto (e non lo si fa!), per non incorrere
in falsificazioni del suo pensiero.
Questo avviene, di solito, perché, come spiegava prima Spadafora, molto spesso non si studiano
gli autori nella loro lingua, in originale, ma li si “interpretano”, servendosi di manuali, di saggi di
seconda mano, oppure di traduzioni. Potrei fare mille esempi di traduzioni fasulle.
Lo ribadisco: io non ho esaminato le traduzioni di Volpicelli. Mi auguro che siano perfette. La
perfezione, però, non è di questo mondo.
Di questi sbagli, purtroppo, io stesso mi sono reso conto piuttosto tardi, ma, ripeto, in qualche
modo sono inevitabili. Per fare una traduzione più “garantita”, non dico perfetta, bisognerebbe
essere in due, almeno al momento della sua revisione: uno che legge l’originale e l’altro che segue
la traduzione. Così facendo però aumentano i costi e – come avete sentito in precedenza – gli
editori non sono molto propensi a spendere. E allora si continua ad andare avanti come prima, per
inerzia.
Ignazio Volpicelli : Sono d’accordo con quest’ultima annotazione del professor Bellerate. Io ho
tradotto tanti autori e so bene che la traduzione non consiste, semplicemente, nel rendere qualcosa
in un’altra lingua, ma è anche, per così dire, un processo di “rimeditazione”, di elaborazione.
Quindi, in effetti, ogni traduzione si discosta necessariamente dall’originale, anche perché nella
traduzione c’è un’interpretazione. D’altra parte esistono dei termini che a volte non sono
traducibili. Questo succede anche con Herbart. Per alcuni termini io mi sono richiamato alle
traduzioni esistenti, comprese quelle che ha fatto Bellerate, anche se, come lui, penso che si
rimanga sempre parzialmente insoddisfatti, perché, magari, si potrebbe trovare un termine più
adeguato. Ogni termine, poi, ha una sua radice che richiama altri termini. A volte ci sono giochi
linguistici che diventa impossibile tradurre.
A questo punto va precisato meglio il significato da dare al termine “epigoni”. Epigoni non vuol
dire, evidentemente, “entusiasti”, “seguaci” o “seguaci pedissequi”. Ma significa – ed in questo
forse ho forzato un po’ il significato del termine – persone che comunque si sono interessate, che
hanno considerato… [incomprensibile]. È questo il caso di Spaventa, il quale è un idealista, però è
un idealista che si richiama molto a Kant e che si interessa di Herbart soprattutto nella misura in
cui vede, ad esempio, alcune affinità – innanzitutto per quanto riguarda il tema del
“cominciamento” della filosofia – tra Herbart ed Hegel. È il caso, inoltre, dell’interpretazione che
Tocco dà di Herbart. Tocco, non a caso, è un neokantiano, finisce con l’approdare al neokantismo.
E quindi, evidentemente, la sua lettura di Herbart risente di talune tematiche kantiane.
In tutti questi autori c’è un tentativo non tanto di definire Herbart o di etichettarlo, quanto, più
che altro, di cercare di interpretarlo e di coglierne quegli aspetti che più possono essere utili allo
sviluppo di determinate tesi. Quindi, anche la lettura è sempre una interpretazione, più che una
lettura tout court, la pretesa di dire ciò che Herbart ha detto. Non è questa lettura che questi autori
compiono, ma è come Herbart può essere utile per affrontare alcuni nodi cruciali. Per esempio, la
lettura che Credaro fa di Herbart o degli herbartiani è direttamente funzionale alla “apertura
pedagogica”, alla funzione che, appunto, Credaro intende far svolgere alla pedagogia nel mondo
della scuola italiana. Viceversa, altri autori vedono in Herbart altre prospettive. È il caso di
Spaventa, il quale, a proposito del problema del “cominciamento” in filosofia, cerca di conciliare
Hegel con Herbart. Spaventa è un grande conoscitore soprattutto dei problemi che sono legati alla
fenomenologia. La sua lettura di Herbart è una lettura che va in questa direzione. Esiste, in altri
termini, anche uno spostamento di Spaventa verso certe posizioni; non dimentichiamo che,
nell’ultimo periodo della sua vita, Spaventa traduce e introduce Lotze in Italia.
Nicola Siciliani de Cumis: Trovo molto importanti l’intervento di Bellerate e la risposta e
l'integrazione di Volpicelli. Perché? Il primo valore che viene fuori da questo dialogo è la questione
della trasparenza dei termini del problema. Bisogna avere cioè sempre presente, non fosse altro
che come riserva mentale, che la traduzione, qualunque, traduzione “invecchia”: anche la migliore
delle traduzioni possibili, fatte in un certo momento, da un determinato traduttore bravissimo,
siccome cambia la lingua dei possibili fruitori, inevitabilmente, finisce col perdere quella patina di
oggettività relativa, storica che pur poteva avere. Insisto, quindi, su questo valore traduttorio
relativo, storico.
Il “punto di vista”, diceva prima Volpicelli. Io dico di più: l’ideologia del traduttore. Il “punto
di vista” non è soltanto un fatto fisico, fisiologico, ma è un fatto di cultura. Per cui, di volta in volta,
in presenza di un vero problema interpretativo, qualunque traduzione deve esser rifatta.
Qualunque traduzione. In questo può essere utile… con tutti gli strumenti, perfino con l’aiuto dei
traduttori, con il controllo di altri esperti, ovverosia con l’ammissione continua dei propri limiti. La
scienza è “limite”. Il problema è questo. Soprattutto se poi vogliamo inserire questo discorso –
come oggi mi sembra sempre più necessario fare – in termini planetari. Se vogliamo pensare
mondialmente dobbiamo avere a che fare continuamente con i nostri limiti di cultura, in quanto si
tratta sempre di sistemi di cultura che incontrano altri sistemi di cultura. Quindi, non è mai un
fatto semplice ma è un fatto complesso, che si sposa ad un altro fatto complesso. C’è, dunque,
questo inevitabile gioco tra quello che vuol dire l’autore… e c’è anche un altro elemento, che
sembrerebbe eliminabile, ma che, di fatto non lo è, cioè il “destinatario”. Quando si fa una
traduzione, per quanto il traduttore voglia essere oggettivo, per quanto cerchi di rendere assoluto”
il dialogo tra se stesso, che traduce, e l’autore che sta traducendo e inevitabile confrontarsi con una
domanda ben precisa: per chi si sta traducendo? Che fine farà questo discorso? Come verrà letto
dai competenti, ma anche dagli incompetenti? Gli educatori, soprattutto, non possono non avere
presente questa dimensione. A tal proposito, sarebbe interessante – se fosse presente in sala –
conoscere il parere di un traduttore di professione, specializzato, in quanto tale, nel ridurre al
minimo l’interferenza ermeneutica, l’interferenza dell’interpretazione.
Un’ulteriore notazione va fatta a proposito di Labriola e del fatto che egli conosce il tedesco.
All’inizio lo ha imparato da autodidatta, in seguito con l’aiuto della moglie, tedesca, che lo
costringe anche a scriverle delle lettere d’amore in tedesco. In questo senso, Rosalia è una
pedagoga eccellente. Tanto che, alla fine, come ha scoperto Volpicelli, Labriola ha letto e ha
transunto i testi herbartiani direttamente dal tedesco.
Insisto, dunque, sulla complessità del problema della traduzione e, soprattutto, sulla
oscillazione dell’uso di quello che andiamo facendo di volta in volta: l’uso scientifico esige delle
cautele, l’uso divulgativo ne esige altre.
Infine, ricollegandomi al filmato che abbiamo visto in precedenza, bisogna tener conto anche
del fatto che la traduzione avviene a tanti livelli: c’è anche una traduzione per immagini, c’è una
per altri registri linguistici ecc. Questi costituiscono l’ordito della ideologia del traduttore, che alla
fine può essere controllata solo alla luce della critica e dell’autocritica. Quindi: da una parte, c’è la
trasparenza dei limiti, dei paletti, del punto di vista, degli obiettivi, dall’altra, il lavoro della critica,
in quanto si tratta di spersonalizzare il più possibile il discorso e far intervenire le competenze
interdisciplinari, gli altri, la collegialità, la comunità scientifica (che, in conclusione, decide dei
risultati).
Marta Fattori: Anzitutto, vorrei fare i complimenti a quanti hanno realizzato il documentario su
Labriola perché lo ho trovato di altissimo livello, da tutti i punti di vista (immagini, lettura e
musica).
Per quanto riguarda il problema della traduzione vorrei dire, in primo luogo, come esperienza
di vita, che da quando avevo quattordici anni ho sempre voluto e desiderato conoscere il russo per
leggere in lingua originale Tolstoj, e in particolare Guerra e pace, un’opera assolutamente
straordinaria. Purtroppo, non lo ho mai imparato. Questo non toglie, tuttavia, che, pur con tutti i
limiti della traduzione, Guerra e pace rimanga un capolavoro.
Venendo invece all’aspetto scientifico, bisogna dire che per tradurre bene – e mi riferisco
esclusivamente ad opere scientifiche, non a testi poetici o letterari – non è sufficiente conoscere
bene le lingue: i grandi traduttori spesso sono persone che parlano non bene la lingua della quale o
nella quale traducono. Certo va conosciuta. Però va conosciuto l’autore, bisogna essere persone di
cultura, bisogna cercare di essere quanto più possibile lontani da qualsiasi ideologia. Anche se mi
rendo conto che non è sempre facile.
Credo che dal punto di vista scientifico sia estremamente importante aver sempre presenti le
difficoltà che esistono nel tradurre un termine particolare. Faccio un esempio che conosco bene:
circa vent’anni fa, quando è tradotto in francese il Novum organon di Bacone, i francesi hanno avuto
difficoltà, perché Bacone usa i termini latini experimentum e experientia. Ora, mentre in italiano, in
inglese ed in molte altre lingue esistono le due parole corrispondenti (esperienza ed esperimento),
in francese esiste soltanto il termine expérience. Questo, ovviamente, cambia totalmente un testo
come il Novum organon che è basato sulla distinzione tra esperienza ed esperimento.
Gli inglesi stanno ritraducendo nell’inglese moderno tutti gli autori inglesi del Seicento e del
Settecento. Questa esigenza risponde a quello che prima è stato definito l’audience. Da un lato, cioè,
c'è la filologia, c’è l’esigenza del rispetto dell’autore, dall’altro c’è quella di far sì che questi autori
vengano capiti.
Per quanto riguarda l’italiano, si potrebbe avere un problema simile con Giordano Bruno.
Naturalmente, dal punto di vista scientifico, è chiaro che un Giordano Bruno che parlasse l’italiano
contemporaneo non sarebbe più Giordano Bruno. Di questo problema il mondo anglosassone è
pienamente cosciente e, anzi, esso viene chiaramente esplicitato. Tuttavia, nonostante ciò, si ritiene
importante tradurre tali autori e tali opere in un inglese comprensibile a tutti.
Esiste, viceversa, un problema estremamente rilevante, anche per quanto riguarda gli autori dei
quali stiamo parlando, che è quello della consapevolezza di tradurre un testo importante – perché
si vuole che esso sia diffuso – con un certo tipo di [incomprensibile]. Da questo punto di vista, ad
esempio, le traduzioni di Kant in italiano sono assolutamente esemplificative.
Il problema, pertanto, è sempre quello della consapevolezza (sia da parte del traduttore che da
parte dell’utente), quello di sapere – come del resto si deve fare ogni volta che si legge un libro –
che cosa c’è dietro. Quindi, più si conosce e meglio è.
C’è poi – e anche questa è una cosa alla quale si deve prestare attenzione, soprattutto per
quanto riguarda gli autori del Seicento, del Settecento e dell’Ottocento – anche estremamente
significativo. [Frase trascritta correttamente]. Faccio, anche in questo caso, un esempio. La prima
edizione del saggio di Locke è in inglese. Dal momento che allora l’inglese era una lingua
sconosciuta ai più, in Europa il saggio di Locke viene diffuso e conosciuto attraverso la traduzione
francese di Cost [???]. In questa traduzione, però, “natura” viene tradotto con “Dio”. Questo
significa che il Locke conosciuto in Europa è il Locke di Cost [???], con la terminologia filosofica di
Cost [???]. Questo ha avuto una notevole importanza nella storia della filosofia moderna e
contemporanea.
Per quanto riguarda il problema posto da Nicola Siciliani de Cumis tengo a dire che
recentemente ho avuto un’esperienza estremamente complessa con la traduzione italiana di
quell’opera stupenda che è Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore di Comenio. Non conoscendo
io il ceco – anche se conosco, parola per parola, Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore
nell’edizione originale – non ho potuto fare io la traduzione. L’ha fatta, invece, un ottimo
traduttore di ceco che però non conosceva molto bene né italiano né Comenio. È stato, quindi,
veramente, un “lavoro a tre”, una traduzione a più mani. Questo per dire che la conoscenza della
lingua non è di per se stessa sufficiente per una buona traduzione.
Marco Antonio D’Arcangeli: Mi sembra che il volume di Volpicelli, nel mentre che soddisfa le
esigenze dello “specialista”, ripercorrendo con analiticità e rigore genesi, sviluppi, interne
articolazioni dell’esegesi e delle “scuole” herbartiane, fra paesi di lingua tedesca e contesto
filosofico e pedagogico italiano, riesca altresì a proporre un’efficace introduzione al pensiero
dell’oldenburghese, risultando, dunque, fruibile e godibile anche da un “lettore medio”. Credo
vada sottolineata la duplice valenza, scientifica e “didattica”, di questo lavoro – che sotto questo
profilo, fra l’altro, fa pensare allo Herbart di Credaro.
Una seconda notazione che vorrei fare si ricollega a quelli che sono i miei interessi e i miei studi:
Credaro, appunto, e lo herbartismo, il “kantismo”, il neokantismo, con particolare riferimento
all’Italia. A me sembra che il valore del lavoro compiuto da Volpicelli risieda anche nel fatto che
evidenziando l’entità e la pregnanza della penetrazione delle idee herbartiane nel nostro contesto
culturale a partire dall’Unità, da Spaventa in poi, contribuisce in maniera decisiva a promuovere
una rilettura della storia della pedagogia, e della filosofia, italiane, fra Diciannovesimo e
Ventesimo secolo. Suggerisce, inoltre, tutta una serie di prospettive utili anche per reinterpretare
quel neokantismo di cui furono esponenti, nel campo storiografico–filosofico, i vari Francesco
Fiorentino (per certi aspetti), Felice Tocco e via dicendo, nel tardo Ottocento, e poi i loro allievi
novecenteschi, che scelsero la via della riflessione educativa, e confluirono nella “Rivista
Pedagogica” (che uscì dal 1908 al 1939).
In altri termini, Volpicelli ha posto in luce, con evidenza, “quanto” Herbart ci sia in tanta
filosofia e pedagogia italiana; e numerosi testi che sono stati analizzati, sin qui, senza prendere in
considerazione la “circolazione” delle idee dell’oldenburghese, andranno ora senz’altro
riesaminati alla luce di questo nuovo elemento. E una “rilettura” in questa chiave s’impone, a mio
avviso – per ribadire e rafforzare quanto detto sopra – soprattutto per la filosofia e la storiografia
filosofica dei neokantiani del secondo Ottocento, e per la filosofia dell’educazione e la pedagogia
dei neokantiani protagonisti dell’esperienza della “Rivista Pedagogica” del primo Novecento.
Nicola Siciliani de Cumis: La competenza specifica che Marco D’Arcangeli testimonia su
Credaro pone un grosso problema, alla luce delle cose che sono state dette ieri e stamattina. Ieri, a
più riprese, sono stati ribaditi l’antineokantismo di Labriola e la distinzione – si è detto – del suo
atteggiamento, negativo verso il neokantismo, indubbiamente complesso e positivo, a tanti livelli,
– come dimostra anche il libro di Volpicelli – nei confronti dello herbartismo.
Credaro, in questo senso, è un ibrido. E Credaro, tra l’altro, viene chiamato dallo stesso Labriola
a succedergli. Negli ultimi anni, quando Labriola comincia a star male e si rende conto che avrà
vita breve, cerca di pilotare la successione. Cerca, dunque, la persona più degna e più adatta a
continuare il suo lavoro (anche se era sicuramente estranea a Labriola l’idea di costruirsi in vitro
uno scolaro che lo scimmiottasse). A tal fine, si chiede, innanzitutto, quali erano le persone di
cultura tedesca, neokantiana, herbartiana? E c’è da dire che probabilmente non aveva neppure
molta scelta, anche perché alcuni di coloro che potevano succedergli erano già stabilmente
sistemati in altre città e in altre università.
Il problema che ha D’Arcangeli di ricostruire Credaro per quello che veramente è stato si
incrocia, pertanto, con la questione della coesistenza e della interna articolazione/opposizione tra
neokantismo ed herbartismo. A tal proposito, desidererei conoscere la sua opinione, perché io
stesso vedo bene i termini del problema ma non ho assolutamente gli strumenti per rispondere con
serietà.
Marco Antonio D’Arcangeli: La questione posta dal professor Siciliani è estremamente
complessa; e anche la “successione” romana del 1902 presenta aspetti non lineari, elementi
contraddittori – così come il rapporto Credaro–Labriola, nel suo insieme. Diversi elementi vengono
emergendo, senza dubbio: ma il quadro risulta ancora piuttosto frammentario. Ad esempio,
esaminando i verbali delle adunanze del Consiglio di Facoltà, sembrerebbe che la chiamata di
Credaro sia stata certamente favorita, ma non per questo particolarmente caldeggiata da Labriola.
Bisogna precisare che il cassinate aveva tutto l’interesse a far sì che la domanda di trasferimento di
Credaro fosse accettata, in quanto la sua istanza di passaggio alla cattedra di Filosofia teoretica non
avrebbe potuto essere accolta sino a che non si fosse trovato un sostituto per Pedagogia. Ma
Labriola in occasione del Consiglio di Facoltà decisivo per l’arrivo di Credaro, mostra di non
conoscerne gran che la produzione scientifica, attribuendogli pubblicazioni «quasi tutte
pedagogiche», mentre il valtellinese vantava titoli non trascurabili di storia della filosofia
(disciplina che, del resto, insegnava da più di dieci anni all’Università di Pavia).
Ignazio Volpicelli: Rispetto al problema della “contraddizione” tra l’antineokantismo di
Labriola e la sua adesione alla posizione di Herbart ritengo che, probabilmente, queste prese di
posizione di Labriola siano spesso anche delle prese di posizione politiche. È un po’ quello che
succede con Spaventa, il quale prende delle posizioni che non sono semplicemente posizioni di
tipo speculativo, ma che sono relazionate a quella che è la posizione della politica italiana.
Nicola Siciliani de Cumis: Io ho una curiosità. Il professor Spaziani insegna presso
l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Varie volte abbiamo parlato
dell’ipotesi di tradurre in termini drammaturgici, di teatro, gli argomenti disciplinari della scuola
media di ogni tipo. Vorrei chiedere a Giorgio Spaziani che cosa è stato per lui come attore questa
esperienza di “traduttore” nei suoi termini di testi abbastanza lontani da quelli che di solito
utilizza. Labriola è un lettore di Shakespeare, ma come credenziale credo non basti. Volevo sapere
che opinione può esprimere su questa sua esperienza eccentrica.
Giorgio Spaziani: L’organizzazione della comunicazione drammaturgica passa per inizio,
centro e fine. Tuttavia, non è sempre facile trovare l’inizio, il centro e la fine in alcuni tipi di testi
piuttosto complessi. La difficoltà sta nel riuscire ad analizzare questi punti e a metterli in risalto
con cambi di intonazione, con passaggi vocali. In realtà la recitazione di questi testi, come di altri,
si può risolvere semplicemente nel cercare di ripercorrere il ragionamento della persona che ha
scritto il pezzo. Tuttavia, quando ci si confronta con personaggi del livello di Labriola, ripercorrere
lo stesso ragionamento è questione abbastanza complessa. Ciò che abbiamo fatto, seppur con i
modesti mezzi e con la buona volontà di tutti, è un primo passo. C’è qualcuno che ha fatto
esperimenti e che ha messo in scena testi al limite dell’impossibile. Questo è un luogo privilegiato
di ricerca e di sperimentazione per la comunicazione drammaturgica. Spero che ci saranno altre
occasioni per portare avanti questo discorso. Sarebbe interessante andare oltre al mettere
semplicemente insieme video, musica e recitazione. Penso ai futuristi e penso al teatro tattile in cui
si passava con una sorta di tabernacolo al cui interno c’erano dei pezzi di stoffa, di spugna, di
spugna naturale. Il teatro tattile veniva mostrato all’ignaro spettatore che naturalmente doveva
toccarlo. Successivamente si chiedeva all’uditorio di esprimere le proprie impressioni. Mi
interesserebbe fare esperimenti di questo genere e anche più spericolati. Spero ce ne sia l’occasione.
Nicola Siciliani de Cumis: Il professor Spaziani, con i suoi collaboratori, lavora da anni a Casal
del Marmo, nelle carceri. Egli fa un’esperienza pedagogica attraverso il teatro e questo è stato, tra
l’altro, anche il motivo per cui ci siamo incontrati.
Un aspetto, in particolare, è stato importante nella collaborazione con i due attori. Essi non si
sono limitati a raccogliere dei testi che io ho dato loro da leggere. Io ho proposto dei testi molto
ampi e ho chiesto loro di selezionare la parte che ritenevano più utile. Una volta fissato il tetto di
sopportabilità dei venticinque minuti della performance teatrale, e avendo una base testuale, il
problema era di ottimizzare la traduzione. La soluzione stava nel trovarsi in presenza di attori
intelligenti, colti, e non solo degli esecutori e nel farli diventare in qualche modo collaboratori. Io
ho cercato di invadere il meno possibile il campo, anche se, fino all’ultimo minuto, abbiamo
giocato sul rigo, sulla parola, per ottimizzare il prodotto. Dunque, non si è trattato soltanto di un
lavoro di esecuzione, esecuzione poi nel senso di esecuzione d’orchestra, ma di composizione.
Sessione pomeridiana
Nicola Siciliani de Cumis: Riprendiamo i lavori. Comincerei con l’osservare che questo
pomeriggio l’uditorio è notevolmente cambiato. Direi, poi, che in tutti questi giorni sono prevalsi
l’idea di parlare di Labriola come oggetto di studio e il sottinteso di mettere l’autore al suo posto,
nel suo tempo. Questa sera, invece, ci occuperemo prevalentemente di noi, piuttosto che di
Labriola. Nel senso che ciò di cui parleremo riguarda le attività di studio della Cattedra romana di
Pedagogia della “Sapienza”, in quanto si collegano variamente alla lezione labrioliana e in quanto
ne riferiscono gli effetti. I risultati scientifici e didattici, sia in senso storico–filosofico sia in senso
metodologico e sperimentale, di cui siamo responsabili nella Facoltà di Filosofia e, soprattutto, nel
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione vanno in questa direzione. Così il
“Laboratorio Labriola”, con le sue numerose ricerche, tesi di laurea, tesine d’esame, ecc., fornisce in
qualche modo la prova di un indotto labrioliano a lunga scadenza. Il libro di Alessandro Sanzo
(L’officina comunista. Enrico Berlinguer e l’educazione dell'uomo) rientra in questo quadro. Egualmente
vi rientra la collana “Diritto di stampa” e la presentazione che ne facciamo adesso con gli amici
Renato Maggiore, che rappresenta l’editore Aracne, e Luigi Punzo, che è qui per almeno tre
ragioni. Punzo è un collega romano solo “imprestato” all’Università di Cassino; in secondo luogo,
egli rappresenta la cerniera delle attività del Comitato Scientifico per le celebrazioni labrioliane del
2004; infine, egli è un militante di partito, del partito di Berlinguer. Per questi motivi gli darei
subito la parola.
Luigi Punzo: Anzitutto, ti ringrazio per avermi prescelto, anche se in modo un po’ proditorio,
in quanto reputo irrilevanti almeno due delle tre motivazioni.
Nicola Siciliani de Cumis: Quali?
Luigi Punzo: Mi ha in qualche modo “incastrato”, moralmente e psicologicamente, il mio
passato, la mia “biografia”, in cui è presente un forte impegno politico.
Debbo premettere, tuttavia, che l’idea di partecipare a questa presentazione dell’opera di Sanzo
mi ha inizialmente procurato un certo imbarazzo. E questo, chiaramente, non per il lavoro in se
stesso – L’officina comunista, infatti, è un libro molto interessante e ben costruito, merito dell’autore
e di chi lo ha guidato nella ricerca –, quanto per il fatto che presentarlo nell’ambito delle
celebrazioni per il centenario della morte di Antonio Labriola poteva sembrare una forzatura. Ma
così non è, in quanto esistono – e tu lo hai spiegato molto bene – validi motivi per vedere
intrecciata questa iniziativa con le celebrazioni labrioliane.
Nicola Siciliani de Cumis: Non va dimenticato, tra l’altro, che quest’anno ricorre anche il
ventennale della morte di Enrico Berlinguer.
Luigi Punzo: Entrando nel merito del lavoro, è opportuno cominciare dalla fine,
dall’Appendice. Nel volume di Sanzo è presente, infatti, un’interessante appendice – illuminante,
tra le altre cose, su tutta una serie di spunti presenti nel libro – in cui ci si occupa dell’attività
formativa in carcere e al confino dei comunisti italiani e dei dissidenti antifascisti. Si tratta, a mio
avviso, di una traccia, di un inizio ricerca che merita senz’altro di essere sviluppata e approfondita.
Tra i nomi che vi si citano c’è quello di Camilla Ravera, la quale, tra l’altro, è stata confinata a
Ponza. Nello specifico, Sanzo ricorda proprio l’attività pedagogica della “maestrina” Ravera. Io ho
avuto la fortuna di conoscere Camilla Ravera e di ascoltare molti dei suoi racconti, delle sue
testimonianze. Ne ricordo in particolare due. La prima è relativa alla sua fraterna amicizia con
Antonio Gramsci nella Torino operaia che viveva l’esperienza dell’«Ordine Nuovo». Gramsci –
raccontava Camilla Ravera – pur essendo un organizzatore meticoloso, quasi “spietato”, del lavoro
politico e del lavoro di redazione del giornale dell’«Ordine Nuovo», arrivava quasi sempre in
ritardo alle riunioni di redazione perché si attardava a parlare con gli operai. Arrivava tardi perché
si fermava a discutere con gli operai, perché cercava di compiere quell’opera pedagogica che, in
qualche modo, è rimasta poi esemplare per i quadri dirigenti del Partito comunista italiano e che
costituisce, giustamente, il filo rosso dell’Officina comunista. La seconda testimonianza riguarda
Berlinguer. “Io – mi raccontava Ravera – conoscevo Mario Berlinguer (il padre di Enrico), il quale
mi parlava spesso di questo suo figlio che quasi lo preoccupava, perché non faceva altro che
studiare (in particolare i classici del marxismo) e me lo raccomandava affinché lo “mettessi in
azione”.
Ho voluto ricordare questi due episodi perché, a mio avviso, il tratto che Sanzo ricostruisce
della tradizione del Partito comunista italiano, in cui Berlinguer si cala interamente, mette in
evidenza proprio questa funzione pedagogica del Partito. Credo, inoltre, che ci si trovi di fronte ad
una caratteristica “genetica”; una caratteristica che ho voluto ricordare attraverso la testimonianza
diretta di Camilla Ravera, protagonista, non soltanto di quella vicenda storica, ma della storia del
PCI e del nostro paese.
Un’altra osservazione da fare, per quanto concerne il volume che stiamo presentando, riguarda
la “leggenda” secondo la quale Berlinguer era iscritto direttamente alla Direzione del Partito.
Ebbene, L’officina comunista contribuisce a sfatare definitivamente questa leggenda. Dal lavoro di
Sanzo, infatti, emerge un Berlinguer giovane che, anche in Sardegna, si danna l’anima, non solo
nello studiare, ma nel fare attività politica (la più diretta, la più umile); traspare un Berlinguer che
insegna i principi comunisti e si impegna a pieno nella lotta quotidiana. Il libro di Sanzo, inoltre, in
quanto abbraccia un periodo limitato della biografia di Berlinguer (gli anni che vanno dal 1945 al
1956) riesce a darci uno squarcio della personalità di Berlinguer in gran parte sconosciuta. Ed è
proprio questo, a mio avviso, il primo importante contributo storiografico che Sanzo dà con questo
suo volume.
Occupandosi del primo decennio di vita repubblicana, Sanzo tratteggia, fondamentalmente,
l'impegno dell’Enrico Berlinguer dirigente della FGCI, vale a dire dell’organizzazione giovanile del
Partito comunista. Ciò viene fatto, non soltanto ricostruendo la storia della FGCI e di Berlinguer –
un’operazione che sarebbe stata chiaramente riduttiva –, ma ponendo questa storia nel Più ampio
contesto della storia del Partito comunista e in rapporto a quelli che sono gli sviluppi della società
italiana nel secondo dopoguerra. A tal proposito, non posso esimermi dal fare una piccola
annotazione critica, utile anche per un’eventuale prosecuzione o approfondimento del lavoro:
ritengo che sarebbe stato opportuno tenere maggiormente in considerazione il contesto storico
della società italiana nel suo complesso. Si corre il rischio, altrimenti, di vedere la storia del
decennio ‘45–‘56 e, più in generale, della società italiana con la lente, con il filtro della storia del
PCI. Si tratta – è bene precisarlo – di un suggerimento, più che di una critica vera e propria;
suggerimento che potrà tornare senz’altro utile anche per una lettura più complessiva della figura
di Berlinguer.
L’impegno di Berlinguer nella FGCI si esplicita anche nell’assunzione di responsabilità per
quanto concerne la costruzione di quello che Palmiro Togliatti definisce il “partito nuovo”. Il
“partito nuovo” costituisce, di fatto, la rottura lo schema dell’Internazionale comunista, con l’idea
del “partito guida”, dello “Stato guida” (l’Unione Sovietica) e l’avvio di quella che lo stesso
Togliatti definisce – e qui gli echi gramsciani sono quanto ami evidenti – la “via italiana al
socialismo”. Enrico Berlinguer, anche nella FGCI, lavora alla costruzione di questo “partito
nuovo”. Ed è significativo, tra l’altro, come ha opportunamente segnalato anche Sanzo, che la
prima importante ed impegnativa esperienza di Berlinguer come dirigente di partito non avvenga
a Roma ma a Milano (circostanza che sfata ulteriormente la già richiamata leggenda dell’iscrizione
di diritto alla Direzione del Partito); avviene, cioè, in un contesto molto più complesso di quello
romano, ormai pressoché interamente assorbito dalla politica dei partiti. A Milano, infatti, erano
ancora fortissime le spinte contraddittorie per uscire dallo stato di una situazione insurrezionale
(la Resistenza) e avviarsi verso la democrazia.
Con l’esperienza milanese, in particolar modo con la costruzione di quel Fronte della Gioventù
che prevedeva l’apertura del Movimento giovanile comunista a tutte le componenti ideologiche
del mondo giovanile, Berlinguer contribuisce notevolmente alla conquista e alla costruzione della
democrazia. Nel libro di Sanzo, a tal proposito, viene riportato un passo tratto da un importante
intervento di Berlinguer nel quale si contesta la “chiusura” della gioventù comunista al proprio
interno, la ritrosia ad aprirsi agli altri. Questa apertura alla società rappresenta per Berlinguer lo
strumento fondamentale per passare (per uscire) dalla clandestinità resistenziale alla luce del sole,
per avviare un processo di democratizzazione reale.
Per costruire il “partito nuovo” è necessario però costruire un “uomo nuovo”; in questo senso,
ho molto apprezzato che L’officina comunista sia dedicato proprio “All’uomo nuovo, ch’è in ognuno
di noi”. La qual cosa, naturalmente, ci conduce ad un discorso etico–politico e, in profondità,
assolutamente pedagogico: Berlinguer e i comunisti italiani ritengono che per costruire la “società
nuova” bisogna costruire/modellare gli uomini che la edificheranno. Si tratta, con tutta evidenza,
di un processo difficile e per nulla lineare che può essere pienamente compreso, in particolare per
quanto riguarda il lavoro compiuto da Berlinguer nel periodo 1945–‘56, soltanto se esso viene
contestualizzato e se si tiene debitamente conto della visione generale della società e della realtà
propria di Berlinguer. Mi riferisco a quella parte dell’Officina comunista in cui si affronta il tema
della (si “sottolinea” la) caratura ideologica dei discorsi sulla educazione e sulla politica che
venivano svolti dal PCI nel suo complesso e, nel contesto di questa discussione, dallo stresso
Berlinguer. Il tema, come si sa, è stato variamente e lungamente affrontato, talvolta con cattiveria e
pesantezza, altre con distanza critica; pertanto, non ritengo opportuno entrare nel merito. Tengo a
dire, però, – e Sanzo lo dice con molta chiarezza, citando numerosi scritti e discorsi berlingueriani
– che Berlinguer era “marxista–leninista credente” e che, come molti comunisti, anch’egli era
affascinato dalla personalità di Stalin.
Non bisogna assolutamente meravigliarsi: nel contesto della “guerra fredda”, infatti, era quasi
inevitabile che fosse così. Ciò nulla toglie, tuttavia, al fatto che Sanzo abbia fatto benissimo a dire
che questo comporta una diseducazione, comporta l’idea che, in qualche modo, si veda tutta la realtà
con una “lente” che mostra – alla luce di certe credenze, di certe illusioni (“il sol dell’avvenire”) –
una realtà deformata. Allo stesso tempo, però, per le cose che dicevo sull’impegno di Berlinguer
nel e per il “partito nuovo” e per la realizzazione del sistema democratico, che necessariamente
prevedeva la crescita e la costruzione di un uomo nuovo, accanto all’aspetto ideologico va
sottolineato l’elemento dell’utopia. Penso, beninteso, ad un’utopia positiva; a quell’utopia che –
richiamando la distinzione fatta da Karl Mannheim – si contrappone all’ideologia come sistema di
idee bell’e pronte, a cui ci si adegua. Mi riferisco, in altri termini, all’utopia come tensione verso
una realtà diversa da quella in cui si vive, che non si condivide. Una tensione presente, certamente,
anche in Berlinguer, ché altrimenti non si capirebbe questo suo impegno, questo suo sforzo
continuo, questo suo pungolo; Berlinguer, infatti, non esita a criticare le manchevolezze
dell’attività del suo partito e dei giovani comunisti. Si tratta, in definitiva, di una tensione verso il
socialismo, verso l’attuazione del socialismo e della democrazia.
Quanto detto per il periodo 1945–56 si comprende meglio e fino in fondo se pensiamo al
cosiddetto “strappo” di Berlinguer e al fatto che egli allora parlò di un “esaurimento della spinta
propulsiva della Rivoluzione d’Ottobre”. Berlinguer si rese conto che quel rinnovamento, quella
costruzione dell’uomo nuovo per cui aveva lottato, prendendo ad esempio anche l’esperienza
socialista sovietica, aveva ormai fatto il suo tempo, si era esaurita e che, pertanto, bisognava
trovare nuove vie. In molti, a questo proposito, si sono chiesti se questa riflessione/posizione di
Berlinguer sia stata il frutto di coerenza o se, piuttosto, non abbia segnato l’avvio di un processo di
revisionismo. Tenendo conto che si tratta di un interrogativo serio e importante, io credo che per la
sua formazione, per la sua coerenza e per la profondità con la quale affrontava i problemi
Berlinguer non possa essere assolutamente tacciato di revisionismo; dovrebbe essergli
riconosciuto, semmai, lo sforzo di trovare nella storia gli elementi per andare oltre un’esperienza
che, in qualche modo, si ritiene esaurita.
Vorrei dire ora qualcosa a proposito del rapporto Berlinguer/Gramsci, un tema quanto mai
interessante, anche dal punto di vista propriamente pedagogico. Ritengo, infatti, che uno studio
sull’influenza della “lezione” gramsciana sul Berlinguer politico potrebbe portare a risultati
importanti. Dopo l’iniziale e parziale utilizzazione che Togliatti a fatto di Gramsci per legittimare e
rafforzare “la via italiana al socialismo”, Berlinguer ha contribuito a far emergere le grandi
potenzialità di pensiero politico presenti nelle riflessioni gramsciane. Per quanto concerne invece
l’aspetto pedagogico – messo opportunamente in evidenza da Sanzo –, vorrei richiamare la vostra
attenzione sul fatto che anche Berlinguer è fermamente convinto che non ci sia una sola agenzia
formativa delegata all’educazione e all’istruzione dei giovani. Le agenzie formative sono
molteplici, come complessa è la società nel suo insieme. Fra queste, a suo avviso, rivestono
particolare importanza il partito e la stampa (oggi diremmo i mass media) e, ancor prima e ancor
più, tutti i rapporti sociali materiali che la società esprime. Questa – come sapete – è una visione
che Gramsci aveva già individuato con molta chiarezza, e che Sanzo mette giustamente in
evidenza, con dovizia di citazioni.
L’ultima considerazione che vorrei fare riguarda le ragioni dell’inserimento della presentazione
di un libro come L’officina comunista, di una figura come quella di Berlinguer, all’interno di questa
commemorazione del pensiero di Antonio Labriola. Non intendo ripetere le cose giuste che hai
detto tu [Siciliani de Cumis], sottolineo, invece, un altro elemento che mi sembra importante.
Labriola si definiva ed è stato definito un “socialista teorico”, cosa che non si può certo dire di
Berlinguer, essendo egli innanzitutto un politico. Pur tuttavia, in Berlinguer esiste un nesso molto
stretto, molto forte tra il politico, l’intellettuale e il teorico (non arrivo fino al punto di dire il
filosofo, ma l’intellettuale certamente sì). Penso qui, prima di tutto, alle cose dette da Berlinguer
sugli intellettuali nel famoso discorso all’Eliseo, estremamente significativo a tal proposito. Pongo
proprio questo tema, perché, da Gramsci in poi, il rapporto intellettuali/politica ha rappresentato
un problema centrale per la cultura e per la sinistra italiana. Guardando all’oggi, tuttavia, questo
rapporto si è molto incrinato.
Ricordo un’intervista a Bobbio, riproposta di recente, in occasione della sua morte, nella quale,
al giornalista che lo intervistava e che gli chiedeva cosa pensava del rapporto tra intellettuali e
politici e se credeva che gli intellettuali potessero determinare in qualche modo l’azione dei
politici, Bobbio rispose che non vedeva un distacco totale tra l’azione degli intellettuali, dei
pensatori, dei filosofi e l’azione dei politici. Esse, a suo parere, andavano per linee parallele. Lo
stesso Bobbio, tuttavia, è autore di un’opera molto interessante e importante (Politica e cultura,
pubblicata da Einaudi), che per la nostra generazione è stata un punto di riferimento. In questa
raccolta di saggi Bobbio spiegava, forse in maniera pratica, concreta, quello che può essere
considerato il reale rapporto tra intellettuali e politica. Pur essendo vero – e Berlinguer, in qualche
modo, rappresenta una sintesi ciò – che non ci può essere un rapporto diretto, se non quando si
arriva al momento culminante, al momento rivoluzionario, io ritengo che il lavoro dell’intellettuale
debba essere sempre presente anche nell’agenda politica. Il vero intellettuale, infatti, è colui che in
qualche modo detta quel criterio del pensare critico che è fondamentale per uno sviluppo reale,
concreto della democrazia e del socialismo.
Dibattito
Nicola Siciliani de Cumis: Della interessantissima conversazione che ci ha proposto Luigi
Punzo io sottolineerei, anzitutto, l’attenzione per il tema della constestualizzazione; e lo farei
partendo proprio dalla questione dell’uomo nuovo, dalla frase posta in epigrafe a L’officina
comunista. Vale la pena di ricordare che Sanzo le sue suggestioni di ricerca le ha avute da un
contesto molto preciso: come ricorda lui stesso nell’Introduzione al volume, egli ha infatti
frequentato alcuni corsi su Labriola ed ha letto il Poema pedagogico. Vedete allora come una stessa
espressione si chiarisce (talvolta, però, può anche succedere che si complichi), se spiegata alla luce
di certe esperienze di contesto…
Sul «Corriere della Sera» di oggi c’è un’interessante nota sul nostro convegno, scritta da Aurelio
Lepre, che comincia affermando che tra Gramsci e Labriola esiste un salto, un abisso. Ciò rimanda,
evidentemente, sia a quanto dicevamo ieri sera che al contesto nel quale Berlinguer si è formato (in
particolare, alla famosa linea De Sanctis–Hegel–Labriola–Gramsci). Credo, ahimè, che Berlinguer
sia stato il frutto pedagogico anche di quella temperie. Capite bene, dunque, l’importanza di
contestualizzare.
La seconda cosa che volevo dire riguarda il fatto che l’utilizzazione di “Labriola oltre Labriola”,
proprio in quanto si tratta di Labriola, può significare anche utilizzare “Labriola contro se stesso”.
Provo a spiegare ciò che intendo dire, partendo dal fatto che L'officina comunista è una tesi di laurea
e che la collana “Diritto di stampa” non vuol essere nient’altro che una collana di tesi di laurea.
Ebbene, in Labriola – non a caso, nel Labriola del papuano – è presente un’idea ricorrente molto
forte: ai fini della didattica, la “pedagogica” non si deve occupare di ricerca. Secondo Labriola, in
altri termini, l’insegnante, per fare bene il proprio lavoro a scuola, non deve porsi troppe
domande. La ricerca, infatti, essendo elitaria, deve essere appannaggio degli studiosi e deve essere
nettamente separata dalla didattica. Tanto è vero che Labriola, insegnando Morale e Pedagogia si
sente scontento e si inventa Filosofia della storia, dove può essere più libero di insegnare a pochi
studenti, ma buoni, la “indisciplina”, non la disciplina.
Ecco allora spiegato il “Labriola contro Labriola”. Il nesso didattica–ricerca, visto
antilabriolianamente e gramscianamente – proprio in omaggio alla rottura tra Labriola e Gramsci
(la critica di Gramsci a Labriola per quanto concerne la questione dell’educazione del papuano la
dice lunga a tal proposito) –, si esplica nel fatto che i docenti, non ultimi quelli universitari, hanno
il dovere di far passare spicchi di ricerca, angoli di ricerca, frammenti di ricerca nella didattica. Si
tratta – me ne rendo perfettamente conto – di un’idea assolutamente minoritaria nel mondo in cui
viviamo, sulla quale, tuttavia, vale la pena di scommettere moltissimo.
La collana “Diritto di stampa”, in quanto espressione e contenitore di una didattica che si
“ricerchizza”, rientra a pieno titolo nella dimensione labrioliana del “Labriola contro Labriola”. Da
questo punto di vista, infatti, Labriola è quanto mai schizofrenico. Da un lato, egli sente tutto il
fascino del parlare con le sartine, con le padrone di casa e con le stiratrici (con le quali si mette
socraticamente alla pari), dall’altro lato, non esita a dividere nettamente la didattica dalla ricerca.
Proprio per quanto attiene un certo fatalismo e la necessità dei tempi lunghi in educazione sono
anni che mi sento in conflitto con un grandissimo pensatore com’è Labriola. E più il tempo passa,
più mi convinco che se noi non pensiamo–proponiamo–lavoriamo per i tempi brevi, i tempi lunghi
si allungheranno sempre più. Proponendo un modello di tipo accelerativo si può innescare, infatti,
una lotta tra il tempo lungo e il tempo accelerato, il tempo dell’utopia. Con la conseguenza che,
così facendo, si sfugge alla pesantezza della storia e può nascere qualcosa di veramente nuovo e
diverso dall’esistente. Da questo punto di vista credo che Berlinguer sia stato ancora un hegelo–
marxista tutto d’un pezzo.
In conclusione, collegato a quanto detto, chiederei al dott. Maggiore in che modo la casa editrice
Aracne (virtualmente una university press romana) vede l’esperienza che stiamo facendo con la
collana “Diritto di stampa”.
Renato Maggiore: Nell’aprile del 2003, prima di dar vita alla collana “Diritto di stampa”, in
redazione abbiamo discusso molto. I dubbi, sostanzialmente, riguardavano il fatto che si sarebbe
trattato di pubblicare delle tesi di laurea. Il pubblico elitario del mondo accademico – ci
chiedevamo – può essere interessato alle tesi di laurea? Contemporaneamente, eravamo coscienti
che pubblicare delle tesi di laurea comportava, innegabilmente, dei rischi.
A convincerci per la creazione della collana che stiamo oggi presentando sono state alcune
considerazioni riguardanti il mondo universitario. Io, ad esempio, per l’incarico che ricopro,
incontro quotidianamente decine di docenti universitari. Parliamo, evidentemente e
principalmente, delle pubblicazioni in cantiere; molto spesso, però, si finisce col parlare della
situazione dell’università e, in particolare, di quella “riforma” che, a torto o a ragione, viene
aspramente criticata. Molti professori hanno la sensazione che si stia puntando al ribasso,
qualitativamente intendo.
Comunque sia, al di là dei giudizi che se ne possono dare, la “riforma” ha investito anche le
case editrici universitarie, compresa Aracne. Anche per questo motivo, dunque, abbiamo sentito
l'esigenza di serrare il confronto con i docenti universitari, alla ricerca di quella “creatività” e di
quell'unità tra la ricerca e la didattica che possono costituire un filo conduttore anche per quanto
riguarda la Facoltà di Filosofia.
Proprio quest’esigenza di “creatività” ci ha definitivamente convinti ad avventurarci in
qualcosa di nuovo, a dar vita alla collana “Diritto di stampa”. Ci siamo così impegnati in una
iniziativa editoriale affascinante e difficile. Non vi nascondo che proponendo L’officina comunista
nelle varie librerie, comprese quelle storiche, abbiamo incontrato alcune difficoltà, dovute, non
tanto all'argomento, quanto al fatto che si tratta di una tesi di laurea. Da parte nostra, ci siamo
sempre sforzati di far notare come queste tipo di pubblicazioni costituiscano un tutto organico;
dalla lettura delle prefazioni e delle postfazioni emerge, infatti, il solido legame esistente tra chi ha
redatto le opere e chi ne ha curato la pubblicazione.
Ricollegandomi a quanto diceva prima il professor Siciliani de Cumis a proposito di university
press vorrei dire che noi stiamo lavorando proprio in questa direzione, cercando di far sì che questo
concetto di derivazione anglosassone si affermi anche in Italia, dove non ha mai attecchito.
L’università italiana, infatti, anche a parere di molti dei professori con i quali mi capita di
colloquiare quotidianamente, è stata da sempre “cannibalizzata”, non ultimo dalle case editrici che
si sono occupate di editoria universitaria. Da ciò sono derivate un insieme di lottizzazioni e di
spartizioni che non hanno certo reso un servizio al Paese e alla stessa università.
In conclusione, con la speranza che la collana “Diritto di stampa” costituisca, anche per quanto
riguarda l’editoria e la realtà universitarie, un punto di partenza e un’innovazione, Aracne si
augura senz’altro che l’esperienza prosegua (annuncio, a tal proposito, che sono in cantiere altri
cinque titoli).
Nicola Siciliani de Cumis: Per quanto riguarda il tema della creatività potrebbe rispondere,
meglio di me, la professoressa Fattori, che ha studiato e scritto libri in proposito. In ordine
all’argomento che qui interessa, passo invece la palla agli studianti, a questa figura curiosa di
studenti–studiosi. La riunione di oggi, pertanto, potrebbe anche servire ad esplicitare il potenziale
di creatività, l’offerta di creatività.
Vorrei invece riflettere brevemente con voi sulla natura della tesi di laurea. Che cos’è la tesi di
laurea? È didattica o ricerca? Onestamente, non saprei dare una risposta netta. Ritengo, tuttavia,
l'ibridazione di questo prodotto sia di fondamentale importanza anche per tentare di risolvere i
problemi connessi alla nostra nuova condizione di universitari riformati e riformanti.
Coerentemente con quanto diceva in precedenza – ovverosia, nel coniugare strettamente il nesso
didattica–ricerca, contro le premesse ottocentesche di tipo positivistico, elitarie anche quando
vogliono manifestare il loro democraticismo dividendo la didattica dalla ricerca in nome
dell'ordine, della razionalità e di tutta una serie di cose, pure apprezzabili in se stesse) – credo che
la laurea di primo livello, la laurea specialistica, la laurea di vecchio ordinamento e, più in
generale, tutti gli elaborati scritti prodotti nell'università ci pongono di fronte al problema di
coniugare la didattica con la ricerca.
Marta Fattori: Vorrei dire alcune cose sia rispetto al nesso didattica–ricerca sia per quanto
riguarda l'edizione delle tesi di laurea. La pubblicazione delle dispense universitarie e delle tesi di
laurea che avevano “diritto di stampa” ha fornito il materiale più importante per la ricerca
scientifica. Le dispense di uno studioso come Chabod, ad esempio, erano testi di ricerca, perché, di
fatto, i corsi monografici erano il risultato – didatticamente esposto agli studenti – di una grossa
ricognizione e preparazione scientifica. A mio avviso, proprio la distinzione tra didattica e ricerca,
come se fossero due campi diversi, è all’origine del degrado dell’università. Io stessa ricordo che
quando sono arrivata all’università fare i corsi senza usare le dispense era indice di serietà, perché
le dispense erano diventate un commercio editoriale.
La scissione tra didattica e ricerca non è dunque di tipo teorico, ma è legata al fatto che per
quanto riguarda l'Italia, la scuola ha ??? sempre di meno lo sviluppo culturale e democratico del
paese. E quindi questo vale anche per le tesi di laurea. Da questo punto di vista io non sono
d’accordo sul porsi il problema è o non è…. ??? La tesi di laurea nella sua origine doveva essere un
lavoro comunque originale quindi come tale scientifico, ??? è il rapporto tra l’espletare in maniera
quotidiana, anche umile, la nostra funzione: questo avviene, non avviene, però, mai la didattica è
stata scissa dalla ricerca. Su questo, io non sono d’accordo con Labriola: di fatto una seria didattica
non può che essere il risultato di un serio lavoro scientifico. Poi ci sono momenti diversi. Poi dal
punto di vista estremamente pratico ??? il problema ad esempio di fare dei corsi molto semplici è
esperienza normale, sia nostra che degli studenti. Gli studenti sanno benissimo che se vogliono
andare meglio non devono andare con il giovane laureato, il giovane assistente che sa soltanto una
piccolissima parte ed è severissimo quando interroga, ma devono andare con il professore ???
Quindi il problema va affrontato in questi termini. Certo, capisco che un giovane editore abbia
delle difficoltà; è anche vero che i più grandi (si parlava di University Press), indubbiamente il
circuito di produzione di questi volumi nel mondo anglosassone ??? però è il circuito ??? Capisco
che il problema sia complesso, però non mi porrei il problema se le tesi di laurea sono creative,
scientifiche, o viceversa no; ci sono delle tesi di laurea che non vale la pena di pubblicare e tesi che
sono scientifiche. Mi sembra avere incominciato a mettere un piccolo ??? per l’University Press. È
certamente importante dare questa possibilità di pubblicazione agli studenti, ai dottorandi, sia
anche ai giovani ricercatori, ??? molto spesso questo in Italia implica tutta una serie di cose: uno
non è che può pubblicare tutte le tesi di laurea, ci vuole una selezione ??? sia da parte dell’editore
sia da parte delle persone che ??? Ma quello che, viceversa, mi premeva sottolineare era proprio il
fatto che ormai sono spesso diventate delle esperienze anche al livello della legalità e non a caso
ancora le dispense sono un metodo per fare soldi. Di fatto la ricerca scientifica, tra l’altro, ha
bisogno di tempo e di ??? work in progress e c’è bisogno ??? Viceversa, invece devo dire, rispetto ai
tanti problemi ???
Nicola Siciliani de Cumis: Ringrazio Marta Fattori per le interessanti e stimolanti riflessioni che
ci ha proposto. Debbo dire, per quanto mi e ci riguarda, che nell’impresa che stiamo presentando
oggi – riprendendo quanto diceva precedente Luigi Punzo a proposito del dover essere – c’è
sicuramente una buona dose di utopia. C’è, però, parimenti, attenzione. Il fatto stesso che le tesi di
laurea per essere pubblicate debbono essere giudicate da specialisti – che ne redigono la
Presentazione e/o la Postfazione – indica che esiste comunque una selezione che va nella direzione
auspicata dalla professoressa Fattori. Detto questo, rimane però da affrontare la questione
importante dell’elevamento dello standard: è vero, cioè, che non potranno e non dovranno essere
stampate tutte le tesi di laurea, pur tuttavia, ritengo che bisognerebbe muoversi come se il maggior
numero di tesi di laurea potesse e dovesse essere stampato.
L’università che ci ha descritto Marta Fattori – che è stata, tra l’altro, anche la mia università e
che molto simile all’università di Labriola – è un’università dei piccoli numeri, delle élite, delle
scuole, della grande dispersione. Oggi, invece, dobbiamo fare i conti con un’università di massa, in
cui il diritto di stampa (non dissociabile dalla dignità di stampa e, quindi, dai doveri connessi alla
pubblicazione di un’opera), deve essere elevato, non abbassato. Un risultato che si ottiene
collegialmente. Non è un caso che un discorso come questo (sul nesso didattica–ricerca, sulla
qualità e sulla pubblicità degli elaborati universitari) provenga proprio da un ambiente come il
nostro, che ha una tradizione di decenni di collegialità condivisa, di linee culturali. Penso, in
particolare, a come nella scuola di Aldo Visalberghi, di Maria Corda Costa e dei loro allievi più
giovani si è sempre affrontato il tema della ricerca di prima mano. Ad esempio: che cosa erano le
“esercitazioni di ricerca” – i cui risultati venivano presentati proprio in questa stessa aula nella
quale ci troviamo – se non entrare nello stato dell’arte, se non dire, in maniera rigorosa, una parola
nuova rispetto ad una situazione di conoscenza acquisita, se non mettere in discussione, anche
ponendo delle domande, quello che già si sapeva su un determinato argomento?
Nell’ambito di qualunque disciplina specifica si può tentare di coniugare davvero il tema
didattica–ricerca nella misura in cui si comprende che gli aspetti positivi dell’università di élite
non muoiono se si riescono a trovare gli strumenti per tradurre il privilegio culturale di alcuni nel
maggior numero possibile di persone. Si tratta, evidentemente, di un problema molto serio, di
difficile soluzione, di una scommessa, comprendente una buona dose di utopia. Ma è il caso di
provarci comunque, nonostante il rischio di sbagliare, di farsi male, di fare brutte figure.
Bisogna pensare che il privilegio culturale di alcuni può e deve essere tradotto, non ridotto. O, se
vogliamo, usando una metafora, deve essere ridotto nello stesso modo in cui il riduttore elettrico
cambia soltanto la grandezza della spina, non la corrente elettrica. La tensione della ricerca deve
cioè passare in qualunque attività universitaria.
Alessandro Sanzo: Innanzitutto, anche a nome di quanti stanno per pubblicare la loro tesi di
laurea nella collana che stiamo presentando, ringrazio il professor Siciliani de Cumis per avere
ideato, coerentemente con quanto va sostenendo e praticando da trent’anni a questa parte, la
collana “Diritto di stampa”. Ringrazio, inoltre, l’editore e il dottor Maggiore, che hanno avuto la
sensibilità culturale e il coraggio editoriale di sostenere l’iniziativa. Un ringraziamento non di
circostanza va, infine, anche al professor Punzo per le interessanti e stimolanti riflessioni che ci ha
proposto; gli sono grato, in particolare, per le annotazioni riguardanti la necessità di
contestualizzare maggiormente l’operato di Berlinguer e l’importanza di estendere la ricerca che
ho condotto agli anni successivi al 1956.
Entrando nel merito del mio lavoro, non spetta certo a me, ovviamente, dare un giudizio di
valore, ma alla comunità scientifica nel suo insieme. Ritengo però opportuno sottolineare il fatto
che L'officina comunista, oltre a colmare un vuoto nella pur vasta storiografia su Enrico Berlinguer e
sul Partito comunista italiano, evidenzia la necessità e l’importanza di studiare un Berlinguer
sostanzialmente ignorato dagli studiosi (ossia il Berlinguer del primo decennio di vita
repubblicana) e, in particolare, quello che appare come un aspetto centrale e un elemento
fondamentale del suo operato: il lavoro educativo.
Detto questo, vorrei richiamare ulteriormente la vostra attenzione su alcuni dei fattori che
possono “giustificare” la presentazione di questo volume nel contesto delle celebrazioni labrioliane
e, così facendo, cominciare ad introdurre il tema delle possibili ricerche che ognuno di noi, a
partire dal proprio campo di ricerca, pensa di produrre.
Preparando l’incontro di oggi sono andato a rivedere le schede di lettura degli scritti
berlingueriani che ho usato per redigere L'officina comunista, soffermandomi in particolare sulla
scheda dei “maestri”, comprensiva dei nomi di coloro che il giovane Enrico Berlinguer considerava
esplicitamente come suoi maestri. Cosa cercavo? Cercavo, ovviamente, il nome di Antonio
Labriola, ma non lo ho trovato. Questo non significa, però, come spiegava precedentemente anche
il professor Siciliani de Cumis, che non esista un rapporto indiretto tra i due, che Labriola non
faccia parte del bagaglio culturale–filosofico–politico di Berlinguer. Tutt’altro. Ritengo, infatti, che
Labriola abbia avuto un ruolo sicuramente significativo – tutto ancora da indagare – nella
formazione berlingueriana. Basti pensare, tra l’altro, a quanta importanza ha avuto la lettura e la
rilettura dell’edizione Manifesto del partito comunista con la nota introduttiva redatta da Labriola,
per l’approdo di Berlinguer al marxismo. E come non pensare poi all’influenza di nonno Giovanni
Lòriga (che ha seguito le lezioni tenute da Labriola all’Università di Roma e che frequenta
assiduamente il caffè Aragno, al pari di Labriola) nella formazione di Enrico Berlinguer.
Nicola Siciliani de Cumis: Considerato l’orario, se siete d’accordo, passerei alle Attività
didattiche e di ricerca del “Laboratorio Labriola”. Seguendo la modalità usata da Alessandro Sanzo,
invito, pertanto, a farsi senz’altro avanti quanti volessero intervenire sul libro o sui temi affrontati
fino ad adesso e quanti avessero delle proposte di ricerca in vista del convegno che si terrà a
Cassino nel mese di ottobre di quest’anno, della Mostra su “Antonio Labriola e la sua Università”
che si svolgerà a Roma all’inizio del 2005 (e, ovviamente, del relativo Catalogo) e, infine, in vista
del convegno romano che chiuderà le celebrazioni labrioliane.
Marzia D'Alessandro: Compiendo una precisa operazione di politica culturale, il Partito
comunista italiano ha cercato di creare una tradizione culturale che da Mondolfo, recuperando
Labriola (emblematico, in questa prospettiva, lo scritto togliattiano Per una giusta comprensione del
pensiero di Antonio Labriola), arrivasse fino Gramsci. Era intenzione di Togliatti, infatti, dare delle
fondamenta teoriche all’azione politica. Tutto ciò ha rappresentato indubbiamente un problema,
poiché le differenze tra il marxismo di Labriola e quello di Gramsci sono evidenti. Si pensi, ad
esempio, alla nota questione del papuano, da leggersi, non come una battuta, ma come
concentrazione di problemi. Da un lato, c’è il marxismo di Labriola, che risente sicuramente di un
certo determinismo, di una certa cultura dell’epoca (il tanto criticato positivismo), di un certo
oggettivismo e di un certo determinismo (la filosofia della storia, i “tempi lunghi”), dall’altro lato,
invece, ci sono il volontarismo e l’istanza politica attiva propri del marxismo gramsciano.
Luigi Punzo: In merito a questo problema della continuità credo che sia opportuno fare
un’osservazione di natura storiografica e, insieme, politica. La lezione togliattiana cerca di
recuperare al dibattito culturale del Partito comunista italiano la parte più consistente della
tradizione culturale italiana. A mio avviso, quindi, non si è trattato tanto di trovare una continuità
di pensiero che conducesse direttamente al cosiddetto socialismo gramsciano e togliattiano,
quanto, di cercare un legame con quella grande tradizione di pensiero – per molti versi e per molti
anni egemone – che era stato il neoidealismo italiano, rappresentato, anzitutto, da Croce e da
Gentile. Va tenuta presente, a tal proposito, la lezione gramsciana, che aveva cercato di fare i conti
con Croce e, attraverso di lui, con Gentile. Si spiega in questo contesto il tentativo compiuto da
Togliatti – uomo profondamente imbevuto di cultura storicista – di ritrovare nella tradizione del
pensiero italiano un punto di riferimento che potesse permettere di impiantare un nuovo discorso
che passava attraverso il marxismo riletto in chiave storicista.
La posizione togliattiana, pertanto, non va letta in chiave di continuismo (da Spaventa,
attraverso De Sanctis e Labriola, naturalmente si arrivava al socialismo e al marxismo rivisto da
Gramsci), ma, piuttosto, come la necessità di trovare un ancoraggio nel dibattito culturale italiano;
veniva compiuta, in tal modo, un’operazione allo stesso tempo culturale e politica, perché
significava coinvolgere nel dibattito sul marxismo e sul “partito nuovo” tutta una serie di
intellettuali che si avevano avuto una formazione di tipo storicista.
Nicola Siciliani de Cumis: Vorrei fare solo un’osservazione rispetto a quanto detto da Marzia
D’Alessandro. La relativa buona fede di Togliatti – relativa, perché, essendo egli un politico, anche
uno studio di natura storiografica non può che essere funzionale, anzitutto, al raggiungimento di
un risultato politico – è data dal fatto che, in realtà, del saggio su Labriola esiste soltanto il titolo.
Togliatti, in altre parole, su Labriola non riesce a scrivere nulla. Perché? Per quale motivo, pur
disponendo di importanti documenti e di un abbondante materiale preparatorio e pur avendo le
capacità e l’intenzione/necessità di scrivere su Labriola, non riesce a farlo? Siamo di fronte ad un
mistero, che si spiega, almeno parzialmente, proprio alla luce della complessità della questione
Labriola. Da questo punto di vista, varrebbe sicuramente la pena di cimentarsi a spiegare, almeno a
livello di illazioni, la ragione di questa non scrittura, di questa non capacità.
Non è un caso, che tutte le citazioni che Togliatti fa di Labriola sono molto contraddittorie tra
loro, anche e soprattutto per il fatto di essere fortemente legate ad un determinato contesto storico,
politico e culturale. Penso, per un verso, alla denuncia togliattiana del fatalismo oggettivo (in un
indimenticabile articolo su «Rinascita») e, per un altro verso, a tutta una serie di comportamenti
togliattiani connotati proprio dal fatalismo oggettivo, come se, in qualche modo, il tatticismo e il
mestiere di politico imponessero a Togliatti di giocare con gli uguali e i contrari.
Andrea Del Monaco: A proposito delle critiche mosse a Togliatti io vorrei richiamare alla
vostra attenzione sulle aspre critiche che gli sono state fatte per la lettura che egli ha dato di
Gramsci, per l'edizione dei Quaderni del carcere e, infine, per come sono stati giustificati i governi di
unità nazionale dal 1945 al 1947, ossia, con lo slittamento dalla formula gramsciana dell’“alleanza
tra le classi” a quella di “alleanza tra i partiti di massa” (riproposta anche da Berlinguer con il
“compromesso storico”). Ciò ha comportato, innegabilmente, una forzatura del pensiero
gramsciano, mai analizzata fino in fondo. Allo stesso modo, nella lettura che ne dà Togliatti, la
tradizione “da Labriola a Gramsci” viene usata per giustificare la strategia politica.
La seconda cosa che vorrei dire riguarda la politica culturale del PCI e la creazione dell’uomo
nuovo. Pensando alla politica culturale del PCI di quegli anni si ha la netta impressione di trovarsi
davanti ad una sorta di Giano bifronte: da un lato, come ha ricordato giustamente Sanzo, ci sono
l’idea di educare le masse e il lavoro pedagogico compiuto da Berlinguer, dall’altro lato, c’è il
difficile rapporto con gli intellettuali (si pensi, ad esempio, al “caso Vittorini”).
In definitiva, sembrerebbe che Togliatti sia interessato al confronto tra le varie posizioni
culturali solo nella misura in cui questo è funzionale all’avanzamento del PCI.
Alessandro Sanzo: In genere, sono restio ad esprimere giudizi sull’operato del Berlinguer
segretario del PCI (1972–1984). Talvolta – mi è capitato anche recentemente presentando il volume
– tale atteggiamento viene frainteso, si pensa che nasconda una qualche non volontà di prendere
posizione. Non si tratta, però, di prendere posizione, ma, almeno per chi voglia porsi sul piano
dell'analisi storiografica, di studiare anche il Berlinguer segretario del PCI come si studierebbe –
dico il primo nome che mi viene in mente – Giovanni Giolitti; rifuggendo, specialmente, dalle
strumentalizzazioni e, dunque, cercando di tenere il più possibile distinti e distanti il piano storico
da quello politico (cosa che, per quanto riguarda Berlinguer, spesso non è avvenuta). Ecco allora
spiegata la mia resistenza a parlare del Berlinguer segretario del PCI, in quanto – non ho alcuna
difficoltà ad ammetterlo – si tratta di un periodo che non ancora adeguatamente e scientificamente
affrontato, per come merita, per come vorrei.
Ciò premesso, mi sembra però comunque opportuno dire qualcosa a proposito del parallelismo
tra la partecipazione del PCI al governo del Paese nell’immediato dopoguerra e il “compromesso
storico”. Anche io ritengo che tra queste due esperienze esistano delle analogie. Esse, tuttavia, per
quanto riguarda Berlinguer, credo siano principalmente ravvisabili nella difesa e nel rafforzamento
della democrazia. Infatti, come all’origine del “compromesso storico” sono rintracciabili, anzitutto,
la paura che l’esperienza cilena potesse ripetersi in Italia e l’intenzione di scongiurare tale pericolo,
una parte fondamentale del lavoro compiuto da Berlinguer nel periodo 1945–1956 è consistito in
un costante lavoro di conquista–difesa–consolidamento del sistema democratico; un impegno che
si è tradotto, direi principalmente, in un complesso e difficile lavoro di educazione democratica dei
militanti comunisti e, tendenzialmente, delle masse popolari italiane.
Un obiettivo che è stato perseguito tenacemente, nonostante i limiti di tipo teorico che, a parere
di Berlinguer e dei comunisti italiani, erano propri del sistema democratico dei partiti. Proprio in
ciò, nella combinazione tra una politica rigorosamente democratica ed una teoria–organizzazione
nella quale invece si esprimono, e si sublimano, le vecchie tradizioni leniniste e rivoluzionarie,
vedrei – d’accordo con quanto ha sostenuto lo storico Renzo Martinelli nella sua Storia del Partito
comunista italiano – la vera “doppiezza” del PCI. Una “doppiezza”, dunque, che non va ravvisata
sul piano politico, in un non detto, in una opzione rivoluzionaria da realizzare al momento più
opportuno e più inatteso, ma nell’intima contraddittorietà di un modo di essere che mette al
servizio di una strategia politica democratica uno sviluppo organizzativo di tradizione leninista.
Anche in questo, a mio avviso, risiedono quell’originalità e quella specificità del comunismo
italiano che lo hanno reso così diverso dal cosiddetto “socialismo reale”.
Anche alla luce di queste considerazioni – ripensando labriolianamente al “genetico” – appare
evidente quanto indagare la formazione di Berlinguer e il suo operato politico–pedagogico nel
primo decennio di vita repubblicana possa essere utile (per molti versi indispensabile) per
comprendere meglio il Berlinguer segretario del PCI.
Luigi Punzo: Considerato che stiamo parlando di un personaggio come Berlinguer, sicuramente
inattuale, nel contesto di un pensatore – Labriola – ancor più inattuale, noto con piacere un interesse
e una partecipazione, anche giovanile, che mi sorprendono positivamente. Siamo di fronte,
dunque, ad una generazione che non epochizza, non fa epochè di un’esperienza che fa parte del
nostro recentissimo passato e su cui, probabilmente, vuole fare chiarezza.
Fatta questa premessa, vorrei rispondere brevemente – quindi in modo assolutamente parziale,
non definitivo – alle questioni poste da Del Monaco; lo faccio, però, limitandomi a richiamare i
termini del problema e mettendo da parte quegli elementi di valutazione biografica o
autobiografica che porterebbero su strade diverse. Per quanto riguarda lo slittamento che lei notava
dall’“alleanza tra le classi” (proposta da Gramsci) all’“alleanza tra i partiti” (ricercata da Togliatti),
naturalmente, come è stato già fatto, si può imputare a Togliatti una lettura strumentale dei
Quaderni. Allo stesso modo, però, a Togliatti va riconosciuto il merito di aver messo
immediatamente in circolazione un pensatore a cui era stato impedito di pensare.
Per quanto riguarda il rapporto società civile/partiti è necessario invece fare una
puntualizzazione che riguarda sia Gramsci che Togliatti, perché altrimenti – data per scontata una
lettura strumentale del pensiero gramsciano – si corre il rischio di commettere un errore. Gramsci,
infatti, passa da una concezione leninista del partito, riconducibile al suo primo impatto con la
rivoluzione russa (il partito elitario, il partito guida), a una concezione del partito che viene fuori
dai Quaderni, secondo la quale il partito è qualcosa di molto più complesso, in cui la funzione
pedagogica rappresenta un fattore fondamentale. In Gramsci, insomma, sono rintracciabili due
distinte visioni del partito, utilizzabili da chi volesse applicare il pensiero gramsciano alla vita
politica concreta.
In questa concezione del partito una funzione fondamentale è attribuita alla figura
dell’intellettuale organico, su cui, tuttavia, dal momento che nella vulgata l’intellettuale è diventato
strumento del principe–partito, si dovrebbe tornare a riflettere. Gramsci, infatti, spiega molto
chiaramente che l’intellettuale è un tecnico – un esperto nei campi in cui applica – che partecipa
alla realizzazione di quella società nuova che il moderno partito, il moderno principe, vuole
costruire.
In questa chiave, fermo restando il fatto che Togliatti legge in maniera strumentale i Quaderni e
avvia un discorso che prevede l’attuazione storica, contestualizzata, del suo gramscismo, bisogna
però tener presente che Togliatti parlava del “partito di massa” e aveva di fronte, da un lato, il
Partito comunista italiano e, dall’altro, la Democrazia cristiana. Se teniamo presente questo fatto
l’“alleanza tra i partiti” si riempie di un contenuto diverso. Non a caso, gli iscritti al PCI
(soprattutto quelli più anziani) hanno sempre sostenuto che la politica del partito riguarda tutta la
società nel suo complesso, mai si riferivano ad una sola parte (anche se, naturalmente, l’interesse
prioritario riguardava le classi deboli, le classi lavoratrici).
In conclusione, è vero quello che lei [Del Monaco] dice, ma si può leggere meglio – si smussano
certi contrasti – se si vede quale valore avevano certi termini (ad esempio “partito”) nell’economia
del pensiero di Togliatti e di Gramsci. Indubbiamente, però, seppure in modo diverso, entrambi
credevano nella costruzione dell’uomo nuovo. Allo stesso modo, è indubbio che in ambedue,
nonostante il tatticismo e nonostante la doppiezza, è presente una profonda tensione etica che
giustifica certe scelte e certi esisti.
Roberto Donini: In vista delle varie iniziative riguardanti Labriola che si svolgeranno nei
prossimi mesi, sarebbe interessante e proficuo riportare l’attenzione sul Labriola storico della
Rivoluzione francese; anche se, a dire il vero, più che di un Labriola storico a tutto tondo si
dovrebbe parlare di un Labriola insegnante di storia. Pur tuttavia, è innegabile che affrontando il
tema della Rivoluzione francese Labriola faccia lezione di storia. Va ricordato, tra l’altro, che il
corso sulla Rivoluzione francese viene svolto nel 1889 e che, nello stesso periodo, Labriola scende in
piazza, partecipando attivamente anche ad una nutrita serie di manifestazioni. Potremmo
addirittura spingerci fino ad affermare che per Labriola il centenario della Rivoluzione francese
forse rappresenta l’unico passaggio di militanza realmente politica, l’abbandono dell’oggettivismo
storico, della necessità storica.
Roberto Sandrucci: Ieri sera il professor Sasso, ma anche altri relatori, hanno fatto più volte
riferimento alla sofferenza psicologica di Labriola, quale dato da prendere in considerazione per
chiunque voglia affrontare la sua opera, soprattutto per quanto riguarda i giudizi aspri, estremi,
che frequentemente esprimeva su fatti e persone. Io sarei più accorto; e il mio intervento, in questo
senso, vorrebbe dare un’indicazione di metodo: ritengo che lo “squilibrio” di Labriola – è evidente
che non stiamo parlando di squilibri e di sofferenze inabilitanti – influisce sulla sua opera quanto
l’equilibrio di Croce influisce sull’opera di Croce, e così come le personalità e le psicologie di ogni
altro autore influiscono su quanto ogni altro autore va scrivendo e dicendo. Credo sia fuorviante e
sempre pericoloso spiegare un “non allineamento” con le ragioni della debolezza psicologica. Ma
soprattutto, resta da dimostrare che la ragionevolezza e la posatezza di un Croce siano strumenti
migliori, più adatti, più sinceri, per comprendere e spiegare la realtà, con le sue ingiustizie e le sue
brutture, che non gli “squilibri” di un Labriola. Forse l’equilibrio va bene per fare accademia, ma
per la ricerca della verità – usiamo questa parola desueta – spesso si rivelano più utili le virulenze
e le intransigenze.
Luigi Punzo: Condivido pienamente quanto ha detto Roberto Sandrucci. Lo condivido da
sempre: quando frequentavo il liceo mi ribellai violentemente alla professoressa di italiano che
attribuiva il pessimismo leopardiano alla sua condizione fisica. Credo, tuttavia, che Gennaro Sasso
intendesse fare riferimento al fatto che Labriola, forse a causa del suo carattere, al contrario di
Croce, non può essere considerato un pensatore sistematico. Vorrei però ricordare che anche la
moderazione di Croce è relativa, basti pensare alle sue famose stroncature (di cui, talvolta, si sente
la mancanza).
Nicola Siciliani de Cumis: Ringrazio Roberto Sandrucci per il suo intelligente intervento, che
sentivo il bisogno di fare io stesso ieri sera; le circostanze (in primo luogo quelle connesse alla
durata dei lavori) non me lo hanno però consentito. Lo ringrazio perché, in fondo, la colpa di quello
che è successo è stata anche mia. Gennaro Sasso, infatti, ha espresso le sue opinioni circa la
sofferenza psicologia di Labriola dopo il mio intervento, in presenza di quella sventagliata di
giudizi, di caricature, di sottolineature e di insulti che io avevo messo assieme essenzialmente per
ragioni retorico–letterarie. La mia intenzione, però, vale la pena di ribadirlo, era quella di far
vedere come dietro l’eccitazione labrioliana fosse presente una pacificazione dei concetti. Qual autore
non è a suo modo eccitato? Anche l’olimpico Croce, a ben guardare, aveva le sue passioni. Ognuno
di noi, in altre parole, ha una propria indole, un proprio carattere.
Mi spiace che oggi pomeriggio Sasso e Miccolis non siano presenti, ma non posso fare a meno di
esprimere la mia opinione, la mia paura. Ho paura, in altri termini, che il mettere l’accento sulla
sofferenza psicologica di Labriola, considerandolo un uomo disturbato, nasconda una sorta riserva
mentale: è disturbata la teoria, il marxismo.
Si tratta di un timore parzialmente mitigato dal fatto che ieri Sasso ha sottolineato la necessità e
l'importanza di studiare il marxismo. Esistono, tuttavia, diversi modi di studiare il marxismo. C’è
il modo dei professori, dei letterati, e c’è il modo di chi è coinvolto nelle cose e soffre. Lo squilibrio
di Labriola, a mio avviso, non è uno squilibrio soggettivo, una patologia individuale, ma è lo
squilibrio di una persona che si confronta intimamente con le cose, con la realtà; lo squilibrio di un
uomo che si mette in gioco in presenza di conflitti che riguardano ben altro che la fattura di un libro
o la tranquilla ricerca in biblioteca. La ricerca in biblioteca, la fattura di un libro, se mai verranno,
costituiscono l’elemento epifenomenico, conseguente, accidentale di un coinvolgimento scientifico
nella realtà del proprio tempo. Gli elementi caratteriali sono innegabili. È decisamente sbagliato,
però, ragionare in termini di patologia.
Maria Serena Veggetti: Mi sembra si siano presentati tre concetti di educazione: un’educazione
come ideologia (la società nuova, con l’esigenza di creare l’uomo nuovo), un’educazione come
utopia (la non separabilità della didattica dalla ricerca) e un’educazione come scienza (quella che
viene proposta dalle Facoltà scientifiche tra 800 e 900) e sembra delineare spazi per una nuova
disciplina, per la quale non c’è posto nell’accademia tradizionale.
Si presenta in realtà il problema del perché e come può essere possibile una psicologia come
scienza dell’educazione.
Maria Montessori indica dei momenti chiave su cui l’educatore può/deve intervenire e utilizza
dei concetti che trae dalla biologia e dalla fisiologia (ad. es. le età sensitive o periodi critici).
In altri paesi, come la Russia, si sta ponendo lo stesso tema. Un po’ sotto la spinta ideologica
(perché si deve fare l’uomo nuovo), un po’ perché una generazione di scienziati Vygotskij, Lurija,
Bernsteijn si pone il problema di costruire un’antropologia marxiana (in dissidio con la prospettiva
marxista ufficiale) che non appiattisca la psicologia dell’uomo sulla fisiologia; quella fisiologia
pavloviana (la fisiologia dei riflessi) che ha conquistato un premio Nobel per la medicina nel 1904.
Vygotskij definisce la psicologia come una scienza storica.
Meglio: la scienza storica è secondo lui la psicologia. In un’opera pochissimo letta e pochissimo
nota, Il significato storico della crisi della psicologia (del 1930, a lungo ignorata anche in Russia), egli
identifica nella educazione come scienza storica la psicologia generale, che ha posto a suo
fondamento la psicologia dialettica, ovverosia, è la dialettica del soggetto storico che diventa
psicologia generale.
Tutto questo perché, evidentemente, il soggetto uomo non si ferma alla logica formale basata
sul principio di non contraddizione. Il pensiero umano deve poter affrontare il conflitto, la
trasformazione dello stimolo nel suo opposto, sul piano percettivo, situazione in presenza della
quale il cane, nelle esperienze di I. P. Pavlov, cade in crisi.
L’uomo, allora, deve fare i conti con la realtà contestuale che lo genera come soggetto di quel
momento e con l’Altro come educatore, il quale gli fornisce gli strumenti per attualizzare, per
capire e superare, per far sua la situazione dell’ora e qui, progettando il futuro.
Non è un caso, e mi sembra che possa essere argomento di maggior riflessione, che proprio
Vygotskij e la comunità scientifica russa ripropongano all’attenzione concetti che erano stati messi
tra parentesi dalla psicologia americana o da altre psicologie europee (ad es. la psicologia dei
processi cognitivi superiori). In altri termini, Vygotskij ripropone all’attenzione la “coscienza” e,
quindi, tutti gli aspetti soggettivi (quelle che lui chiama “le forme superiori del comportamento”),
ovvero, la scienza del soggetto. La psicologia come scienza storica è la scienza del soggetto umano,
che si genera dall’educazione scientifica.
Nicola Siciliani de Cumis: Mentre Serena Veggetti parlava ho provato a tradurre
labriolianamente ciò che diceva; ho pensato, cioè, a quali ricerche si potrebbero produrre sulla
scorta delle cose che ha detto, in presenza del fatto storico che è stato Antonio Labriola.
A mio avviso, in Labriola sono presenti tutti e tre i concetti di educazione, fermo restando che
bisogna indagare in quali modi essi sono presenti, con quale linguaggio, con quale specificità.
Uno studente che volesse fare una tesi di laurea sulle modalità di educazione presenti nel
pensiero di Labriola, pertanto, dovrebbe cominciare col fare un’indagine di tipo terminologico, di
tipo concettuale e di tipo storico, mettendo alla distanza il discorso di Labriola e vedendo come
questi concetti, per differenza, sono esaminati in Labriola. Allo stesso modo, in tutto il discorso di
Labriola è centrale il tema della coscienza; Labriola, infatti, è particolarmente attento al tema
dell’apriori. Per quanto riguarda il tema della scienza storica, infine, sarebbe interessante riflettere
ulteriormente su quali sono i livelli d’uso del termine e del concetto di storicismo e di storicità in
Labriola.
Tengo a precisare, però, che è di fondamentale importanza guardare il più possibile a Labriola
così com’era, contestualizzarlo, collocarlo nel suo tempo e vederne poi, per differenza, le
utilizzabilità. Si tratta, lo so bene, di un discorso molto complesso, perché mescola due piani che è
sempre bene che metodologicamente rimangano distinti: la prospettiva rispetto al passato e la
prospettiva rispetto al futuro.
Marco Antonio D’Arcangeli: Il tema che vorrei trattare a Cassino è il rapporto Labriola–
Credaro, sia dal punto di vista istituzionale (il passaggio di cattedra alla “Sapienza”, nel 1902), sia
da quello degli eventuali rapporti personali (benché, sinora, non riscontrati), sia, ancora, sotto il
profilo concettuale: esiste un minimo comune denominatore fra il cassinate e il valtellinese,
Labriola e Credaro “significano” Herbart, la ricezione e la diffusione del pensiero (etico e
pedagogico in specie) dell’oldenburghese; ma li accomuna anche un certo rapporto, a mio avviso
complesso, con il neokantismo. A questo riguardo, volevo fare una piccola annotazione rispetto a
ciò che è stato detto stamattina: non v’è dubbio, infatti, sulla recisa negativa presa di posizione di
Labriola nei confronti del “ritorno a Kant”, in Germania e altrove (compresi gli epigoni nostrani),
ed altresì sul posteriore “neokantismo”, intendo quello “fisiologico”, quello della interpretazione
fisiologistica dell’apriori, nei confronti del quale Labriola manterrà sempre le distanze; e da
Spaventa in poi, sino a Gentile compreso, la “stroncatura” di questa lettura kantiana, da parte degli
hegeliani, è risoluta, netta. Ma c’è tutto un versante neokantiano – quello che pensa a delle scienze
dell’uomo e della società emancipate dal determinismo e rozzo materialismo di certo positivismo –
che potrebbe aver interessato Labriola (anche al di là della secchezza di certi suoi giudizi): ed è
questa l’ipotesi su cui vorrei lavorare. Il rapporto Labriola–Credaro, in altre parole, potrebbe
rappresentare una “finestra” sulle possibili relazioni tra Labriola e un certo neokantismo, e un
certo herbartismo italiano a cui furono molto legati, come ha fatto vedere in particolare Massimo
Ferrari nel suo volume su Felice Tocco, tanti neokantiani: che studiarono a fondo Herbart e gli
herbartiani. In breve, vorrei riprendere questo discorso, ma partendo dal rapporto tra Labriola e
Credaro.
In questa ricerca avrei piacere di coinvolgere i ragazzi del “Laboratorio Labriola” del professor
Siciliani, i quali, in occasione di questo Convegno – mi piace sottolinearlo, e non soltanto per
l’affetto che indubbiamente mi lega a tutti loro, visto che anch’io sono “cresciuto” qui... – hanno
offerto una prova di grande impegno ed efficienza. Il “Laboratorio” ha già tanti impegni in
agenda; e non vorrei risultare un invadente “intruso”, ma per una parte almeno del lavoro che ho
in mente – lo studio delle tesi di laurea all’archivio della “Sapienza”, fra Labriola e Credaro –
l’apporto di questi giovani studiosi sarebbe veramente prezioso per me, che lavorando
all’Università di L’Aquila ho una limitata disponibilità di tempo. Si dovrebbe partire ricostruendo
l’elenco dei laureati di Labriola, per poi effettuare una ricerca a tappeto; ci sono difficoltà legate
alla situazione degli archivi della “Sapienza”, ma non è escluso che si possa rinvenire subito
qualche tesi: mi sembra un buon tema di ricerca.
Nicola Siciliani de Cumis: Nel 1954, sul «Corriere di Firenze», Delio Cantimori scrisse un
interessante articolo sul tema dell’autoironia di Labriola, parlando dell’autoironia come di quella
particolare “scarlattina” che possono affrontare e superare soltanto quelli che hanno consuetudine
con il pensiero di Hegel. A mio avviso, l’autoironia è uno strumento per curarsi da soli, non per
essere curati dagli altri. Chi riesce a ridere di se stesso ha già superato le ragioni delle risate degli
altri, ha già intrapreso il cammino della guarigione.
Ecco, allora, che quanti avessero una competenza sul tema e dell’ironia e dell’autoironia – e
quindi dell’umorismo in tutte le sue forme – potrebbe dare un contributo interessante anche per
quanto riguarda Labriola. Lo stesso potrebbe fare chi avesse studiato il tema “Gramsci sui
giornali”, soprattutto nella chiave africana. Sono evidenti, infatti, i molteplici punti di contatto di
questo argomento con un tema come quello del “papuano”. Mi chiedo, addirittura, se non sia
proprio questo lo strumento per portare alle estreme conseguenze quella che era anche un’idea di
Labriola: usare i giornali per la costruzione del sapere storico di prima mano.
Volendo, potrei continuare a lungo, indicare innumerevoli altre direzioni di ricerca. Chiudo,
invece, sull’idea che “Labriola e noi” può significare anche “Noi al di là di Labriola” e, persino,
“Noi contro Labriola”. In che senso? Nel senso dell’indotto labrioliano, del non dottrinario;
dell’indotto come elemento di ricaduta, senza limitazioni di sorta per quanto concerne i contenuti
di ricerca.