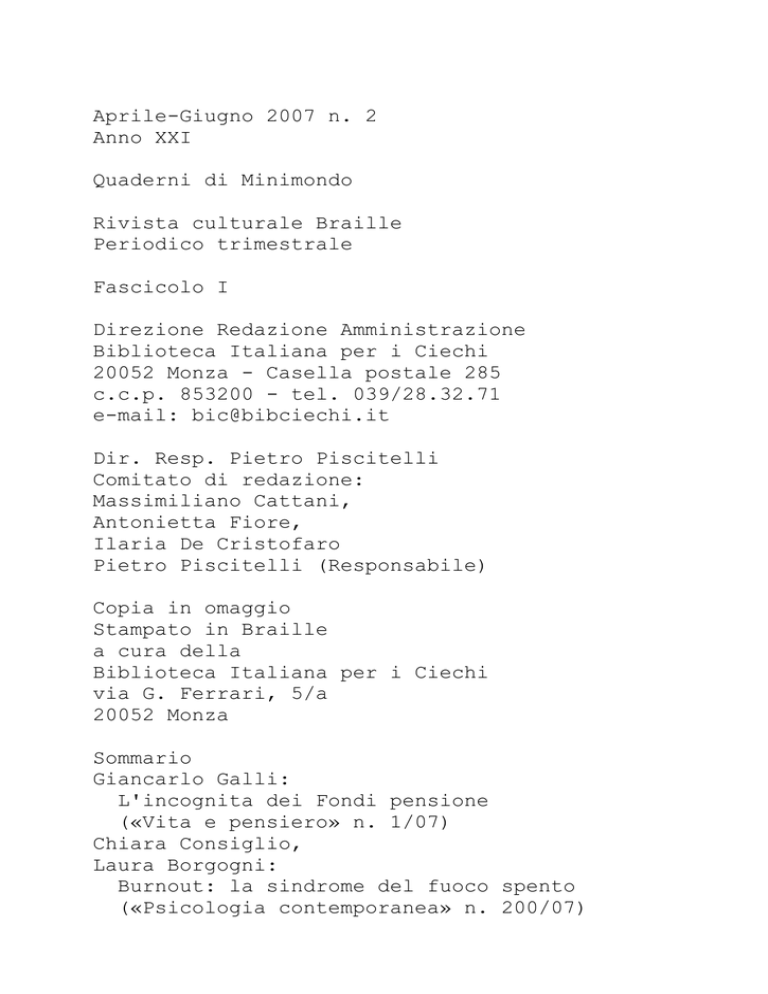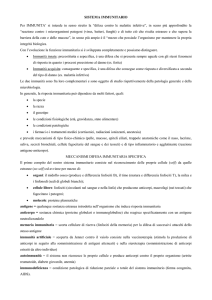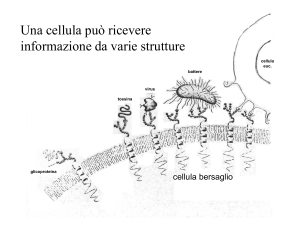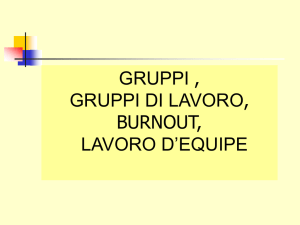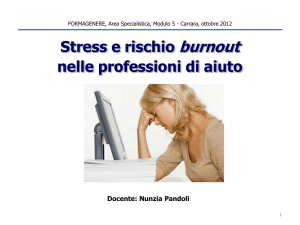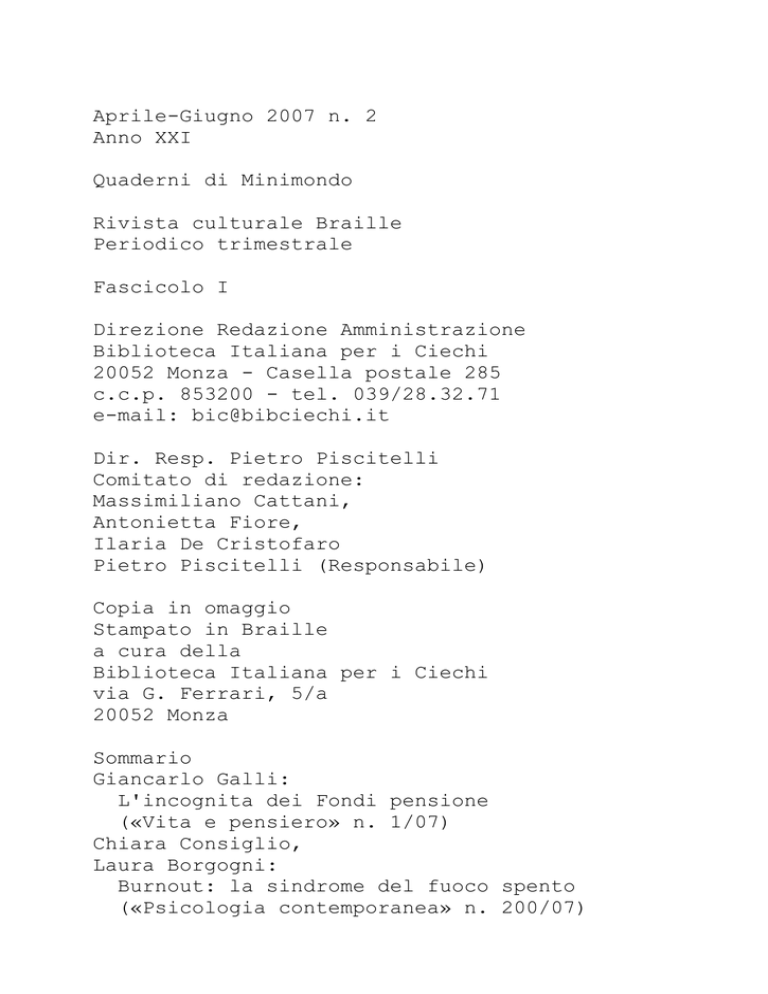
Aprile-Giugno 2007 n. 2
Anno XXI
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo I
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20052 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Ilaria De Cristofaro
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille
a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
via G. Ferrari, 5/a
20052 Monza
Sommario
Giancarlo Galli:
L'incognita dei Fondi pensione
(«Vita e pensiero» n. 1/07)
Chiara Consiglio,
Laura Borgogni:
Burnout: la sindrome del fuoco spento
(«Psicologia contemporanea» n. 200/07)
Luke A.J. O'Neill:
L'altra immunità
(«Le Scienze» n. 442/05)
Franco Di Maria,
Ivan Formica:
Gli inquilini dell'inconscio
(«Psicologia contemporanea» n. 201/07)
Carlo Bordoni:
La cultura come spettacolo
(«Prometeo» n. 96/06)
Comunicato:
Trascrizione personalizzata di opere (book
on demand)
Valeria Venza:
Mantova: un fiume di storia
(«Ulisse» n. 267/07)
Lietta Tornabuoni:
Cinecittà: settant'anni di sogni
(«Specchio» n. 558/07)
Oretta Zanini De Vita:
Il cibo in giallo
(«Cucina & Vini» n. 85/07)
Mauro Novelli:
Omaggio a Piero Chiara
(«Letture» n. 633/07)
Marina Verzoletto:
Glenn Gould: il pianista che non amava il
pianoforte
(«Letture» n. 636/07)
L'incognita dei Fondi pensione
- Il 2007 vedrà la rivoluzione del Tfr, una
sfida che rende inquieti molti lavoratori. La
previdenza complementare assicurerà davvero il
nostro futuro? Quello americano può essere
considerato un modello per i buoni risultati
che ha fornito. -
Proprio alla vigilia del nuovo anno, quasi a
lenire le ansie di milioni d'italiani che
s'apprestano (entro giugno) a decidere il
futuro della loro tanto amata liquidazione ora
ridotta a una sigla (Tfr, che significa
Trattamento di fine rapporto), è giunta una
notizia confortante. Mittente, la Covip,
Commissione di vigilanza sui fondi di pensioni
già esistenti per la previdenza complementare
di alcune categorie. Messaggio: nell'ultimo
triennio, intercorrente fra il 31 ottobre 2003
e la stessa data del 2006, il rendimento è
stato del 17,8% rispetto al 7,8 del tasso di
rivalutazione del Tfr lasciato nelle casse
aziendali, e che le ditte utilizzano come
finanziamento per le loro attività, a un costo
decisamente inferiore a quello dei vari
prestiti bancari.
Detto così, la conclusione è sin troppo
evidente, e gratificante: i 10-14 miliardi di
euro che annualmente maturano per il Tfr
potranno assicurare ai lavoratori pensioni
integrative crescenti, ben più robuste che in
passato. Quindi la legge appena entrata in
vigore si prospetta come un ottimo affare, e i
Fondi pensione dovrebbero mietere consensi,
mentre coloro che eviteranno di scegliere
affidandosi all'Inps o lasciando il peculio in
azienda, dovranno accontentarsi.
Tutto ciò, in teoria. In pratica, è arcinoto
che nessuno fa regali. Non certo lo Stato, che
con la riforma del Tfr pensa di cogliere due
piccioni con un sol colpo: 1) i miliardi che
finiscono all'Inps, cronicamente deficitario,
alleggeriranno il bilancio statale costretto a
pareggiare l'attuale divario entrate-uscite;
2) l'«integrativo» compenserà l'ormai certa
riduzione progressiva della pensione ordinaria
in rapporto sia a quanto versato sia
all'ultima retribuzione sia in conseguenza
della durata media della vita, in progressivo
allungamento.
Una constatazione al riguardo: allorché, sul
finire dell'Ottocento, il cancelliere tedesco
Bismarck varò per la Prussia divenuta Germania
la «pensione generalizzata» (e non più solo
concessa a dipendenti pubblici e militari),
chiese al suo ministro delle finanze di
fissare un'età. Risposta: 65 anni. Con
l'aggiunta: ci arrivano in pochi... Ora, la
«speranza di vita» supera gli 80 anni per le
donne, e li sfiora per gli uomini. Mentre nel
frattempo un susseguirsi di lotte sociali,
accompagnate da rivendicazioni populiste e
corporative e dal minor rigore delle finanze
pubbliche, ha abbassato i termini di accesso
alla pensione (in Italia, si discute
sull'elevazione a 60 anni, nel Nord Europa e
in Usa ci si proietta verso i 67-70).
Comunque, è chiaro come il sole che l'attuale
sistema non può reggere a lungo.
Si dica allora quel che va detto, evitando
funambolismi: anche la «nuova destinazione»
del Tfr (all'origine, «retribuzione
differita», sorta di salvadanaio-paracadute
del quale il lavoratore finora ha goduto a
conclusione delle sue prestazioni, lunghe o
brevi che fossero) non costituisce un regalo.
Semmai l'esatto contrario: una forma di
risparmio-investimento, dal volto benevolo, in
realtà coercitivo. Costellato da
interrogativi, che le normative in fase di
elaborazione non contribuiscono a chiarire.
Non è tuttavia questa la sede per sviscerare
la controversa questione della previdenza
integrativa legata a doppio filo al futuro del
Tfr. Il problema vero è di altra natura,
finanziaria. Traduzione: riusciranno i nuovi
Fondi pensione (o per quanto la riguarderà,
l'Inps) a garantire una rivalutazione
superiore a quella attuale? S'era detto
all'inizio della «buona notizia» proveniente
dalla Covip. Scavando, si scopre una
situazione ben diversa. Comunque variegata.
Ovvero: il citato tasso di rivalutazione
triennale differisce da Fondo a Fondo: per gli
obbligazionari puri (minimo rischio) il
rendimento effettivo è stato di appena il
6,2%. Per andare oltre, sino al 26,2% degli
azionari, occorre che i gestori assumano (con
soldi altrui e lucrando cospicue provvigioni)
le alee d'investimenti in Borsa.
A questo punto, i pericoli sono dietro
l'angolo, essendo i mercati finanziari
soggetti a un andamento altalenante, una sorta
di montagna russa, con forti impennate e
paurosi tonfi. Ora, accade che dopo i crolli
del 2000 (crack della New Economy) e del 2001
(11 settembre, attacchi terroristici in Usa)
le Borse abbiano ampiamente recuperato.
Qualcuna, Wall Street, la numero uno mondiale,
toccando nuovi record: quota 12.463, rispetto
al massimo del 29 febbraio 2000 (11.750),
sebbene ancora sconti la débacle del Nasdaq
(il mercato dei titoli dell'Alta tecnologia),
fermo a 2.415 contro un top di 5.133.
In sostanza, dopo una fase di appannamento,
stanno tornando entusiasmo e fiducia fra i
risparmiatori. «Raramente si era visto un
consenso positivo così generalizzato sulle
prospettive delle Borse», ha scritto per «24
Ore» Marco Liera, brillante analista (30
dicembre). Titolando: «Bond? No, meglio le
azioni». Ma di questa manna, chi ha saputopotuto profittarne? Certamente i grandi
finanzieri, e in non poca misura i cultori del
«fai-da-te» (almeno due milioni di piccoli e
medi risparmiatori che grazie anche a Internet
fanno del trading, ovvero comprano-vendono
sfruttando le fluttuazioni); assai meno quegli
11 milioni di famiglie italiane
sottoscrittrici di Fondi comuni, una forma di
risparmio assimilabile ai futuri Fondi che
ospiteranno il Tfr.
In proposito il «Corriere della Sera» (20
novembre 2006, inchiesta di Giuditta Marvelli
e Francesca Monti) ha condotto un'interessante
analisi, partendo da un'ipotesi: quel che
sarebbe accaduto se fin dal 1988 gli italiani
avessero potuto investire la liquidazione in
un Fondo pensione integrativo, come all'epoca
si cominciò a ventilare. Risultato: in
diciotto anni, ben 77 Fondi comuni sugli 82
esaminati hanno battuto la tradizionale
rivalutazione del Tfr (il 75% dell'inflazione
più l'1,5%). La percentuale dei «vincitori»
scende però vertiginosamente sulle scadenze
più brevi. A cinque anni, meno di un Fondo su
due ha battuto il rendimento garantito dal Tfr
attuale. Pertanto, chi nel frattempo ha
lasciato l'azienda, ha trovato un gruzzolo
(subito e contante) spesso più pingue di
un'analoga accumulazione attraverso un Fondo.
Sapranno fare meglio i gestori dei nuovi
Fondi pensione? L'interrogativo, in cui si
mischiano speranze e dubbi, è al momento privo
di risposte convincenti, salvo un dato
fattuale, concreto. La devoluzione del Tfr,
purtroppo obbligatoria per le imprese con
oltre 50 dipendenti, risulterà a scadenza
conveniente per il lavoratore solo nel caso di
un investimento articolato, e con una robusta
capacità d'iniziativa. Senza subire il
condizionamento delle banche e delle compagnie
assicurative che attualmente, in Italia,
controllano la quasi totalità dei Fondi comuni
esistenti. E apprestandosi a gestire i nuovi
Fondi pensionistici.
L'esempio più interessante viene
dall'America, dove 80 milioni di famiglie, tre
su quattro, si affidano per pensioni, rendite
supplementari, assistenza sanitaria, a Fondi
assolutamente autonomi. Come si trattasse di
società in cui i soci-azionisti, oltre ad
avere voce in capitolo, nominano o licenziano
gli amministratori in base ai risultati.
Mediamente eccellenti. Una ricerca della
Ibbotson Associates ha documentato che
nell'arco di 80 anni, fra il 1926 e il 2005, i
vari Fondi hanno assicurato un rendimento
annuo fra il 5,5 e il 10,4%, a seconda della
loro abilità di muoversi fra azioni e
obbligazioni. Non solo Wall Street, peraltro.
È recente («Financial Times», 28 dicembre
2006) l'annuncio di un'iniziativa della
primaria banca d'affari Goldman Sachs: il
lancio di un Fondo da 6,5 miliardi di dollari
(circa 5 miliardi di euro) principalmente
riservato agli Enti pensionistici privati con
l'intento di diversificare i rischi
borsistici, investendo nelle grandi
infrastrutture che assicurino, sul medio-lungo
termine, una alta redditività. Porti,
autostrade, aeroporti. Onde mettere al riparo
i pensionati e gli assistenti dai pericoli
rappresentati sia dalle oscillazioni di Wall
Street sia dalle difficoltà incontrate dai
Fondi aziendali (Enron in California, Ford e
General Motors a Detroit).
Fidarsi insomma della Borsa, ma anche agire
in proprio. Perché allora, non prendere ad
esempio, sia pure con le dovute cautele, il
modello dei Fondi targati Usa? Evitando che i
Fondi pensione si trasformino in una semplice
cinghia di trasmissione di capitali
all'interno del «sistema esistente».
Comunque vada, i Fondi pensione in
gestazione penalizzeranno i lavoratori.
Complicato e parziale riscatto in caso di
licenziamento o disoccupazione, malattia e
urgenze familiari, incognite sulla
rivalutazione. Da sommare a una domanda per
nulla peregrina: che ne sarà dei 10-14
miliardi di euro annui accumulandi?
Nell'attesa di risposte esaustive, poiché di
«soldi nostri», di «retribuzione differita»
trattasi, è opportuno che i lavoratori
italiani siano messi nella condizione di
valutare capendo. Chiamati come sono a un
sacrificio. Evitando fumisterie legate agli
andamenti borsistici, e guardando al bene
comune.
In tal senso, vanno prendendo forma
iniziative di notevole interesse. Spicca
quella del finanziere-imprenditore bresciano
Romain Zaleski (all'onore delle cronache per
le molteplici partecipazioni in banche e
assicurazioni), proprietario della Metalcam in
Val Camonica, 130 miliardi di fatturato in
acciai speciali e piattaforme petrolifere e
270 dipendenti ai quali ha proposto: «Mettete
il Tfr in azienda, e avrete un posto nel
consiglio d'amministrazione». Quindi la
creazione di una società ad hoc, la Lavoro
spa, con i lavoratori in maggioranza (due su
tre) nel consiglio. La Metalcam è impegnata il presidente Zaleski in persona - a
sostenerne lo sviluppo anche attraverso
prestiti bancari in modo che il Fondo marci su
due gambe: la redditività aziendale e gli
investimenti. Impossibile far pronostici, ma
possiamo immaginare che l'Inps faccia meglio?
Quella del Tfr, non nascondiamoci dietro un
dito, è una piccola rivoluzione per chi
lavora. Che si trasformi in uno «scippo»
legalizzato o in un'opportunità dipende da
come verrà concretamente gestito: da puntello
per il deficit pubblico a strumento che può
(potrebbe) risultare il punto d'inizio di un
processo partecipativo dei lavoratori
all'economia.
Giancarlo Galli
(«Vita e Pensiero» n. 1/07)
Burnout: la sindrome del fuoco spento
A chi non è capitato di sentire le proprie
energie completamente consumate e assorbite
dagli impegni di lavoro? Di cominciare una
nuova giornata lavorativa sentendosi già
stanchi e senza risorse? Di avvertire
l'inutilità del proprio operato di fronte alle
difficoltà quotidiane, all'indifferenza dei
propri colleghi e alle richieste pressanti
dell'organizzazione? Di sentirsi totalmente
insensibili di fronte al disagio e alle
richieste di aiuto degli altri?
Quando questa condizione non è più
temporanea e occasionale ma diventa prevalente
e si cronicizza nel tempo, parliamo di
burnout, una vera e propria sindrome
lavorativa che causa uno stato di malessere
intenso al lavoratore e al tempo stesso gli
impedisce di essere professionalmente
efficace.
Il termine stesso mette in evidenza alcuni
tratti salienti della sindrome: burnout
infatti rimanda a ciò che è bruciato,
logorato, fuso, scoppiato. Non è un caso che
una delle metafore a cui spesso fanno
riferimento gli stessi lavoratori colpiti
dalla sindrome sia quella di un fuoco che, un
tempo acceso e bruciante di energia, si è ora
spento, lasciando il posto a delle fredde
ceneri.
Il burnout è dunque un fenomeno
caratterizzato dal completo esaurimento
emotivo e psicofisico del lavoratore,
accompagnato dal distacco, o da una vera e
propria avversione verso il lavoro, i
colleghi, i superiori, i clienti o gli utenti,
ecc. Quali sono i segnali che permettono di
riconoscere il burnout e in che modo si può
intervenire?
I sintomi del burnout
Parlando di burnout, alcuni decenni fa si
faceva riferimento esclusivamente ad alcune
categorie di lavoratori: i medici, gli
infermieri, gli insegnanti e, più in generale,
gli operatori sociali. Infatti la forma più
classica della sindrome si manifesta nelle
professioni cosiddette «di aiuto», quelle che
si svolgono all'interno dei contesti
sociosanitari e scolastici, in cui l'obiettivo
dell'attività lavorativa è la cura, l'aiuto,
l'educazione o la riabilitazione. Christina
Maslach è la studiosa che più si è occupata di
burnout ed è a lei che dobbiamo la
sistematizzazione teorica più nota della
sintomatologia del fenomeno. Questa si
caratterizza per tre segni distintivi,
contemporaneamente presenti:
1) Esaurimento emotivo: la persona avverte
di aver «bruciato» tutte le sue energie; si
sente stanca, svuotata, senza più risorse
fisiche ed emozionali per affrontare
l'attività lavorativa.
2) Depersonalizzazione: la persona manifesta
un atteggiamento freddo e cinico nelle
relazioni con gli altri, che sono sempre più
caratterizzate da indifferenza e annullamento
delle emozioni. Al concetto di
depersonalizzazione si è venuto
progressivamente a sostituire quello di
disaffezione. La differenza è notevole: mentre
con il concetto di depersonalizzazione si
poneva l'accento su una risposta disfunzionale
agli utenti, con il concetto di disaffezione
si pone l'accento su una risposta
disfunzionale al lavoro in sé e per sé.
3) Riduzione dell'efficacia professionale:
la persona avverte un crescente senso di
inadeguatezza, una diminuzione, o perdita,
della propria competenza professionale e una
mancanza di fiducia nelle proprie possibilità.
Vi possono poi essere numerosi altri
sintomi, come umore depresso, ansia,
instabilità emotiva, senso di colpa, bassa
tolleranza alle frustrazioni, disturbi
psicosomatici ed anche aumento dei
comportamenti rischiosi.
Secondo i primi studi i soggetti più esposti
al burnout sarebbero quelli più empatici,
idealisti e tendenti ad identificarsi con gli
altri, ma anche quelli più introversi,
ansiosi, ossessivi e altamente entusiasti.
Spesso sono proprio questi tratti di
personalità ad orientare la scelta di
intraprendere una professione di aiuto, con
una passione e un entusiasmo inizialmente
notevoli, che poi però non trovano sufficiente
riscontro nella realtà lavorativa.
Non tutte le persone sono ugualmente esposte
al burnout; può capitare che su due colleghi
che lavorano nello stesso reparto per uno
stesso periodo di tempo, affrontando
quotidianamente le medesime difficoltà
lavorative, uno sia colpito da burnout e
l'altro no. In casi del genere spesso è
l'efficacia personale, ossia la convinzione
della persona di riuscire a gestire con
successo le situazioni, anche quelle
complesse, a rappresentare il fattore
determinante. Il lavoratore con un'elevata
efficacia personale vedrà le difficoltà
lavorative come delle sfide davanti alle quali
insistere e aumentare l'impegno e i fallimenti
come occasioni di apprendimento e stimoli a
migliorare. Il lavoratore con bassa efficacia
personale sarà invece portato a vedere le
difficoltà come ostacoli insormontabili e
tenderà ad arrendersi, a vedersi già sconfitto
in partenza, ed anche davanti alle situazioni
incerte sarà portato a mettere meno impegno e
ad avere sempre meno fiducia in sé. In breve:
un basso livello di efficacia personale è un
fattore predisponente alla manifestazione
della sindrome del burnout, laddove un alto
livello costituisce un fattore particolarmente
protettivo.
Negli ultimi tempi, oltre al passaggio dal
concetto di depersonalizzazione a quello di
disaffezione, si sono anche estesi i contesti
di osservazione del burnout. Con il tempo ci
si è infatti resi conto che il fenomeno poteva
riguardare non solo gli operatori sanitari ed
educativi, ma anche molti altri lavoratori
sottoposti a forte e costante stress
quotidiano. Specialmente oggi, in un contesto
di mercato globale e competitivo,
caratterizzato da estrema precarietà e
instabilità del lavoro e dell'economia stessa,
e al tempo stesso da forte velocità, in un
mondo in cui non ci sono più certezze, tranne
il fatto che occorre costantemente adattarsi
ai cambiamenti e correre per battere la
concorrenza, tutte le professioni possono
essere esposte al burnout.
Consideriamo anche il fatto che il lavoro
nella nostra società è sempre più centrale per
l'identità personale, tanto nei suoi risvolti
affettivi quanto in quelli relazionali e
sociali. In esso vengono investite molte delle
proprie risorse in termini di energie, tempo,
motivazioni e capacità.
Le conseguenze del burnout non sono solo
individuali (depressione, disturbi
psicosomatici, abuso di sostanze,
insoddisfazione, ecc.), ma anche
organizzative: assenteismo, calo delle
performance e della qualità del servizio,
abbandono. Appare dunque importante e quanto
mai attuale che le organizzazioni si
preoccupino di tutelare le proprie risorse
umane, sostenendole nel fronteggiare lo
stress, che può ripercuotersi nella qualità
della vita personale, ma anche nella
prestazione lavorativa, nel rapporto con i
colleghi, i clienti e gli utenti. Diventa
allora fondamentale pianificare e realizzare
strategie di prevenzione del disagio
lavorativo, intervenendo su ciò che può essere
fonte di benessere e di coinvolgimento.
L'organizzazione
Studi recenti evidenziano che il burnout può
essere compreso e affrontato solo se lo si
considera come un problema che coinvolge
l'intera organizzazione in cui si manifesta.
Le disfunzioni organizzative possono avere un
peso molto rilevante nell'insorgenza della
sindrome. L'organizzazione, infatti, definisce
i vincoli e le risorse che le persone hanno a
disposizione ed è nel contesto lavorativo che
si strutturano i rapporti con gli altri e si
definiscono le regole che li sostengono. Vi
sono dunque svariati aspetti - strutturali,
culturali, relazionali e di ruolo - che hanno
un forte impatto sull'incidenza e sul grado di
burnout che può manifestarsi in
un'organizzazione.
A questo proposito Maslach e Leiter (1997)
hanno approntato uno strumento di analisi
della vita lavorativa. Si tratta del Maslach
Burnout Inventory, di cui è oggi disponibile
anche l'adattamento italiano (Questionario di
Check-up Organizzativo: Borgogni et al.,
2005). Tale strumento esplora: a) la relazione
personale con il lavoro, b) le principali aree
della vita lavorativa e c) i processi di
gestione.
a) La relazione con il lavoro riguarda il
livello di «job engagement». Con tale
espressione ci si riferisce a tre dimensioni
antitetiche a quelle caratterizzanti il
burnout:
1) energia (vs esaurimento),
2) coinvolgimento (vs disaffezione),
3) efficacia (vs inefficacia).
La persona «engaged» (ossia impegnata,
coinvolta) svolge il proprio lavoro con grande
energia, si sente coinvolta a livello
emozionale e affettivo in quello che fa e
contemporaneamente percepisce di riuscire nel
proprio lavoro e di dare con esso un
contributo importante all'organizzazione.
b) Le aree della vita lavorativa riguardano:
1) il carico di lavoro,
2) il controllo sulla propria attività
lavorativa,
3) il riconoscimento (economico e
psicologico),
4) l'integrazione sociale,
5) l'equità dell'organizzazione,
6) la congruenza tra valori personali e
organizzativi.
Se la persona avverte una mancanza di
sintonia tra sé ed una o più di queste aree,
può incappare nel burnout.
c) I processi di gestione riguardano più
specificamente le aree dell'intervento. Esse
sono:
1) il cambiamento,
2) la leadership,
3) lo sviluppo delle competenze,
4) la coesione di gruppo.
Burnout ed engagement non dipendono solo
dalle persone e neppure solo dalle
organizzazioni, ma sono l'effetto combinato di
caratteristiche individuali, fattori
relazionali, ambientali e sociali che
interagiscono tra loro. Sono senza dubbio
rilevanti sia le motivazioni e le aspettative
della persona circa l'attività lavorativa, sia
il tipo di ambiente più o meno favorevole in
cui essa viene a trovarsi, nonché la
compatibilità tra l'organizzazione e le
caratteristiche individuali. Al tempo stesso
diviene centrale la capacità della persona di
affrontare le situazioni frustranti, di
reagire positivamente alle difficoltà, di
contribuire al cambiamento proprio e
dell'ambiente lavorativo.
Il sovraccarico relazionale
Come si vede, il grande merito del nuovo
approccio al burnout è quello di aver
proficuamente allargato l'interesse tanto ai
lavoratori quanto al contesto organizzativo
nel suo insieme, e quindi anche alla
possibilità di prevenire e curare la sindrome
a più livelli. C'è però da dire che tale
approccio rischia di offuscare quella
relazione dell'operatore con l'utente di cui
parlavamo prima e che in origine
caratterizzava ampiamente l'analisi del
burnout.
Eppure bisogna tenere presente che gli
aspetti relazionali costituiscono un elemento
molto importante nei contesti organizzativi
attuali, perché le persone sono continuamente
esposte a situazioni interpersonali difficili,
se non proprio conflittuali, ad esempio sono
obbligate al confronto con persone provenienti
da culture diverse e portatrici di valori
nuovi, situazioni che tendono ad incrementare
la diffidenza e la complessità dei rapporti.
Inoltre, mai come oggi nelle organizzazioni
appare indispensabile il lavoro in partnership
con il cliente, del quale in ogni settore
viene costantemente monitorato il livello di
soddisfazione. Siamo passati da organizzazioni
fondate sul prodotto tecnico a organizzazioni
fondate sull'orientamento al cliente, perché
si è visto che in definitiva è quest'ultimo a
premiare e garantire la sopravvivenza
dell'organizzazione.
Per questo il nostro gruppo di ricerca sta
introducendo nello studio del burnout una
nuova dimensione, che abbiamo definito
«sovraccarico relazionale» (Borgogni et al.,
2006). Lo scopo è quello di recuperare la
sostanza di quel concetto di
depersonalizzazione che si è venuto negli
ultimi tempi dissolvendo. Il concetto di
sovraccarico relazionale orienta il
monitoraggio delle pressioni degli altri,
clienti o utenti che siano, sui lavoratori e
dei loro conseguenti sentimenti di fastidio e
di indifferenza. Il sovraccarico relazionale
può emergere in tutti i contesti in cui sia
rilevante, per il conseguimento degli
obiettivi organizzativi, la relazione
interpersonale e può riguardare non solo il
rapporto con il cliente o l'utente, ma anche
quello con i superiori, i colleghi e i
collaboratori.
L'intervento
Che fare? Quali possono essere gli
interventi per uscire dal burnout e promuovere
l'engagement? Se tutta l'organizzazione è
coinvolta e motivata a prevenire o ridurre il
burnout, si può pensare ad un'azione globale
che, attraverso il potenziamento della
capacità delle persone di far fronte agli
stressor negativi, si ponga l'obiettivo di
incrementare la propensione dell'individuo a
lavorare con energia, ad essere emotivamente
coinvolto e a sentirsi efficace nel proprio
lavoro. Lavorando per il potenziamento
dell'efficacia personale e per lo sviluppo del
job engagement è infatti possibile creare le
condizioni per stimolare il coinvolgimento nel
lavoro e migliorare la prestazione del
personale, contribuendo contemporaneamente a
migliorare la vita lavorativa delle persone.
Ma come si può articolare un vero e proprio
intervento di questo tipo?
Intanto si può lavorare su più fronti, sia
nell'ambito della prevenzione che della
riduzione del fenomeno. A livello
organizzativo è importante conoscere la
condizione attuale attraverso un'analisi del
contesto. Il checkup dell'organizzazione
individua le variabili significativamente
intrecciate con il burnout. Queste
costituiscono gli elementi da cui partire per
«proteggersi» dalla sindrome. Può trattarsi,
ad esempio, delle relazioni con colleghi e
superiori, del carico di lavoro, della
percezione del management, ecc. In tal caso
gli interventi possono prevedere cambiamenti
strutturali, come ad esempio la ridefinizione
dei ruoli e dei carichi di lavoro, o programmi
di formazione rivolti ai responsabili per lo
sviluppo delle capacità gestionali.
A livello individuale è possibile prevedere
programmi di sviluppo dell'efficacia
personale, data la sua rilevanza come fattore
di protezione. Si tratta soprattutto di
interventi di coaching e counseling
individuale volti a rafforzare la capacità di
gestione delle emozioni e dello stress, delle
relazioni interpersonali e il time management.
Altre azioni possono interessare lo sviluppo
dell'interdipendenza, del sostegno reciproco e
della gestione del conflitto attraverso la
formazione al lavoro di gruppo.
Nei contesti sociosanitari sono risultati
efficaci interventi di formazione per medici e
infermieri, orientati allo sviluppo della
relazione con il paziente e in particolare di
specifiche competenze psicologiche per la
gestione della comunicazione e della relazione
con il paziente e con i familiari, nonché
gruppi di self-help guidati per condividere
tra gli operatori le criticità vissute ed
individuare possibili azioni per
fronteggiarle.
Complessivamente, alla luce delle ricerche e
dei diversi filoni d'intervento prospettati,
sembra raccomandabile considerare il burnout
come un fenomeno complesso e multideterminato,
in cui gioca un ruolo significativo il peso
congiunto dei diversi fattori (individuali,
relazionali e organizzativi), più che di ogni
singolo aspetto preso da solo. Ancor più utile
è intervenire prima che il fenomeno insorga e
in questo la ricerca condotta negli ultimi
anni ci aiuta molto. Si possono infatti creare
le condizioni individuali e di contesto per
prevenire il burnout o, meglio ancora, per
rafforzare l'impegno e il coinvolgimento nel
lavoro e nell'organizzazione.
Le professioni d'aiuto
Gli operatori sanitari, medici e infermieri,
e gli insegnanti sono le figure più
tipicamente colpite da burnout. Chi non ha
avuto modo di osservare, almeno una volta,
qualche infermiere o qualche medico che si
comportava in modo scorbutico e insensibile
nei confronti dei pazienti, come se questi
fossero degli oggetti piuttosto che delle
persone? Oppure qualche insegnante che non
credeva più nel suo lavoro, che non prestava
attenzione ai suoi studenti, dai quali era
anzi quasi infastidito, che si limitava a
ripetere in modo routinario e stereotipato il
programma, senza alcun coinvolgimento o
interesse? Il fatto è che queste professioni
richiedono un notevole dispendio di energia
fisica e psicologica, perché comportano grande
disponibilità e pazienza verso gli altri,
comprensione delle loro difficoltà e capacità
di offrire supporto in qualsiasi momento.
Tutto ciò può essere particolarmente faticoso
nei contesti ospedalieri, quando ci si
confronta con pazienti difficilmente
recuperabili, portatori di malattie che
mettono a nudo i limiti della scienza e delle
buone intenzioni, oppure quando il carico di
lavoro è particolarmente elevato. In queste
situazioni l'operatore avverte un senso di
frustrazione per l'incapacità di portare a
termine l'obiettivo fondamentale del suo
lavoro, ossia la cura e la guarigione del
paziente.
Quando le richieste diventano
particolarmente pesanti o eccessive, il
lavoratore è costretto ad investire quantità
crescenti di energia, pur ricevendo ben poco
in cambio, tanto sul piano relazionale
(gratitudine da parte degli utenti, sostegno
da parte dei colleghi, gratificazioni da parte
dei superiori) quanto su quello organizzativo
(remunerazione, crescita professionale, ecc.).
Man mano che passa il tempo l'operatore può
non farcela più a sostenere le richieste e può
cercare di proteggersi sviluppando un graduale
distacco, che può tramutarsi progressivamente
in insofferenza verso il lavoro e l'utenza.
Pessimismo e disillusione possono facilmente
diventare modi di fronteggiare il vissuto di
fallimento.
Molti studi hanno dimostrato che nei
contesti ospedalieri le figure maggiormente a
rischio di burnout sono gli infermieri. Questi
operatori trascorrono più tempo dei medici con
i pazienti, per cui si confrontano di più con
la sofferenza e il disagio. Rispetto ai
medici, probabilmente, può esserci anche una
minore identificazione nel lavoro. Va detto
che non tutti i reparti sono uguali:
particolarmente esposti sono gli operatori del
pronto soccorso, dei reparti di
neurochirurgia, cardiologia e oncologia, dove
l'impatto con la sofferenza è maggiore e dove
la possibilità di riuscita è talvolta
indipendente dal proprio operare.
Nella scuola gli insegnanti più a rischio
sono quelli che si trovano a gestire classi
molto numerose, di sedi collocate in periferia
o in luoghi svantaggiati, o che devono
confrontarsi con alunni portatori di
problematiche specifiche (bullismo,
iperattività, handicap fisici e mentali) che
possono avere ripercussioni su tutto il
sistema classe.
Ma dalle ricerche è emerso che sono in gioco
anche altri fattori. I rapporti con i colleghi
e i superiori, ad esempio, costituiscono due
elementi cruciali, capaci di favorire
l'insorgenza e modulare l'intensità della
sindrome: un rapporto di collaborazione,
sostegno reciproco e confronto costruttivo con
i colleghi e la dirigenza, può aiutare a
vivere più serenamente il disagio lavorativo e
a trovare, anche attraverso il confronto,
strategie appropriate per fronteggiare il
proprio malessere. Può essere anche il solo
ascolto reciproco a ridurre il rischio di
burnout, perché in tal modo si acquista una
maggiore forza e fiducia in se stessi,
ritrovando nell'altro uno specchio su cui
riflettere le proprie incertezze, paure,
intolleranze.
Chiara Consiglio
Laura Borgogni
(«Psicologia contemporanea» n. 200/07)
L'altra immunità
- A lungo trascurata dalla scienza, la
risposta immunitaria innata è il primo
sbarramento difensivo dell'organismo. Scoperte
sorprendenti sul suo funzionamento potrebbero
portare a nuove terapie. Un uomo sta rientrando a casa con il treno
della sera quando il passeggero che gli siede
accanto inizia a tossire. Mentre si scherma
dietro al giornale augurandosi che il vicino
non abbia nulla di serio, il suo sistema
immunitario si mette al lavoro. Se il microbo
che il suo malaticcio vicino sta diffondendo
nell'aria è uno di quelli che il nostro
pendolare ha già incontrato in precedenza, un
intero battaglione di cellule immunitarie
addestrate - la fanteria del cosiddetto
sistema immunitario adattativo - si ricorderà
di quel particolare aggressore e lo spazzerà
via nel giro di poche ore, senza che il nostro
pendolare si accorga di essere stato
contagiato. Se però il virus o il batterio è
tra quelli contro cui non ha mai combattuto,
interverrà un tipo diverso di risposta
immunitaria. Questo sistema immunitario
«innato» riconosce famiglie generiche di
molecole prodotte da un'ampia gamma di agenti
patogeni. Quando individua le molecole
estranee, il sistema innato scatena una
risposta infiammatoria in cui alcune cellule
deputate a difendere l'organismo cercano di
isolare l'invasore bloccandone la diffusione.
l'attività di queste cellule e delle sostanze
chimiche che producono accelera il processo di
arrossamento e il gonfiore che compaiono nel
sito dell'infezione, e giustifica allo stesso
tempo la comparsa della febbre, i dolori
muscolari e gli altri sintomi pseudoinfluenzali che accompagnano molte infezioni.
L'aggressione di tipo infiammatorio è sferrata
inizialmente da recettori detti Toll-like
(TLR), un'antica famiglia di proteine cui
spetta il compito di modulare l'immunità
innata negli organismi, dai granchi all'uomo.
Se i recettori TLR falliscono, l'intero
sistema immunitario si sgretola, lasciando il
corpo in balia dell'infezione. Tuttavia, anche
un eccesso di attività dei recettori può
causare disturbi che si manifestano con una
cronica e pericolosa infiammazione, come
l'artrite, il lupus e addirittura le malattie
cardiovascolari.
La scoperta dei recettori TLR ha suscitato
tra gli immunologi un'euforia generale, e oggi
un gran numero di ricercatori si è dedicato a
questa linea d'indagine nella speranza di
trovare la spiegazione ai molti misteri che
ancora ammantano l'immunità, le infezioni e le
malattie che coinvolgono anomalie nelle difese
immunitarie. Lo studio dei recettori TLR e
degli eventi molecolari che hanno luogo dopo
che queste molecole sono entrate in contatto
con un agente patogeno sta iniziando a
rivelare potenziali bersagli per farmaci che
potrebbero incrementare l'attività protettiva
dell'organismo, rafforzare i vaccini e curare
un'ampia gamma di malattie devastanti e
potenzialmente mortali.
La cenerentola delle immunità
Fino a cinque anni fa, parlando del sistema
immunitario la parte del leone spettava al
sistema di difesa adattativo. I libri di testo
fornivano dettagliate descrizioni sulla
capacità dei linfociti B di produrre anticorpi
che si legano a specifiche proteine, gli
antigeni, presenti sulla superficie degli
agenti patogeni invasori. Ma davano molto
spazio anche ai linfociti T, cellule che
espongono sulla loro superficie recettori in
grado di riconoscere frammenti proteici di
origine patogena. Questa risposta è chiamata
adattativa perché nel corso di un'infezione si
adatta in modo da gestire in maniera ottimale
il particolare microrganismo responsabile
della malattia.
L'immunità adattativa si è conquistata
spazio sotto i riflettori anche perché
fornisce il sistema immunitario di memoria:
una volta eliminata un'infezione, i linfociti
B e T specificamente addestrati rimangono nei
paraggi, e istruiscono il corpo a respingere
aggressioni successive. È questa capacità di
ricordare le infezioni pregresse che consente
ai vaccini di proteggerci dalle malattie di
origine virale o batterica. I vaccini,
infatti, espongono l'organismo a una versione
indebolita di un patogeno (o a suoi frammenti
del tutto innocui), ma il sistema immunitario
reagisce come reagirebbe nei confronti di
un'aggressione reale, generando cellule
memoria con funzione protettiva. Grazie alla
presenza di linfociti T e B, dopo che un
organismo ha incontrato un microbo e gli è
sopravvissuto non ne sarà sopraffatto una
seconda volta.
Il sistema immunitario innato, al confronto,
appariva piuttosto scialbo. I ricercatori
erano convinti che i suoi componenti compresi gli enzimi ad azione antibatterica
presenti nella saliva e un gruppo di proteine
collegate fra loro (chiamate collettivamente
«complemento») che uccidono i batteri nel
flusso sanguigno - fossero meno sofisticati
degli anticorpi specifici e dei linfociti T
killer, anche perché il sistema immunitario
innato non modula le proprie risposte allo
stesso modo di quello adattativo.
Ma liquidando la risposta immunitaria innata
come noiosa e priva di interesse gli
immunologi trascuravano una scomoda realtà: il
sistema immunitario adattativo non può
funzionare se manca la più «grezza» risposta
innata. Il sistema innato produce proteine
segnale, le citochine, capaci non solo di
indurre l'infiammazione, ma di attivare anche
i linfociti B e T necessari per la risposta
adattativa. Per funzionare in modo ottimale il
sistema più sofisticato ha bisogno del suo
compagno più umile.
Alla fine degli anni novanta gli immunologi
disponevano di un'enorme quantità di
informazioni sul funzionamento del sistema
immunitario adattativo, ma avevano solo una
vaga idea dell'immunità innata. In
particolare, non capivano in che modo i
microbi attivassero la risposta innata, o
precisamente in che modo questo tipo di
stimolo contribuisse a guidare la risposta
adattativa dei linfociti T e B. Di lì a poco,
però, compresero che buona parte della
risposta si celava nei recettori TLR, prodotti
da diverse cellule del sistema immunitario.
Tuttavia, per riuscire a caratterizzare queste
proteine gli scienziati hanno dovuto seguire
un percorso tortuoso, che ha attraversato i
processi di sviluppo del moscerino della
frutta, la ricerca di nuovi farmaci contro
l'artrite e addirittura il neonato campo della
genomica.
Una proteina stravagante
Il cammino iniziò nei primi anni ottanta con
la scoperta delle citochine. Queste proteine
con funzione di messaggero sono prodotte da
diversi tipi di cellule immunitarie, fra cui i
macrofagi e le cellule dendritiche. I
macrofagi pattugliano i tessuti dell'organismo
a caccia di segnali che indicano un processo
infettivo, e quando captano una proteina
estranea danno inizio alla risposta
infiammatoria. In particolar modo, inglobano e
distruggono l'invasore che espone quella
proteina e producono una serie di citochine,
alcune delle quali lanciano un allarme che
richiama altre cellule nel sito
dell'infezione, mettendo tutto il sistema
immunitario in stato di allarme. Le cellule
dendritiche fagocitano i microbi invasori e
intercettano i linfonodi, dove presentano
frammenti delle proteine del patogeno ad
armate di linfociti T, e liberano citochine.
Tutte queste attività concorrono ad attivare
la risposta immunitaria adattativa.
Per studiare le funzioni delle singole
citochine i ricercatori dovevano trovare la
maniera di indurne la produzione. Il modo più
efficace per stimolare i macrofagi e le
cellule dendritiche a produrre queste molecole
in laboratorio, si è scoperto, è esporre
queste cellule ai batteri, o ancora meglio, a
specifiche componenti batteriche. In
particolare, a stimolare una potente risposta
immunitaria è una molecola prodotta da
un'ampia gamma di batteri, chiamata
lipopolisaccaride (LPS). Nell'uomo,
l'esposizione a LPS scatena la febbre e può
portare a shock settico, una sorta di
cortocircuito vascolare mortale causato da
un'azione dirompente e distruttiva delle
cellule immunitarie. LPS evoca questa risposta
infiammatoria stimolando macrofagi e cellule
dendritiche a liberare due citochine: il
fattore di necrosi tumorale-alfa (TNF-alfa) e
l'interleuchina-1 (IL-1).
In effetti, è stato dimostrato che sono
proprio le citochine a regolare la risposta
infiammatoria stimolando le cellule
immunitarie all'azione. Se non sono tenute
sotto controllo, queste molecole possono
accelerare la comparsa di disturbi come
l'artrite reumatoide, una malattia autoimmune
caratterizzata da un'eccessiva infiammazione
che provoca la distruzione delle
articolazioni. Perciò i ricercatori
ipotizzarono che, riuscendo a limitare gli
effetti di TNF-alfa e di IL-1, si sarebbe
potuto rallentare la progressione della
malattia, alleviando al contempo la sofferenza
dei pazienti. Per mettere a punto una simile
terapia, però, c'era bisogno di maggiori
informazioni sul funzionamento di queste
molecole, così il primo passo fu quello di
identificare le proteine con cui esse
interagiscono.
Nel 1988, John Sims e i suoi colleghi della
Immunex di Seattle scoprirono un recettore
proteico che riconosce IL-1. Questo recettore
è ancorato sulla membrana di molte cellule
diverse dell'organismo, tra cui anche i
macrofagi e le cellule dendritiche. La
porzione recettoriale che sporge all'esterno
della cellula si lega a IL-1, mentre il
segmento che giace all'interno trasmette il
messaggio che indica che IL-1 è stata captata.
Sims ha esaminato con attenzione la porzione
interna del recettore per IL-1, nella speranza
di ricavarne indizi sul modo in cui la
proteina trasmette il suo messaggio: sperava,
per esempio, che lo studio del recettore gli
rivelasse quali sono le molecole segnale che
esso attiva all'interno delle cellule. Invece
il dominio interno del recettore umano per IL1 si è rivelato diverso da ogni altro
recettore che i ricercatori avevano analizzato
in precedenza, cosa che li ha confusi non
poco.
Poi, nel 1991, mentre lavorava alla
risoluzione di un problema completamente
diverso, Nick Gay dell'Università di Cambridge
ha fatto una strana scoperta. Stava cercando
proteine simili a una proteina sintetizzata
dal moscerino della frutta, chiamata Toll, che
in tedesco significa «bizzarro, stravagante».
Toll era stata identificata a Tubinga, in
Germania, da Christiane Nusslein-Volhard, che
l'aveva battezzata così perché le drosofile
che ne sono prive hanno un aspetto piuttosto
strano. Questa proteina aiuta l'embrione di
drosofila in via di sviluppo a differenziare
le regioni apicali da quelle basali, tanto che
il corpo dei moscerini in cui la proteina è
assente appare a soqquadro, come se gli
insetti avessero perduto la lateralizzazione.
Gay passò in rassegna il database che
conteneva tutte le sequenze geniche conosciute
a quel tempo, alla ricerca di geni che
presentassero un'elevata omologia di sequenza
con il gene che codifica per Toll, e che
potessero quindi codificare per proteine
simili, o Toll-like. Alla fine scoprì che una
parte della proteina Toll mostra una
sorprendente somiglianza con la porzione
interna del recettore umano per IL-1, il
segmento che aveva meravigliato così tanto
Sims.
In un primo momento, la scoperta parve priva
di significato: per quale motivo una proteina
coinvolta nei processi infiammatori umani
avrebbe dovuto somigliare a una proteina che
indica all'embrione di drosofila qual è la
regione apicale? La scoperta rimase un mistero
fino al 1996, quando Jules A. Hoffmann e i
suoi collaboratori del CNRS di Strasburgo
dimostrarono che la drosofila usa le proteine
Toll per difendersi dalle infezioni fungine.
Nella drosofila, almeno in apparenza, Toll
svolge numerose funzioni ed è coinvolta tanto
nello sviluppo embrionale quanto nell'immunità
adulta.
Pulci d'acqua, stelle marine ed esseri umani
La somiglianza fra il recettore per IL-1 e
la proteina Toll riguarda esclusivamente i
segmenti proteici inseriti all'interno della
cellula. I domini esposti all'esterno, invece,
sono abbastanza diversi fra loro. Questa
osservazione ha indotto i ricercatori a
cercare delle proteine umane che somigliassero
completamente a Toll. Dopo tutto, solitamente
l'evoluzione conserva le strutture che
funzionano meglio, e se Toll era in grado di
mediare le risposte immunitarie nel moscerino
della frutta era probabile che proteine simili
avessero un'analoga funzione anche nell'uomo.
Nel 1997, su suggerimento di Hoffmann,
Ruslan Medzhitov e Charles Janeway Jr. della
Yale University scoprirono la prima di queste
proteine, che chiamarono «Toll umana». Nel
giro di sei mesi Fernando Bazan e i suoi
colleghi della DNAX di Palo Alto, in
California, identificarono cinque proteine
Toll umane, a cui diedero il nome di recettori
Toll-like (TLR). Uno di questi, TLR4, era la
stessa proteina Toll umana descritta da
Medzhitov e Janeway.
In quel momento, i ricercatori non sapevano
ancora con precisione quale poteva essere il
contributo dei recettori TLR all'immunità
umana. Janeway aveva scoperto che riempiendo
di recettori TLR4 la membrana delle cellule
dendritiche si induceva la produzione di
citochine; tuttavia non era in grado di
precisare in che modo TLR4 era attivato
durante un'infezione. La risposta giunse alla
fine del 1998, quando Bruce Beutler e
collaboratori, allo Scripps Institute di La
Jolla, in California, scoprirono che topi
mutanti incapaci di rispondere allo stimolo di
LPS hanno una versione difettosa del recettore
TLR4. Mentre i topi normali muoiono di sepsi
nel giro di un'ora dall'iniezione di LPS, i
mutanti sopravvivono e si comportano come se
non fossero neppure stati esposti alla
molecola. In altre parole, la mutazione nel
gene che codifica per il recettore TLR4 rende
questi animali resistenti a LPS.
La scoperta confermò in modo inequivocabile
che il recettore TLR4 si attiva quando
interagisce con LPS, dal momento che il suo
compito è proprio quello di avvertire la
presenza di questa molecola. Questa
constatazione costituì un importante progresso
nel campo della sepsi, poiché svelò il
meccanismo molecolare che sta alla base
dell'infiammazione, fornendo al contempo un
nuovo possibile bersaglio per la cura di un
disturbo per cui vi era una drammatica urgenza
di terapie efficaci. Nel giro di due anni i
ricercatori stabilirono che la maggior parte
dei recettori TLR - di cui attualmente si
conoscono dieci varianti umane - riconosce
molecole che risultano importanti per la
sopravvivenza di batteri, virus, funghi e
parassiti. Il recettore TLR2, per esempio, si
lega all'acido lipoteicoico, una componente
della parete cellulare batterica. Il recettore
TLR3 riconosce il genoma dei virus mentre il
TLRS riconosce la flagellina, una proteina che
forma i flagelli ondulati usati dai batteri
per nuotare. Il TLR9, infine, riconosce una
sequenza genetica segnale chiamata CpG,
presente nei batteri e nei virus sotto forma
di lunghe stringhe e in una forma chimica
diversa dalle sequenze CpG che caratterizzano
il DNA dei mammiferi.
È evidente che i recettori TLR si sono
evoluti per riconoscere e reagire a molecole
che rappresentano componenti fondamentali
degli organismi patogeni. L'eliminazione o
l'alterazione chimica di uno qualsiasi di
questi elementi potrebbe menomare un agente
infettivo e impedire ai patogeni di schivare i
recettori TLR mutando fino a che queste
componenti diventano irriconoscibili. E dal
momento che molti microrganismi hanno in
comune un gran numero di questi elementi,
bastano appena dieci TLR per proteggerci
praticamente da ogni patogeno conosciuto.
L'immunità innata non è un'esclusiva
dell'uomo. Questo sistema, infatti, è molto
antico: anche le mosche hanno un sistema di
risposta immunitaria innato, come pure le
stelle marine, le pulci d'acqua e quasi ogni
altro organismo esaminato finora, molti dei
quali utilizzano i recettori TLR come innesco.
I vermi nematodi hanno un sistema che consente
loro di percepire i batteri infettivi e
nuotare in direzione opposta per evitarli.
Anche le piante sono ricche di TLR: il tabacco
ne ha uno chiamato proteina N, che gli serve
per difendersi dal virus del mosaico del
tabacco. La piantina Arabidopsis ne ha più di
200. Molto probabilmente, le prime proteine
Toll-like hanno avuto origine in un organismo
unicellulare che è stato l'antenato comune di
piante e animali, e forse queste molecole
hanno addirittura contribuito alla nostra
evoluzione, agevolandola. Se fossero stati
privi di un efficace mezzo di difesa dalle
infezioni, probabilmente gli organismi
pluricellulari non sarebbero neanche riusciti
a sopravvivere.
Assalto al castello
Un tempo si pensava che il sistema
immunitario innato offrisse una protezione non
molto più sofisticata di quella delle mura di
un castello: l'azione vera e propria sarebbe
cominciata solo dopo che il nemico aveva fatto
breccia e le truppe all'interno del castello i linfociti T e B - cominciavano a combattere.
Oggi sappiamo che le mura del castello sono
costellate di sentinelle, i recettori TLR, che
identificano gli invasori e suonano l'allarme
per mobilitare le truppe e preparare lo
spiegamento difensivo necessario a contrastare
vigorosamente l'aggressione. In altre parole,
i recettori TLR scatenano sia il sistema
innato sia quello adattativo.
Il quadro che ne emerge è più o meno il
seguente. Quando un patogeno entra per la
prima volta nell'organismo, uno o più
recettori TLR, come quelli presenti sulla
superficie dei macrofagi sentinella e delle
cellule dendritiche, si lega alle molecole
estranee - per esempio a LPS presente sui
batteri gram-negativi. Una volta in azione, i
TLR inducono le cellule a liberare particolari
serie di citochine. Queste proteine messaggero
reclutano quindi ulteriori macrofagi, cellule
dendritiche e altre cellule coinvolte nella
risposta immunitaria affinché abbattano e
aggrediscano in maniera non specifica il
microbo predatore. Allo stesso tempo, le
citochine secrete da queste cellule possono
produrre i classici sintomi dell'infezione,
tra cui febbre e i dolori muscolari tipici
dell'influenza.
I macrofagi e le cellule dendritiche che
hanno fatto a pezzi un agente patogeno ne
espongono i frammenti sulla loro superficie,
assieme ad altre molecole che indicano la
presenza di un organismo nocivo. I frammenti
così esposti, assieme alle citochine liberate
in risposta ai TLR, finiscono per attivare i
linfociti T e B. Queste cellule riconoscono
quelle specifiche porzioni proteiche e,
nell'arco di diversi giorni, sono stimolate a
proliferare e a sferrare un attacco potente ed
estremamente mirato contro quel particolare
invasore. Senza l'effetto di innesco dei
recettori TLR, i linfociti B e T non si
attiverebbero e l'organismo non sarebbe in
grado né di montare una risposta immunitaria
completa, né di conservare alcun tipo di
memoria relativa alle infezioni precedenti.
Dopo l'infezione iniziale, sul campo di
battaglia resta un numero sufficiente di
linfociti T e B «memoria», che permettono
all'organismo di affrontare in modo più
efficace l'invasore nel caso si ripresenti.
Quando un microbo ricompare, le cellule
memoria che lo riconoscono iniziano a
proliferare con rapidità, rinforzando le
difese in modo che possano facilmente
sopraffare l'avversario. La rapidità con cui
agisce questo esercito di cellule memoria è
tale che il processo infiammatorio può
addirittura non manifestarsi. Di conseguenza,
la vittima non si rende conto di essere
ammalata e può addirittura non notare
l'infezione quando questa si ripresenta.
Dunque, l'immunità innata e l'immunità
adattativa fanno parte dello stesso sistema
che riconosce ed elimina i microbi, e
l'interazione reciproca fra questi due sistemi
è l'elemento che rende così forte il nostro
sistema immunitario.
La scelta dell'arma
Per comprendere appieno in che modo i
recettori TLR controllino l'attività
immunitaria, gli immunologi devono
identificare le molecole che trasmettono
segnali dai TLR attivati ancorati sulla
superficie della cellula fino al nucleo,
mettendo in moto geni che codificano per
citochine e altri attivatori dell'immunità.
Questa linea di ricerca sta impegnando molti
laboratori, e noi abbiamo già effettuato
alcune affascinanti scoperte.
Oggi sappiamo che i TLR, come molti
recettori situati sulla superficie cellulare,
si assicurano l'aiuto di una nutrita schiera
di proteine segnale che portano il messaggio
fino al nucleo, un po' come i pompieri di una
squadra che si passano i secchi d'acqua di
mano in mano fino all'incendio. Tutti i TLR,
con la sola eccezione di TLR3, trasmettono il
loro segnale a una proteina adattatore
chiamata MyD88. Quale sia la proteina
successiva incaricata di trasmettere più in là
il segnale dipende dal tipo di TLR: il mio
laboratorio studia la proteina Mal, da noi
scoperta, che aiuta a trasportare i segnali
generati da TLR4 e TLR2. Per trasmettere il
segnale, TLR4 ha anche bisogno di altre due
proteine, Tram e Trif, mentre TLR3 fa
affidamento sulla sola Trif. Shizuo Akira,
dell'Università di Osaka, ha dimostrato che i
topi ingegnerizzati geneticamente in modo da
non produrre nessuna di queste proteine
segnale mediatrici non riescono a rispondere
ai prodotti batterici: questa osservazione
suggerisce che le proteine associate ai TLR
potrebbero rappresentare nuovi bersagli per
nuovi agenti antinfiammatori o antimicrobici.
L'interazione con gruppi diversi di proteine
segnale consente ai TLR di attivare diversi
set di geni che perfezionano le risposte
cellulari in modo che corrispondano meglio al
tipo di patogeno che incontrano. TLR3 e TLR7,
per esempio, percepiscono la presenza dei
virus. Quindi danno il via a una successione
di interazioni molecolari che inducono la
produzione e il rilascio di interferone, la
principale citochina ad azione antivirale.
TLR2, attivato dai batteri, stimola il
rilascio di una miscela di citochine tra le
quali non figura l'interferone, che però
risultano più adatte ad attivare un'efficace
risposta antibatterica da parte
dell'organismo.
La scoperta che i TLR possono individuare
diversi prodotti microbici e contribuire a
modulare la risposta immunitaria per
ostacolare il nemico sta rivoluzionando le
teorie che vedevano nel sistema immunitario
innato solo una barriera statica e incapace di
discriminazione. In realtà, si tratta di un
sistema dinamico che controlla quasi ogni
aspetto dell'infiammazione e dell'immunità.
Dalla Legionella al Lupus
Una volta riconosciuto il ruolo di primo
piano dei TLR, i ricercatori hanno subito
sospettato che numerosi disturbi di natura
infettiva e collegati all'immunità potevano
dipendere dalla presenza di forme tronche o
eccessivamente attive di questi recettori.
L'intuizione si è rivelata corretta: i difetti
nell'immunità innata determinano una maggiore
suscettibilità nei confronti di virus e
batteri. Nel corso di uno studio durato
vent'anni, è emerso che chi è dotato di una
forma ipoattiva del recettore TLR4 ha il 50
per cento di probabilità in più di contrarre
banali infezioni quotidiane, come raffreddori
e influenza. Invece, chi muore a causa del
cosiddetto morbo del legionario spesso è
portatore di una mutazione nel gene per il
recettore TLR5 che disattiva la proteina,
compromettendone la risposta immunitaria
innata e rendendola incapace di annientare il
batterio Legionella. D'altro canto, una
risposta immunitaria troppo zelante può essere
altrettanto funesta. Negli Stati Uniti e in
Europa oltre 400.000 persone all'anno muoiono
di sepsi, complicazione che deriva da
un'eccessiva risposta immunitaria guidata dai
TLR4.
Altri studi puntano in direzione del ruolo
dei TLR nelle malattie autoimmuni come il
lupus eritematoso sistemico e l'artrite
reumatoide. In questi casi i TLR possono
reagire ai prodotti derivanti dalle cellule
danneggiate, diffondendo una risposta
infiammatoria inappropriata e promuovendo una
reazione errata da parte del sistema
immunitario adattativo. Nel lupus, per
esempio, si è scoperto che TLR9 reagisce
contro il DNA dell'organismo. L'immunità
innata e i TLR potrebbero avere un ruolo anche
nelle malattie cardiache: sembra infatti che
le persone che hanno una mutazione nei TLR4
siano meno inclini a sviluppare malattie
cardiovascolari. Lo spegnimento del recettore
TLR4 potrebbe avere un effetto
cardioprotettore, perché sembra che
l'infiammazione contribuisca alla formazione
delle placche che occludono le arterie
coronarie. Perciò, la manipolazione del TLR4
potrebbe costituire un altro approccio in
grado di prevenire o di limitare questa
condizione.
Regolare il volume
La maggior parte delle grandi aziende
farmaceutiche è interessata a utilizzare i TLR
e le proteine segnale loro associate, poiché
queste molecole potrebbero essere un bersaglio
per farmaci in grado di curare infezioni e
disturbi legati all'immunità. Con il
diffondersi della resistenza agli antibiotici,
la comparsa di virus nuovi e più virulenti e
la minaccia crescente del bioterrorismo, è
sempre più urgente riuscire a sviluppare nuovi
metodi per aiutare il nostro organismo a
combattere le infezioni.
Le ricerche sui TLR, per esempio, potrebbero
condurre allo sviluppo di vaccini più sicuri e
più efficaci. La bontà della maggior parte dei
vaccini dipende dall'inclusione di un
adiuvante, una sostanza che dà il via alla
risposta infiammatoria, che a sua volta
aumenta la capacità del sistema adattativo di
produrre le cellule memoria auspicate.
L'adiuvante impiegato nella maggior parte dei
vaccini odierni non provoca una risposta
adattativa completa, ma favorisce piuttosto i
linfociti B rispetto ai linfociti T. Per
scatenare una risposta più energica, diverse
aziende hanno messo gli occhi sui composti che
attivano TLR9, un recettore che riconosce
un'ampia gamma di batteri e di virus e che
determina una consistente risposta
immunitaria.
I TLR, inoltre, ci stanno insegnando a
difenderci da armi biologiche come il virus
del vaiolo. Questi virus, che rappresentano
un'arma potenziale nell'arsenale dei
bioterroristi, possono inattivare i TLR
evitando così di essere individuati ed
eliminati. In collaborazione con Geoff Smith
dell'Imperial College di Londra, i miei
collaboratori hanno scoperto che rimuovendo la
proteina virale che inattiva i TLR riuscivamo
a produrre un virus indebolito, che poteva
fungere da base per un vaccino che
difficilmente avrebbe provocato un'infezione
accidentale e fatale di vaiolo.
Disponendo di adeguate conoscenze sui TLR e
sull'immunità innata, i medici potrebbero
riuscire a prevedere quali sono i pazienti che
reagiscono debolmente durante un'infezione e a
curarli in maniera più aggressiva. Se, per
esempio, dei pazienti arrivassero in ospedale
con i sintomi di un'infezione batterica e si
scoprisse che hanno una forma mutata del
recettore TLR4, il medico potrebbe bombardarli
di antibiotici o di sostanze capaci, in
qualche modo, di sostenere la loro risposta
immunitaria per impedire all'infezione di
causare danni duraturi.
Naturalmente, bisogna trovare un equilibrio
tra l'esigenza di stimolare una risposta
immunitaria sufficiente a eliminare il microbo
e il rischio di accelerare una risposta di
tipo infiammatorio che provocherebbe più danni
che benefici. Analogamente, qualunque farmaco
somministrato con l'intento di attenuare
l'infiammazione reprimendo l'attività dei TLR
e il rilascio delle citochine non deve, allo
stesso tempo, ridurre le difese dell'organismo
contro le infezioni.
I farmaci antinfiammatori che interferiscono
con il TNF-alfa, una delle citochine prodotte
in seguito all'attivazione di TLR4, offrono un
quadro che invita alla cautela. Il TNF-alfa
prodotto durante un'infezione e
un'infiammazione può accumularsi nelle
articolazioni dei pazienti affetti da artrite
reumatoide. I composti antinfiammatori
alleviano l'artrite, ma alcune persone che li
assumono finiscono con l'ammalarsi di
tubercolosi. È probabile che l'infezione sia
latente, ma contenendo la risposta
infiammatoria si corre il rischio di soffocare
le risposte patogeno-specifiche permettendo al
batterio di riemergere.
In breve, i TLR sono come la manopola per
regolare il volume di un impianto stereo,
poiché bilanciano l'immunità adattativa e
l'infiammazione. I ricercatori e le compagnie
farmaceutiche stanno ora cercando la maniera
per regolare questi controlli, in modo che
riducano l'infiammazione senza mettere fuori
combattimento l'immunità.
Considerando che fino a sette anni fa dei
TLR non si sentiva nemmeno parlare, possiamo
senz'altro dire che i ricercatori hanno
compiuto enormi progressi nella comprensione
del ruolo che queste proteine giocano sul
fronte avanzato delle difese dell'organismo.
L'immunità innata, che per molto tempo è
rimasta avvolta dall'oblio, è diventata
all'improvviso la reginetta del ballo.
Le pulci di Mechnikov
La scoperta dei recettori Toll e Toll-like
ha ampliato una linea di ricerca iniziata
oltre un secolo fa, quando il biologo russo
Ilya Mechnikov scoprì, in pratica, l'immunità
innata. Negli anni ottanta dell'Ottocento,
Mechnikov staccò alcune spine da un albero di
mandarino e le infilò in una larva di stella
marina. Il mattino seguente notò che le spine
erano circondate da cellule mobili che, così
egli suppose, stavano inglobando i batteri
introdotti assieme ai corpi estranei.
Successivamente Mechnikov scoprì che la pulce
d'acqua (Daphnia) esposta a spore fungine
attiva una risposta analoga. Questo processo,
chiamato fagocitosi, è il fulcro attorno a cui
ruota l'immunità innata, e la sua scoperta
meritò a Mechnikov il premio Nobel nel 1908.
Luke A.J. O'Neill
(«Le Scienze» n. 442/05)