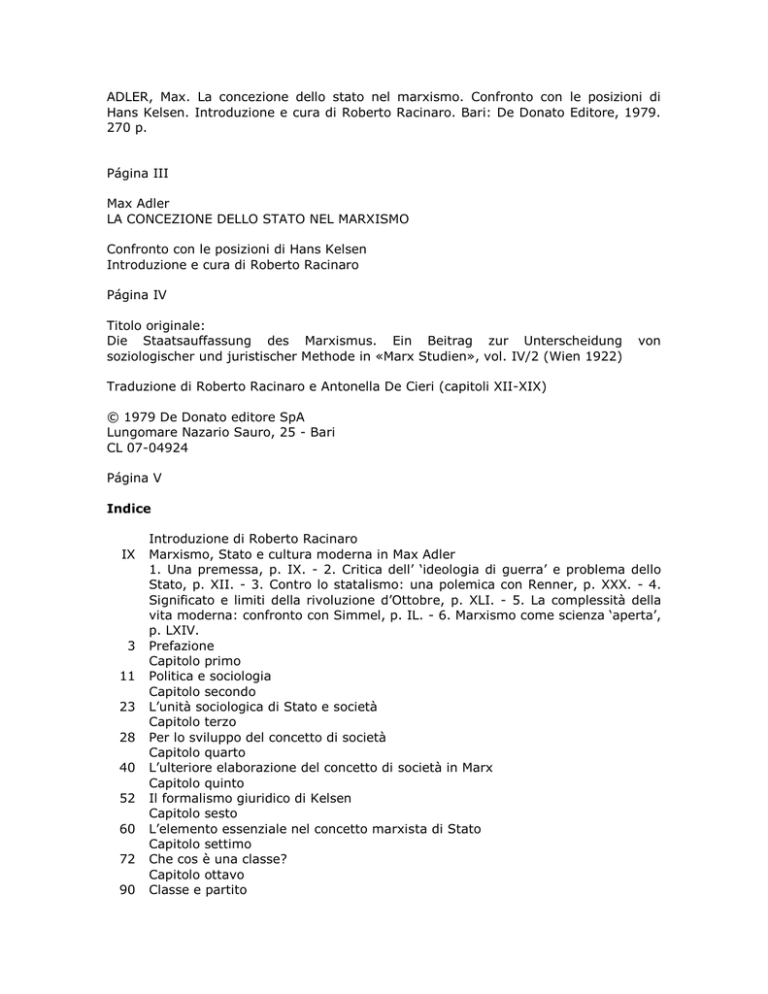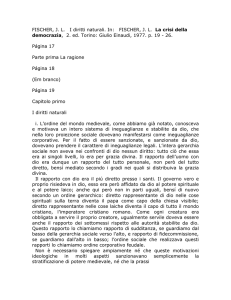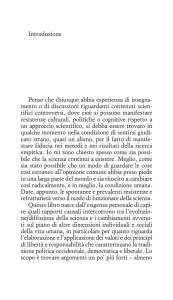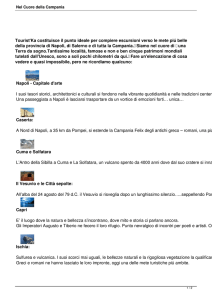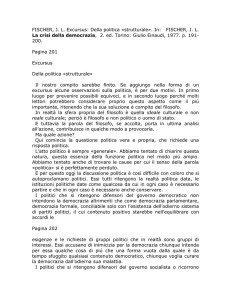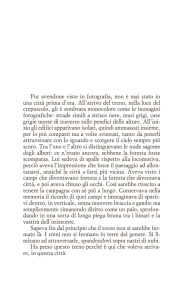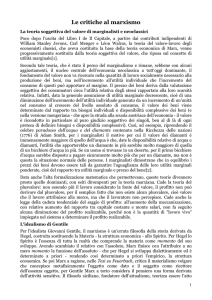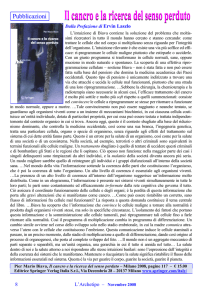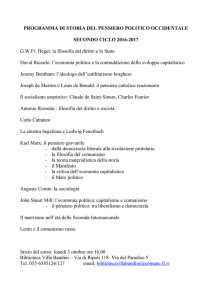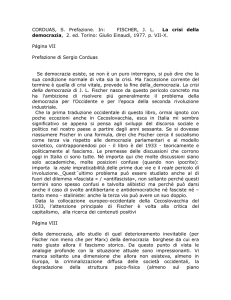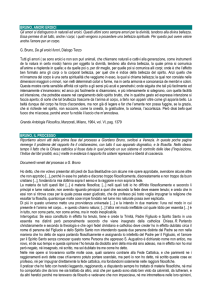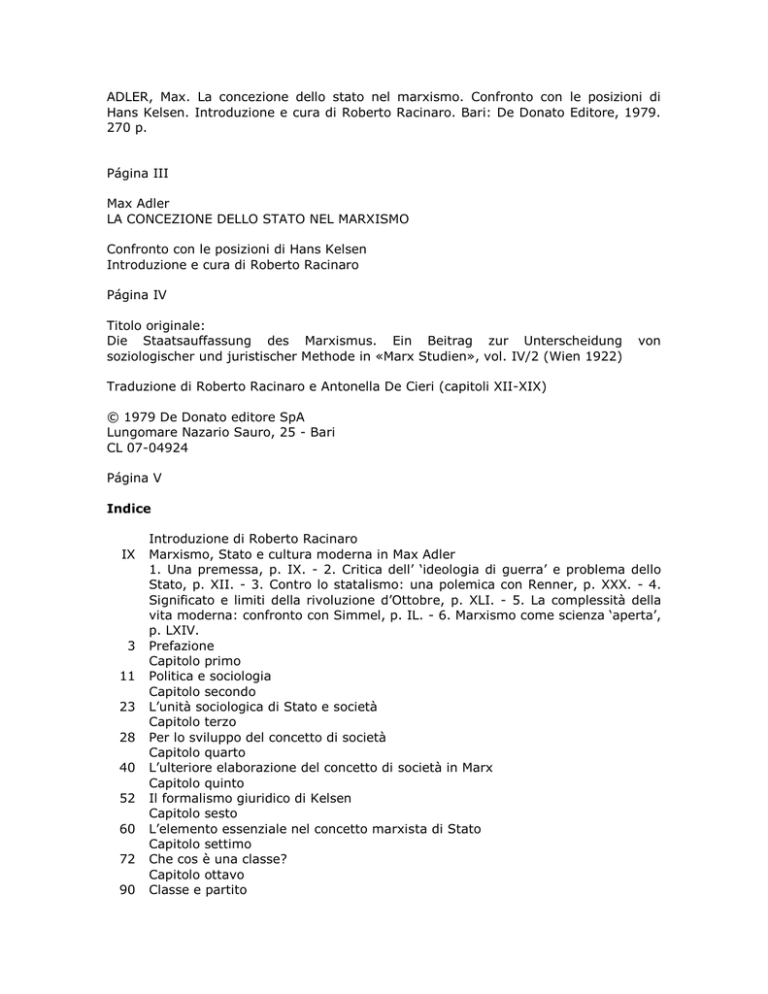
ADLER, Max. La concezione dello stato nel marxismo. Confronto con le posizioni di
Hans Kelsen. Introduzione e cura di Roberto Racinaro. Bari: De Donato Editore, 1979.
270 p.
Página III
Max Adler
LA CONCEZIONE DELLO STATO NEL MARXISMO
Confronto con le posizioni di Hans Kelsen
Introduzione e cura di Roberto Racinaro
Página IV
Titolo originale:
Die Staatsauffassung des Marxismus. Ein Beitrag zur Unterscheidung
soziologischer und juristischer Methode in «Marx Studien», vol. IV/2 (Wien 1922)
von
Traduzione di Roberto Racinaro e Antonella De Cieri (capitoli XII-XIX)
© 1979 De Donato editore SpA
Lungomare Nazario Sauro, 25 - Bari
CL 07-04924
Página V
Indice
IX
3
11
23
28
40
52
60
72
90
Introduzione di Roberto Racinaro
Marxismo, Stato e cultura moderna in Max Adler
1. Una premessa, p. IX. - 2. Critica dell’ ‘ideologia di guerra’ e problema dello
Stato, p. XII. - 3. Contro lo statalismo: una polemica con Renner, p. XXX. - 4.
Significato e limiti della rivoluzione d’Ottobre, p. XLI. - 5. La complessità della
vita moderna: confronto con Simmel, p. IL. - 6. Marxismo come scienza ‘aperta’,
p. LXIV.
Prefazione
Capitolo primo
Politica e sociologia
Capitolo secondo
L’unità sociologica di Stato e società
Capitolo terzo
Per lo sviluppo del concetto di società
Capitolo quarto
L’ulteriore elaborazione del concetto di società in Marx
Capitolo quinto
Il formalismo giuridico di Kelsen
Capitolo sesto
L’elemento essenziale nel concetto marxista di Stato
Capitolo settimo
Che cos è una classe?
Capitolo ottavo
Classe e partito
98
Capitolo nono
Democrazia politica e democrazia sociale
Página VI
Capitolo decimo
112 Democrazia e libertà
Capitolo undicesimo
124 Rivoluzione o evoluzione?
Capitolo dodicesimo
142 La democrazia e la sua organizzazione
Capitolo tredicesimo
159 La dittatura
Capitolo quattordicesimo
174 Governo e amministrazione
Capitolo quindicesimo
185 Excursus sull’anarchismo
1. La negazione della costrizone, della legge e dell’autorità, p. 185. - 2.
Ordinamento giuridico e ordinamento convenzionale, p. 199. - 3. La distinzione
specifica tra anarchismo e sodalism, p. 205. - 4. Socialismo e individualismo, p.
214.
Capitolo sedicesimo
222 Il presunto anarchismo del marxismo
1. L’idea di liberazione, p. 222. - 2. Forze politiche e forze sociali. Lo ‘Stato
politico’, p. 225. - 3. La rottura della macchina statale, p. 234. - 4. L’estinzione
dello Stato, p. 238.
Capitolo diciassettesimo
239 Il ‘miracolo’ della organizzazione senza Stato
Capitolo diciottesimo
249 L’utopismo in Marx ed Engels
Capitolo diciannovesimo
266 Perché non veniamo compresi?
270 Poscritto
Página VII
Introduzione
di Roberto Racinaro
Página VIII (em branco)
Página IX
Marxisrno, Stato e cultura moderna in Max Adler
La dottrina del materialismo storico è l’organizzazione critica del sapere sulle
necessità storiche che sostanziano il processo di sviluppo della società umana, non è
l’accertamento di una legge naturale, che si svolge ‘assolutamente’ trascendendo lo
spirito umano. È autocoscienza, stimolo all’azione, non scienza naturale che esaurisca i
suoi fini nell’apprendimento del vero.
A. GRAMSCI
1. Una premessa
Non è forse del tutto inutile, nell’accostarsi a un testo come La concezione dello Stato
nel marxismo, sgombrare il campo da qualche equivoco cui il testo stesso, in
apparenza, può dane adito.
Nato dall’esigenza di rispondere alle critiche che Hans Kelsen aveva rivolto alla teoria
politica del. marxismo, il libro di Max Adler há un andamento prevalentemente teorico,
che può suscitare l’impressione, nel lettore, di una pura e semplice contrapposizione
‘ideologica’, da parte di Adler, rispetto alle critiche kelseniane.
In verità, nulla è piú lontano dalle intenzioni adleriane del disegno di contrapporre
all’interpretazione kelseniana ‘erronea’ una propria ‘corretta’ interpretazione di Marx
[Nota 1]. Su questo punto Adler
Página X
stesso può richiamarsi a buon diritto — come avviene nella Prefazione a La concezione
dello Stato nel marxismo — alle posizioni espresse didotto anni prima e, in generale, al
progetto che stava dietro la fondazione delle «Marx-Studien». Il richiamo — nella
scelta del titolo del primo organo dell’austromarxismo — a quella prestigiosa rivista
filosofica che erano le «Kant-Studien» è sùbito evidente e, del resto, esplicitamente
ammesso da Adler [Nota 2]. Meno noto è il fatto che, in uno stadio avanzato di
realizzazione del progetto — quando cioè di esso si era già discusso con Viktor Adler, si
erano fatti i primi passi presso l’editore e alcuni lavori (per esempio, quello di
Hilferding su Böhm-Bawerk) erano già quasi pronti —, lo stesso Adler sembra dubitare
dell’opportunità d’intitolare la rivista «Marx-Studien», proprio per il timore che un tale
titolo possa attirare, fin dall’inizio, il sospetto di un eccesso di ‘filologismo’ o, per altro
verso, di ‘ortodossia’.
Abbiamo rinunziato al titolo «Marx-Studien» — strive Max Adler in una lettera a
Kautsky — perché esso circoscriverebbe in maniera troppo ristretta lo scopo e il
programma dell’iniziativa e potrebbe facilmente suscitare il sospetto come se si
trattasse di una sorta di Marx-Philologie [Nota 3].
L’eco di queste preoccupazioni è facilmente riscontrabile nell’editoriale — cui si fa
explicito riferimento nelle prime pagine del libro del ’22 — con cui si apriva il primo
volume delle «Marx-Studien». Pariendo dal presupposto che il marxismo «non è un
sistema rigido», e difendendosi preventivamente dalle accuse di ‘ortodossia’ e
‘dogmatismo’, l’editoriale affida ai lavori stessi che saranno ospitati dalla rivista il
còmpito di definire un’immaPágina XI
gine nuova e ‘aperta’ del marxismo — in quanto patrimonio di idee e di concetti da
mantenere in vita attraverso il continuo confronto critico con la realtá —, un’immagine
che può definirei solo attraverso il piú stretto rapporto del marxismo con gli sviluppi del
sapere moderno.
Proprio i lavori di questo volume — si legge nell’editoriale — mostreranno come noi
vediamo, nel marxismo, ogni cosa in sviluppo, uno sviluppo che, però, crediamo di
poter afferrare correttamente solo quando venga dappertutto stabilito un collegamento
consapevole dei risultati e dei metodi di pensiero marxisti con la vita spirituale
moderna nel suo insieme, cioè con il conenuto del lavoro filosofico e sociologico del
nostro tempo. [Nota 4]
Il confronto critico con Kelsen, agli inizi degli anni Venti, dunque, risponde ad
esigenze analoghe a quelle cui aveva risposto, nei primi anni del Novecento, il
confronto con il neokantismo. Kelsen è, da questo punto di vista, il teorico che ha
portato alle estreme conseguenze — ma «in maniera piú profonda e molto piú
coerente» — la problematica su cui, all’epoca della Bernstein-Debatte, aveva
richiamato l’attenzione Rudolf Stammler. Mentre quest’ultimo rimaneva ancora
impigliato nelle maglie della falsa contrapposizione fra «causalitá» e «teleologia» —
mostrando la sua incapacità, quindi, di distinguere fra telos e norma (la quale ultima
soltanto rappresenta un’effettiva contrapposizione rispetto alla causalità) — Kelsen per
primo ha condotto a fondo, nel suo àmbito specifico, «la lotta della gnoseologia
moderna contra lo psicologismo» [Nota 5].
L’ulteriore passo avanti compiuto da Kelsen rispetto al neokantismo tradizionale [Nota
6] richiede, corrispondentemente, che anche il
Página XII
marxismo riadegui le sue categorie, rispetto alle nuove critiche, piú sottili e raffinate,
che provengono dall’armamentario teorico kelseniano. Nel caso del confronto critico
con il kelsenismo, anzi, è ancora piú chiaro ciò che nel confronto con il neokantismo e
con Stammler si leggeva fra le righe: il fatto, cioè, che, la chiarificazione teorica ha il
suo fondamento — e, insieme; la sua destinazione — al di fuori di se stessa, nella
prassi [Nota 7]. Sottolineando la contemporaneità dell’apparizione delle opere di
Stammle e di Bernstein, Adler aveva richiamato l’attenzione — nel 1904 — sul rapporto
organico esistente fra neokantismo e revisionismo. Nel caso di Kelsen, il rapporto con
la ‘crisi del marxismo’ che data (perlomeno) dalla guerra mondiale è ancora piú
evidente, se è vero che già la prima pagina di Socialismo e Stato prende le mosse dalle
difficoltà — una questione ‘di principio’ — che, il socialismo si trova a dover affrontare
dal momento che, in seguito al crollo militare in Russia, in Germania e in Austria, si è
trovato a dover assumere compiti di governo. Ma, come nel 1904 non si era limitato a
respingere a limine le critiche revisionistiche, anzi si era sforzato di assumere —
ripensandoli in maniera autonoma — i contenuti di realtà in esse presenti; cosí, nel
1922, il tentativo, di Adler è quello di ripensare e approfondire alcuni concetti
fondamentali del marxismo; confrontandoli con le trasformazioni delia società e dello
Stato intervenute nell’ultimo decennio.
2. Critica dell’ ‘ideologia di guerra’ e problema dello Stato
Il problema che Adler ha presente, nel momento in cui scrive il libro sulla concezione
marxista dello Stato, non è, dunque, semplicemente, un problema di Marx-Philologie.
Si tratta; piuttosto, di verificare la ‘vitalità’ stessa del marxismo, in una fase in cui essa
sembra essere divenuta problematica persino all’interno del movimento operaio.
Página XIII
Da qesto punto di vista, anzi, la polemica con Kelsen è il punto di arrivo di un lavoro
di riflessione molto piú lungo e complesso — su cui occorre richiamare l’attenzione — e
che per Adler ha avuto inizio con gli anui della guerra mondiale. Non è eccessivo
sostenere, anzi, che è proprio in tale periodo che nascono una serie di questioni
strategiche — all’interno del movimentos operaio austriaco e europeo in generale —
destinate a fas incontrare quasi ‘necessariamente’ Marx Adler con il problema dello
Stato e del rapporto fra classe operaia e Stato.
Fin dall’aprile 1915, raccogliendo in un volumetto alcune conferenze e saggi (in parte
già pubblicati su «Der Kampf»), Adler giustifica questa nuova edizione dei suoi scritti
presentandola come un primo tentativo di verificare la possibilità «di mantenere la
coerenza dei concetti marxisti» [Nota 8]. Lo scatenamento di forze brutali che la
guerra comporta sembra portare lo scompiglio anche all’interno del movimento
operaio, altrimenti non si capirebbe come mai cosí spesso si senta ripetere «che i fatti
della storia, che ora si verificaro, dovrebbero condurre a piú di un mutamento dei
fondamenti di principio del marxismo», non si capirebbe, anzi, come mai piú d’uno
parli «del crollo della teoria del socialismo». Un tal modo di vedere comporta, secundo
Adler, «la vera e propria bancarotta del socialismo scientifico, poiché significa la sua
abdicazione di fronte alla prima situazione storica divenuta critica; significa
l’ammissione che il socialismo scientifico, con i suoi mezzi concettuali, non sarebbe in
grado di dominare la nuova situazione» [Nota 9]. Se questo fosse del tutto vero, lo
scacco sarebbe tanto piú vistoso in quanto il marxismo, come teoria del socialismo,
nasce e si fonda sull’esigenza del rapporto piú stretto fra scienza e vita:
La posizione della teoria rispetto alla vita — com’è noto — in nessun luogo è piú
discussa che nell’àmbito della politica: Ed è una delle rivendicazioni culturali maggiori
che il socialismo moderno fa valere, da Karl Marx in poi, quella di avere infine posto
termine a questa disputa con l’acquisizione di una scienza politica, che compenetra la
vita storica e l’azione politica con la conoscenza delle forze motrici e della legalità della
vita sociale. [Nota 10]
Alla tesi di coloro che sostengono che la teoria marxista è minacciata dagli eventi
della storia piú recente e, in particolare, della guerra mondiale, va obbiettato che essa
è piuttosto messa in periPágina XIV
calo «da uno strano romanticismo del sentimento e del modo d’intuire, che, nonostante
la sua origine borghese, si è fatto strada nelle file del proletariato» [Nota 11].
Si sentono spesso risuonare — osserva Adler — frasi altisonanti come ‘il futuro della
Germania si basa sul mare’, ‘vogliamo il nostro posto al sole’ ecc.;
contemporaneamente, si è andata sviluppando tutta un’ideologia intorno all’idea di
nazione [Nota 12]. Ma proprio il socialismo non dovrebbe mai perdere di vista il fatto
che «tutto quest’impeto verso l’esterno, tutta questa famosa espansione dell’idea
nazionale moderna non è altro che un fenomeno di movimento del capitalismo» [Nota
13]. In quanto tale, essa è inscindibile dalla natura del capitalismo — cioé dall’essenza
del suo modo di produzione e di scambio —; ma non è affatto una ‘necessità’ per il
proletariato, né si può dire che tale idea sia veramente ‘nazionale’ in senso storicoculturale.
L’attuale idea di nazione non ha piú nulla a che fare con quella presente nella filosofia
e nella cultura settecentesche, ove era strettamente connessa ad ideali umanitari e
cosmopolitici; non è piú l’idea di nazione propugnata da Fichte, che, in quanto primo
pensatore nazional-tedesco; può essere considerato anche come il primo socialista
tedesco [Nota 14]. Proprio per questo rimane indimostrato e indimostrabile il fatto
«che le vie dell’espansione capitalistica siano anche, in pari tempo, quelle
dell’emancipazione proletaria» [Nota 15]. L’idea di nazione, quale viene propugnata dai
suoi sostenitori contemporanei, conduce al nazionalismo e questo si trasforma, ben
presto, in imperialismo: «aspirazione al potere e al predominio mondiale» [Nota 16]. È
quí, appunto, che l’‘interesse’ del proletariato si divide da quello del capitalismo.
Non si dica che l’imperialismo è l’ultima e suprema forma del capitalismo che, appunto,
val la pena di attraversare, perché — in base alla
Página XV
teoria di Marx — il socialismo potrebbe anzi derivare solo dal pleno sviluppo del
capitalismo. Un tal modo di pensare ripete, ancora una volta, l’ingannevole conclusione
(su cui in piú modi si è richiamata l’attenzione), secondo cui ciò che è necessario per lo
sviluppo capitalistico proprio per questo andrebbe considerato anche come una
necessità per la politica del proletariato. In base a questa logica il socialismo non
sarebbe mai dovuto entrare in lotta per delle leggi in difesa degli operai. [Nota 17]
L’accezione fortemente antievoluzionistica (e quindi antieconomicistica) della
concezione del marxismo che opera dietro queste analisi adleriane è sùbito evidente.
Ciò su cui occorre ritornare a riflettere, invece, è quella categoria di ‘romanticismo’
(Romantik), con cui Adler tende ad interpretare un atteggiamento mentale divenuto
prevalente all’interno del movimento operaio e di larghe fasce dell’intelligenza tedesca
(e non solo tedesca) all’indomani dello scoppio della guerra mondiale. Si tratta; senza
dubbio, piú di una formula descrittiva che di una categoria analitica, rigorosamente
fondata. E questo limite non è privo di conseugenze, perché pregiudica — almeno in
parte — la capacità adleriana di analizzare alcune profonde trasformazioni della forma
della razionalità, che connotano, in pari tempo, parallele trasformazioni del lavoro
intellettuale nonché del rapporto fra intellettuali e politica.
Vi è qui, in un certo senso, una contraddizione (non esplicita) all’interno dell’universo
concettuale adleriano. La tesi interpretativa di Adler è già nota: marxismo e socialismo
non sono direttamente messi in crisi dalla guerra, bensí da quella sorta di
‘romanticismo’, che, nato all’esterno del movimento operaio, si va affermando anche al
suo interno. L’uso della categoria ‘romanticismo’ tende, oggettivamente, a riproporre
un’immagine delle ‘ideologie’ altre rispetto al marxismo come semplice ‘errore’ o
‘irrazionalismo’. Il che, da una parte, restituisce un’immagine estremamente
(eccessivamente) ‘lineare’ del marxismo (della forma di razionalità) con cui Adler opera
concretamente. E, d’altra parte, propone un concetto di ‘ideologia’ che non è
certamente quello adleriano.
Attraverso la categoria ‘romanticismo’, tuttavia, Adler si apre la via ad una
ricognizione delle ideologie degli intellettuali tedeschi, che, da un lato, restituisce un
tratto peculiare del marxismo di Adler — il rapporto ininterrotto e fertile con la cultura
esterna al movimento operaio — e, dall’altro, ne mette allo scoperto il fundamento: la
consapevolezza che, nella battaglia culturale, non sono in gioco semplici ubbie
intellettualistiche, ma che avviene un vero e proprio scontro di egemonie. L’ideologia,
strive infatti
Página XVI
fin d’ora Adler, «non è qualcosa d’impotente» («nicht etwas kraftloses ist»), ma è «un
potere che unifica gli uomini e li spinge avanti, e grazie alla quale soltanto tutte le
forze reali raccolte nella profondità della vita sociale diventano attive e acquistano
forma» [Nota 18].
La critica adleriana alla Protessorenliteratur — espressione con la quale Adler indica,
ironicamente, le innumerevoli prese di posizione degli intellettuali tedeschi durante la
guerra mondiale — in Prinzip oder Romantik! (il primo volumetto con cui si apre la
serie degli scritti adleriani del periodo della guerra) è appena accennata, anche se si
tratta di un cenno alle opere di due autori di primo piano come Sombart e Scheler
[Nota 19]. Ma essa viene largamente ripresa nelle due opere successive: Zwei Jahre...!
e Klassenkampf gegen Völkerkampf, ove, anzi, Adler si sforza di valorizzare — di
contro a tutte quelle posizioni che in maniera aperta o larvata si schierano a favore
della guerra e della supremazia tedesca, sostenendo il primato della Kultur tedesca
rispetto alla Zivilisation degli altri popoli [Nota 20] — quelle fratture interne che,
soprattutto intorno al ’17 [Nota 21], si vanno delineando all’interno del ceto
intellettuale tedesco [Nota 22].
Fin dall’inizio della guerra, larghe fasce d’intellettuali, nel tentativo di definire il ruolo
della nazione tedesca nel mondo, finiscono con l’attribuirsi Il còmpito
di dare alla guerra un senso positivo. Nelle ‘idee del 1914’ [...] la guerra non era piú
semplicemente una lotta difensiva, che la Germania aggredita doveva sostenere contro
la superiorità nemica, ma al di là di questo significato assumeva il carattere di piú alta,
fatale necessità, che affondava le sue radici nell’antiteticità che opponeva lo spirito
tedesco, la cultura tedesca e la vita pubblica tedesca elle corrispondenti forme di vita
del nemico esterno. [Nota 23]
Página XVII
Adottando una terminologia che ricorda da vicino la distinzione sombartiana fra popoli
di ‘mercanti’ e popoli di ‘eroi’, nel 1914 Thomas Mann — che, pure, negli anni
successivi avrebbe preso partito per la repubblica di Weimar — scrive che la guerra
non è stata voluta dalla Germania, bensí da «trafficanti senza scrupoli» [Nota 24]. È
vero, tuttavia, — prosegue Mann — che tutta «la virtú e la bellezza della Germania [...]
si affermano soltanto in guerra». La guerra, infatti, fa riemergere i valori della Kultur
tedesca contro il carattere astratto e meccanico della Zivilisation che ha contraddistinto
lo sviluppo delle altre potenze europee (Inghilterra e Francia in particolare):
L’anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per essa il concetto
piú sublime. La corruzione e il disordine dell’imborghesimento le sembrano un ridicolo
orrore. [...] E la stessa profonda, istintiva antipatia la nutre pet l’idéale pacifista della
civilizzazione. Non è la pace appunto l’elemento della corruzione civile, corruzione che
le appare divertente e spregevole al tempo stesso? Essa è bellicosa per moralità, non
per vanità e sete di gloria, né per imperialismo. Ancora l’ultimo dei grandi moralisti
tedeschi, Nietzsche (che del tutto erroneamente si definí l’immoralista) non faceva
segreto delle sue simpatie guerriere, militaresche. [Nota 25]
L’esperienza della guerra rilancia con forza i motivi idealistici propri della cultura
tedesca da Kant e Goethe a Fichte. Certo, si riconosce, la situazione attuale è molto
«piú difficile» e «piú complicata» di quella che si trovarono a fronteggiare i pensatori
tedeschi tra la fine del Settecento e gl’inizi dell’Ottocento. Nel frattempo, infatti, la
Germania è divenuta un grande Stato (Gross staat) e un’azienda economica gigantesca
(wirtschaftlicher Riesenbetrieb) molto complessa:
Il còmpito di collegare lo spirito metafisico con queste condizioni dell’esistenza dei
grandi Stati modemi è divenuto molto phi difficile di quanto non fosse all’epoca del
pastore e el farmacista di Arminio e Dorotea. In questa situazione anche presso di noi
crebbe quel duro intellettualismo e quella fredda calcolabilità del puro uomo d’affari,
del puro specialista e professionista, quel senso del potere finanziario e industriale e la
spietata concorrenza, che chiamiamo americanismo. [Nota 26]
Página XVIII
Il ‘nuovo’ idealismo — accomunato a quellllo fitchtiano-ottocentesco dalla
consapevolezza che «le idee non germinano dalle teorie e dalle dottrine, bensí dalla
poderosa esperienza vissuta» [Nota 27] — si è impadronito del lavoro politico e
tecnico, di quello sociale e di quello militare, e ha trascinato con sé gli «uomini della
società» (i Gesellschaftsmenschen), i filistei, i dottrinari e i sognatori, tutti inserendoli
in un’attivítà animata da un nuovo spirito comunitario:
Da anni la nostra gioventú aspirava, di contro allo specialismo [Spezialistentum], a
nuove sintesi, aspirava a una nuova vitalità di contro al freddo intellettualismo. Ora
c’era sintesi e vita, creazione e azione; fede e realismo, fantasia e dovere pratico si
ritrovavano. [Nota 28]
Collegato a questo primo, poi, si andava sviluppando un altro sintomo,
particolarmente significativo. La distinzione fra ‘comunità’ e ‘società’ — fra la società
«astrattamente razionalizzata e soggettivizzata» e la «grande comunità unificata per
sangue e istinto, costume e simbolo» — che, secondo l’analisi avviata per primo da
Toennies [Nota 29], caratterizza lo sviluppo moderno del rapporto fra Stato e società,
in Germania ha assunto forme abnormi. Ora, proprio questo iato sembra saldarsi
grazie alla scoperta della possibilità di un nuovo rapporto fra ‘populo’ e Kultur:
È stata questa l’esperienza indimenticabile, spesso descritta, di quel poderoso agosto,
ed è stata questa, allo stesso tempo, la liberazione dalla profonda opposizione [...] fra
il nostro popolo, sano, efficiente, laborioso e le spinte dei cosiddetti intellettuali con
tutti i loro pessimismi, sofismi e snobismi. [Nota 30]
Sembra di assistere — per usare ancora le parole di Ernst Troeltsch — a una
«ritrasformazione del mondo da società in comunità» [Nota 31]. La divaricazione fra il
mondo della Kultur, che offriva una immagine sempre piú sconsolata di sé e un quadro
sempre piú tragico del mondo, e le masse che o, nelle campagne, vivevano nelle vecPágina XIX
chie forme di vita organicamente collegate, oppure, nelle fabbriche, si organizzavano
ton forte fede net futuro, sembrava essere giunta all’apice quando sopraggiunge la
guerra e
insieme con essa la rivelazione di ciò che era comune a tutti. Era, alto stesso tempo,
l’impressione travolgente della silenziosa dedizione al dovere, della disciplina e
dell’efficienza delle masse e il trionfo della prestazione obiettiva. Nel lavoro della
guerra si fondevano tutti: nobili e umili, colti e incolti, e le divisioni ritornavano ad
essere la divisione naturale del lavoro e della prestazione [...] L’immensa importanza
dell’agosto consiste nel fatto che, sotto la pressione del pericolo, ha premuto tutto il
popolo in un’unità interiore quale prima non c’era mai stata. [Nota 32]
Le parole di Troeltsch qui citare — come quelle di Mann ricordate precedentemente —
descrivono in maniera efficace uno stato d’animo estremamente diffuso e sono tanto
piú significative in quanto provengono da intellettuali, che, nell’immediato dopoguerra,
si professeranno in favore della repubblica. La successione degli eventi — e, non da
ultimo, il dibattito sugli obiettivi di guerra — avrebbe ben presto messo in crisi questa
interpretazione delle ‘idee del 1914’, rivelandone tutto il carattere ‘mitico’ [Nota 33].
Già net ’17, del resto, all’interno della comune base di partenza — identificabile,
appunto, in una diffusa interpretazione delle ‘idee del 1914’ — si produce una frattura
fra gli spiriti piú illuminati (i conservatori moderati, poi favorevoli all’esperienza di
Weimar) e l’area piú reazionaria, rappresentata da molti di coloro che sarebbero di lí a
poco confluiti nella Vaterlandspartei. [Nota 34]
Página XX
Ciò su cui va richiamata l’attenzione, tuttavia, è un altro punto. Il fatto, cioè, che la
guerra — l’atteggiamento rispetto ad essa — induce comunque una profonda
trasformazione di tutto il ceto intellettuale: della sua autocoscienza, del modo in cui
esso concepisce il suo ruolo e la sua stessa attività. L’‘interventismo della cultura’ — di
cui la Professorenliteratur rappresenta solo una delle manifestazioni piú vistose — è, in
realtà, il sintomo di un nuovo rapporto fra intellettuali e politica e, in ultima analisi,
della consapevolezza che le vecchie ‘potenze’ (a cominciare dallo Stato) hanno perso la
loro separatezza [Nota 35]. Non è per niente casuale, quindi, che il dibattito sulla
Kriegsideologie si trasformi, in piú d’un caso, in quello sull’origine, la forma e la
funzione dello Stato [Nota 36]. Del resto, perfino gli aspetti piú ‘ideologici’ della
Kriegsideologie, come, per esempio, l’insistenza sulla guerra come elemento che
stimola la fusione fra gli straff sociali piú diversi (l’incontro fra classi dirigenti e popolo,
fra Kultur e masse), finisce con il richiamare l’attenzione su un altro dato attraverso cui
è possibile intravedere una trasformazione reale dello Stato: vale a dire, il nuovo
rapporto che, con la guerra, si viene a stabilire tra masse e Stato. Non casualmente, i
settori piú illuminati dell’intelligenza conservatrice tedesca vengono mano a mano
ridefinendo la propria ‘missione’ attribuendo a sé una funzione precipua di mediazione,
promuovendo — anche attraverso un rapporto non piú semplicemente ostile rispetto
alla socialdemocrazia — l’entrata delle masse nello Stato [Nota 37].
Diviene piú chiaro — se si tiene conto di tutto ciò — il senso del confronto critico,
portato avanti da Adler negli anni della guerra, con la Kriegsideologie e con la
Professorenliteratur, nel senso che esso costituisce non un antecedente generico, bensí
un punto di riferimento specifico della sua riflessione sullo Stato.
Página XXI
Sono significative, in proposito, già le considerazioni con cui, nel 1916, Adler si
difende dai due diversi tipi di critica, che possono essere rivolti contro le sue
considerazioni sulla guerra mondiale. A chi gli rimproveri di far valere una critica
‘sentimentale’ e non marxista della guerra, Adler obietta che la sua è una critica rivolta
non contro i ‘mali della guerra’, bensí contro la guerra in quanto tale. Di
‘sentimentalismo’, semmai, possono essere accusate quelle posizioni che richiedono
una limitazione e una ‘umanizzazione’ della guerra stessa. A tali posizioni, che si
richiamano al diritto internazionale e all’umanità, sfugge completamente il carattere
della guerra moderna:
sia l’affondamento delle navi mercantili nemiche sia l’attacco aereo contro i territori
nemici, questa orrenda estensione della guerra, alla popolazione pacifica, che ci è stata
portata per la prima volta dalla guerra attuale, può essere biasimata in quanto
violazione del diritto internazionale propriamente da coloro che riconoscono per
principio la guerra come strumento del diritto internazionale solo a causa di una
concezione, del tutto retriva e astorica, dell’essenza della guerra moderna. [Nota 38]
Queste posizioni si fondano su una distinzione fra esercito e popolazione pacifica, che è
un residuo dell’epoca assolutistica; «quando la guerra e la politica erano effettivamente
un’occupazione dei governanti». Questa concezione «era possibile in un tempo in cui
non esistevano ancora gli eserciti popolari e non erano ancora degli interessi popolari
— reali o opinati — a determinare la política». Oggi una tale visione delle cose è del
tutto insostenibile:
La guerra ha afferrato l’intero paese e l’intero popolo, essa ricava dal paese intero, da
tutto il suo lavoro e da tutta la sua popolazione la forza di resistenza, che sui fronti
giunge semplicemente alla sua espressione ultima. [Nota 39]
È la presenza non piú passiva delle masse e la loro partecipazione attiva alla lotta
politica a mutare la forma stessa della guerra e a rendere retorica l’esigenza di una
‘umanizzazione’ della guerra e realistica, invece, l’esigenza di una critica della guerra in
quanto tale. Ed è, ancora una volta, il ruolo nuovo che le masse assumono sulla ribalta
della storia mondiale — con la carica di volontà e consapevolezza che esse portano — a
mostrare la deficienza della critica, secondo cui non si può criticare la guerra perché ciò
significherebbe ignorare o misconoscere la sua ‘necessità’ storica. Si
Página XXII
tratta, in questo caso, di un’accusa ‘pseudomarxista’, che ha un doppio difetto. Da una
parte, infatti, ignorando il ruolo della volontà — e di ogni fattore consapevole — nei
processi storici, fa del marxismo una sorta di fatalismo, laddove esso non solo non è
puro accertamento di ciò che è (Inventarisierung), ma si definisce piuttosto come
critica teorica rivolta alla trasformazione (Neugestaltung) [Nota 40]. Ma, d’altra parte,
si fonda su una identificazione fra necessità dello sviluppo capitalistico (con i suoi esiti
imperialistici) e necessità dello sviluppo storíco tout court, che è contestata dalla
presenza — in forma sempre piú consapevole e organizzata — del proletariato stesso.
I ‘fatti’ economici da soli — conclude Adle — non conducono a nessun socialismo senza
quell’altro fatto che è rappresentato dall’ideologia proletaria, cioè da una tendenza
dello spirito e della volontà del proletariato rigorosamente costituita nella sua
opposizione rispetto al mondo borghese. La formazione di questa ideologia è rimasta
molto indietro negli ultimi anni prima della guerra e questo è stato, non da ultimo, uno
dei motivi del crollo dell’Internazionale. Ma essa è stata sopraffatta nella maniera piú
pericolosa dall’ideologia della guerra e dall’ideologia dello Stato ad essa connessa [...]
La critica dell’ideologia della guerra [...] è quindi ben lungi dall’essere pura ideologia.
[Nota 41].
Se si tiene conto di ciò si comprende anche l’insistenza con cui Adler torna a riflettere
— proprio in questi anni — su alcuni momenti alti della cultura filosofica tedesca. La
ricostruzione di una tradizione culturale allo stesso tempo nazionale e ‘democratica’ (o,
addirittura, pre-socialista) si presenta infatti come un’esigenza direttamente teoricopolitice. Il proletariato può far sua l’idea kantiana della «pace perpetua», ad esempio,
proprio perché essa non è una semplice utopia; ma si fonda su una visione reslistica
del processo storico — quella concezione che, prendendo le mosse dalla teoria della
«insocievole socievolezza», fa di Kant un ‘precursore’ di Hegel e di Marx [Nota 42] —
e, per tal via, esso può risolvere la contraddizione, che la guerra rende evidente, fra il
livello di sviluppo raggiunto dall’economia mondiale e la forma politica, del suo
Página XXIII
modo di esistenza: contraddizione irrisolvibile all’interno delle tendenze imperialistische
del capitalismo [Nota 43]. Ma, ancora piú, il proletariato può richiamarsi a Fichte, che,
per primo, ha abbozzato il piano di un’educazione popolare, centrato intorno all’idea
della necessità di superare la separazione fra ‘colti’ e ‘incolti’, finalizzato alla
formazione di «uomini nuovi», che già all’interno della vecchia società si svincolino da
essa per prefigurare la società futura [Nota 44].
L’incontro una ‘filosofia’ e ‘popolo’, peraltro, non deve mai avvenire a discapito della
capacità critica della prima. È questo che, invece, sembra essersi verificato fin
dall’inizio della guerra, quando ha cominciato a prender corpo quella che Adler
definisce una Militarisierung der Philosophie. È nata cosí una Kriegsphilosophie, una
«filosofia di guerra» che ha acquistato certo quanto a ‘popolarità’, ma rinunziando
completamente al suo abito critico [Nota 45].
In particolare, occorre intervenire criticamente contra ogni tentativo di giustificazione
etica della guerra. ‘Vitalismo’, ‘psicologismo’, ‘anarchismo sociale’ ecc. si sono dati la
mano nel costruire una vera e propria «metafisica della guerra» [Nota 46]. Quei germi
di ‘romanticismo’ irrazionalistico, che erano già presenti all’interno dellla costellazione
delle ‘idee del 1914’ [Nota 47], assumono tuttavia una veste particolarmente
pericolosa quando culminano nel tentativo di una giustificazione etica dellla guerra, dal
momento che essa sembra fondarsi su alcuni princípi che derivano direttamente da
una concezione fondamentalmente socialista. Di solito; infatti, la fondazione etica della
guerra termina nella contrapposizione fra la concezione individualistica e utilitaristica
degli avversari della guerPágina XXIV
ra, e lo spirito di sacrificio di cui danno prova i sostenitori della guerra.
In questo modo guerra e collettivismo, da una parte, e, pace e individualismo,
dall’altra, vanno a parare in una notevole affinità interna. In tali circostanze quale altra
scelta rimane al socialismo se non quella di assumere il partito della guerra? [Nota 48]
La formulazione piú paradossale di una tale fondazione etica della guerra è però,
senza dubbio, quella di Max Scheler [Nota 49]. Per Scheler, infatti, il principio
fondamentale dell’etica è l’amore. Ma l’‘amore’ di cui egli parla non è un generico
amore per il prossimo, bensí quello
che è rivolto alla realizzazione di valori superiori nella cerchia dei portatori di tali valori.
Ciò vuol dire: perfetto non è quell’amore che abbraccia la cerchia piú ampia possibile di
uomini, come per esempio la filantropia, bensí quello che — per quanto ristretta sia la
sua cerchia — abbraccia coloro che sono divenuti portatori dei valori piú elevati.
Tali valori, inoltre, non sono un bene uniformemente distribuito, ma sono
nazionalmente differenziati. Per cui la scelta in favore della pace o della guerra non può
essere decisa a priori, bensí solo dopo aver stabilito quale delle due situazioni favorisce
l’affermazione dei valori piú elevati. «L’amore puro non è rivolto al benessere, ma alla
salvezza. Esso non conosce, pertanto, la finzione utilitaristica di una equivalenza di
valore (Gleichwertigkeit) delle comunità umane [...] Esso decide la differenza di valore
attraverso l’azione guerresca e proprio in ciò consiste l’eticità della guerra», che
diviene, in tal modo, una sorta di Gottesgericht, una specie di tribunale divino [Nota
50].
In verità, questa giustificazione e fondazione etica della guerra; tentata da Scheler,
non va a parare in altro che in un cattivo sillogismo, in una sorta di circolo vizioso.
Essa culmina «nella proclamazione della guerra vittoriosa come dimostrazione della
superiorità del valore dell’amore di una comunità, cioè nel piú completo
Página XXV
autosuperamento di ogni valutazione etica per mezzo della fattualità extraetica». Ma
ciò conduce a un evidentissimo circolo vizioso: «è etica soltanto la vittoria della
comunità portatrice di un amore di valore piú elevato; ma è sempre etica quella
comunità, portatrice di amore, che vince» [Nota 51]. Questa filosofia, che è capace di
giustificare ambiguamente qualsiasi misfatto [Nota 52], in realtà non è altro —
conclude Adler — che una forma di malcelato sciovinismo.
Dietro le conclusioni aberranti di Scheler, in realtà — come nota di sfuggita Adler
stesso [Nota 53] — operano problemi piú complessi, in particolare, un serrato
confronto critico, da parte di Scheler, con la filosofia kantiana, che Adler non può certo
condividere. Ciò che in questa critica a Scheler sembra sfuggire ad Adler è l’importanza
centrale del distacco scheleriano dal (neo-)kantismo, in quanto sintomo di una
profonda trasformazione della forma della razionalità, che di lí a poco — non
casualmente — avrebbe facto avvertire le sue istanze all’interno della stessa riflessione
teorico-politica e persino entro il dibattito sulla teoria del diritto e dello Stato [Nota
54]. Attraverso la critica scheleriana del formalismo kantiano passa l’esigenza di un piú
stretto rapporto fra ‘scienza’ e ‘vita’, mediata dall’istanza di una determinazione non
meramente ‘formale’ dell’oggetto della scienza. Parimenti, l’introduzione di una
categoria come quella dell’‘amore’ è anch’essa finalizzata a mettere in discussione quel
parametro eccessivamente lineare di razionalità, che sembra provenire dal kantismo (e
rispetto al quale il neokantismo stesso non ha detto nulla di nuovo), nonché, in ultima
analisi, a rompere la distinzione troppo rigida fra ragion pura e ragion pratica (in
termini neokantiani: fra scienze della natura e scienze della cultura) e, quindi, a
riportare la ‘vita’ (i ‘valori’, le scelte, la politica) all’interno della costituzione stessa
della scientificità.
Si tratta di una serie di problemi con cui Adler stesso si era, almeno in parte, già
confrontato — soprattutto nella sua Auseinandersetzung con Max Weber [Nota 55] — e
su cui, di lí a poco, sarebbe stato costretto a ritornare a riflettere, sia pure attraverso
diverse mediazioni culturali: non Scheler, ma piuttosto Simmel (e una certa lettura di
Hegel), da una parte, e Weber e Schmitt, dall’altra.
Ciò su cui occorre richiamare l’attenzione, per concludere l’esame, qui abbozzato,
della critica adleriana della Professorenliteratur e, in generale, della Kriegsideologie, è
un altro punto. La teoria scheleriana della gerarchia dei valori — della loro non
GleichwerPágina XXVI
tigkeit —, attribuendo implicitamente alla Kultur tedesca una sorta di superiorità
rispetto a quella degli altri popoli — sovente degradata, come si è già accennato, a
semplice Zivilisation —, finiva con il presentare, sia pure in forma particolarmente
raffinata, un topos típico della letteratura tedesca di quegli anni: quello, cioè,
dell’Anderssein (delta ‘diversità’) del popolo tedesco.
Mai come in questo caso — osserva Adler — si è fatto di necessità virtú. E, in
particolare, da quando si è acquisita consapevolezza di questa ‘diversità’ (Anderssein)
per mezzo della critica politica dei contemporanei, non sono mai mancati difensori che,
orgogliosamente, si sono professati in favore di questa distinzione (Unterschiedenheit)
del popolo tedesco, facendone non solo un tratto del carattere nazionale, ma
addirittura un vantaggio etico dei tedeschi rispetto a tutti gli altri popoli. [Nota 56]
Persino intellettuali come Troeltsch — cui peraltro, osserva Adler, va il merito di aver
portato avanti una critica efficace dell’imperialismo [Nota 57] — non hanno saputo
sottrarsi alla tentazione costituita da questo luogo comune della Kriegsideologie
quando si è voluto caratterizzare l’idea ‘tedesca’ di líbertà in contrapposizione a quella
delle potenze occidentali, sostenendo che essa «consiste piú in doveri che in diritti; o
tuttavia in diritti che sono allo stesso tempo doveri [...] La libertà non è uguaglianza,
bensí servizio del singolo, al suo posto, nella posizione di organo (Organstellung) che
gli spetta» [Nota 58]. Definizione, questa, in sé e per sé corrispondente al vero, solo
che da questa concezione, nota Adler, «deriva poi quella teoria; divenuta quasi una
professione di fede ufficiale, secondo cui la mancanza di democrazia, nel popolo
tedesco, è solo apparente, e i giudizi dell’estero — e cosí pure quelli dei pochi critici
interni — deriverebbero solo dall’incapacità di valutare il ruolo che dovere e
responsabilità giocano nel carattere del popolo tedesco» [Nota 59].
Non può, pertanto, non essere accolto con tanto maggior favore il primo serio
tentativo di andare a fondo, attraverso una meditata analisi storico-política, nel
discutere il probIema della ‘diversità’ tedesca: è questo uno dei meriti principali di
un’opera pubPágina XXVII
blicata nel 1915 da Hugo Preuss [Nota 60], e subito recensita e lungamente discussa
da Max Adler su «Der Kampf» [Nota 61].
Il problema da cui Preuss prende le mosse è appunto quello relativo al perché
dell’ostilità con cui non solo le nazioni nemiche, ma anche quelle neutrali guardano alla
Germania. Una prima risposta — la piú ovvia — è quella che rinvia alla campagna di
menzogne scatenata dai nemici per screditare la Germania. Ma tale risposta spiega ben
poco: come mai una tale campagna ha potuto prender piede nonostante i rapporti
pluriennali della Germania con le altre nazioni, rappord che avrebbero dovuto
contribuire a formare già da prima una sua diversa immagine? Né si può attribuire
l’odio antitedesco all’improvviso e rapido sviluppo economico di questo paese: anché
l’Inghilterra ha accresciuto enormemente la sua potenza, ma ciò — anche se non le ha
procurato amore — ha indotto piuttosto le altre nazioni ad allearsi ad essa.
Una risposta piú convincente comincia ad affacciarsi quando si guardi il problema con
gli occhi con cui lo guarda il mondo extra tedesco. Balza allora in primo piano il
problema del militarismo prussiano e del ruolo da esso avuto nella storia moderna della
Germania.
Ciò che per noi è il compimento del sogno dell’unità tedesca grazie all’istituzione del
Reich — osserva Preuss — per i francesi e per tutti i paesi esteri che simpatizzano con
essi significa la sottomissione sotto il militarismo prussiano attraverso la politica
bismarckiana del ferro e del fuoco. [Nota 62]
In realtà, ciò che qui viene in questione è appunto la politica bismarckiana e il peso
che, nel determinarla, ha avuto l’avversione rispetto allo sviluppo democratico
dell’occidente. Lo stesso militarismo prussiano, dunque, viene in questione non tanto in
sé e per sé, ma piuttosto come sintomo di una determinata struttura della política
interna della Germania. È qui che ritorna il problema della Andersartigkeit, della
‘diversità’ tedesca [Nota 63] ed è qui che Preuss mostra, con una «splendida analisi»
[Nota 64], come l’Anderssein dei tedeschi — cioè, la permanenza dello Stato
autoritario (Obrigkeitsstaat)
Página XXVIII
e di una struttura politica fortemente antidemocratica — abbia pesato e pesi tuttora
nell’aggravare l’isolamento internazionale della Germania.
Mentre in Inghilterra e in Francia si andavano costituendo le istituzioni della vita
statale «grazie alle quali le guide politiche popolari potevano emergere», in Germania
non si verificava nulla del genere. «Il nucleo della forma statale moderna è la sua
opposizione rispetto al governo autoritario». Ora, mentre in Occidente si è assistito al
superamento di questa opposizione, in Germania la forma statale moderna è stata
assunta senza che questo significasse la contemporanea rimozione dello
Obrigkeitsstaat:
La Prussia-Germania appare, proprio a causa della sua posizione cosí preminente sia
dal punto di vista economico che culturale, come la vera e propria portatrice di quel
principio politico ‘conservatore’ che sta in forte opposizione rispetto a tutte le
organizzazioni statali che o non hanno conosciuto, oppure hanno superato il dualismo
fra governo autoritario e forma statale moderna. [Nota 65]
A ben guardare, lo sviluppo delle forme politiche tedesche ha esercitato un’influenza
sull’organizzazione politica delle altre nazioni solo in tre àmbiti: nel campo del servizio
militare obbligatorio, in quello dell’assistenza sociale e; infine, nell’autoamministrazione cittadina. Ma neanche questi contributi delle forme politiche tedesche
alla modernizzazione sono riusciti a superare il dualismo fra Obrigkeitsstaat e forma
statale moderna, né a saldare il rapporto fra classe operaia e Stato. Tanto meno, poi,
ad, eliminare quella ‘diversità’ della Germania, che la isola dagli altri popoli, e che ha il
suo fondamento — non da ultimo — nella ‘organizzazione’, o forse sarebbe piú esatto
dire nella ‘organizzabilità’, che è tipica dei tedeschi:
Qualcosa di completamente diverso da tale organizzabilità è però la capacità di
autoorganizzazione, che presuppone una volontà comune fortemente sviluppata, una
consapevolezza esplicita di costituire da sé lo Stato, di procurarsi da sé la libertà e non
di riceverla semplicemente da esso. [Nota 66]
Si tratta, dunque, di promuovere ovunque lo sviluppo di tale capacità di
autoorganizzazione, poiché solo per tale via è possibile superare la ‘diversità’ tedesca,
spingendo — artraverso la conversione dello Stato autoritario in uno ‘Stato popolare’
(Volksstaat) — lá Germania sulla stessa strada percorsa dalle nazioni che si sono date
una forma statale moderna.
Página XXIX
È quindi effettivamente necessario [...] che anche il popolo tedesco venga alla fine
afferrato dalla tendenza del processo di sviluppo politico moderno, che è rivolta
all’istituzione dell’identità fra popolo e Stato. [Nota 67]
Occorre, cioè, — come sostiene lo stesso Preuss — che il popolo «si sappia unito con il
suo Stato e con la sua costituzione, poiché lo Stato non è altro che il popolo
organizzato grazie alla costituzione». Deve pertanto venir meno la vecchia concezione,
secondo cui il governo sarebbe il rappresentante dello ‘Stato’, in opposizione al
Parlamento in quanto rappresentante del ‘popolo’; come pure deve venir meno la
visione secondo cui i partiti d’opposizione sarebbero «ostili al Reich». Si tratta di un
processo che non può realizzarsi altrimenti che attraverso «la piú completa
politicizzazione del popolo» [Nota 68]. Anche per questa via, dunque, ritorna la
centralità del problema dell’autoorganizzazione [Nota 69].
Proprio qui — proprio, cioè, quando raggiunge il punto saliente — s’intravede però, in
pari tempo, secondo Adler, il limite dell’analisi di Preuss. Questi, infatti, «non sa o non
vuol dire nulla circa le forze che devono realizzare quest’opera di trasformazione», cioè
di politicizzazione del popolo tedesco e di sua autoorganizzazione.
Nella sua ricerca — osserva Adler — Preuss ha completamente tralasciato il rapporto
fra governo autoritario e divisione in classi e fra esso e il modo in cui le opposizioni di
classe si sono tradotte in forme di dominio e di sottomissione politici [Nota 70]
Proprio per questo essa corre due rischi. Da una parte, quello «di identilicare
completamente lo Stato con un’organizzazione di potere, che non rappresenta interessi
di classe [...] Ma, d’altra parte, essa sembra porre come fine, dello sviluppo della
politica interna, da perseguire, una volontà politica comune, che — posta tale
indipendenza dalle opposizioni reali di classe — significherebbe una trasformazione
radicale della struttura politica, se però questa volontà politica comune non fosse resa
impossibile appunto da tale divisione in classi» [Nota 71]. L’ultima parola di Preuss,
pertanto, sembra
Página XXX
piuttosto un’«esortazione etica» anziché una proposta politice. Anche perché
nell’analisi di Preuss, cosí acuta riel tratteggiare lo sviluppo delle forme politiche,
manca ogni accenno al «sottofondo» che le sostiene: cioè a quell’intreccio
anacronistico fra interessi di classe dei vecchi Junker e degli agrari e interessi
dell’industria pesante, che è finalizzato al mantenimento della subalternità delle masse
del proletariato. Eppure, proprio e solo da qui, dal proletariato, viene l’unico esempio di
capacità di autoorganizzazione:
Se, pertanto, è giusto che solo l’autoorganizzazione è il mezzo grazie al quale il popolo
tedesco può formarsi un futuro, che possa effettivamente essere chiamato suo, allora
la lotta di classe proletaria deve diventare — ancora piú di quanto lo sia stato finora —
l’unica àncora di speranza di ogni futura configurazione politica. [Nota 72]
3. Contro lo statalismo: una polemica con Renner
Il confronto con l’opera di Preuss consente ad Adler di accostarsi direttamente al
problema dello Stato. Tale problema, peraltro, era già presente — in maniera piú o
meno esplicita — nel dibattito intrapreso da Adler con alcune delle opere piú
emblematiche della Kriegsliteratur: non solo gli scritti di Sombart e Scheler — o, in
forma piú articolata, quelli di Troeltsch [Nota 73] — ma anche le opere, diffusissime, di
R. Kjellén, J. Plenge; J. J. Ruedorffer, K. Lamprecht ecc. [Nota 74] L’insistenza su
alcuni temi — come, per esempio, la capacità della guerra di promuovere una fusione
fra i diversi ceti sociali — è, all’interno di questa letteratura, di per sé significativa.
Essa implica non solo la messa in discussione dell’assioma marxista ‘classico’ circa la
divisione della società in classi, ma, al di lá di ciò, introduce a una riflessione piú
complessiva sulle forme politiche, sulle istituzioni, sullo Stato. Si fa sempre piú strada,
in tal modo, la convinzione secondo cui la guerra ha fatto «piazza pulita delle
concezioni democratiche, o liberali o meramente contrattualistiche, per non dire
socialistiche, della
Página XXXI
genesi e della funzione dello Stato», convinzione accompagnata dall’altra, parallela,
secondo cui dalla guerra sarebbe necessariamente venuto fuori «uno Stato diverso,
autoritario e al tempo stesso coinvolgente le masse» [Nota 75]. Non casualmente,
proprio da questo contesto sarebbe nata una vasta letteratura, che avrebbe investito
direttamente i temi della democrazia, del parlamentarismo, della forma dello Stato in
generale: da Weber a Schumpeter e Spengler, da Kelsen a Schmitt e Kirchheimer
[Nota 76].
La guerra e le sue implicazioni segnano, peraltro, un momento di svolta non solo
all’esterno, ma anche all’interno della classe operaia: del resto, non casualmente, già il
primo scritto adleriano degli anni di guerra, Prinzip oder Romantik!, muoveva
dall’esigenza di combattere — come già si è visto — quella sorta di ‘romanticismo’,
che, nato dalla cultura ‘borghese’, si andava affermando anche entro le file del
movimento operaio.
Ciò che a questo punto diviene chiaro è il fatto che quella che appariva
semplicemente una Romantik piú o meno ‘irrazionalistica’ può in realtà tradursi in una
ben determinata concezione dello Stato, del rapporto fra classe operaia e Stato,
nonché in una non meno determinata concezione ‘statalistica’ della transizione al
socialismo.
Assume quindi un particolare rilievo l’aspra polemica, che, nel 1916, vede
contrapposti Max Adler e Karl Renner, proprio in relazione al problema dello Stato.
Intervenendo su «Der Kampf» per rispondere polemicamente a un precedente articulo
di Rudolf Hilferding (intitolato Konflikt in der deutschen Sozialdemokratie), apparso
sulla stessa rivista, Renner affronta il tema della «crisi del socialismo» introducendo
un’analisi del rapporto fra classe operaia e Stato per la quale, di lí a poco [Nota 77], si
sarebbe meritato l’etichetta (non del tutto immotivata, per la verità) di autorevole
rappresentante del Kriegsmarxismus [Nota 78].
Richiamandosi all’autorità di Otto Bauer, per garantirsi il diritto
Página XXXII
di autodefinirsi marxista [Nota 79], Renner risponde alle critiche che Hilferding aveva
mosso alla Direzione del partito in relazione all’atteggiamento assunto con la politica
del 4 agosto (il voto a favore dei crediti di guerra). Il voto favorevole dei
socialdemocratici — obbietta Renner — non significa affatto un’approvazfone della
guerra, ma la semplice constatazione del fatto che la guerra c’è e che l’unico
atteggiamento realistico, di fronte a ciò, è quello della difesa del paese. «Noi non
abbandoniamo la nostra patria nell’ora del pericolo!», scrive Renner, ripetendo la
formula con cui la Direzione del partito aveva giustificato la scelta del 4 agosto.
Certo, prosegue Renner, alla destra del partito c’è stato anche chi — «per lo piú
intellettuali» [Nota 80] — ha tentato di speculare. Ma questo non si può certo dire di
uomini come Ebert, Scheidemann e Müller, che «neanche per un istante hanno avuto
intenzione di sacrificare l’autonomia della politica proletaria, la lotta di classe e l’idea
intemazionalista». Il voto in Parlamento, in realtà, non faceva che prendere atto di un
atteggiamento estremamente diffuso:
Dappertutto, in tutti i singoli Stati, in tutte le città e in tutti i villaggi, in tutti i Consigli
e in tutti gli enti, nelle strade e nelle cese, i compagni si precipitavano spontaneamente
a prestare aiuto.
È questo, anzi, il motivo fondamentale su cui Renner insiste nel difendere la politica del
4 agosto: la critica di Hilferding è poco obbiettiva perché egli — «del tutto
diversamente da Fritz Adler, che giudica ugualmente tutti i socialdemocratici di tutti i
paesi belligeranti» [Nota 81] — passa sotto silenzio il fatto che tutto il proletariato
europeo ha assunto, allo scoppio della guerra, il medesimo atteggiamento. Anzi,
Hilferding non solo evita d’indagare «il fondamento economico» di un fenomeno cosí
generale (l’adesione della classe operaia alla guerra), ma tace anche circa il tentativo
operato dalla socialdemocrazia tedesca di concordare un attegggiamento comune con
le altre socialdemocrazie europee [Nota 82].
Página XXXIII
È a questo punto che Renner inserisce le considerazioni piú interessanti del suo
intervento. Mettendo da parte la discussione di carattere storico-politico, finalizzata alla
difesa dell’operato della socialdemocrazia nei confronti della guerra, Renner passa
infatti a dedurre; da questa esperienza, alcuni princìpi generali, di ordine strategico,
che investono direttamente il rapporto fra teoria e movimento.
Il fatto che il proletariato abbia preso dappertutto posizione a favore dei rispettivi
governi «sfida tutto il pensiero tradizionale dei socialisti e giustamente tormenta la loro
coscienza» [Nota 83]. Di fronte a questo dato di fatto, a nulla vale l’attéggiamento di
Hilferding, che sembra voler intentare un processo per tradimento «della ‘ideologia’
tramandata» [Nota 84]. Piuttosto, per i marxisti si pongono due problemi: 1. capire
per quale motivo le masse, senza ecceziòne, si sono schierate a favore dei rispettivi
paesi; 2. domandarsi che cosa resti, a questo punto, della solidarietà internazionale. A
tali questioni non è possibile rispondere — osserva Renner, introducendo
argomentazioni che mostrano una forte affinità rispetto a quelle che, di lí a qualche
anno, Hans Kelsen avrebbe fatto valere contro Max Adler e Otto Bauer [Nota 85] — se
non si tiene conto di un dato di fatto fondamentale:
Innanzi tutto sono da molto passati i tempi in cui il proletariato, al di fuoro delle classi
della società civile-borghese, era una minoranza inessenziale dello Stato [...] il
proletariato è divenuto la classe piú numerosa di ogni comunità e, sotto piú d’un
profilo, addirittura il suo portatore [...] Quanto piú il proletariato progredisce, tanto piú
s’identifica con la comunità in cui vive. Ogni pericolo, che minaccia la comunità, tanto
piú minaccia anche le classi lavoratrici e propio esse per lo piú. [...] Con la progressiva
industrializzazione, dobbiamo sempre piú tener conto del fatto che il destino del
proletariato di un paese coincide con la sorte dello Stato. Già oggi i proletari
avvertono: noi siamo il popolo, noi siamo lo Stato! Sorge perciò per la teoria socialista
il dovere rigoroso di distinguere in maniera piú precisa lo Stato in quanto insieme del
popolo organizzato (organisierte Volksgesamtheit) dallo Stato in quanto istituzone di
dominio (Herrschaftseinrichtung). [Nota 86]
Il fatto che, durante la guerra, proprio là dove il proletariato si presentava come classe
piú estesa e piú importante del paese (come in Inghilterra e in Francia) i suoi
rappresentanti tanto piú si sono avvicinati al governo dello Stato, dà molto da pensare:
ciò spinge
Página XXXIV
a ritenere, infatti, che non la lontananza, bensí la vicinanza allo Stato sia sintomo della
maturità della classe [Nota 87].
Il primo punto, su cui Max Adler richiama l’attenzione, nella sua replica [Nota 88],
riguarda directamente l’opportunità di abolire semplicemente la ueberlieferte Ideologie,
quell’ideologia tradizionale, che, in fondo, non è altro che quell’ideologia del marxismo,
«che, naturalmente, doveva avere il còmpito di distruggere l’ideologia borghese, ma
non di lasciare il proletariato senza ideologia. Perché un’azione storica senza ideologia
è impossibile, visto che è sempre lo spirito dell’uomo quello in cui devono tradursi le
sue condizioni di vita e di sviluppo economiche per pervenire all’azione storica» [Nota
89]. Il problema non è di pura e semplice ‘ortodossia’, dato che non si tratta di
‘professarsi’ in favore di Marx («sich zu Marx zu bekennen»), bensí «di pensare
attraverso di lui» («durch ihn zu denken»). Esso riguarda, piuttosto, un nodo centrale,
che, non casualmente, era emerso con forza negli anni della Bernstein-Debatte: quello
del rapporto fra teoria e movimento e, piú in generale, quello relativo alla possibilità di
pensare — e, eventualmente, al modo in cui pensare — un concetto di «storia come
scienza» e di «politica fondata sulla scienza» [Nota 90].
Se il socialismo moderno non deve perdere la sua essenza marxista, per cui esso è
semplicemente conoscenza sociale tradotta in azione politica, allora solo l’unità teorica
(theoretische Einheitlichkeit) può fondare e mantenere l’unità (Einigkeit) della sua
azione. [Nota 91]
Certo, il modo in cui qui Adler imposta il problema del rapporto fra ‘teoria’ e
‘movimento’ può apparire eccessivamente riduttivo: quasi che fra la prima e il secondo
si debba stabilire non un rapporto di tensione dialettica, bensí di carattere riflessivo e
speculare, per cui le reciproche valenze si salderebbero esaustivamente. Occorre
dunque tener conto — nel valutare questa impostazione adleriana — sia del
fondamento teorico su cui si basa, sia del fine cui è rivolta.
Per quanto riguarda il primo punto, non può esser passato sotto silenzio il fatto che
Adler rivendica l’unità teórica come fondamento dell’unità d’azione politica dopo il
serrato confronto — da
Página XXXV
Causalità e teleologia fino a Marxistische Probleme [Nota 92] — da una parte con il
neokantismo e con il revisionismo e, dall’altra, con gli sviluppi contemporanei della
scienza sociale da Sombart a Weber. La distinzione neokantiana fra lo statuto
epistemologico delle Geisteswissenschaften e quello delle Naturwissenschaften
costituisce secondo Adler — implicitamente o esplicitamente — il sostrato e l’impianto
teorico su cui il revisionismo bernsteiniano — e, piú in generale, il socialismo
neokantiano — hanno negato la possibilità di una «politica fondata sulla scienza» [Nota
93]. Il problema di Adler, dunqué, è quello di vedere come sia possibile — e che cosa
significhi — mantenere aperta la possibilità di una ‘politica come scienza’ dopo la ‘crisi’
non solo delle grandi sintesi hegeliane, ma dopo l’ulteriore dissoluzione delle sintesi
positivistiche [Nota 94]: questo e non altro significa la presa di posizione critica di
Adler rispetto a quelle forme di marxismo ‘ortodosso’ — da Plechanov allo stesso
Kautsky — che, attraverso la riproposizione di una concezione del marxismo come
Weltanschauung (in cui il rapporta di esso con lo sviluppo delle scienze moderne
appare del tutto chiuso), esibiscono chiaramente la loro subalternità al ‘naturalismo’
positivistico. Niente di piú significativo, in proposito, del resto, della critica adleriana
del concerto di materialismo [Nota 95]. Critica che, in quanto aspetto specifico di
quella piú generale rivolta contro il naturalismo, continua ad operare — come dato
definitivamente acquisito e di cui si tratta, semmai, di approfondire la portata — anche
negli scritti del periodo di cui ci si sta occupando. Come dimostra, tra l’altro,
l’utilizzazione in positivo, da parte di Adler, della critica condotta da Kelsen contro ogni
forma di ‘antropomorfismo’ (o sostanzialismo) nella concezione dello Stato. A coloro
che deduPágina XXXVI
cono la necessità del conffitto fra gli Stati da una teoria del potere applicata all’idea di
Stato, infatti, Adler obbietta — citando Kelsen [Nota 96] — che «lo Stato in quanto
concetto giuridico non fa affatto parte del mondo, del potere e delle vittorie, della lotta
e del dominio, cioè non fa affatto parte del mondo degli eventi storici , bensí del
mondo delle norme e delle idee» [Nota 97].
Se si tiene presente tutto ciò, si può cominciare ad intendere che l’istanza adleriana
di una compenetrazione fra unità teorica e unità politica non è il prodotto di una
esigenza (piú o meno positivistica) di ‘riduzione a sistema’, per altro verso tipica della
vulgata tanto della Seconda quanto della Terza Internazionale [Nota 98]. Muovendo
dalla crisi del concetto di ‘scientificità’ che costituisce il sostrato logico-epistemologico
di una visione del marxismo come Weltanschauung, Adler è portato piuttosto a porre
— perlomeno tendenzialmente — l’istanza di un concetto di ‘scienza’ che, proprio per
aver fatto i conti fino in fondo con il naturalismo — e nulla è piú significativo, in
proposito, della segnalazione della permanenza di un limite naturalistico, nonostante
tutto, non solo in Mach, ma nello stesso weberismo —, superi la scissione weberiana
fra ‘conoscenza dei mezzi’ e ‘conoscenza dei fini’, riconducendo i valori (le ‘scelte’)
all’interno della costituzione delle scienze stesse.
Mettendo momentaneamente da parte l’approfondimento di questo punto, val la pena
di ritornare alla discussione con Renner per seguirne alcuni sviluppi e tentare di
cogliere — attraverso i suoi esiti — il senso dell’insistenza adleriana sulla simmetria fra
unità teorica e unità politica.
Cosa significa, dunque, in tale contesto, il richiamo alla «‘ideologia’ tramandata»
come fondamento di una prassi unitaria? In riferimento al problema in discussione —
cioè, il problema dello Stato — l’ideologia del marxismo insiste sul concetto di Stato di
classe: «Tuttavia, questo concetto ha sempre avuto il significato per cui il proletariato
sta di fronte allo Stato in maniera interiormente distinta (innerlich geschieden), per
quanto, ovviamente, sia ad esso legato con tutti i suoi interessi di vita immediati»
[Nota 99]. La consapevolezza di questo senso di ‘distinzione’ — aggiunge Adler
Página XXXVII
— è ció che propriamente si indica con il concetto di coscienza di classe
(Klassenbewusstsein). Quest’ultimo concetto ha una funzione complessa. Esso è
legato, innanzi tutto, al carattere non economicistico del marxismo, per il quale i
concetti economici sono concetti sociologici e, quindi, «contengono sempre tutta la
società e la sua ideologia». Ció significa che «il concetto di classe, anche ove venga
colto ‘semplicemente’ da un punto di vista economico, esclude il momento politico
altrettanto poco di quanto esclude quello morale e quello ideologico in generale» [Nota
100]. Questa dimensione complessiva — e non semplicemente economica — del
concetto di classe è assicurata, specificamente, dalla coscienza di classe. È solo grazie
a quest’ultima, d’altra parte, che «la classe penetra nel processo sociale». Il marxismo
non è scienza naturale: esso, pertanto, non può limitarsi al puro rilevamento del ‘dato’
— alla semplice Inventarisierung — ma è previsione di tendenze e, ad un tempo,
intervento per la realizzazione delle medesime. La previsione; cioè, non ha carattere
meramente contemplativo, ma è momento interno determinante della realizzazione di
una tendenza di contro ad altre. L’ideologia ‘tradizionale’, allora, serve, da una parte,
in generale, per preservare e garantire la prassi del movimento operaio dal puro e
semplice tatticismo; ma, piú in particolare, serve a orientare — attraverso la
costituzione della coscienza di classe e di quel senso di ‘distinzione’ che ad essa si
collega — il rapporto con le istituzioni e, innanzi tutto, con lo Stato. «L’interesse che
riunisce dappertutto il proletariato allo Stato nella sua forma attuale», scrive in tal
senso Adler, «non è un interesse per lo Stato [am Staat], ma nello Stato [im Staat]».
Questo significa che, pur operando all’interno dello Stato al fine di acquistare maggior
peso ed influenza, le aspirazioni del proletariato non si esauriscono in una serie di
rivendicazioni, sia pur importanti, ma pur sempre di carattere corporativo. L’interesse
del proletariato, infatti, è «storico-evolutivo», guarda cioè agli sviluppi futuri possibili,
«e questo sviluppo accenna al di là dello Stato stotico» [Nota 101]. La coscienza di
classe — qual senso di ‘distinzione’ che è garantito dall’ideologia tramandata —
consente d’imprimere anhe nelle idee di ‘patria’, ‘bene dello Stato’, ‘patriottismo’; «il
senso proletario del futuro» [Nota 102]. Solo in tal modo il proletariato può
«preservarsi dal considerare la sua necessaria convivenza
Página XXXVIII
con i dominanti [...] come una solidarietà o addirittura come un dovere» [Nota 103].
L’insistenza sul tema della coscienza di classe, nonché sul fatto che il proletariato, par
agendo all’interno dello Stato, non è interessato allo Stato in quanto tale — né, tanto
meno, allo Stato storicamente esistente — perché esso guarda alle tendenze di cui il
presente è gravido, consente di ricavare alcune conclusioni sia in ordine al problema
(precedentemente posto) del concetto di ‘scienza’ con cui opera Adler, sia, piú
specificamente, in ordine al problema del concetto di ‘Stato’ che proprio nel confronto
con Renner comincia ad emergere.
Com’è possibile — si potrebbe riassumere cosí il problema di Adler —, fermo restando
il carattere ‘oggettivo’ e ‘avalutativo’ della scienza [Nota 104], evitare l’esito che ne ha
ricavato Max Weber, cioè la divaricazione fra scienza e politica? È qui, appunto, che
torna ad avere un ruolo importante il concetto di coscienza di classe. Esso, infatti,
contenendo in sé «il concetto di valutazione etica» [Nota 105], può consentire
d’immaginare un concetto di scientificità, in cui ‘conoscenza’ e ‘valutazione’ non siano
piú sconnesse, ma in cui piuttosto la valutazione sia ricondotta all’interno del piano
della conoscenza. La coscienza di classe, in tal caso, significa allo stesso tempo una
capacità di previsione e di anticipazione, che, però, — come si è precisato poc’anzi —
non hanno affatto il carattere di una gelida costruzione aprioristica da filosofia della
storia, ma significano piuttosto — se le continue riflessioni di Adler, volte a dimostrare
la possibilità e il significato di una causalità mediata dalla coscienza, devono avere un
senso — che la ‘valutazione’ non è un elemento esterno rispetto al processo di cui si
prevedono le linee di sviluppo.
Se, dunque, per il marxismo si tratta di mostrare come un determinato fine debba
nascere ‘in maniera naturalisticamente necessaria’ nella storia, in ciò è sempre incluso,
come fattore causale, l’uomo che valuta, e che ritiene anche giusto questo fine. [Nota
106]
Ben lungi dall’essere una pura astrazione, dunque, la ‘previsione’ è la mediazione
attraverso la quale Adler tenta — sia pur restando fedele all’esigenza di oggettività e di
avalutatività, che per il marxismo sono essenziali se esso, dev’essere in grado di
misurarsi da pari a pari con gli sviluppi delle scienze sociali esterne al
Página XXXIX
movimento operaio [Nota 107] — di ricondurre (al di là del neokantismo) la ‘vita’
all’interno della costituzione della scientificità.
Che tale tentativo dovesse apparire a Kelsen — in questo ancora fortemente legato
(almeno negli anni Venti) a un parametro di scientificità tipicamente neokantiano —
una sorta di «sincretismo metodologico» [Nota 108], è fin troppo ovvio. Sta di fatto,
d’altra parte, che è proprio tale sincretismo metodologico a consentire ad Adler
un’utilizzazione (altrimenti inconcepibile) di quelle teorie dello Stato e del diritto, che —
nate all’interno del movimento operaio, ma in forte contrapposizione al neokantismo —
ponendo l’esigenza di una maggiore ‘concretezza’ del diritto, avviano ad una piú fertile
comprensione di alcune trasformazioni dello Stato tedesco (e non solo tedesco), fra gli
anni Venti e gli anni Trenta, trasformazioni assai difficilmente pensabili attraverso la
forma di razionalità sottesa dalle ‘distinzioni’ neokantiano-kelseniane [Nota 109].
Ma, se si tiene conto di ciò, si comprende meglio anche la critica che Adler rivolge alla
distinzione, proposta da Renner, fra lo Stato in quanto comunità organizzata del popolo
e lo Stato come organizzazione di dominio. Tale contrapposizione, infatti, «può avere
soltanto il senso di una contrapposizione fra idea e effettualità; per dirlo nel linguaggio
giuridico: lo Stato de lege ferenda contro lo Stato de lege data. Cioè, lo Stato in quanto
comunità organizzata del popolo designa un còmpito» [Nota 110]. Ma proprio se le
cose stanno cosí — proprio, cioè, se lo Stato in quanto comunità organizzata del popolo
è un còmpito — tanto piú è necessario il mantenimento della ‘coscienza di classe’ e del
senso di ‘distinzione’ (la innere Geschiedenheit) del proletariato. Altrimenti, il
contrabbandare lo Stato attuale per la comunità organizzata del popolo significa, a dir
poco, semplicemente un amore sviscerato e ‘feticistico’ per lo Stato in quanto tale, e
un’incapacità di fondo di condurre un’analisi sociologica — cioè, un’analisi storica
differenziata, in cui pervengono a fusione analisi politica e analisi sociale — dello Stato.
È possibile dire che lo Stato attuale è una comunità organizzata del popolo, infatti, solo
a patto di condurre un’analisi dello Stato del tutto ‘astratta’, formalistica, cioè, — nel
senso adleriano — ‘giuridica’. In tal caso — quando, cioè, l’analisi dello Stato prescinde
completamente dal suo contenuto di
Página XL
classe — si ripresenta il rischio, che Adler ha già denunziato nell’analisi di Hugo Preuss:
quello, cioè, di concepire lo Stato semplicemente come una «organizzazione di
potere». In apparenza, nulla sembra piú lontano dal concetto di Stato come,
«organizzazione di potere» che il concetto di Stato come «comunità organizzata del
popolo». E nessuno, piú di Kelsen, ha messo in risalto il carattere ideologico dell’idea di
Stato come ‘comunità’, come Gemeinwesen (salvo poi a ripresentarla in forma
sublimata). Di fatto, comune all’una e all’altra concezione è una visione
‘strumentalistica’ dello Stato. Certo, il concepire lo Srato come «organizzazione di
potere» appare molto piú realistico, mentre il definirlo come «comunità organizzata del
popolo» sembra molto piú ideologico. Tanto la prima quanto la seconda definizione,
però, —tralasciando tutte le possibili distinzioni — si fondano su una analoga
sconnessione fra analisi política e analisi sociale. In tal senso, appunto, si può parlare
di una visione strumentalistica dello Stato: lo Stato come «mezzo di tecnica sociale» —
ovvero come «machina» per usare definizione di Schumpeter [Nota 111] —
diversamente fungibile a seconda del soggetto che lo usa. Non casualmente, del resto,
è lo stesso Renner, a poter passare, senza gravi difficoltà, dal concetto di Stato come
«comunità organizzata del popolo» a quello dello Stato come «leva del socialismo»
[Nota 112].
Appare, dunque, in Rermer — non diversamente che in Kelsen — una forma di
autonomizzazione del politico, che, secondo Adler, è quanto di piú lontano ci si possa
immaginare dal marxismo come sociologia [Nota 113]: cioè, come teoria delle forme di
sviluppo della società, nella cui analisi critica non è possibile tenere distinti i diversi
livelli. Né vi sono dubbi, per Adler, che tale forma di ‘autonomizzazione’ del politico
vada a parare in una sorta di statalismo, se è vero che, di lí a poco, egli potrà parlare
con ironia dei «neomistici dello Stato à la Karl Renner» [Nota 114].
Página XLI
4. Significato e limiti della rivoluzione d’Ottobre
Certo, nel momento in cui Adler si esprime in questi termini nei confronti di Renner —
nel saggio Die sozialistische Idee der Befreiung bei Karl Marx (scritto per il centenario
della nascita di Marx, ricorrente il 5 maggio 1918) — sono avvenuti alcuni fatti di
estremo rilievo, sia all’interno della socialdemocrazia austriaca, sia all’interno di quella
tedesca. Nella prima si è andato realizzando un processo di progressiva
radicalizzazione, anche in forme laceranti, come mostra in maniera significativa lo
stesso gesto di Fritz Adler del 21 ottobre 1916 [Nota 115]. È quest’ultimo, nella sua
Autodifesa, a scagliare contro, Renner — «per il quale principio supremo è lo Stato
austriaco» [Nota 116] — l’accusa piú infamante quando lo definisce il Lueger della
socialdemocrazia austriaca [Nota 117].
Già nel luglio 1916 — riprendendo il tema di una conferenza tenuta al circolo culturale
«Karl Marx» [Nota 118] il 23 giugno — Fritz Adler aveva accostato le idee di Renner a
quelle che erano sostenute dai propugnatori delle «idee del 1914» e, in particolare, dal
teorico del socialismo nazionale (e prussiano) Johann Plenge. Comune a questi e a
Renner [Nota 119], in particolare, è un concetto di ‘organizzazione’, che mostra quanto
poco fosse salda l’idea di democrazia in alcuni socialdemocratici.
Renner ha oggi la stessa posizione sostenuta un tempo da Eduard Bernstein. Ma oggi
Bernstein sta nella ‘minoranza’, poiché — prescindendo completamente da tutte le
teorie socialiste — egli è stato sempre un leale democratico. Renner è stato, nel
revisionismo, piú radícale,
Página XLII
lo ha esteso anche all’ideale democratico, egli è — in senso pieno — un puro
precorritore delle idee del 1914. [Nota 120]
Ma il problema della ‘democrazia’ e ‘libertà’ — in contrapposizione all’affermarsi di
vedute statalistíche o, comunque, ‘centralistiche’ — riceve un ulteriore stimolo dai
contemporanei sviluppi della situazione tedesca e dall’atteggiamento della stessa
socialdemocrazia tedesca. Non casualmente, nel luglio del 1917, Max Adler pubblica,
su questi temi, un articolo che — secondo quanto si legge in una lettera a Kautsky
quasi contemporanea — è «completamente attraversato da una chiara sfiducia circa la
serietà della Majoritätspartei di pervenire a una democrazia effetiva» [Nota 121]. Alle
dimissioni di Bethmann-Hollweg — chieste, per bocca di Matthias Erzberger [Nota
122], da conservatori, nazional-liberali e Centro (con un atteggiamento di sostanziale
astensione da parte di socialdemocratici e progressisti) — infatti, non fa seguito una
democratizzazione, ma un nuovo colpo di mano da parte del comando supremo e
dell’imperatore, che, senza curarsi del Reichstag, nomina direttamente Michaelis
«facendo cosí fallire in modo addirittura grottesco una possibile offensiva per la
parlamentarizzazione» [Nota 123]. Il «nuovo sistema» — la svolta ‘democratica’ —
vanno quindi a parare nella situazione paradossale e, per la verità, assai poco
democratica, per cui tutti i partiti — come osserva ironicamente Adler — attendono con
ansia il primo discorso del nuovo cancelliere per scoprire se è dalla loro parte o meno
[Nota 124].
La verità è che il tempo ha mostrato tutta la validità delle osservazioni di Hugo
Preuss, che, per primo, ha ricondotto l’Anderssein dei tedeschi al fatto che la Germania
— diversamente dalle altre potenze occidentali — non ha conosciuto uno sviluppo
democratico. «Ora, però, il richiamo all’autogoverno del popolo» — ritenuto
Página XLIII
un’eresia al primo apparire dell’analisi di Hugo Preuss [Nota 125] — «è divenuto
addirittura una parola d’ordine patriottica in Germania, alla quale — fatta eccezione per
la casta degli Junker e dei padroni del vapore (Schlotbarone), ai quali, come spesso è
avvenuto in questa guerra, si sono associati con prontezza servile alcuni professori e
intellettuali di estrazione nazional-liberale — nessun partito del Reichstag tedesco osa
sottrarsi» [Nota 126]. La vecchia «idea tedesca di libertà» non è piú una virtù e il
sistema dello Obrigkeitsstaat è divenuto, improvvisamente, intollerabile: «fra le
vecchie democrazie in Occidente e la giovane libertà in Russia, il popolo tedesco non
vuoi restare piú a lungo il solo ad essere guidato dall’alto» [Nota 127]. Il mutamento di
sistema, in Germania, non può ridursi a una semplice «crisi ministeriale», né può
consistere nel fatto che, al posto di alcuni funzionari superiori del Reich, subentrino
alcuni parlamentari.
Ma tutto dipende dal fatto che il popolo, infine, si decida, per mezzo dei suoi
rappresentanti eletti, a determinare da sé il sono destino, a fare la sua propria politica.
[Nota 128]
Mentre, dunque, alcuni dei filoni principali del marxismo europeo — non solo Renner,
ma anche Kautsky, Cunow, Bernstein e, di lí a poco, lo stesso Hilferding [Nota 129] —
partendo dall’analisi delle transformazioni del capitalismo nell’ultimo quarantennio (e
sia pur facendo valere la giusta istanza di una transformazione del rapporto fra classe
operaia e Stato), si orientano sempre piú verso una enfatizzazione del ruolo dello Stato
in quanto tale, proprio Adler — proprio, cioè, i pensatore che mostra, all’interno del
marxismo europeo degli anni Venti, una sensibilità tutta ‘pregramsciana’ per
Página XLIV
la complessità dell’intreccio fra politica ed economia — si muove in una direzione
sostanzialmente diversa e innovatrice [Nota 130]. In tal senso, la ricerca adleriana
rompe quella inusitata (e tutt’altro che innocua) ‘traducibilità di linguaggi’, per cui,
negli anni Venti, uno studioso come Schumpeter — sùbito dopo aver affermato la
vitalità del capitalismo concorrenziale (nonostante la crisi finanziaria dello Stato fiscale,
conseguente alla guerra) [Nota 131] — può richiamarsi in positivo all’esigenza
leniniana di una «sottomissione senza riserve delle masse alla volontà unica di chi
dirige il processo lavorativo» [Nota 132]; e un osservatore sensibile dei primi eventi
della repubblica di Weimar come Troeltsch può accettare l’idea del socialismo in quanto
questo significhi «economia pianificata» [Nota 133]; e Kelsen può sottolineare le
analogie esistenti fra la critica weberiana e quella leniniana del parlamentarismo [Nota
134]; e Rathenau, d’altra parte, — tutt’altro che parco di critiche, per altro verso, nei
confronti del socialismo contemporaneo — guarda non senza interesse a quella
corrente, che viene dall’oriente, «contraddittoria e tuttavia profondamente sentita: ad
andare contro la democrazia per amore della libertà» [Nota 135].
Il nesso che si viene a stabilire, per Adler, tra problema dello Stato e problema della
democrazia e dell’autoorganizzazione, costituisce il parametro e l’orizzonte a partire dai
quali è possibile comprendere il suo rapporto non solo con i teorici socialdemocratici e
con le correnti della scienza sociale contemporanea, bensí anche il suo atteggiamento
rispetto alla rivoluzione russa.
I primi interventi adleriani, già all’indomani della rivoluzione di febbraio, sono segnati
fondamentalmente da un interrogativo: quale sarà l’atteggiamento del nuovo governo
rivoluzionario russo nei confronti della guerra? La speranza, ovviamente, è che la
rivoluzione russa — i suoi dirigenti — prendano immediatamente posiPágina XLV
zione per la pace [Nota 136], ponendo fine alle mire imperialistiche della borghesia
russa. È tale l’attesa in tal senso che quando — il 1° luglio 1917 — si verifica, da parte
russa, una ripresa dell’offensiva, Adler non esita a parlare dell’esistenza di una
«contraddizione» all’interno della rivoluzione [Nota 137], sia pure in parte giustificata
dal comprensibile timore russo nei confronti del militarismo e della Obrigkeitsregierung
tedeschi [Nota 138].
Ciò che va rilevato, fin da questi primi interventi sulla rivoluzione di febbraio, è un
altro punto: la tendenza, cioè, a valutare gli eventi russi non isolandoli, ma per i riflessi
internazionali che essi possono avere. E questo non nel senso — secondo Adler
‘miope’, cioè incapace di elevarsi «all’altezza storico-mondiale» — che la confusione
nell’impero russo (conseguente alla rivoluzione) rischia di far vacillare «uno degli
appoggi piú potenti dell’Intesa» [Nota 139]. Ma nel senso che la vittoria contro lo
zarismo è una vittoria di tutte le forze che aspirano alla democrazia:
Se ai nostri giorni giunge a compimento ciò che è stato l’aspirazione di tutti i paesi
d’Europa per tutto il diciannovesimo secolo; se ora è infine crollato quel dominio
violento, che è stato — dai tempi della Santa Alleanza — il baluardo della reazione in
Europa [...] la vittoria su questa potenza dell’oscurantismo non dev’essere allora, in
pari tempo, una vittoria e un rafforzamento per ogni paese, per ogni popolo, che ci
tenga allo sviluppo della democrazia e al progresso politico? [Nota 140].
La nuova Russia — la Russia della libertà popolare, della Volksfreiheit — non potrà non
mostrarsi aperta e sensibile a ogni richiamo che le venga rivolto in tale spirito di libertà
[Nota 141]. La lotta di liberazione condotta dal popolo russo diviene uno stimolo ad
avvertire in maniera sempre piú dolorosa «la mancanza di effettiva democrazia» [Nota
142], anche in tutti gli altri paesi.
La tendenza che emerge da questi primi giudizi [Nota 143] è abbastanza evidente: la
rivoluzione russa ha un’importanza tale da segnare una svolta nella storia europea e
mondiale, per i processi che attiva, per le forze che mette in movimento e per le
speranze che suscita, ben al di là dei suoi confini geografici.
Sette anni piú tardi, nel saggio scritto per la morte di Lenin,
Página XLVI
Adler ribadisce sostanzialmente — sia pure all’interno di un giudizio piú complessivo, in
cui vengono segnalati i limiti di centralismo, interno ed esterno (nei rapporti, cioè, con
i partiti socialisti degli altri paesi), della rivoluzione russa — queste prime valutazioni.
Se còmpito di ogni rivoluzione è quello di distruggere le istituzioni sopravvissute e le
vecchie forme di vita, che sono divenute un ostacolo allo sviluppo, per dar spazio
all’ulteriore evoluzione della società, bisognerà allora ammettere che «non c’è mai
stata rivoluzione piú profonda di quella russa»:
E quest’opera grandiosa ha la sua importanza non solo per la Russia: è un tassello
nell’opera di liberazione del mondo stesso. E [...] Le catene, che Lenin ha spezzato in
Russia, erano catene già pronte anche per noi. [Nota 144]
Ma vi è ancora un altro punto, che Adler sottolinea in positivo a proposito della
rivoluzione russa. Il fatto, cioè, che essa — attraverso l’idea dei consigli di fabbrica
[Nota 145] — ha fornito l’esempio di uno strumento organizzativo capace di superare
l’impasse, in cui la socialdemocrazia (e la stessa organizzazione sindacale) si è venuta
g trovare negli ultimi tempi.
Il rapido sviluppo della socialdemocrazia nei dieci anni immediatamente precedenti la
guerra — osserva Adler — non significò affatto un rafforzamento del suo carattere
rivoluzionario. Proprio al contrario; nelle due direzioni principali della sua attività, sul
piano politico come sul piano sindacale, si dovette osservare un inquietante
abbassamento di livello e un adattamento all’ordine sociale del capitalismo. I sindacati
erano sempre piú organismi di lotta per gli interessi piú immediati degli operai; essi si
interessavano ai problemi particolai ed erano pronti a fare grandi sacrifici nelle lotte
per gli aumenti salariali e per migliori condizioni di lavoro, ma si mostravano contrari
ad ogni altro sacrificio se questo minacciava d’indebolire la forza sindacale. Sotto la
loro influenza, il socialismo assunse a poco a poco la forma di una assicurazione
popolare burocratica. [Nota 146]
È in tale contesto che si è inserita l’idea dei consigli operai, operando in maniera
liberatoria. Grazie ad essi «l’autodeterminazione
Página XLVII
democratica del popolo» si è riempita di nuovi contenuti; «i legami tra la massa e i
suoi eletti» si rinsaldano e, in pari tempo, «rinasce l’iniziativa del partito, il quale si
arricchisce di innumerevoli impulsi popolari che non avrebbero avuto, altrimenti, la
possibilità di manifestarsi» [Nota 147].
Ciò che invece non è immaginabile è la possibilità di ‘trapiantare’ il modello sovietico,
cosí com’è, in situazioni storiche diverse. Questo non è possibile, perché il bolscevismo
è «una tattica risultante da condizioni storiche e sociali locali e non trapiantabile, senza
modifiche, in qualsiasi luogo, malgrado la sua ricchezza di indicazioni generali» [Nota
148]. Per quanto riguarda l’obbiettivo del superamento dello Stato borghese, non è
possibile pensare «una soluzione uniforme e valida per tutti i paesi, ma dipende
proprio dal modo e dal grado dello sviluppo della differenziazione sociale e del processo
politico rivoluzionario» [Nota 149]. La arretratezza russa [Nota 150], l’eccezionalità
delle condizioni in cui si è venuta a realizzare la prima rivoluzione socialista, hanno allo
stesso tempo determinato i suoi limiti. La dittatura del proletariato è in stretto rapporto
con «l’idea di un’autentica democrazia» [Nota 151]. Ciò significa che essa non può non
avere un carattere di massa: il proletariato deve rappresentare l’unione, se non di
tutti, «almeno dei piú importanti interessi popolari» [Nota 152]. Ma è qui che diviene
visibile la contraddizione dell’esperienza sovietica: il fatto che essa, da una parte, ha
avviato un processo in cui le masse sembrano potersi riappropriare della loro iniziativa,
rompendo la sclerotizzazione di un rapporto burocratico fra ‘dirigenti’ e ‘diretti’;
mentre, dall’altra, anche — ma non soltanto — a causa dei condizionamenti storici in
cui si è realizzata, presenta un limite ‘giacobino’ [Nota 153]. L’organizzazione dei
bolscevichi si è fondata sulla «rinuncia alla conquista delle masse». È per questo —
osserva Adler anticipando alcune critiche, su cui piú tardi avrebbe insistito Kelsen —
che la dittatura dei bolscevichi
non è affatto una dittatura del proletariato, ma la dittatura di un piccolo gruppo di
dirigenti proletari; senza contare che essa può diventare anche una dittatura contro
una grande parte del proletariato, come
Página XLVIII
dimostra l’attuale governo sovietico, il quale opprime non solo la borghesia, ma anche
tutti i socialisti non bolscevichi. [Nota 154]
L’opera di Lenin — che non ha nulla a che vedere con il Putschismus — rappresenta
un grande tentativo di ‘rivitalizzazione’ del socialismo: una lotta continua contro il
seelenloser Sozialismus, contro l’atrofia rivoluzionaria. È tuttavia significativo — e dà
da riflettere — il fatto che questo capo rivoluzionario, per il resto mai prigioniero di
schemi preconcetti («er nie ein Mann der Formeln war»), abbia commesso in
particolare un errore: quello di voler dirigere in maniera centralistica («von einem
Zentralpunkt aus») la tattica socialista al di fuori della Russia [Nota 155]. A partire da
un tale limite, difficilmente riconducibile alla (e giustificabile attraverso la) arretratezza
delle condizioni russe, è possibile guardare sotto una luce diversa sia la forma di
primato della politica (come primato del partito), che si è andata realizzando in Russia,
sia la forma di Stato che ivi si è andata costituendo. Nata dalla tattica
dell’organizzazione bolscevica, fondata sulla «rinuncia alla conquista delle masse»,
essa è stata tuttavia costretta, in seguito, a operare una serie di concessioni, non solo
ai contadini, ma anche agli ‘specialisti’, agli intellettuali borghesi. È per questo che lo
Stato sovietico non può essere considerato uno Stato proletario [Nota 156].
Con parole non molto diverse da quelle di Adler, nello stesso giro di anni, anche Otto
Bauer criticava il carattere di «socialismo dispotico» [Nota 157] che la dittatura del
proletariato aveva assunto in Russia. Anch’egli, non diversamente da Max Adler,
individuava
Página XLIX
nel problema dell’autoorganizzazione — significativa in tal senso la sua attenzione per
la «democrazia industriale» [Nota 158] — un obiettivo centrale della strategia del
movimento operaio. E, da questa consapevolezza, faceva derivare la denuncia —
ancora piú esplicita che in Adler — di quello ‘statalismo’ (la «credenza superstiziosa»
nell’onnipotenza dello Stato), sul cui terreno finivano con l’incontrarsi,
paradossalmente, il vecchio socialismo prussiano e il nuovo bolscevismo:
tra il socialismo prussiano dei Lensch, Plenge, Spengler, che celebrano lo Stato
prussiano come il preludio al socialismo e il socialismo come una realizzazione dell’idea
prussiana dello Stato, ed il comunismo russo esiste un’intima affinità: qui come là vi è
la stessa credenza superstiziosa nella spontanea forza creatrice della taumaturgica
violenza; qui come là vi è la medesima speranza nello Stato onnipotente, in grado di
controllare gl’individui in tutte le sfere della loro vita, qui come là vi è lo stesso
vaneggiamento dell’onnipotenza di una minoranza dominante che possa e debba
portare con la coercizione a forme piú alte di vita delle masse obbedienti e docili. [Nota
159]
5. La complessità della vita moderna: confronto con Simmel
Contro le tendenze dominanti, di carattere ‘statalistico’ — tendenze dominanti, e sia
pure con diverse articolazioni, non solo all’interno del bolscevismo e del socialismo
marxista, ma anche in gran parte della politologia e del pensiero sociologico
contemporanei — Adler insiste nel definire lo Stato «un pezzo di società» [Nota 160]:
«Società e Stato, per i marxisti, non sono due cose diverse» [Nota 161].
Quest’affermazione — contro la quale avrebbe polemizzato aspramente Hans Kelsen
[Nota 162] — viene fondata, da Adler, attraverso un frequente richiamo a Marx. In
realtà, però, essa non può essere compresa se non inserendola in un contesto piú
complessivo di problemi. Essa, infatti, non è deducibile linearmente da alcuna
‘autorità’: meno che mai, in questo caso, la Marx-Philologie può risolvere dei problemi.
La questione, semmai, è un’altra. Si tratta, cioè, di vedere fino a che punto alcune
formulazioni ‘classiche’ del marxismo sono in grado di cogliere alcune trasformazioni
reali
Página L
dello Stato moderno: tenendo conto ovviamente della libertà d’interpretazione che
Adler fin dall’inizio si è riservata, rifiutando l’idea del marxismo come sistema
‘compiuto’ e, quindi, la distinzione fra marxismo e adlerismo [Nota 163].
Che sia questa, e non altra, la posta in gioco, è reso evidente da alcuni elementi.
L’unione di Stato e società, innanzi tutto, è volta a scongiurare un pericolo che
inevitabilmente si presenta — lo dimostrano già il confronto sia con Hugo Preuss sia
con Karl Renner — ogni qualvolta lo Stato appaia ‘distinto’ dalla società: il pericolo,
cioè, che lo Stato diventi per tale via uno strumento neutro, diversamente fungibile.
L’interpretazione dello Stato come sistema di norme va bene — come si è visto [Nota
164] — finché si tratta di portare avanti, anche all’interno della teoria dello Stato, la
lotta contro ogni tipo sostanzialismo o di naturalismo. Diviene problematica, invece,
quando tale acquisizione metodologica e epistemologica diventa — come si verifica in
Kelsen — la mediazione attraverso la quale lo Stato si trasforma in un puro «mezzo di
tecnica sociale».
Ma, in secondo luogo, fino a che punto la ‘distinzione’ fra Stato e società aiuta a
capire le trasformazioni del mondo contemporaneo, quelle trasformazioni che
divengono particolarmente evidenti nella trasformazione della democrazia in
democrazia organizzata? [Nota 165] Ovvero, quando, per un verso, lo Stato si
‘socializza’ sempre di piú, radicandosi nella società civile, mentre, per l’altro verso, tutti
gli àmbiti di quest’ultima si politicizzano mettendo in crisi ogni possibilità di
‘neutralizzazione’? [Nota 166] È possibile, di fronte a tali trasformazioni, mantenere
quella distinzione rigida fra diritto e realtà storica — fra piano delle norme e piano
dell’essere — che Kelsen vuol far valere? Non vi è, inoltre, il rischio che anche nel
Página LI
kelsenismo si ripresenti — sia pure in forma idealizzata e sublimata — una sorta di
statalismo?
Alcuni elementi dell’analisi adleriana sono già noti: ogni forma di ‘centralismo’
conduce a un distacco, estremamente pericoloso, fra dirigenti e diretti e, in generale,
contiene il rischio della burocratizzazione. Non casualmente il socialismo ‘moderno’ si è
rifatto all’idea dei consigli operai — o, per altro verso, agli elementi innovativi contenuti
nel socialismo delle gilde [Nota 167] — nel tentativo di elaborare nuovi istituti («forme
nuove della lotta socialista di clase»), che, essendo caratterizzati dalla partecipazione
attiva e diretta delle masse, dalla loro iniziativa costante e, soprattutto, dalla
subordinazione spontanea a regole e norme che non sono imposte dall’esterno,
funzionino — per riprendere una locuzione gramsciana — da scuola di vita statale
[Nota 168].
Questa dissoluzione dello «Stato Leviatano», inoltre, non sinifica affatto,
necessariamente, la fine della centralizzazione tout couti bensí la sostituzione della
centralizzazione dall’alto con una che sia «il prodotto organico che si sviluppa
spontaneamente a partire dai bisogni di singoli gruppi d’interesse, dunque dal basso,
cosí come sono appunto le necessità della produzione della impresa o anche soltanto i
vantaggi, che scaturiscono dall’unificazione, a consigliare una tale organizzazione che
si pone al di sopra dei singoli raggruppamenti» [Nota 169].
Questa nuova linea strategica, d’altro canto, nasce dall’esigenza i tenere conto di
alcune trasformazioni reali del mondo contemporaneo e, ad un tempo, di riclassificarle
dal punto di vista della classe operaia. Quel dibattito sulla democrazia, sul
parlamentarismo e, in generale, sullo Stato, che ha preso l’avvio proprio dagli anni
della prima guerra mondiale, ha posto l’accento sull’insostenibilità delle vecchie
«vedute centralistiche» [Nota 170] e ha sollevato il problema di come sia possibile,
tenendo conto della pluralizzazione e della complessità della società contemporanea —
ad un tempo inificata e scomposta dall’attraversamento di cerchie «la cui rete
s’ipessisce giornalmente di nuovi fili» [Nota 171] — avviare tuttavia in essa alcune
linee di ricomposizione.
Ciò esige però, in pari tempo, una profonda revisione degli strumenti concettuali.
Kelsen insiste sul fatto che la giurisprudenza non
Página LII
deve spiegare la ‘vita’ [Nota 172]: ma questo va bene solo fin quando si rimane sul
piano critico-gnoseologico. È meno accettabile, invece, nei limiti in cui sembra
condurre a un predominio del metodo giuridico rispetto a quello sociologico.
L’impostazione kelseniana, infatti, conduce a trascurare il fatto che — come mostra il
problema della ‘dittatura’ — vi sono problemi di realtà concreta che sono, ad un tempo,
problemi giuridici [Nota 173]. È già significativa, del resto, l’elaborazione della
tendenza della giurisprudenza moderna che va sotto il nome di «scuola del diritto
libero» [Nota 174], che è solo «un sintomo significativo» della «insoddisfazione» e «del
tormento interiore del giurista pensante, ed è solo un caso particolare, che si presenta
all’interno della determinatezza tecnica e metodologica di un singolo specialismo» di
quei motivi di pensiero, che si presentano sia in altre cerchie specialistiche sia in altri
momenti della vita politica e sociale, che «spingono ad andare oltre l’espressione
letterale delle leggi, redatta una volta per tutte, e immutabile, verso la loro forma
vivente, configurata attraverso un’applicazione concreta, volta per volta, del diritto»
[Nota 175].
Ciò significa che — come avrebbero obbiettato i critici di parte ‘fenomenologica’ a
Kelsen [Nota 176] — la delimitazione dell’oggetto giuridico non può essere puramente
formale (erkenntniskritisch), ma dev’essere oggettiva (gegenständlich) [Nota 177]:
cosí, ad esempio, «non si può scindere l’autorità dello Stato» — obbietta a Kelsen, da
un diverso punto di vista, Carl Schmitt [Nota 178] — «dal valore (Wert) di esso».
Página LIII
Ma, se il problema che a questo punto si pone è quello di un rapporto piú stretto fra
scienza e vita — se è questo, cioè, il nodo intorno al quale si articola un processo di
trasformazione sia delle forme della razionalità, sia della forma della politica — è lo
stesso neokantismo di Adler a esser messo in questione. Non casualmente, criticando il
«marxismo trascendentale» di Adler dal punto di vista di una «filosofia concreta», che
trae ispirazione da alcuni motivi del secondo Dilthey non meno che da Heidegger [Nota
179], Herbert Marcuse insiste, in un suo saggio degli anni Trenta, sull’impossibilità di
pervenire, attraverso il metodo trascendentale, alla realtà concreta.
Il metodo trascendentale osserva Marcuse — significa anzitutto un distacco cosciente e
sistematico dagli oggetti, dalla realtà quale l’incontriamo nell’esperienza spaziotemporale. Ciò non significa che nel corso della ricerca questa realtà non sia tenuta
costantemente presente, setto forma di esempio, verifica, applicazione; ma essa non
costituisce mai il ‘filo conduttore’ del metodo. L’interesse, il senso e lo scopo della
ricerca è altrove. Ciò che essa si propone di appurare [...] non sono le leggi che
esistono in questa realtà, l’esistenza concreta dell’uomo e il suo rapporto col mondo —,
ma la possibilità di questo mondo e delle sue leggi. [Nota 180]
Proprio per il fatto che l’interesse della filosofia trascendentale è rivolto alla semplice
possibilità, essa è interamente segnata dall’«allontanamento dalla realtà»: «il metodo
trascendentale si rivolge ad un campo di oggetti che ha una natura interamente
diversa dalla realtà che esiste e accade nello spazio e nel tempo» [Nota 181]. Ciò
significa che il tentativo adleriano di una fondazione trascendentale dell’esperienza
sociale può risultare interessante nei limiti in cui «si riferisce all’esperienza sociale
come oggetto di un sistema scientifico di ricerca e quindi alla fondazione gnoseologica
della scienza sociale». Esso va invece criticato se pretende di essere una fondazione
gnoseologica «dello stesso essere e accadere sociale» [Nota 182].
Adler avrebbe risposto alcuni anni piú tardi — nella sua ultima opera — alle critiche di
Marcuse, sostenendo che, per chi abbia
Página LIV
un minimo di consuetudine con la filosofia trascendentale, la distinzione marcusiana fra
esperienza possibile e esperienza reale è del tutto priva di senso [Nota 183]. Anzi,
rovesciando contro il suo critico l’accusa di ‘neokantisrno’ Adler fa notare che Marcuse
può sostenere la tesi che il sociale è indifferente al problema dell’«esperienza
possibile» solo perché, forse inconsapevolmente, è ancora legato alla distinzione,
windelbandiano-rickertiana, fra scienze della natura e scienze dello spirito [Nota 184].
Tralasciando di entrare nel merito della Auseinandersetzung fra Max Adler e il giovane
Marcuse, va comunque detto che il ‘sospetto’ di quest’ultimo era tanto legittimo quanto
infondato. Il tentativo adleriano di una fondazione trascendentale della socializzazione
— precedente, quindi, rispetto a quella consentita dal mondo della produzione, dei
rapporti economici e sociali — è rivolto fin dall’inizio ad un’unico scopo: ribadire che
non esiste struttura economica, che non sia ab initio inscritta entro forme (istituzionali,
giuridiche, politiche, filosofiche, religiose ecc.). In tal senso, la tematica del carattere
trascendentale dell’esperienza sociale costituisce il vero e proprio fondamento teorico
dell’antieconomicismo adleriano — basti pensare al tema della realtà dell’ideologia
[Nota 185] o al rifiuto del concetto di classe come concetto puramente economico
[Nota 186] — quell’antieconomicismo, che distingue fortemente il marxismo di Adler
dal panorama europeo contemporaneo.
Ma ciò su cui, soprattutto, occorre richiamare l’attenzione, è un altro punto: cioè il
carattere molto particolare del rapporto di Adler con Kant, in maniera specifica in
ordine al rapporto tra filosofia teoretica e filosofia pratica.
È nota l’indicazione di Kant, — scrive Adler — che scuote profondamente il pensiero, di
fare attenzione a ciò, se cioè la ragione teoretica e quella pratica, che si distinguono in
maniera cosí rigida nell’essere e nel dover-essere, alla fine tuttavia non si rapportino in
una radice comune. Io non oso decidere se questa radice sia già posta nell’elemento
sociale-trascendentale. Ma se si tiene conto del fatto che è posta qui l’origine della
relazione dell’individuo con il prossimo in generale, che solo a partire da qui prende le
mosse quella molteplicità dei soggetti, che costituisce quel mondo spirituale, che
sperimenta la sua regolamentazione nella norma, e che d’altra parte ogni norma
riconduce a una volontà pura, che, nella sua validità generale e nella sua assenza di
contraddizioni racchiude inscindibilmente in sé il riferimento
Página LV
a una molteplicità indeterminata di soggetti del volere: allora mi sembra che qui,
comunque, siamo giunti vicini, essenzialmente, al ceppo comune della legalità della
coscienza in generale. [Nota 187]
Mentre, da una parte, Adler presenta Kant come precursore di Hegel e Marx;
dall’altra, la tematica relativa all’unificazione derivante dalla ungesellige Geselligkeit
viene sottratta al confronto con la smithiana «mano invisibile»: Kant non ha nulla a
che fare con il liberalismo [Nota 188].
E questo intanto è possibile, per Adler, in quanto egli fin dall’inizio inserisce un
elemento ‘materiale’ all’interno del ‘formalismo’ kantiano: cioè il rapporto con la storia
visto sotto il profilo del problema dello sviluppo sociale. L’etica kantiana è importante
perché consente di «assumere la causalità del volere umano non piú come un fatto
indefinito e indefinibile nel computo della necessità storica, bensí come un fattore la cui
direzione è determinata» [Nota 189]. Il metodo trascendentale non è ‘vuoto’: non è
affatto vero che esso possa assumere, surrettiziamente, qualsiasi contenuto. Dal
momento che esso è il fondamento della socializzazione non può non essere carico, fin
dall’inizio, dei valori che nelle diverse forme di socializzazione vengono alla luce:
Non dalle istanze etiche si sviluppano nuove condizioni sociali, ma al contrario col
trasformarsi dei rapporti sociali fra gli uomini questi mutamenti devono
necessariamente manifestarsi alla loro coscienza come istanze morali. È lo stesso e
identico processo storico causale, quello nel quale si trovano riuniti i rapporti sociali e i
giudizi morali che su di essi si pronunciano. [...] L’imperativo categorico [...] non è
propriamente altro che la forma della connessione sociale, la forma dell’effettiva
socializzazione dell’uomo. [Nota 190]
Certo, se si tiene conto di questa interpretazione anti-formalistica di Kant — una
interpretazione in cui, del resto, la distanza fra Kant e Hegel si assottiglia di molto
[Nota 191] — si comprende perché Adler non potesse condividere le critiche di Scheler
al formalismo kantiano [Nota 192]. Meno chiara è, invece, la ostilità adleriana nei conPágina LVI
fronti del tentativo scheleriano in quanto tale: tentativo volto, da una parte, a
presentare un’immagine piú complessa della forma della razionalità, che attraverso
l’affermazione di un intreccio fra elemento intellettuale e elemento ‘emozionale’ [Nota
193], fosse in grado, d’altra parte, di teorizzare il modo in cui il ‘valore’
(«l’interessamento ‘a qualcosa’») è parte costitutiva (non esterna) di una «visione del
mondo» e, anzi, opera già all’interno delle tecniche, se è vero che
La tecnica non è affatto soltanto una ‘applicazione’ a posteriori d’una legge puramente
contemplativo-teoretica, che sarebbe determinata esclusivamente dall’idea della verità
dell’osservazione, della logica e della matematica pura. Ma è piuttosto la volontà di
dominio e di guida [...] che condetermina già i metodi del pensiero e dell’intuizione
come anche i fini del pensiero scientifico. [Nota 194]
Tralasciando comunque questa problematica, che consentirebbe forse di scorgere
alcuni punti di contatto — paradossali se si pensa alla costante polemica fra Adler e
Scheler [Nota 195] — fra i due pensatori, val la pena di soffermarsi su un altro punto.
Il fatto, cioè, che la Auseinandersetzung con Kant e il neokantismo sottende una
problematica piú generale: quella di una riadeguazione della forma della razionalità
rispetto alla complessità di un presente che non sembra piú dominabile attraverso
alcuna veduta ‘sintetica’. Una tale riadeguazione si rende tanto piú necessaria in
quanto, di fatto, è già operante all’interno del modo di funzionare dei singoli
specialismi in cui è scisso il cervello sociale e in cui concretamente (sempre piú)
s’incarnano le scelte politiche [Nota 196]. È questo il signifiPágina LVII
cato della compenetrazione sempre piú stretta fra metafisica (i valori, la politica),
scienza e progetto tecnico. La crisi crescente delle vecchie ‘vedute centralistiche’; il
processo — solo apparentemente contraddittorio — di diffusione dello Stato e della
politica e contemporaneamente di accentramento della decisione: tutto ciò accresce la
complessità dei processi sociali e politici — e, rispettivamente, della forma della
contraddizione — nel corso degli anni Venti-Trenta [Nota 197].
Sarebbe eccessivo scorgere, già in Adler, una lucida consapevolezza di tutto ciò. È
tuttavia estremamente significativo il fatto che Adler stabilisca, in tale contesto, un
rapporto esplicito e positivo con Georg Simmel, con quel sociologo e filosofo, che,
muovendo dall’analisi delle trasformazioni della vita dell’uomo moderno nell’epoca della
metropoli [Nota 198], aveva sempre piú richiamato l’attenzione sul carattere
conflittuale [Nota 199] delle relazioni che contraddistinguono la società moderna e, in
generale, sulla dissoluzione della vecchia Gemeinschaft in una ‘società’ dominata da
pure ‘relazioni’ [Nota 200].
Página LVIII
Il limite di Kant, per Simmel, sta appunto nel suo intellettualismo, nel suo tentativo di
«estendere il valore delle norme valide per il pensiero a tutti i piani della vita» [Nota
201]. Si scopre, qui, il suo rapporto — sia pure critico — con quel meccanicismo che
sembrava voler negare ogni spazio alle idee, ai valori, agli scopi. Il kantismo, infatti, è
un primo tentativo di ripristinare l’unità — la cui esigenza permane anche dopo il
naturalismo della scienza meccanicistica — fra natura e spirito, fra meccanismo e
senso interno, fra obbiettività scientifica e valori: Kant «ha elevato il soggettivismo dei
tempi moderni, l’autonomia dell’io e la sua irriducibilità all’elemento materiale, al
culmine, senza in ciò abbandonare minimamente la saldezza e l’importanza del mondo
oggettivo» [Nota 202]. Ma ciò può riuscire, a Kant, solo portando all’apice
l’interpretazione scientifico-intellettualistica dell’immagine del mondo:
non le cose, bensí il sapere sulle cose diviene, per Kant, il problema tout court. La
unificazione delle grandi dualizzazioni: natura e spirito, anima e corpo, gli riesce a
patto di voler unificare soltanto le immagini della conoscenza scientifica; l’esperienza
scientifica con l’uguaglianza generale delle sue leggi è la cornice che compendia tutti i
contenuti dell’esistenza in una forma: quella della comprensibilità conforme
all’intelletto. [Nota 203]
Del tutto diverso, invece, è il tentativo goethiano di ricomporre i dualismi tradizionali.
Goethe rinuncia a un ‘sistema’ filosofico, anzi gli manca completamente l’«intenzione
della filosofia come scienza»: in Goethe si tratta sempre, piuttosto, «dell’espressione
immediata del suo sentimento del mondo» [Nota 204]. Ciò che lo distingue
radicalmente da Kant è il fatto che egli cerca la ricomposizione delle scissioni fra spirito
soggettivo e oggettivo, fra natura e spirito, «all’interno del loro fenomeno
(Erscheinung) stesso» [Nota 205]. Il ‘ritorno a Goethe’ — che si contrappone
all’unilaterale zurück zu Kant! degli anni Settanta — deriva direttamente da questo
atteggiamento di Goethe, per cui egli non tenta di saldare la scissione né andando al di
là dei fenomeni — facendoli cogliere dall’io ‘gnoseologico’ come semplici
‘rappresentazioni’ —, né acquietandosi con la cosa in sé:
Página LIX
Dell’Assoluto in senso teorico — dice Goethe — non oso parlare; ma posso affermare
che: chi lo abbia riconosciuto nel fenomeno, e lo abbia tenuto sempre presente, ne
ricaverà un gran guadagno. [Nota 206]
È a questo punto che Simmel si vede costretto ad andare al di là della filosofia
trascendentale, a risalire a un elemento superiore — la vita — che sorregga le stesse
funzioni a priori dello spirito [Nota 207].
La necessità del primato della vita nasce direttamente dalla enorme complicazione del
rapporto desiderio-mezzo-scopo nella moderna Kultur [Nota 208]. La perdita di
trasparenza, all’interno di questo rapporto, è anzi tale da far sí che la tecnica — cioè, la
scienza dei mezzi — assorba la maggior parte delle energie [Nota 209]: è in questa
situazione che nasce il bisogno di un Endzweck, di uno ‘scopo finale’:
L’ansioso problema del senso e dello scopo del tutto si costituisce solo quando attività
e interessi innumerevoli, su cui ci concentriamo come se fossero valori definitivi, ci si
rivelano nel loro semplice carattere di mezzi. [Nota 210]
È questa la condizione di Sehnsucht, di nostalgia-aspirazione, che caratterizza l’uomo
moderno. La dissoluzione di ogni Endzweck equivale alla fine di ogni fondamento: il
risultato sembra essere l’assoluta scomposizione della realtà, la fine di ogni possibile
sintesi. È qui che s’inserisce la vita come possibilità di pensare uno sviluppo che, pur in
assenza di uno scopo finale, sia tuttavia dotato di senso:
la vita stessa — dice Simmel — può divenire scopo della vita e, in tal modo, è sottratta
al problema di uno scopo ultimo, che giaccia al di là del suo processo che scorre in
maniera pura e naturale [...] Il fatto che un processo fattuale debba valere come
sviluppo — in senso storico-psicologico o anche in senso metafisico — pertanto non
dipende piú da uno scopo ultimo posto al di fuori di esso, che, a partire da sé,
attribuisca a quel processo un certo significato di mezzo o di transizione. [...] Ogni
stadio dell’esistenza umana trova ora il suo scopo
Página LX
non in qualcosa di assoluto e definitivo, bensí in ciò che è immediatemente piú elevato
[in dem nächsthöherem]. [Nota 211]
Proprio in questa concezione Adler scopre, da una parte, «la natura metafisica» del
concetto di vita, che è, per Simmel, «un’energia creatrice di valore» e, dall’altra, un
«inaudito ottimismo della vita», che avvicina Simmel molto piú a Nietzsche che non a
Schopenhauer [Nota 212], e che culmina nell’affermazione secondo cui la vita è
sempre piú-vita (Mehrleben), anzi piú-che-vita (Mehr-als-Leben).
Ma, a parte queste osservazioni critiche, è un’altra — e molto piú significativa ai fini
del nostro discorso — l’idea-guida del confronto adleriano con Simmel. Si tratta, cioè,
dell’idea secondo cui è erroneo pensare di poter definire l’esperienza intellettuale di
Simmel attraverso la categoria di ‘relativismo’: e questo, in particolare — e per quanto
possa apparire paradossale — tanto meno dopo la radicalizzazione in senso ‘metafisico’
di tale (apparente) relativismo. Dopo l’incontro con Kant, infatti, il ‘relativismo’ di
Simmel diventa
da metodo, che consisteva semplicemente nell’indicare, all’interno della conoscenza, la
relazione generale dei suoi singoli contenuti l’uno con l’altro, metafisica, che pone in
relazione tutta la conoscenza con un’essenzialità posta dietro di essa, cioè appunto con
il fatto originario della vita, grazie a cui soltanto viene acquisita un’immagine completa
del mondo. Il relativista e lo scettico finisce da metafisico. [Nota 213]
Proprio questo esito metafisico costringe a ripensare l’itinerario intellettuale di
Simmel al di fuori di ogni schema classificatorio. Già nella Philosophie des Geldes
Simmel non solo non nega, ma addirittura afferma che la conoscenza presuppone
sempre — per aver valore di verità — un’istanza ultima e assoluta: «Solo che non
possiamo mai sapere quale sia questa conoscenza assoluta» [Nota 214]. Sussiste
sempre la possibilità di trovare un principio superiore, per cui non è mai lecito chiedere
dogmaticamente il pensiero, ma occorre piuttosto considerare l’ultimo punto, di volta
in volta acquisito, come il’penultimo. La relatività della conoscenza, cosí intesa, non
conduce però necessariamente a un processo all’infinito (nel senso che ogni verità
dipende da un’altra), perché questo processo di fondazione della verità può piegarsi in
circolo: «Spesso, cioè, si scopre che la dimostrazione di un principio, quando la si
Página LXI
segua attraverso tutti i suoi presupposti, è possibile solo se si suppone come già
provato il principio da dimostrare» [Nota 215]. Si arriva cosí a una sorta di
dimostrazione tautologica o a un ‘sillogismo circolare’ (Zirkelschluss) [Nota 216].
Non è impensabile che la nostra conoscenza, considerata come un tutto, sia
inevitabilmente prigioniera di questa forma. Se si pensa cioè all’immenso intreccio di
presupposti, da cui dipende ogni singola conoscenza, allora Simmel ritiene non escluso
che la dimostrazione di A riconduca, attraverso una catena di argomentazioni
sufficientemente lunga, nuovamente ad A. [Nota 217]
La «legittimazione reciproca» dei contenuti della conoscenza, quale emerge nel
Zirkelschluss, va considerata come una forma fondamentale del conoscere, che in tal
modo diventa un processo sospeso (freischwebender Prozess) i cui membri si tengono
reciprocamente [Nota 218].
Inoltre, i principi costitutivi della verità di una conoscenza possono essere trasformati
in principi regolativi, tali cioè che non dicano come le cose effettivamente vanno, ma
semplicemente facciano come se le cose andassero effettivamente in un tal modo
[Nota 219].
Se essi valgono solo come principi euristici, se cioè li consideriamo solo come vie che si
possono alternativamente percorrere, ciò consente la contemporanea applicazione dei
princìpi piú opposti. E, evidentemente, solo in tal modo la nostra conoscenza diviene
adeguata alla realtà. [Nota 220]
Se si tiene conto di queste considerazioni si scorge che la ‘relatività’ simmeliana non
significa affatto «un indebolimento del concetto di verità, non è una detrazione della
verità bensí, al contrario, è l’essenza della verità stessa, il modo in cui soltanto le
nostre rappresentazioni possono diventare piena verità» [Nota 221].
Página LXII
È qui che occorre tener conto di quello che Simmel chiama il «carattere di frammento
della Vita» [Nota 222], per cui ogni soggetto vive non in uno, ma in piú mondi. I
contenuti della coscienza riflettente, infatti, si ordinano secondo i piú diversi punti di
vista, e costituiscono ognuno un mondo a sé. Lo stesso soggetto vive, insieme, in un
mondo religioso, artistico, etico e storico. Tutti questi mondi hanno lo stesso
contenuto, ma motivi diversi lo portano a formazioni complessive del tutto distinte.
«Tutti i nostri contenuti psichici, vissuti passivamente o attivamente, sono frammenti
di mondi, ognuno dei quali significa una totalità di contenuti del mondo particolarmente
formata». Non c’è quindi speranza «di pervenire, partendo da uno qualunque dei punti
di vista dei contenuti della nostra coscienza, a cogliere l’intero della nostra vita» [Nota
223].
L’impulso della vita è, invece, quello di presentarsi come quella totalità che essa è. Vi
è, nella filosofia simmeliana, la tendenza costante a rompere le «catene della
conoscenza soltanto logica», che tende a separare, e in ciò Simmel fa venire alla
mente «un altro ribelle filosofico contro la logica, Hegel» [Nota 224], il quale supera le
«barriere della conoscenza» intellettualistica grazie alla dialettica [Nota 225].
Non diversamente che in Hegel, inoltre, in Simmel è ben presente il problema della
costituzione dello «spirito oggettivo». Solo che, in Simmel, questo è il prodotto della
vita: in essa, infatti, esistono le Vorformen der Idee [Nota 226]. Per quanto i contenuti
dell’idea possano apparire diversi dalla vita, in realtà si presentano sempre le stesse
forme che già la vita ha elaborato. Ma proprio qui, nel processo di oggettivazione della
vita, si costituisce un secondo problema di cui non si può non tener conto se si vuol
effettivamente comprendere il senso (non relativistico) del relativismo di Simmel:
Dappertutto, attraverso lo svincolamento delle forme spirituali e delle categorie, che la
vita ha sviluppato per i suoi scopi pratici, da questa destinazione, nasce una nuova
connessione, che ora irrompe nella vita
Página LXIII
come un ordinamento oggettivo dello spirito e addirittura la determina in base a sé.
[Nota 227]
Vi è, qui, uno dei grandi meriti di Simmel che tenta — con piú forza dei suoi
predecessori — di radicare le idee, «per cosí dire, nella terra». Ma, dalla tensione fra
la, vita e le forme in cui la prima si è oggettivata nasce comunque una nuova
lacerazione, che ha una parte dominante nello spiegare il carattere «metafisico» del
relativismo di Simmel, che ha la sua radice in un terzo elemento, cui bisogna
accennare. Si tratta, cioè, di quel problema — cui Simmel allude «nel saggio, molto
oscuro, sulla legge individuale» [Nota 228] — per cui la vita non è, ad ogni istante, la
totalità delle sue determinazioni, bensí è in sé «conclusa» (abgeschlossen), è
«concentrata intorno al suo significato», ovvero è un’individualità.
Il motivo per cui Simmel introduce questo tema della «individualizzazione della vita»,
osserva Adler, dipende dalla sua «aspirazione di poter inserire nella sua immagine del
mondo anche la molteplicità e le differenziazioni della vita spirituale, che, in una
considerazione concettuale, scompaiono completamente» [Nota 229]. Ma, se si tien
conto di ciò, il relativismo di Simmel appare infine
in quella luce, in cui esso non si presenta piú come un indebolimento della nostra
conoscenza, bensí piuttosto come l’unico mezzo per impadronirsi della totalità
dell’essere. Sarebbe dunque meglio non usare l’espressione relativismo, fin troppo
fraintesa, per la natura di questo punto di vista filosofico, ma sarebbe preferibile
parlare di un plurarismo dei principi. [Nota 230]
Ora, però, questo «pluralismo dei principi» è ben lungi dal significare conciliazione
eclettica. La Differenzierung del tempo non tollera mediazioni artificiose: «le
opposizioni non devono essere ‘conciliate’ o ‘superate’, esse possono solo — come
Simmel dice nel suo libro Kant und Goethe — essere negate attraverso il dato di fatto
del loro essere vissute» [Nota 231]. La grandezza di Simmel sta appunto nel fatto di
essere stato l’«interprete di un’epoca» [Nota 232]: un interprete non passivo, se è
vero che nella sua riflessione è possibile rintracciare, ad un tempo, la constatazione
della impossibiPágina LXIV
lità di ritornare, dalla Fragmentarisierung, alle vecchie ‘sintesi’ e la ribellione (sia pure
inconsapevole) contro quelle scissioni, che, in fondo, non sono altro che il prodotto di
una estremizzazione della divisione capitalistica del lavoro [Nota 233]:
Ed è questa l’importanza vera e propria dello spirito simmeliano, ciò in cui egli si
conferma un puro figlio del nostro tempo altamente differenziato, della nostra epoca
della divisione del lavoro, anche del lavoro intellettuale, spinta al culmine: il fatto che
egli rappresenta la reazione piú profonda contro la frammentazione del nostro essere.
[Nota 234]
6. Marxismo come scienza ‘aperta’
L’importanza del confronto adleriano con Simmel va ribadita con forza. Attraverso la
riflessione filosofica e sociologica di Simmel, infatti, Adler fa sua un’immagine della
‘società’, che non è piú definita dalla sua contrapposizione alla ‘comunità’ intesa —
unicamente essa — come «forma solidale» [Nota 235]. Quella esigenza di una rottura
degli schemi astraenti dell’intelletto — in cui Adler ravvisa una tendenza fondamentale
della filosofia simmeliana, nonché il suo rapporto con la dialettica hegeliana —
significa, tradotta nel linguaggio della Sociologia, la necessità di un’immagine non piú
armonicistica o organicistica di quel complesso di relazioni che costituiscono la società
stessa. Persino il conflitto gioca un elemento positivo nella sua costituzione [Nota 236].
E, soprattutto, non esiste «società in generale», collocata al di là — magari come loro
fondamento metafisico-sostanzialistico — delle particolari «forme di relazione» fra i
soggetti [Nota 237]. I rapporti fra gli uomini — a cominciare da quelli di comando e di
subordinazione — appaiono quindi in forma molto piú complessa, anche perché il
fenomeno piú caratteristico, che emerge da questo tipo di analisi, è l’«incrociarsi di
cerchie molteplici nelle singole personalità» [Nota 238].
Página LXV
Se si tiene conto di tutto ciò, si comprende anche l’apertura — in alcuni capitoli
centrali del libro sulla concezione dello Stato nel marxismo [Nota 239] — di Adler alle
analisi di Max Weber, Roberto Michels e Carl Schmitt. E si chiariscono anche alcune
delle mediazioni culturali grazie alle quali — di contro alle diverse ipotesi ‘statalistiche’,
dominanti nel marxisrno conteniporaneo — Adler possa interpretare Io Stato come un
«pezzo di società» epossa insistere su un’immagine del socialismo, che — basandosi
sempre su quella «società solidale» che può nascere dall’introduzione di una
«democrazia sociale» [Nota 240] privilegi tutta la diversità possibile di momenti di
autoorganizzazione dal basso. La contemporaneità dei due studi su Simmel e sul
sistema dei consigli può aver mediato — sia pure attraverso la relativa ‘occasionalità’
del primo — esigenze distinte, ma convergenti.
Certo, proprio il concetto adleriano di «democrazia sociale» e, soprattutto, quello ad
esso legato di «società solidale», sembrano far retrocedere in secondo piano la lezione
simmeliana e sembrano far riemergere la suggestione toenniesiana della vecchia
Gemeinschaft.
Anche se questa ipotesi non può essere del tutto esclusa, essa va tuttavia considerata
all’interno della costellazione problematica in cui s’inserisce. Essa si determina — in tal
senso — attraverso il contrasto rispetto al concetto kelseniano di democrazia come
dominio della maggioranza [Nota 241], nel quale Adler scorge il permanere di un
presupposto individualistico [Nota 242]. È tuttavia significativo che Adler parli di una
«società solidale» (o, piú precisamente, di una «socializzazione solidale» come senso
specifico della democrazia); che, cioè, attribuisca alla società — e non allo Stato come
Gemeinwesen — la ricomposizione delle scissioni e delle contrapposizioni. Finché la
società è lacerata da contrasti d’interesse — finché non esistono ‘valori’ comuni [Nota
243] — anche la democrazia (fonPágina LXVI
data sul dominio della maggioranza) è una dittatura, perché la sottomissione della
minoranza è pur sempre una violenza. L’errore di Kelsen è quello di assumere come
modello di dittatura quello realizzato in Russia, ove, invece, ci si trova di fronte a una
forma di ‘terrorismo’ esercitato da una minoranza: il presupposto della ‘dittatura’ (del
proletariato), invece, è appunto il dominio della maggioranza della popolazione su una
minoranza.
L’equazione fra democrazia politica e dittatura, dunque, consente secondo Adler di
ricostruire un’immagine piú efficace della società contemporanea; piú efficace anche di
quella che è consentita dallo stesso concetto di «equilibrio delle forze di classe» [Nota
244].
Al congresso di, Linz nel ’26 — com’è noto — questi temi sarebbero stati al centro del
dibattito fra Bauer e Adler. Nel concetto di Gleichgewicht, probabilmente, Adler
scorgeva el pericolo di un ripresentarsi delle tesi kelseniane — nonostante le importanti
distinzioni introdotte da Bauer [Nota 245] — dello Stato come mezzo di tecnica sociale.
Il problema, di non facile soluzione, che Adler si trova davanti è quello di tener conto di
quella crescente complessità sociale, la cui consapevolezza gli veniva mediata anche
attraverso l’elaborazione filosofico-sociologica di Simmel, senza peraltro dover
accettare che la scoperta di tale complessità si rovesciasse in una conferma delle tesi
kelseniane [Nota 246].
È qui che il richiamo alla «socializzazione solidale», consentita dalla democrazia
sociale, aveva un senso, paragonabile, in una certa misura, a quello che, in altri
contesti, aveva avuto il richiamarsi alla coscienza di classe: il mantenimento, cioè, di
un senso di ‘diPágina LXVII
stinzione’ della classe operaia mediato dal riferimento (progettuale) a un modello
diverso di società.
Questo abbozzo di soluzione della difficoltà interna poc’anzi accennata, in realtà,
probabilmente poneva piú problemi di quanti ne risolvesse. Non, certo, quelli cui
alludeva Rudas quando — nel recensire Storia e coscienza di classe — parla di
un’affinità elettiva fra Adler e Lukacs [Nota 247]: quello che al ‘materialista’ Rudas
appariva puro idealismo era piuttosto la rivendicazione irrinunziabile di uno statuto
produttivo della teoria marxista, strettamente connesso alla sua capacità di
tematizzare il presente come storia. Ma, certo, non mancavano altri problemi: a
cominciare da quello di come far operare, concretamente, la ‘criticità’ del marxismo —
il suo stesso senso di distinzione — all’interno delle cerchie speciali entro cui la politica
si va diffondendo [Nota 248].
Dopo il ’26 — dopo, cioè, il congresso di Linz — la posizione politica di Adler si va
sempre piú radicalizzando a sinistra, con conguenze non sempre positive, anche dal
punto di vista teorico [Nota 249]. Le sistematizzazioni dell’inizio degli anni Trenta non
apportano — rispetto agli scritti del periodo 1904-26 — modifiche sostanziali: se mai,
manifestano i rischi connessi sempre a tal genere di imprese [Nota 250]. Nel 1936, un
anno prima della morte, quando in Austria si è già affermato il fascismo [Nota 251],
Adler pubblica la sua ultima opePágina LXVIII
ra, Das Rätsel der Gesellschaft (il sottotitolo è: Per la fondazione critico-gnoseologica
della scienza sociale). Pubblicata presso una casa editrice minore, diffusa in poche
copie, scritta non senza qualche riguardo alla censura — in una situazione sempre piú
difficile anche dal punto di vista umano [Nota 252] — l’ultima opera è tuttavia in gran
parte un ritorno alla impostazione fatta valere fin da Causalità e teleologia: un ultimo,
impegnato tentativo di fare i conti — e di mettere il marxismo a confronto — con «la
vita spirituale moderna nel suo insieme, cioè con il contenuto del lavoro filosofico e
sociologico del nostro tempo» (come Adler aveva scritto nel 1904). Cassirer e Husserl,
Dilthey, Simmel e Weber, Rickert, Spranger, Toennies, Sombart e Oppenheimer: sono
questi i pensatori con cui Adler si misura nella sua ultima opera. Molti dei giudizi ivi
contenuti potranno apparire frettolosi o erronei [Nota 253]. Ciò che rimane, tuttavia, è
la coerenza rispetto a un modo di concepire il marxismo come scienza ‘aperta’. Almeno
in questo Adler dava una prima indicazione circa il contesto generale entro cui soltanto
può essere avviato a soluzione quel problema cui si accennava poc’anzi: il problema
del rapporto fra criticità e forme. Almeno in questo, Adler ‘indicava una via’, sia pure
ancora molto lunga e complessa.
I Ad Adler non sarebbe dispiaciuto, probabilmente, essere definito con il titolo di una
delle sue opere: Wegweiser.
Página 1
LA CONCEZIONE DELLO STATO NEL MARXISMO
Página 2 (em branco)
Página 3
Prefazione
Le seguenti ricerche sul concetto di società e di Stato nel marxismo sono nate dietro lo
stimolo della critica che il mio amico, l’eccellente teorico di diritto statuale prof. Hans
Kelsen, ha esercitato nei confronti del marxismo, nel suo saggio Socialismo e Stato,
pubblicato nel vol. IX dell’«Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der
Arbeiterbewegung» (a cura di Grünberg), e apparso anche in volume con lo stesso
titolo. Già nell’estate del 1921 ho tenuto all’università di Vienna una conferenza su
questo tema, in cui erano brevemente abbozzati i concetti fondamentali, che nel
presente libro sono esposti piú dettagliatamente. Sulla base di questa origine si spiega
la forma polemica del presente lavoro, che tuttavia vuol essere piú che semplice
polemica. Poiché il confronto con le concezioni critiche di Kelsen ha condotto allo stesso
tempo a una serie di questioni controverse che, attualmente, sono oggetto della piú
vivace discussione anche in campo marxista, e nelle quali è pressantemente necessario
un chiarimento concettuale della terminologia adottata, per lo piú molto ambigua, e
delle rappresentazioni fondamentali, ancora molto meno chiare. Questo vale in
particolare per i concetti di dittatura e di democrazia, non meno che per quelli di libertà
politica e individuale, allo stesso modo che per il rapporto del concetto di libertà con la
società e per le idee di individualismo e anarchismo che ad esso riconducono. L’oggetto
del libro è dunque costituito da una quantità di problemi contenutistici del marxismo
che, di volta in volta, conducono completamente al di là della polemica con Kelsen. Se
ciononostante ho mantenuto l’esposizione polemica dell’oggetto della mia ricerca, l’ho
fatto non solo perché in tal modo è possibile presentare in maniera piú vivace e
intuitiva i diversi lati del nostro tema, ma anche per l’importanza della critica
kelseniana. Quest’ultima viene lodata e viene sentita, in campo antimarxista, come
una critica per piú versi ‘annientante’ Ma, anche a prescindere da questo, essa
Página 4
fa comunque, a causa della giusta e pur sempre crescente stima di cui Kelsen gode in
quanto acutissimo e ingegnosissimo rielaboratore del problema logico-giuridico,
un’impressione durevole proprio sugli animi teorici, sia all’interno sia all’esterno della
sua scuola, soprattutto su quegli animi che all’autorità di questo pensatore non
possono contrapporre correttivamente una sufficiente consuetudine con la cosa stessa.
E, comunque, la critica a Marx di Kelsen in un punto torreggia al di sopra del tipo di
quei dotti galli da combattimento che annullano sempre di nuovo il marxismo che si
riteneva già da molto eliminato, e la cui dubbia conoscenza della cosa che criticano
dev’essere chiaramente bilanciata dall’audacia irriflessiva con cui danno i loro giudizi
critici, insignificanti ma molto appassionati. La critica kelseniana si distingue
positivamente da questo genere grazie all’onestà, anzi appassionata volontà di verità,
che percorre anche la sua critica a Marx cosí come tutti gli scritti di questo vero
scienziato. La ricerca dei motivi per cui, ciononostante, la sua critica doveva condurlo
in errore, fa del presente libro ciò che viene detto nel sottotitolo, ne fa cioè un
contributo alla distinzione fra il metodo sociologico e il metodo giuridico-formale del
pensiero, ed eleva quindi il suo significato, al di là dello stimolo puramente polemico,
ad un piano generale.
Il compito che mi sono posto con questo confronto critico con Kelsen è limitato a
snodare la sua critica a Marx, per questa volta, dunque, non ha nulla a che fare con il
suo punto di vista propriamente logico-giuridico. Questa limitazione dell’oggetto era
data non solo dallo scopo, che mirava anzi non a una discussione della teoria
kelseniana del diritto e dello Stato, bensí alla concezione della società e dello Stato nel
marxismo; ma essa era anche giustificata dal fatto che Kelsen stesso ha ripetutamente
affermato — con quale diritto, lo si vedrà — che era sua intenzione offrire solo una
critica immanente del marxismo, cioè una critica non dal suo punto di vista, ma da
quello del marxismo stesso. Pertanto, non solo poteva, ma addirittura necessariamente
doveva restare al di fuori della considerazione la specifica teoria kelseniana
dell’essenza del diritto e dello Stato: con il che però non si vuol dire che un confronto
critico con essa non sarebbe, proprio per noi marxisti, una necessità pressante. Io
ritengo impossibile una fondazione non contraddittoria del marxismo — in cui io
scorgo, come spessissimo ho fatto presente, un sistema sociologico — senza una
comprensione teorico-gnoseologica dei suoi problemi. Il problema centrale del
marxismo, la concezione materialistica della storia, il rapporto dell’ideologia con
l’economia, in particolare del potere con il diritto, può essere dominato solo grazie a
una chiara riflessione sul modo di funzionare dell’elemento spirituale in generale, e per
questo è nePágina 5
cessaria una critica della conoscenza particolarmente nella direzione, ancora poco
elaborata, delle condizioni sociali della conoscenza.
Fra i critici della conoscenza delle forme giuridiche e statali Kelsen assume oggi bensí
un posto di primo piano; in maniera piú profonda e molto piú coerente di quanto
avvenisse nella logica giuridica di Stammler viene da lui assunta l’elaborazione del
problema: com’è possibile la società, com’è possibile lo Stato e il diritto? Ma proprio
perché ritengo che neanch’egli sia pervenuto fino alla fine del lavoro critico, ma si è
prematuramente arrestato alla forma normativa, invece di penetrare fino alla sua
forma naturale, in cui si ha una relazione trascendentale della coscienza individuale
con una molteplicità immanente di centri di coscienze coordinati, la quale fa parte
ancora della situazione di fatto teorico-reale (seinstheoretischer Tatbestand) della
coscienza — proprio per questo ritengo indispensabile un confronto critico, da parte
marxista, con gl’importanti scritti di logica giuridica di Kelsen. Tuttavia, questo non si
può realizzare nei limiti del presente lavoro. L’acquisizione di quest’altro confronto
critico, comunque, sarà per noi motivo di maggior compiacimento che non il presente.
Poiché mentre nell’attuale polemica siamo costretti nell’essenziale ad atteggiarci
negativamente nei confronti di Kelsen, il quale in questo caso non può agire con il suo
specifico spirito, in quel caso, persino là dove crediamo di non poter fare a meno di
andare al di là della sua concezione del diritto e dello Stato, ci vedremo tuttavia
comunque arricchiti e meglio orientati nel nostro proprio pensiero da una quantità di
luce sull’essenza di questi fenomeni sociali.
In quanto segue si tratterà di un’esposizione della concezione marxista fondamentale
dello Stato e della società. Molteplici esperienze, in discussioni pubbliche e private, mi
hanno insegnato che non è superfluo ripetere ciò che la tendenza che è rappresentata
dalle «Marx-Studien» intende per concezione marxista. Non si tratta dello sforzo
meschino e della polemica zelante su ciò che Marx e Engels a tale pagina dei loro scritti
hanno detto o non hanno detto. Questo ci appare un affare interessante piuttosto solo
e essenzialmente da un punto di vista storico-letterario, come un’occupazione che, dal
punto di vista teorico, non fa fare un passo avanti e che anzi va a parare, con facilità,
nella scolastica. Pertanto, una critica che sostenesse che qualcuna delle teorie qui di
seguito sviluppate non la si trovi espressa in Marx e Engels e che sia tutt’al piú
adlerismo, ma non marxismo, non colpirebbe in generale , il punto di vista della nostra
ricerca, nei limiti in cui non venga insieme dimostrato che questa teoria contraddice i
presupposti fondamentali del pensiero di Marx e Engels. Poiché per noi il marxismo non
è un sistema compiuto, un libro suddiviso in paragrafi, rispetto al quale è possibile solo
un commentario limitato dal testo
Página 6
della legge, ma è una maniera di pensare teorica fondamentale. Essa esige, anzi,
attraverso la sua coerenza interna ci spinge non solo a pensare al di là dei risultati dei
suoi creatori, ma, innanzi tutto, ci spinge a mettere questi risultati stessi, dalla forma
rigida di libro che essi hanno, in quell’unità vivente in cui vengano il piú possibile
superate quelle contraddizioni e quelle incompletezze, che nascono sempre,
necessariamente, quando la totalità del pensiero si riveste della limitatezza e della
frammentazione della comunicazione linguistica. Per questo già nell’articolo
programmatico di queste «Marx-Studien» (vol. I [1904], p. VII) scrivevamo di
considerare nostro còmpito, nello sviluppo ulteriore dei concetti marxisti, «il vedere
non come, in Marx, la lettera abbia avuto sempre ragione, bensí come ottenga e possa
ottenere ragione lo spirito da cui essa è derivata». Mi sembra questa l’unica via per cui
il «marxismo» non significa ciò che i suoi avversari vorrebbero che fosse ritenuto: cioè,
una concezione del mondo di un singolo uomo, sia pure importante, ma significa ciò
per cui lo sosteniamo e lo affermiamo: una nuova tendenza, da non smarrire piú, della
nostra coscienza scientifica.
Nonostante l’attento sforzo non si sono potute evitare, in singoli luoghi del libro, delle
ripetizioni. La complessità dell’oggetto della ricerca comporta il fatto che esso non è
mai oggetto della discussione nel suo insieme, bensí sempre solo con una parte del suo
contenuto. L’inconsueta quantità del contenuto storicamente vivente della società in
generale è possibile dominarla teoricamente solo grazie alla scomposizione
concettuale. In tal modo, però, ciò che fa tutt’uno e che è un insieme viene isolato in
maniera innaturale e resiste, anche concettualmente, a questa violenza, risospingendo
di continuo, anche dal punto di vista concettuale, verso un completamento con ciò che
di volta in volta è rimasto all’esterno dell’astrazione teorica. Non si può parlare di
libertà senza definire il concetto di dominio; non si può parlare di anarchismo senza
discutere il concetto della costrizione statale; non si può parlare di dittatura senza aver
chiaramente riconosciuto quello di rivoluzione. Ma questi concetti esigono anche che li
si metta reciprocamente in relazione l’uno con l’altro e, in ogni capitolo che tratta di
uno di essi, costringono a richiamare o a presupporre i risultati dell’altro. Si hanno cosí
delle ripetizioni, che sono inevitabili poiché fanno parte della cosa. Servono solo a
illustrare le debolezze della comunicazione umana, che deve dire in successione ciò che
si pensa in una volta. Poiché però, proprio nel caso dei concetti qui trattati, tanti non
pensano nulla in generale, può forse essere legittimo consolarsi con la parola magica:
devi per forza dirlo tre volte.
Infine, devo dire che l’ultimo libro di Kelsen: Der soziologische und der juristische
Staatsbegriff (che, del resto, non si occupa piú
Página 7
del marxismo), cosí come uno scritto (che, a quanto pare, si occupa dello stesso tema
di questo libro) di Herbert Sultan: Gesellschaft und Staat bei Karl Marx und Friedrich
Engels, mi sono pervenuti solo durante la correzione delle bozze, per cui non ho potuto
tener conto del loro contenuto.
Vienna, 10 giugno 1922
Página 8 (em branco)
Página 9
MOTTO PER I CRITICI DOTTI DEL MARXISMO
[Dal dialogo fra Dionisodoro e Ctesippo:]
Potremmo forse, replicò, contraddirci discorrendo ambedue della stessa cosa, o, cosí,
senza dubbio, diremmo la medesima cosa?
Fu d’accordo.
Ma se nessuno dei due, proseguí, discorre di una certa cosa, potremmo in tal caso
contraddirci? o, cosí, nessuno di noi due non menzionerebbe neppure la cosa?
Ctesippo fu d’accordo anche in questo.
Ma, forse, ciò avviene quando parlo di una cosa e tu di un’altra? può darsi sia allora
che ci contraddiciamo? oppure quando io parlo d’una cosa e tu non parli affatto? Ma chi
non parla può contraddire chi parla?
Eutidemo, 286 a
[Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari 1966, p. 1027]
Página 10 (em branco)
Página 11
Capitolo primo
Politica e sociologia
Abitualmente la lingua viene conosciuta come un mezzo per comprendersi. Ma la storia
della filosofia e della polemica sui problemi scientifici mostra il contrario. E questo è un
destino, invero da sempre lamentato, ma tuttavia apparentemente del tutto
inevitabile, della storia della cultura (Geistesgeschichte), destino che fa sí che la
discussione di tanti problemi centrali del pensiero duri già dei secoli — si pensi solo alla
polemica sulla libertà del volere — e tuttavia torni sempre a tormentarsi con gli stessi
argomenti, senza fare passi avanti, perché non viene mai raggiunta o anche soltanto
progettata un’intesa sul senso letterale dei concetti, per esempio su quello di volere e
di libertà. Per cui è uno spettacolo triste e allo stesso tempo ridicolo lo scorgere come
tante di queste polemiche senza fine e talvolta assai aspre in fondo sono
semplicemente diverbi, provocati semplicemente dal fatto che le due parti dicono la
stessa parola, ma con essa ciascuna intende qualcosa di diverso.
Da che cosa deriva tuttavia propriamente questo strano fenomeno, doppiamente
strano se lo si ritrova anche presso pensatori che altrimenti emergono per l’acume
particolare del loro spirito e per la coerenza dei loro ragionamenti? Il motivo sta nel
fatto che anche il dotto, sebbene a partire dalla propria esperienza dovrebbe saperlo
meglio, fin troppo spesso dimentica che la lingua ha il suo significato universale — in
cui essa ha cancellato ogni momento personale, ogni colorazione soggettiva —
propriamente soltanto nelle frasi retoriche degli scambi tipici della vita quotidiana, ma
che, al di là di ciò, ciascuno parla la sua propria lingua. E questo vale, proprio per la
lingua del pensatore, in misura tanto maggiore quanto piú egli è un pensatore
originale, cioè creativo. Se quindi ci si accosta alle parole di una teoria semplicemente
come esse si presentano secondo l’uso linguistico corrente, non si sarà mai sicuri di
avere afferrato anche lo spirito da cui sono nate, e l’incomprensione è inevitabile per
quanto si possano addurre magari a faPágina 12
vore della propria opinione numerosissime citazioni, letteralmente, dagli scritti del
pensatore esaminato. Le parole di un pensatore non sono affatto contenuti significativi
fissati come i vocaboli nel dizionario di una lingua. Esse sono un pensiero vivente, delle
funzioni del suo lavoro spirituale, che vogliono suscitare nell’ascoltatore un’altrettale
funzione. Senza questo contatto, francamente, queste parole divengono un semplice
profluvio di termini e, stampate nei libri, divengono semplici concetti del dizionario
della lingua. Ma per comprenderle quest’ultimo non basta affatto, è necessario bensí il
dizionario dello spirito, di cui sono una parte, la comprensione dell’interezza di quel
punto di vista teorico di cui questi concetti si presentano come gli elementi. E questo
tanto piú in quanto il loro senso, anzi, va cercato, in generale, al di là dei significati
correnti letterali. Per esempio, i termini della filosofia kantiana — come quello di cosa e
di fenomeno, di esperienza e di natura — sembrano essere i significati letterali piú
consueti che ci siano; ognuno pronunzia giornalmente innumerevoli volte queste
parole. Ma chi cominciasse a interpretare queste parole, in Kant, partendo dal senso
del dizionario tedesco e non dallo spirito della enciclopedia rivoluzionaria del pensiero
kantiano, dovrebbe necessariamente patire miserevolmente un naufragio [Nota 1].
La stessa cosa vale per i significati delle parole in Marx, il quale ha fondato — ciò che
non sempre viene sufficientemente valutato — per quanto riguarda un pezzo della
nostra esperienza, cioè per quanto riguarda la nostra vita sociale-storica, anche un
modo di pensare che allo stesso tempo rovescia il fondamento e pone un nuovo
fondamento. Per una gran parte dell’opinione pubblica colta Marx è ancora,
essenzialmente, uno studioso di economia politica, sebbene proprio egli si sia sforzato
di superare la limitatezza storica e teorica del punto di vista dell’economia politica. Non
casualmente egli ha intitolato le sue opere principali di economia scritti per la «Critica
dell’economia politica» e ha con ciò espresso il fatto che egli si voleva contrapporre
criticamente a tutta la problePágina 13
matica dell’economia politica e, invero, non con una nuova e ‘migliore’ economia
politica, bensí discoprendo i suoi fondamenti e le sue relazioni sociali. Il significato
specifico del pensiero marxengelsiano si basa assolutamente sul terreno sociologico.
Sia Marx sia Engels erano assolutamente dominati dal problema dell’essenza e della
legalità della vita sociale. È stato innanzi tutto quest’interesse teorico, nato comunque
dall’appassionato interesse pratico di trasformare la società esistente, a conferire al
loro lavoro concettuale la tendenza verso la critica dell’economia politica, e del resto
anche Engels stesso, nelle sue notizie biografiche su sé e su Marx, ha sempre
sottolineato il fatto che la loro teoria fondamentale della società, la concezione
materialistica della storia, era compiuta già prima del Manifesto del partito comunista,
già nel 1845, per cui la teoria economica si presenterebbe soltanto come
un’applicazione della veduta sociologica fondamentale già acquisita [Nota 2]. Se Marx
ed Engels non vengono interpretati come pensatori sociologici, se non si penetra — nel
caso di ognuno dei loro concetti — nel nuovo senso sociologico, che essi hanno fatto
scorrere nel vecchio significato della parola, se si considera anzi questa trasvalutazione
(Umwertung) sociologica completamente e soltanto come un accessorio politico o
addirittura agitatorio, che non appartiene all’altezza scientifica concettuale del
problema, allora non si possono non ‘scoprire’, nel marxismo, una quantità di
contraddizioni e di insensatezze; solo che gli si fa parlare una lingua che non è la sua e
che, anzi, gli è proprio incomprensibile.
Mi sembra esser questo l’errore della ricerca che Hans Kelsen ha compiuto sui
rapporti fra il socialismo e lo Stato nel suo scritto Socialismo e Stato [Nota 3]. L’Autore
chiama il suo lavoro, nel sottotitolo,
Página 14
Una ricerca sulla teoria politica del marxismo e indica con ciò, in maniera abbastanza
precisa, anche i limiti della sua concezione del marxismo. Poiché il significato del
marxismo, che apre nuove vie alla comprensione della politica, significato che ha però
un effetto rivoluzionario anche per la storia del pensiero scientifico in generale,
consiste appunto nel fatto che, dal suo punto di vista, è divenuto impossibile il concetto
di una teoria della politica come sistema sussistente per sé, separato dalla teoria della
vita sociale. Non esiste una ‘teoria politica’ del marxismo, che si possa trattare
indipendentemente dalla sua teoria sociologica. Poiché la politica — cioè la posizione di
fini statali propri e la lotta contro fini statali avversi — per il marxismo è soltanto un
pezzo del processo sociale causale. E il problema della teoria sociologica del marxismo
è appunto quello d’illuminare il suo corso anche secondo tendenze che si estendono nel
futuro seguendone i fattori causali.
Ovviamente Kelsen deve rinunziare proprio a questo problema. Poiché egli interpreta
il marxismo — di cui giustamente sottolinea il fatto che, secondo la sua teoria,
l’ordinamento socialista della società «non è un ideale da perseguire per motivi etici,
ma il prodotto che risulta necessariamente da un processo sociale che scorre in
maniera conforme a leggi» — in modo tale che da questa concezione sarebbe
completamente esclusa la volontà del proletariato, tutti i suoi sforzi e tutti i suoi piani
(p. 2 [10]). Ma, chi proceda in tal modo, non può non precludere a se stesso l’accesso
a una interpretazione non contraddittoria della teoria sociologica fondamentale del
marxismo, della concezione materialistica della storia. In tal caso, comunque, si tratta
di un fraintendimento tipico di questa teoria, derivato dalla sua denominazione di
concezione ‘materialistica’ della storia e dalla sua tendenza a definire anche lo sviluppo
sociale come sviluppo naturalisticamente necessario. In ciò si trascura sempre il fatto
che tanto Marx quanto Engels hanno distinto nella maniera piú rigida il loro
materialismo da quello delle scienze naturali, la loro ‘natura’ dalla natura priva di
coscienza e volontà dei processi fisico-chimici [Nota 4]. La natura di cui Marx ed Engels
parlano è la natura sociale dell’uomo, cioè quindi la natura umana quale è possibile
solo in forma socializzata, la natura della socializzazione. E, con ciò, la volontà e gli
sforzi umani, i giudizi pensanti, conformi allo scopo e etici, sono posti, una volta per
tutte,
Página 15
nello specifico legame della socializzazione, come una componente integrante della
natura. Anzi, la natura sociale consiste, in generale, solo in questo atteggiamento che
valuta attivamente degli uomini socializzati. Per questo già nelle sue geniali tesi su
Feuerbach, in cui abbozzò per cosí dire il compendio concettuale della sua teoria, Marx
scrisse le parole che dovevano alla fine rendere impossibile lo spiacevole
fraintendimento del ‘materialismo’ e del ‘naturalismo’ marxista:
Il difetto principale d’ogni materialismo fino ad oggi — compreso quello di Feuerbach
— è che l’oggetto (Gegenstand), la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la
forma dell’obietto (Objekt) o della intuizione; ma non come attività sensibile umana,
prassi; non soggettivamente. Di conseguenza è accaduto che il lato attivo, in
contrapposto al materialismo, fu sviluppato dall’idealismo: ma astrattamente, poiché
naturalmente l’idealismo non conosce l’attività reale, sensibile in quanto tale [Nota 5].
Comprendere questo lato attivo della natura, inserirlo nella conoscenza causale,
comprendere l’esistenza naturale della società umana come un processo di «prassi
rovesciante»: è questo il problema specifico del marxismo, che Marx ed Engels
perseguono dall’inizio della loro autonoma riflessione con tutta la passione di una
inflessibile volontà di pensatori. Già negli «Annali franco-tedeschi» Marx aveva
formulato in maniera classica il rapporto dell’elemento volontaristico con quello causale
nella sua teoria, cosí scrivendo:
Allora non affronteremo il mondo in modo dottrinario, con un nuovo principio: qui è la
verità, qui inginocchiati! Noi illustreremo al mondo nuovi principi, traendoli dai princìpi
del mondo. Noi non gli diciamo: abbandona le tue lotte, sono sciocchezze; noi ti
grideremo la vera parola d’ordine della lotta. Noi gli mostreremo soltanto perché
effettivamente combatte, poiché la coscienza è una cosa che esso deve far propria,
anche se non lo vuole [Nota 6].
Pertanto, si tratta soltanto di rendere consapevole l’intero processo storico, che nella
sua forma volontaristica e valutativa, nei suoi ‘principi’ spirituali, non solo rimane
intatto, ma proprio in questi viene compreso, di renderlo consapevole di se stesso,
nella sua determinatezza causale, a partire «dai princípi del mondo», cioè nella sua
condizionatezza sociologica. Ché la coscienza, di cui qui Marx parla, non è nient’altro
che il fatto di destare il mondo dai sogni su se stesso, nient’altro che il fatto «che gli si
spiegano
Página 16
le sue proprie azioni». E alla stessa maniera di Marx scrive il giovane Engels nella sua
prima lettera a Marx:
Finché non ci saranno un paio di scritti nei quali, sul piano logico e storico, i princìpi
siano sviluppati in quanto necessaria prosecuzione del modo passato di vedere le cose
e della gloria passata, tutto si ridurrà a una specie di dormiveglia e i piú continueranno
a brancolare nel buio. [Nota 7]
Concordando completamente con questo punto di vista degli scritti giovanili il
Manifesto del partito comunista esprime poi i medesimi concetti già nel linguaggio della
concezione materialistica della storia, quando dice:
Le posizioni teoriche dei comunisti non poggiano affatto sopra idee, sopra princìpi che
siano stati inventati o scoperti da questo o quel rinnovatore del mondo. Esse sono
soltanto espressioni generali dei rapporti effettivi di una lotta di classe che già esiste,
di un movimento storico che si svolge sotto i nostri occhi. [Nota 8]
E, pervenuto alla maturità del suo lavoro scientifico, Marx ripete ancora le stesse
vedute sociologiche fondamentali circa il rapporto fra politica e conoscenza sociale
nella frase calunniata perché per lo piú ancora incompresa: «La classe operaia non ha
da realizzare degli ideali, ma da liberare gli elementi della nuova società, che si sono
già sviluppati nel seno della società borghese che sta crollando» [Nota 9]. ‘ ’
Il punto di vista sociologico del marxismo significa quindi l’unità di teoria e prassi, di
scienza e politica, nel senso che esso scorge anche nella politica — nella ‘coscienza’
politica degli uomini — un pezzo del processo sociale stesso, di fronte a cui la
conoscenza causale non deve improvvisamente interrompersi. Naturalmente, il politico,
in quanto uomo di volontà e d’azione, sta del tutto nell’àmbito di un comportamento
che pone fini, fa scelte e riflette, e in cui per la sua coscienza non è dato trovare
neanche un atomo di «necessità naturale». La sfera del volere è appunto una sfera del
tutto diversa da quella dell’indagine pensante su questo volere, e la causalità è
completamente e soltanto una categoria di quest’ultimo modo di considerare, è una
categoria della conoscenza dei processi della volontà, ma non dell’attività del volere
stesso [Nota 10]. Il
Página 17
rapporto fra scienza e politica nel marxismo non va inteso nel senso che il politico
marxista cerca di sperimentare innanzi tutto a partire dalla scienza ciò che
necessariamente accadrà, per poi indirizzare in base a ciò il suo atteggiamento.
Piuttosto, questo era quel concetto di scienza sociale che era proprio degli utopisti, che
volevano fare della scienza una sorta di ricettario per l’attività social-rivoluzionaria. Per
il marxismo scienza e politica rimangono due modi di atteggiarsi che stanno in settori
completamente diversi della vita: la prima è la considerazione pensante dei processi
storici, la seconda la configurazione diretta dei medesimi. Ma quest’ultima non cessa
nel suo significato attuale, anzi neanche nel suo significato futuro, di essere oggetto
della prima. Cioè: le volontà e i progetti delle classi e dei loro gruppi e capi, il
perseguimento di scopi e il giudizio etico, che è direttamente attivo nella storia che
procede, rientra comunque, in quanto fattore causale, nella considerazione pensante di
questo processo in movimento e si produce, quando si abbia un’analisi
sufficientemente penetrante, in anticipo per il futuro, perlomeno nelle decisive
tendenze fondamentali. Qui, ove discutiamo il punto di vista di principio del marxismo,
non si tratta affatto di questo, se questa previsione è molto o poco realizzabile, ma si
tratta di questo punto di vista teorico stesso, a partire dal quale la politica non è altro
che la stessa legalità causale della società vissuta nella sfera della volontà. E solo cosí
è possibile, ma ora anche necessario, il fatto che i princípi della conoscenza — come
diceva Engels — siano semplicemente la continuazione necessaria della storia stessa.
Ciò che sul terreno della società è «naturalisticamente necessario», quindi, deve
sempre essere ripensato, voluto, valutato e approvato dall’uomo; tutto ciò che nella
storia dev’essere attivo non può non passare — come ripetutamente ha detto Engels —
«attraverso la testa dell’uomo». Gli uomini, dice ancora Engels, fanno da sé la loro
storia [Nota 11]. E noi aggiungiamo: soltanto gli uomini; nessuno, neanche ‘lo sviluppo
economico’, la fa per essi. Neanche i
Página 18
marxisti ‘piú dogmatici’ hanno mai intes altrimenti la ‘necessità naturalistica’ del
processo economico. Cosí, nel suo libro Il programma di Erfurt, che egli stesso
definisce un «catechismo della socialdemocrazia», Karl Kautsky scrive:
Se si parla dell’inarrestabilità e necessità dello sviluppo sociale si presuppone
naturalmente che gli uomini siano uomini e non delle vuote marionette; gli uomini con
determinate esigenze e passioni, con determinate energie fisiche e spirituali, che essi
cercano di utilizzare nel modo migliore. Arrendersi passivamente a ciò che appare
inevitabile non significa far seguire il proprio corso allo sviluppo economico, quanto
piuttosto arrestarlo. [Nota 12]
Gli uomini, pertanto, dovranno sempre considerarsi come realizzatori delle loro azioni
e come tali dovranno valutarsi, ammirarsi e combattersi. E la storia sarà sempre una
lotta fra idee, un contrasto per realizzare degli ideali, anzi, diventerà questo in maggior
misura quanto piú gli uomini saranno condotti dal loro sviluppo sociale a una piú
grande spiritualità. Ma non appena essi non soltanto conducono questa lotta ideale, ma
cercano insieme d’interpretare pensando; non appena, quindi, per cosí dire, si
sollevano con un salto dal settore di colui che lotta a quello di chi prende in
considerazione — il che, come dimostrano Marx e Engels, è possibile nella lotta piú
violenta, certo grazie a un grande sforzo del pensiero — allora tutto lo Sturm und
Drang delle anime, anzi tutte le proprie valutazioni e il perseguimento dei propri fini,
appaiono come altrettanti elementi causali dell’evento, che ora devono essere inseriti e
compresi nella serie dell’ordinamento, ad essi propria, della necessità causale. Cosí il
politico marxista giunge poi a considerare anche la sua volontà appassionata solo come
il compimento di necessità sociali, la cui comprensione teorica certo non gli dà dei fini,
ma glieli illumina e gliene facilita il perseguimento [Nota 13].
Página 19
I fini e le valutazioni dell’evento politico, quindi, non nascono dal marxismo, dalla
scienza, bensí solo dall’intreccio del processo sociale stesso. Non sono il prodotto, ma
l’oggetto della ricerca scientifica. E solo entro questi limiti è giusto, ma anche decisivo,
il fatto che la comprensione teorica acquistata del processo genetico-causale
dell’evento sociale deve divenire sempre piú addirittura un momento causale di questo
evento, quanto piú essa domina il giudizio, le valutazioni e le azioni dell’uomo [Nota
14].
Come a una tale concezione, che si fonda proprio sulla rigida distinzione fra giudizio e
apprezzamento, fra conoscenza e valutazione, si possa rimproverare — come fa Kelsen
(pp. 2-3 [10-11] ) — la una «strana mescolanza fra un punto di vista teoricoesplicativo e uno pratico-politico», mi è incomprensibile. Questo rimprovero disconosce
piuttosto proprio la problematica della sociologia in generale che, per principio, dal
“Savoir pour prévoir” di Saint-Simon, non può rinunziare a seguire la causalità sociale
anche nel futuro; solo che è stato il marxismo per primo a scoprire la dinamica della
vita sociale che accenna al futuro. Pertanto, fallisce anche l’altro rimprovero che Kelsen
fa al marxismo:
È un tragico sincretismo metodologico, è la piú radicale confusione dei limiti fra realtà
e valore, se il politico, al problema circa ciò che egli deve fare, circa lo scopo del suo
tendere, si acquieta con una risposta che è data semplicemente alla scienza
esplicativa, al suo problema circa l’essere e il divenire (p. 3 [10-11]).
Ma neanche questo fa il politico marxista, bensí egli agisce muovendo dall’interesse di
classe del proletariato, cioè muovendo dall’essere, e soltanto questo costituisce per lui
il programma del suo volere e del suo agire, gli pone il suo dovere; solo che la
conoscenza dell’essenza, dell’importanza e della funzione storica della opposizione di
classe e della lotta di classe determina la sua volontà stessa maniera completamente
diversa che il semplice e istintivo contrasto di classe della massa incolta. Egli, quindi,
certamente, di fronte al problema circa ciò che egli deve fare, non si accontenta con la
risposta della scienza circa ciò che è o accade. Giustamente Kelsen afferma che al
problema circa il giusto fine dell’agire non si può mai rispondere con la conoscenza di
ciò che necessariamente accadrà (ibid.). Ma, dalla risposta della scienza, il marxista
ricava rassicurazione che «il programma del suo volere e del suo agire» sta nella
direzione dello sviluppo necessario del processo soPágina 20
ciale, cioè, che i motivi delle sue valutazioni e dei suoi fini sono tali che devono essere
realizzati politicamente dal processo causale dell’evento sociale in misura sempre piú
grande e con sempre maggiore chiarezza. Certo, la posizione di fini giusta è, in sé,
qualcosa di diverso rispetto a quella causalmente necessaria; ma questa è una
distinzione, che vale soltanto per la coscienza direttamente volente. Per la
considerazione causale anche la giusta posizione di fini è soltanto un processo causale
e un oggetto scientifico come ogni altro. Il problema di quali decisioni dovranno
maturare, come decisioni giuste, in determinate situazioni sociali di ogni classe e di
ogni gruppo di classi, è del tutto legittimo sul terreno dell’indagine causale ed è una
ricerca da portare a termine unicamente all’interno del suo metodo, certo, dopo che
essa abbia assunto in sé, come momento causale, il concetto del valutare. Ma non
soltanto essa può, bensí essa deve necessariamente inserire le valutazioni dell’agire
nel nesso causale; poiché, anzi, la causalità sociale scorre soltanto attraverso la
coscienza, cioè attraverso la determinatezza di direzione della volontà, che valuta,
pone o rifiuta fini, definisce come giusti o sbagliati degli scopi [Nota 15]. Dalla
causalità, certo, non deriva mai la legittimazione di uno scopo; ma questa
legittimazione, in quanto forma necessaria in cui scorre ogni motivazione — poiché
l’uomo riconosce sempre qualcosa con la sua volontà o lo disapprova, lo rigetta —
diviene elemento dell’evento sociale solo grazie alla causalità. Se, dunque, per il
marxismo si tratta di mostrare come un determinato fine debba nascere «in maniera
naturalistica necessaria» nella storia, in ciò è sempre incluso, come fattore causale,
l’uomo che valuta, e che ritiene anche giusto questo fine. Si potrebbe pertanto definire
anche la concezione materialistica della storia come la teoria della motivazione
sociologica delle valutazioni, ed è anzi questo il senso di quel concetto fondamenale,
molto calunniato ma poco compreso, per cui l’ideologia, cioè le valutazioni morali,
religiose, artistiche ecc., costituiscono una sovrastruttura sulla base economica.
Si ha quindi un necessario intreccio della determinatezza normativa della direzione
con la causalità dell’evento, in quanto la prima è la forma, in cui la seconda è in
generale possibile nell’àmbito della coscienza. E sta qui, da ultimo, la spiegazione della
rappresentazione del marxismo circa la necessità naturalistica di uno sviluppo
progressivo del processo sociale, che cosí spesso è stato indicato come utopismo o
come dogmatismo acritico. Poiché ora si scorge chiaramente quanto ci si lasci sfuggire
l’essenza di ciò che il marxismo ha riconosciuto come necessità sociale qualora si
ritenga, con Kelsen, che sia un caso
Página 21
se il fine posto dal punto di vista della valutazione etica e politica coincide del tutto,
contenutisticamente, con il resultato, assunto in quanto causalmente determinato, dal
punto di vista della conoscenza della realtà, di uno sviluppo necessario in futuro (p. 3 [
11] ).
Certamente, qualora s’intenda per realtà, in senso marxista, un processo puramente
meccanico, un processo economico despiritualizzato nel senso piú vero della parola.
Ma, come abbiamo visto, di questa conoscenza della realtà fanno parte, naturalmente
e necessariamente, anche i valori etici e politici, che determinano causalmente — cioè
realizzano — il loro risultato solo grazie al fatto che agiscono nella storia come fattori
causali. E poiché una conoscenza causale del processo sociale mostra che certi valori
etici e certi fini vengono motivati in misura sempre maggiore da determinate
circostanze sociali di vita, devono ottenere una forza sociale sempre maggiore, la
tendenza del processo causale che concorda con l’ideale si produce, da ultimo, non piú
come un caso, e neanche come una costruzione da filosofia della storia, bensí come un
rapporto genetico-causale. Ma proprio questa è la funzione della concezione
materialistica della storia grazie al suo concetto di un movimento della storia in
opposizioni e in lotte di classe. Poiché nel concetto di coscienza di classe e di lotta di
classe è immanente il concetto di valutazione etica, senza di cui nessuna classe
montante ha finora potuto porre e perseguire i suoi fini. Nella lotta di classe, non
appena è divenuta consapevole, viene sempre portata a termine anche una lotta del
diritto e della morale. Ma queste posizioni di fini morali si producono, per il punto di
vista della teoria sociologica, in maniera causale a partire dalle situazioni della vita
economica delle relative classi, quasi come un prodotto automatico del meccanismo
sociale. La conoscenza della «necessità naturalistica» del processo culturale, della
vittoria del socialismo, si fonda sulla necessità causale della nascita di valutazioni
morali sempre piú numerose contro il capitalismo, causate in ultima analisi dal
processo economico del sistema dell’economia capitalistica. L’idea di progresso è
divenuta per la prima volta nel marxismo, da semplice credenza, com’è ancora in Kant,
una tendenza certa dell’evento causale stesso [Nota 16].
Stanno dunque cosí le cose per quanto riguarda quell’opinabile, tragico «sincretismo
metodologico» e per quella «strana mescolanza fra un punto di vista teorico-esplicativo
e uno pratico-poPágina 22
litico», che Kelsen rimprovera al marxismo. Non solo non esiste alcuna traccia di tutto
ciò, ma al contrario: il marxismo si fonda appunto sulla piú rigorosa distinzione
concettuale della storia come processo sociale dell’evento e come volontà e azione
politiche. Solo che esso non rinunzia a comprendere teoricamente queste ultime
insieme come un pezzo del primo, e realizza ciò grazie al suo concetto fondamentale
dell’uomo socializzato, il quale, in quanto soggetto motivato attraverso la
socializzazione e attivo a partire da essa, è il fattore causale creativo, «rovesciante»,
della concezione materialistica della storia. «La vita sociale», si legge nelle già citate
tesi su Feuerbach, «è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che sviano la teoria verso
il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella
comprensione di questa prassi» [Nota 17]. Fa parte di questa comprensione della
prassi umana, di questa disposizione teorica del marxismo, il fatto che anche i
«misteri» della prassi politica vengono tolti dalla loro apparente autonomia e vengono
risolti nel rapporto della prassi umana in generale, cioè vengono esposti come elementi
della socializzazione attiva dell’uomo. Nel marxismo, anche i concetti politici, come
quelli economici, vengono ripensati in categorie sociologico-storiche, di modo che,
come dicevamo all’inizio, non vi può essere una teoria politica autonoma del marxismo.
Piuttosto, ogni concezione, che si offra come una tale teoria politica autonoma, diviene
immediatamente dal punto di vista marxista addirittura un problema da risolvere per la
sua critica sociologica e per la sua spiegazione causale, come per esempio la teoria del
liberalismo o quella scienza statale, oggi cosí amata, à la Adam Müller. Piú avanti,
discutendo la critica kelseniana di ciò che egli chiama la teoria politica del marxismo,
vedremo nel particolare e con tutta chiarezza a quali inevitabili fraintendimenti della
concezione marxiana fondamentale dello Stato e della società deve necessariamente
condurre il non scorgere il carattere sociologico anche del pensiero ‘politico’ di Marx e
Engels.
Página 23
Capitolo secondo
L’unità sociologica di Stato e società
La concezione fondamentale, cui riconduce tutto ciò che Marx ed Engels hanno esposto
da un punto di vista teorico sullo Stato e la politica, è quella sociologica. Si tratta
pertanto di comprendere lo Stato come un fenomeno della vita sociale e d’intendere la
sua nascita e le sue trasformazioni come un pezzo del processo causale. Che questo
sia assolutamente possibile da un punto di vista metodologico lo può contestare solo
chi, per principio, neghi che il concetto della vita sociale sia possibile come concetto
naturalistico (Naturbegriff) e che il concetto di società possa essere pensato come un
concetto di essere. Quindi, chi, per esempio, come Rudolf Stammler, sia dell’avviso che
il concetto della vita sociale e, quindi, quello della società, sia possibile pensarlo solo in
quanto concetto normativo — e che, pertanto, la società significhi solo una relazione
normativa fra gli uomini, e non una relazione di essere — non potrà non scorgere, fin
dall’inizio, nel concetto di una sociologia come scienza causale l’errore fondamentale
del marxismo e della sociologia moderna in generale. Fortunatamente, però, questa
riflessione critica non è fondata, ma si basa essa stessa sul fatto che il punto di vista
critico-gnoseologico non viene seguito in maniera sufficientemente critica. Non si tratta
qui d’esporre ciò in dettaglio e rinvio semplicemente al luogo in cui ho tentato di far ciò
[Nota 1]. Come
Página 24
risultato si è avuto il fatto che l’elemento sociale non è fondato nel rapporto di
successione degli atti di volontà sotto l’idea del dovere, bensí ha il suo fondamento già
precedentemente nell’essere della coscienza, non essendo possibile alcun atto di
conoscenza, alcun atto di pensiero senza una relazione inerente di ogni soggetto della
conoscenza a una molteplicità indeterminata di altri soggetti, grazie alla quale il
proprio modo di pensare e il proprio contenuto di pensiero dev’essere necessariamente
concepito come possesso ugualmente possibile di ogni altra coscienza. In tal modo
l’elemento sociale è già, per l’esperienza umana, tanto trascendentale quanto lo sono
le condizioni della coscienza del resto finora riconosciute come trascendentali. L’uomo,
già prima di ogni socializzazione storico-economica, è socializzato nel suo essere
spirituale, nella sua coscienza teorica. Ed egli trova nel processo storico-sociale
soltanto sviluppato ciò che egli è già in sé nel suo soggetto trascendentale:
l’insuperabile relazionalità ad altri soggetti, uguali per essenza, e l’unificazione (InEinsetzung) con essi.
È questo, dunque, il fondamento critico-gnoseologico — qui ovviamente solo
accennato e non fondato — in base a cui l’elemento sociale si presenta come un pezzo
di relazioni di essere fra gli uomini — non diversamente dallo spazio, dal tempo e dalla
detenninatezza categorica — cioè come un pezzo di natura, senza che perciò (è questo
il pericoloso fraintendimento che gli avversari ne fanno seguire sempre falsamente) ne
debba derivare un pezzo di naturalismo. Poiché l’elemento sociale non è, appunto,
essere semplicemente, bensí essere sociale, allo stesso modo in cui, anzi, la natura in
generale non è — secondo un’opinione comunque ancora molto diffusa e che purtroppo
si trova proprio fra i critici del ‘naturalismo’ — semplicemente soltanto natura ed
assolutamente dello stesso genere. Al contrario, occorre rinviare al fatto che la legalità
naturale, nelle forme della natura meccanica, fisica, chimica organica e spirituale,
indica una progressiva complicazione dell’essere, e fra di esse sussistono certo delle
dipendenze fondate su una legalità naturalistica, che però non sono assolutamente
deducibili l’una dall’altra. La riduzione di tutte queste forme all’unica forma della
meccanica fa parte piuttosto di quei falsi problemi acritici dell’epoca metafisica della
scienza della natura [Nota 2].
Punto di partenza del marxismo è dunque il concetto di società come essere ed
evento sociale, che rende fin dall’inizio impossibili gli uomini come essenze isolate, ma
li mostra piuttosto come esPágina 25
enze reciprocamente riferite, cioè non semplicemente come essenze sociali, bensí
come essenze socializzate. Il punto di vista della nuova concezione, si legge in Marx
già nella nona e nella decima tesi su Feuerbach, non è piú: i singoli individui nella
società civile, bensí: «la società umana ovvero l’umanità socializzata» [Nota 3]. Nella
società non si entra, essa non è fondata per mezzo di un patto, né viene prodotta per
mezzo della socievolezza e della simpatia, né viene forzatamente costituita per mezzo
di un impulso sociale, bensí è posta storicamente-economicamente con gli uomini, allo
stesso modo in cui essa è data trascendentalmente con la coscienza. Per questo Marx
introduce questo concetto di società allo stesso tempo come componente ineliminabile
del concetto dell’esistenza degli uomini in generale proprio all’inizio dei suoi famosi
abbozzi della concezione materialistica della storia, nel citatissimo brano, nella
seguente maniera:
Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti
determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che
corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali.
L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della
società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e
alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. [Nota 4]
La società è, dunque, un fatto originario, una relazionalità orinaria degli uomini l’uno
con l’altro per mezzo della loro attività produttiva, che è possibile solo in questa
relazionalità, e cosí società e produzione divengono,soper il marxismo, concetti
scambievoli.
Ambedue sono, comunque, in quanto concetti, delle astrazioni, ma, per riprendere
l’espressione usata una volta da Marx, delle astrazioni che hanno un senso, a patto che
ci si guardi dal far oltrepassare ad esse i loro limiti e dal farle diventare delle
ipostatizzazioni: «La produzione in generale è un’astrazione, ma un’astrazione che ha
un senso, in quanto mette effettivamente in rilievo l’elemento comune, lo fissa e ci
risparmia una ripetizione» [Nota 5]. Essa diviene incomprensibile soltanto quando si
perde di vista il fatto che, in questa generalità, si sviluppa una molteplicità storica di
forme, che invero riconduce dappertutto a quelle condizioni generali della produzione,
ma non può essere spiegata solo a partire da queste:
Página 26
Esistono delle determinazioni comuni a tutti gli stadi della produzione, che vengono
fissate dal pensiero come generali; ma le cosiddette condizioni generali di ogni
produzione non sono altro che questi momenti astratti con i quali non viene spiegato
alcuno stadio storico concreto della produzione. [Nota 6].
Il concetto generale di produzione e altrettanto quello di società, pertanto, hanno solo
la funzione di determinare la direzione, in cu il pensiero sociologico in generale deve
comprendere e elaborare il suo oggetto. Ogni fenomeno sociale va inteso come un
pezzo della socializzazione in generale, cioè della produzione sociale. Ma questa non è
mai «produzione in generale», allo stesso modo in cui non esiste «coscienza sociale in
generale». «Bensí è sempre un determinato organismo sociale, un soggetto sociale che
agisce entro una totalità, piú o meno considerevole, di rami di produzione» [Nota 7], vi
è sempre un livello storicamente determinato della produzione e, quindi, delle forme di
coscienza economiche e ideologiche, in cui la ‘società’ e la ‘produzione’ sono effettive.
Ad ognuno di questi livelli della produzione corrisponde dunque un determinato
ordinamento della vita sociale, o, per meglio dire: è un tale determinato ordinamento,
che viene vissuto nelle forme specifiche della coscienza sociale, una delle quali si
sviluppa come forma particolare della coscienza giuridica [Nota 8].
Ora, lo Stato, nelle sue diverse configurazioni — come Stato patriarcale, feudale,
assolutistico, costituzionale e parlamentare — a sua volta è soltanto una modificazione
di questa sovrastruttura giuridica in determinate condizioni storiche. Cioè: il marxismo
scorge nello Stato una forma di manifestazione storica della società. Società e Stato,
per i marxisti, non sono due cose diverse, in particolare, non stanno in opposizione
reciproca. Ciò che abitualmente si presenta come tale opposizione e che anche viene
cosí indicato in un modo di esprimersi non pregnante, è la contraddizione fra
Página 27
il livello raggiunto nello sviluppo delle forze produttive sociali e le forme della loro
applicazione protette dall’ordinamento statale. Ma questa contraddizione deriva
appunto dal fatto che società e Satato non sono due essenzialità (Wesenheiten)
diverse, bensí dal fatto che in condizioni del tutto determinate, che si sono realizzate
nella storia, la società esiste appunto soltanto nella forma dello Stato. Quando pertanto
Kelsen (a pag. 8 del suo saggio) scrive: «Un presupposto essenziale per il concetto di
Stato è la sua chiara delimitazione rispetto a quello di società», si esprime in ciò già il
suo punto di partenza del tutto diverso da quello del marxismo, il quale — sia legittimo
o meno — non può non farlo fallire di fronte alla caratteristica dei concetti marxisti e
non può non rendergli impossibile ogni critica effettiva dei medesimi. Poiché una critica
è possibile soltanto sullo stesso fondamento di cui fanno parte i concetti criticati;
altrimenti, al posto della critica di un punto di vista si ha un altro punto di vista, e in tal
caso dovrebbe in anticipo essere decisa la questione su quale sia il punto di vista
giusto, anzi, se sia opportuna una tale disputa. Poiché vi sono anche dei punti di vista,
che possono valere l’uno accanto all’altro non appena si sia riconosciuto che invero essi
si escludono, ma considerano due lati diversi di una cosa, e pertanto ognuno rinunzia a
correggere l’altro dal suo punto di vista.
Si può quindi far valere l’esigenza di una delimitazione del concetto di Stato rispetto a
quello di società solo quando si abbia già una concezione in cui Stato e società
vengano sentiti come qualcosa di diverso, perché — come fa Kelsen — si scorge nella
società il concetto causale dell’unificazione degli uomini sotto qualsivoglia spinta della
necessità, dell’abitudine, dell’inclinazione, dell’interesse ecc., mentre si scorge nello
Stato il concetto normativo dell’ordinamento di questa convivenza. Se invece lo Stato
viene concepito fin dall’inizio solo come un pezzo di società; se non trova posto, nel
pensiero, in generale, alcuna divisione di principio e concettuale fra Stato e società,
non nascerà poi alcun bisogno di una «chiara delimitazione» fra Stato e società. Al
contrario, nasce ora addirittura il bisogno teorico di superare questa delimitazione e di
dissolvere la sua ‘chiarezza’ — la separazione di Stato e società — come un’apparenza
ingannevole. È proprio questa — come vedremo — la prestazione specifica del
marxismo ed è questo l’elemento unitario, nella sua elaborazione critico-sociale, non
solo dei concetti economici, ma anche di quelli politici. Proprio come Marx ha dissolto il
feticismo della merce, cioè l’apparenza ingannevole di una vitalità e di un’autonomia
che aderisce alla merce stessa di contro all’uomo, cosí ha dissolto anche il feticismo
dello Stato, cioè l’autonomizzazione della personalità dello Stato di contro alla società.
Página 28
Capitolo terzo
Per lo sviluppo del concetto di società
La separazione dei concetti di Stato e società rappresenta soltanto una prima fase del
processo dello sviluppo del concetto di società stesso e vi ha avuto, storicamente, un
diverso significato. Il primo grande avvio alla costituzione del concetto di società è dato
dal diritto naturale e, in esso, diritto positivo e diritto razionale, lo Stato e l’umanità
(che era soltanto un’altra espressione per dire società), si separano come realtà e
ideale. Qui, dunque, non sussiste alcuna vera e propria contrapposizione fra Stato e
società, bensí soltanto una distanza infinita, che tuttavia è possibile superare grazie
alla sempre maggiore realizzazione delle istanze del diritto naturale nel processo
storico; e da qui si produce l’idea di un progresso dello Stato verso una sempre
maggiore libertà e umanità, cioè verso una sempre maggiore socialità. La
contrapposizione di Stato e società si presenta per la prima volta in Hegel e, per
questa nuova concezione, era decisivo un potente evento storico, che ha agito in
maniera rivoluzionaria sia per il pensiero sociologico in generale sia per la vita statale:
la rivoluzione francese. E questo effetto si è collegato non tanto alla sua azione positiva
stessa, quanto piuttosto alla temibile disillusione che ha lasciato proprio in pensatori
profondi e critici.
La rivoluzione francese avrebbe dovuto portare la realizzazione del diritto razionale
della teoria del diritto naturale; libertà, uguaglianza e fratellanza erano le sue
illuminanti istanze ed esse infiammavano molto al di là dei confini della Francia. Ed
esse dovevano essere realizzate attraverso l’eliminazione dei privilegi di ogni sorta, che
rendevano impossibile la libertà e l’uguaglianza degli uomini nello Stato, attraverso
l’abbattimento dei ceti. Finora il ceto — con la sua regolamentazione legale dei diritti e
dei doveri ad esso collegati e con il conferimento di privilegi legali a certi gruppi
d’interesse — era stato il principio che aveva dato l’ordinamento alla vita statale e
insieme a quella sociale. Adesso cadevano i diritti di
Página 29
ceto e, con ciò, anche i privilegi — vi erano soltanto cittadini, che erano tutti uguali di
fronte alla legge —, perlomeno nel senso iniziale della rivoluzione, che non sapeva
ancora nulla del diritto elettorale legato al censo; ma l’uguaglianza e, ancora meno, la
libertà e la fratellanza, non erano ancora state raggiunte. I ceti erano stati aboliti ma
ora si presentava, tutt’in una volta, un nuovo potente elemento di disuguaglianza e
d’illibertà nello Stato, che, fino ad ora, era stato celato dall’esistenza dei ceti: cioè, le
classi. Diveniva con ciò visibile un elemento di differenziazione che si prendeva gioco di
ogni livellamento giuridico, anzi, era per questo incomprensibile. Poiché proprio sulla
base dell’uguaglianza giuridica di principio emergeva per la prima volta questo
elemento di differenziazione, nella disuguaglianza di un fatto — nella disuguaglianza
del possesso — che non poteva essere costituito, ma quindi non poteva neanche
essere eliminato, dai principi giuridici. Il possesso, anzi, appariva soltanto come
l’esercizio di un diritto, che proprio grazie al principio dell’uguale tutela dei diritti era
ora santificato e garantito per tutti. Ma, all’interno di questo diritto al possesso
santificato si palesò il fatto che non per tutti vi era un possesso uguale da difendere e
che, per la maggior parte, non v’era quasi nulla da difendere.
Ma, d’altra parte, questa quantità di possesso si presentava come il frutto del lavoro e
del merito individuale o anche, soltanto, della fortuna, anzi addirittura dell’abuso
individuali; e, allo stesso tempo, veniva alla luce l’immenso potere dell’interesse
individuale a mantenere comunque per sé questo possesso e, se possibile, accrescerlo.
Ora, i singoli erano per un certo tempo tanto unificati nello Stato quanto l’uno all’altro
contrapposti, in generale, però, erano posti in un tale rapporto l’uno con l’altro e in una
tale relazione totale che ora, per la prima volta, lo Stato si elevò ad una vita autonoma
e egoista. Nacque da qui la comprensione di un altro legame fra gli uomini oltre a
quello fondato dalle relazioni giuridiche. Al contrario, si produsse ora un legame fra gli
uomini, che, apparentemente, all’interno di quello statale stava per sé e il cui
significato naturale, per quanto fosse compreso dallo Stato anche in forma giuridica,
non consisteva affatto in questa forma giuridica, bensí nel suo contenuto rivolto
all’interesse egoistico, economico, alla soddisfazione degli interessi di possesso. E
questa nuova comprensione, in quanto conoscenza di un rapporto sociale, fu
contrapposta al rapporto statale. È innanzitutto a Hegel che va ricondotta questa
formazione concettuale che continua ad agire anche nel presente [Nota 1].
Página 30
Per intendere bene questo concetto di società e per capire come sia divenuto
possibile il suo antagonismo rispetto allo Stato, anzi come sia divenuto necessario,
occorre tener presente — il che per lo piú viene tralasciato — che il concetto di società
in Hegel non è il concetto generale della vita sociale in generale, che oggi colleghiamo
con la parola società e che egli non conosceva ancora, bensí è quello della «società
civile». Esso viene sempre trattato, in Hegel, sotto questa espressa definizione. In
Hegel, pertanto, non abbiamo a che fare con un concetto generale-teorico, bensí con
un concetto storico di società. In essa egli descrive l’essenza dell’egoismo economico
che si sviluppa liberamente, dell’economia capitalistica e dello spirito bourgeois, di cui
— in quanto sistema dell’atomismo sociale — egli aveva abbozzato alcuni splendidi
tratti caratteristici psicologici già nei suoi scritti giovanili, in particolare nel saggio Le
maniere di trattare scientificamente il diritto naturale [Nota 2]. Per questo sistema
dell’atomismo sociale egli aveva coniato, nella Fenomenologia, l’espressione,
estremamente significativa, di «regno animale dello spirito», poiché in esso si sviluppa
l’intreccio di essenze che, come gli animali, pensano solo a sé, si sviluppa
«l’individualità che è a se stessa reale in sé e per se stessa» [Nota 3]. Per questo nella
Filosofia del diritto, nell’Aggiunta al § 182, si legge anche:
La società civile è il divario (Differenz) che si presenta tra la famiglia e lo Stato, se
anche lo sviluppo di essa segue piú tardi di quello dello Stato; poiché, in questo
divario, presuppone lo Stato, che essa deve avere presente come un che di autonomo,
per esistere. Del resto,
Página 31
la scoperta della società civile appartiene al mondo moderno, che assegna per la prima
volta il loro diritto a tutte le determinazioni dell’idea [Nota 4].
Quindi, in Hegel, ciò che si contrappone allo Stato non è la società in generale, bensí
la società civile, che egli considera come un livello di sviluppo nel dispiegamento dello
spirito oggettivo verso la forma piú alta dell’eticità, verso lo Stato. In ciò, essa è un
tale livello di sviluppo che, presa per sé, significa la negazione dell’eticità. Si deve qui
tener presente la forma hegeliana dello sviluppo di tesi, antitesi e sintesi, che non
significa affatto una direzione graduale di progresso. Sebbene dunque Hegel tratti la
società fra i fenomeni dello spirito oggettivo, e cioè in particolare come seconda forma
dell’eticità tra la famiglia e lo Stato, essa non è tuttavia una loro forma mediana.
Piuttosto essa è, secondo Hegel, l’antitesi rispetto alla eticità che nella famiglia si
presenta in un primo stadio, ancora inconsapevole, ma immediatamente realizzato.
Poiché la famiglia sente se stessa come un’unità che fa pervenire a coscienza
l’individualità del singolo solo come membro di questa unità e fa dell’amore la sua
inclinazione portante (Filosofia del diritto, § 140). La società civile significa invece
appunto la dissoluzione di quest’ultima, l’atomizzazione dei suoi membri, di cui essa fa
individui sussistenti per sé e che pensano solo a sé, la cui inclinazione reciproca non è
piú l’amore, bensí l’amore di sé, l’egoismo [Nota 5]. La società diviene, secondo la
famosa espressione di Hegel, il «sistema dei bisogni», e questo significa la
contrapposizione ad un sistema dell’eticità: come tale va concepito lo Stato, la sintesi
fra famiglia e società civile. Nella società civile, pertanto, la società è nella sua
dualizzazione. «La sostanza», si legge nel § 523 dell’Enciclopedia, «che, in quanto
spirito, si particolarizza astrattamente in molte persone (la famiglia è una sola
persona), in famiglie o individui, i quali sono per sé in libertà indipendente e come
esseri
Página 32
particolari, — perde il suo carattere etico; giacché queste persone in quanto tali non
hanno nella loro coscienza e per loro scopo l’unità assoluta, ma la loro propria
particolarità e il loro essere per sé: donde nasce il sistema dell’atomistica». Altrettanto
si legge nella Filosofia del diritto, Aggiunta al § 184: «L’ethos è qui perduto nel suo
estremo» [Nota 6].
Ma, in questa contrapposizione fra Stato e società in Hegel, vorrei richiamare
l’attenzione su un punto, che è di grande importanza per lo sviluppo ulteriore di questo
rapporto concettuale. Abbiamo appunto visto che, in Hegel, non si tratta tanto di una
separazione concettuale necessaria fra Stato e società civile, bensí che la società civile
gli appariva semplicemente come un gradino verso la perfetta eticità, verso lo Stato.
Questo rapporto storico si esprime solo nel fatto che, secondo l’esposizione penetrante
e ripetuta di Hegel, questo sistema dei bisogni, quest’atomistica egoistica degli
individui, in fondo, è solo una falsa coscienza, un’apparenza, con cui l’individuo
inganna se stesso e gli altri. Si ritiene qualcosa di particolare, di posto unicamente su
se stesso, mentre non ha cessato di essere un membro del rapporto spirituale, dello
spirito oggettivo. Non può sfuggire alla sua unità: può semplicemente disconoscerla e
negarla. Per questo, già il capitolo della Fenomenologia, in cui si parla dell’individualità,
che vuol essere soltanto in sé e per sé, e non vuol ritenere reale null’altro che la sua
azione individuale, ha il significativo titolo: Il regno animale dello spirito e l’inganno, o
la cosa stessa. In quanto gl’individui ritengono e pretendono di servire soltanto sé o la
cosa stessa, di cui si sono appropriati, tuttavia con l’azione — che è possibile solo in
relazione agli altri, al loro atteggiamento concordante o di rifiuto — non possono non
dimostrare che ogni realizzazione della loro volantà si compie solo grazie all’atto del
«trasporre il Suo nell’elemento universale, per modo che esso diventa e deve diventare
Cosa tutti» [Nota 7]. Gl’individui si danno come reciprocamente singolarizzati si
accolgono reciprocamente come tali, per mostrarsi tuttavia, in ogni momento del loro
fare, attraverso la valutazione comunitaria del medesimo, attraverso la sua
accettazione e il suo rifiuto, come spiritualmente legati. Per cui si legge chiaramente
nella Filosofia del
Página 33
diritto, nella discussione della società in quanto regno dell’egoismo, «cerchia della
particolarità»:
Ma, ora, si presenta il rapporto, per cui il particolare deve essere il primo elemento
determinante per me, e, quindi, è annullata la determinazione etica. Ma io sono
soltanto in errore, particolarmente per il fatto che, credendo di tener fermo il
particolare, tuttavia l’universalità e la necessità della connessione resta la cosa prima
ed essenziale; quindi, io sono, in genere, nel grado dell’apparenza; e, poiché la mia
particolarità resta l’elemento determinante per me, cioè il fine, io servo, quindi,
all’universalità, che propriamente conserva il potere ultimo sopra di me. (Aggiunta al §
181).
È interessante e, insieme, istruttivo, per il rapporto storico-spirituale del pensiero
marxiano con la filosofia hegeliana, il vedere come questa teoria hegeliana
dell’atomizzazione solo apparente della società civile ritorna in Marx in una forma che
tende già, dallo sprofondamento metafisico dell’individuo, verso la fusione sociale pura.
Per parlare con precisione e nel significato prosaico — leggiamo nella Sacra famiglia
— i membri della società civile non sono atomi. [...] L’individuo egoistico della società
civile si può gonfiare, nella sua rappresentazione non sensibile e nella sua astrazione
non vivente, fino a diventare l’atomo, cioè un’essenza irrelata, autosufficiente, priva di
bisogni, assolutamente piena, beata. La realtà sensibile, non beata, non si preoccupa
dell’immaginazione dell’individuo; ciascuno dei sensi di lui lo costringe a credere al
senso del mondo e degli individui fuori di lui, ed anche il suo stomaco profano gli
ricorda quotidianamente che il mondo fuori di lui non è vuoto ma è ciò che
propriamente riempie. Ciascuna delle sue attività essenziali e delle sue proprietà,
ciascuno dei suoi impulsi vitali diventa il bisogno, la penuria, che trasforma il suo
egoismo, il suo desiderio di sé, in desiderio di altre cose e di altri uomini fuori di lui.
Ma, poiché il bisogno del singolo individuo non ha un senso evidente di per sé per
l’altro individuo egoistico che possiede i mezzi per soddisfare quel bisogno, e quindi
non ha una connessione immediata con il soddisfacimento, ogni individuo è quindi
costretto a creare questa connessione, diventando parimenti il mediatore fra il bisogno
altrui e gli oggetti di questo bisogno. Sono quindi la necessità naturale, le proprietà
umane essenziali, per quanto alienate possano apparire, l’interesse, che tengono uniti i
membri della società civile; il loro legame reale è la vita civile, e non la vita politica.
Non è dunque lo Stato che tiene uniti gli atomi della società civile, ma il fatto che essi
sono atomi solo nella rappresentazione, nel cielo della loro immaginazione, — il fatto
che nella realtà sono esseri fortemente distinti dagli atomi, cioè [...] uomini egoistici.
Solo la superstizione politica immagina ancora oggi che la vita civile debba di nePágina 34
cessità essere tenuta unita dallo Stato, mentre al contrario, nella realtà, lo Stato è
tenuto unito dalla vita civile. [Nota 8]
Anche il concetto marxiano di società ha assunto come punto di partenza della sua
elaborazione sociologica del problema della società la concezione della società civile in
quanto semplice apparenza dell’autonomia atomistica dei suoi elementi, solo che esso
porta a termine la dissoluzione di questa apparenza in maniera diversa da Hegel.
Secondo quest’ultimo l’apparenza si produce necessariamente dalla scissione dello
spirito oggettivo e può essere superata solo grazie a un processo spirituale, grazie al
fatto, cioè, che la coscienza s’immerge nell’essenza unitaria di questo spirito oggettivo.
In Marx quest’apparenza viene presentata come prodotto necessario di una
determinata forma storica della socializzazione umana, cioè di quella forma, in cui tutti
gli atti della socializzazione devono essere compiuti da individui isolati, non consapevoli
della loro socializzazione, e viene eliminata grazie all’abolizione di questo ordinamento
sociale. In Hegel la nascita dell’apparenza atomistica e la sua dissoluzione rimane un
processo all’interno della coscienza; in Marx esso diviene un processo dell’evento
sociale, che determina causalmente questi cambiamenti della coscienza [Nota 9].
Se in Hegel il concetto di società era ancora un semplice membro nello sviluppo dello
spirito oggettivo per il suo pieno dispiegamento nello Stato, per cui l’opposizione fra
Stato e società era, propriamente, solo transitoria e indicava soltanto la scissione
dell’idea etica dello Stato con l’egoismo come principio fondamentale della società
civile, esso diviene, in Lorenz von Stein, un concetto generale-teorico. Ed è qui che
nasce, propriamente, la teoria della necessaria opposizione concettuale fra Stato e
società in generale. Per quanto riguarda il punto principale, per quanto riguarda cioè
Página 35
la distinzione della società, in quanto «sistema dei bisogni», dell’«atomismo», in
opposizione allo Stato in quanto sistema del generale, dell’eticità, Stein è rimasto
sempre un puro allievo di Hegel. Ma, tuttavia, egli scorge già, nella società, una forma
di collegamento generale dell’esistenza sociale dell’uomo, che sta alla base tutte le
configurazioni della vita statale, e di cui egli cerca di scoprire le leggi. E, pertanto,
spetta a questo pensatore, troppo poco apprezzato, perché posto in ombra dalla luce
del pensiero marxiano, comunque il grande merito di aver fatto valere per primo, come
tedesco, il programma di una scienza della società e di aver offerto importanti
contributi alla sua realizzazione. Se, in questo programma, egli è rimasto solo al primo
slancio, non poca responsabilità di ciò spetta alla contrapposizione hegeliana, rimasta
insuperata, di Stato e società. Essa, cioè, ha fatto sí che anche Stein scorgesse nella
sua «teoria della società» non ancora una vera e propria scienza fondamentale, bensí
solo una parte di un «sistema di scienza dello Stato», le cui due altre parti erano la
teoria dello Stato e la teoria dell’amministrazione, e ha fatto sí che fra queste parti del
sistema non sussistesse alcuna unità di metodo. Poiché la teoria della società è, in
Stein, la teoria della condizione di classe della società, la teoria dell’ordinamento
costituito attraverso i rapporti di potere nella società, mentre la teoria dello Stato si
occupa dell’ordinamento giuridico, che, per Stein, consegue dal concetto di un
ordinamento costrittivo che rappresenta l’interesse generale, e la teoria
dell’amministrazione deve indicare i mezzi per la realizzazione di un tale ordinamento
giuridico all’interno della società classista. Conformemente a questo suo carattere
etico, pertanto, la teoria dello Stato e dell’amministrazione pretende un metodo di
trattazione del tutto diverso dalla trattazione sociologica, causale, che anche la teoria
della società di Stein aveva già adottato. In tal modo, però, tutta la conoscenza teorica
introdotta con la teoria della società, che Stein aveva già condotto a una chiara
comprensione del carattere di classe dello Stato e della necessità della lottta di classe,
andava a parare nel compromesso di un appiananto pratico delle opposizioni fra Stato
e società, nella teoria dell’amministrazione che assumeva in Stein uno spazio cosí
particolare [Nota 10].
Página 36
Già la prima opera di Stein, il libro — cosí importante per la storia del socialismo
moderno — su Der Sozialismus und Kommunismus im heutigen Frankreich, apparso
nel 1842, è molto indicativo anche per il nostro argomento, poiché in questo libro si
trova illustrata, in maniera intuitiva e avvincente, la forte impressione della novità che,
con il concetto di società, si è dischiusa alla riflessione dell’epoca. Da questo libro
emerge una sorta di rivelazione per gli spiriti critici del tempo d’allora, il concetto di
società nella sua distinzione dallo Stato agisce qui come una scoperta scientifica
formale. Ed è molto utile offrirsi, ancor’oggi, all’impressione di questa novità, poiché,
nella concezione moderna, il concetto di società ha assunto fin troppo spesso
l’impronta dell’ovvietà, che ha condotto a creare, non di rado, una assoluta mancanza
di concetti intorno all’oggetto che questo concetto indica. Per fin troppe persone, oggi,
il concetto di società indica solo una parola comoda che facilmente si piazza là dove
mancano concetti.
Página 37
Fin dall’inizio, in questo libro, il concetto di società si presenta, per Stein, nel rapporto
piú stretto con quello di movimento e di rovesciamento sociale. «Che cos’è una
rivoluzione sociale?», egli domanda nella Prefazione (p. IV). «Come si distingue da
quella politica? In breve: che cos’è la società e come si riferisce allo Stato?». E sotto
l’impressione vigorosa dell’«elemento nuovo», cioè del proletariato (p. 9), la cui
emergenza gli aveva mostrato lo studio del movimento sociale in Francia, s’impone la
nuova conoscenza di ciò che era stato l’elemento decisivo in tutti i rovesciamenti
politici degli ultimi anni e che aveva fatto fallire gl’ideali di libertà della rivoluzione
francese, in quanto l’aveva fatta andare a parare nel diritto elettorale legato al censo
della costituzione borghese.
Qual è il momento che ha avuto tanta forza da mantenersi in mezzo agli sviluppi piú
splendenti dell’uguaglianza e da provocare delle formazioni che ad essa si
contrappongono in maniera cosí diretta? [...] È il possesso. Il principio dell’uguaglianza
ha trovato qui, infine, il suo vero avversario. E, anche senza avere completa
consapevolezza del suo specifico significato, comincia già ora a sospettare che la
disuguaglianza del possesso sia il vero scoglio contro cui farà naufragio. [Nota 11]
Ma, con ciò, viene trovato un nuovo punto di vista per la trattazione del movimento
rivoluzionario, che consente di comprendere che il movimento rivoluzionario stesso, nel
presente, ha cambiato il suo posto di combattimento. La lotta per l’uguaglianza si
compie ora in una sfera completamente diversa: «Se prima era il potere statale la
sfera in cui si metteva alla prova, adesso è la società» [Nota 12]. La lotta politica con
lo Stato fa posto a una «lotta nel cuore della società». È quindi necessario
contrapporre una scienza della società alla nostra precedente scienza dello Stato. Né la
teoria dello Stato, né la filosofia del diritto, né la teoria dell’economia politica, sono in
grado di presentarci «in un’unità scientifica» l’interezza reale della vita comunitaria
degli uomini, poiché esse considerano ogni volta un lato di essa.
Ora, dov’è l’idea, che fa di questa interezza reale un intero nell’intuizione? Finora non
l’abbiamo; vi è semplicemente una parola che deve nascondere questa deficienza, e la
nasconde male. È la società, nel cui concetto consiste la soluzione di quel còmpito.
[Nota 13]
I punti di vista relativi a una nuova scienza, in questo libro di Stein semplicemente
accennati, della quale del resto il suo libro rappresentava la prima applicazione, punti
di vista che fanno appaPágina 38
rire in chiara luce tutti i vantaggi e tutte le contraddizioni della concezione
fondamentale di Stein, trovano ora la loro prima attuazione sistematica nel primo
volume della sua Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich (apparsa nel 1850),
che aveva come sottotitolo: Il concetto di società [Nota 14]. Qui si palesa chiaramente
il progresso di Stein oltre Hegel nel punto che abbiamo già sottolineato, per cui il
concetto di società, da semplice fase di sviluppo, diviene un concetto generale.
L’opposizione fra società e Stato, in verità, viene mantenuta, ma non è piú
l’opposizione fra due momenti separati dello sviluppo spirituale, bensí un’opposizione
immanente ad ogni vita comunitaria storica. Società e Stato ora, in generale, non
vanno piú divisi, neanche nel senso per cui, per esempio, lo Stato avrebbe la missione
di superare la società e di conservarla (aufheben) nella sua universalità, e con ciò esso
sarebbe condotto alla sua espressione perfetta, ovviamente raggiungibile solo nell’idea,
bensí società e Stato sono «i due elementi vitali di ogni comunità umana» [Nota 15].
Solo che da ciò deriva «il fatto che il contenuto della vita della comunità umana non
può non essere una continua lotta dello Stato con la società e della società con lo
Stato» [Nota 16]. Poiché in ciò Stein rimane uno scolaro fedele di Hegel, nel fatto che
Stato e società sono soltanto le forme di organizzazione di princípi reciprocamente
contrapposti e che il principio dello Stato è l’interesse generale, quello della società
invece è l’interesse individuale [Nota 17].
Il concetto sociologico di società in quanto concetto di una forma universale della vita
comunitaria in generale e delle sue leggi di cambiamento è elaborato con chiarezza
ancora maggiore nella Gesellschaftslehre di Stein, che apparve nel 1856 come seconda
parte del suo System der Staatswissenschaft. Questo libro è cosí eccellente che può
apprestare ancor’oggi validi servigi per acquisire vedute sociologiche. Ma proprio in
esso il mantenimento della contrapposizione fra Stato e società — che in Hegel era
ancora possibile poiché ivi era filosofia della Storia, ma qui si fonda su una confusione
dei metodi — si sviluppa fino a un limite in cui l’insostenibilità teorica comincia a
divenire consapevole di se stessa. Poiché qui Stein non solo afferma che con il concetto
puro di Stato da solo la vita della comunità non può essere assolutamente compresa
(p. 53), ma qui viene da lui stesso sempre piú chiaramente espresso il fatto che in
nessuno Stato ‘reale’ può essere affatto realizzato l’interesse generale, cioè l’idea dello
Stato puro, perché, al contraPágina 39
rio, l’interesse di potere e l’interesse legato al possesso della classe dominante diviene
il principio decisivo della costituzione dello Stato (Staatsbildung). E cosí il problema di
come dalla ‘società’ si debba giungere a uno ‘Stato’ rimane qui tanto piú insoluto in
quanto la soluzione di Stein, in base a cui il principato e il funzionariato sono gli
elementi, che devono rappresentare — al di là della violenza d’interessi puramente
della società — gl’interessi generali e dovrebbero risolvere il conflitto grazie alla loro
amministrazione diretta in questo senso (p. 73), va a parare direttamente nell’utopia,
e in un’utopia reazionaria.
Non dobbiamo occuparci, qui, d’una esposizione della teoria dello Stato e della società
di Stein, ma dovevamo farlo solo sotto il nostro punto di vista per imparare a
conoscere in maniera piú dettagliata quella direzione di pensiero in cui — come
pretende Kelsen — si produce il bisogno di una chiara delimitazione fra Stato e società.
Vediamo ora che questa delimitazione ha, già nel suo progenitore Hegel e altrettanto
nel suo continuatore Stein, la tendenza a distinguere lo Stato in quanto idea, in quanto
essenza normativa, dalla società in quanto condizione fattuale: per cui questa
tendenza di pensiero è anzi cosí simpatica a Kelsen. In tal modo lo Stato si separa
comunque dalla sociologia per divenire semplicemente oggetto dell’etica o, come in
Kelsen, della teoria del diritto, mentre d’altra parte la teoria della società va a finire in
un isolamento insuperabile rispetto a tutti gl’interessi vitali reali dello Stato. E cosí il
problema se sussista effettivamente una contrapposizione fra Stato e società diviene
un problema vitale per una sociologia, che, come quella marxista, voglia comprendere
anche lo Stato.
Página 40
Capitolo quarto
L’ulteriore elaborazione del concetto di società in Marx
Nella concezione del marxismo l’opposizione fra Stato e società viene tolta. Questo
superamento (Aufhebung), che noi riteniamo uno dei concetti principali della
concezione sociologica fondamentale del marxismo, non si compie in modo tale che
questa opposizione viene completamente negata, bensí in modo tale che essa viene
assunta, al contrario, e spiegata come una realtà, ma non come un’antitesi logica del
concetto, bensí come il rispecchiamento (Spiegelung) di un antagonismo reale delle
forze sociali. Marx ed Engels anche in questa direzione hanno superato la filosofia
hegeliana nel loro modo produttivo, in quanto cioè non l’hanno semplicemente lasciata
cadere come un errore, ma hanno ‘salvato’ il suo contenuto di verità nella loro propria
concezione. Cosí, anche in questo caso, il dissidio hegeliano fra i concetti di Stato e
società viene indicato, da una parte, come un’apparenza semplicemente ideologica,
ma, d’altra parte, il nucleo reale di questa oppositività viene scoperto nella legalità del
processo sociale stesso. E questo avviene grazie alla conoscenza del fatto che lo Stato
è soltanto una forma storica di manifestazione della vita sociale in generale. Una forma
di vita determinata, dispiegatasi nel corso dello sviluppo storico, della socializzazione
umana, si mostra, nella coscienza dei suoi portatori, come comunità (Gemeinwesen),
come Stato; ma, ciononostante, rimane la società stessa, solo a un determinato livello
storico della sua manifestazione. Essa si era manifestata prima, per esempio, come
gens, come stirpe, come città, come popolo.
Ma da che cosa deriva l’oppositività di questa forma di socializzazione, che conduce a
una separazione fra Stato e società? Ciò è fondato nella natura sociale anche della
coscienza singola che in ultima analisi è possibile presentare solo da un punto di vista
critico-gnoseologico, e in base a cui la consapevolezza della socialità — anche ove si
tratti di una semplice socialità di gruppi o di clasPágina 41
si — per la coscienza ingenua passa necessariamente attraverso le rappresentazioni di
una universalità dell’interesse e di una solidarietà del tutto, e all’interno di questo
rapporto il singolo vede se stesso come un membro, uguale a tutti gli altri membri di
questo rapporto, certo utile agli altri, ma anche da essi stimolato. In questo senso si
potrebbe dire che l’uomo è, per natura, non solo un’essenza sociale bensí anche
democratica [Nota 1]. La comunità gli appare soltanto come un ingrandimento e un
rafforzamento della sua propria essenza individuale, anzi non può non apparirgli cosí,
poiché anzi egli già nel suo pensiero e nella sua volontà individuale è incline alla
validità universale di questi due lati della sua essenza, cioè quindi al collegamento
intenzionale con una molteplicità indeterminata di compagni dello stesso genere. Sia
pure senza penetrare fino alla radice critico-gnoseologica del carattere sociale di ogni
attività spirituale dell’individuo, Marx ha tuttavia elevato a pietra angolare della sua
critica dell’ideologia delle classi il fatto stesso, per cui l’uomo non può sperimentare
nulla di sociale senza averlo prima ricondotto sotto la categoria dell’universale. In un
brano molto indicativo, ma poco noto, leggiamo:
Le idee e i pensieri degli uomini erano naturalmente idee e pensieri su se stessi e
sulla loro condizione, la loro coscienza di sé, degli uomini, giacché era una coscienza
non soltanto della singola persona, ma della singola persona in connessione con l’intera
società, e dell’intera società in cui essi vivevano. Le condizioni da essi indipendenti,
entro le quali producevano la loro vita, le forme di scambio necessarie che vi erano
connesse, i rapporti personali e sociali cosí posti, dovevano assumere, in quanto
venivano espressi in pensieri, la forma di condizioni ideali e di rapporti necessari, ossia
trovare la loro espressione nella coscienza come determinazioni scaturenti dal concetto
dell’uomo, dall’essenza umana, dalla natura dell’uomo. Ciò che gli uomini erano, ciò
che la loro condizione era, appariva nella coscienza come la rappresentazione
dell’uomo, dei suoi modi di esistere o delle sue determinazioni concettuali piú precise.
[Nota 2]
È qui, poi, anche la fonte del diritto naturale, che respinge come irrazionale e
contraddittorio rispetto alla essenza umana (cioè, quindi, propriamente come non
sociale), tutto ciò che contraddice il
Página 42
sistema di socialità non contraddittorio di volta in volta riconosciuto. Ma qui è anche la
fonte del diritto positivo, che deriva la sua legittimazione a valere anche per tutti e a
farsi obbedire soltanto da questa forma fondamentale di ogni socialità, per cui essa si
riferisce all’intero, all’interesse generale, alla conservazione e alla rappresentanza della
solidarietà di tutti. Questa fondamentale comunizzazione (Vergemeinschaftung)
dell’uomo solo nel dovere — sia che si tratti dei comandamenti intimi della morale, sia
che si tratti delle prescrizioni esterne del diritto — acquista una forma di coscienza e
una forma di vita nuova perché riferita all’agire.
In ogni socializzazione si costituisce una certa organizzazione, che ha lo scopo di
mantenere e di difendere questa forma di vita degli uomini in essa unificati. Questa
organizzazione, con i suoi portatori, costituisce il ‘governo’, lo ‘Stato’ di questa forma
sociale. Fino a quando la configurazione reale di una socializzazione non cela in sé
ancora alcuna opposizione economica — come, pe esempio, all’interno delle forme di
vita, piú o meno leggendarie, del comunismo originario — la forma di coscienza di
questa vita coincide con il suo contenuto, ‘Stato’ e società sono la stessa cosa. Ma già
in questa organizzazione stessa vi sono dei germi, che tendono a superare questa
identità, in quanto la quantità di potere, che essa concede a singoli uomini, pone
facilmente questi in condizione di sfruttare la loro posizione certo in nome dell’insieme,
ma, in realtà, per il proprio interesse. La forma sociale diviene cosí un mezzo contro la
socialità stessa e crea al suo interno dei contrasti che non possono non spezzare
l’identità originaria dei concetti di comunità, diritto e Stato. Ma questa rottura non si
compie con uguale immediatezza nella coscienza degli uomini, i quali continuano ad
usare questi concetti nel loro significato solidale, anche quando Stato e diritto già da
molto tempo non rappresentano piú una comunità priva di contraddizioni e solidale.
Anzi, a causa della natura sociale della loro essenza, per cui possono pensarsi solo in
quanto esemplari di una specie, essi pervengono quasi per necessità di cose a
trattenersi in questo genere di rappresentazione come se fosse qualcosa di ovvio. Per
cui Engels poteva dire:
Lo Stato ci si presenta come il primo potere ideologico sugli uomini. La società si crea
un organo per la difesa dei suoi interessi comuni contro gli attacchi interni ed esterni.
Questo organo è il potere dello Stato. Appena sorto, quest’organo si rende
indipendente dalla società, e ciò tanto piú quanto piú diventa organo di una classe
determinata, e realizza in modo diretto il dominio di questa classe. [Nota 3]
Página 43
L’elemento proprio della forma statale è dunque questo, il fatto che essa pensa
sempre la socializzazione sotto il concetto dell’interesse generale, mentre, in realtà,
sono sempre gl’interessi particolari delle forze dominanti all’interno della
socializzazione quelle che costituiscono lo Stato e esprimono la sua essenza. Il che
significa che non vi è un qualcosa, sussistente per sé, lo Stato, che si contrapponga a
un altro istituto elementare, alla società; ma la forma statale è l’ideologia
contraddittoria, in cui la realtà sociale viene vissuta e formata. Essa è contraddittoria
perché, in base alla sua forma, è sempre rivolta all’universalità della comunità, ma, in
base al suo contenuto, rappresenta sempre soltanto interessi parziali. L’idea dello
Stato rappresenta una volontà universale e ricava da questo presupposto
l’autorizzazione a dettare leggi, cui ognuno deve piegarsi. Ma non ‘tutti’, bensí le classi
dominanti della società dettano il contenuto di questa volontà universale, per cui le
leggi sono appunto soltanto la volontà particolare dei dominanti protocollata nella
forma della volontà universale. È appunto questa la dialettica tipica del concetto di
Stato, che ha condotto alla divisione di due princìpi comunitari reciprocamente
contrapposti — quello altruistico dello Stato e quello egoistico della società —, per cui
nella forma statale un complesso d’interessi in sé puramente parziale ha assunto la
forma di una solidarietà universale, che esige non semplicemente l’obbedienza esterna
ai suoi comandamenti, bensí anche il riconoscimento della sua santità. La legge dello
Stato dev’essere eseguita non solo in quanto ordinamento costrittivo, bensí dev’essere
onorata e rispettata anche in quanto ordinamento giuridico.
È estremamente interessante e ricco d’insegnamenti per la storia culturale
(Geistesgeschichte) del socialismo il fatto che lo svelamento di questa contraddizione
interna dell’idea borghese di Stato e del suo ordinamento giuridico si compia già alla
soglia del socialismo moderno e, in verità, quasi contemporaneamente presso due dei
suoi primi propugnatori: presso il suo primo teorico, Tommaso Moro, e presso il primo
capo di un movimento comunista in Germania, Thomas Münzer. Nel libro Utopia, che
contiene tante geniali anticipazioni della successiva critica del sistema capitalistico e
dei concetti del socialismo moderno, sebbene sia stato scritto quattrocento anni fa, in
un’epoca in cui questo sistema capitalistico era solo agli inizi, in questo libro
meraviglioso, dunque, si legge:
Esaminando adunque e considerando meco questi Stati che oggi in qualche luogo si
trovano, non mi si presenta altro, cosí Dio mi aiuti! che una congiura di ricchi, i quali,
sotto nome e pretesto dello Stato, non si occupano che dei propri interessi. E
immaginano e inventano ogni maniera, ogni arte con cui conservare anzitutto, senza
paura di
Página 44
perderlo, ciò che hanno disonestamente ammucchiato essi, e in secondo luogo come
serbar per sé, al prezzo piú basso possibile, ciò che a fatica producono tutti i poveri,
volgendolo a proprio utile. Queste subdole disposizioni i ricchi stabiliscono che vengano
osservate in nome dello Stato, cioè anche in nome dei poveri, e cosi diventano legge!
[Nota 4]
E del tutto analogamente scrive Münzer nel suo ultimo scritto intitolato Hoch
verursachte Schutzrede, che Karl Kautsky definisce il suo scritto piú appassionato e
rivoluzionario:
I potenti fanno come vogliono [...] il piatto principale dell’usura, delle ruberie e dei
banditismi sono i nostri signori e i nostri prìncipi, che s’impossessano di tutte le
creature. I pesci nell’acqua, gli uccelli nell’aria, i frutti sulla terra: tutto dev’essere loro.
Poi fanno diffondere il comandamento di Dio fra i poveri, e dicono: Dio ha comandato
che tu non devi rubare; essi stessi però non seguono il comandamento [...] Se poi egli
[il povero] commette peccato sia pure in misura minima, dev’essere impiccato. [Nota
5]
Il nucleo giusto della teoria hegeliana della contraddizione fra Stato e società è
dunque quello per cui vi è qui una opposizione reale all’interno dei rapporti sociali di
vita stessi, che viene dapprima celata dalla forma ideologica in cui i medesimi si
presentano nello Stato, legati in un’unità apparentemente solidale. Questa forma
ideologica, in cui gli uomini divengono consapevoli della loro socializzazione come di
uno stato giuridico, cioè in quanto membri di un ordinamento che rappresenta interessi
generali, fa parte delle forme necessarie della coscienza sociale in generale, e da qui
nasce anche l’apparenza della contraddizione fra Stato e società. Ogni interesse di
classe vuol configurare la sua volontà come dominante, tende quindi a impadronirsi del
potere nello Stato e a proclamare la sua volontà come la volontà dell’interesse
generale. In questo processo storico anche il ‘diritto’ è sempre dalla parte della classe
oppressa, poiché con la sua liberazione l’ambito dell’‘interesse generale’ sperimenta
sempre un allargamento. Da dove derivi questa forma ideologica della socializzazione;
se essa sia — come dicevamo — effettivamente una forma ultima di coscienza; quale
sia la sua legalità particolare: tutto ciò non è un problema della sociologia e, quindi,
neanche del marxismo; ciò fa parte della critica della conoscenza, che qui, a mio
avviso, va necessariamente chiamata in causa per realizzare un
Página 45
necessario completamento del senso giusto della concezione materialistica della storia
— anche la moderna scienza della natura, anzi, non può piú applicare i suoi concetti
fondamentali senza una consapevole elaborazione dei risultati critico-gnoseologici
[Nota 6]. La concezione marxista presuppone questa forma ideologica dell’ordinamento
giuridico, in cui viene vissuta la socializzazione, ed è lecito che la presupponga. Il suo
còmpito è soltanto quello di spiegare il riempimento concreto di questa forma e le
configurazioni particolari e i mutamenti di questo contenuto a partire dalle
configurazioni e dai mutamenti dei rapporti sociali stessi. E la piú importante di queste
spiegazioni consiste nel fatto di prestare attenzione fin dall’inizio al fatto che la forma
statale non è identica alla forma giuridica, bensí indica soltanto quella configurazione
storica particolare della forma giuridica, in cui una parte della società ha il potere di
spacciare la sua volontà e il suo interesse come se fosse l’intero.
Da questo rapporto fondamentale deriva ora una doppia conseguenza, cui Marx ha
accennato in alcune espressioni ancora troppo poco considerate dei suoi scritti giovanili
che in maniera molto illuminante privano di quest’apparenza l’opposizione hegeliana, in
base a cui lo Stato sarebbe il generale, mentre la società sarebbe l’elemento privato,
egoistico. Questa opposizione, cioè, è solo la necessaria conseguenza ideologica della
mistificazione borghese del concetto di Stato e di diritto, che deriva dall’identificazione,
ovvia per il punto di vista borghese, del suo interesse di classe con l’ordinamento
statale e giuridico in generale. Ed essa fa si che non solo, da un lato, i semplici
interessi particolari delle classi dominanti nella società civile si presentino come
interessi generali, come interessi sacri della nazione e, quindi, dello Stato, ma fa anche
sí che, d’altra parte, tutti gl’interessi delle classi dominate — anche se superano di
molto per interno significato sociale e per estensione del loro àmbito quelli dominanti
— appaiano come interessi privati, di cui lo Stato non è necessario che si preoccupi.
Cosí, per esempio, da questo punto di vista la libertà del contratto di lavoro, cioè il
diritto di sfruttamento libero da ogni regolamentazione statale, appare come un
interesse generale, come un interesse dello Stato, che dev’essere altrettanto sacro
della proprietà privata. La previdenza per gli anziani, invece, cioè il problema di come
debbano vivere gli anziani, dopo aver lavorato per tutta una vita, quando a causa
dell’età siano divenuti inabili al lavoro e non abbiano altre fonti di sostentamento, è un
loro affare privato, che, secondo la veduta dello Stato borghese,
Página 46
difettoso dal punto di vista della politica sociale, va risolto solo attraverso mezzi privati
(beneficenza). Del tutto coerentemente, pertanto, la miseria, la povertà appaiono — da
questo punto di vista — non propriamente come un fenomeno sociale, bensí come un
destino privato, come la conseguenza o di una sfortuna particolare o dell’incapacità,
dell’indolenza, dell’amministrazione deficiente di chi ad esse è soggetto. Poiché il
contenuto etico del vincolo sociale coincide con lo Stato — e cioè, in questo caso, con il
dominio degli interessi legati al possesso — la povertà ricade, dal punto di vista
consapevolmente borghese, non solo nella sfera del privato, bensí quasi in quella del
vizio. E i proprietari sono — questa veduta si è mantenuta da Aristotele fino ai libri di
Lorenz von Stein — non solo quelli che di fatto esercitano il dominio, bensí anche quelli
che meritano di dominare.
Marx tratta questa contraddizione intrinseca all’ideologia borghese dello Stato in
maniera particolarmente penetrante nei suoi contributi agli «Annali franco-tedeschi»,
e, invero, sotto il punto di vista dell’opposizione fondamentale fra l’emancipazione
umana e l’emancipazione semplicemente politica. Io vi ho dettagliatamente accennato
già una volta [Nota 7]. L’espressione ‘umana’ tradisce l’influenza di Feuerbach, che
allora cominciava ad agire su Marx. Ma con essa s’intende già qualcosa di piú
dell’umanesimo feuerbachiano, in particolare il punto di vista di una concezione sociale
fondamentale rispetto a quella semplicemente politica, che non ha ancora riconosciuto
l’intreccio sociale generale di tutte le relazioni e situazioni della vita umana dietro le
forme politiche che sono semplicemente la sua espressione storica. È nota, sotto
questo profilo, la critica marxiana dei ‘diritti dell’uomo’ della rivoluzione francese, nella
cui forma, che comprende in maniera particolarmente enfatica l’universalità, egli mette
a nudo per cosí dire la necessità del meccanismo ideologico, grazie al quale a un
contenuto semplicemente particolare viene impressa la forma dell’universalità. Marx
mostra che
nessuno dei diritti dell’uomo oltrepassa dunque l’uomo egoista, l’uomo in quanto è
membro della società civile, cioè individuo ripiegato su se stesso, sul suo interesse
privato e sul suo arbitrio privato, e isolato dalla comunità. Ben lungi dall’essere l’uomo
inteso in essi come ente generico, la stessa vita del genere, la società, appare
piuttosto come una cornice esterna agli individui, come limitazione della loro
indipendenza originaria. L’unico legame che li tiene insieme è la necessità
Página 47
naturale, il bisogno e l’interesse privato, la conservazione della loro proprietà e della
loro persona egoistica. [Nota 8]
La concezione politica della società, cioè la visione che trova realizzati nella forma
statale gli interessi generali della vita sociale, è dunque, per Marx, solo una
emancipazione parziale: ove questo concetto indica tanto l’emancipazione sociale
quanto quella intellettuale. Perché, fin quando si permane soltanto in questa
concezione, il singolo rimane anche nella conoscenza prigioniero delle contraddizioni di
questa ideologia. Questa scinde l’esistenza dell’uomo in una maniera appunto
pericolosa.
Lo Stato politico perfetto — dice Marx — è per sua essenza la vita generica
(Gattungsleben) dell’uomo, in opposizione alla sua vita materiale. Tutti i presupposti di
questa vita egoistica continuano a sussistere al di fuori della sfera dello Stato, nella
società civile, ma come caratteristiche della società civile. Là dove lo Stato politico ha
raggiunto il suo vero sviluppo, l’uomo conduce non soltanto nel pensiero, nella
coscienza, bensí nella realtà, nella vita, una doppia vita, una celeste e una terrena, la
vita nella comunità politica nella quale egli si considera come ente comunitario, e la
vita nella società civile nella quale agisce come uomo privato, che considera gli altri
uomini come mezzo, degrada se stesso a mezzo e diviene trastullo di forze estranee.
[Nota 9]
La concezione puramente politica, pertanto, non può, in generale, abbracciare l’insieme
del rapporto sociale, poiché essa è fin dall’inizio una concezione parziale, la visione —
determinata da un punto di vista di classe — di una parte della società. Per questo,
anche, Marx chiama la rivoluzione solamente politica una «rivoluzione parziale». Il
concetto di Stato della società civile è stato preparato e costituito ad un tempo con la
rivoluzione politica della borghesia. «Su che cosa si fonda una rivoluzione parziale, una
rivoluzione soltanto politica?», si domandava Marx già nel suo scritto Per la critica della
filosofia del diritto di Hegel. «Sul fatto che una parte della società civile si emancipa e
perviene al dominio generale, sul fatto che una determinata classe intraprende la
emancipazione generale della società partendo dalla propria situazione particolare». E
aggiunge:
Nessuna classe della società civile può sostenere questa parte, senza provocare un
momento di entusiasmo in sé e nella massa, un momento nel quale essa fraternizza e
confluisce nella società in generale, si scambia con essa e viene intesa e riconosciuta
come sua rappresentante universale [...] Soltanto in nome dei diritti universali della
Página 48
società, una classe particolare può rivendicare a se stessa il dominio universale. [Nota
10]
Come si vede, nelle fasi storiche in cui, con la vittoria di una classe impetuosamente
progrediente, si compiono le grandi liquidazioni dello sviluppo sociale, non si parla
affatto di una contraddizione fra Stato e società e, ancora meno, la società si presenta
qui come il regno dell’egoismo e dell’interesse puramente individuale. Piuttosto, in
queste epoche, ogni nuova creazione statale riceve la sua piú alta consacrazione
proprio dal punto di vista della società e diviene cosí fulmineamente chiaro il rapporto
vero e proprio, per cui appunto Stato e società sono una e medesima cosa, solo che il
primo è la forma di coscienza ideologica della seconda in quanto rapporto reale
dell’esistenza umana. Solo quando, dopo il raffreddamento dell’entusiasmo
rivoluzionario, diviene visibile il colore vero e proprio di questa realtà — in quanto si
palesa che non tutte le forme e relazioni della socializzazione hanno trovato
accoglimento nella forma statale, bensí soltanto quelle nella cui difesa i portatori della
rivoluzione avevano avuto un interesse vitale — soltanto allora si compie la scissione
fra i concetti di Stato e società. E questa scissione continua a sussistere, da un punto
di vista ideale, fino a quando non sia acquisito un punto di vista, a partire dal quale
questa scissione venga penetrata appunto come un’apparenza, un punto di vista
prodotto dal fatto che il concetto di Stato, in sé non contraddittorio, viene applicato a
un contenuto che, nella sua intima oppositività, gli è del tutto inadeguato, anzi non può
non contraddirlo direttamente: viene applicato cioè alla realtà sociale divisa in classi.
Questo punto di vista è quello del marxismo. Esso è il distogliersi dal mondo dei riflessi
ideologici e il «ricondurre il mondo umano, i rapporti umani all’uomo stesso». Questa
è, come dicevamo prima, non soltanto una trasformazione della rivoluzione
semplicemente politica in rivoluzione sociale, ma, innanzi tutto, è anche una
emancipazione del pensiero stesso, un rivoluzionamento anche della concezione
dell’essenza dello Stato e della società stessi. È giusto, in questo doppio senso, ciò che
Marx scriveva:
Solo quando il reale uomo, individuale, riassume in sé il cittadino astratto, e come
uomo individuale nella sua vita empirica, nel suo lavoro individuale, nei suoi rapporti
individuali è divenuto ente generico (Gattungswesen), soltanto quando l’uomo ha
riconosciuto e organizzato le sue ‘forces propres’ come forze sociali e, perciò, non
separa piú da sé la forza sociale nella figura della forza politica, soltanto allora
l’emancipazione umana è compiuta. [Nota 11]
Página 49
Cosí, dunque, dal punto di vista marxista, cioè sociologico, lo Stato è soltanto una
forma ideologica di una struttura sociale, che in essa si manifesta, ma che nella sua
essenza va ancora ricercata e, dopo che questa è stata scoperta, quella si palesa una
forma troppo ristretta. Per questo Marx definisce il superamento di questa concezione
troppo ristretta, perché semplicemente politica, l’emancipazione umana; e per questo
egli definisce la concezione semplicemente politica, «l’intelletto politico», come un
modo di pensare limitato e necessariamente unilaterale, che è incapace «di scoprire la
fonte delle infermità sociali» [Nota 12]. L’opposizione fra Stato e società, che si
presume come un’opposizione necessaria, scompare non appena si sia riconosciuto che
il punto di vista dello Stato è soltanto la rappresentazione di un tutto astratto, «che
esiste soltanto grazie alla scissione della vita reale», mentre solo lo sguardo rivolto alla
società discopre il tutto reale, di cui nello Stato appare sempre soltanto un’immagine
distorta. In tal modo, quindi, quest’opposizione viene definitivamente superata; Stato e
società sono un’unità indivisibile in quanto, in certe condizioni storiche, cioè, dopo la
formazione dei contrasti economici di classe, lo Stato è quella forma di coscienza
sociale, in cui si presenta e si configura la socializzazione. L’apparenza dell’opposizione
fra Stato e società si spiega a partire dal fatto che questa forma storica, per cui
determinati interessi parziali, non appena siano divenuti dominanti, si fanno valere
come interessi generali, come interessi statali, questa forma storica viene assunta
come se fosse la forma essenziale della vita sociale stessa, per cui lo ‘Stato’ appare
come una forma originaria della vita umana esattamente come la ‘società’.
In questo caso la concezione marxista ha compiuto esattamente la stessa svolta
critica del pensiero che ha compiuto rispetto ai concetti economici. Notoriamente, è
questo il carattere nuovo e che rovescia la precedente trattazione dell’economia
politica della concezione marx-engelsiana, per cui essa non scorge piú nei fenomeni
economici determinazioni naturali eterne della vita economica in generale, bensí forme
dell’essere e dell’evento sociale che sono semplicemente divenute storicamente e che,
pertanto, possono essere cambiate dall’ulteriore processo storico. Essa rompe
decisamente con quella concezione borghese dei fenomeni economici, che, anche se
deve ammettere uno sviluppo precedente che arrivi fino ad essi, tuttavia, come dice
Marx nella seconda Prefazione al
Página 50
Capitale, concepisce l’ordinamento capitalistico «come forma assoluta ed ultima della
produzione sociale». Anche le categorie economiche — proprietà privata, merce,
salario, profitto, capitale, ecc. — sono condizionate, sia per quanto riguarda la loro
nascita, sia per quanto riguarda la loro sussistenza, dalla configurazione e dal
mutamento dei rapporti di produzione che stanno alla loro base, allo stesso modo che
lo sono, nella serie successiva, le altre categorie ideologiche. Tutte «queste idee,
queste categorie», dice Marx già nello scritto Miseria della filosofia, «sono tanto poco
eterne quanto i rapporti che esse esprimono. Sono prodotti storici e transitori. Vi è un
continuo movimento di accrescimento delle forze produttive, di distruzione di rapporti
sociali, di formazione d’idee; di immobile non vi è che l’astrazione dal movimento:
‘mors immortalis’» [Nota 13].
Questa fluidificazione stessa di apparentemente immutabili determinatezze naturali
della vita sociale, che il marxismo mette in atto nei confronti dei concetti economici,
esso la compie anche nel caso di quelli politici. Lo ‘Stato’ è tanto poco una forma
essenziale dell’esistenza sociale quanto lo è il ‘capitalismo’. I concetti di Stato, potere
politico, interessi pubblici, e simili, sono — nel rapporto concettuale del marxismo —
soltanto concetti storici. Essi significano sempre un’espressione particolare di livelli di
organizzazione sociale del tutto determinati, storicamente divenuti, ma non significano
mai una forma di questa struttura sociale in generale. Per il concetto di Stato vale
esattamente la stessa cosa che Marx ha detto una volta a proposito del concetto di
proprietà, esprimendosi cosí:
In ogni epoca storica la proprietà si è sviluppata diversamente e in rapporti sociali
interamente differenti. Così, definire la proprietà borghese non significa altro che
descrivere tutti i rapporti sociali della produzione borghese. Voler dare una definizione
della proprietà come d’un rapporto indipendente, di una categoria a parte, di una idea
astratta ed eterna, non può essere che un’illusione della metafisica o della
giurisprudenza. [Nota 14]
Portando a termine questa interpretazione storica, il marxismo intende, per Stato, «il
potere organizzato di una classe per opprimere un’altra classe», come già si può
leggere nel Manifesto del partito comunista. Diviene quindi chiaro che ogni critica, che,
di fronte a questo concetto di Stato, scenda in campo con un concetto generale
dell’essenza dello Stato in generale, si lascia sfuggire completamente lo specifico punto
di vista del marxismo.
Página 51
Ora, è proprio questo ciò che fa la critica kelseniana, il cui concetto di Stato, del
resto, non solo è un concetto cosí generale che non dice proprio nulla circa il
particolare livello storico di organizzazione e circa la caratteristica della struttura
statale realizzata, ma, oltre a ciò, è un concetto normativo, allude quindi a una
trattazione completamente diversa dei fenomeni sociali rispetto ai concetti sociologici,
che sono sempre concetti che si riferiscono all’essere, cioè sono concetti dell’essere e
del divenire dei fenomeni sociali. Ma, momentaneamente, vogliamo ancora prescindere
da quest’ultimo momento. Si potrebbe in particolare osservare che una critica dal
punto di vista di un concetto generale può essere tuttavia opportuna anche rispetto a
una concezione storica se, in particolare, essa conduce a mostrare che i concetti storici
sono in contraddizione con un dato di fatto generale, di cui essi appaiono tuttavia come
una modificazione. E una tale critica non è assolutamente in contraddizione con il
marxismo, anzi, corrisponde piuttosto a ciò che abbiamo già sentito persino nelle
parole di Marx circa la necessità di concetti generali astratti, che vanno messi alla base
di ogni considerazione pensante. Se si rimane solo consapevoli del fatto che essi sono
semplici astrazioni, che acquistano tutto il loro significato solo grazie alla quantità
mutevole della materia storica concreta, da cui sono stati ottenuti, allora questi
concetti generali servono addirittura ad ordinare e promuovere la nostra conoscenza.
Vogliamo pertanto vedere se, a partire da questo punto di vista, il concetto kelseniano
di Stato ha per la sociologia — e qui si tratta soltanto di questa — un significato critico
e sistematico.
Página 52
Capitolo quinto
Il formalismo giuridico di Kelsen [Nota *]
Nella sua teoria dello Stato Kelsen intende, per Stato, un’associazione di dominio
(Herrschaftsverband), ove è dapprima indifferente se questa associazione di dominio
coincida o meno con un ente territoriale. «Decisivo è soltanto il carattere di dominio.
Ciò significa, però, innanzi tutto, nient’altro se non che l’ordinamento della convivenza
umana, che si è soliti definire come Stato, è un ordinamento costrittivo, e che questo
ordinamento coincide [...] con l’ordinamento giuridico» (p. 6 [17]). Kelsen definisce
quindi lo Stato come ordinamento costrittivo giuridico e scorge in ciò un connotato che
definisce in maniera sufficiente lo Stato. Ma già da ora è possibile riconoscere il fatto
che con una tale definizione, puramente formale, non si è acquisito proprio nulla per
quanto riguarda il problema della essenza di una determinata forma storica di Stato. Lo
Stato patriarcale è una organizzazione costrittiva giuridica esattamente come lo Stato
borghese. Ma che cosa produce la distinzione? Se si risponde: appunto la diversa
configurazione dell’organizzazione costrittiva, allora è proprio questo l’interesse
sociologico: il riconoscere su che cosa di volta in volta si fondi l’organizzazione
costrittiva e che cosa conduca al suo mutamento e alla sua trasformazione. La
definizione dello Stato in generale come organizzazione costrittiva giuridica ha
all’incirca lo stesso significato che definire un animale materia organizzata. Tutt’e due
le volte una definizione cosí larga può avere propriamente solo un significato reale, un
significato — per cosí dire — di ammonimento: nel caso degli animali, a non pensare di
poter ricavare una vita animale da materia non organizzata; nel caso degli Stati,
invece, a richiamare l’attenzione sul fatto che tutta la vita
Página 53
statale si trova fin dall’inizio in una determinata forma organizzativa giuridica ed è
comprensibile solo a partire da questa.
Quest’ultimo è bensí anche il significato, in fondo polemico, della definizione
kelseniana dello Stato. Fin dall’inizio il concetto di Stato dev’essere condotto sotto il
punto di vista giuridico, cioè normativo, di un ordinamento prescrittivo
(Befehlsordnung), e con ciò la trattazione causale viene troncata alla radice. La vita
statale — che è equivalente a vita sociale, poiché lo Stato è un pezzo della vita sociale
— viene fin dall’inizio caratterizzata come un oggetto di considerazione normativa, nel
quale non interessa piú come sia nato e come si trasformi, bensí come è ordinato e
come debba venir diversamente ordinato. E, allo stesso tempo, in riferimento alla
critica della teoria marxista dello Stato, il concetto kelseniano di Stato ha ancora un
significato polemico particolare, che, per quanto derivi da un fraintendimento di fondo,
rende tuttavia unicamente possibile tutta questa critica. Kelsen cioè prende le mosse
— come vedremo — dal curioso presupposto, secondo cui la teoria marxista lotta
contro il carattere costrittivo dell’ordinamento statale in generale; e quindi egli ha
gioco facile nel mostrare che questa teoria, in quanto vuol fare ‘estinguere’ lo Stato, va
a parare nell’anarchismo, senza volerselo confessare, e quindi è in sé contraddittoria.
Momentaneamente vogliamo prescindere da ciò — su cui piú avanti ci si deve
soffermare dettagliatamente —, e vogliamo anche qui rinunciare a una discussione
della distinzione di principio, dal punto di vista critico-gnoseologico e dal punto di vista
metodologico, che esiste nella concezione dello Stato in Kelsen e nel marxismo,
discussione che fa parte di un altro àmbito. Poiché Kelsen, anzi, vuol esercitare nei
confronti dei concetti del marxismo addirittura una critica immanente, cioè una critica
che non parta dal suo punto di vista, bensí dal punto di vista proprio del sistema
criticato stesso; e solo una critica di questo genere merita un tale nome; poiché ogni
altra critica non è piú una critica del marxismo, bensí una polemica contro di esso,
condotta da un altro punto di vista, ad esso estraneo. Vedremo ancora che a Kelsen
non è riuscito di mantenere questa strada della critica immanente, poiché egli è troppo
kelseniano perché questo potesse riuscirgli. Lo constateremo subito già al primo passo
di questa critica, là dove indica la presunta quantità di contraddizioni del concetto
marxista di Stato. Vediamo dunque come Kelsen riesce a trovare in sé insufficiente e
contraddittorio il concetto di Stato in Marx e Engels.
Kelsen parafrasa innanzi tutto il concetto marxiano di Stato, per cui lo Stato viene
concepito come l’organizzazione di dominio di una classe, il cui scopo sarebbe quello di
sfruttare la classe doPágina 54
minata. Egli rimprovera innanzi tutto a questo concetto di Stato che questa definizione
non solo non corrisponde all’essenza della cosa, ma che, oltre a ciò, nel carattere
distintivo dello sfruttamento come scopo del dominio utilizza un elemento
completamente insufficiente per offrire una determinazione concettuale. È ovvio, cioè,
che ogni ordinamento costrittivo viene esercitato non per se stesso, bensí per uno
scopo che sta al di fuori di esso; questo scopo può essere lo sfruttamento dei
sottoposti, ma non è necessario che lo sia. Il concetto di Stato, quindi, non viene
affatto definito in maniera univoca attraverso lo scopo dello sfruttamento (pp. 6-7
[19]).
In questo ragionamento, logicamente inoppugnabile, che si offre apparentemente
come una critica immanente del marxismo, viene però subito e in maniera quasi
elementare alla luce la netta diversità della concezione sociologica (marxista) dello
Stato rispetto a quella kelseniana giuridico-formale. Per quest’ultima non si tratta
affatto dello Stato quale effettivamente è, quale vive e agisce nella realtà sociale,
quale si è realizzato e si è ulteriormente configurato da un punto di vista storico,
psicologico, causale. Per Kelsen è invece importante soltanto «lo Stato in quanto tale»,
quale esso esiste nel cielo dei concetti giuridici. Egli, pertanto, non mette neanche mai
in discussione il fatto che, forse, la molteplicità di significati della definizione giuridicoformale dello Stato è ricondotta a una univocità storica grazie al processo sociale.
Certo, «lo Stato in quanto tale» può perseguire scopi statali di mille tipi e, pertanto, la
definizione giuridico-formale dello Stato deve adattarsi a tutte queste molteplici forme
di Stato. Ma, nella realtà sociologica, forse, fra tutti questi scopi solo uno è stato
realizzato e poteva essere realizzato, allo stesso modo in cui, per esempio, anche lo
sviluppo del mondo animale avrebbe potuto realizzare diverse organizzazioni, ma
culmina nella forma organizzativa dei vertebrati. Ma proprio questa realtà è ciò a cui
unicamente s’interessa la sociologia e ciò che, pertanto, il marxismo cerca di
comprendere nello Stato. Ciò, però, sta completamente al di fuori della costituzione
dello Stato kelseniano. Quindi, qui non viene posta affatto la questione della natura
sociale dello Stato e, pertanto, ad essa non si dà neanche una risposta. Piuttosto, tutta
la problematica kelseniana e la sua critica del concetto marxista di Stato la si può
comprendere solo se si tiene presente il fatto che essa ha come oggetto solo quanto
segue: qualunque sia il rapporto effettivo della vita sociale, che storicamente è entrato
in azione come Stato, com’è concepito dagli uomini sotto l’unità di una personalità
statale? in quale specifico processo coscienziale i fatti sociali del vivere e dell’agire
insieme divengono forme giuridiche e statali?
Página 55
Questa
problematica
è
certamente
straordinariamente
importante,
anzi
fondamentale; ma si vede sùbito, è una problematica essenzialmente criticognoseologica e, in quanto tale, essa non ha immediatamente nulla a che fare con il
problema sociologico della nascita e dello sviluppo delle forme giuridiche e statali. È un
grande merito, ancora insufficientemente apprezzato, dei lavori di Kelsen di aver
portato avanti l’elaborazione normativa del concetto di diritto e di Stato, al di là della
prima impostazione di Stammler (che doveva insabbiarsi nella confusione fra
concezione teleologica e normativa), grazie alla rielaborazione della concezione
normativa portata a termine con stupefacente chiarezza e con acuta coerenza. Il modo
in cui Kelsen, nel suo campo, conduce la lotta della critica della conoscenza moderna
contro lo psicologismo, la sua purificazione del concetto di diritto e di Stato da ogni
fibrilla di volontà psicologica, finché tutte queste forme giuridiche appaiono piuttosto
come regole di determinati tipi d’imputazione, che risalgono da ultimo a pure relazioni
di norme (Normalbeziehungen), fanno parte delle cose piú acute e istruttive, che la
filosofia del diritto possa offrire riguardo alle parole enigmatiche che sono diritto e
Stato.
Questo apprezzamento del lavoro di Kelsen non viene per nulla diminuito dal fatto
che, come credo, l’eliminazione della volontà dal concetto critico-gnoseologico di diritto
e, pertanto, anche dal concetto di Stato, non è possibile: e in ciò ovviamente — in
questo son d’accordo con Kelsen — non penso alla volontà psicologica. Ma ogni norma
riconduce da ultimo alla volontà pura, è pensabile solo come forma di manifestazione
della medesima e ricava da ciò, dall’autonomia del volere puro, la forza obbligante. Fa
tutt’uno con ciò, inoltre, dal mio punto di vista, il fatto che non posso neanche
considerare la critica della conoscenza kelseniana propriamente come una critica della
conoscenza del conoscere sociologico, bensí soltanto come una discussione
normologica (normlogisch), che non è ancora pervenuta fino alle ultime necessità
concettuali del concetto di diritto e di Stato, un limite, che forse è voluto, ma che
tuttavia e proprio per questo ha necessariamente come conseguenza il pervicace
fraintendimento del punto di vista sociologico. La critica della conoscenza kelseniana
vuole arrestarsi a Stato e diritto in quanto concetti giuridici, e ne ha pieno diritto in
quanto logica giuridica. All’improvviso, però, ne deriva la concezione per cui Stato e
diritto sono pensabili soltanto come concetti giuridici, e da ciò deriverebbe poi
ovviamente la conseguenza per cui una sociologia, come scienza causale della società,
è impossibile, poiché la vita sociale si presenta sempre in qualche forma giuridica.
Notoriamente, Stammler ha ricavato questa conseguenza, mentre Kelsen non sembra
del tutto risoluto a
Página 56
far ciò. In verità, non si riesce a scorgere del tutto chiaramente ciò che egli vuol
lasciare alla sociologia; anche il suo volumetto, che del resto offre un eccellente
orientamento, Tra metodo giuridico e sociologico [Nota 1]; difende propriamente solo il
campo del primo e sembra equiparare la sociologia quasi alla psicologia sociale. Ma
tuttavia, sia qui, sia nella sua opera fondamentale Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre, l’esistenza di una sociologia come scienza causale non viene
contestata. Poiché però Stato e diritto, nella loro nascita e trasformazione,
costituiscono il tema principale di una tale sociologia, è allora naturale, anche da un
punto di vista di teoria della conoscenza, la domanda se Stato e diritto siano
effettivamente pensabili solo come concetti normativi, ovvero se essi non si fondino su
un’altra relazione concettuale, altrettanto elementare e che forse riconduce ancora di
piú nella legalità della coscienza. E mi sembra essere proprio questo il caso — come ho
già detto ripetute volte e, quindi, qui posso semplicemente accennarlo — in quanto
tutti i concetti giuridici devono essere da ultimo pensati come forme della
socializzazione. Ma la socializzazione non è una relazione normativa della coscienza
pura, fa parte bensí della coscienza teoretica, cioè delle forme conoscitive della
medesima. La conoscenza trascendentale, cioè le funzioni conoscitive che sole rendono
possibile ogni esperienza, sono contemporaneamente riferite, in maniera immanente,
in ogni coscienza singola, alla possibilità di una molteplicità indeterminata di attività
funzionali che concordano con la loro singolarità, e solo a partire da ciò si costruisce,
per la coscienza singola, il suo mondo di conoscenze universalmente valide, il suo
mondo sociale. Solo in tal mondo è possibile la relazione normativa e, quindi, lo Stato
e il diritto da un punto di vista giuridico. La conoscenza si sperimenta in maniera
individuale, ma, fin dall’inizio, com’è nello spazio e nel tempo, cosí è anche nella
socializzazione. La socializzazione dell’esperienza è l’ultimo fondamento trascendentale
della vita sociale in generale. Essa è l’elemento sociale-trascendentale, cui non può
non ricondurre ogni critica della conoscenza, che voglia fondare la sociologia, con un
sicuro significato specifico, come scienza causale [Nota 2].
Página 57
La originarietà e la caratteristica trascendentale del punto di vista normativo non
viene in tal modo assolutamente tolta. Deve essere subito eliminato il fraintendimento
per cui io penserei di dedurre la forma di pensiero normativa da quella teoretica della
socializzazione trascendentale. Questo sarebbe un grave errore e un disconoscimento
totale del principio trascendentale in generale. La coscienza normativa è un tipo
assolutamente ultimo e autonomo di legalità della coscienza in generale, che, in
quanto tale, viene vissuto quanto il tipo teoretico. Ma va qui introdotta una
annotazione, ove si può trattare soltanto di indicazioni per circoscrivere il proprio punto
di vista, non di una esposizione particolareggiata. È nota l’indicazione di Kant, che
scuote profondamente il pensiero, di fare attenzione a ciò, se cioè la ragione teoretica
e quella pratica, che si distinguono in maniera cosí rigida nell’essere e nel doveressere, alla fine tuttavia non si rapportino in una radice comune. Io non oso decidere
se questa radice sia già posta nell’elemento sociale-trascendentale. Ma se si tiene
conto del fatto che è posta qui l’origine della relazione dell’individuo con il prossimo in
generale, che solo a partire da qui prende le mosse quella molteplicità dei soggetti, che
costituisce quel mondo spirituale, che sperimenta la sua regolamentazione nella
norma, e che d’altra parte ogni norma riconduce a una volontà pura, che, nella sua
validità generale e nella sua assenza di contraddizioni racchiude inscindibilmente in sé
il riferimento a una molteplicità indeterminata di soggetti del volere: allora mi sembra
che qui, comunque, siamo giunti vicini, essenzialmente, al ceppo comune della legalità
della coscienza in generale.
Tuttavia non ci si può qui ulteriormente occupare di ciò e, del resto, né si mira a un
confronto critico con il punto di vista gnoseologico di Kelsen, né tale confronto può
essere portato a termine [Nota 3]. In questa sede si tratta soltanto, in quanto
indichiamo la
Página 58
tendenza e la caratteristica del lavoro di Kelsen, di mostrare la diversità di principio dei
nostri punti di vista. Conformemente a ciò, dunque, la trattazione kelseniana dello
Stato vuole essere soltanto una trattazione giuridica, o, per meglio dire: una critica
della conoscenza dei concetti giuridici, ove però passa anche l’idea che Stato e diritto
non possano essere altrimenti pensati che giuridicamente. Il suo problema, pertanto,
non è mai che cosa siano Stato e diritto, bensí in quale genere di pensiero ci muoviamo
quando parliamo di Stato e diritto, di sovranità e legge, di colpa, punizione e
obbligazione. Questa problematica ha come oggetto tanto lo Stato odierno quanto
quello babilonese, il diritto nella società borghese quanto quello di un tempo originario
di diritto matriarcale. È di natura completamente formale e, in quanto questione
critico-gnoseologica, non può neanche essere altrimenti. Nei suoi Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre, pertanto, Kelsen paragona, in maniera anche acuta, la teoria del
diritto alla geometria. Come questa, nella definizione della sfera, non tiene conto del
materiale, che la forma sferica contiene in sé, cosí i concetti giuridici non dicono nulla
circa i loro elementi contenutistici. Ed egli aggiunge:
Il rimprovero, che viene sempre ripetuto a un metodo puramente formale, per cui
esso darebbe risultati ‘insoddisfacenti’, poiché non comprenderebbe la vita reale,
lascerebbe inspiegata la vita fattuale del diritto, si fonda su un completo
disconoscimento della natura della giurisprudenza, la quale appunto non deve
comprendere la realtà del mondo dell’essere, non deve ‘spiegare’ la vita. [Nota 4]
Se le cose stanno cosí, e tenendo pure conto del fatto che Kelsen accenna
ripetutamente al fatto che il contenuto dei concetti giuridici rimane affidato a una
trattazione particolare, non piú formale, bensí causale e che qui, in particolare,
sarebbe il luogo della sociologia [Nota 5], allora la polemica contro la concezione dello
Stato nel marxismo agisce quasi come un increscioso fraintendimento metodologico.
Poiché la trattazione marxista non è una concezione semplicemente formale, giuridica,
bensí è appunto una concezione causale, sociologica, dei fenomeni statali e giuridici.
Ma questa polemica diviene possibile se si ha presente — ciò cui si è già accennato —
che la divisione fra trattazione giuridica e sociologica, in Kelsen, in fondo è soltanto
una divisione
Página 59
incompleta, poiché egli conosce solo una teoria della conoscenza dei concetti giuridici,
ma non una teoria della conoscenza dei concetti sociologici. Egli è pertanto
propriamente dell’opinione che Stato e diritto non possano essere compresi, da un
punto di vista teorico, altrimenti che in maniera giuridica; e l’abbandono di tutt’e due i
concetti alla sociologia per quanto riguarda il loro contenuto avviene solo precario
modo, cioè con l’idea che la sociologia qui non ha alcun proprio possesso, bensí può
configurare il suo oggetto solo con i concetti presi in prestito dalla scienza giuridica
[Nota 6]. In verità, quindi, in Kelsen il riconoscimento della sociologia è soltanto
apparente e ciò che egli chiama cosí si rivela, a una considerazione piú ravvicinata, in
parte come una storia del diritto e dello Stato, in parte come una rielaborazione sociopsicologica delle relazioni giuridiche e statali. E la polemica contro la concezione
marxista dello Stato ha il senso di mostrare che anch’essa — non che non sia giuridica;
questo sarebbe un risultato troppo particolare per una critica che lotta anche contro la
confusione metodologica — bensí da un punto di vista sociologico non può procedere
oltre: in breve, che non esiste, contrariamente alle ripetute assicurazioni verbali,
alcuna trattazione sociologica dello Stato. Passiamo dunque, dopo questa divagazione
di critica della conoscenza, nuovamente a questo scopo specifico della ricerca
kelseniana.
Página 60
Capitolo sesto
L’elemento essenziale nel concetto marxista di Stato
Ricordiamoci di ciò che Kelsen rimproverava al concetto marxista di Stato: sarebbe
concettualmente insufficiente considerare lo scopo dell’organizzazione del dominio, cioè
lo sfruttamento di una classe da parte di un’altra, come elemento determinante
dell’essenza dello Stato. «Poiché in primo luogo vi sono degli Stati, cioè delle
organizzazioni di dominio, in cui non è possibile mostrare lo sfruttamento economico
come loro contenuto essenziale; in secondo luogo, lo sfruttamento economico non è
neanche affatto l’unico scopo dello Stato moderno» [p. 19]. Anzi, ancora di piú, «si può
affermare che soltanto un ordinamento costrittivo è in grado d’impedire quella
condizione di sfruttamento». Non si deve neanche dimenticare che l’economia
capitalistica è nata proprio dal liberalismo, che proprio l’ordinamento economico che si
fonda sullo scopo dello sfruttamento ha lottato contro lo Stato, cioè contro
l’organizzazione costrittiva, fino quasi ai limiti della teoria anarchica e che, d’altra
parte, la legislazione di politica sociale è la dimostrazione del fatto che l’organizzazione
costrittiva, cioè lo Stato, è in grado di agire nella direzione di un arginamento dello
sfruttamento e del superamento dell’opposizione di classe. Il concetto marxista di
Stato sarebbe fondato solo se potesse essere mostrato che un dominio politico, che un
ordinamento costrittivo in generale, è possibile semplicemente con il mantenimento
dello sfruttamento economico, cioè del dominio di classe. Ma proprio quest’ultimo
presupposto è contrastato dal concetto, cosí importante nel marxismo, del dominio del
proletariato, che costituisce anche uno Stato, lo Stato di transizione proletario, la
dittatura del proletariato sulla borghesia, che non si fonda e non si vuol fondare
certamente sullo sfruttamento (pp. 6-13 [17-20, 37-42]).
Ciò che innanzi tutto ci tocca in particolare in questa critica è il fatto che Kelsen, il
quale altrimenti si sforza dappertutto di distinguere nella maniera piú netta i metodi
del pensiero nella dePágina 61
terminazione dei concetti, in questo caso va a urtare duramente contro questa
esigenza da lui giustamente fatta valere in maniera intralasciabile. Egli vuole offrire
una critica immanente del concetto marxista di Stato, cioè egli vuol mostrare come il
concetto di Stato del marxismo è contraddittorio per il suo contenuto stesso. Ma egli
comincia con il dimostrare che il concetto marxista di Stato non corrisponde... al suo
concetto di Stato, al concetto kelseniano di Stato, e con ciò emerge ovviamente ancora
una volta la diversità delle concezioni, ma adesso gravata del pericolo di andare a
parare in una disputa terminologica. In particolare, quando Kelsen adduce, contro il
marxismo, che sono esistiti anche Stati senza sfruttamento, quest’argomentazione ha
forza probativa solo dal punto di vista della sua concezione formale, poiché egli intende
per Stato semplicemente appunto l’organizzazione costrittiva della vita comunitaria.
Poiché però il marxismo prende le mosse non da un concetto di Stato formale, bensí
materiale, non da un concetto di Stato giuridico, bensí sociologico, questa critica non lo
scalfisce minimamente. Per il marxismo, non già ogni organizzazione costrittiva è uno
Stato, bensí soltanto quella il cui contenuto è il dominio di classe. Una critica
immanente, cioè una critica che si voglia porre sul terreno dello stesso concetto
criticato, deve mostrare, a proposito di questo concetto, che esso è impossibile
secondo i suoi propri presupposti, cioè è impossibile da un punto di vista sociologico,
non da un punto di vista giuridico.
Per il concetto marxista di Stato, quindi, è essenziale solo il fatto che lo Stato, come
si dice già nel Manifesto del partito comunista, è «il potere organizzato di una classe
per opprimerne un’altra». Questo contenuto essenziale Kelsen lo esprime in modo tale
che fa, dello sfruttamento di una classe da parte di un’altra, lo scopo dello Stato. Solo
che questo non è pensato in maniera marxista. Poiché lo sfruttamento di una classe da
parte di un’altra non viene anzi posto dallo Stato, è un dato di fatto economico. Lo
sfruttamento non è lo scopo dello Stato, anzi non è neanche lo scopo del processo di
produzione capitalistico. Il suo unico scopo è il profitto, la creazione di plusvalore, e lo
sfruttamento è soltanto una condizione necessaria per la realizzazione di questo scopo.
Non è dunque lo Stato a sfruttare la classe sottomessa, né, rispettivamente,
sottomette una classe allo scopo dello sfruttamento, ma la classe sfruttata nel
processo di produzione diviene sottomessa anche politicamente. Lo Stato non ha come
scopo lo sfruttamento, non è un mezzo per lo sfruttamento, bensí è la sua forma
pubblico-giuridica. «Lo Stato moderno», dice Friedrich Engels, «non è altro che
l’organizzazione che la società borghese si dà per mantenere le condizioni esterne
generali del modo di produzione capitalistico di fronte agli attacchi sia degli
Página 62
operai che dei singoli capitalisti» [Nota 1]. E, inoltre, lo Stato è un’organizzazione della
classe sfruttatrice in ogni periodo per mantenere le sue condizioni esterne di
produzione, cioè, in particolare, per tenere con la violenza la classe sfruttata nelle
condizioni di oppressione (schiavitú, servitú della gleba o semiservitú feudale, lavoro
salariato) date dal modo di produzione esistente [Nota 2]. Lo sfruttamento, quindi, non
viene creato dallo Stato e non può quindi neanche essere il suo scopo. Ma lo Stato
conferisce bensí a questo sfruttamento una forma determinata, appunto quella
dell’ordinamento giuridico. È esso a fare, degli agenti della produzione, dei dominanti e
dei dominati. Il fatto che questo è possibile solo grazie a una propria ideologia, grazie
all’ideologia giuridica, che ha le sue forme originarie, non deducibili dall’economia, e
che ha la sua propria legalità, non va certo contestato e proprio da Marx e Engels non
è stato contestato [Nota 3]; allo stesso modo in cui si deve ammettere che molti
marxisti non hanno riconosciuto questa autonomia della forma giuridica e ancor’oggi, a
causa di una deficiente preparazione di critica della conoscenza, non la comprendono.
Ma di ciò non ci si può ulteriormente occupare qui, ove non ci si occupa della forma
giuridica dello Stato, bensí della sua essenza sociale, di ciò che sorregge e riempie
quella forma.
Il fatto che lo Stato persegua ancora altri scopi, che non sono quelli dell’oppressione
di classe e dello sfruttamento — e al riguardo si pensa di solito e volentieri agli scopi
culturali — non è, proprio per quanto riguarda la sua natura sociologica, caratteristico.
Poiché, al contrario, il suo connotato effettivamente caratteristico, per cui esso è la
forma giuridica dello sfruttamento, determina completamente l’estensione e il livello
dell’interesse, con cui tutti gli altri scopi vengono perseguiti dallo Stato. Ne dà una
dimostrazione fin troppo eloquente la continua lagnanza di tutti
Página 63
gli spiriti preoccupati della cultura (Kultur), a partire da Rousseau, Kant e Herder. E,
chiunque sia interessato dal punto di vista spirituale, non sperimenta forse, nel suo
àmbito di lavoro, il fatto che per gl’interessi della cultura spirituale, anzi, per
gl’interessi delle semplici opere assistenziali, all’interno del sistema economico
capitalistico volto al profitto, cui servono tanto le costituzioni monarchiche quanto
quelle repubblicane, il bilancio dello Stato presenta solo delle voci misere e, in
confronto agli interessi di dominio (esercito, marina), ridicole, per tutti gli effettivi
interessi popolari? Perché la scuola del popolo non può essere portata a quel livello, cui
la pedagogia già da lungo tempo vorrebbe fosse posta? Perché non possono essere
istituiti ospedali e case di salute popolari nella quantità e con la dotazione necessarie?
Perché istituti scientifici devono accontentarsi del minimo indispensabile, a meno che,
per caso, qualche volta non venga in aiuto l’umore di un miliardario? Perché i mezzi di
comunicazione non possono essere costruiti in modo tale da offrire a ogni uomo del
popolo quella comodità, che solo il ricco ha nel treno di lusso? Perché per questo, e per
molte altre cose, lo Stato non ha alcun mezzo, e non vuole neanche averlo. Poiché
questi mezzi esso dovrebbe prenderli dai proprietari, cioè dovrebbe tagliare le entrate
che derivano loro dallo sfruttamento, e a questo punto cessa ogni perseguimento di
scopi, per quanto esso possa presentarsi in maniera ideale e rivolto al bene del popolo,
a meno che esso non sia — ma di ciò si parlerà ancora — in qualche modo imposto.
Certamente, dunque, gli Stati ‘perseguono’ anche scopi diversi da quello dello
sfruttamento (che del resto essi — come si è mostrato — addirittura non perseguono
nei limiti in cui non funzionano da datori di lavoro). Ma tutti questi scopi:
amministrazione della giustizia, educazione scolastica, tutela dell’arte e dei beni
spirituali, assistenza per il popolo, igiene ecc., costituiscono oggetti d’interesse
pubblico solo in una sfera ristretta, che coincide con il minimo di ciò che serve al
mantenimento dell’ordinamento statale in generale. Se le opere assistenziali non
fossero necessarie per mantenere il popolo sufficientemente sano, per fornire soldati
per l’esercito e forza-lavoro per la macchina; se l’educazione scolastica non fosse
necessaria perché altrimenti militarismo e industria non funzionerebbero; se l’igiene
non fosse auspicabile — visto che si vive in una città insieme con il popolo povero —
per difendersi dal contagio, allora anche questi scopi, in quanto scopi non redditizi,
cadrebbero fuori dell’interesse pubblico dello Stato, come del resto si verificava in
epoche piú antiche (si pensi solo agli inizi della grande industria in Inghilterra). Al di là
di questo minimo, ognuno di questi scopi appare come un interesse privato, appare
lodevole e apprezzabile servire ad esso, ma tuttavia, contemporaneamente, appare
come una specie di lusso,
Página 64
che, appunto, solo il lusso può permettersi. Kelsen dice giustamente che tutto ciò non
ha nulla a che fare con la forma giuridica dello Stato, in cui tutti gli scopi ideali
potrebbero trovare ugualmente il loro compimento umanamente possibile. Certo: ma
ciò dimostra soltanto quanto poco siamo stati utili alla nostra conoscenza dell’essenza
dello Stato quando abbiamo messo allo scoperto la sua forma logico-giuridica. Quando
dello Stato so soltanto che è una organizzazione costrittiva, con questo non mi è stato
detto nulla sull’essenza dello Stato in cui viviamo, in cui da secoli si formano i destini
dell’umanità e da cui si producono le grandi tendenze di trasformazione in un nuovo
futuro. Solo la considerazione sociologica ci discopre la funzione e l’importanza di
questo ordinamento costrittivo. Il concetto giuridico di Stato mi fa capire come penso
quando parlo di Stato e diritto: cioè, il fatto che riferisco i fenomeni della vita sociale
all’unità di un ordinamento giuridico. Ma che cosa penso con questi concetti, quali
fenomeni compongono questo ordinamento: riguardo a tutto ciò quel concetto non dice
proprio nulla. E tuttavia solo ciò esprime l’essenza di una conoscenza dello Stato;
poiché quel concetto dello «Stato in generale» non esiste mai e in nessun posto, ma è
sempre un determinato ordinamento costrittivo che esiste come Stato. Se Kelsen a
questo proposito mi dice che è proprio questa la distinzione fra il punto di vista
giuridico e quello sociologico, gli do ragione; solo che allora non avrebbe dovuto
chiamare il punto di vista sociologico del marxismo di fronte al tribunale della sua
critica giuridica.
Ora, però, il concetto marxista di Stato dovrebbe essere in sé contraddittorio perché,
da una parte, lo sfruttamento capitalistico nel sistema del liberalismo nega
l’ordinamento statale quasi fino al limite dell’anarchismo, mentre d’altra parte,
all’interno dello Stato capitalistico, la politica sociale mostra che lo sfruttamento può
essere superato grazie a delle leggi, per cui allo Stato si può addirittura collegare una
tendenza verso il superamento dello sfruttamento. Queste critiche mostrano di nuovo
come il modo di pensare di Kelsen, del tutto formale, sia completamente incapace di
addentrarsi in profondità nel modo storico di concepire, che è proprio del marxismo. Il
punto di vista sociologico non è solo logicamente diverso da quello giuridico, ma scorre
— per cosí dire — in una dimensione completamente diversa. Mentre il punto di vista
formale è atemporale, quello materiale non può prescindere da un riferimento al
tempo; mentre la concezione giuridica vede il suo oggetto in riposo, coglie per cosí dire
l’elemento statico nel mutamento dei fenomeni, la concezione sociologica segue questo
movimento senza tregua e non può non essere, necessariamente, dinamica. Per questa
dinamica dei concetti marxisti — che i suoi fondatori hanno chiamato dialettica — non
ha alcuna attenzione Kelsen, che crede di esercitare
Página 65
una critica soltanto immanente, ma in realtà non riesce a venir fuori dalla sua pelle
puramente formale, logico-giuridica. E solo in tal modo sono divenute possibili quelle
critiche che Kelsen ritiene effettivamente decisive per eliminare il concetto marxista di
Stato, secondo cui lo Stato è semplicemente la forma giuridica pubblica dello
sfruttamento.
Se invece si colgono le cose in maniera dialettica, come fa il marxismo, «nel loro
flusso, nel loro movimento storico», risulta allora quanto segue: il liberalismo era
‘liberale’ solo in relazione al sistema di regolamentazione e di violenza contro cui
combatteva. Esso non negava ‘lo Stato’ in generale, bensí soltanto lo Stato che
rappresentava una catena per esso, cioè per la borghesia in fase ascendente, per il
capitalismo che si andava sviluppando. Esso combatteva il feudalesimo, lo Stato di
polizia, il sistema delle corporazioni e dei privilegi [Nota 4]. Ed esso lottava non per ‘la
libertà’, bensí per le libertà del terzo stato, innanzi tutto per la libertà di commercio,
cioè per la libertà dello sfruttamento. Là dove non si trattava della sua libertà, cioè
della libertà della borghesia, anche il liberalismo aveva subito a portata di mano ‘lo
Stato’. Per questo esso, ogni qualvolta raggiungeva il dominio, la faceva finita
radicalmente con ogni libertà degli altri, anzi la denunziava come ‘anarchia’, in quanto,
com’è noto, combatteva come anarchico anche ogni movimento del proletariato che
tendesse a conquistare anche per sé piú libertà. E, ancor’oggi, per il borghese
benpensante, socialismo e anarchismo sono toute même chose. Il liberalismo, in
quanto teoria dello Stato, lungi dal costituire una confutazione della teoria delle classi
del concetto marxista di Stato, può essere in generale compreso solo a partire da
questa, a meno che non si vogliano prendere le sue illusioni cosmico-storiche per oro
colato e non si vogliano spargere lacrime per il crollo di quegli elevati ideali umanitari,
quali comunque erano quelli della rivoluzione francese. L’idea del liberalismo, secondo
cui lo Stato dovrebbe limitarsi al minimo della difesa della vita e della proprietà dei
suoi cittadini e, al di là di questo, far sí che ognuno si curi di se stesso
Página 66
nella maniera migliore possibile — quest’idea, che sapeva parlare in maniera cosí
sublime della libertà dell’individuo e della dannosità della costrizione statale — in fondo
non era altro che l’espressione dell’interesse economico della classe degli imprenditori
capitalistici di essere sicuri di non venire derubati e uccisi nei loro affari, ma, al di là di
ciò, di poter liberamente fare ciò che fosse necessario per concludere questi affari, in
particolare, di essere completamente liberi di fare contratti salariali con i ‘loro’ operai
come gli piaceva. Il minimo di ‘diritto dell’uomo’ alla difesa della proprietà e della vita
bastava a questa ‘negazione’ dello Stato per far marciare immediatamente tribunali e
soldati, quando gli operai si prendevano la libertà di non voler lavorare come
pretendevano gl’imprenditori e di preferire piuttosto di fare la fame, cioè di scioperare.
Tutto ciò rimane celato, giustamente, in quanto per esso indifferente, a un punto di
vista semplicemente logico-giuridico; il punto di vista sociologico non può
prescinderne, ma rimane tuttavia anche tutelato sia di fronte al rischio di scorgere nel
liberalismo l’avvocato difensore dello sfruttamento, ma, allo stesso tempo, anche di
fronte a quello di scorgere in esso una contraddizione rispetto al carattere costrittivo
dello Stato di classe [Nota 5].
Página 67
Ugualmente, solo un modo di trattazione del tutto formale e astorico può vedere nella
politica sociale la tendenza al superamento dello Stato di classe. Sarebbe cosí se la
‘politica sociale’ fosse in potere autonomo, al di sopra delle classi! C’è comunque
sempre stato un gran numero d’ideologi ottimisti, che hanno creduto a una tale
divinità, che si sono dedicati al suo servizio e che addirittura, come partito di coloro
che si dedicavano alla politica sociale, s’immaginavano di poter salvare lo Stato dal suo
male fondamentale dall’opposizione di classe. E dappertutto questo partito è stato
schiacciato, fino a divenire privo di significato, fra le pietre da macina di questa
opposizione. La legislazione di politica sociale è nata essenzialmente da due radici:
innanzi tutto, dal bisogno della classe dominante di addolcire l’impoverimento del
proletariato, che cominciava a rendere quest’ultimo inabile al processo di produzione e
al militarismo e, inoltre, lo trasformava in una massa sempre piú minacciosa; ma in
secondo luogo, e successivamente, dalla pressione del proletariato organizzato. Sotto il
primo profilo la politica sociale non significa una tendenza al superamento dello
sfruttamento capitalistico, bensí alla sua conservazione. Le misure di politica sociale,
quali vengono dapprima prodotte per iniziativa della classe dominante (limitazione del
lavoro delle donne e dei fanciulli, riposo domenicale, assicurazioni contro le malattie e
gl’infortuni), sono per cosí dire degli investimenti per condurre a termine nella maniera
migliore e, innanzitutto, in maniera indisturbata, gli affari, e questo lo capiscono subito
perlomeno gli elementi piú intelligenti e quelli che pensano politicamente all’interno
della classe imprenditoriale [Nota 6]. Ma nella seconda direzione la legislazione di poliPágina 68
tica sociale è direttamente il risultato della lotta di classe stessa, cioè il risultato,
strappato con le minacce alla classe dominante piú o meno dal proletariato, di un
movimento rivoluzionario rivolto alla lotta contro lo Stato di classe stesso. E anche là
dove questo movimento sia soltanto di natura sindacale, per cui non si può definire
propriamente rivoluzionario il proletariato da esso guidato, la tendenza verso questa
limitazione dello sfruttamento non sta appunto nello ‘Stato’, cioè nella volontà delle
fasce sociali dominanti in questa organizzazione costrittiva, ma viene ad esso impressa
con la forza dal potere delle organizzazioni operaie, o, rispettivamente, si produce
come risultante di queste forze. Comunque, il fatto che ogni disegno di legge di politica
sociale venga subito accolto dalla piú aspra lotta di classe e, ancor di piú, il fatto che la
difesa ufficiale e legale delle leggi in difesa degli operai scritte nei codici possa
diventare una difesa quasi corrispondente al suo significato solo grazie a una lotta
incessante delle organizzazioni operaie, dimostra quanto poco la politica sociale possa
essere definita una tendenza dello Stato all’abolizione dello sfruttamento economico.
Dal momento che le leggi in generale vivono solo nei limiti
Página 69
in cui operano degli interessi volti alla loro applicazione, si può allora tranquillamente
dire, anzi non si può non riconoscere, che ogni politica sociale è viva solo nei limiti in
cui l’attività della classe operaia, avversa allo sfruttamento e allo Stato di classe, la
riempie di un’azione effettiva.
Tutt’e due questi argomenti, dunque, secondo cui il liberalismo, da una parte, e la
politica sociale, d’altra parte, rendono contraddittorio il concetto marxiano di Stato, si
sono rovesciati nel loro contrario, in quanto abbiamo visto come ambedue siano
comprensibili solo grazie a questo concetto nel loro specifico rapporto sociologico con
lo Stato, un rapporto che può essere tralasciato solo grazie alla concezione
fondamentale, del tutto formale, di Kelsen. Si è palesato, allo stesso tempo, che
ambedue queste argomentazioni in generale sono possibili solo in quanto la critica di
Kelsen — contrariamente all’intenzione manifestata nelle parole di mantenersi sul
terreno del concetto criticato, quindi di essere immanente — è rimasta ferma al suo
punto di vista puramente formale e, pertanto, non poteva non tralasciare in particolare
il significato storico del concetto marxista di Stato, il suo carattere dinamico. Ora,
come stanno le cose per quanto riguarda l’ulteriore argomentazione di Kelsen, da cui si
deve produrre, in maniera particolarmente drastica, l’impossibilità concettuale della
concezione marx-engelsiana dello Stato, per cui lo Stato borghese dev’essere dissolto
da quello proletario, il quale però, dal momento che non potrebbe piú avere come
scopo lo sfruttamento, non sarebbe tuttavia pitl uno Stato? In quanto il marxismo
parla di uno Stato di classe del proletariato, della dittatura del proletariato, anzi,
poiché questi concetti sono appunto idee guida della sua teoria politica, esso esprime
chiaramente il fatto che dunque vi è uno Stato che non è un’organizzazione dello
sfruttamento e toglie quindi, secondo l’opinione di Kelsen, il suo proprio concetto di
Stato.
In questa polemica vediamo svilupparsi ulteriormente i disastrosi effetti
dell’ineliminabile formalismo kelseniano. Allo stesso tempo diviene qui molto
percepibile, come fonte continua di errori, l’erronea opinione, già rifiutata, secondo cui
il concetto marxista di Stato scorgerebbe lo scopo dello Stato nello sfruttamento
economico. Kelsen attribuisce al marxismo un concetto dello Stato in quanto tale; ma
lo Stato in quanto tale è, per i marxisti, in generale, un concetto non utilizzabile, bensí
una astrazione per divenire tutt’al piú consapevoli del fatto che con questa definizione
generale si riassume una quantità di fenomeni storici molto diversi, circa il cui
carattere essenziale con quell’astrazione si dice tanto poco quanto poco si dice con il
concetto di modo di produzione in quanto tale circa la distinzione fra l’economia
familiare (Oikenwirtschaft) e l’economia capitalistica. Il marxista, pertanto, propriaPágina 70
mente conosce non lo Stato, bensí lo Stato capitalistico, cui in particolare si riferisce il
suo interesse teorico e pratico. E anche quando parla dello Stato semplicemente, nella
sua concezione immanentemente storico-dinamica egli pensa sempre, con ciò, allo
Stato borghese. Se pertanto egli usa, in qualche caso, la parola Stato per un altro
sostrato, per esempio per lo stato proletario, allora l’oggetto cosí indicato è appunto
qualcosa di diverso dallo Stato borghese. Pertanto non si può scorgere a priori nulla di
particolare o di contraddittorio nel fatto che non tutti i connotati dello Stato borghese si
riscontrano nello Stato proletario. L’elemento essenziale per il concetto marxista di
Stato è soltanto questo, il fatto che si tratta di un dominio di classe, per cui
l’organizzazione comunitaria, in quanto Stato, rappresenta sempre una forma di
oppressione.
Ma Kelsen identifica continuamente dominio di classe e sfruttamento economico e con
tono trionfante chiede: dov’è, nello Stato proletario, questo sfruttamento, cui il
proletariato vuol porre fine? Anzi, ancora di piú: dov’è in questo Stato, il dominio di
classe? Poiché questo sarebbe possibile soltanto grazie allo sfruttamento economico;
quello di classe sarebbe un concetto economico, che deriva la sua origine dalla
posizione dell’uomo nel processo di produzione. Se si riflette sul fatto che, anche dopo
la vittoria, il proletariato può sí impadronirsi tutt’in una volta del potere politico, ma
solo poco alla volta può abolire il capitalismo, perché la trasformazione della
produzione capitalistica in quella socialistica è possibile compierla solo in maniera
graduale, allora nello Stato proletario addirittura continua a sussistere la borghesia
«ancora per un certo tempo come classe sfruttatrice» (p. 12 [41]). Ma «un dominio di
classe senza sfruttamento economico è un non senso. Un gruppo di uomini non può
dominare come ‘classe’ e insieme essere dominato economicamente come classe» (p.
14 [44-5]). Di fatto, quindi, il dominio del proletariato nello Stato da esso costituito
non è piú un dominio di classe contro una classe oppressa, bensí appunto, come in
ogni Stato, un’organizzazione costrittiva per tutti. «Nel cosiddetto Stato di classe
proletario, i resti della borghesia — che si vanno continuamente fondendo insieme —
tuttavia non sono ‘dominati’ diversamente da come lo sono i membri del proletariato
stesso» (p. 14 [43]). Non si tratta piú del dominio di una classe, bensí di un partito,
dal concetto economico di proletariato si è passati al concetto politico di un partito del
proletariato. E l’idea sociologica dello Stato di classe proletario va cosí a parare in
elementi interpretabili in maniera puramente giuridico-formale, in particolare in una
organizzazione costrittiva, il cui contenuto viene posto dai postulati di un partito che
persegue determinate norme giuridiche.
Di fronte a questa argomentazione, che abbandona ad ogni punto
Página 71
il terreno del marxismo, anzi, propriamente, gli scorre accanto, è difficile per i marxisti
riportare le cose nel loro effettivo rapporto concettuale marxista. Poiché, quasi ad ogni
parola usata da Kelsen, classe, partito, concetto economico e concetto politico,
dev’essere intrapresa la traduzione dal linguaggio giuridico in quello nostro sociologico.
Si palesa a questo punto, in maniera particolarmente vistosa, come, nonostante le
numerose citazioni, sia impossibile dominare una teoria, e tanto piú criticare una
teoria, che — abituati ai concetti statici del proprio punto di vista formale — non si
riesce, dato il dinamismo, caratteristico e necessario, delle sue funzioni concettuali, a
inserire nel proprio modo di pensare. Vogliamo tuttavia tentare di esporre le differenze
piú importanti che esistono fra la concezione del professor Kelsen e la nostra.
Página 72
Capitolo settimo
Che cos’è una classe?
Innanzi tutto va dunque rifiutata l’identificazione fra oppressione di classe e
sfruttamento economico. Nello Stato proletario la classe della borghesia viene oppressa
sebbene non possa venir sfruttata economicamente, la quale ultima cosa non fa
neanche parte della forma di questa dominazione. Mentre il dominio di classe della
borghesia era la forma in cui essa manteneva il suo sfruttamento economico, il
dominio di classe proletario è la forma in cui esso — sia pure soltanto poco alla volta —
toglie questo sfruttamento. Sia nell’uno sia nell’altro caso ciò è possibile solo a patto di
una violenza esercitata contro gl’interessi di classe contrapposti. Qui, certo, è
necessario far chiarezza sul concetto marxista di classe. Kelsen lo definisce — nel
quadro della concezione marxista — come un concetto semplicemente economico, che
egli vede pertanto spogliato di ogni contenuto politico. E ciò gli sembra corrispondere
chiaramente alla concezione fondamentale del marxismo, alla concezione materialistica
della storia, che anzi dichiara l’‘economia’ fondamento di ogni ideologia, quindi anche
della ‘politica’.
La concezione materialistica della storia — come abbiamo già visto abbondantemente
all’inizio di questo libro (pp. 4 ss. [cfr. supra, pp. 12-3]) — ha la sfortuna di essere
stata per lo piú incompresa e uno dei concetti piú misconosciuti, fra i suoi avversari
borghesi, è il concetto dei rapporti economici. Poiché non ci si può rappresentare in
maniera abbastanza ‘materialistica’ i rapporti economici, che secondo questa teoria
costituiscono gli elementi determinanti fondamentali dell’evento sociale, ci s’immagina
al riguardo abitualmente una situazione ‘economica’ spogliata di ogni formazione
(Formung) spirituale, la cui amorfa qualità naturalmente nessuno può propriamente
descrivere, una deficienza che poi si addossa alla teoria stessa come difetto logico
fondamentale. Non è possibile qui dire in maniera dettagliata — ciò che ho fatto altrove
— il fatto che significa sopprimere violentemente ogni comPágina 73
prensione della concezione materialistica della storia qualora non si sappia che,
secondo questa, non esiste alcun dualismo fra una materia economica aspirituale e una
vita spirituale su di essa costruita, ma che i rapporti economici non sono altro che
rapporti di produzione e di scambio, cioè rapporti fra uomini, quindi rapporti spirituali,
e che quindi un unico legame di natura spirituale avvolge tutti i fenomeni sociali, dai
fenomeni economici fino alle altezze della contemplazione mistica. Non va tralasciato il
fatto che Marx definiva l’elemento ideale come «l’elemento materiale trasposto nella
testa dell’uomo» e che questa trasposizione spirituale dell’elemento materiale è il
concetto portante del materialismo economico, come dimostrano già le marxiane tesi
su Feuerbach. Solo questa trasposizione fa dell’elemento materiale qualcosa di sociale:
solo in quanto l’elemento materiale entra nello specifico rapporto funzionale ideale
«della testa dell’uomo», cioè viene appercepito nelle forme dell’esperienza sociale,
dell’elemento social-trascendentale, essendo riferito al legame originario della
coscienza individuale con una coscienza in generale, nasce una natura sociale, nascono
fenomeni sociali nelle diverse forme della coscienza sociale [Nota 1].
I rapporti economici, le condizioni e i processi economici, in breve, l’‘economia’ in
generale, non è affatto possibile pensarla a prescindere da una qualche forma di
ideologia sociale, e la teoria della concezione materialistica della storia, secondo cui
l’‘economia’ sarebbe il fondamento per tutta la sovrastruttura della coscienza sociale,
significa, se rettamente compresa, che il concreto riempimento storico delle forme
della coscienza sociale riceve l’impulso determinante da quella sfera, in cui viene
assicurato il mantenimento e il rinnovamento della vita; che questo complesso di scopi
e di limiti, che definiamo economici, ha da una parte una funzione direttiva per lo
sviluppo di ogni ideologia; significa che è da essa che — sia pure da ultimo e in forma
mediata e celata — prendono l’avvio i suoi problemi; e significa d’altra parte che quella
sfera è determinante per il fondamento e l’estensione in cui questi
Página 74
problemi acquistano importanza sociale. Ma ‘l’economia’ è essa stessa sempre un
elemento inscindibile, un elemento spirituale — estraibile solo nell’astrazione — di tutto
questo rapporto ideologico, in quanto essa esiste anzi solo in forme giuridiche, morali,
politiche, i religiose [Nota 2].
Dopo questa necessaria digressione sul significato della concezione materialistica
della storia è ora chiaro che, quando la teoria marxista parla di concetti economici, con
questo non può pensare a fatti che cadano fuori del rapporto dell’ideologia sociale,
bensí che, al contrario, essa abbraccia insieme in ogni caso questa ideologia, ma cerca
di chiarirsela dal lato della sua determinazione economica. Se quindi per il marxismo il
concetto di classe è sicuramente un concetto economico, questo non significa che per
esso non possa allo stesso tempo essere un concetto giuridico, politico, anzi un
concetto morale; è tutte queste cose insieme, solo viste dal lato della determinazione
economica, ed è proprio grazie a questa prestazione comprensiva che anzi la
concezione economica della storia diviene una concezione sociologica, che i concetti
economici
Página 75
fondamentali divengono allo stesso tempo concetti sociologici. Essi sono possibili solo
come categorie sociali: a partire dalla direzione economica iniziale essi discoprono la
realtà della società intera.
Se quindi, secondo la concezione marxista, la classe è innanzi tutto un concetto
economico, è subito chiaro che essa con ciò non viene calata in una materia economica
morta — il che sarebbe una rappresentazione impensabile non solo per il marxismo,
ma in generale —, bensí al contrario nella vivacità del rapporto sociale complessivo
stesso, che essa orienta soltanto secondo punti di vista economici. La classe, in quanto
concetto politico, non solo non si distingue dal suo concetto economico, ma il primo,
anzi, è soltanto quest’ultima articolazione economica consapevolmente colta. Nei limiti
in cui si attribuisce carattere politico a tutte le relazioni che sussistono per la vita nello
Stato — sia che si tratti di relazioni positive o negative — allora, una volta presupposta
come data l’opposizione di classe, tutti i momenti della classe devono essere
contemporaneamente economici e politici: poiché nei primi le classi si costituiscono,
nei secondi agiscono. Pertanto, già nella Miseria della filosofia, Marx scriveva: «Non vi
è alcun movimento politico che non sia contemporaneamente un movimento sociale»
[Nota 3]. Per il punto di vista sociologico del marxismo, pertanto, l’elemento
economico della classe non va affatto separato da quello politico. Soltanto il loro
insieme costituisce l’uno e l’altro in quanto fenomeno sociale (soziale), in quanto
fenomeno della società (gesellschaftliche).
Ma osserviamo ancora piú da vicino questo concetto fondante del marxismo. Che
cos’è una classe? Non si può fare a meno di rimpiangere sempre di nuovo il fatto che
Marx non abbia portato a termine il capitolo trentaduesimo del vol. III del Capitale, che
doveva trattare il concetto di classe, per cui esiste solo un inizio striminzito di questo
capitolo. Ma persino questo contiene già un accenno importante, in quanto il problema:
che cosa è una classe? viene da Marx trasformato nell’altro problema “Che cosa
costituisce una classe?” [Nota 4] A prima vista, dice Marx, sembra come se questo sia
dovuto «all’identità dei redditi e delle fonti di reddito». Ma Marx rifiuta questa risposta
perché in tal modo ognuno degl’innumerevoli gruppi di uomini nati dalla divisione
sociale del lavoro, che abbia una particolare fonte di reddito, sarebbe già una classe e,
per esempio, i medici e gli impiegati costituirebbero due classi. Con questa critica
s’interrompe purtroppo il manoscritto.
Si deve certo lamentare il fatto che il capitolo sulle classi sia rimasto, in Marx, un
frammento, come, in generale, il fatto che
Página 76
non abbiamo — né da parte di Marx, né da parte di Engels — un’esposizione
complessiva del loro concetto di classe e di lotta di classe. Ma, ora, concludere da ciò
che, poiché Marx e Engels non sono pervenuti a esporre in maniera sistematica la loro
concezione del concetto di classe, essi in generale non ne abbiano avuto alcun concetto
chiaro e stabile, sarebbe bensí un tipo di logica brutale, in particolare brutale rispetto
alla possibilità di poter migliorare la propria comprensione. E, tuttavia, questo tipo di
critica fa parte dei pezzi brillanti della lotta accademica contro il marxismo. Anzi, com’è
noto, in base al medesimo metodo — dopo R. Stammler — si pronunziano sentenze
oracolari circa l’«incompiutezza» della concezione materialistica della storia e circa il
fatto che essa non è stata «pensata fino in fondo», poiché neanche nel suo caso si
dispone di un edificio teorico sistematico. Il marxismo, comunque, in tanto «non è
pensato fino in fondo», in quanto esso, nato dai compiti della lotta sociale e in parte in
essi sviluppatosi, lascia anche qualcosa da pensare a chi lo voglia cogliere nell’insieme.
Ma, di fronte al marxismo, che pertanto esige che si ricostituisca in maniera autonoma
il rapporto che i suoi concetti hanno avuto nello spirito dei suoi creatori, manca
completamente la volontà e, a quanto sembra, anche la capacità, di prendere
effettivamente su di sé questa «fatica dello spirito», come la chiamava Hegel. E cosí la
dotta critica perviene alla conclusione — per essa sola umiliante — di pensare, in tutti i
casi in cui i concetti di Marx e Engels riguardo a un oggetto (come per esempio la
concezione materialistica della storia o il concetto di classe) si trovino dispersi in
innumerevoli brani e, pertanto, in piú di un caso mostrino anche delle contraddizioni
nel particolare, sovente solo nella forma espressiva, di pensare dunque che alla loro
base non vi sia neanche alcuna concezione complessiva di carattere unitario. Invece di
cercar questa, tali critici si accontentano di sputar sentenze su singoli frammenti e di
fare i pedanti in maniera indegna, senza tener conto delle parole di Kant, con cui si
rigetta ogni critica di tal genere:
In singoli punti, ogni esposizione filosofica può essere attaccabile [...]; con tutto ciò,
la struttura del sistema, considerata come unità, non corre il minimo pericolo per
questi attacchi: pochi soltanto posseggono la scioltezza di mente, che è necessaria per
abbracciare con lo sguardo un sistema, quando è nuovo, e ancora in minor numero poi
sono quelli che hanno voglia di farlo [...]. Sottilizzando [...] si possono trovare anche
delle apparenti contraddizioni, se si confrontano tra loro singoli passi, avulsi dal loro
contesto [...] ma [tali contraddizioni] sono assai facilmente risolubili, per chi si è
impadronito dell’idea complessiva. [Nota 5]
Página 77
Quando per esempio Hans Delbrück [Nota 6] definisce l’esposizione del Manifesto
comunista, nel punto in cui espone il concetto della storia della società come storia di
lotte fra classi, come «un’insalata di frutti acerbi» e fa valere la critica per cui Marx non
avrebbe conosciuto la distinzione fra classe e ceto, visto che nel Manifesto si parla
contemporaneamente della lotta fra liberi e schiavi, fra membri della corporazione
(Zunftbürger) e artigiani (Gesellen) ecc.; quando Rudolf Stammler, nella sua opera piú
recente [Nota 7], nella sua presa di posizione — che, e questo è degno di nota, non si
è lasciata scoraggiare né dalla critica di Max Weber né da quella mia [Nota 8] —
rispetto all’«incompiutezza» della concezione materialistica della storia e al suo «non
esser pensata fino in fondo» cosí scrive: «La teoria della lotta di classe è bensí l’errore
piú dannoso del socialismo moderno [...]. Essa fallisce perfino per i seguaci del
materialismo sociale, poiché essa non corrisponde né alle esigenze di una chiara
comprensione dei concetti qui necessari né neanche al chiarimento dei punti di vista
decisivi per la legittimazione delle tensioni sociali», ci troviamo soltanto di fronte a due
esempi — offerti da due rappresentanti autorevoli della dotta critica — di ciò che
addirittura è possibile nel verde bosco della scienza. Il fatto che proprio Marx abbia
rielaborato nella maniera piú decisa la distinzione fra classe e ceto — come vedremo
piú avanti — e il fatto che, pertanto, per esempio, abbia amaramente schernito
Lassalle, perché questi, nel suo discorso Ueber den besonderen Zusammenhang der
gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes [Sul particolare
rapporto dell’attuale periodo storico con l’idea del ceto operaio], definisce la classe
operaia un ceto [Nota 9], in tal modo non può non rimanere naturalmente celato a un
dotto, che vuol soltanto ‘attaccare’ il marxismo piuttosto che studiarlo e, a questo fine,
‘estrapola’ dall’immensa quantità del suo materiale, una, dico una frase del Manifesto
comunista, sebbene un tal metodo non faccia parte propriamente delle virtú
professionali di uno storico. Ma, naturalmente, altrettanto poco sono virtú professionali
quelle del filosofo sociale Stammler, il quale, tranPágina 78
quillamente, accredita come deficiente comprensione di Marx e Engels quelle cose che
egli stesso non è riuscito a pensare fino in fondo nel marxismo, cioè tutto ciò che egli
non comprende nel marxismo e, per quanto riguarda il rapporto fra i singoli brani,
rapporto che egli non trova, si tranquillizza, soddisfatto di sé, attribuendo ciò a una
deficiente «comprensione dei concetti qui necessari» in Marx.
L’opinione secondo cui le vedute di Marx e Engels sulla natura della classe siano
altrettanto frammentarie del capitolo sulle classi nel Capitale è, invece, tanto ridicola
quanto erronea. Poiché la risposta al problema: “Che cosa costituisce una classe?”
Marx l’aveva già data negli scritti del tempo in cui aveva concepito le sue vedute
fondamentali, nella Miseria della filosofia e nel Manifesto comunista e, poi, in maniera
del tutto particolare, nel frammento della Introduzione a Per la critica dell’economia
politica. Basta soltanto che noi collochiamo gli accenni ivi contenuti nello spirito della
concezione marxista per far chiarezza sul concetto sociologico di classe. In base a ciò,
innanzi tutto, anche la classe — come tutti gli altri concetti marxisti — è una categoria
storica. Essa cioè non è una forma necessaria della vita sociale stessa, ma è divenuta
necessaria solo per cause storiche determinate. Orbene, queste cause stanno nella
struttura economica della società, nel genere del suo processo di produzione e della
sua distribuzione, della sua suddivisione dei beni [Nota 10].
La distribuzione non costituisce, rispetto alla produzione, una sfera autonoma, che
scorra all’esterno di essa o accanto ad essa, ma, al contrario, non è altro che una
funzione della produzione. Marx ha esplicato questo punto, che poi doveva costituire il
contenuto
Página 79
del secondo e del terzo libro del Capitale, in forma certo abbozzata, ma tuttavia molto
efficace, nel frammento della Introduzione a Per la critica dell’economia politica. Ivi egli
si rivolge contro «la rozzezza e la aconcettualità (Begriffslosigkeit)» del punto di vista
dell’economia politica borghese, per cui produzione, scambio, distribuzione e consumo
sono soltanto sfere separate dell’economia politica, per cui l’«insieme organico» viene
rozzamente smembrato per esser poi messo casualmente in relazione ed essere
portato in un semplice rapporto di riflessione. Egli mostra invece come non soltanto
produzione e consumo hanno un rapporto fattuale inscindibile, in quanto la produzione
è allo stesso tempo consumo, logorio di beni produttivi, e il consumo è insieme
produzione; creazione di un nuovo mercato per lo smercio, di un’occasione di
produzione; in quanto inoltre la produzione forma e trasforma il modo del consumo
stesso e il consumo produce sempre nuovi bisogni per la produzione. Ma anche la
distribuzione, la suddivisione dei beni prodotti non si presenta come un momento
casuale a autonomo fra produzione e consumo, ma costituisce insieme con questi un
insieme sociale, in cui il fattore determinante è il modo di produzione e il livello della
produzione. «Una produzione determinata determina quindi un consumo, una
distribuzione, uno scambio determinati, nonché i determinati rapporti tra questi diversi
momenti» [Nota 11]. Tuttavia hanno luogo anche effetti retroattivi della distribuzione e
del consumo sulla produzione; ma l’insieme costituisce tuttavia un processo, «in cui la
produzione è l’effettivo punto di partenza e perciò anche il momento che abbraccia e
supera gli altri» [Nota 12].
Le classi — noi, come Marx, consideriamo la proprietà fondiaria, il capitale e il lavoro
salariato come le loro tre principali grandi articolazioni — si presentano dapprima come
risultato della distribuzione. Il prodotto sociale della produzione viene diviso fra
proprietari fondiari, possessori di capitali e operai. Ma questa suddivisione non sta
sospesa per aria né si basa sulla volontà di una qualche potenza, saggia o meno, che
domini sugli uomini. Essa ha piuttosto i suoi reali presupposti in un tipo storicamente
determinato di produzione sociale, nel modo di produzione capitalistico. La rendita
fondiaria presuppone la proprietà fondiaria, l’interesse del capitale e il profitto
imprenditoriale presuppongono la proprietà dei mezzi di produzione e la classe operaia
proletaria (besitzlose Arbeiterschaft), e il salario operaio è appunto il prezzo di questa
forza-lavoro proletaria.
Página 80
I rapporti e i modi di distribuzione appaiono perciò solo come il rovescio degli agenti di
produzione. Un individuo, che prende parte alla produzione nella forma del lavoro
salariato, partecipa ai prodotti, ai risultati della produzione, nella forma del salario. La
struttura della distribuzione è interamente determinata dalla struttura della
produzione. La distribuzione è essa stessa un prodotto della produzione, non solo per
quanto riguarda l’oggetto, e cioè nel senso che solo i risultati della produzione possono
essere distribuiti, ma anche per quanto concerne la forma e cioè nel senso che il modo
determinato in cui si prende parte alla produzione determina le forme particolari della
distribuzione, la forma in cui si prende parte alla distribuzione. [Nota 13]
Certo, si potrebbe ancora domandare che cosa determina il modo determinato in cui
si prende parte alla produzione, in che modo, in generale, si perviene alla
differenziazione fra proprietari fondiari, possessori di capitali e proletari (Nichtbesitzer).
E qui sembra che questa suddivisione vada spiegata non piú in chiave economica, ma
piuttosto politicamente, cioè con la violenza nuda e cruda. Marx stesso ha rivolto a se
stesso questa critica che ritorna sempre di nuovo. Egli dice: «A considerare intere
società, la distribuzione sembra, da un altro punto di vista ancora, precedere la
produzione e determinarla, come per cosí dire un fatto pre-economico». Ed egli fa
come esempio la presa di possesso dei fondi da parte di un popolo conquistatore, la
riduzione della popolazione in schiavitù, il frazionamento della grande proprietà
fondiaria in seguito a una rivoluzione ecc. [Nota 14]. In tutti questi casi la distribuzione
— quindi la costituzione in classi — non sembra determinata dalla produzione, bensí, al
contrario, la produzione sembra determinata dalla distribuzione.
Solo che, di contro a ciò, Marx richiama l’attenzione sul fatto che in questo continua
ad agire «la concezione piú superficiale» dell’economia borghese consistente nel
considerare la distribuzione separata dalla produzione. Poiché la distribuzione dei
prodotti, anche in questi casi di un intervento violento, rimane legata alle condizioni
della produzione. Se non tenesse conto di queste condizioni, la produzione stessa
ristagnerebbe e ogni distribuzione cesserebbe per mancanza di beni da dividere. Anche
il conquistatore e la rivoluzione, quindi, non possono semplicemente suddividere i beni,
ma sono costretti insieme a suddividere i mezzi di produzione e a collocare gli uomini
nei posti di produzione richiesti da questi mezzi.
Ma, prima che la distribuzione sia distribuzione dei prodotti, essa è: 1) distribuzione
degli strumenti di produzione e 2) — il che è una
Página 81
ulteriore determinazione dello stesso rapporto — distribuzione dei membri della società
tra i differenti generi di produzione (sussunzione degli individui sotto rapporti di
produzione determinati). La distribuzione dei prodotti è chiaramente solo un risultato di
questa distribuzione che è compresa nel processo di produzione stesso e che
determina la struttura della produzione. [Nota 15]
Dunque, la conquista, la rivoluzione, le leggi ecc. danno forma alla distribuzione, ma
possono far ciò solo all’interno di un quadro, che viene costituito dalla raggiunta
altezza del modo di produzione o, rispettivamente, dalla costellazione storica dei
rapporti di produzione. È un’illusione credere che il conquistatore possa comportarsi ad
arbitrio con il popolo sottomesso. Piuttosto, il fatto che egli devasti il paese e deporti la
popolazione, oppure prenda per sé la proprietà fondiaria, riduca in schiavitù il popolo
oppure si accontenti dei tributi: tutto ciò dipende dal fatto che il modo di produzione
del popolo conquistatore faccia apparire l’una o l’altra misura come quella piú
auspicabile per il suo interesse produttivo (cioè, per il suo potere e per la sua
ricchezza). Che della popolazione vinta si facciano degli schiavi o degli affittuari,
ovvero addirittura che la sua classe dominante si fonda con quella dei vincitori, tutto
ciò è predisposto nelle condizioni della produzione, e in questo il modo di produzione
piú elevato determina la direzione persino là dove esteriormente è quello che soggiace:
Marx offre come esempio di ciò le conquiste germaniche nell’impero romano.
Infine, si potrebbe ancora obbiettare che però, nonostante questo condizionamento
economico dei risultati della violenza (Gewalt) questa stessa rimane un fatto
extraeconomico e pre-economico. Ma anche riguardo a ciò Marx ci dà una risposta, che
accenna alla direzione in cui va risolto, dal punto di vista della sua concezione
economica fondamentale, il capitolo, molto discusso, del rapporto fra violenza ed
economia. Marx osserva, una volta, che «anche il diritto del piú forte è un diritto» e,
un’altra volta, che è una rappresentazione tradizionale quella «secondo cui in certi
periodi si sia vissuto soltanto di rapina». Ma non si dovrebbe dimenticare che il tipo di
rapina stesso è a sua volta determinato dal tipo di produzione [Nota 16]. Se cerchiamo
di pensare fino in fondo questi accenni nello spirito del rapporto in cui sono stati fatti,
cioè nello spirito del rapporto organico del modo di esistenza economico e sociale della
vita storica, allora troviamo che la violenza (conquista, rivoluzione) stessa è soltanto il
prodotto di un determinato livello economico della produzione, che persegue con la
violenza dei fini che si producono innanzi tutto e soltanto a partire da questa situaPágina 82
zione economica. Fino a quando le forze produttive, in un insieme sociale, non sono
ancora tanto sviluppate da garantire il sufficiente soddisfacimento di tutti, la violenza
— verso l’esterno e verso l’interno — sarà sempre la funzione necessaria di questo tipo
di livello di produzione. Guerra, pirateria, schiavismo, diritto del piú forte, non sono
altro che, da una parte, forme primitive dell’economia stessa dal lato di chi esercita la
violenza e, d’altra parte, in base alla loro possibilità, sono essenzialmente condizionate
e limitate dal livello di sviluppo economico dal lato di chi la violenza subisce. «Una
nazione di speculatori di borsa», dice Marx, «non può essere rapinata allo stesso modo
di una nazione di vaccari». Un conquistatore trascinerà via il popolo, dai suoi
insediamenti, nel proprio impero solo qualora possa ivi utilizzarlo in un lavoro
schiavistico. «Quando si ruba lo schiavo, si ruba direttamente lo strumento di
produzione. Ma allora occorre che la produzione del paese per il quale si è compiuta la
rapina, sia organizzata in modo da permettere il lavoro schiavistico» [Nota 17]. La
rapina, la conquista, in breve: la violenza stessa è dunque, a sua volta, solo una
funzione della produzione e, per la precisione, questa volta del livello delle forze
produttive.
È questa dunque la risposta al problema di Marx: che cosa costituisce una classe? Le
classi sono il risultato del processo di produzione sociale; esse nascono
necessariamente dalle condizioni della produzione, dalla divisione, in essa insita, degli
strumenti di produzione e dall’articolazione, in tal modo data, dei membri della società
produttiva. Engels ha formulato ciò, una volta, in maniera molto pregnante, nel
seguente modo:
Sino a quando il complessivo lavoro sociale fornisce solo un provento che supera
soltanto di poco ciò che è necessario per un’esistenza stentata di tutti, sino a quando
perciò il lavoro impegna tutto o quasi tutto il tempo della maggioranza dei membri
della società, necessariamente la società si divide in classi. [Nota 18]
L’essenza sociale di una classe non è espressa né dalla diversità della rendita o del
possesso, né dal fatto di svolgere un’uguale occupazione. La distinzione fra ricco e
povero è tanto poco una distinzione di classe quanto quella fra lavoratore e ozioso o fra
lavoratore intellettuale e lavoratore manuale. Quando, abitualmente anche negli scritti
marxisti si parla delle due grandi classi dei proprietari e dei proletari, con ciò non
s’intende l’opposizione fra ricchi e poveri, bensí quella fra coloro che posseggono i
mezzi di produzione e coloro che non posseggono altro che la forza-lavoro. E
Página 83
quando si parla di una classe di lavoratori intellettuali, lo si fa appunto tenendo conto
del fatto che il lavoro intellettuale — nelle sue tre forme: libero lavoro scientifico o
artistico, attività funzionariale e lavoro inserito nel processo di produzione capitalistico
— ha una diversa posizione, ciascuna volta, rispetto al processo di produzione sociale
nella società capitalistica [Nota 19]. Sono quindi sempre le relazioni economiche con la
produzione e, quindi, con la distribuzione a determinare il carattere della classe.
Ma questi momenti economici costituiscono soltanto il suo contenuto, non la sua
forma. Quest’ultima essi l’acquistano naturalmente soltanto a partire dalle forme della
coscienza sociale in generale, in cui, anzi, è fin dall’inizio inserito ogni elemento
economico, poiché solo attraverso questa coscienza viene vissuto. Anche questo è
stato affermato da Marx stesso. Egli rinvia innanzi tutto al fatto che, naturalmente, la
produzione ha alcuni presupposti, che — per cosí dire — stanno al di fuori di essa, per
esempio la divisione dei mezzi di produzione data dalla natura. Ma questi
all’inizio possono sembrare come di origine naturale. Attraverso il processo di
produzione stesso essi vengono commutati da fattori naturali in fattori storici, e se per
un periodo appaiono come presupposto naturale della produzione, per un altro essi
hanno costituito un risultato storico di quest’ultima. [Nota 20]
Cioè, i presupposti quasi-naturali (naturwüchsig) della produzione in generale non
vengono presi in considerazione in quanto tali dal punto di vista sociologico, bensí
soltanto in quanto componenti di un processo di lavoro già sociale. La terra, in quanto
tale, è un composto di sostanze minerali e vegetali; essa diviene un fattore sociologico
soltanto in relazione al lavoro umano, di cui è oggetto. Il clima ridente rimane un fatto
meteorologico, cui è estraneo ogni riferimento al ridere o al piangere, e diviene un
momento sociologico solo grazie al suo riferimento al sostentamento umano da esso
dipendente ecc.
Cosí, già alla radice del modo in cui si formano i suoi concetti l’esperienza sociale
compie quella caratteristica trasposizione «nella testa dell’uomo» — dall’isolamento
naturalistico alla relazionalità umana — che è soltanto l’espressione psicologico-storica
dell’elemento social-a-priori, il cui carattere teorico-gnoseologico già conosciamo.
L’esperienza sociale, quindi anche quella economica,
Página 84
è impossibile al di fuori delle forme della relazione e dell’unificazione di una molteplicità
indeterminata di uomini l’uno con l’altro. Queste forme, nel loro insieme, costituiscono
la forma sociale, esse sono tanto il presupposto del sentimento di comunità quanto
quello della morale, del diritto, della religione, dell’estetica. Per questo Marx,
esprimendo con ciò un concetto che rende superflua tutta la critica di Rudolf Stammler
contro la concezione materialistica della storia, in quanto contiene già la
regolamentazione esterna come forma della società senza la confusione metodologica
di Stammler, per questo Marx dice: «Ogni produzione è appropriazione della natura da
parte dell’individuo entro e mediante una determinata forma di società. In questo
senso è una tautologia dire che la proprietà (l’appropriazione) è una condizione della
natura». Quando si riducono queste e simili «trivialità al loro effettivo contenuto, esse
dicono piú di quanto non sappiano i loro predicatori. E cioè che ogni forma di
produzione produce i suoi propri rapporti giuridici, la sua forma di governo ecc.» [Nota
21].
La classe è dunque, già in quanto concetto economico, un membro di questa forma
sociale, membro da cui l’ideologia di quest’ultima è inscindibile. I concetti economici
sono appunto concetti sociologici, essi contengono sempre tutta la società e la sua
ideologia: solo che questa viene colta nella sua determinazione economica
fondamentale. E l’elemento decisivo per il nostro tema è il fatto che, dunque, il
concetto di classe, anche ove venga colto ‘semplicemente’ da un punto di vista
economico, esclude il momento politico altrettanto poco di quanto esclude quello
morale e quello ideologico in generale, poiché è solo tutto questo che esprime la classe
in quanto categoria sociale. Il marxismo esprime ciò nel concetto, per esso abituale,
secondo cui fa parte della classe una coscienza di classe. Solo grazie a questa la classe
diventa un momento che penetra nel processo sociale. Ricordiamoci del modo in cui,
nel capitolo frammentario sulle classi, Marx ha rifiutato la semplice «identità dei
redditi» come connotato costitutivo delle classi stesse. Cosí si legge già prima, in Marx,
a proposito del piccolo contadino francese, ciò che invece vale bensí in generale:
Nella misura in cui milioni di famiglie vivono in condizioni economiche tali che
distinguono il loro modo di vita, i loro interessi e la loro cultura da quelli di altre classi
e li contrappongono ad esse in modo ostile, esse formano una classe. Ma nella misura
in cui tra i contadini piccoli proprietari esistono soltanto legami locali e la identità dei
loro interessi non crea tra di loro una comunità, una unione politica su scala nazionale
e una organizzazione politica, essi non costituiscono una classe. [Nota 22]
Página 85
E già nella sua prima critica di Proudhon Marx scrive:
Le condizioni economiche avevano dapprima trasformato la massa della popolazione
del paese in lavoratori. La dominazione del capitale ha creato a questa massa una
situazione comune, interessi comuni. Cosí questa massa è già una classe nei confronti
del capitale, ma non ancora per se stessa. Nella lotta, [...] questa massa si riunisce, si
costituisce in classe per se stessa. Gli interessi che essa difende diventano interessi di
classe. [Nota 23]
Il Manifesto comunista descrive questo sviluppo delle classi a partire dalla lotta fra
gl’interessi nelle sue frasi lapidarie, intramontabili, che dipingono nella maniera piú
concisa la storia precedente e svelano la sua miseria classista rimasta sempre uguale.
Per classe, dunque, intendiamo quella comunità consapevole degli interessi di un
gruppo di uomini, che da ultimo è condizionata dalla loro uguale posizione nella
produzione sociale. Poiché il modo e l’estensione della soddisfazione dei loro bisogni
vitali dipende da quest’ultima, allora, per esprimermi in maniera concisa, vorrei
definire questo gruppo d’interessi gli interessi sociali vitali della classe. È chiaro che
questa espressione è, da un lato della stratificazione in classi, un segno positivo;
dall’altro, un segno negativo; cioè l’espressione interessi vitali significa, nel caso di una
classe oppressa, che la situazione che si produce a partire dalla sua condizione
economica, la danneggia nei suoi interessi vitali, la fa apparire limitata. L’unificazione
del concetto di classe con quello di interessi sociali vitali di un gruppo economico di
uomini ha ora il vantaggio logico di evitare la reificazione (Versachlichung) del concetto
di classe in quanto categoria ‘economica’ mistica, e mette in conto la classe, fin
dall’inizio, come fattore spirituale, come deve avvenire, nel marxismo, per tutti i suoi
concetti economici: per cui Marx, proprio riguardo al suo concetto principale, il
capitale, non si stanca di combattere l’interpretazione reificante e feticistica del
medesimo [Nota 24].
Página 86
E ora è anche chiaro ciò che va mantenuto della critica, tanto amata negli ultimi
tempi, secondo cui Marx avrebbe una rappresentazione cosí oscura del suo
fondamentale concetto di classe che di frequente parlerebbe di una classe là dove si
tratta soltanto di un ceto, come avviene proprio all’inizio del Manifesto comunista,
quando egli cita, come esempi di lotte di classe, la lotta fra patrizi e plebei, baroni e
servi della gleba o membri delle corporazioni e artigiani. Questa critica sembra ritenere
che l’articolazione della società in ceti escluda l’opposizione di classe. Questa veduta è
la degna controparte dell’opinione, cosí diffusa, secondo cui la concezione
materialistica della storia significherebbe che, una volta eliminata l’opposizione di
classe, «per mancanza di rapporti economici» non ci potrebbe piú essere alcuno
sviluppo storico. Ma come qui una forma storica determinata dei rapporti economici,
cioè quella fondata sull’opposizione di classe, viene identificata con la struttura
economica della società in generale (che, naturalmente, può essere anche una
solidale), allo stesso modo, in quella critica, tutt’al contrario, ceto e classe vengono
assunti come elementi del tutto distinti, che anzi si escludono. È proprio questa,
invece, la conoscenza che Marx vuol comunicarci: il fatto che anche le lotte dei ceti
erano lotte di classe, poiché il ceto è soltanto una particolare forma di manifestazione
storica della classe. La distinzione fra ceto e classe è una distinzione assolutamente
soltanto storica: in particolare, è la distinzione per cui il ceto è una forma di
organizzazione giuridica di determinati interessi vitali, mentre la classe viene
direttamente organizzata dalla funzione sociale di questi interessi. Per questo il ceto fa,
di ciò che corrisponde all’interesse classe dei suoi membri, una loro prerogativa e un
loro privilegio, mentre la classe vera e propria non può piú mantenere questo privilegio
giuridicamente, attraverso le prerogative di ceto, bensí soltanto attraverso la violenza
della sua superiorità economica. Questa distinzione storica è stata anche storicamente
superata: dalla rivoluzione francese, che ha abolito tutte le prerogative di ceto e ha
introdotto l’uguaglianza giuridica borghese. Ma, com’è noto, con ciò essa non ha
eliminato il carattere di classe della società, bensí, al contrario, solo ora lo ha fatto
emergere chiaramente, come del resto si legge chiaramente proprio all’inizio del
Manifesto comunista:
La moderna società borghese, sorta dalla rovina della società feudale, non ha
eliminato i contrasti fra le classi. Essa ha soltanto posto nuove classi, nuove condizioni
di oppressione, nuove forme di lotta in luogo delle antiche. [Nota 25]
Página 87
La critica dotta, secondo cui Marx avrebbe continuamente scambiato classe e ceto,
rivela dunque soltanto una ridicola pedanteria, che però è allo stesso tempo molto
triste, poiché tradisce un’inammissibile mancanza di circospezione circa il senso e lo
spirito veri dei concetti di Marx. Essa segna in rosso come errore grossolano proprio ciò
che è la vera e propria funzione sociologica del concetto marxista di classe, in
particolare il riconoscere l’ideologia giuridica della costituzione per ceti in quanto
sovrastruttura, in quanto forma di coscienza sociale della struttura classista della
società, dietro le cui forme romantiche vanno cercate, come loro elementi costitutivi, le
forze reali del modo di produzione e degli interessi di produzione, di cui i suoi membri
non necessariamente devono essere consapevoli. Certo, le lotte fra i ceti nell’antica
Atene o Roma, ovvero le guerre schiavistiche, ovvero le eresie religiose del medioevo,
non erano le lotte di classe del XIX secolo. La critica ‘dotta’ si riduce a questa
ridicolaggine. Ma erano le forme di manifestazione storica delle lotte di classe di quel
tempo e solo se considerate cosí ci divengono effettivamente comprensibili. E in questo
senso sociologico è assolutamente lecito definire i ceti come classi senza dover essere
costretti ad accettare il rimprovero, tipico di una pedanteria e di un’arroganza
professorali, per cui non si scorgerebbe con chiarezza la distinzione di questi due
concetti.
Da tutto ciò si ricava, sotto il profilo che a noi interessa, quanto sia falso lo scorgere
l’essenza del dominio di classe semplicemente nello sfruttamento economico, per cui
senza di questo diviene impossibile ogni dominio di classe, da una parte e, dall’altra,
un gruppo di uomini, che non può piú sfruttare, cessa di essere una classe e, pertanto,
non può piú neanche essere oppresso come classe. Lo sfruttamento economico è
semplicemente il momento costitutivo della classe; le classi che ne sono nate, però,
costituiscono poi delle strutture sociologiche, che, grazie a tutto il complesso dei loro
interessi, hanno la loro propria realtà, stabilità e tendenza alla ricostituzione nella
ideologia da loro costituita. Ammesso pure che il proletariato vinca e che addirittura
possa, tutt’in una volta, eliminare tutto lo sfruttamento economico, che possa
addirittura socializzare subito tutta la proprietà privata dei mezzi di produzione,
ciononostante in un primo momento sussisterebbe ancora la classe borghese, la classe
dei proprietari, poiché la situazione culturale (geistige) degli interessi della proprietà e
degli imprenditori non può essere superata allo stesso modo della sua manifestazione
materiale. Non è esatto, pertanto, che divenga privo di senso — come ritiene Kelsen —
parlare di un dominio di classe in senso marxista, qualora ad esso non sia collegato
uno sfruttamento economico, come non può non succedere nello Stato proletario.
Piuttosto, è chiaro il fatto che, anche in questo caso, l’opposizione di classe conPágina 88
tinua a sussistere, in quanto il complesso degli interessi vitali portati per il loro
predominio sociale continua ancora a sussistere come realtà sociale e tende ad
acquistare nuovamente la sua validità. Nella lotta di classe si erano scontrate le due
tendenze della borghesia e del proletariato ed esse continuano ancora a farlo. È mutata
soltanto la distribuzione del potere e ciò costituisce la diversità della forma dello Stato
dopo la vittoria del proletariato: prima è la borghesia a usare l’ordinamento costrittivo
del diritto contro il proletariato, dopo è questo a usarlo contro la borghesia.
Nell’esistenza di una coscienza di classe senza un sostrato economico non si può
scorgere però una critica alla concezione economica fondamentale, perché anzi, per la
precisione, la borghesia espropriata rappresenta ancora un pezzo di quest’economia
stessa, che anzi esisteva solo nella coscienza di questi uomini, grazie alla loro attività
di imprenditori, banchieri, proprietari fondiari ecc., e, pertanto, esiste ancora fin
quando questi uomini esistono, anzi sono addirittura in grado di trasmettere la loro
ideologia. Anche la generazione che cresce nello spirito dei suoi genitori fa parte
ancora dell’esistenza economica della classe borghese, poiché è determinata
ideologicamente da questa economia.
Ma, pensa Kelsen, nello Stato proletario ciononostante non si può parlare di un
dominio di classe e, quindi, il concetto marxiano di Stato qui fallisce, poiché, non
appena non vi sia piú alcuna oppressione economica, i membri della classe prima
dominante non possono essere dominati diversamente dai membri del proletariato
‘dominante’. Le norme costrittive dello Stato proletario si rivolgono appunto contro
tutti (p. 14 [43]). Qui, ancora una volta, il metodo giuridico formale s’incrocia con
quello sociologico. Se — come fa Kelsen — lo Stato viene considerato da un punto di
vista semplicemente giuridico, cioè come organizzazione costrittiva, allora neanche
nello Stato borghese vi è alcuna ‘oppressione’. Anche in esso le norme costrittive si
rivolgono contro tutti; anzi proprio questo costituisce l’ipocrisia e la menzogna di quel
sistema, che si vanta orgogliosamente d’essere uno Stato di diritto: il fatto che in esso
“tutti sono uguali di fronte alla legge”. L’oppressione, il dominio di classe della
borghesia, consiste qui nel principio giuridico “uguale per tutti”, secondo cui la
proprietà privata è sacra. Questa statuizione giuridica è sufficiente a conservare le
differenze del possesso e, quindi, lo sfruttamento economico. Nello Stato proletario
basta ugualmente la «norma costrittiva uguale per tutti», secondo cui la proprietà
privata dei mezzi di produzione non può piú sussistere, per eliminare, da una parte,
questo sfruttamento e, d’altra parte, per colpire economicamente un’intera classe,
quella dei proprietari. La norma costritriva, uguale per uttti, del riconoscimento della
proprietà privata,
Página 89
sottomette i proletari agli interessi dei proprietari; quella analoga del superamento
della proprietà privata sottomette i proprietari agli interessi dei proletari. Se il
proletariato si sente violentato dalla forma giuridica borghese, non di meno si sentirà
violentata la borghesia da quella proletaria. Nell’uno e nell’altro caso, di volta in volta,
le classi non stanno in un uguale rapporto con l’ordinamento giuridico: ed è questo che
decide il carattere del dominio. Si tratta soltanto di vedere all’interesse vitale di quale
gruppo serve l’ordinamento giuridico. E ogni interesse, che venga impedito nella sua
attuazione dall’ordinamento giuridico, ovviamente si sente dominato, oppresso e lo è
anche. E questo accade, nello Stato proletario, all’interesse dello sfruttamento
economico, all’interesse capitalistico, all’interesse di classe della borghesia. Non è
dunque per niente esatto — e la storia del bolscevismo lo dimostra — che sotto il
dominio del proletariato l’opposizione di classe scompaia immediatamente e che le
norme costrittive si rivolgano in ugual maniera contro tutti.
Ma a questo punto Kelsen obbietta che questo non è piú un dominio di classe, bensí il
dominio di un partito, ancor piú «qualora la forma statale, per il dominio che va
istituito attraverso la rivoluzione del proletariato, sia la democrazia» (p. 15 [46]). E
quest’ultima è «senza dubbio l’opinione del Manifesto comunista. “L’elevarsi del
proletariato a classe dominante” e “la conquista della democrazia” vengono definiti —
nella piú stretta relazione — come il fine della rivoluzione operaia» (ibid.). Siamo con
ciò pervenuti alla discussione di un importante concetto politico e — nella situazione
odierna del socialismo rivoluzionario — di un concetto politico contestato nella maniera
piú violenta: siamo pervenuti cioè alla discussione del significato della democrazia
all’interno della concezione marxista, e con ciò sono in strettissimo rapporto i concetti
di partito, dittatura e rivoluzione. L’intera storia impetuosa di questo tempo apre la sua
problematica gravida di destino in questi concetti, che ora appaiono anche
contraddittori per il pensiero teoretico, quasi quanto si presentano contrastanti nella
vita reale: comunque, solo a patto che la critica che Kelsen fa valere nei loro confronti
abbia effettivamente ragione d’essere.
Página 90
Capitolo ottavo
Classe e partito
Nella democrazia — dice Kelsen a pagina 15 [p. 46] del suo libro — in cui tutti i
cittadini dello Stato, direttamente o indirettamente, vengono fatti partecipare,
attraverso il generale e uguale diritto di eleggere la rappresentanza popolare, alla
formazione della volontà dello Stato, e all’esercizio del dominio politico, non può
esprimersi politicamente un dominio di classe in generale, nei limiti in cui tutti —
lavoratori e imprenditori, sia i proletari sia la borghesia — hanno politicamente uguali
diritti. Un domino di classe economico è possibile [...] Se non si verifica neanche
questo [Nota 1], non si può parlare di un dominio di classe in generale.
Ma come dobbiamo intendere il fatto che in una democrazia perfetta — secondo il
presupposto di Kelsen — non è possibile invero un dominio politico di classe, ma
tuttavia è possibile un dominio di classe economico? Egli risponde anche a questa
domanda: «Se il partito, che nella rappresentanza popolare ha la maggioranza —
ferma restando l’uguaglianza politica formale — rende possibile uno sfruttamento
attraverso il contenuto dell’ordinamento giuridico».
Ma anzi proprio questo fa la democrazia borghese, per quanto sia ‘perfetta’, cioè
dedita alla «tutela dell’uguaglianza formale dei diritti politici» dei cittadini dello Stato. E
proprio qui si fonda la contraddizione cosmico-storica di ogni democrazia borghese
edificata sull’opposizione di classe, la sua intima falsità e mendacità. la sua tipica
autoillusione il fatto che in essa vi siano solo diritti uguali e che lo Stato di diritto, che
la esprime compiutamente, ponga i cittadini dello Stato in una relazione
completamente uguale rispetto all’interesse pubblico dello Stato. Già nei loro primi
scritti Marx e Engels hanno distrutto spietatamente questa illusione borghese, che
apparteneva comunque ai sogni
Página 91
fiorenti della borghesia rivoluzionaria; si legga la critica dei cosidetti diritti dell’uomo
nel giovane Marx e la critica dei diritti di libertà inglesi nel giovane Engels, che allora —
precedendo Marx nella critica sociale — scriveva queste parole:
L’eguaglianza democratica è una chimera, la lotta dei poveri contro i ricchi non può
essere combattuta sul terreno della democrazia o dell politica. Anche questo grado è
dunque solo uno stadio transitorio, l’ultimo mezzo puramente politico che ancora deve
essere sperimentato e dal quale deve subito svilupparsi un nuovo elemento, un
principio che oltrepassa la politica. Questo principio è il socialismo. [Nota 2]
Qui Engels richiede un principio che «oltrepassa la politica», qui, ove ci si
aspetterebbe un principio che oltrepassi la democrazia. Si presti attenzione a questa
identificazione della democrazia con il concetto della politica, da cui s’intuisce fin d’ora
il fatto che il concetto di politica proprio come quello di Stato, di classe e tutti gli altri
simili concetti del marxismo in generale acquistano il loro significato particolare nella
struttura del medesimo, significato che non è uguale al significato consueto della
parola, ma risulta soltanto dal suo essere storicamente riferito al carattere di classe
della società borghese. Questo lo vedremo e lo comprenderemo ancora piú
chiaramente nel confronto critico (Auseinandersetzung) sul concetto di democrazia,
perché per Marx e Engels la lotta dei partiti borghesi nello Stato era invero una lotta
politica, ma la lotta di classe — come Marx mostrava già nella Miseria della filosofia —
alla fine non poteva non far nascere nel proletariato «un principio che oltrepassa la
politica».
La democrazia borghese è caratterizzata dal fatto che non solo mantiene fattualmente
le condizioni di esistenza della borghesia, ma le pone sotto la tutela del diritto. Essa
non può non mantenere lo sfruttamento economico, senza di cui non c’è alcuna
valorizzazione del capitale e alcuna rendita fondiaria, ed essa fa ciò mantenendo la
proprietà privata dei mezzi di produzione e tutta la regolamentazione giuridica richiesta
da questo principio giuridico, anzi lo stabilisce come un diritto fondamentale. Nella
democrazia perfetta questo sarebbe possibile — secondo la terminologia di Kelsen —
solo se il «partito della proprietà privata, del possesso» ha la maggioranza richiesta
nella struttura rappresentativa legislativa. Ma guardiamo per una volta piú da vicino
questo ‘partito’. Per prima cosa, in una democrazia non potrebbe esserci Stato né
potrebbe esserci un parlamento, in cui si costituisca un «partito del possesso». Una
tale cinica franchezza ripugna completamente alla natura della democrazia e della
politica
Página 92
borghese. Esso si chiamerebbe, perlomeno, partito dei ‘salvatori della patria’ o
dell’ordinamento sacro, dei difensori della civiltà e dell’etica ecc. Per lo piú, inoltre, non
si presenterebbe neanche come partito, poiché non potrebbe farlo a causa della
eterogeneità, anzi a causa dei contrasti che altrimenti esistono fra i suoi membri, ma
apparirebbe come ciò che anche è, come una coalizione di tutti quei partiti, che,
invero, altrimenti hanno poco in comune, ma si trovano unificati nella lotta contro gli
avversari che violano il loro fondamento: la proprietà privata. Ora, suvvia! — questo
«partito dei proprietari privati», la cui maggioranza mantiene l’ordinamento giuridico
borghese, sussiste di fatto in ogni democrazia borghese e comprende non solo
conservatori e liberali, non solo tutti gli altri contrasti nazionali e confessionali, ma
unifica addirittura gli... avversari monarchici o aristocratici della democrazia nella lotta
contro gli avversari della proprietà privata. Tutti questi diversi gruppi, quindi, vengono
unificati in tal caso, al di là del loro particolare interesse politico, nazionale,
confessionale o anche culturale, in un interesse comune, superiore e che domina ogni
altra veemenza, anzi ostilità del loro punto di vista, perché questo fa parte del loro
interesse economico vitale: il mantenimento del loro ruolo economico in quanto fruitori
dello sfruttamento del lavoro sociale. Ma ciò significa: tutti questi diversi gruppi
divengono un unico ‘partito’ solo grazie alla comunità della loro situazione economica
all’interno dell’interesse di produzione e distribuzione sociale: possono essere un
‘partito’ perché già prima sono una classe, la classe dei proprietari contro la classe dei
proletari. Questo dato di fatto non viene assolutamente mutato dalla circostanza per
cui un tale ‘partito’ può avere la maggioranza nella popolazione soltanto perché — in
parte a causa della dipendenza da coloro che dominano, in parte attraverso
influenzamenti diretti e indiretti, in parte attraverso innumerevoli vincoli della
tradizione, della morale e della religione correnti, della consuetudine, della pigrizia di
pensiero e dell’insipienza, dell’indolenza e della mancanza di carattere, dell’ambizione e
dell’avidità — per grandi parti di questa maggioranza la loro comunità d’interesse è
soltanto illusoria. Poiché sappiamo già che una classe acquista realtà sociologica non
già attraverso la situazione economica solamente, bensí innanzi tutto nella
sovrastruttura ideologica, che su di essa diviene possibile [Nota 3].
Página 93
Ora, certo, questa unificazione classista di tutta una quantità di gruppi che per il resto
si combattono reciprocamente nella maniera piú violenta la si può chiamare — per
amore di una determinata teoria — un ‘partito’. Perché, nella terminologia, esiste
libertà fino al punto di usare violenza alle parole inermi. Solo
Página 94
che poi viene appunto sicuramente smarrito ogni senso determinato della parola
partito e viene raggiunta quella dannosa vaghezza dell’espressione linguistica, in cui le
parole possono significare semplicemente tutto, quindi, per esempio, classe e partito
possono diventare una sola cosa. Quanto ciò sia in contrasto già con lo spirito della
lingua si palesa nel fatto che, in quanto precede, solo a fatica — il lettore lo avrà
avvertito — per voler indagare che cosa significhi l’espressione ‘partito’ nel concetto di
un partito della maggioranza democratica, abbiamo evitato la definizione corretta di
quei gruppi da cui esso è costituito: cioè, abbiamo evitato la denominazione di partiti.
Poiché anzi questi gruppi null’altro sono se non partiti: il partito dei conservatori, dei
liberali, dei democratici della politica sociale, dei monarchici, dei repubblicani, degli
antisemiti, dei liberi pensatori ecc. Qui la parola partito è al suo posto e chi la usi
ancora in altro senso, naturalmente è libero di farlo, ma poi non può non essere
consapevole del fatto che pronunzia la parola partito in un doppio significato: una volta
come concetto dei difensori di un determinato ordinamento sociale e, un’altra volta,
come insieme dei rappresentanti di un determinato interesse particolare all’interno di
un ordinamento sociale.
E in tal modo siamo pervenuti, — proprio sul terreno della democrazia pura — alla
distinzione caratteristica, che, nella concezione marxista, separa classe e partito, ma,
quindi, anche lotta di classe e lotta di partito. Queste avvengono, per il sociologo, in
ambiti sociologici completamente distinti, che non possono affatto esser raggiunti dalla
trattazione semplicemente giuridica, poiché per essa stanno all’interno di un solo
ambito, in particolare in uno e medesimo ordinamento giuridico. Deriva da ciò, inoltre,
il fatto che, alla fine, anche il concetto di politica diviene contraddittorio (zwiespältig),
di modo che il marxista si è già da molto tempo abituato a dividere — proprio come
nello Stato distingue sempre lo Stato borghese e quello proletario — la politica
borghese da quella proletaria. Non si tratta — come qualcuno ha interpretato in
maniera miope — di un orgoglio marxista o di un’arroganza socialdemocratica, bensí si
tratta di una diversa altezza della considerazione teorica, come diverrà chiaro nel
prosieguo.
Nel marxismo, dunque, partito e classe sono due concetti di contenuto e di significato
molto diverso, un contenuto e un significato che acquistano assolutamente e soltanto
dalla loro relazionalità con lo sviluppo sociale, e che si fonda sulla divisione sociale dei
ruoli, che deriva dalla legalità economica di questo sviluppo. Per questo Marx e Engels
avvertivano qualcosa di falso — nonostante la loro appassionata presa di partito in
favore della
Página 95
causa del proletariato — quando qualcuno li definiva uomini di partito [Nota 4], e per
questo Marx scriveva a Freiligrath le parole famose, che sono cosí indicative riguardo al
modo in cui egli concepiva la sua politica: «Per partito io intendevo il partito nel grande
significato storico» [Nota 5].
Ora, che significa «partito nel grande significato storico»? Significa, che si tratta di
una presa di posizione, che tratta lo sviluppo storico nella sua necessità sociale, sia che
lo approvi, sia che lo rifiuti. La necessità dello sviluppo sociale si realizza soltanto nelle
aspirazioni classiste dei membri della società. A seconda che il perseguimento di
queste aspirazioni di classe allarghi o restringa la cerchia della società, la presa di
posizione a partire da qui fondata sarà una presa di posizione o nel senso dello
sviluppo sociale o contro di esso, ed a questo non apporta alcun cambiamento il fatto
che anche la seconda tendenza — dal punto di vista della coscienza che ne ha e,
ancora di piú, nella sua fraseologia — si sia sempre presentata e sempre si presenterà
come un aspirazione insita nell’interesse generale della società. Ché, dal punto di vista
della trattazione sociologica, non si tratta di ciò che un’aspirazione sociale crede o
afferma circa se stessa, bensí di ciò che essa è. «E come nella vita privata si fa
distinzione tra ciò che un uomo pensa e dice di sé e ciò che dice e fa in realtà, tanto
piú nelle lotte della storia si deve far distinzione fra le frasi e le pretese dei partiti e il
loro organismo reale e i loro reali interessi, tra ciò che essi s’immaginano di essere e
ciò che in realtà sono» [Nota 6].
Per quanto riguarda il mondo capitalistico, in cui viviamo e che rimane tale anche in
una democrazia borghese perfetta, dall’analisi economica delle sue leggi fondamentali
si ricava il fatto che la proprietà privata dei mezzi di produzione agisce come un limite
(Schranke) rispetto al pieno dispiegamento delle forze produttive sociali, e ciò in una
doppia direzione. Innanzi tutto, il principio supremo della produzione capitalistica, cioè
l’acquisizione del profitto, consente questo dispiegamento solo nella misura in cui
appunto il profitto non ne venga diminuito, per cui delle possibilità tecniche, che invero
sarebbero auspicabili dal punto di vista sanitario e sociale, rimangono inutilizzate,
perché non ‘rendono’. Ma, in secondo luogo, la stessa condizione del profitto impedisce
l’utilizzazione dello stesso livello produttivo già raggiunto al fine di un godimento
uguale per tutti, cioè in favore del biPágina 96
sogno sociale vero e proprio. Ogni presa di posizione, che voglia mantenere questi
rapporti, affermerà, invero, che questo è ciò che esige il vero interesse della società.
Abbiamo già visto, nel secondo capitolo, che questo fa appunto parte della dialettica
necessaria della coscienza politica nello Stato borghese, il fatto che in esso gli interessi
particolari non possono non assumere la forma di interessi pubblici generali, poiché
solo in quanto tali possono diventare interessi statali e possono pervenire a un dominio
che non sia violenza nuda e cruda, bensí dominio giuridico. E questo si verificherà in
maniera del tutto particolare in una comunità democratica. Ma se si va al di là di
questo linguaggio da politica di partito e si risale al suo nucleo, alla sua presa di
posizione effettiva, risulta allora che la presa di posizione avversa allo sviluppo sociale
rappresenta sempre un interesse particolare, anche se si presenta come interesse
generale, mentre la presa di posizione a favore dello sviluppo sociale rappresenta
sempre l’interesse generale, anche se appare nella forma dell’interesse particolare,
cioè anche nella forma dell’interesse proletario di classe [Nota 7].
Ora, deriva da qui la differenziazione sociologica per quanto riguarda il significato del
proletariato persino là dove esternamente si presenti soltanto come un partito politico
fra altri partiti. L’interesse particolare del proletariato coincide con l’interesse generale
in una nuova società, senza classi, coincide cioè con l’interesse al rovesciamento
dell’ordinamento economico e giuridico sussistente. L’interesse particolare di tutti i
gruppi borghesi coincide invece con il mantenimento di questo ordinamento. Il primo è
rivoluzionario e favorevole allo sviluppo; il secondo è necessariamente conservatore e
ostile allo sviluppo. E, applicato alla democrazia, da cui abbiamo preso le mosse, ciò
significa: la maggioranza in una democrazia, nei limiti in cui si riferisca non a
ordinamenti parziali all’interno dello Stato, bensí all’ordinamento stesso nel suo
insieme, è o un’espressione del punto di vista classista dell’interesse di classe borghese
o di quello dell’interesse di classe proletario; nell’uno e nell’altro caso lottano per il
dominio non contrasti di partito, bensí contrasti di classe e, pertanto, è sempre una
classe che, in maniera piú o meno perfetta — ciò dipende dalle forze dell’avversario —
fa valere nel dominio il suo principio di classe. Il dire che in una democrazia non può
esistere un dominio politico di classe significa, pertanto, trattare la democrazia nello
spazio vuoto, nel cielo puro dei concetti del pensiero giuridico formale. Fino a quando
la democrazia si fonda sul terreno dei contrasti di classe, piuttosto, essa non è affatto
Página 97
possibile in generale. La democrazia non è possibile né nello Stato borghese né in
quello proletario — da qui la critica legittima del bolscevismo contro la difesa, del tutto
non-marxista, del principio democratico in quanto tale, di cui si dovrà parlare ancora
piú avanti —, ma è possibile soltanto nello Stato sociale della società senza classi, che
appartiene soltanto al futuro. E questo vale addirittura per la democrazia borghese, nei
limiti in cui essa era soltanto un programma della borghesia rivoluzionaria; poiché in
questa essa era anzi, propriamente, l’anticipazione concettuale di una tale situazione
senza classi, quando la borghesia poteva ancora, anzi non poteva non pensare che,
con la sua vittoria, sarebbero state eliminate tutte le forme di oppressione e sarebbero
stati fondati i diritti dell’uomo, la libertà di tutto ciò che ha aspetto umano. Un sospetto
circa l’impossibilità della democrazia nello Stato di classe balena del resto già nel piú
grande precursore di questa idea di una costituzione sociale solo futura, quando, una
volta, pronunzia le parole gravide di significato:
A prendere il termine nella sua rigorosa accezione, non è mai esistita una vera
democrazia, né esisterà mai. [...] Se vi fosse un popolo di dèi, esso si governerebbe
democraticamente. Un governo cosí perfetto non conviene ad uomini. [Nota 8]
No, per gli uomini di una società di classe la democrazia rimane un problema
insolubile e Rousseau non poteva ancora pensare come possibili uomini diversi. Ciò ci
conduce alla discussione dei concetti piú contestati del marxismo, ai concetti di
democrazia e di dittatura.
Página 98
Capitolo nono
Democrazia politica e democrazia sociale
Il concetto di democrazia è divenuto problematico, all’interno, del marxismo, solo in
seguito alla critica e, ancora di piú, in seguito alla tattica del bolscevismo. Fino ad
allora, se si esclude l’anarchismo e numerosi sindacalisti rivoluzionari, quasi nessuno
dubitava del fatto che la conquista della democrazia faccia parte dei còmpiti essenziali
della lotta di classe rivoluzionaria. Già nel Manifesto comunista si dice che «il primo
passo nella rivoluzione operaia è l’elevarsi del proletariato a classe dominante, la
conquista della democrazia [Nota 1]. Ma la critica del bolscevismo ha contribuito a far
apparire il concetto di democrazia, all’interno del marxismo, piú contraddittorio di
quanto questo concetto difficile fosse prima mai stato. E questo si è verificato per il
fatto che, invero, la teoria di Lenin — e ciò è il suo merito, grande e duraturo — ha
fatto energicamente valere la teoria della lotta di classe e del carattere classista dello
Stato contro una confusione opportunistica e incoerente del punto di vista marxista,
ma ne ha dato un’applicazione, che era in contraddizione con tutti i principi di questa
teoria marxista dello Stato. La teoria marxiana dello Stato proletario è caratterizzata
dal fatto che, in esso, il proletariato è divenuto la classe dominante, cioè, in senso
marxista, la classe che rappresenta, dal punto di vista economico, il potere decisivo
nella società. Applicare questa teoria alla situazione eccezionale russa — creata da
inauditi casi storici —, nella quale il potere politico non era nelle mani del proletariato,
bensí soltanto in quelle di un gruppo di esso, era semplicemente impossibile. È a
partire da questa contraddizione fattuale, e non dal concetto marxista, che si
producono tutte le costruzioni, in piú d’un caso in verità artificiose e arbitrarie, con cui
la teoria e la polemica dei bolscevichi vuol difendere e vuol rendere credibile
Página 99
la sua tesi, che si rivela sempre piú come un autoinganno, secondo cui il sistema russo
dei soviet sarebbe la vera e propria realizzazione della teoria marxista della dittatura
del proletariato e del suo rapporto con la democrazia. Nessuna metaviglia che qui, ove
si è già appuntata energicamente la critica dei marxisti non bolscevichi, vi sia materiale
abbondante anche per la critica di Kelsen; solo che egli crede di aver colpito, con la
contraddizione che egli ha indicato nella politica bolscevica, anche la teoria marxista.
La mancanza della distinzione di questi due punti di vista, certo, va notata anche nella
polemica di piú di un avversario marxista del bolscevismo, e succede cosí che oggi i
concetti di democrazia, dittatura e rivoluzione del proletariato facciano parte di quei
concetti, che mostrano una condizione di confusione teorica, che corrisponde assai
poco al livello del socialismo marxista, che, giustamente, si chiama socialismo
scientifico. Forse, se dapprima lasciamo completamente da parte la polemica fra
politica socialdemocratica e bolscevica e se ci fermiamo alla critica di un avversario di
tutt’e due le tendenze, cioè alla critica del professor Kelsen, riusciremo ad acquisire le
direttive generali della teoria marxista, a partire dalle quali una strada libera da errori
e fraintendimenti conduce alla comprensione teorica dei concetti messi in discussione.
L’intenzione di Kelsen — questo dev’essere sempre tenuto presente — era di
esercitare una critica immanente dei concetti del marxismo, cioè quella di porsi dal loro
punto di vista e, poi, di mostrare che essi, già a partire da se stessi, sono intimamente
contraddittori. Abbiamo già visto, per tutto il cammino fin qui percorso, che egli non ha
raggiunto il presupposto soggettivo di questa critica, cioè quello di porsi innanzi tutto
sul terreno della visione marxista e di ripensare a partire da essa i suoi concetti. E non
gli poteva riuscire poiché questa visione — lo vedremo ancora piú chiaramente — gli è
per l’appunto estranea e perché non basta, per esercitare una critica immanente contro
una teoria copernicanamente nuova come è la teoria marxista, criticare semplicemente
soltanto i suoi princìpi (Sätze) e sottomettere questi ultimi, come se fossero — per cosí
dire — i paragrafi del marxismo, a una interpretazione grammaticale e logica, come
altrimenti sogliono fare, legittimamente, i giuristi. In tal modo, la critica di Kelsen va a
parare dappertutto nella strada obbligata di un confronto fra i concetti marxisti e quelli
della sua propria teoria del diritto e dello Stato e, pertanto, non poteva non prodursi,
dal suo punto di vista, una contraddizione insolubile. Ma, in realtà, non è neanche una
contraddizione, bensí soltanto la diversità del punto di vista giuridico e sociologico, del
modo di pensare formale e di quello storico.
La stessa cosa si ripete quanto riguarda il problema della
Página 100
democrazia. Nel sistema concettuale del marxismo questo concetto è sempre un
concetto storico, per cui occorre sempre domandare: di qualle democrazia
propriamente si parla? Ancora una volta, Kelsen contrappone a questo concetto un
concetto puramente formale di democrazia, a partire dal quale, naturalmente, non
possono non prodursi contraddizioni d’ogni genere nella trattazione marxista di
quest’oggetto.
Per Kelsen la democrazia è, innanzi tutto, «un principio di organizzazione puramente
formale, che, in sé e per sé, non può pretendere alcun valore universale e
incondizionato per ogni scopo organizzativo» (p. 120 [168]). Pertanto, «non si può
seriamente far valere contro lo Stato borghese il fatto che esso non sarebbe una vera
democrazia perché la popolazione lavoratrice sarebbe completamente esclusa dalla
direzione del processo produttivo» [p. 167]. Poiché la democrazia è una forma di Stato
e fino a quando la produzione non fa parte ancora delle funzioni dello Stato, la sua
deficienza all’interno della costituzione della democrazia non può neanche essere
imputata a quest’ultima come una mancanza. Kelsen ritiene elemento decisivo
semplicemente «il principio, che caratterizza la democrazia, dell’universalità e
dell’uguaglianza del diritto alla partecipazione nella formazione della volontà della
comunità (p. 120 [168]). Se si segue questo carattere della democrazia nel suo
sviluppo e nella sua azione pieni, allora si produce, per Kelsen, una serie di
conseguenze, che egli sviluppa nel corso di una critica che per piú versi si perde nei
dettagli, e che noi possiamo cosí riassumere: 1) nella democrazia piena, che tuttavia il
marxismo indica come un fine necessario della lotta del proletariato, il dominio di
classe è impossibile ed esiste solo una lotta dipartito; i concetti di lotta di classe, di
oppressione di classe e di Stato di classe divengono qui privi di senso. Si è già parlato
di ciò e quanto è stato già qui mostrato come erroneo verrà completato con la
seguente discussione. 2) Il concetto di dittatura, introdotto da Marx e Engels, nel
sistema della democrazia non ha, ugualmente, alcun senso. Ne acquista uno soltanto
qualora la maggioranza venga dominata con la forza da una minoranza — come
avviene nel bolscevismo russo — che però oltraggia ogni democrazia. L’immagine,
collegata con questo concetto di dittatura, di una lotta contro la democrazia o
addirittura di un suo superamento, è pertanto in sé contraddittoria, e tutta questa serie
d’immagini va spiegata piú con i bisogni della lotta politica contro la borghesia che con
quelli di una teoria non contraddittoria. 3) La stessa cosa vale per il concetto di
rivoluzione proletaria, in particolare nell’immagine marxista — portata in primo piano
dal bolscevismo — della rottura della macchina statale. Poiché, all’interno della
democrazia, in fondo, per trasforPágina 101
mare l’ordinamento borghese in quello socialista, non c’è bisogno nemmeno di
mutamento della costituzione, tanto meno quindi di una rivoluzione. La distinzione fra
la transformazione rivoluzionaria e quella pacifica della società, una volta che si sia
conquistata la democrazia, perde ogni importanza teorica. E la distruzione della
macchina statale, a ben guardare, si palesa come la sostituzione di una forma statale
meno democratica con una piú democratica. Anche in tal caso la terminologia
rivoluzionaria non ha alcun valore teorico, ma è essenzialmente soltanto un
adattamento all’agitazione e ai bisogni della lotta politica. Infine, 4), tutto ciò può
essere reso visibile nel caso particolare della Comune di Parigi, di cui Marx e Engels
stessi dicevano che era un esempio di dittatura del proletariato, e a proposito della
quale va mostrato il fatto che, proprio nell’analisi che Marx fa delle sue istituzioni, esso
significa soltanto una trasformazione nella direzione della democratizzazione della
politica e dell’amministrazione. Se quindi la Comune è stata effetivamente una
dittatura del proletariato, allora proprio essa ha dimostrato che è stata possibile solo in
quanto forma di democrazia, basata sulla maggioranza del diritto elettorale universale.
Ma tutta questa critica è legata, nel libro di Kelsen, ancora ad un’altra tendenza, che
rende ancora piú difficile sbrogliare tutti gli spostamenti del punto di vista marxista che
in essa hanno luogo; in particolare, essa è legata alla polemica, già citata, e che
attraversa tutto il libro, contro ciò che Kelsen chiama la venatura anarchica della teoria
marxista dello Stato. Ho volutamente trascurato, finora, l’esistenza di questo punto, e
farò cosí anche in questo capitolo, per non accrescere ancora di piú la quantità dei
punti di vista. Ma vi sarà occasione, in un capitolo successivo, di mostrare
dettagliatamente quanto la concezione kelseniana sia ancora estranea al marxismo
quando, nella teoria dell’«estinzione dello Stato» e della «abolizione dello Stato»,
scorge una forma di... anarchismo e, pertanto, nella lotta di principio contro
l’anarchismo, da parte del marxismo, scorge soltanto un pezzo della sua
contraddittorietà irrimediabile.
Ora, per ritrovare, attraverso questa foresta di osservazioni critiche, la via spianata
verso la reale concezione marxista del problema della democrazia e della dittatura, con
cui coincide quello della rivoluzione, non possiamo evitare di cominciare anche noi con
determinazioni concettuali e, innanzi tutto, non possiamo non interrogarci circa
l’essenza del concetto di democrazia. E l’elemento decisivo che, innanzi tutto, in ciò va
tenuto fermo è il fatto che questo concetto, dal nostro punto di vista — come si è già
detto — è un concetto assolutarnente storico. Il concetto kelseniano di democrazia è
invece un concetto altrettanto formale del suo concetto di Stato. Proprio come questo,
esso può contenere il contenuto
Página 102
piú diverso e gli scopi organizzativi piú vari. Suona quindi poi del tutto plausibile
l’asserzione, secondo cui la disuguaglianza economica non costituisce alcun argomento
contro la democrazia, poiché questa, in base alla sua forma, si riferisce solo
all’uguaglianza dei diritti polici. Già a partire da qui si comprende che la democrazia è
qualcosa di diverso a seconda se è qualcosa di diverso lo Stato, di cui essa è forma.
Poiché in uno Stato in cui anche le funzioni economiche siano funzioni politiche — per
usare la terminologia di Kelsen — l’uguaglianza dei diritti della democrazia significa
qualcosa di completamente diverso che nello Stato odierno. Nascondere questa
distinzione parlando di una cresccita della sfera politica dello Stato è un gioco di parole,
per amore di un pricipio formale, che proprio in questo caso mostra la sua insuficienza.
Uno Stato in cui l’economia venga inserita per principio nella sfera politica, è ancora,
certo, una organinazione costrittiva proprio come quello in cui si verifica il contrario.
Per il giurista ciò può essere indifferente, mentre dal punto di vista sociologico si
producono le forti distinzioni dello Stato di diritto liberale, da una parte, dello Stato di
polizia del mercantilismo e dello Stato socialista libero, dall’altra parte. Deriva
immediatamente da ciò il fatto che l’inserimento degli scopi economici nella forma
statale, in sé e per sé, non deve affatto portare necessariamente alla democrazia
politica, come dimostra l’esempio dei mercantilisti. E si palesa, allo stesso tempo, che il
concetto di democrazia è un concetto formale essenzialmente diverso da quello di
Stato. Il concetto di Stato, in quanto tale, è un’astrazione ammissibile, poiché, con la
forma dell’organizzazione constritiva, essa estrapola un connotato della vita sociale,
che è stato sempre proprio di ogni forma dei legami sociali della produzione: si tratta
di un punto che il marxismo, come avremo ancora occasione d’esporre, non contesta
assolutamente, contrariamente a quanto crede Kelsen che spara le sue bordate piú
temibili contro questo opinabile anarchismo della teoria marxista. Mentre dunque il
concetto di uno Stato in generale è una rappresentazione lecita, non si può dire lo
stesso di una democrazia in generale. Poiché essa non fa parte di una forma statale in
generale, ma definisce sempre una forma statale già determinata, quindi, girà nella
sua forma puramente concettuale conduce fuori dal semplice formalismo del concetto
di Stato. Dobbiamo pertanto rifiutare di parlare di un concetto di democrazia in
generale, e dobbiamo invece piuttosto riconoscere che il concetto di una democrazia in
quanto tale, il concetto di una democrazia pura o perfetta, non è altro che l’idea di una
forma statale sotto presupposti determinati, che vanno ancora stabiliti nella loro
struttura economico-sociologica. Diverrà poi chiaro che l’idea della democrazia perfeta
è soltanto l’anticipazione concettuale di una società senza classi.
Página 103
Circa quest argomento mi sono già espresso una volta, in maniera dettagliata, nel
mio scritto Democrazia e consigli operai [Nota 2]. E poiché Kelsen, nel suo libro, parla
anche della discussione ivi svolta, mi sia concesso di ripetere anche sotto questo profilo
le relative argomentazioni. Democrazia significa, letteralmente e in base al suo senso,
dominio del popolo, autodeterminazione del popolo. Ora, nella società di classe, per
quanto la constituzione possa essere ‘democratica’, una tale democrazia non è
possibile, poiché nello Stato capitalistico manca il presupposto fondamentale di un
dominio popolare, manca cioè l’unità del popolo. Nello Stato capitalistico non vi è
ancora un’unità popolare, bensí solo una popolazione, che non rappresenta né un’unità
economica, né un’unità culturale né una ideologica, bensí rappresenta piuttosto — in
ognuna di queste direzioni — una disgregazione di classi, che è tenuta insieme solo
dalla costrizione del dominio di classe. All’interno della piú radicale uguaglianza dei
diritti politici la disuguaglianza economica costituisce contrapposizioni tali che non può
non andar necessariamente smarrito ogni senso di democrazia, cioè della costituzione
di una volontà popolare unitaria e generale. Rimane soltanto la constituzione di una
maggioranza (Maiorisierung) piú o meno brutale.
E ora bisogna prestare attenzione a questo fatto, per cui in questo problema della
maggioranza si discopre la natura propria della democrazia. Il principio della
maggioranza non è affatto, come tanti credono, il principio essenziale della
democrazia. Poiché nella semplice maggioranza dei voti non si può ancora trovare un
motivo giuridico vero e proprio per cui essa debba decidere. Al contrario, la
maggioranza semplice conduce all’annullamento di ogni autodeterminazione del
popolo, poiché violenta sempre la parte pili piccola attraverso quella piú grande. Se la
democrazia, di fatto, non può fare a meno delle risoluzioni delta maggioranza — e le
cose stanno eftetivamente cosí – il fondamento di ciò deve consistire in qualcos’altro
che non nella semplice, grossolana superiorità numerica dei voti.
L’effettivo principio vitale della democrazia — dico nel saggio già citato — Rousseau
l’ha indicato in maniera geniale, ma è stato ancora poco apprezzato nel suo significato
rivoluzionario. Non si tratta della volontà della maggioranza, bensí della volontà
comune, della volontà generale. Secondo Rousseau, la votazione è soltanto il mezzo
attraverso il quale la volontà comune dev’essere constatata. Coloro che sono stati
meno votati devono piegarsi non perché sono in meno, non perché gli altri sono i piú
forti, ma perché la votazione ha mostrato che essi sono in contraddizione con la
volontà comune. E Rousseau può trarre
Página 104
questa conseguenza, che al primo sguardo stupisce anzi appare forzata, perché prende
le mosse dal presupposto, che certo era un’illusione, ma era l’illusione cosmico-storica
della borghesia rivoluzionaria, secondo cui il suo dominio avrebbe significato l’effettiva
liberazione del genere umano da tutti i contrasti di dominio e, pertanto, avrebbe
fondato l’unità solidale del popolo. Non appena, in particolare, il popolo costituisce una
comunità solidale, cioè non appena non vi siano piú opposizioni vitali nell’insieme del
popolo, a partire dalle quali le votazioni si organizzano, le differenze del numero di voti
non significano piú, effettivamente, una violazione di interessi vitali, bensí soltanto
delle diversità d’opinioni, piú o meno neutrali, circa l’utilità e il carattere pressante
delle decisioni proposte. La votazione diventa un semplice atto di amministrazione
sociale o di conduzione d’affari. E, allo stesso modo in cui, in un’unione o in una società
commerciale, coloro che sono in minoranza non si sentono violentati — nei limiti in cui
la votazione non si riferisce allo scopo dell’insieme, il che corrisponde, nello Stato, agli
interessi vitali, che non sono in discussione, di tutti i cittadini — poiché ciò che viene
deciso, viene pur sempre voluto anche da essi, anche se essi lo avrebbero visto
realizzato in maniera completamente diversa, cosí avviene pure in una comunità di
popolo solidale. [Nota 3]
Página 105
Il fatto che quest’unità dell’insieme del popolo, la solidarietà dei suoi interessi,
costituisce il vero e proprio fondamento della democrazia, si palesa nel fatto che è
caratteristico di tutti i propugnatori della idea democratica la tendenza a mantenere lo
Stato in limiti misurati, per evitare una disuguglianza dei rapporti di vita, e nel fatto
che essi combattono la ricchezza per dislocare, se possibile, tutti i cittadini in una
uguale condizione media di benessere. Quando Montesquieu scorge nella virtù la tutela
piú sicura della democrazia; quando Rousseau sottolinea sempre di nuovo il fatto che
le leggi democratiche sono utili solo «se ognuno ha qualcosa e nessuno troppo poco»,
si vede già qui farsi strada il riconoscimento del fatto che il principio della democrazia
non può non andare a parare in una lotta con le condizioni effetive della società
borgese. Ed è questa, anche, la tragicità
storica della democrazia nel mondo
borghese: essa non può non essere guastata dai contrasti economici di classe, che
derivano dalle sue condizioni di esistenza. L’idea della volontà comune — e questo è la
democrazia — non ha alcuna possibilità di realizzarsi in una situazione sociale, in cui
ogni votazione — proprio se avviene in forme effettivamente democratiche — non può
non ricondurre alle contrapposizioni della volontà di classe. Ora, queste forme
democratiche, sono espresse, nella maniera piú compiuta, nella rappresentanza
popolare parlamentare che si fonda sul dititto di voto universale. E cosí vediamo che,
sul terreno della società di classe, neanche la rappresentanza popolare piú democratica
può mai condurre all’espressione di una volontà popolare unitaria. Nelle forme
dell’antodeterminazione parlamentare del popolo si compie sempre soltanto un pezzo
della lotta di classe: essa è sempre un’operazione di potere, una violenza di una classe
contro l’altra classe, che, con la sua maggioranza, impone le leggi all’altra classe
riluttante.
Ora, ogni confusione circa il concetto di democrazia nasce dal fatto che — come
appunto vediamo — questo concetto può essere realizzato solo in una società senza
classi, ma tuttavia, già all’interno di una società di classe, non può non apparire ad
ogni classe che in essa lotta preliminarmente per affermarsi, come la sua idea-guida,
poiché, in base alla dialettica sociologica — già spesso indicata — della forma statale,
nessun interesse particolare o di classe può pervenire al dominio nello Stato se non
presentandosi come rappresentante di interessi generali. Ogni estensione dei diritti
politici dei cittadini, ogni allargamento della capacità d’influenzare la formazione della
volontà statale, pertanto, non poteva poi non apparire posta nella direzione dell’idea
della democrazia, cioè non poteva non essere concepita come conquista democratica.
Página 106
Deriva da ciò, per la trattazione sociologica, il fatto che la parola democrazia indica
un concetto polisenso. Ed è possibile pervenire a intendersi su questo tema solo se ci si
attiene a una terminologia fissa. Propongo dunque: poiché el concetto di democrazia si
realizza solo in una società senza classi, vogliamo definire questa democrazia piena, la
democrazia corrispondente al suo concetto, democrazia sociale; mentre definiamo
tutte le altre forme, che altrimenti vengono definite democrazia, democrazia politica
[Nota 4]. E poiché può facilmente accadere che nel flusso del discorso, una volta o
l’altra, si tralasci l’aggettivo, va allora detto, una volta per tutte, che, quando si parla
di democrazia all’interno di una società di classe, s’intende con ciò soltanto la
democrazia politica, cioè la democrazia, che propriamente non è una democrazia e,
pertanto, dev’essere superata, se si vuole la democrazia; e che, invece, quando si
parla di democrazia all’interno di uno Stato non di classe, s’intende la democrazia
sociale, cioè una democrazia che ancora non esiste, ma dev’essere conquistata, a sua
volta, se si vuole la democrazia. Se si distinguono questi due significati della parola
democrazia, allora si risolvono le apparenti contraddizioni delle parole di Marx ed
Engels e non appare piú stupefacente il fatto che Engels, una volta, definisca la
democrazia una chimera e, poi, dichiari che essa è la forma in cui il proletariato può
pervenire al dominio, ovvero il fatto che Marx ironizzi sulla «superstizione
democratica», che «nella repubblica democratica scorge il regno millenario» e,
tuttavia, presenti la Comune, che tuttavia di fatto era una democrazia, come esempio
di dittatura del proletariato [Nota 5].
Página 107
Ciò che Kelsen obbieta (pp. 124-8 [171-3]) a questa discussione del concetto di
democrazia riferendosi esplicitamente al mio scritto Democrazia e consigli operai, non
entra nel merito vero e proprio della determinazione concettuale e, quindi, ancora una
volta, ignora il problema sociologo della democrazia. Ivi egli dice che la critica, secondo
cui la forma statale democratica presupporrebbe un’unità sociale che non esiste e,
pertanto, il principio della maggioranza significherebbe una meccanizzazione (io non ho
parlato di meccanizzazione, bensí di una brutalizzazione) dell’organismo sociale, è una
vecchia accusa dell’autocrazia e dell’aristocrazia. E l’unica cosa stupefacente sarebbe il
fatto che la validità assoluta del principio di maggioranza venga ora messa in dubbio
da una parte che, finora, aveva scorto il suo sostegno fondamentale proprio in questo
principio. Solo che il vantaggio specifico del principio di maggioranza e, quindi, della
democrazia, consisterebbe nel fatto che, con la massima semplicità dell’organizzazione,
assicurerebbe la piú estesa integrazione politica della compagine statale
(Staatsgesellschaft). Mentre la costruzione dello Stato sulla base di gruppi cointeressati
non potrebbe non condurre, in primo luogo, a un immenso appesantimento degli
apparati, impossibile per i rapporti moderni e, in secondo luogo, a una lotta continua
fra di essi per il potere nello Stato. Senza dubbio, non è lecito sopravvalutare
l’integrazione dello Stato messa in atto dal principio di maggioranza:
Se vale per qualsiasi Stato, anche per la democrazia vale ciò che Nietzsche dice del
‘nuoyo idolo’ «Quello che ha nome Stato è il piú gelido dei mostri. E gelidamente
mentisce e dalla sua bocca scaturisce questa menzogna: io, Stato, sono il popolo»
[Nota 6]
Página 108
Che la volontà dello Stato sia la volontà del popolo rimane, anche nell’organizzazione
democratica dello Stato, una finzione, ma non perché la democrazia non sia in grado di
esprimere la volontà vera del popolo, ma perché il fenomeno politico della volontà
popolare, in generale, è al massimo grado problematico. La massa, in generale, non è
capace d’iniziativa. Ciò che la volontà del popolo è, si decide, per lo pú, già prima di
ogni pratica democratica, per mezzo di una pratica autocratica, in particolare, per
mezzo della volontà del capo, che impone al popolo la sua volontà.
Non è forse questo un modello esemplare di polemica che fallisce il suo bersaglio?
Ma, insieme, essa è molto istruttiva, perché espone nella maniera piú chiara
l’inadeguatezza metodologica del metodo giuridico-formale di Kelsen per criticare un
punto di vista sociologico. Innanzi tutto, Kelsen sposta tutta la discussione,
dall’esposizione critica del concetto di democrazia e dell’importanza della decisione
della maggioranza, in quella della valutazione dell’utilità della pratica basata sulla
maggioranza. Il nostro problema era entro quali limiti possa essere scorta proprio nel
principio di maggioranza la forma di espressione della democrazia, e la risposta a
questo problema ci ha condotto ad osservare che ciò, dal punto di vista concettuale, è
possibile soltanto a patto che la votazione avvenga non fra interessi diversi, fra
interessi vitali reciprocamente contrastanti, bensí piuttosto sulla base dell’armonia di
questi interessi. Ma questa esposizione critica cade completamente al di fuori
dell’interesse di Kelsen: e questo è ovvio, poiché il giurista bada solo alla forma della
votazione; mentre non si deve curare del problema di chi abbia il diritto di votare e in
quale modo, non si deve curare di tutte quelle circostanze che costituiscono il
contenuto sociale di questa votazione, la distribuzione economica dei ruoli nella
medesima, le dipendenze e le motivazioni che ne derivano. Ma il problema che noi
avevamo posto era soltanto questo problema relativo alla funzione contenutistica del
principio di maggioranza, un problema che produceva, come risposta, una differenza
nella società fondata sul contrasto di classe e in quella senza classi, poiché nel primo
caso la maggioranza significa dominio unilaterale, mentre nel secondo significa
amministrazione comunitaria. Ma non abbiamo «messo in dubbio la validità assoluta
del principio di maggioranza», di cui volevamo piuttosto esporre la giustezza di fronte
alla scepsi dannosa e aristocratica («la ragione è stata sempre dei pochi»).
Quanto Kelsen sia incapace, partendo dal suo punto di vista, d’immedesimarsi nel
nostro, lo mostrano le sue altre obiezioni circa la «pesantezza» dell’applicazione del
principio dell’uguaglianza dePágina 109
gli interessi nella democrazia. Egli ne fa un principio di costituzione dei gruppi sulla
base d’interessi uguali nello... Stato odierno. Cioè, egli dimostra proprio ciò che la
nostra critica della democrazia politica vuole appunto dimostrare: il fatto che, finché
esistono nello Stato contrasti degli interessi vitali, non è possibile una democrazia. A
coronamento di questa autocritica Kelsen cita la frase di Nietzsche, che potrebbe
essere messa appunto come motto della teoria puramente giuridica dello Stato e del
diritto, quando essa dimentica che la semplice forma del diritto e dello Stato, grazie
alla sua universalità concettuale, ha sempre agito, nella storia, come l’espediente piú
forte d’inganno sociale: autoinganno e menzogna. Ma, se il giurista dogmatico, che ha
fiducia cieca nella lettera della legge, si fa il segno della croce di fronte all’affermazione
che la pretesa dello Stato: «Io, Stato, sono il popolo», sia una bugia; e se il giurista
critico ride maliziosamente della meraviglia del suo collega dogmatico, poiché è certo
che a lui ‘non può succedere’, visto che il suo Stato non è una bugia, ma solo una
forma in cui entra tutto, il sociologo marxista domanda invece: che razza di Stato è
questo, che diviene un gelido mostro, perché lo Stato è una menzogna e perché non
può fare a meno di esserlo? E quindi egli viene condotto alla struttura economica dello
Stato, in cui le contraddizioni dell’ideologia dello Stato trovano la loro soluzione nei
contrasti della realtà sociale: una nuova strada del pensiero, che conduce
completamente fuori dal magico cerchio giuridico, dal quale, alla fine, cade fuori — piú
che venir fuori — anche un pensatore acuto come Kelsen. Ché, alla fine della sua
polemica, egli trova problematico «il fenomeno politico fondamentale della volontà
popolare», dato che il popolo vuole soltanto ciò che il capo gl’impone.
Quest’argomentazione non fa parte né del metodo giuridico né di quello sociologico.
Ricava il suo contenuto da una visione psicologico-volgare, là dove è piú volgare.
Perché, certamente, il fenomeno fondamentale della volontà popolare non è
«massimamente problematico», bensí è un problema, ma non nella sua accezione
popolare, bensí nel senso che nasce la questione di come sia possibile questo concetto
di un’unità dei molti in un’unica volontà. Kelsen, nei suoi scritti di diritto statale, ha
magistralmente mostrato come il concetto giuridico della volontà statale ha in comune
con la categoria psicologico-individuale della volontà singolare soltanto il nome. Egli
sembra credere che il concetto sociologico della volontà comune significhi soltanto la
somma di volontà psicologiche singolari. Sotto questo profilo, basta rinviare al fatto
che, dal nostro punto di vista, la volontà comune è una categoria sociologica, non
psicologica, il cui carattere sociologico consiste appunto nell’unificazione delle singole
sfere, la quale va al di là dei singoli. Solo cosí si realizza una volontà complessiva
diversa da
Página 110
ogni volontà singola; e questo processo di unificazione si fonda sul carattere social-apriori della coscienza. Ma, a prescindere da ciò, persino accettando la problematica
kelseniana della volontà popolare, per il sociologo nasce la questione: da dove deriva,
al ‘capo’, la materia di quella volontà, che egli impone alla ‘massa’, e com’è possibile
che la ‘massa’ consenta che altri interpreti, e interpreti essa stessa, questi contenuti
della volontà come volontà popolare? E a questo punto le immagini, massimamente
indeterminate, di ‘capo’ e ‘massa’ si differenziano in immagini assai concrete di
situazioni e interessi economici, e l’asserzione relativa alla massa priva d’iniziativa
trapassa nella verità fondamentale della concezione materialistica della storia, secondo
cui, appunto, non lo spirito, bensí l’interesse è la forza motrice della storia.
Coincide con tutto il tralasciamento delle due diverse strutture sociali, che tutt’e due
le volte hanno lo stesso nome di democrazia, il fatto che Kelsen, infine, affermi contro
di me che è strano il fatto che il socialismo, che ha sempre strappato alla società di
classe la maschera dell’universalità, alla fine tuttavia, nell’apologia dello Stato di classe
proletario, si serve della stessa finzione e pone il proletariato come rappresentante di
interessi comuni. Questa sarebbe l’assolutizzazione dogmatica dell’ideale politico di un
determinato ordinamento sociale, anzi, sarebbe la finzione tipica di ogni regime
aristocratico e autocratico, innanzi tutto della teocrazia (pp. 124-5 [171-2]). Di contro
a ciò va innanzi tutto detto che il marxismo non ha mai detto altro, del proletariato e
dello Stato di classe proletario, se non che esso rappresenta gli interessi di classe del
proletariato; e che, pertanto, al marxismo non è mai capitato di usare la finzione,
secondo cui la lotta di classe proletaria sarebbe una difesa di interessi generali. Se
fosse cosí, non vi sarebbe anzi alcuna lotta. Il marxismo bensì insegna — e ne ha dato
una fondazione dal punto di vista economico — che l’attuazione di questi interessi di
classe va nella direzione che produce l’istituzione di una situazione sociale solidale. Non
si tratta affatto di idealizzare o sublimare l’interesse di classe proletario se lo definiamo
un interesse rivolto alla comunità e, pertanto, capace di stimolare la società, in
contrapposizione all’interesse di classe borghese inteso come quell’interesse che
mantiene la scissione della società e, quindi, come principio reazionario. Piuttosto è
chiaro, per i marxisti, che tanto nell’uno quanto nell’altro caso si tratta dell’egoismo
della classe. Ma la sua funzione sociologica è, nei due casi, totalmente diversa.
Nessuno ha espresso ciò con parole piú chiare e imperiture di Ferdinand Lassalle. Nel
suo Arbeiterprogramm egli dice:
Fino a quando e nei limiti in cui le classi inferiori della società perseguono il
miglioramento della loro situazione di classe, vanno verso
Página 111
il suo superamento, fino ad allora e entro questi limiti questo interesse personale,
anziché contrapporsi al movimento storico e, quindi, essere condannato all’immoralità,
secondo la sua tendenza coincide piuttosto assolutamente con lo sviluppo di tutto il
popolo, con la vittoria della idea, con i progressi della civiltà, con il principio vitale della
storia stessa, che non è altro che lo sviluppo della libertà. [...] Loro, miei signori, si
trovano pertanto nella felice situazione, invece d’essere insensibili all’idea, di poter
essere piuttosto destinati — grazie al Loro interesse personale stesso — alla massima
sensibilità per l’idea stessa. Loro si trovano nella felice situazione per cui ciò che
costituisce il Loro vero interesse personale coincide con il battito palpitante della storia,
con il principio motore vitale dello sviluppo etico. Loro possono pertanto dedicarsi allo
sviluppo storico con passione personale ed essere certi di essere tanto pi ú morali
quanto pi ú è infiammata ed ardente questa passione, nel suo significato puro, qui
esposto [nota 7].
La composizione dell’interesse di classe proletario con l’interesse sociale comune,
dunque, non è un’identificazione, bensí lo stabilirsi di una relazione, che acquista tutto
il suo significato solo dallo sviluppo storico, cioè dal ruolo che questo sviluppo
attribuisce al proletariato. Dove stia, in tutto ciò, la ‘finzione’ dell’ideologia aristocratica
o, addirittura,
teocratica, dove stia l’ ‘assolutizzazio ne’ di ideali politici, mi è
semplicemente incomprensibile. O, per meglio dire: una tale opinione diviene súbito
comprensibile non appena ci si ricordi del fatto che il giurista che usa un metodo
formale non sa nulla e nulla può sapere dello sviluppo storico, della diversa valutazione
(T axation) dell’egoismo di classe, della diversa posizione rispetto alla solidarietà dei
membri della società. Per lui, per l’uomo del « diritto uguale per tutti », una classe è
buona o cattiva quanto un’altra e tutte gli sono indifferenti, poiché nello ‘Stato’ non
domina la classe, bensí l’organizzazione costrittiva. Un tale punto di vista, certo, non
assolutizza ’ alcun ideale politico, ma assolutizza se stesso fino al punto in cui non sa
dire piú nulla, ‘assolutamente’, circa l’effettiva costituzione e il destino dello Stato.
Naturalmente, poi, l’unica forza sociale che può istituire una democrazia effettiva, la
forza di classe del proletariato, non può non apparirgli come presa nella malia di una
finzione
Página 112
Capitolo decimo
Democrazia e libertà
In un altro saggio, apparso quasi contemporaneamente allo scritto su Socialismo e
Stato, Kelsen si addentra maggiormente nel problema del principio di maggioranza
della democrazia. Si tratta del saggio, assai ricco d’idee, Intorno alla natura e al valore
della democrazia [nota 1], la cui considerazione sarà molto istruttiva anche sotto il
nostro punto di vista, poiché in tal modo perveniamo a un nuovo lato del nostro
problema, cioè alla questione di quale importanza sociologica abbiano le idee di libertà
e uguaglianza. In questa trattazione Kelsen parte dalla constatazione che l’idea della
democrazia contiene non solo il principio dell’uguaglianza dei cittadini, ben s, innanzi
innanzi tutto, quello della loro libertà. Da questo punto di vista appare poi giustificato il
principio di maggioranza, poiché garantisce l’unica possibilità sulla quale può essere
assicurata perlomeno la libertà del maggior numero. « Soltanto se si muove dal
concetto che — se non tutti — devono essere liberi almeno il maggior numero possibile
di uomini, ossia dunque che il minor numero possibile di essi debbano trovarsi con la
loro volontà in contrasto con la volontà dominante dell’ordinamento sociale — si può
giungere per una via razionale al principio di maggioranza » [nota 2]. Muovendo da qui
Kelsen trova — e questo è indiscutibile — che la democrazia, se viene costruita sulla
libertà dell’individuo, conduce a una « differenza inevitabile » fra la volontà del singolo
e l’ordinamento statale, che fa apparire ‘insalvabile’ questa libertà del singolo. Ciò
conduce, nel corso dello sviluppo delle idee, a uno spostamento per quanto riguarda il
soggetto della libertà. Al posto dell’individuo subentra l’insieme, il collettivo sociale, in
cui l’individuo vive. Ora si tratta soltanto della libertà di questo insieme
Página 113
e solo a partire da questo punto di vista scompare la contraddizione che, altrimenti, il
principio di maggioranza rappresenta rispetto alla libertà del singolo. L’idea di
democrazia è cosí pervenuta, da una posizione di partenza soggettivistica — quella
della libertà dell’individuo — a un risultato finale oggettivistico: alla libertà dell’insieme.
E questa contraddizione sarebbe caratteristica di Rousseau non meno che di Kant e di
Fichte [nota 3].
Va innanzi tutto constatato che, in questa discussione, anche Kelsen perviene
soltanto a dedurre il principio di maggioranza dalla libertà dell’intero. Il mio punto di
vista della democrazia sociale coincide completamente con questa posizione. Pertanto,
indico anche con soddisfazione il fatto che, in questa trattazione, Kelsen deve
ammettere: « Non vi è dubbio che l’ideale della maggior possibile eguaglianza
economica sia un ideale democratico. E, perciò, soltanto la socialdemocrazia è una
perfetta democrazia » [nota 4]. Ma Kel sen, a causa del suo metodo formale
s’accontenta d’aver trovato la democrazia ancorata nell’autodeterminazione della
collettività sociale, senza domandarsi ancora di che genere debba essere una tale
collettività sociale. La constatazione che non può essere una collettività fondata sul
contrasto di classe, ma soltanto una solidale dal punto di vista economico, è una
constatazione che non è possibile fare dal punto di vista giuridico, e la dannosa
espressione dei giuristi: Quod non est in actis, non est in mundo”, vale anche per il
mondo concettuale puramente giuridico di Kelsen. Quando pertanto Kelsen ritiene che
il principio di maggioranza sia essenziale per la democrazia fino al punto che essa « per
la sua natura, non solo presuppone concettualmente un’opposizione — la minoranza —
ma la riconosce anche politicamente » [nota 5], questa conseguenza mostra già la
pericolosità e la deficienza del suo metodo formale. Poiché questa affermazione ha
come presupposto una collettività sociale in generale, senza pensare insieme la
struttura economica particolare. Poiché, ove una tale struttura economica non sia piú
fondata sul contrasto di classe, certo, nelle votazioni, può esserci ancora
un’opposizione, ma, dal punto di vista concettuale, essa non va piú presupposta come
necessaria. E, d’altra parte, nel caso in cui sussista tale contrasto di classe, anche la
maggioranza democratica ’, « secondo la sua piú intima natura », non ha affatto
riconosciuto politicamente la minoranza, bensí utilizza piuttosto la sua maggioranza per
dominare questa minoranza. Questo lo vedremo ancora piú chiaramente nel capitolo su
La dittatura. Ora si palesa, ancora una volta, il fatto che ogni tentativo di determinare
Página 114
l’essenza della democrazia a prescindere dalla sua funzione sociologica come
autodeterminazione di una collettività solidale, va a parare nelle contraddizioni che
Kelsen vuole evitare.
Per ritornare ora alla discussione kelseniana del fatto che la democrazia emerge dal
concetto di libertà, non posso non concordare assolutamente con Kelsen sul fatto che il
cosiddetto concetto di libertà individuale è insalvabile e, se viene mantenuto, la
democrazia diviene priva di senso. Kelsen crede di aver portato avanti, con ciò,
qualcosa di grave contro il marxismo, poiché anzi egli conduce tutto il suo libro —
come è stato piú volte osservato — a parare in ciò: a scoprire una tendenza anarchica,
rivolta verso la libertà dell’individuo, in Marx e Engels, nel loro rifiuto dello Stato,
tendenza anarchica che rappresenterebbe una stridente contraddizione fra la teoria
economica del marxismo e la sua dottrina politica. Ma di ciò si dovrà ancora parlare.
Qui, però, va detto che anche noi rifiutiamo la libertà dell’individuo come punto di
partenza non solo nella discussione della democrazia, ma in quella di ogni fenomeno
sociale, ma non perché essa conduca a una differenza insuperabile fra trattazione
individuale e trattazione sociale, bensí perché essa non è un concetto teoricamente
sostenibile. Il punto di vista della libertà individuale è una componente tipica di una
ideologia di classe, dell’ideologia borghese, che tanto sotto il profilo politico quanto
sotto quello sociologico e, infine, pertanto anche sotto quello filosofico, è rimasta
attaccata alla facciata esterna del fenomeno sociale della libertà. Come lo Stato si
presentava alla coscienza borghese soltanto come un prodotto della volontà, di modo
che valeva la pena di far diventare dominante in esso la propria volontà, cosí, anche
dal punto di vista filosofico, la coscienza singola e la volontà singola acquistò una
posizione centrale nella riflessione, e la ricerca sulla natura e le leggi dell’intelletto
umano dominò completamente, a partire dal XVII secolo, l’interesse filosofico
dell’epoca. In questa teoria della autonomia delle leggi e della libertà dello spirito
umano si compiva la proclamazione dell’indipendenza spirituale della borghesia prima
della sua indipendenza politica.
Ma, giustamente e in maniera molto acuta, Kelsen ha mostrato come il punto di vista
della libertà individuale, alla fine, conduce alla contraddizione, per cui l’individuo
tuttavia deve mantenersi vincolato al suo voto, se non si deve cadere nell’anarchia, e
dunque attraverso l’uso della libertà si rende non libero. Ma questa contraddizione
sussiste appunto soltanto dal punto di vista della libertà individuale, che, come ci ha
mostrato Kelsen, dovrebbe essere svincolato da quello della libertà collettiva.
Ammesso pure: ma che ne è poi della libertà individuale?
L’elemento essenziale non sta in questo svincolamento, attraPágina 115
verso il quale si perviene a un rigido dualismo fra una Weltanschauung individualistica
e una collettivistica, che anche Kelsen sembra seguire e che, alla fine, farebbe
insabbiare ogni discussione di problemi sociali nella disputa irrisolvibile di queste ultime
opposizioni — secondo la massima triviale, qui elevata però a veduta fondamentale: “I
gusti non si discutono ” [nota 6].Un tale relatiPágina 116
vismo, che mette in discussione la scienza della vita sociale, non va semplicemente
rifiutato, ma addirittura neanche esiste. Naturalmente questo si ricava solo da quella
concezione critico-gnoseo logica del trascendentalismo kantiano, in cui — e su questo
da anni mi sono inutilmente sforzato di richiamare l’attenzione — anche l’elemento
sociale appare soltanto come un lato a priori della nostra coscienza in generale. Solo in
tal modo la critica della ragion pura acquista tutto il suo significato rivoluzionario, che
abbraccia cioè anche la scienza sociale, e Kant diviene il punto conclusivo della vecchia
e il punto iniziale della nuova filosofia [nota 7], colui che porta a compimento il
pensiero individualistico e dà inizio a quello collettivistico.
Si produce quindi sùbito, come elemento essenziale per il nostro tema, quanto segue:
il concetto di libertà individuale diviene contraddittorio politicamente innanzi tutto
perché è un non senso, perché dal punto di vista dell’individuo in generale non è
possibile alcun concetto di libertà, e ciò che cosí si indica è soltanto assenza di limiti,
o, per meglio dire, possibilità di porsi al di là dei limiti. Giustamente si è richiamata
l’attenzione sul fatto che questa libertà, propriamente, è un elemento negativo, un
esser liberi da qualche cosa. Va invece osservato — e questo finora è stato sempre
tralasciato, come del resto è stata popolarizzata, anzi volgarizzata la teoria kantiana
della libertà dell’autodeterminazione della volontà — il fatto che il concetto di libertà, in
generale, non è
Página 117
un concetto individuale, bensí un concetto collettivo, poiché con il concetto di
autodeterminazione della volontà non si pensa affatto la volontà psicologica singola,
bensí il processo della volontà in generale, che, in ogni volontà singola, appare
necessariamente riferito a una molteplicità indeterminata di soggetti di volontà, allo
stesso modo in cui il processo del pensiero, nella coscienza singola, appare sempre
riferito a una tale molteplicità di soggetti di pensiero. Il soggetto psicologico della
volontà — esattamente come il soggetto psicologico del pensiero — è una semplice
forma di manifestazione. La libertà individuale, in quanto libertà del singolo, in quanto
sentimento atomistico, è un’apparenza paralogistica, un autoinganno inevitabile
dell’individuo. Il concetto di libertà contiene, necessariamente, la sottomissione della
volontà semplicemente sotto la sua legge, e questo, nella coscienza singola, non può
apparire altrimenti che come sottomissione della medesima ad una norma, che,
secondo la sua possibilità concettuale, non può piú essere individuale, ma, andando al
di là dell’individuo, inserisce quest’ultimo, in maniera non contraddittoria, nel sistema
di una molteplicità indeterminata di soggetti di volontà individuali.
Ciò che Kelsen presenta come mutamento di significato della democrazia, questo
spostamento del soggetto della libertà dal lato individuale a quello collettivo, è, in
fondo, la confluenza di due concezioni politiche fondamentali del tutto diverse, in
particolare, del liberalismo e della democrazia. Abitualmente si ritengono queste due
tendenze identiche o tuttavia molto affini, soprattutto, storicamente, si sono
presentate spesso unite nella lotta contro l’assolutismo e il feudalesimo e, per lo pii, si
sono presentate indistinte anche per la coscienza dei partiti in lotta. Ma proprio per
questo è doppiamente necessario chiarirsi il fatto che fra liberalismo e democrazia
sussistono delle distinzioni profonde, anzi di principio, che hanno fatto degli odierni
teorici neoliberali addirittura degli aspri avversari della democrazia. Solo sulla base di
una chiara distinzione di ciò che appartiene al ragionamento liberale e di ciò che
appartiene a quello democratico si produce un’immagine chiara della natura della
democrazia e scompaiono le contraddizioni che le vengono attribuite cosí come, in
particolare, la scorretta valutazione dei pensatori — come Rousseau, Kant e Fichte —
legati alla creazione di idee democratiche, che, quindi, non oscillano piú in uno strano
conflitto fra individualismo e collettivismo.
La libertà, e invero quella individuale, è la stella polare del liberalismo; l’uguaglianza,
invece, quella della democrazia. La prima idea riconduce la società al singolo, la
seconda, invece, pone il singolo accanto a una molteplicità indeterminata di altri, con
cui
Página 118
sta in rapporto come uguale fra uguali. Anche l’idea democratica contiene il principio
della libertà, ma non quella del singolo, bensí quella dell’insieme, nella cui libertà
anche al singolo tocca la sua parte uguale. A partire da qui si produce già il significato
completamente diverso della libertà e il suo significato, per cos í dire, subordinato,
all’interno della democrazia, di contro alla sua posizione centrale nel liberalismo.
Questo fondamentale rapporto fra liberalismo e democrazia è stato esposto, in maniera
decisiva, in verità senza trattare esplicitamente con questo nome questo tema, ma
elaborando tuttavia chiaramente la contrapposizione obbiet tiva, da G. Jellinek, nel suo
scritto, conciso ma ricco di contenuto, sui diritti dell’uomo e del cittadino in Francia
[nota 8]. Qui viene prodotta, da un punto di vista di storia delle idee, la dimostrazione
del fatto che i diritti dell’uomo e del cittadino, in Francia, derivano da una concezione
dello Stato e della società completamente diversa da quella del contratto sociale di
Rousseau, con cui abitualmente li si mette in rapporto, anzi che quest’ultima è
assolutamente ostile all’idea dei diritti dell’uomo, cioè all’immagine di diritti che
spetterebbero all’individuo indipendentemente dallo Stato e addirittura contro di esso
[nota 9]. L’idea di diritti di libertà inalienabili, di cui l’individuo conserverebbe qualcosa,
per cos í dire, anche dopo il contratto sociale, in nome dei quali assumere un
atteggiamento ostile verso lo Stato, verso la comunità, è una componente del pensiero
liberale, non del pensiero democratico. I diritti fondamentali dell’individuo precedono,
nel liberalismo, i diritti statali della comunità, anzi, in tal modo, lo Stato appare.
nropriamente, soltanto come il prodotto dell’accordo comune e libero di tutti. «
Danprima è stato istituito il diritto del creatore dello Stato, cioè dell’individuo
inizialmente libero e illimitato: poi, meno della creazione degli individui, quello della
comunità » [nota 10]. Nello stesso senso, ma in maniera niú pungente, a causa della
sua dura posizione polemica contro la democrazia e a favore della monarchia liberale,
Wilhelm Hasbach ha espresso l’opposizione delle due tendenze e la posizione di
Rousseau ostile al liberalismo
E, con analoga avversione nei confronti della
democrazia, ma appoggiandosi specificamente a un’opposizione — per altro verso
molto gradita e degna di riconoscimento — contro gli eccessi del patriottismo ’, che,
mettendosi al servizio della politica di guerra, si presentava come affermazione di un «
senso comunitario » puro, Leopold von Wiese
Página 119
aveva nuovamente compiuto — già durante la guerra — la distinzione critica fra Locke
e Rousseau, fra liberalismo e democrazia [nota 12]. Ricordiamoci ora della distinzione
che abbiamo fatto fra demo, crazia politica e sociale, in base a cui solo la seconda è in
grado di fondare una comunità reale perché solidale. t quindi senz’altro chiaro che il
liberalismo non può non essere diverso dalla democrazia, non può anzi non esserle
avverso, già per il fatto che esso non ha, in generale, l’idea di una comunità. Esso
conosce soltanto azioni singole, che scorrono l’una accanto all’altra o l’una contro
l’altra, dal cui libero gioco esso spera che nasca alla fine un’armonia. Ma non ha troppa
fiducia nel suo proprio gioco. Ché, infine, è proprio esso a produrre l’idea dello Stato
come difesa comunitaria di tutti. Del tutto al contrario di quanto abitualmente si crede,
dunque, il liberalismo, in fondo, crede nello Stato. Poiché per esso lo Stato non si fonda
su una vita propria della comunità, cioè, poiché esso prende le mosse non dalla
socializzazione dell’individuo, bensí dall’isolamento del medesimo, da una parte, in
verità, non riconosce alcun potere sovraordinato rispetto all’individuo, ma, d’altra
parte, non può immaginarsi la convivenza di questi individui in altro modo che
attraverso un dominio che li tiene insieme, e il cui potere esso vuol sapere limitato a
ciò che è assolutamente necessario. Il liberale, pertanto, propriamente, in fondo
all’anima è colui che crede nell’autorità, è un sostegno dell’ordinamento, in breve, è un
elemento che ‘mantiene lo Stato’; mentre, al contrario, il democratico della volontà
comune, che non conosce limiti di alcun genere — neanche, come diceva Rousseau,
quelli del contratto sociale — non ha alcun timore reverenziale di fronte allo Stato e
all’ordinamento, ma scorge il potere ultimo e l’unica legge nei bisogni della volontà
generale del popolo. È per questo motivo che già Kant e, in particolare, Fichte, non
hanno avuto molta tenerezza per lo Stato Positivo, per lo « Stato della necessità », cui
contrapponevano lo Stato di ragione, anzi, com’è noto, Fichte è giunto fino alla veduta
per cui lo scopo di ogni governo sarebbe di rendersi superfluo, in quanto al posto dello
Stato governerebbe la legge etica. È paradossale, ma corrisponde tuttavia al rapporto
reale, sia dal punto di vista della storia delle idee sia dal punto di vista di classe, il fatto
che, esaminandole pii nel dettaglio, le rappresentazioni correnti del rapporto del
liberalismo e della democrazia con lo Stato si rovesciano completamente: il primo
afferma lo Stato in quanto organizzazione di dominio, poiché esso è anzi l’ideologia
della classe dominante, che vuole conservare la proPágina 120
prietà; la seconda nega invece lo Stato in quanto macchina per il dominio fino al limite
dell’anarchismo, poiché essa vuol appunto abolire questo dominio e vuol fondare al suo
posto la solidarietà della comunità. L’affinità con l’anarchismo, rimproverata al
marxismo cosí spesso e presentata come tanto contraddittoria, da parte di Kelsen —
affinità di cui dovremo ancora parlare dettagliatamente —, acquista così sin da ora un
aspetto meno contraddittorio, come del resto già ora possiamo intuire che la negazione
dello Stato, da parte dell’anarchismo, potrebbe avere ancora un altro significato che
non quello che abitualmente gli viene attribuito [nota 13].
Si ottiene dunque, cosí, che la componente egualitaria della democrazia non è affatto
necessario che stia in contraddizione con la sua componente libertaria, a patto che
tanto la libertà quanto l’uguaglianza siano sottratte alla sfera del liberalismo, cioè alla
concezione individualistica e siano inserite nella sfera, ad esse propria, della
socializzazione dell’esistenza umana, la cui espressione politica è la democrazia sociale.
Solo da questo punto di vista libertà e uguaglianza diventano ciò che nel liberalismo
non sono, cioè attributi complementari. Adesso esse non indicano piú tanto condizioni
del singolo, quanto piuttosto lati della socializzazione stessa e divengono propriamente
soltanto espressioni diverse per indicare una trattazione diversa della stessa cosa, cioè
appunto della socializzazione. Nei limiti in cui, sulla base di ciò essa viene considerata
qual è, al livello della configurazione solidale del suo ordinamento, grazie alle volontà
concordi dei suoi membri, questi si presentano come liberi: per quanto rigorosa possa
essere la regolamentazione della loro vita; e nei limiti in cui, d’altra parte,
quest’ordinamento della vita viene riconosciuto soltanto come un’emanazione della
socializzazione solidale, che i sinPágina 121
goli costruiscono grazie a una funzione di lavoro umano uguale, essi si presentano
come uguali, per quanto possano essere diverse le loro funzioni all’interno della
società. Per questo, già nella Sacra famiglia, Marx definiva acutamente l’uguaglianza
soltanto come un modo « francese, cioè politico » di esprimere « l’unità essenziale
degli uomini, la coscienza generica (Gattungsbewusstsein) ed il comportamento
generico dell’uomo, l’identità pratica dell’uomo con l’uomo, cioè la relazione sociale o
umana dell’uomo con l’uomo » [nota 14].
Questo punto di vista della socializzazione, a partire dal quale soltanto può essere
superata la contrapposizione fra liberalismo e democrazia, è identico al punto di vista
sociologico del marxismo, che non può evitare di trattare Stato ed economia non piú
dal punto di vista dell’individuo, bensí soltanto da quello dell’insieme sociale, in cui si
sviluppano, o, per meglio dire: di cui sono funzioni. E questo insieme non è un
superorganismo mistico, ma sono i singoli uomini stessi, ma in quanto nature
socializzate, cioè come nature che, già nel loro pensiero, non possono immaginarsi
alcuna cosa senza riferirla a una molteplicità indeterminata di altre nature dello stesso
genere. E da questo rapporto critico-gnoseologico del concetto di libertà con l’insieme
sociale, quindi anche con la democrazia, si ricava anche che Kelsen a torto rimprovera
alla filosofia critica, dopo Kant e Fichte, la contraddizione — di cui sarebbe rimasta
inconsapevole — per cui sarebbe pervenuta, da una posizione di partenza
soggettivistica, a un risultato finale oggettivistico. Questo rimprovero si fonda piuttosto
su un fraintendimento di fondo del carattere critico-gnoseologico della filo sofia classica
tedesca, che Kelsen, insieme con molti altri considera evidentemente — si confronti la
sua annotazione a p. 54 [96] [nota 15] – come una filosofia soggettivistica. Deve
invece finalmente diffondersi l’interpretazione piú corretta, secondo cui la filosofia
classica tedesca prende le mosse bensí dal soggetto della conoscenza, ma soltanto per
eliminare radicalmente e per sempre l’apparenza soggettivistica della sua coscienza.
Essa scorge tuttavia il suo compito principale nel mettere in evidenza la legalità della
coscienza in generale, che essa naturalmente può trovare e mettere in evidenza solo là
dove è presente, cioè nel soggetto singolo. Ma, quanto piú le riesce questa operazione
del mettere in evidenza (Herausarbeitung), tanto piú l’individuo s’immerge nella
legalità della vita spirituale in generale. Nei miei studi sulla storia culturale del
socialismo ho accennato per questo anche al fatto
Página 122
che, essenzialmente, la filosofia classica tedesca — e, in verità, già nella sua parte
logica, e non quindi soltanto nella critica della ragion pratica — è una filosofia della
coscienza sociale, per cui, per usare la terminologia di Kelsen — già il suo punto di
partenza è oggettivistico ’6. E, in questo senso, appartiene alla stessa tendenza anche
Rousseau, di cui ho comunque indicato il fatto che la sua idea del contratto sociale
vuole rendere intuibile non il momento soggettivistico della conclusione del patto, bensí
quello collettivistico del legame generale della volontà singola [nota 17]. In tal modo,
qui, la contrapposizione fra liberalismo e democrazia si mostra, da ultimo, vincolata da
un punto di vista critico-gnoseologico.
La democrazia, in questa accezione di un’autodeterminazione dell’insieme sociale,
presuppone però che questo insieme sia tale di fatto e non soltanto fittiziamente. Cioè,
poiché l’insieme sociale non può esistere altrimenti che nell’insuperabile relazione
reciproca delle coscienze delle sue parti, cioè dei singoli uomini, allora la coscienza
dell’insieme deve anche poter riempire tutte le sue parti in questa relazione reciproca.
Esse devono potersi trovare unite da questa relazione anche nei loro scopi e nei loro
interessi vitali, e non separate e contrapposte. Poiché una compagine costituita da
parti consapevoli non può altrimenti costituire un intero. Se non si verifica questo,
questa compagine può essere un insieme tutt’al pi ti per un’altra trattazione, per una
trattazione che la colga dall’esterno, sotto determinati punti di vista, esterni rispetto
alle parti, ma non può essere un insieme per se stesso. Una tale coscienza uguale in
tutti i singoli membri della società è possibile soltanto se vi è un’uguaglianza degli
interessi vitali che si riferiscono all’ordinamento di questo insieme. Solo questa
struttura economica della vita sociale, in cui tutte le questioni della lotta vitale degli
individui, che oggi costituiscono il fondamento vero e proprio della formazione della
maggioranza, sono per cosí dire un senso comune sociale (ein gesellschaftliches
Adiaphoron), un’ovvietà, di cui non si parla, poiché sono in anticipo ugualmente
ordinate per tutti, crea quel milieu ideologico, in cui, poi, le decisioni della maggioranza
non vengono più sentite, da quelli che sono in minoranza, come una limitazione della
libertà. Certo, anche nella democrazia sociale ci saranno opinioni diverse e partiti
contrapposti. Ma, pur con tutta la passionalità di tali divisioni partitiche, la minoranza
non considererà il suo soggiacere come una sottomissione a un atto di dominio, come
altrimenti avviene dapPágina 123
pertutto nella democrazia politica, ma come una misura amministrativa, certo non
auspicata, ma, tuttavia, in fondo spontaneamente voluta, poiché la norma della
decisione della maggioranza, anzi, è soltanto, addirittura, una disposizione di utilità
relativa al modo di condurre delle vicende, in cui, già prima di ogni votazione, è
garantita la salvaguardia, per principio, di tutti gl’interessi personali fondamentali.
In tal modo, anche questa discussione del problema della democrazia, in cui abbiamo
tenuto presente il suo rapporto con l’idea di libertà, riconduce al medesimo risultato e
rafforza ulteriormente ciò che abbiamo ottenuto già all’inizio di questa ricerca: il fatto
che il concetto di democrazia, in quanto concetto formale, che si adatta a tutte le
forme di società, non è in generale possibile, e il fatto che esso è, invece,
l’anticipazione ideologica di una situazione sociale determinata, che ancora non esiste:
l’anticipazione della condizione di una società solidale; e, infine, il fatto che è da qui
che deriva il doppio significato della parola democrazia. Perché nel corso dello sviluppo
sociale si collega, di volta in volta, con la lotta di una classe per istituire una maggiore
solidarietà sociale (cioè, per superare la sua oppressione economica e politica),
appunto quest’idea della democrazia, con la sua aspirazione e tendenza politica, che
definisce quindi se stessa come lotta per la democrazia, anche se questa aspirazione e
tendenza politica, in base alla sua struttura economica, non può affatto realizzare
questa democrazia. Sta qui la radice dell’affinità fra democrazia e rivoluzione, era qui il
fondamento della fusione storica di liberalismo e democrazia, ma, innanzi tutto, si
fonda qui la necessità del collegamento concettuale fra democrazia e socialismo,
poiché solo il secondo può realizzare la prima. Ma per questo si è presentata la
necessità di distinguere concettualmente, in forma definitiva, queste due forme
storiche di manifestazione della democrazia, celate dall’unico nome di democrazia e di
distinguerla, anche terminologicamente, come democrazia politica e sociale, se si vuol
pervenire, infine, intorno a questo tema, dalla disputa peggiore a un’effettiva
comprensione reciproca. Cesseranno poi anche le lamentele sulle cosiddette
contraddizioni del marxismo, per lo meno per quanto riguarda questo capitolo.
Página 124
Capitolo undicesimo
Rivoluzione o evoluzione?
Siamo ora in grado, sulla base della comprensione acquisita circa la natura della
democrazia e evitando l’ambivalenza di questa parola, di passare ai concetti di
dittatura e rivoluzione, malamente assunti insieme dalla critica kelseniana.
Contemporaneamente ci sarà offerta anche l’occasione di tentare di ovviare a un’altra
confusione delle interpretazioni, largamente diffusa anche al di fuori di questa critica,
facendo ricorso al punto di vista sociologico del marxismo. E la discussione dettagliata
dei capitoli precedenti circa il senso dei concetti marxisti di Stato, classe, partito e
democrazia consentirà di essere qui piú brevi. Perché, in fondo, in queste esposizioni è
contenuto già tutto l’essenziale anche circa questi due temi, discussi in maniera tanto
infuocata sia dalla teoria sia dalla politica.
La questione specifica, di cui in questo caso ci dobbiamo occu pare all’interno della
critica kelseniana, è quella se il concetto dello sviluppo rivoluzionario dallo Stato
borghese a quello proletario ha ancora in generale un senso, quando si sia constatato
che Marx e Engels si rappresentavano questo processo come un processo che scorre
all’interno delle forme della democrazia, quindi partendo dal presupposto che il
proletariato rappresenti la stragrande maggioranza della popolazione. Secondo Kelsen,
vi è qui una grande contraddizione fra la dottrina politica del marxismo e la sua teoria
economica. Quest’ultima sarebbe senza dubbio evoluzionistica: farebbe emergere il
potere del proletariato dal suo sviluppo economico fino a farlo diventare la classe pii
forte della società. Ma, poi, — presupposta la condizione della democrazia politica —
sarebbe inutile l’applicazione della violenza. Marx stesso, come dimostra il suo
discorso di Amsterdam del 1872, non avrebbe escluso, negli Stati parlamentari, uno
sviluppo pacifico verso il socialismo. E, di fatto, dovrebbe essere considerata come una
delle poche esperienze sicure della storia il fatto che, in verità,
Página 125
l’introduzione della democrazia esige per lo piú la violenza, mentre poi il
proseguimento del suo sviluppo in una costruzione organica si compirebbe con i suoi
propri mezzi, cioè pacificamente (pp. 28 e 92 [63 e 141]). Lo sviluppo verso la
democrazia parlamentare — posto che esista il diritto universale di voto — è soltanto
una questione di tempo. Una volta che il proletariato abbia la maggioranza in
parlamento, non vi è poi neanche bisogno — per trasformare lo Stato capitalistico in
quello proletario — di un cambiamento della costituzione, bensí di semplici leggi
economiche. Che cosa significano ancora, allora, i concetti di dittatura del proletariato ’
e di ’ rivoluzione ’? Non è un semplice gioco di parole parlare di un annullamento dello
Stato da parte della dittatura proletaria, ove di fatto si ha soltanto una trasformazione
dello Stato compiuta dal proletariato divenuto maggioranza democratica (p. 32)? Si
vede, di fatto, che le parole dittatura, rivoluzione e abolizione dello Stato
rappresentano soltanto una fraseologia rivoluzionaria mantenuta per motivi di
agitazione politica, parole che, qualora vengano ricondotte al significato della teoria
economica del marxismo, possono essere interpretate in maniera semplicemente
evoluzionistica oppure divengono del tutto prive di significato (p. 97).
Anche in questo caso, tutta questa critica mantiene la sua apparenza di
giustificazione solo nei limiti in cui permane nel modo di pensare del tutto formale del
suo autore. Ancora una volta, non vi è affatto una critica immanente del marxismo,
bensí una critica tale in cui i suoi concetti non vengono mai presi nella loro pienezza
storico-sociale, ma, per cosí dire, come gusci in cui può essere versato qualsiasi
contenuto. È indicativa di ciò già la veduta di Kelsen — che del resto appare
giustamente strana e fa stupore certamente tanto allo storico quanto al politico —
secondo cui la democrazia ha bisogno di mezzi rivoluzionari si per essere
necessariamente introdotta, ma non per essere estesa e formata (p. 92).
Naturalmente, per i giuristi questa estensione consiste soltanto in quella ottenuta
attraverso le leggi — decise dai parlamenti — sull’allargamento del diritto elettorale,
del diritto di coalizione ecc. Il fatto che ognuna di tali riforme parlamentari sia stata
preceduta dalle lotte di classe piú violente nello Stato stesso, da dimostrazioni di
massa delle masse popolari private dei diritti, fors’anche da scioperi e da lotte nelle
strade, finché la maggioranza nelle strade ha costretto la maggioranza nel parlamento
« a costruire con uno sviluppo organico » la democrazia: tutto ciò, naturalmente, cade
al di fuori della trattazione giuridica di tutto questo processo di sviluppo. Per questo
punto di vista, pertanto, anche il diritto universale di voto è la forma in cui la
democrazia deve pervenire alla sua piena espressione, poiché il giurista può solo
contare i voti, ma non li può ponderare. Per il giurista, la
Página 126
funzione del diritto universale di voto si esaurisce con il fatto che esso è il mezzo per
portare alla luce la volontà del popolo in quanto volontà della maggioranza, se è
effettivamente ‘universale’ e ‘uguale’. Marx e Engels, invece, hanno sempre messo in
rilievo il fatto che il diritto universale di voto può essere la forma politica per gli scopi diversi, a seconda della diversa struttura sociale di un paese -e del rispecchiamento
ideologico della medesima in un certo periodo. Cosí, Napoleone III con l’aiuto del
diritto universale di voto diede il colpo di grazia alla repubblica e, all’interno delle sue
forme, istituí il dominio della grande borghesia; cosí, per Bismarck il diritto universale
di voto era solo uno strumento nella lotta contro il liberalismo borghese e, in Austria,
un mezzo per rafforzare il potere dinastico statale contro il separatismo delle
nazionalità. E, nelle sue lettere per la « New York Tribune », Marx una volta (nel 1855)
espone nel suo modo brillante la differenza che la richiesta del diritto universale di voto
aveva in Francia e in Inghilterra.
In Inghilterra — egli dice — non vi è alcun dubbio sul significato del diritto universale
di voto, né sul suo nome. E la charte delle classi popolari e significa appropriazione del
potere politico come mezzo per la realizzazione dei loro bisogni. Il diritto universale di
voto — che in Francia, nel 1848, veniva inteso come parola risolutiva
dell’affratellamento generale — viene inteso pertanto, in Inghilterra, come una parola
di combattimento. Là il contenuto immediato della rivoluzione era il diritto universale di
voto; qui il contenuto immediato del diritto universale di voto è la rivoluzione [nota 1].
A ciò non si può obbiettare, come fa Kelsen, che il dato di fatto dell’abuso non
democratico del diritto universale di voto non dimostra nulla contro la sua capacità di
essere un puro mezzo di espressione della democrazia. Certo, ammette Kelsen,
l’indifferenza politica di grandi masse popolari, la loro dipendenza economica, le
limitazioni che derivano dalla tecnica della suddivisione delle circoscrizioni elettorali e
della pratica elettorale, ecc. offuscano il risultato del diritto universale di voto. Ma,
nel senso della teoria di Marx e Engels si può trattare soltanto di liberare la
democrazia — magari anche con la forza — da queste ristrettezze e di trasformarla,
per mezzo della generalizzazione dei diritti politici e della garanzia di una piena libertà
politica, in una democrazia reale, pura, che quindi assicura spontaneamente alla
maggioranza del popolo — al proletariato — il dominio (p. 101 1149]).
Página 127
Questa obiezione è il modello piú puro di un modo di pensare da giurista; esso scorge
le limitazioni della democrazia soltanto nella carenza delle disposizioni di legge sul
diritto elettorale e delle ordinanze di attuazione a ciò relative. Il fatto che queste
‘limitazioni’ si radichino però nel potere di classe dei gruppi sociali nello Stato, potere
di classe che fa giocare la sua influenza all’interno delle forme giuridiche aventi
validità, il fatto che dunque queste limitazioni non possono essere superate
legalmente, ma solo conferendo un contrappeso a questo potere di classe attraverso
fatti extragiuridici: tutto ciò cade all’esterno di questa trattazione. Fa parte dei meriti
teorici di Lenin l’aver nuovamente indirizzato l’attenzione a quel lato del modo di
pensare marxista, in cui il suo concetto fondamentale — secondo cui lo Stato, finché è
costruito sulla base dell’opposizione di classe, rimane, anche nella forma democratica,
una macchina oppressiva — è pervenuto grazie a Marx stesso a un’espressione acuta,
fin troppo spesso trascurata anche da parte marxista. Già nel 18 Brumaio Marx ha
mostrato che tutti i progressi della forma statale, dal feudalesimo, attraverso lo Stato
assolutistico, la monarchia legittimistica e costituzionale, fino alla repubblica
parlamentare, non potevano non condurre ad altro che a fare del potere statale uno
strumento di dominio piú conveniente per la classe o per i gruppi di classi di volta in
volta dominanti. « Tutti i rivolgimenti politici non fecero che perfezionare questa
macchina, invece di spezzarla ». I progressi della democrazia erano ugualmente
soltanto mutamenti di ruolo nella lotta dei partiti borghesi, lotta nella quale « il
possesso di questo enorme edificio dello Stato » fu considerato « come il bottino
principale del vincitore » [nota 2]. E ciò che qui scriveva il giovane’ Marx, lo
confermava il Marx ’ maturo ’, quando, ne La guerra civile in Francia, dice: « Dopo
ogni rivoluzione che segnava un passo avanti nella lotta di classe, il carattere
puramente repressivo del potere dello Stato risultava in modo sempre piú evidente »
[nota 3]. Leone Trockij, nel suo scritto Terrorismo e comunismo, ha riassunto molto
bene tutto ciò che a un modo di pensare puramente giuridico non può non apparire
come ‘limitazione’ della democrazia, che non avrebbe nulla a che fare con la sua
‘natura’, e da cui però si vede subito che appartiene alla natura della situazione sociale
capitalistica e può essere mutato solo mutando questa. Trockij dice:
Il borghese capitalista fa questo calcolo: “Fino a quando ho in mano le terre, le
fabbriche, le officine, le banche; fino a quando possiedo i giornali, le università, le
scuole; fino a quando — e questo è
Página 128
ciò che piú conta — conservo il controllo dell’esercito, l’apparato della democrazia,
comunque venga ricostruito, rimarrà obbediente alla mia volontà. Subordino
spiritualmente ai miei interessi la piccola borghesia stupida, conservatrice, priva di
carattere, proprio come la domino materialmente. [...] Per quando è insoddisfatta e
protesta, ho creato una gran quantità di valvole di sicurezza e di parafulmini. Al
momento giusto farò nascere partiti d’opposizione, che spariranno domani, ma che
oggi offrono alla piccola borghesia la possibilità di esprimere la sua indignazione senza
alcun pericolo per il capitalismo. Manterrò le masse del popolo, col pretesto
dell’educazione generale obbligatoria, sull’orlo della completa ignoranza, non offrendo
loro nessuna opportunità di superare quel livello che i miei esperti di schiavitú
spirituale considerano sicuro. Corromperò, ingannerò, e terrorizzerò gli elementi piú
privilegiati o i piú arretrati del proletariato stesso. Impedirò cosí che l’avanguardia della
classe operaia raggiunga le orecchie della maggioranza della classe operaia, e, d’altra
parte, gli strumenti necessari della supremazia e del terrorismo rimarranno in mano
mia ” [nota 4].
Noi rifiutiamo, invero, come si è già detto, la teoria bolscevica della dittatura dell’
‘avanguardia’, ma solo nel senso per cui l’energia rivoluzionaria di una cosiddetta élite
operaia deve sostituire la maturità economica necessaria per il dominio della classe
operaia. Ma, se si prescinde da ciò, la trasformazione della democrazia borghese in
quella proletaria non sarà certamente soltanto un problema aritmetico di maggioranza.
Si tratta soltanto di vedere se il proletariato, con il suo numero relativo e con la sua
organizzazione, è cresciuto fino a diventare la classe decisiva nello Stato. Allora
agiscono le ‘limitazioni’ della democrazia, in particolare, i mezzi per influenzare e
intimidire le parti incerte del popolo secondo il suo disegno e la trasformazione dei
rapporti sussistenti si compie sicuramente attraverso la pressione di una classe che
non ha affatto bisogno della maggioranza numerica, poiché ha in mano il potere di
fatto. La questione, discussa tanto e in maniera appassionata, se la dittatura è una
dittatura della maggioranza o della minoranza, è quindi posta in maniera del tutto
falsa, perché ci si rappresenta la maggioranza soltanto in forma parlamentare. Se noi,
senza dubbio, possiamo interpretare la dittatura del proletariato — con Marx e Engels
— soltanto come espressione di una maggioranza del popolo, con ciò non s’intende
affatto soltanto la semplice espressione numerica, ciò che giustamente una volta
Friedrich Adler ha chiamato la casualità dell’aritmetica; s’intende invece che il
proletariato — e questo, comunque, nella ’sua interezza, o, tuttavia, nella sua
immensa maggioranza — è divenuto, grazie alla sua importanza e alla sua forza
organizzata, il
Página 129
rappresentante di tutti gli strati sociali d’opposizione della società borghese e, nel
momento della sua azione rivoluzionaria, li trascina con sé. Ma questo non è poi un
processo di democrazia parlamentare, questo è un evento rivoluzionario.
E, sotto questo profilo, vorrei citare ancora una circostanza, che, naturalmente, non
costituisce comunque un problema per la questione dubbia del giurista (come si possa
parlare, all’interno della democrazia, ancora di rivoluzione), mentre costituisce un
problema per la questione dubbia del sociologo. Attraverso di essa diviene anche pili
chiaro ciò che va mantenuto del rimprovero, secondo cui Marx ed Engels si sarebbero
semplicemente serviti di una fraseologia rivoluzionaria per un contenuto
evoluzionistico. Questa circostanza è il cosiddetto rapporto fra coscienza democratica e
coscienza della legalità. Secondo questa concezione la democrazia cura da sé il suo
male. Il suo fondamento è, anzi, la legge creata per mezzo della volontà popolare, il
terreno del diritto, che viene continuamente costruito per mezzo di nuovo diritto. I
difensori di queste interpretazioni esigono pertanto anche dal prole. tariato che esso
riveda le sue idee « oscure », ‘immature’ e semplicemente ‘propagandistiche’ circa un
rovesciamento rivoluzionario della società e che si ponga, infine, sul terreno della
trasformazione legale come unico terreno che vada scientificamente difeso.
Va invece detto che questa rappresentazione della legalità dello sviluppo storico fa
parte delle illusioni piú rozze dell’ideologia borghese dello Stato, che, dimentica della
sua propria origine, deve dedicarsi a un culto della legalità, che non è altro che
un’autodifesa della classe dominante. Tanto pii è necessario procurarsi al riguardo
concetti chiari e non far cadere il proletariato in questo puro spirito di classe della
legalità. Poiché esistono oggi abbastanza stimoli in questa direzione per il fatto che il
proletariato, difendendo le sue conquiste politiche e sindacali, dopo la rivoluzione del
1918, contro la reazione monarchica o d’altro genere, è diventato quasi l’unico
difensore della democrazia politica e della sua forma moderna, la repubblica
democratica. Ma il carattere rivoluzionario del proletariato, in senso sociologico,
consiste appunto in ciò, nel fatto che esso deve formare la sua opposizione sociale
rispetto alla democrazia politica, anche nel suo svincolamento intellettuale
dall’ideologia di essa, contrapponendo al semplice principio della persistenza nella
legalità la coscienza della necessità di una nuova creazione dell’insieme sociale. Dopo il
fallimento della rivoluzione del 1848 Marx scriveva già, sulla « Neue Rheinische
Zeitung »: « Non l’abbiamo mai nascosto. Il nostro terreno non è il terreno del diritto,
è il terreno rivoluzionario » [nota 5]. E, nel suo discorso di difesa di as
Página 130
sise, di fronte ai giurati di Colonia, egli ripete che « giustamente » è considerato,
insieme con i suoi compagni di fede politica, « nemico del terreno giuridico », ma
contemporaneamente fa notare come questo sia stato vero per ogni classe che tenda
all’affermazione e, non da ultimo, anche per la borghesia che ora si spaccia come
sostenitrice del terreno giuridico:
Ma, miei Signori, che cosa intendono per affermazione del terreno giuridico?
L’affermazione di leggi che appartengono ad un’epoca sociale passata, che sono state
fatte da rappresentanti di interessi sociali scomparsi o in declino, che quindi innalzano
a livello di legge solo questi interessi entrati in contraddizione con i bisogni generali.
Ma la società non ,si fonda sulla legge. Ciò è una presunzione giuridica. La legge deve
piuttosto fondarsi sulla società, dev’essere l’espressione dei suoi interessi e bisogni
comuni, risultanti ogni volta dal modo di produzione materiale, contro l’arbitrio del
singolo individuo [nota 6].
E, ancora trentasei anni più tardi, nella Prefazione al discorso di difesa, Engels
scriveva che esso è importante anche per il nostro tempo perché preserva « il punto di
vista rivoluzionario rispetto al legalismo ipocrita del governo ». « Il fatto di esigere da
un partito che esso debba sentirsi legato non solo di fatto, ma anche moralmente, dal
cosiddetto ordinamento giuridico esistente; che esso debba promettere in anticipo che,
qualsiasi cosa accada, non ha intenzione di rovesciare questa situazione giuridica, da
esso combattuta, anche qualora esso sia in grado di farlo », ciò non significherebbe
altro che esso partito « debba obbligarsi a mantenere in vita per l’eternità
l’ordinamento politico sussistente ». Il piccolo borghese tedesco, certo, non ha mai
fatto una rivoluzione, ma l’ha solo patita. « La richiesta del piccolo borghese tedesco,
rivolta al partito socialdemocratico tedesco, ha dunque soltanto il significato che questo
partito [...] non deve assolutamente collaborare a fare le rivoluzioni, ma le deve patire
tutte » [nota 7]. Certo, a chi abbia presente solo il lato formale della democrazia, la
continuità della situazione giuridica non può non apparirgli — in un certo senso —
come la sua essenza, situazione giuridica che tanto più la garantisce quanto più è
evoluta: l’inclinazione alla lealtà (loyale Gesinnung), pertanto, appare come la virtù
specifica dei democratici. Va evitata soltanto ogni azione non parlamentare, che urti
contro la santità dei diritti democratici fondamentali. Ma già il giovane Engels sapeva
dire, intorno a questa santità, una parola che neanche oggi dovrebbe essere
dimenticata dal proletariato. Egli difendeva energicamente l’« illegalità » dei cartisti e
diceva:
Página 131
Cogliamo l’occasione per dire due parole sul modo in cui si rispetta la santità della
legge in Inghilterra. È vero, per il borghese la legge è sacra, poiché è opera sua,
emanata con il suo consenso per sua protezione e vantaggio. Egli sa che, se anche una
singola legge può danneggiare la sua persona specifica, tuttavia l’intero complesso
della legislazione protegge i suoi interessi, e sa soprattutto che la santità della legge, la
intangibilità dell’ordine [...] è il sostegno più valido della sua posizione sociale. Nella
legge, allo stesso modo che nel proprio dio, il borghese inglese ritrova se stesso, per
questo la ritiene sacra, e per gusto il bastone del poliziotto, che in fondo è il suo
bastone, ha su di lui un potere calmante di efficacia mirabile. Per l’operaio invece le
cose si presentano in maniera molto diversa. Egli sa anche troppo bene ed ha
sperimentato anche troppo di frequente come la legge sia per lui una sferza fabbricata
dal borghese e, se proprio non vi è costretto, non se ne cura [nota 8].
A ragione, dunque, nel capitolo (molto considerevole) sulla Democrazia, nel suo libro
già citato, Trockij ha accennato al pericolo notevole che deriva, da questa tendenza
psicologica della democrazia alla lealtà, per l’inclinazione di classe del proletariato. Lo
Stato borghese-democratico, in verità, favorisce certo lo sviluppo della classe
lavoratrice, ma « pone anche dei limiti a questo sviluppo con la legalità borghese, che
accumula e inculca abilmente negli strati superiori del proletariato delle abitudini
borghesi e dei pregiudizi legalitari » [nota 9].
Vediamo dunque, già prima di un’indagine più ravvicinata sul concetto di rivoluzione,
che un’inclinazione rivoluzionaria non solo è possibile anche all’interno della
democrazia, ma ha un significato molto positivo. Essa non è altro che l’aspirazione ad
eliminare quei ‘limiti’, che anche Kelsen vuol sapere eliminati per la realizzazione della
democrazia ‘pura’. Ma essa collega a ciò, allo stesso tempo, la comprensione del fatto
che questa eliminazione è possibile solo contemporaneamente al rovesciamento di
tutto il sistema sociale esistente, di cui quelle ‘limitazioni della democrazia’ appaiono
come singoli lati, poiché, appunto, una democrazia libera da contraddizioni interne è
possibile non come democrazia politica, ma solo come democrazia sociale.
Che cosa significa dunque rivoluzione in senso marxista? Innanzi tutto, ancora una
volta, un concetto storico: non è una contrapposizione di una rivoluzione in quanto tale
a una evoluzione in quanto tale, bensí è la conoscenza — determinata da un certo
livello di sviluppo delle forze produttive all’interno della forma capitalistica dei rapporti
di produzione e stimolata dall’interesse di
Página 132
classe del proletariato — di un nuovo compito sociale, legato alla volontà, nata in
maniera altrettanto necessaria, di portare a termine questo compito, in particolare, di
fare della presa di possesso sociale dei mezzi di produzione (e non della proprietà
privata di essi) la base dell’ordinamento sociale. Il concetto di rivoluzione, nel
marxismo, è identico a quello di rivoluzione sociale e in una parola sola significa:
abolizione dell’opposizione di classe come fine, dominio del proletariato come mezzo
per raggiungere questo fine. Nel caso che, al di là di questo concetto storico di
rivoluzione, se ne cerchi ancora uno generale, questo può essere soltanto: volontà
sociale di trasformazione sulla base di una conoscenza teoretica rovesciante. Nel
marxismo, anche il concetto sociologico di rivoluzione non è affatto un concetto
‘semplicemente’’ economico, ma si perfeziona — come tutti i concetti del marxismo —
come concetto sociale, cui appartiene dunque sempre la sua sovrastruttura ideologica,
grazie alla quale soltanto esso diviene un concetto sociologico. E, entro questi limiti,
nonostante sia redatta in forma idealistica, la nota definizione di Lassalle circa la
distinzione fra rivoluzione e riforma va pur sempre definita classica:
Rivoluzione significa rovesciamento e, quindi, si è avuta sempre una rivoluzione
quando al posto della situazione esistente si è insediato, non importa se con la violenza
o meno — in questo non si tratta affatto dei mezzi — un principio completamente
nuovo. La riforma, invece, ha solo quando il principio della situazione esistente viene
mantenuto e viene soltanto sviluppato nella direzione di esiti più miti o più coerenti e
più giusti. Ancora una volta, neanche in questo caso si tratta di mezzi. Una riforma può
realizzarsi attraverso insurrezioni e spargi‘i mento di sangue e una rivoluzione, invece,
nella maniera più pacifica [nota 10].
Página 133
Se dunque non è affatto necessario, per la rivoluzione, che essa si sviluppi ‘in
maniera violenta’, non è neanche affatto contrario al suo concetto — e questo è
decisivo rispetto a Kelsen — il fatto che essa si compia ‘legalmente’. In sé e per sé, è
pensabile che questo dominio del proletariato possa venire istituito assolutamente
senza lottare grazie a una risoluzione parlamentare di maggioranza. Ma questo può
interessare, in quanto lato essenziale di questo processo, tutt’al più i giuristi; per
quanto riguarda l’importanza sociologica della rivoluzione, proprio tale questione — se
è possibile istituire ‘pacificamente’ o ‘in maniera violenta’ il domiPágina 134
nio del proletariato — è del tutto secondaria. Poiché l’elemento essenziale consiste
soltanto nel fatto che, con questo dominio del proletariato, subentra un cambiamento
fondamentale nella funzione sociale del dominio, una rottura con il carattere che aveva
avuto finora. Poiché è un dominio non piú finalizzato alla conservazione del potere di
una classe e al mantenimento della struttura di classe dello Stato, bensí
all’abbattimento di ogni potere di classe in generale, quindi anche di quello proprio,
attraverso la trasformazione della vita fondata sullo Stato di classe in una vita fondata
sull’assenza di classi, nella quale persino il dominio perda il suo carattere di
oppressione. Nei verbali delle sedute del parlamento, qualora la rivoluzione sociale si
compia in forma democratica, tutto questo può forse essere andato avanti senza una
rottura rivoluzionaria della costituzione; si ha, per esempio, una maggioranza
qualificata, che ha superato la proprietà privata, finora garantita dalla costituzione,
nella forma di una risoluzione ‘legale ’. Ma ciò che al giurista, nelle sue formule, appare
come ‘continuità’ dello Stato di diritto, dal punto di vista sociologico è il piú gigantesco
mutamento della struttura economica dello Stato, di modo che ‘lo Stato’, prima e dopo,
non è piú la stessa cosa. Rivoluzione sociale, per i marxisti, non significa
necessariamente né rottura del diritto né utilizzazione della violenza in generale, bensí
la trasposizione, consapevole del fine, della società in un nuovo ordinamento
economico, che si è già preformato nel suo seno. Proprio Marx e En gels ci hanno
insegnato a comprendere e hanno esposto per la prima volta nel Manifesto comunista,
in modo lapidario, come all’interno della forma giuridica immutata siano possibili le più
forti rivoluzioni sociali grazie allo sviluppo economico [nota 11]. Per noi, appunto, la
rivoluzione non è, innanzi tutto, né un concetto giuridico, né un concetto politico, bensí
sociologico, e si riferisce al mutamento nella disposizione della coscienza e della
volontà rispetto alla struttura sociale dello Stato. Lo spostamento che avviene nella
funzione sociale delle singole classi — uno spostamento ottenuto grazie al continuo
della struttura sociale stessa — fa sí che, alla fine, ambedue le classi, sia la dominante
sia la dominata, possano stare nell’organismo sociale solo dando luogo a
contraddizioni: la prima, sempre meno capace di dominare lo Stato effettivamente nel
proprio interesse e di garantire il godimento indisturbato del dominio — la guerra
mondiale e, ancor piú, la ‘pace’ che ne è seguita sono una testimonianza non pi ú
tralasciabile di ciò —; la seconda, sempre
Página 135
piú limitata, nelle sue richieste di avanzamento, dalla società, quanto piú questa
società diviene, in maniera del tutto chiara, la sua società, la società dei lavoratori. La
rivoluzione, quindi, è soltanto il consapevole adattamento della forma esterna della
società alla sua nuova struttura interna: certo, una rottura con il vecchio, ma non
necessariamente una rottura del diritto, bensí piuttosto una rottura con le vecchie
istituzioni e tradizioni, con la vecchia concezione borghese della società, con lo spirito
dello Stato di classe, con tutta l’ideologia delle classi prima dominanti.
Ciò che caratterizza dunque il concetto di rivoluzione, e per cui esso si distingue dalla
semplice riforma, è il fatto che esso rompe l’identità dei fondamenti economici della
società, il fatto che esso non è necessariamente una rottura della costituzione statale,
ma è sempre una rottura della costituzione economica della società; il fatto che esso,
come scriveva il giovane Marx, « non lascia restare in piedi i pilastri della casa », come
facevano tutte le rivoluzioni semplicemente politiche poiché non attaccavano la
proprietà privata dei mezzi di produzione e, quindi, non abolivano l’opposizione di
classe stessa. Questo concetto sociologico di rivoluzione, ben lungi dall’essere non
pensato (gedankenlos) o non scientifico, è addirittura un concetto precisamente nel
senso di Kelsen, a patto che la sua idea di rivoluzione venga trasportata dal campo
giuridico in quello sociologico. Nel suo libro da poco apparso e che fa bensí epoca nel
campo della costruzione logica di una teoria del diritto — libro su cui dovrò ritornare
sotto un altro aspetto — Kelsen illustra acutamente il concetto giuridico di rivoluzione
affermando che il criterio decisivo non è se il mutamento è piú o meno profondo nello
Stato, bensí se questo mutamento è stato prodotto costituzionalmente oppure
attraverso una rottura della costituzione. Sarebbe per esempio immaginabile che una
monarchia trapassi in una repubblica attraverso una risoluzione costituzionale, cioè
attraverso una sanzione della risoluzione parlamentare da parte del monarca. Ciò non
sarebbe una rivoluzione; lo sarebbe invece una proclamazione della repubblica per
esempio attraverso un pronunciamento unilaterale del parlamento [nota 12].
Prescindiamo dal fatto che anche qui, ancora una volta, si palesa quanto la maniera di
pensare puramente giuridica sia vuota, anzi priva di
significato e, da ultimo,
addirittura erronea, per quanto riguarda la comprensione
quanto, in base a questo concetto, le trasformazioni piú
esternamente possono essere ‘costituzionali’, perdono il loro
mentre delle violazioni della costituzione, che, in sé, possono
la marcia dello sviluppo sociale, vengono promosse
dei processi sociali, in
forti della società, che
carattere rivoluzionario,
essere insignificanti per
Página 136
al rango di eventi ‘rivoluzionari’. Ma è certo che ciò che essenzialmente viene pensato
nell’idea di rivoluzione, la rottura con l’identità dell’antico, il superamento della
continuità, da un punto di vista giuridico è possibile soltanto grazie a una rottura
costituzionale, che, appunto, fa succedere ad una forma giuridica un’altra forma, che
non deriva da essa.
Lo stesso succede nel caso della rivoluzione sociale: la costituzione della società, cui
essa tende, non è un cambiamento della vecchia, bensí un’altra costituzione. Dal
punto di vista della proprietà privata dei mezzi di produzione e della cura individuale
dell’economia — per quanto questo punto di vista possa aver sperimentato delle
limitazioni — non vi è alcun passaggio che conduca a quello della proprietà comune dei
mezzi di produzione e della cura sociale dell’economia. Proprio il fatto che quelle
‘limitazioni’ valgono sempre come tali mostra lo iato delle concezioni, che, a partire da
qui, realizza tutta l’ideologia economica, politica e culturale.
Ma a questo punto emerge una nuova obiezione. Si dirà, e Kelsen anzi ha pensato
questo, che il concetto sociologico di rivoluzione proprio ora si mostra contraddittorio,
poiché, invero, nella rottura dell’ordinamento giuridico, il nuovo ordinamento non
avrebbe alcun rapporto con il vecchio; ma la nuova costituzione sociale, proprio
secondo le teorie di Marx e Engels, si sviluppa tuttavia sempre proprio dalla vecchia. È
la vecchia disputa sul rapporto fra rivoluzione e evoluzione, che ai tempi del
revisionismo di Bernstein ha prodotto un errore, che non è stato ancora superato.
Un’opposizione fra evoluzione e rivoluzione, in rapporto al processo sociale, può
essere assunta solo da chi colga i rapporti e le potenze economiche — che, secondo la
concezione materialistica della storia, determinano in ultima istanza lo sviluppo storico
— in quella maniera ‘materialistica’, de-spiritualizzata (geistfrei) e insulsa (geistlos),
che abbiamo già in piú modi respinto. Se non si dimentica la frase di Marx: « Nella
mia teoria l’elemento ideale è l’elemento materiale trasposto nella testa dell’uomo »,
allora si sa — e non lo si dimentica piú — che non esiste causazione economica, che
non si compia in pari tempo nella testa dell’uomo. Il continuo cambiamento dei
rapporti economici attraverso lo sviluppo del modo di produzione capitalistico si compie
dunque soltanto grazie alla sua infinita trasposizione nelle teste degli uomini: cioè crea
dapprima nella testa dei proletari la coscienza della loro situazione economica, poi la
conoscenza dei mezzi per porvi rimedio e, infine, la volontà d’agire. Solo l’azione, però,
crea il rimedio, solo l’azione produce il mutamento dei rapporti economici, crea il loro
nuovo ordinamento. Certo, il marxismo ha sempre insegnato: « Una formazione sociale
non perisce finché non si siano
Página 137
sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di
produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società
le condizioni materiali della loro esistenza » [nota 13]. Ma ciò naturalmente non
significa che queste nuove condizioni materiali di esistenza siano già la nuova società
stessa. I critici dotti della concezione materialistica della storia ci attribuiscono sempre
un tale « autonomismo dell’economia ». Al contrario, proprio riferendosi a questa
preparazione ‘evolutiva’ della nuova società Marx descrive in maniera molto precisa e
che non può dar adito a fraintendimenti la ‘missione storica’ della classe operaia, che
deriva da questa evoluzione: « La classe operaia non ha da realizzare degli ideali, ma
da liberare gli elementi della nuova società, di cui è gravida la vecchia e cadente
società borghese » [nota 14]. Ecco che cos’è la rivoluzione: la liberazione degli
elementi di un nuovo ordinamento. L’accenno al mutamento evolutivo dei fondamenti
economici della rivoluzione, che fa parte dell’essenza del marxismo, non è dunque una
contraddizione, ma non è altro che la determinazione sociologica della rivoluzione, il
suo inserimento nella causalità sociale, che naturalmente è un continuum. Chi definisce
ciò una contraddizione fra un contenuto evoluzionistico e una terminologia
rivoluzionaria, in fondo non ha una chiara immagine del fatto che ogni nascita del
nuovo — anche nell’àmbito dell’evoluzione biologica, quindi — considerata dal lato
causale, riconduce al continuum delle sue condizioni.
La rappresentazione secondo cui nuovi generi della serie della evoluzione biologica
nascono attraverso un mutamento e un adattamento graduali, è riconosciuta già oggi
come un fraintendimento dei fondamenti del darwinismo. Né la selezione artificiale né
quella naturale può produrre qualcosa di nuovo, ma può solo valorizzare e mantenere il
nuovo che si sia presentato spontaneamente e improvvisamente. L’evoluzione
organica, pertanto, in generale è possibile solo grazie a una serie di rivoluzioni
organiche continuate (mutazioni), ognuna delle quali rappresenta una rottura con il
vecchio e l’inizio di un elemento nuovo. Si mostra cosí che rivoluzione e evoluzione,- in
generale, non sono opposti; poiché la seconda si riferisce al rapporto causale dei
cambiamenti, la prima al genere dei medesimi. Opposti sono semplicemente
rivoluzione e riforma (variazione), in quanto la prima indica un cambiamento in seguito
a una rottura con la situazione precedente, la seconda indica il cambiamento all’interno
di questa situazione [nota 15].
Página 138
Una tale rottura con il vecchio è rappresentata dalla rivoluzione proletaria, che pone,
al posto del dominio della borghesia e dei suoi principi di economia privata, il dominio
del proletariato e dei suoi principi e delle sue istituzioni socio-economiche. Ma il
giurista Kelsen si arresta all’apparenza formale: egli trova che prima vi era lo Stato
borghese, adesso ve n’è ancora uno, solo che è proletario. Egli trova dunque degno di
nota il fatto che qui Marx e Engels parlino di rivoluzione, là dove invece la continuità
della democrazia porta a termine la transizione dallo Stato capitalistico a quello
proletario (p. 30 [66]).
Visto che Marx tiene fondamentalmente ferma la teoria dello Stato di classe
proletario, che sarà sostituito, dalla rivoluzione sociale, al posto dello Stato di classe
capitalistico, non si capisce facilmente perché egli polemizzi in modo cos í deciso contro
la rappresentazione secondo cui, con la rivoluzione sociale, avrebbe luogo
semplicemente un cambiamento del partito dominante nello Stato. Egli afferma che lo
Stato dev’essere annullato. Ma, tuttavia, soltanto per essere riconosciuto in quanto
Stato, e, invero, di nuovo in quanto Stato di classe! Non si tratta poi soltanto di una
polemica su una parola, su una immagine intuitiva, se si parla di un ‘annullamento’
dello Stato di classe capitalistico, o di una ‘trasformazione’ del medesimo? (p. 32 [68]).
Basta soltanto confrontare queste frasi con il contenuto concettuale della teoria
marxista della società e dello Stato per toccare con mano, in maniera particolarmente
drastica, l’incapacità assoluta del punto di vista giuridico-formale di porsi, sia pure
soltanto per un istante, sul terreno di quella teoria, che esso vuol criticare. Basta il
fatto che il dominio capitalistico e quello proletario fondino ambedue uno ‘Stato’, e,
nell’essenza, non dovrebbe essere cambiato nulla! Il fatto che lo Stato proletario ha
una funzione completamente diversa da quella dello Stato borghese; il fatto che,
innanzi tutto, in quest’ultimo il carattere di classe è destinato a durare — ché anzi
l’essenza di quest’ordinamento statale consiste appunto nel mantenerlo —, mentre, al
contrario, nello Stato proletario il carattere di classe è soltanto il mezzo per abbattere il
contrasto di classe stesso: tutto questo rimane fuori del campo visivo degli occhi del
giurista, ciechi di fronte alla realtà della vita sociale.
Per questo, anche per quanto riguarda l’esigenza marxiana di distruggere la macchina
statale — esigenza che Marx definisce una necessità incondizionata della conquista
proletaria del dominio Kelsen non sa cominciare in altro modo se non scorgendo anche
in essa soltanto una contraddizione rispetto alla teoria evolutiva e una concessione ai
bisogni della propaganda radicale. Con questa immagine della distruzione della
macchina statale, dice Kelsen, si
Página 139
può solo intendere che al posto di un determinato ordinamento statale ne viene posto
un altro, oppure che al posto dei precedenti organi statali vengono impiegati uomini
nuovi, oppure anche che vengono costituite funzioni statali del tutto nuove. In ogni
caso la rottura della macchina statale si riduce comunque a un cambiamento della
forma statale o degli organi statali o ad ambedue le cose (pp. 32-3 [68-9]). Ma il
marxismo non s’interessa proprio di ciò cui il giurista, trionfante, assegna valore: del
fatto, cioè, che anche dopo la rottura della macchina statale esiste ancora una forma
statale. Questo è importante soltanto per Kelsen, perché egli identifica il concetto di
Stato di Marx, che indica sempre uno Stato storico, con il suo Stato formale, che
comprende tutte le possibili forme statali, e ora crede seriamente di dover dimostrare
che, dopo l’annullamento o la distruzione dello Stato (Marx pensa di quello
capitalistico), rimane ancora uno Stato (Kelsen pensa quello proletario). Naturalmente
questa è poi una ‘vittoria’ del punto di vista giuridico su quello marxista, tanto piti
facile quanto è una disputa del tutto vana, questa volta una vera e propria disputa
sulle parole.
L’essenziale di questa rappresentazione, fondamentalmente importante, della rottura
della macchina statale, che Lenin ha meritevolmente risospinto al centro
dell’attenzione della trattazione, mostrando che non era un’osservazione
semplicemente casuale di Marx, bensí una concezione che si riaffacciava sempre, a
partire da Il 18 brumaio, l’essenziale di questo concetto, dunque, sta appunto nella
visibilizzazione della rottura con il vecchio, dell’annientamento del precedente
contenuto economico e politico dello Stato, che la rivoluzione sociale dovrebbe
compiere. L’istituzione dello Stato dei proletari, quindi, non significa soltanto il dominio
di un nuovo partito nel milieu sociale rimasto per il resto immutato, bensí l’abolizione
delle vecchie condizioni sociali di vita e l’introduzione di nuove condizioni da parte della
classe in ascesa. Riguardo a questa rottura, in generale, vale ciò che Marx diceva della
Comune di Parigi, che egli apprezzava come un primo esempio di questa rottura (si
tratta di un brano citato anche da Kelsen senza essere effettivamente valutato):
Il suo vero segreto fu questo: che essa fu essenzialmente un governo della classe
operaia, il prodotto della lotta della classe dei produttori contro la classe degli
accaparratori, la forma politica finalmente scoperta nella quale si poteva compiere
l’emancipazione del lavoro [nota 16]
Ma, naturalmente, se in questa frase si tralascia l’essenziale, cioè la forma nuova del
lavoro sociale e, con aria trionfante, ci si accon
Página 140
tenta soltanto del fatto che anche qui si parla di un ‘governo’ e di una forma ‘politica’,
quindi di forme statali in generale, allora si raccolgono i concetti marxisti in un vaso
così malfermo che non ne rimane nulla.
Per questo anche tutta la critica penetrante che Kelsen dedica alla questione se la
Comune di Parigi era effettivamente, nel senso di Marx e Engels, un primo esempio di
una tale distruzione della macchina statale, non può non andare a insabbiarsi in
dispute bizantine le pii ingannevoli. È quasi tragicomico vedere come qui la critica
giuridica scorra sempre a lato del contenuto oggettivo dell’esposizione marxista e si
lanci su ogni parola da cui può ricavare — ciò che il marxismo non ha mai pensato di
contestare
che anche la Comune era un’organizzazione costrittiva. L’abolizione
dell’esercito professionale sarebbe non un superamento della forza militare, ma,
essendo stato sostituito « con il popolo in armi », sarebbe solo la sua trasposizione in
un’altra forma. Al posto del diritto di voto fondato sui privilegi sarebbe subentrato il
diritto universale di voto: ancora una volta, una forma dello Stato « non distrutto ». E
la sostituzione dell’istituto parlamentare con un istituto « che lavora », non
significherebbe, come pensa Marx, l’annientamento del parlamentarismo, bensí la sua
trasformazione in una forma che si approssima alla democrazia diretta, in quanto
unisce alla legislazione anche il potere esecutivo. Un corpo rappresentativo « cessa
forse di essere un parlamento (Parlament) — in tedesco, una Volksvertretung
[rappresentanza popolare] — qualora gli spettino, accanto alla legislazione, anche
funzioni esecutive, in particolare la scelta degli uomini cui è affidato l’esecutivo? » [p.
71], domanda Kelsen, facendo immediatamente, del fenomeno storico della Comune,
la categoria giuridica di « una istituzione che lavora » in generale. Naturalmente.
Naturalmente, quando si trasformi concettualmente una istituzione che legifera
soltanto in una che allo stesso tempo amministra anche, ‘il’ parlamentarismo non
cessa; ma nella trasformazione storica, di cui parla Marx e di cui in generale tratta la
teoria marxiana, in tal modo cessa il parlamentarismo borghese, cioè cessa il fatto che
la rappresentanza popolare ’ è al servizio degli interessi di dominio di una classe, che
vuole il mantenimento dello sfruttamento economico e, quindi, dell’opposizione di
classe, e viene sostituita con un istituto rappresentativo, che vuole proprio il contrario.
Ha dunque un suo significato reale il fatto di non indicare due cose cosí diverse —
diverse assolutamente come i due concetti di democrazia — con il medesimo nome. E
quando Lenin a un certo punto dice di non potersi invero immaginare una democrazia
senza corpo rappresentativo, ma di potersela bensí immaginare senza
parlamentarismo, ha torto Kelsen nello scorgere in ciò « un rePágina 141
stringimento, non autorizzato, del concetto di parlamentarismo » (p. 35 [71]). Questa
distinzione terminologica, piuttosto, contribuisce soltanto a richiamare l’attenzione sul
fatto che, per il punto di vista marxista, l’unica cosa interessante è appunto non la
forma giuridica, bensí la funzione sociale del suo contenuto. Altrimenti andiamo a finire
in un modo tale di considerare le cose, per cui diviene in verità possibile una continuità
della forma giuridica a partire dalle delibere di un villaggio di ottentotti per arrivare fino
a quelle dei parlamenti attuali — certo anche esternamente confortata da una serie di
fenomeni che ricordano, in queste moderne istituzioni, la civiltà degli ottentotti —, ma
che tuttavia è soltanto la continuità di una nebbia concettuale, in cui scompaiono tutti i
connotati caratteristici delle cose. Invece, proprio questa considerazione critica, assai
insufficiente, della Comune di Parigi, se ci teniamo a ciò che Marx considerò come la
sua essenza — l’eliminazione della burocrazia, dell’esercito di professione e la
trasformazione del parlamentarismo in un organismo di lavoro — proprio questa
considerazione conduce a ciò che si potrebbe chiamare, in verità, non il problema
centrale teorico, bensí pratico, della democrazia, conduce cioè alla questione della sua
possibilità organizzativa. Di essa Kelsen si è occupato solo in maniera del tutto
secondaria. Ciononostante non possiamo evitare di occuparcene un po’ piú
dettagliatamente, perché dal chiarimento di questo rapporto dipende non solo una
migliore comprensione di ciò che Marx scorgeva nella Comune, bensí, in particolare,
diviene anche píú chiaro ciò che il marxismo s’immagina per concezione dello Stato del
futuro.
Página 142
Capitolo dodicesimo
La democrazia e la sua organizzazione
Se ai giorni nostri la democrazia è divenuta cosí spesso oggetto di profonda critica, di
una scepsi quasi disperata, e ogni volta si risente parlare di crisi della democrazia, il
motivo di ciò non risiede né nell’apparente contraddizione in cui essa si trova rispetto
alla dittatura, né nel suo fallimento inevitabile all’interno del parlamentarismo dello
Stato di classe. In base a queste due linee interpretative non esiste affatto un reale
problema della democrazia, bensí soltanto dei fenomeni che debbono risultare
contraddittori perché si applica il concetto di democrazia ,a una situazione sociale dello
Stato che non gli corrisponde. Il problema effettivo della democrazia emerge in un
orizzonte completamente diverso. R. Michels nel suo stimolante libro intitolato La
sociologia del partito politico ha il merito di essersi soffermato, sicuramente non tra i
primi, ma in modo piuttosto ampio, su questo problema, e dopo di lui W. Hasbach
[nota 1] e in particolare M. Weber hanno trattato con efficacia, da un altro angolo
visuale, il medesimo argomento [nota 2]. Il problema specifico della democrazia
consiste nel fatto che essa, a quanto pare, per le esigenze interne alla sua
organizzazione, deve svilupparsi in modo contraddittorio. Ovunque, infatti, deve
ricorrere a una qualche forma di rappresentanza, non appena oltrepassa la piccola
struttura di una comunità primitiva, nella quale è ancora possibile un esercizio diretto
della democrazia, e persino in questa emerge un capo al quale la democrazia si
assoggetta. Sembra perPágina 143
tanto insita in ogni democrazia la tendenza ad alimentare da se stessa nuovi conflitti,
che vanificano l’uguaglianza e la solidarietà tra i suoi membri. Per questo motivo
Michels parla addirittura di una inflessibile legge di oligarchia, che si manifesta
all’interno della democrazia [nota 3], e che, espressa in una formula molto sintetica,
suona all’incirca cosí: « La organizzazione è la fonte del dominio degli eletti sugli
elettori, di coloro che ricevono un incarico su coloro che lo conferiscono, dei delegati
sui deleganti » [nota 4]. Si tratta di una tendenza organica che è comune a tutte le
forme di democrazia, sia a quelle rivoluzionarie che a quelle conservatrici. « Si sarebbe
tentati di vedere in ciò una tragicommedia: le masse si accontentano di impiegare
tutte le loro forze nel consentire l’alternarsi dei loro signori » [nota 5].
A questa tendenza irreversibile si aggiunge un altro elemento a rendere cosí
problematica la democrazia e che consiste nel fatto che tutte le forme di
organizzazione che essa deve produrre, per raggiungere i suoi scopi, immediatamente,
per cosí dire, vanno sclerotizzandosi, si irrigidiscono in un puro meccanismo, in una
macchina. Gli organi si convertono presto in una burocrazia, in un ceto con dei propri
interessi di classe e di dominio, i quali rappresentano nuovamente un elemento di
conflittualità all’interno della democrazia. Questo aspetto della sua evoluzione è stato
trattato in particolare da M. Weber, il quale ha dimostrato che la burocrazia non è
soltanto un prodotto dello Stato o dell’amministrazione statale, ma che già all’interno
dei partiti politici, dunque nelle forme essenziali, attraverso le quali si manifesta la
democrazia moderna, il peso maggiore della loro attività e della loro influenza è
sostenuto dall’apparato che ogni partito ha sviluppato per la propria organizzazione e
che questo apparato è completamente diretto da una burocrazia di partito, la quale
appare tanto pii indispensabile quanto pii sono estese le masse che il partito abbraccia.
« In tutte le organizzazioni il lavoro effettivo è svolto in misura crescente da impiegati
e da agenti di ogni tipo. Tutto il resto è solo vernice ed apparenza » [nota 6]. Weber
considera questa burocratizzazione come una tendenza necessaria, tale da non dover
essere neppure contrastata. Infatti è ciò che garantisce una direzione razionale,
costruita su basi professionali, degli affari (Ge schafte). A questo punto si profila la
domanda che costituisce propriamente la questione decisiva della democrazia: com’è
possibile ancora, in generale, la democrazia di fronte a questo doPágina 144
minio incontrastato e inevitabile della tendenza alla burocratizzazione? [nota 7]
Ancor prima di questi critici della democrazia e dell’affermazione di una classe di
politici di professione (Berufspolitikertum) F. Engels ha svolto una critica altrettanto
radicale e proprio in relazione alla situazione dei partiti americani, presa in
considerazione dagli autori precedenti. Engels però era sin dall’inizio consapevole che
la sua critica non colpiva la democrazia in generale, bensí la democrazia borghese.
Nella sua Introduzione allo scritto di Marx La guerra civile in Francia ha richiamato
l’attenzione sul processo di autonomizzazione degli organi della società, quale si attua
anche in una repubblica democratica, che trasforma i suoi funzionari (Beamten) da
servitori in suoi padroni.
In nessun paese — scrive Engels — i ‘politici’ formano una sezione della nazione cosí
separata e cosí potente come nell’America del Nord. Quivi ognuno dei grandi partiti che
si alternano al potere viene a sua volta governato da gente per cui la politica è un
affare. [...] E noto come da trenta anni gli americani cerchino di scuotere questo giogo
diventato insopportabile e come, a dispetto di ciò, affondino sempre più nella palude
della corruzione. Proprio in America possiamo vedere nel miglior modo come si compia
questa autonomizzazione del potere dello Stato rispetto alla società, di cui in origine
esso era destinato a non essere altro che uno strumento. Quivi non esiste dinastia, non
nobiltà, non esercito regolare [...] non burocrazia con impieghi stabili e con diritto alla
pensione. E ciononostante ci sono due grosse bande di speculatori politici che entrano
in possesso del potere, alternativamente, e lo sfruttano per gli scopi più corrotti, e la
nazione è impotente contro questi due grandi cartelli di politicanti, che si presumono al
suo servizio, ma che in realtà la dominano e la saccheggiano [nota 8].
Anche all’interno del movimento operaio proletario questo problema da molto tempo
si è imposto persino alla coscienza delle masse. La linea antiautoritaria dell’anarchismo
e il successivo sindacalismo sono, per l’appunto, forme nelle quali lo sforzo di lottare
contro la burocratizzazione e di garantire alle masse un’immediata e più decisiva
influenza fu tra le cause principali del loro sorgere e della loro straordinaria forza
d’attrazione, che momentaneamente esercitarono sui lavoratori. In particolare,
l’esigenza sindacalista dell’action directe poté diventare cosí popolare perché con essa
non si esprimeva semplicemente una capacità di agire in modo diretto e con degli
effetti immediatamente visibili sullo Stato di classe, ma perché anche questa azione
era attuabile solo attraverso l’intervento immediato e diretto delle masse stesse.
Página 145
In tal modo il singolo poteva cullarsi nella illusione di non essere più costretto a farsi
rappresentare come elettore, ma di poter agire immediatamente per i suoi scopi, in
quanto membro autonomo di una collettività. È ancora molto vivo nel nostro ricordo
con quanta irresistibile forza d’attrazione l’idea dei consigli operai, dopo la rivoluzione
russa, si sia impadronita ovunque delle masse, non solo perché essa
era avvolta
dall’alone romantico, allora non ancora manifesto, che doveva accompagnare il
bolscevismo, ma perché sembrò mettere a disposizione uno strumento reale,
attraverso il quale le masse, nella fabbrica, nel commercio, nella filiale d’agenzia,
nell’ufficio, nei luoghi in cui lavoravano e si associavano, venivano poste nella
condizione di infrangere le forme sclerotizzate di una direzione politica e sindacale, e di
stabilire al loro posto la propria vitalità rivoluzionaria, quale nuovo principio
organizzativo [nota 9]. L’attenzione sempre crescente che il socialismo inglese delle
gilde attira su di sé è anch’essa il risultato di un movimento di resistenza, che
scaturisce dalle spinte ricorrenti delle masse verso la democrazia diretta, e che è
rivolto contro la burocratizzazione, la meccanizzazione e la separazione di una casta
dirigente all’interno della democrazia. Anche qui agisce, come motivo propulsivo, il
fatto che la salvezza non risiede nella rigida centralizzazione a partire dall’alto, bensí
soltanto nella costruzione dell’organizzazione sociale a partire dal basso, sulla base,
dunque, delle masse autonomamente attive e determinantisi in organizzazioni locali.
Il futuro dei sindacati — si legge in Cole — non dipende dai grandi dirigenti nazionali,
bensí da quelli locali nonché dai dirigenti delle aziende, dipende dalla minoranza
intelligente all’interno della massa [...] Il movimento dei sindacati deve diventare
nuovamente democratico, deve basarsi sulle aziende, perché da queste deriva l’origine
e il completamento del suo potere. Nella misura in cui le aziende diventeranno il fulcro
della vita sindacale, s’imporranno spontaneamente anche le altre esigenze: nuove
funzioni, nuovi metodi, un nuovo apparato e uomini nuovi [nota 10].
Il superamento di questo destino della democrazia, per cui essa deve capovolgersi in
oligarchia e arenarsi in una forma burocratica, appare impossibile a Michels. L’unica
soluzione può consistere — a suo avviso — pertanto solo nel « paralizzare il più
possibile » queste tendenze nocive, compito questo che dev’essere svolto
principalmente dalla « pedagogia sociale ». Del resto, il
Página 146
valore della democrazia consiste, per lui, nel fatto che, rispetto all’aristocrazia e alla
monarchia, è « il male minore » [nota 11]. Il giudizio di M. Weber non è cosí
totalmente pessimistico. Egli prende, per cosí dire, il toro per le corna, individuando in
ciò che Michels chiama la tendenza alla oligarchia una via di uscita per la democrazia.
Nella formazione di energiche personalità di dirigenti, ma responsabili di fronte alle
masse, risiede l’unica possibilità di impedire la sclerosi della democrazia in una
macchina burocratica. Il rimedio dev’essere ricercato quindi nello sviluppo di un
sentimento politico, cioè di una facoltà di decidere in modo autonomo e con senso di
responsabilità sociale negli affari della pubblica amministrazione e di governo. « I
politici devono bilanciare il dominio dei funzionari » [nota 12].
Per quanto M. Weber abbia ragione nel criticare la caricatura del parlamentarismo,
che si affermò in Germania prima del crollo, e sia legittima anche oggi, anzi proprio
oggi, la sua stroncatura del carattere assolutamente apolitico della borghesia tedesca,
immersa nel culto dell’autorità [nota 13], pure si può dubitare che la formazione,
sicuramente necessaria, di una classe dirigente, politicamente matura, possa essere
uno strumento efficace per prevenire la trasformazione della democrazia da una forma
di autodeterminazione delle masse in un dominio su di esse attraverso i loro dirigenti
[nota 14]. Sull’altro versante il pessimismo di Michels è cosí
Página 147
scarsamente motivato che egli stesso individua nella « pedagogia sociale » una via
d’uscita che avrebbe dovuto significare per lui qualcosa di più che uno strumento per
paralizzare le tendenze dimostratesi pericolose per la democrazia, se avesse preso in
considerazione anche la trasformazione dell’ambiente che si produce in una democrazia
sociale. Una tale analisi però è indispensabile; infatti, che la democrazia, in quanto
democrazia politica, debba svilupparsi in modo contraddittorio è stato riconosciuto
anche da noi come una necessità. Ci si chiede se ciò sia valido anche per la democrazia
sociale.
Su questo problema nodale della democrazia Kelsen non si è propriamente
soffermato. Lo sfiora soltanto quando si mette a discutere della importanza, da lui
completamente ignorata, del concetto socialista della trasformazione di un governo
esercitato su uomini in un’amministrazione di cose, e identifica immediatamente la
tendenza della democrazia sociale all’abolizione e al superamento di una casta
autoritaria di funzionari con la soppressione pura e semplice dei funzionari in genere.
In tal senso il problema di come si possa conciliare l’esigenza di una classe di
funzionari, formata su base professionale, con l’autodeterminazione democratica,
diventa per lui la monotona « contraddizione », che attraversa tutto il suo libro, e di
cui ci occuperemo più diffu samente, « tra anarchia e organizzazione, tra la teoria
politica e la teoria economica » nel marxismo (pp. 88-9 [135 ] ). In ogni caso
dobbiamo ammettere che non di rado nella letteratura socialista e anarchica la
necessità, anche per la società socialista, di una classe di funzionari di professione
(berufsmassigen Beamtentums) fu ignorata, perché non si prestò sufficiente attenzione
al fatto che la lotta contro la burocrazia non era diretta contro la formazione
specialistica, bensí contro la sua separazione in una classe specifica, con dei propri
interessi e aspirazioni di potere, in breve appunto contro la sua dimensione autoritaria.
Solo la maggiore « vicinanza allo Stato » del proletariato, il suo prendere contatto in
modo più approfondito, attraverso l’imporsi dei problemi della socializzazione, e in
particolare attraverso la conquista di molte amministrazioni comunali, con i compiti
relativi alla gestione di grosse aziende, ha acuito lo sguardo circa la necessità di una
formazione professionale anche per questo genere di attività. Questa esperienza ci ha
insegnato che appartiene alle molteplici illusioni della democrazia piccolo-borghese la
sua rappresentazione preferita, secondo la quale i compiti organizzativi della
democrazia sociale si semplificherebbero e ridurrebbero a tal punto da potere essere
svolti da chiunque e per giunta come seconda occupazione. Nella misura in cui Kelsen
individua anche in alcune
Página 148
affermazioni di Lenin una simile concezione [nota 15], ha sicuramente ragione nella
sua polemica verso il bolscevismo. Ma il bolscevismo spontaneamente si è liberato
molto presto di questa opinione erronea e che ritroviamo solo ai suoi inizi, come lo
stesso Kelsen del resto ha dovuto ammettere sulla base del brano, da lui citato, tratto
dal famoso discorso di Trockij Arbeit, Disziplin und Ordnung, nel quale si dice:
La democratizzazione non consiste affatto in ciò, (questo è l’abc pei ogni marxista),
nel negare il valore delle persone, che sono in possesso di conoscenze specialistiche,
ma nel sostituirle ovunque e sempre attra verso collegi elettorali.
E se Kelsen ritiene (p. 123 [170] ) che nella repubblica dei soviet anche questo
principio elettivo per gli organi pubblici non poté essere salvaguardato senza eccezioni,
poiché lo stesso Trockij non lo fece valere per l’Armata rossa, gli bastava proseguire
nella lettura per vedere come Trockij non considerasse in generale questo principio
elettivo come « l’ultima parola della costruzione economico-statale della classe operaia
».
Il passo in avanti deve consistere nell’autolimitazione dell’iniziativa dei compagni,
nella giusta e vantaggiosa autolimitazione della classe operaia la quale sa in quale
momento il rappresentante eletto dai lavoratori può dire una parola decisiva e quando
è necessario cedere il posto al tecnico, allo specialista che è fornito di conoscenze
determinate, al quale si deve conferire una maggiore responsabilità e che deve essere
sottoposto a un attento controllo politico [nota 16].
E Lenin stesso, la cui vera grandezza politica consiste non solo nel riconoscere
prontamente i suoi errori, ma anche nel confessarli e nel correggerli, mostrando una
coraggiosa assenza di riguardo verso se stesso e verso le opinioni dei suoi ciechi
seguaci, dichiara già nel marzo del 1918:
Senza specialisti che dirigano i diversi settori della scienza, della tecnica, della
ricerca, il passaggio al socialismo è impossibile, giacché il socialismo esige un’avanzata
cosciente delle masse verso una produttività del lavoro maggiore rispetto a quella del
capitalismo e che parta dai risultati raggiunti dal capitalismo [nota 17].
Página 149
Ma la nostra analisi non concerne il bolscevismo, bensí la democrazia in generale e a
tale riguardo mi sembra che il pericolo, indicato come inevitabile, di una
contraddizione, che si sviluppa fatalmente in essa, tra le sue intenzioni e la forma
organizzativa che deve assumere, scompaia non appena si consideri la democrazia
nella sua forma specifica, in quella sociale, liberata dunque dai conflitti economici tra le
classi. Smetteremo quindi anche di concepire la democrazia in una relazione
logicamente necessaria, quasi di identità, con l’attuale forma statale e avremo
acquisito quella fluidità nel modo di rappresentare le cose, che è indispensabile se si
vogliono perseguire sviluppi sociali nel futuro.
La degenerazione della democrazia in seguito al costituirsi di una casta di funzionari
pubblici di professione, e la sua trasformazione da un’organizzazione che consente al
popolo di autodeterminarsi in uno strumento per il suo dominio da parte di questa
casta, mi sembra che siano impedite in modo decisivo da due contromovimenti che
oggi sono riconoscibili come tendenze verso una democrazia sociale, perché i loro
effetti si fanno già sentire ed è sulla base di essi che possiamo essere sicuri che gli
uomini del futuro, i quali vorranno proporsi come loro ideale la democrazia, sapranno
anche trovare dei rimedi completamente nuovi. Su questi principi, per cosí dire
portanti, di ogni democrazia Marx ha richiamato l’attenzione con particolare vigore. Si
tratta in primo luogo della formazione politica delle masse, della loro apertura ad una
coscienza di classe proletaria, rivoluzionaria, il che rappresenta però soltanto l’aspetto
fenomenico, relativo alla nostra epoca, e colorato, per cosí dire, attraverso di essa, di
una coscienza sociale, di un sentimento sociale. Il secondo elemento concerne la
costruzione dal basso dello « Stato », cioè della vita fondata sulla solidarietà sociale, a
partire dunque dalle piccole, ristrette relazioni sociali, ancora piene di vita, quali si
costituiscono sulla base di legami locali, aziendali, di natura economicocollettiva, nel
quadro della soddisfazione piú diretta dei bisogni. Ciò non comporta una ricaduta nel
modello rappresentativo primitivo o, come si
dice volentieri, ‘piccolo-borghese’
dell’utopismo. Viene operata soltanto una generalizzazione del principio già da molto
tempo confermato dalla storia della democrazia, soprattutto nella sua forma inglese,
secondo il quale ciò che di democratico riesce ad attuarsi all’interno della società
classista, ha potuto svilupparsi solo in base al principio di autogestione dal basso dei
comuni e delle comunità finalizzate a uno scopo. A un primo sguardo lo sviluppo che
conduce dalla molteplicità e dal frazionamento politici ai grandi Stati centralizzati
nazionali e autoritari di oggi sembra indubbiamente contraddire la tendenza
Página 150
all’autogestione di tipo federativo. Ma sia Marx che Engels hanno posto l’accento sul
fatto che dobbiamo considerare questa linea di sviluppo verso il centralismo statale
solo come un fenomeno transitorio, prodotto da forze e situazioni storiche specifiche e
non come una tendenza sociale universalmente valida. Quest’ultima opinione è
piuttosto solo il frutto di un’abitudine di pensiero acritica. La vita sociale dell’uomo si
svolge già da secoli in forme sociali organizzate sempre crescenti e più centralizzate.
Non dobbiamo stupirci se, come dice Engels, « sin da bambini si è abituati a ritenere
che gli affari comuni all’intera società non possano essere curati diversamente da come
finora è stato fatto, cioè attraverso lo Stato e i suoi organi di autorità al loro posto »
[nota 18] il che vuol dire in modo autoritario e burocratico. Solo che
il potere statale centralizzato, con tutti i suoi organi dappertutto presenti: esercito
permanente, polizia, burocrazia, clero e magistratura — organi istituiti in base al piano
di divisione del lavoro sistematica e gerarchica — risale ai tempi della monarchia
assoluta, quando servi alla nascente società borghese come arma potente nella sua
lotta contro il feudalesimo [nota 19].
Il centralismo del potere statale, al di là di ogni sua trasformazione nella forma di una
repubblica democratica o di un costituzionalismo parlamentare, è rimasto dal punto di
vista interno identico a sé, come il più potente strumento di potere nelle mani dei
proprietari, fino all’ultima forma in cui si è manifestato come imperialismo.
Indubbiamente Marx ha conosciuto quest’ultimo solo nella sua forma bonapartista, ma
lo ha caratterizzato, nonostante l’accordo esteriore che esso presenta con le forme
democratiche, in un modo che risulta valido anche per il presente, allorché dice di
esso:
L’imperialismo è la forma più prostituita e insieme conclusiva di quel potere statale
che la nascente società borghese aveva cominciato ad elaborare come strumento della
propria liberazione dal feudalesimo, e che la società borghese nel momento del suo
massimo sviluppo aveva trasformato in uno strumento di asservimento del lavoro al
capitale [nota 20].
Marx, invece, individua nella Comune parigina la forma della « repubblica sociale ». Il
che significa:
La Comune di Parigi doveva naturalmente servire da modello per tutti i grandi centri
industriali della Francia. Una volta stabilito a PaPágina 151
rigi e nei centri periferici l’ordinamento comunale, il vecchio governo centralizzato
avrebbe dovuto cedere il posto anche nelle province allo autogoverno dei produttori.
Questo autogoverno doveva diventare « la forma politica anche del villaggio più
piccolo » e al di sopra di queste comuni si doveva costruire un sistema di
rappresentanze distrettuali e infine l’assemblea nazionale [nota 21].
È dunque chiaro che si deve abbandonare l’idea di un’autodistruzione inevitabile della
democrazia pura. Negli organismi di autogoverno che ivlarx prefigura ancora soltanto a
livello territoriale, ma che già nel sistema sovietico risultano fondati sull’ordinamento
aziendale, e che nel socialismo delle gilde sono costruiti su un sistema globale di
organizzazione dei bisogni, l’antico Stato Leviatano si scinde in una pluralità multiforme
di corpi collegati da interessi e scopi comuni. Al loro interno, pertanto, il fatto di essere
informati, l’interesse, la cultura e la solidarietà dei membri stabiliscono una base per la
nomina e il controllo degli organi, che si configura in un modo completamente diverso
rispetto a ciò che è possibile fare in una situazione in cui le masse popolari stanno in
un rapporto passivo verso gli organi che hanno contribuito a nominare e a eleggere.
L’ignoranza delle funzioni di ufficio e professionali, l’impossibilità di estendere un
controllo su di esse, l’assenza di ogni potere organizzativo non soltanto nei confronti
dei funzionari, bensí anche verso i propri deputati sono i fattori che hanno impedito per
molto tempo all’opinione pubblica, anche nei grandi Stati parlamentari, di riacquistare
la consapevolezza che tutti questi organi pubblici sono di fatto una realtà di cui
ciascuno è partecipe e che contribuisce a determinare. Questa estraneazione delle
masse, anche nel caso in cui hanno partecipato all’elezione, si può cogliere
emblematicamente nel modo in cui anche uomini colti reagiscono nei confronti di atti
compiuti dal governo e di decisioni parlamentari. Di fronte alla imposizione di una
nuova tassa è possibile sentire esclamare in tono particolarmente acceso: “Ma guarda
che cosa vanno a decidere di nuovo quelli! ”. Oppure si tenta di scoprire con curiosità
che cosa escogiteranno quelli, cioè il governo e il parlamento, ecc. È completamente
assente la consapevolezza che “coloro che stanno in alto” e “coloro che stanno dentro”
sono stati collocati ai loro posti dagli uomini che stanno in basso e all’esterno e, cosa
che occorrerebbe valutare con più attenzione, possono nuovamente essere allontanati.
Nelle forme politiche della « Comune » una tale estraneazione non è possibile o è
possibile soltanto con maggiore difficoltà, e
Página 152
in questo modo la spinta più forte a una degenerazione della democrazia viene a
perdere la sua efficacia. L’interesse comune, la conoscenza materiale e collettiva dei
compiti amministrativi, dei bisogni e delle necessità della rispettiva sfera di
organizzazione non solo tiene uniti i membri della comunità in una salda
consapevolezza delle proprie responsabilità, ma induce anche i loro rappresentanti a
rapportarsi in un modo completamente nuovo rispetto a essi; si tratta, infatti, di un
rapporto in cui la superiorità degli organi non costituisce più un pericolo, in quanto può
tornare solo a vantaggio degli obiettivi, anzi delle aspettative dell’intera sfera di
interessi della comunità. È soltanto a partire da ciò che una posizione autoritaria
(obrigkeitliche) si converte in un’autorità (Autoriat) effettiva, interiormente avvertita,
riconosciuta, anzi auspicata e forse persino amata; allo stesso modo all’interno di un
partito o in una scuola artistica, filosofica o altro, i seguaci si subordinano a un capo,
riconosciuto superiore, non solo da un punto di vista materiale, ma con venerazione,
con gioia per l’opera, con piacere nei confronti della guida sicura, anzi molto spesso
direttamente con amore.
Com’è naturale lo « Stato », che si costruisce su una tale ‘comunalizzazione’ delle sue
componenti è qualcosa di profondamente diverso dall’attuale Stato centralizzato, anche
nella
sua forma
democratica. Dobbiamo
guardarci dall’applicare senz’altro le
categorie del presente a questo prodotto della democrazia sociale, che appartiene
dunque al futuro sociale. Già Marx si è opposto a che si consideri la costruzione della
repubblica sociale, basata su una rete di comuni, unicamente come una ricaduta in
antiquate e ristrette forme di vita di piccoli Stati, di cui il medioevo ci ha fornito
l’esempio nelle sue strutture cittadine, oppure come « una forma portata all’estremo
dell’antica lotta contro l’eccesso di centralizzazione dello Stato moderno » [nota 22]. E,
se ciò risulta valido per la struttura ancora territoriale della comunalizzazione
(Kommunisierung) dello Stato, teorizzata da Marx, un tale discorso riguarda in misura
maggiore la forma più recente di questa comunalizzazione (Kommunisierung) della
società, portata a compimento dalle idee organizzative del sistema consiliare e del
socialismo delle gilde. Rispetto a questo nuovo problema, che costituisce il nodo reale
dell’organizzazione di una democrazia sociale, non è più possibile ricorrere al vecchio
contrasto tra centralismo e federalismo. Ciò fu intuito da Marx quando, riferendosi alla
Comune come al modello della nuova organizzazione sociale, disse:
Página 153
L’unità della nazione non doveva essere spezzata ma al contrario organizzata
attraverso la distruzione di quel potere statale che pretendeva di essere l’incarnazione
di questa unità ma indipendente e superiore alla nazione stessa, nel corpo della quale
era nondimeno solo un’escrescenza parassitaria [nota 23]
Anzi, Engels, quattordici anni più tardi, sottolinea che già nella rivoluzione francese
del 1789 l’autogoverno dei dipartimenti, delle circoscrizioni e dei comuni costituí la leva
più importante della rivoluzione e che ciò non si pose in conflitto con la centralizzazione
che fu innalzata su questa base.
Un autogoverno locale e provinciale è cosí poco in contraddizione rispetto alla
centralizzazione politica e nazionale, quanto non è necessariamente connesso con
quell’ottuso egoismo cantonale e comunale che ci viene incontro cosí disgustosamente
in Svizzera e che nel 1849 in Germania tutti i tedeschi meridionali, sostenitori di una
repubblica federale, dovevano assumere a modello [nota 24].
La dissoluzione dello Stato in una tale rete associativa di comuni, consigli e gilde non
ha dunque assolutamente niente a che vedere con l’attuale contrapposizione tra
centralismo e federalismo. La centralizzazione politica ed economica che si esprime
oggi nello Stato e nei cartelli è principalmente uno strumento di potere e di dominio;
nel contrasto tra centralizzazione e decentramento non si manifesta un semplice
principio organizzativo, bensí il conflitto esistente tra i vari gruppi di potere all’interno
della sfera statale ed economica. In questo caso la centralizzazione è pertanto possibile
sempre soltanto ‘dall’alto’, cioè attraverso la volontà di un gruppo di potere che gode di
una posizione di preminenza e che impone il suo dominio agli altri interessi
contrastanti; al contrario la centralizzazione che si attua in una democrazia sociale è il
prodotto organico che si sviluppa spontaneamente a partire dai bisogni di singoli gruppi
di interesse, dunque dal basso, cos í come sono appunto le necessità della produzione,
dell’impresa o anche soltanto i vantaggi, che scaturiscono dall’unificazione, a
consigliare una tale organizzazione che si pone al di sopra dei singoli raggruppamenti.
Questo aspetto della questione è ignorato da E. Bernstein nel suo libro Der
Sozialismus einst und jetzt, il quale ripete però di fatto solo i più vieti errori del libro
del 1899 I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia con cui scese in
campo contro il marxismo. Già in quell’occasione aveva presentato
Página 154
come sostanzialmente analoghe le idee di Marx circa la comuna lizzazione e quelle di
Proudhon [nota 25], ma non aveva avuto ancora il coraggio di qualificare lo stesso
pensiero di Marx come « piccolo-borghese ». A questa affermazione perviene nel suo
scritto piú recente [nota 26], il cui tratto distintivo consiste nel caratterizzare ciò che
Bernstein chiama il socialismo di oggi in base a un piú accentuato distacco da Marx,
rispetto al socialismo di un tempo. In primo luogo occorre precisare che dalla critica,
che Marx rivolge a Prouhon, non deriva che Proudhon non abbia formulato nessun
concetto esatto, e che perciò ogni coincidenza tra le vedute di Marx e le sue conduca
inevitabilmente a bollare Marx come un « piccolo-borghese ». Al contrario,
l’interpretazione cos í diffusa del « federalismo » della teoria anarchica come un modo
di pensare piccolo-borghese appartiene ai molteplici luoghi comuni e pregiudizi
consolidati riguardo all’anarchismo. Indubbiamente il « federalismo » anarchico, in
particolare nei suoi rappresentanti iniziali, spesso non è sostenuto da un’adeguata
intuizione della complessità e dell’estensione mondiale della vita economica moderna,
ma ciò non incide sul valore del pensiero fondamentale, in base al quale un sistema di
effettiva libertà sociale non può essere costruito su una centralizzazione relativa
semplicemente alla sfera economica. In maniera molto istruttiva per una migliore
comprensione dell’anarchismo, da auspicare proprio nell’interesse del socialismo,
suona quanto afferma il socialista delle gilde Cole, un uomo dalle vedute moderne, né
piccolo-borghese né anarchico. A suo avviso í socialisti delle gilde sono pervenuti alla
elaborazione di una nuova teoria politica basata sul « riconoscimento che un dominio
puramente industriale non può rappresentare un progresso rispetto a uno puramente
politico » [nota 27]. Si può veramente credere che Marx, allorché espose il suo
pensiero sulla comunalizzazione della società, non fosse consapevole del fatto che non
si trattava pii di una comunità a economia piccolo-borghese, bensí, come Bernstein
obietta con comica serietà al grande critico del sistema capitalistico mondiale, di paesi
« con imprese moderne [...] e con rapporti economici che oltrepassano di gran lunga
l’ambito della comunità »? [nota 28]. A questo punto l’esposizione di Bernstein che
nretende di essere cosí rigorosa, sfocia soltanto in un’esibizione della propria incapacità
di riflettere su opinioni consolidate. La sua obiezione, ad esempio, circa il fallimento cui
andrebbe incontro una tale
Página 155
comunalizzazione, in relazione al compito specifico di regolare il corso di un fiume, a
causa degli interessi assolutamente divergenti tra gli abitanti della valle e quelli dei
monti, dimostra che Bernstein si rappresenta le comuni semplicemente come degli
individui sottratti a ogni connessione sociale, che agiscono e litigano gli uni con gli altri.
Al contrario, com’è ovvio, l’ampia connessione di interessi e di distribuzione delle forze
sociali, quale esisteva già prima nello Stato, continua a sussistere, nella sua globalità,
anche dopo, dunque non solo pretende di essere rispettata, ma ottiene anche di fatto
ciò, sfruttando le necessità poste in essa, con l’unica differenza che ora tale processo si
sviluppa con la partecipazione degli interessati, perciò spesso con maggiore efficacia,
talvolta con minore efficacia di prima. Inoltre, se non si pone piú a fondamento la
rappresentazione delle comuni, quali finora si sono sviluppate, ma quella di una gilda
che sin dall’inizio si ponga oltre i confini di una comunità, risulta assolutamente
incomprensibile come una società organizzata in questo modo non possa di volta in
volta elaborare il criterio cui deve ispirarsi la centralizzazione, che essa giudica
opportuna e che sarà imposta anzi dalla natura della cosa stessa.
Cosí vediamo anche Cole prendere le mosse proprio dalle « colossali dimensioni » che
le organizzazioni economiche e politiche hanno assunto nello Stato capitalistico e che
tendono ad ampliarsi sempre piú attraverso l’imperialismo e la formazione di trusts. Ma
— a suo avviso — già nella stessa Inghilterra, per non parlare dei paesi in cui si è
verificata una rivoluzione proletaria, si è dimostrato
che la democrazia comporta un’inversione di tendenza. Ciò non significa che le
potenti unità economico-politiche del capitalismo si scindano in piccoli gruppi
indipendenti; ma la democrazia determina sicuramente un esteso processo di
decentramento e di scomposizione, cui fa seguito di nuovo una riunificazione su base
federalistica.
E, come se si rivolgesse direttamente a Bernstein e a critici del genere, aggiunge:
La tensione verso una superiore forma di organizzazione e centralizzazione è la
conseguenza naturale dell’attuale situazione della classe operaia, ma non ci autorizza
ancora a trarre nessuna conclusione su quale forma di organizzazione il popolo
sceglierà in seguito alla sconfitta del capitalismo. [...] Una cosa è certa: la tendenza a
creare organizzazioni locali in una società libera e democratica si imporrà con forza
[nota 29].
Página 156
Giustamente il marxista R. Hilferding definisce le intuizioni del socialismo delle gilde
come l’espressione di un modo di pensare empirico, semplicistico e asistematico, ma
che, in quanto scaturito dall’esperienza diretta dei lavoratori, può rappresentare una
specie di rivitalizzazione per le idee marxiste dello Stato e della lotta di classe [nota
30]. Ed è in tal senso che egli sottolinea in particolar modo che la concezione dello
Stato dei socialisti delle gilde rispecchia le concrete tendenze evolutive che conducono
o « verso un’economia basata sull’antagonismo capitalistico o verso un’economia
armonico-socialista » [nota 31], cioè, nella nostra terminologia, rispecchia
l’opposizione fra una democrazia politica e una democrazia sociale. L’esigenza di una
comunalizzazíone dello Stato attuale non mira dunque a un puro federalismo o a un
decentramento, ma è in primo luogo la richiesta fondamentale di abolire i conflitti di
classe e, insieme, l’ipotesi di una nuova forma di organizzazione della società senza
classi, basata su organismi di autogoverno e concepita dall’angolo visuale di uno spirito
di partecipazione e di responsabilità che organizza gli uomini in modo nuovo, anche dal
punto di vista interiore.
Ed è in questa prospettiva che effettivamente il centro di gravità della futura
democrazia non risiederà nella politica, bensí nella pedagogia, in un’accezione
completamente diversa e piú ampia, rispetto al modo in cui veniva concepita da
Michels. Infatti questo tipo di pedagogia, nella sua azione globale e peculiare, oggi non
è ancora possibile; essa sarà un prodotto del nuovo assetto sociale senza classi, in cui
potrà finalmente attuarsi l’ideale, da lungo tempo ambito, di comunicare una cultura
politica che sia al tempo stesso una cultura sociale e etica, in quanto queste tre sfere
di valutazione finiranno col coincidere. In un capitolo successivo ci occuperemo piú
diffusamente dell’obiezione assurda, ma che proprio per questo motivo non smette di
circolare e che purtroppo è ripresa da Kelsen, secondo la quale è prova di un utopismo
ingenuo e non scientifico, una sorta di fede nei miracoli, l’ipotizzare, per quanto
riguarda la società socialista, uomini diversi da quelli attuali. Vedremo come una tale
obiezione sia cosi poco giustificata quanto lo sarebbe il comportamento di un sapiente
di un popolo primitivo, il quale volesse dimostrare che non è possibile immaginare
uomini diversi da quelli primitivi. Ma un sapiente di quell’epoca storica sarebbe ancora
autorizzato a fare ricorso a questo tipo di logica, in quanto è per l’appunto un uomo
appartenente a una cultura primitiva. Noi muoviamo viceversa dal fermo presupposto
che l’ideologia è una funzione dell’economia ,e che
Página 157
il mutamento globale, quale finora non si è mai attuato, dell’economia di una società
solidale, fondata sugli strumenti della tecnica e della cultura moderne, avrà delle
ripercussioni sullo spirito e l’animo delle generazioni cresciute in essa. In ogni caso qui
l’educazione e i costumi si dispiegheranno in tutto il loro itnmènso campo d’azione.
Non possiamo neppure immaginare che cosa sarà in grado di attuare un tipo di
educazione che non sia piú costretta a contrastare gli sforzi dell’individuo per emergere
e svilupparsi, ma che viceversa valorizzi queste tensioni, in quanto impulsi favorevoli
agli scopi della nuova organizzazione sociale! Se i grandi spiriti del XVIII secolo,
Lessing e Herder, Rousseau e Kant, Schiller e Fichte, Pestalozzi e Owen, hanno
venerato nella educazione una potenza miracolosa capace di porre su nuove basi il
mondo, in ciò peccarono di ingenuità, in quanto non si avvidero che l’educazione di
uomini nuovi non può andare disgiunta da un immenso processo di dissoluzione degli
antichi rapporti borghesi, che del resto nella loro epoca non si ponevano affatto come
superati, ma che allora cominciavano a svilupparsi nella loro peculiare struttura
contraddittoria. In se stesso il pensiero, che attribuisce una forza socialmente creativa
e un ruolo importante all’educazione, conserva una sua validità, sebbene nel XVIII e
XIX secolo esso rappresenti soltanto una geniale anticipazione di effetti che saranno
pienamente sperimentati forse solo nel XXI. Già oggi l’educazione sociale nel senso di
un’educazione orientata in base ai compiti e agli obblighi di una società senza classi,
cioè un’educazione socialista, rappresenta lo strumento essenziale per l’affermazione di
una cultura realmente sociale e di un modo di pensare e di sentire democratici [nota
32].
Una comunalizzazione della vita sociale e una educazione sociale sono, a mio avviso, i
rimedi giusti ai guasti provocati dall’attuale centralizzazione e burocratizzazione
all’interno della democrazia. Giustamente il famoso giurista Klein, che non si può
assolutamente definire un socialista, nel suo libro sull’essenza della organizzazione
oggi afferma che nelle attuali formazioni comunitarie, laddove è assente una
conflittualità interna, probabilmente non si svilupperà neppure una tendenza
all’oligarchia.
Non si può parlare di un vero e proprio dominio, di un comandare da un lato e di un
obbedire dall’altro, soprattutto in organizzazioni nelle quali, come accade in società
religiose, in associazioni artistiche e scientifiche e in unioni del genere, le persone, che
hanno un ruolo
Página 158
direttivo, hanno bisogno della collaborazione attiva dei soci. Al contrario esse debbono
avere tanta piú considerazione per le opinioni e i desideri dei soci, quanto piú sanno
che la loro impresa andrebbe incontro a un fallimento se, per un dissenso tra la
direzione e gli altri membri, l’organizzazione smarrisse la sua capacità organizzativa
[nota 33].
Si può veramente ipotizzare che le cose andrebbero diversamente in gilde, comuni e
consigli del futuro? Ma è sterile disputare su questo argomento come su tutte le cose di
cui non abbiamo diretta esperienza. Lo abbiamo fatto solo nei limiti in cui è stato
necessario per dimostrare la falsità dell’opinione secondo la quale la democrazia
sarebbe destinata fatalmente a degenerare in una forma di dittatura autoritaria e in
una burocrazia sclerotizzata. Come non è possibile proiettare nella futura
organizzazione sociale le forme statali attuali, cos í dobbiamo apprendere la validità del
detto della lancia che guarisce da sola le ferite che procura. Le insufficienze e i guasti
della democrazia possono essere superati solo dalla democrazia, se essa non è piú un
fenomeno che trova la sua realizzazione nello Stato, ma una democrazia effettiva e
valida in se stessa. Anche qui si rivela la straordinaria forza del punto di vista marxista
che fornisce quella chiarezza indispensabile per non indicare con il medesimo concetto
di Stato’ due cose cosí completamente diverse come lo Stato di classe democratico e la
democrazia senza classi. Esso costituisce l’accesso tanto alla comprensione dello Stato
quanto a quella della democrazia.
Página 159
Capitolo tredicesimo
La dittatura
L’analisi precedente ha restituito il senso effettivo, cioè sociologico, dei concetti di
Stato, democrazia e rivoluzione, liberandoli dalle prospettive astratte, in cui hanno
subito le piú strane deformazioni, e in base a ciò è venuta emergendo
contemporaneamente la loro ineliminabile interconnessione. Si è dimostrato anche,
però, che ambedue i risultati sono possibili solo se questi concetti vengono considerati
dal punto di vista del conflitto e della lotta di classe, che consente di cogliere la
dimensione storica in cui essi si manifestano, e non dal punto di vista della loro forma
giuridica, che occulta la loro realtà storica. A questo punto non ci resta che applicare lo
stesso metodo all’ultimo concetto della critica di Kel sen, quello di dittatura.
Il problema di cui ci occupiamo qui è, definito in breve, questo: come mai Marx ed
Engels, i quali pure si mossero, in linea di massima, sul terreno della democrazia,
poterono indicare nel concetto di dittatura la meta della lotta di emancipazione del
proletariato. Ci si chiede, in altri termini, se democrazia e dittatura siano o no in
contraddizione reciproca. Si mostrerà anche come questo problema appartenga a quel
genere di quesiti che vengono dibattuti nel modo piú appassionato possibile, sebbene o
proprio perché in realtà non sono affatto dei problemi, ma acquistano il loro carattere
problematico solo in virtú di questioni impostate in modo erroneo, sono pertanto dei
falsi problemi. Ma prima di imboccare la strada che ci condurrà alla discussione di
questo stato di cose, liberi dagli ostacoli che ci impediscono l’accesso alla questione
effettiva, vorrei osservare subito che la cosiddetta dittatura del bolscevismo russo non
sarà affatto presa in considerazione nel• la nostra indagine. Essa infatti non
corrisponde in nessun modo alla teoria marxista, quale è stata esposta in primo luogo
dagli stessi capi del bolscevismo russo. Anche dal loro punto di vista Marx ed Engels
hanno inteso senz’alcun dubbio, con la dittatura
Página 160
del proletariato, il dominio della classe proletaria, basato, se non sulla sua
maggioranza numerica, — sebbene anche questo sia il senso di questo concetto in
Marx ed Engels — sulla sua preminenza nella connessione sociale complessiva. Poiché
in Russia il proletariato non costituisce né la maggioranza della popolazione, né
dispone di un netto predominio in seno all’organizzazione sociale russa — predominio
che, com’è noto, spetta ai contadini — e poiché neppure come classe il proletariato
esprime una maturità, che si estenda a tutti i suoi membri, il concetto di dittatura ha
subito, in Lenin e Trockij e quindi nella teoria bolscevica nel suo complesso, una fatale
correzione, in base alla quale non ha designato piú la dittatura della classe del
proletariato, ma solo di una parte di questa, della cosiddetta avanguardia, del reparto
avanzato della élite operaia. Del resto anche Trockij ha dovuto ammettere ciò nel suo
libro intitolato Terrorismo e comunismo, nel quale afferma « che la dittatura dei soviet
è stata resa possibile mediante la dittatura del partito ». Diversamente la dittatura in
generale non sarebbe affatto possibile. « Il dominio rivoluzionario del proletariato ha
nel proletariato stesso come presupposto il dominio politico di un partito con un
programma chiaro e una ferrea disciplina interna » [nota 1] La radice di una tale
correzione apportata al concetto di dittatura, che conserva sí la terminologia marxista,
ma si allontana dallo spirito del marxismo, per sfociare in quello di un Blanqui, si
ritrova già nel libro di Lenin Stato e rivoluzione, in cui si afferma che il proletariato è
l’unica classe capace di porsi alla testa di tutte le altre classi lavoratrici sfruttate. Da
ciò scaturisce — secondo Lenin — l’autorizzazione, per quella parte del proletariato che
ha già raggiunto una consapevolezza di classe, a guidare, come avanguardia, « l’intero
popolo » [nota 2]. All’interno di questo modo di pensare, che sostituisce al ruolo di
guida, già pienamente acquisito, sul piano economico, dal proletariato, la sua semplice
capacità, resta del tutto irrisolta la questione se il restante « intero popolo » voglia
lasciarsi guidare o se non si metta piuttosto a combattere dapprima nel modo piú
violento possibile contro questo tipo di direzione, per quanto essa possa risultare
conveniente rispetto ai suoi specifici interessi economici. In tal modo il pensiero della
dittatura del proletariato, che in Marx ed Engels rappresenta la forma conclusiva della
lotta di tutta la classe proletaria, nel bolscevismo passa ad indicare l’inizio di una lotta
di classe del proletariato, che diversamente non avrebbe affatto la possibilità di
giungere a maturazione. Dalla dittatura del proletariato, la quale esprime
l’autoaffermazione vittoriosa dei suoi intePágina 161
ressi di classe, si sviluppa la politica di un gruppo dirigente che dovrebbe operare
nell’interesse del proletariato, ma che in fondo è solo una variante del dispotismo
illuminato che credeva anch’esso di esercitare il suo potere nell’interesse del popolo. La
dittatura bolscevica non ha dunque, né nella teoria né nella prassi, niente a che vedere
con il problema marxista della dittatura. La sua teoria è solo un tentativo, scaturito dai
bisogni della lotta rivoluzionaria in Russia, di giustificare la propria tattica e, insieme a
questa, andrà incontro, al pari di molte altre cose nel bolscevismo, a una radicale
trasformazione. Se si vuole comprendere il significato del concetto di dittatura nel
contesto del marxismo teorico si può, anzi si deve, tralasciare tutto ciò che Kelsen
adduce come elemento per criticare le contraddizioni esistenti tra questo concetto
bolscevico di dittatura da un lato e il pensiero stesso della democrazia e il marxismo
dall’altro, e che spesso viene a coincidere con la critica che Kautsky, Otto Bauer,
Hilferding e io abbiamo svolto [nota 3].
Kelsen ritiene di aver rivelato la contraddittorietà di questo concetto per il fatto che la
dittatura del proletariato diviene possibile, secondo l’opinione di Marx ed Engels, solo
quando il proletariato è in grado di rappresentare la maggioranza della popolazione, il
che significa però che questo concetto trapassa in quello di democrazia. Ma il problema
del rapporto della dittatura con la democrazia non consiste affatto in ciò. La questione
se alla dittatura sia o no necessaria la maggioranza è diventata oggetto di un cosí
animato dibattito soprattutto a causa della tattica bolscevica, ma finisce col trascurare
il problema effettivo, cosí come lo hanno visto e risolto Marx e Engels. Il senso
specifico del concetto di dittatura può essere colto solo se non si perde di vista il
duplice significato del concetto di democrazia, in base al quale esso desiPágina 162
gna tanto la democrazia politica quanto quella sociale; e in base a ciò l’idea di dittatura
sta a indicare che la democrazia politica, poiché è pur sempre una forma di dominio di
classe, non è stata né sarà mai possibile senza dittatura in generale. La dittatura del
proletariato non è pertanto qualcosa di inaudito, ma rappresenta — sebbene nelle
forme della democrazia politica — la sostituzione della dittatura borghese con quella
proletaria.
Non ci sembra opportuno soffermarci più diffusamente su questo argomento: esso
emerge dall’insieme coerente di quanto finora è stato esposto. Nella democrazia
borghese sussiste indubbiamente la dittatura delle classi dominanti. Ciò affiora
immediatamente con rozza evidenza ogni qualvolta, nei periodi cosiddetti critici, le
classi dominanti sospendono la costituzione dello Stato, proclamano lo stato di
emergenza e sguinzagliano soldati, magistrati e polizia dietro le masse diventate
‘sediziose’. In quella occasione il giurista offre la propria assistenza e dimostra che
tutto si è svolto ‘in modo costituzionale’: la corte suprema ‘riconosce’ che nessuna
legge è stata violata. Com’è possibile dunque che si attui una dittatura? Lo statista
Bismarck, spirito cinico e geniale nell’accezione borghese del termine, era andato più
vicino alla conoscenza realè e, soprattutto, si era mostrato più sincero nella
consapevolezza della propria forza, non solo allorché impose per lunghi anni alla
socialdemocrazia delle leggi speciali, ma anche quando, prossimo a morire, definí il
carattere dittatoriale del dominio borghese con le seguenti parole:
La socialdemocrazia rappresenta per la corona e lo Stato una minaccia di guerra più
pericolosa di quanto non lo siano oggi le nazioni straniere e deve essere trattata da
parte dello Stato come una questione di guerra e di potere, piuttosto che come una
questione giuridica. [nota 4]
Bisogna tener presente che questo tipo di dittatura è sicuramente esercitata da una
minoranza su una maggioranza, sebbene essa sia resa possibile solo in quanto
gl’interessi effettivamente dominanti sanno ottenere l’appoggio di larghi settori della
popolazione, i quali credono che in tal modo i loro interessi siano favoriti [nota 5].
Página 163
La dittatura del proletariato, dunque, all’interno della democrazia politica non
rappresenta più affatto un problema. Se il proletariato domina è naturale che
anch’esso imposti il suo dominio come una questione di potere di contro alle tendenze
sociali antagonistiche, come a suo tempo ha fatto la borghesia. Il fatto che, dunque,
nelle situazioni critiche, la libertà di stampa, la libertà d’assemblea, la libertà
d’associarsi ecc. di certe parti del popolo — che poi s’identificheranno con la classe
dominante abbattuta — vengano limitate o tolte, non costituisce affatto una
contraddizione rispetto alla ‘democrazia’. Finora infatti si è sempre trattato unicamente
della democrazia politica, il cui fondamento non è ancora uno Stato senza classi. La
soppressione delle libertà politiche non è altro che la necessaria prosecuzione della
lotta di classe del proletariato, solo che esso utilizza ora gli strumenti fornitigli dallo
Stato, allo scopo di eliminare più rapidamente tutti i residui dell’antico sistema. Anche
Engels per questo motivo ha respinto, nella lettera sul programma di Gotha, che Bebel
ha pubblicato nelle sue memorie, la pretesa del « libero Stato popolare », che il
proletariato dovrebbe fondare, in quanto ha visto in esso un confuso discorrere a
vuoto.
Poiché lo Stato è indubbiamente un fenomeno transitorio di cui ci si serve nella lotta,
nella rivoluzione, per annientare i propri nemici, è pura follia parlare di un libero Stato
popolare: fin quando il proletariato si serve dello Stato, non lo utilizzerà nell’interesse
della libertà, ma per l’annientamento dei suoi avversari e non appena si può parlare di
libertà cessa di sussistere lo Stato in quanto tale [nota 6].
In breve, l’uso dello Stato per la soppressione dei nemici del proletariato non è altro
che « lo stato di eccezione » del governo proletario, il quale tanto meno può essere
considerato come una contraddizione rispetto alla democrazia, in quanto esso, in base
al presupposto che la dittatura del proletariato è possibile solo come dittatura della
maggioranza della popolazione nel senso che Marx e Engels hanno attribuito a tale
espressione, si basa anch’esso sulla decisione della maggioranza.
A questo punto va richiamata l’attenzione su un lavoro, molto
Página 164
interessante, di Cari Schmitt-Dorotic [nota 7]. Esso tenta di esporre il concetto di
dittatura « dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria » —
come si legge nel sottotitolo del libro — da un punto di vista storico, come « concetto
centrale della dottrina costituzionale e dello Stato ». Comunque, questo concetto
sarebbe divenuto uno slogan politico a un punto tale che, proprio a partire da ciò, si
spiegherebbe l’avversione dei teorici del diritto quanto al tenerne conto. Dorotic cerca
invece di costruire il concetto di dittatura come concetto giuridico. Ciò avviene grazie a
due distinzioni molto importanti e che creano molta chiarezza. Innanzitutto, si opera
una distinzione fra dittatura e dispotismo; quindi, all’interno della prima, fra due forme
della medesima, fra la dittatura commissaria e la dittatura sovrana. Ogni dittatura, in
particolare, è caratterizzata dal fatto che essa è, invero, un mezzo eccezionale, ma,
innanzi tutto, è soltanto un mezzo per realizzare un determinato ordinamento
giuridico. Ciò esprime la differenza fra dittatura e dispotismo. « Una dittatura che non
mirasse a un obbiettivo corrispondente a un’idea normativa (però da realizzare nel
concreto), che non si prefiggesse cioè di rendersi superflua, si ridurrebbe a un
dispotismo arbitrario » 8. La dittatura nega certo anche il diritto esistente, ma non per
mettere al suo posto il puro arbitrio: essa nega il diritto esistente per portare a
compimento il diritto.
L’interna dialettica del concetto sta in questo, che la negazione riguarda proprio
quella norma che attraverso la dittatura si vuole assicurare nella realtà storico-politica.
Può aversi cioè un’opposizione fra il dominio della norma che si vuole attuare e il
metodo adottato per attuarla. Dal punto di vista della filosofia del diritto, qui è
l’essenza della dittatura, cioè nella possibilità generale di una separazione fra norme
del diritto e norme di attuazione del diritto [nota 9].
La dittatura commissaria, ora, è quella forma di attuazione eccezionale del diritto, che
è normativizzata nella costituzione esistente stessa, come del resto già il diritto statale
romano prevede che possa essere ordinata una dittatura. « Il potere assoluto del
dittatore poggia su di una autorizzazione ricevuta da un organo costituzionale
preesistente » [nota 10].
La dittatura commissaria sospende in concreto la costituzione medesima per
difenderne l’esistenza. [...] L’autonomia metodologica del problePágina 165
ma della attuazione del diritto emerge qui con la massima chiarezza [..] Di
conseguenza la dittatura è un problema di realtà concreta senza cessare con ciò di
essere anche un problema giuridico [nota 11].
Anche la dittatura sovrana è una tale forma di attuazione del diritto, che si oppone
alla situazione giuridica esistente, ma essa non vuol piú conservare questa stessa,
bensí scorge nell’insieme dell’ordinamento esistente la situazione che attraverso la sua
azione vuole eliminare. Essa « non sospende una costituzione esistente per un [ ...]
diritto costituzionale, bensí cerca di creare una costituzione, che essa considera come
la costituzione autentica » [nota 12]. Anch’essa si richiama a una costituzione, a una
norma, ma che devono essere create per la prima volta. Si potrebbe credere che,
quindi, questa forma di dittatura si sottragga a ogni trattazione giuridica; che si tratti
di una semplice questione di potere. « Le cose però si presentano diversamente se si
suppone un potere che, pur non essendo costituito in vinti di una costituzione, ha con
ogni costituzione vigente un nesso tale da apparire come potere fondante. ...] È
questo il significato del pouvoir constituant »[nota 13]. SchmittDorotié intende con ciò
la concezione, sviluppata dopo la rivoluzione francese, della sovranità popolare, della
sovranità dell’insieme solidale del popolo. La dittatura sovrana trova dunque la sua
legittimazione nell’idea giuridica, che del resto sta a fondamento di ogni costituzione
stabilita, della corrispondenza con la volontà generale. Il dittatore rimane anche in
questo caso commissario, « ma commissario diretto del popolo in virtú del potere non
costituito, ma costituente del popolo, e dunque un dittatore che detta legge anche al
suo mandante senza cessare per questo di dipenderne quanto alla propria
legittimazione » [nota 14]. Quest’analisi estremamente lucida nel libro viene illustrata
nel corso di un’esposizione rigorosamente storica e, come risultato dell’indagine, che
coincide con la nostra impostazione generale, viene sottolineato che non si può «
definire in generale la dittatura come la soppressione della democrazia » perché essa è
solo un mezzo per raggiungere uno scopo determinato [nota 15]. Al contrario mi
sembra che il concetto di dittatura sovrana possa essere chiarito nel suo autentico
significato sulla base di quanto finora ho detto riguardo alla distinzione tra le due forme
di democrazia, cos i come esso può a sua volta convalidare questa distinzione. Rispetto
alla concezione giuridica formale-positivistica di Kelsen queste analisi di ordine
concettuale sicuramente
Página 166
saranno risultate inutili. A favore di una sostanziale convergenza (che Kelsen respinge
in quanto giusnaturalistica) parla il fatto che anche Schmitt-Dorotie alla fine si rivolge
contro Kelsen,
per il quale il problema della dittatura è cosí poco un problema giuridico, quanto
un’operazione al cervello è un problema logico, coerentemente col suo formalismo
relativistico, il quale ignora che in questo caso si tratta di qualcosa di completamente
diverso, del fatto che cioè l’autorità dello Stato non può essere concepita
separatamente dal suo valore. [nota 16]
A prescindere dall’infelice paragone con l’operazione al cervello dobbiamo essere
d’accordo con l’autore. Il suo pensiero, tradotto dal modo di esprimersi
ideologicogiuridico in quello sociologico, significa che il nesso tra il « valore » dello
Stato e la sua « autorità » esige l’indicazione dei determinati contenuti concreti e
sociali i quali di volta in volta pretendono di rappresentare l’« autorità » della forma
giuridica.
La nostra interpretazione della dittatura del proletariato come « stato di eccezione »
risulta pertanto applicabile in modo non contraddittorio, dal punto di vista giuridicoformale, all’interno del concetto di democrazia sociale. Solo di recente si è divenuti
consapevoli che, per rappresentare in modo chiaro la dittatura del proletariato, bisogna
liberarsi dalla tentazione di vedere esemplificato questo concetto di dittatura nella
situazione del bolscevismo russo. Ciò che là si è chiamato dittatura del proletariato, è,
come abbiamo in precedenza dimostrato, molto lontano dall’essenza di questo
concetto, quale viene inteso dal marxismo, per il quale designa sempre un dominio di
classe, il dominio dunque della classe del proletariato, mentre in Russia neppure la
maggioranza del proletariato, ma solo una parte di esso, anzi in fondo soltanto una
cerchia ristretta di rivoluzionari decisi e che perseguono in teoria l’interesse del
proletariato, esercita, in condizioni assolutamente singolari, una dittatura sull’intera
società, vale a dire anche sul proletariato. Se si prescinde per il momento da questa
situazione che porta solo il nome di dittatura del proletariato, mentre in realtà esprime
semplicemente il terrorismo di un partito, diventa pienamente comprensibile che, fin
quando la democrazia sarà semplicemente una democrazia politica, anche il
parlamentarismo piú perfetto non escluderà una privazione dei diritti della minoranza,
anzi la legittimerà, in quanto tale democrazia si basa sulla decisione della
maggioranza. Fin quando uno Stato si trova dilaniato dai conflitti economici tra le
classi, malgrado assicuri a tutti molto democraticamente il diritto di voto, non è una
rappresentanza poPágina 167
polare, perché in esso non esiste un popolo solidale. Pertanto, anche nelle forme
dell’autodeterminazione del parlamento si compie soltanto un episodio della lotta di
classe. E la maggioranza democratica del parlamento, nello Stato di classe, esprime
sempre una volontà di potenza della classe che comanda sulla maggioranza e impone,
attraverso di essa, le sue leggi e ottiene la loro osservanza. Se Marx parla ad un certo
punto di dittatura della borghesia, ciò non prova, come ritiene Kelsen, che questo
concetto sia rivoluzionario solo sul piano terminologico, mentre in realtà sarebbe un
concetto di tipo evoluzionistico, perché la borghesia esercita questa dittatura solo
attraverso il parlamento, ma rafforza la nostra tesi, secondo la quale la democrazia e
la dittatura sono soltanto due lati di una medesima realtà. Per questo motivo anche
Marx, ad esempio, definisce la repubblica parlamentare in Francia con Luigi Bonaparte
al vertice « come un governo di aperto terrorismo di classe » [nota 17]
La dittatura e la democrazia non sono pertanto in contraddizione perché non possono
essere contrapposte l’una all’altra” [nota 18]. La dittatura è essa stessa una forma di
democrazia, vale a dire di quella politica. Si può dire soltanto: democrazia e terrorismo
sono in
Página 168
contraddizione, perché il terrorismo rappresenta sempre il potere’ di una minoranza.
Parimenti possiamo affermare che la dittatura e la democrazia sociale sono in
contraddizione, perché il dominio della maggioranza in una democrazia sociale, che si
realizza in assenza di un vitale conflitto di interessi della minoranza, non è per
l’appunto una dominazione sulla minoranza, bensí solo un deliberare a suo nome e
nella sua volontà. Questo è anche il senso delle osservazioni fatte da Lenin contro le
quali polemizza fraintendendole Kelsen (p. 98 [147 ] ): « Noi non auspichiamo
l’avvento di un ordinamento sociale in cui non venga osservato il principio della
sottomissione della minoranza alla maggioranza » [nota 19], e, alcune righe prima: «
La democrazia non s’identifica con la sottomissione della minoranza alla maggioranza
». Kelsen rileva a questo punto una contraddizione. Ma in base al contesto generale in
cui si trova inserito il brano è chiaro a che cosa Lenin intenda riferirsi: nell’ordinamento
sociale si verifica una subordinazione (Unterordnung) della minoranza, ma non una
oppressione di questa da parte della maggioranza. La democrazia sociale non si
identifica dunque con la sottomissione della minoranza, perché in essa non esistono
interessi di dominio da parte della maggioranza. In questo caso è la minoranza a
subordinarsi spontaneamente, nella democrazia politica al contrario, nello Stato,
secondo la terminologia marxista, essa viene costretta a questa subordinazione
dall’intero sistema di potere dello Stato. Ma che cosa accade, si chiede Kelsen, se la
minoranza non si subordina? Kelsen trova, ancora una volta, contraddittoria la risposta
data da Lenin, in quanto ritiene che Lenin — che avrebbe per l’appunto indicata come
necessaria questa subordinazione anche nella società futura — neghi ora,
improvvisamente, questa necessità. In particolare Lenín dice:
Ma, aspirando al socialismo, noi abbiamo la convinzione che esso si trasformerà in
comunismo, e che scomparirà quindi ogni necessità di ricorrere in generale alla
violenza contro gli uomini, alla sottomissione di un uomo a un altro, di una parte della
popolazione a un’altra, perché gli uomini si abitueranno a osservare le condizioni
elementari della convivenza sociale, senza violenza e senza sottomissione.
A questo riguardo Kelsen osserva stranamente: il che dunque significa: ci aspettiamo
un ordinamento sociale senza subordinazione (p. 99 [147]). Egli ignora completamente
la distinzione decisiva tra sottomissione (Unterwerfung) e subordinazione (Unter
ordnung), tra minoranza omogenea ed eterogenea; egli costruisce, ancora una volta,
le sue forme sociali nello spazio asfittico e indeterminato di concetti puramente formali,
per cui, com’è natuPágina 169
rale, una sottomissione è anche una subordinazione, e pertanto una società senza
sottomissione sarebbe anche senza... subordinazione: come se sottomissione e
subordinazione fossero identiche. Del resto dovremo tornare più diffusamente su
questa significativa distinzione sociologica e sulla questione della costrizione sociale in
relazione alla discussione sul presunto anarchismo della concezione marxista della
società.
Non resta ora che discutere l’obiezione secondo la quale la dittatura del proletariato,
se non è dunque più espressione di una minoranza, ma di una maggioranza, è una
cosa del tutto superflua, che viene alla fine vanificata dalla democrazia. Infatti, in base
al presupposto della democrazia come fondamento della dittatura del proletariato,
quest’ultimo si troverà a fronteggiare, in maggioranza schiacciante, un piccolo gruppo
di capitalisti, di proprietari terrieri e di parassiti di ogni genere. Non sarà quindi come
sparare con cannoni su passeri? A che servirà la repressione esercitata nei confronti di
un pugno di oppressori di un tempo diventati ormai impotenti? Sarà sufficiente
applicare le nuove leggi, contro di essi, cosí come contro ogni altro, ad esempio contro
un proletario che avrà opposto resistenza. A che scopo dunque ricorrere alla forza e a
leggi speciali contro questa piccola minoranza (pp. 16-7 e 102-3 [48-9 e 150-1 ])?
Ma una domanda del genere, e il modo di concepire che sta a suo fondamento, sono
possibili solo se si considerano appunto le cose in modo puramente formale e, quindi,
se si guarda a una distinzione soltanto numerica tra i partiti che agiranno all’interno del
nuovo ordinamento statale. In base a una tale concezione i membri sconfitti delle classi
dominanti dovranno perdere, insieme alla loro posizione di classe, anche i loro
sentimenti e i loro interessi di classe. Questa rappresentazione si connette alla visione
meccanicistica che attribuisce un ruolo determinante all’economia e che già nel capitolo
sul concetto di classe abbiamo dovuto respingere. Se ripensiamo a come in
quell’occasione abbiamo riconosciuto che all’essenza di una classe appartiene il fattore
ideologico della sua coscienza di classe, diventa senz’altro chiaro che una classe non
cessa di esistere per il solo fatto che le condizioni economiche, che hanno presieduto
alla sua nascita e alla sua esistenza, sono state eliminate. Fino a quando esisteranno
membri di questa classe i quali abbiano la volontà di ripristinarla e i quali nel loro modo
di essere spirituale e volontario esprimano l’interesse di conservare la loro posizione di
classe e perfino si preoccupino di diffondere questa volontà e questo interesse, di fare
propaganda presso i coetanei, e di educare i giovani a ciò, fino a quel momento ci sarà
ancora questa classe e continueranno ad esistere conflitti di classe. E una tale
conflittualità è tanto più periPágina 170
colosa in quanto, nonostante il proletariato abbia la maggioranza, non può costruire in
un sol colpo la società socialista, ma in diverse sfere della organizzazione economica,
politica, religiosa e culturale ancora per molto tempo dovranno essere trascinati
importanti residui delle precedenti condizioni di vita, che potranno costituire altrettanti
punti di partenza di una reazione di classe. A tale riguardo, già nel 1905, contro coloro
che trovavano insolito il ricorso alla violenza nei confronti di una minoranza, Lenin
scriveva: « Essi si sbagliano perché non prendono in considerazione questo fenomeno
nel suo sviluppo. Dimenticano che il nuovo potere non cade dal cielo, ma sorge, si
evolve accanto, contro l’antico potere, in lotta contro di esso » [nota 20] In breve,
costoro ignorano che le pure forme della democrazia non dicono nulla circa il loro
contenuto. Contro una minoranza che si trova anch’essa sul terreno della classe
dominante, il cui dominio si propone di esercitare soltanto in modo diverso, e del
potere della quale aspira ad essere maggiormente partecipe, non è necessaria nessuna
repressione, sebbene anche ciò sia spesso accaduto. Ma non appena la minoranza mira
a rovesciare lo stesso dominio di classe, la sua impotenza momentanea non è un buon
motivo per risparmiarla. perché diversamente le sarebbe fornita l’occasione per attirare
a sé un potere pii! ampio. Ancora una volta, vediamo quanto risulti dannoso, in una
critica sociologica dei concetti marxisti, trascurare la distinzione tra classe e partito,
che sicuramente non viene presa in considerazione a livello giuridico. La dittatura del
proletariato è il potere di una classe contro l’altra, non contro un partito, un potere che
non dev’essere perseguito semplicemente fino alla detronizzazione di questa classe,
ma fino al suo annientamento, perché solo a partire da ciò è possibile una società
senza classi. A questo punto parlare di un pugno di uomini e stupirsi per il fatto che
contro di essi è necessario il ricorso alla violenza (Gewalt), ha lo stesso significato che
se ci si stupisse che nell’ottobre 1921 l’Europa centrale si sia trasformata in un
deposito bellico contro un pugno di carlísti. L’intera questione diventerà un problema
solo per un rappresentante della democrazia, o, piú precisamente, per un burocrate
della democrazia, il quale nel suo ufficio di registrazione non abbia alcuno schedario
per la realtà storica.
I teorici bolscevichi nei loro scritti e discorsi hanno sviluppato, con grande precisione,
il senso specifico della dittatura del proletariato, concepita come potere di classe. Su
questo punto essi non si sbagliano affatto per quanto riguarda il lato teorico, rispetto al
quale al contrario hanno messo in luce molte cose che si erano dileguate dalla
coscienza di parecchi marxisti, ma hanno fatto una
Página 171
errata applicazione di questa teoria alla propria politica. t indubbiamente il segno di un
errore fatale scrivere, come fanno nella nona delle Tesi sulla rivoluzione sociale:
Finora si è insegnata la necessità della dittatura del proletariato senza avere indagato
la forma di questa dittatura. La rivoluzione socialista russa ha scoperto questa forma; è
la forma della repubblica dei Soviet, concepita come forma duratura di dittatura del
proletariato e (in Russia) dello strato piú povero dei contadini. [nota 21]
Già l’inclusione « in Russia » dei contadini piú poveri prova che in questo caso non è
piú possibile parlare di dittatura del proletariato. E la storia interna della repubblica dei
soviet, con la sua terribile lotta all’ultimo sangue contro i contadini e con la
capitolazione finale del comunismo davanti a essi, dimostra che non è il caso di parlare
di una solidarietà di interessi tra queste classi, la quale sarebbe la sola a poter basare
la dittatura sulla maggioranza della popolazione. Ciò che resta è la dittatura del
governo centrale moscovita. Ma nonostante la mortale contraddizione esistente nel
bolscevismo tra la teoria e la prassi, che ha avuto per conseguenza in Russia il declino
graduale della ‘dittatura’ economica e politica ‘del proletariato’ [nota 22], la decima
tesi esprime sul piano concettuale in modo eccellente il carattere della dittatura del
proletariato come un potere che, anche all’interno della democrazia, rimane nella sua
essenza sempre il potere di una classe contro un’altra. Ivi si legge:
Il senso della dittatura del proletariato consiste, per cosí dire, nello stato di guerra
permanente contro la borghesia. t dunque evidente che tutti coloro che si lamentano
per le azioni violente dei comunisti, dimenticano completamente che cosa significhi
effettivamente una dittatura. La rivoluzione stessa è un atto di rozza violenza ’. La
parola dittatura in tutte le lingue non significa niente altro che un regime di violenza.
L’importante è qui il contenuto di classe della violenza. In tal modo viene fornita la
giustificazione storica della violenza rivoluzionaria. [nota 23]
A questo punto vorrei aggiungere un’osservazione che si riferisce a una distinzione
fatta da Kautsky riguardo al concetto di dittatura. Egli distingue tra la dittatura come
forma di governo e come circostanza (Zustand), e in base a ciò ritiene che solo la
prima possa essere oggetto di una controversia. Infatti che il proletariato, nel
Página 172
passaggio dalla società capitalistica a quella socialista, dovrà dare vita
provvisoriamente a una circostanza di dittatura, è anche per lui un dato indiscutibile
[nota 24]. Soltanto mi sembra che questa differenziazione non sia complessivamente
molto intellegibile, e che possa condurre piuttosto a un inevitabile fraintendimento
circa il concetto di dittatura. Ciò che evidentemente Kautsky pensa è che bisogna
guardarsi dal concepire la dittatura del proletariato come una forma durevole della
società socialista e non piuttosto come una circostanza di transizione, momentanea.
Questo pensieto non è espresso in modo appropriato attraverso la contrapposizione tra
i concetti di circostanza e forma di governo. Infatti, com’è ovvio, la semplice
circostanza della dittatura del proletariato, sebbene sia e debba essere qualcosa di
momentaneo, tuttavia, nel corso della sua durata è necessariamente una forma di
governo, vale a dire appunto il dominio del proletariato, lo Stato proletario. E, inoltre,
la durata della fase di transizione non può essere valutata in anticipo, né riguarda la
trattazione teorica della dittatura. La transizione può durare anni o decenni, ma
teoricamente è una fase transitoria, il che non va preso semplicemente nel senso che
‘tutto passa’, ma nell’accezione specificamente marxista, in base alla quale il suo
superamento, il suo declino sistematico, è qui lo scopo consapevole dell’attività di
governo del proletariato. Ma, proprio in base a ciò, nel quadro di quest’attività, essa si
pone come una ’circostanza durevole, che va mantenuta in modo permanente fino a
quando l’obiettivo non sia stato raggiunto. Se dunque Kautsky polemizza contro le
Tesi sulla rivoluzione sociale, precedentemente citate, perché parlano di una «
dittatura durevole », di uno « stato di guerra permanente » e, per quanto riguarda la
dittatura, affermano addirittura (nella nona tesi): « Qui non si può parlare di un
fenomeno transitorio nel senso ristretto del termine, ma della forma dello Stato che
s’impone nel corso di un’intera epoca storica » [nota 25], la sua polemica può colpire
solo l’identificazione, proposta dai bolscevichi, della costituzione dei soviet con la
dittatura del proletariato e forse solo questo è il suo obbiettivo. Ma sussiste il pericolo
che questa critica delle tesi, piú volte citate, venga riferita anche al concetto della
dittatura stessa, e per questo occorre bensí dire che — una volta svincolato il suo
contenuto dalla sua applicazione alla Russia — va considerata come un’eccellente
caratterizzazione di ciò che Marx ed Engels hanno inteso con la dittatura del
proletariato. Non vi può essere alcun dubbio sul fatto che la dittatura dovrà durare
lungo un’intera epoca storica, vale a dire durante la fase di pasPágina 173
saggio dalla società capitalistica a quella socialis di essa manterrà in piedi una forma di
governo, quella dello Stato proletario, attraverso la quale alimenterà — sul fondamento
della democrazia, piú precisamente della democrazia politica, anzi come suo sbocco —,
uno stato di guerra permanente contro la borghesia. In tal senso si risolve dal nostro
punto di vista il tormentato problema del rapporto tra dittatura e democrazia. La
dittatura del proletariato è possibile solo all’interno della democrazia, il che vuol dire
sorretta dalla maggioranza della popolazione, ma essa giunge a compimento soltanto
attraverso la democrazia ed esercita il potere in quanto democrazia. Una
contraddizione continua a sussistere solo per colui che pensa alla democrazia sociale,
all’interno della quale indubbiamente la dittatura è impossibile, ma che non esiste
ancora, le cui condizioni devono essere appunto create dalla dittatura del proletariato.
Se la democrazia sociale è un regno celeste, come i nostri avversari affermano in tono
di derisione, — di questo argomento torneremo a discutere — è inutile in ogni caso,
fino a quando restiamo sulla terra della democrazia politica, chiedere di essere
partecipi dei suoi benefici.
Página 174
Capitolo quattordicesimo
Governo e amministrazione
La critica ‘immanente’ del concetto marxista di Stato, coi quale Kelsen vuole mettere
in luce la contraddizione interi questo concetto, sembra però trovare il suo compimento
soli nella dimostrazione che la teoria politica marxista della sop sione del dominio di
classe e dello Stato conduce a un’ass autonegazione. Dal suo punto di vista non vi è
alcun dubbio i teorici marxisti, nella loro terminologia che si limita a una negazione
dello Stato, non si rendono affatto conto che tutt argomenti, che essi adducono contro
lo Stato, sono in grad formularli solo attraverso concetti statali. In tal senso K vuole
presentarci la dottrina marxista della « estinzione dello to » come una sorta di farsa,
nella quale con grande frago Stato viene condannato a morte, mentre già si aggira
inton suoi mortali nemici, lieto nella sua nuova condizione. E noi n sti sembriamo una
riedizione del buon semplicione della comf di Molière che non finiva di stupirsi quando
gli venne dem per tutta la vita aveva parlato in prosa: mentre con rabbi devamo di
‘sopprimere’ lo Stato non abbiamo fatto altro la vita, e proprio attraverso questa
‘soppressione’, che lavorare a favore dello Stato.
La spiegazione di questa opinione sulla ridicola contradd esistente nel marxismo,
proprio nel suo pensiero centrale, in quello della soppressione dello Stato, va
individuata nello stesso luogo in cui abbiamo già visto profilarsi le altre fonti di
fraintendimento e di incomprensione da parte della critica giuridica nel fatto che i
concetti con cui opera sono appunto diversi dai nostri e quindi anche termini,
apparentemente identici, hanno un contenuto radicalmente differente. Una critica del
genere è destinata a restare sterile, anzi a riuscire addirittura dannosa. In primo luogo
impedisce al critico la comprensione del suo oggetto e quindi getta in uno stato di
irrimediabile confusione tutti coloro che non
Página 175
sono in condizione di riconoscere la diversità dei punti di parteni da cui muovono il
critico e ciò che viene criticato. Con un’uni osservazione possiamo mettere in luce tutto
il lato tragicomic della critica che viene qui rivolta alla dottrina marxista dello Stato: la
soppressione dello Stato, di cui parlano Marx ed Engel riguarda lo Stato di classe,
quella di cui parla Kelsen, lo Stato in generale. Per questo motivo, se Marx ed Engels
hanno ragionl non gli rimane piú niente, e la concezione marxiana conduce, sl condo
Kelsen, difilato ll’anarchismo. La critica kelseniana mucn da un’equazione, pienamente
giustificata sul piano formale-giur dico — in un orizzonte quindi ancora una volta
limitato — m che non ha alcun significato a livello sociologico. L’equazione e questa:
Stato = organizzazione costrittiva. Da ciò scaturisce che per lui la soppressione dello
Stato coincide con la soppressione dell’organizzazione costrittiva. Se pertanto può
dimostrare che anche la società socialista dovrà disporre di un’organizzazione
confluiva, che anche in essa ci saranno un governo, delle funzioni politiche, organi
pubblici, sistemi per regolare l’economia, in breve tutta una rete organizzativa che
dovrà reggersi sulla costridone predisposta contro gli oppositori -- a meno che non si
lebba produrre l’interruzione di ogni progresso sociale — in tal nodo il marxismo è
confutato e si prova che la sua teoria dello ;tato è un controsenso, una vera assurdità.
In una tale polemica ion si prende in considerazione il fatto che il marxismo col
con’etto di Stato intende riferirsi solo a una determinata forma stoica di organizzazione
costrittiva, cosí come si ignora che Porgalizzazione costrittiva, che continuerà a
esistere dopo la soppressione li quella forma storica di Stato, sarà sul piano culturale e
psicoociologico, ma in particolare su quello sociologico, qualcosa di otalmente diverso.
Per Kelsen organizzazione costrittiva è a aganizzazione costrittiva. Che cosa venga
ottenuto con la forza, chi l’ottenga, in che modo venga ottenuto, non ha assolutamente
importanza; non è all’altezza dei concetti giuridici e può solo offuscare la purezza del
pensiero giuridico [nota 1].
Página 176
Con la individuazione dell’equivoco relativo al concetto di Stato, che sta a fondamento
di tutta la critica kelseniana e rende di fatto possibile il suo effetto principale, lo
smascheramento della tendenza anarchica del concetto marxista di Stato, è diventato
invero superfluo soffermarsi ulteriormente su questa parte del libro. Se ciò in seguito
nondimeno è accaduto, e perfino con una certa ampiezza, non è stato solo perché si
tratta del pensiero fondamentale e specifico della critica kelseniana, al quale occorre
rivolgere con insistenza la nostra attenzione, come all’obietitvo di tutta la sua indagine.
Non sarebbe affatto necessario per noi occuparci ancora di esso, una volta chiarita
l’inesattezza del suo punto di partenza. Ma ciò può avere degli effetti positivi, se,
ripercorrendo questa via sbagliata, attraverso l’inevitabile ignoranza che essa
manifesta nei confronti del contenuto specifico dei concetti marxiani, riacquistiamo una
chiara consapevolezza della specificità del metodo sociologico e vediamo riconfermata
l’insufficienza della critica giuridica nei suoi confronti.
Kelsen individua nella dottrina marxista della distruzione dello Stato, della sua
soppressione attraverso l’eliminazione dei conflitti di classe, non solo un contenuto
fortemente contraddittorio, ma persino una spiccata tendenza all’anarchismo. Per
questo motivo intitola il par. 9: L’ideale anarchico del comunismo (p. 44 [par.10, p.
841), parla ripetutamente di un fondamentale orientamento individualistico del
pensiero di Marx ed Engels (pp. 26 e 42 [57 e 78]) e ritiene perfino che non si possa
parlare di un conflitto teorico tra socialismo e anarchismo (p. 43 [82-3]). Questa
direzione di pensiero individualistica viene a trovarsi per giunta — secondo Kelsen — in
un contrasto molto stridente rispetto alla presentazione economica della società
socialista la quale non sarebbe affatto possibile senza una straordinaria
regolamentazione della vita economica. Sembra esserci una certa ironia nel fatto che
Engels da un lato individui nell’anarchia dello Stato di classe la radice dello
sfruttamento, dall’altro annunci « in un sol tratto » nella comunità comunista la
liberazione dallo sfruttamento, sebbene essa, non essendo piú uno Stato, non
conoscendo quindi
Página 177
nessuna forma di costrizione, si costruisca comunque sull’anarchia della produzione (p.
53 [92]). Già il Manifesto dei comunisti crede di poter rinunciare all’ordine costrittivo
dello Stato. Esso insegna — secondo Kelsen — che con la soppressione delle differenze
di classe ogni produzione viene a concentrarsi nelle mani degli individui associati e il
potere pubblico perde il suo carattere politico (p. 13 [43]). Con ciò non si afferma
soltanto che il potere pubblico viene a perdere il suo carattere di dominio di classe, pur
continuando a esistere in quanto tale. Ma, nella misura in cui il Manifesto designa come
meta la sostituzione della società classista attraverso « una associazione, in cui il libero
sviluppo di ognuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti », esso mira — secondo
Kelsen — alla fine del potere pubblico in generale. Infatti il carattere di questa
associazione può essere interpretato per lui solo nel modo seguente: « Una libera
associazione, in opposizione a una organizzazione costrittiva, a una organizzazione di
dominio, al sistema di un potere pubblico, in breve: a uno Stato» (p. 17 [48]).
Per ora fermiamoci qui. È utile dipanare immediatamente l’equivoco di cui rischiamo
di essere vittime insieme al critico; dopo aver visto in un’altra occasione come Kelsen
identificasse ordinamento costrittivo e Stato, emerge ora che egli identifica
quest’ultimo anche con un ordinamento di dominio, in quanto per lui il termine dominio
è solo un elemento giuridico, cioè puramente formale. Noi al contrario distinguiamo tra
dominio e amministrazione, gestione degli affari (Geschdftsleitung), come abbiamo già
dovuto fare nel corso della discussione sul concetto di democrazia. Adoperiamo il
termine dominio solo dove sussistono importanti conflitti di interesse, in una forma tale
che alla volontà vitale degli uni può essere imposta la volontà contrapposta degli altri.
Solo nel caso in cui un’organizzazione costrittiva racchiuda una tale eterogeneità tra i
membri che stanno in essa, si trasforma in dominio, nella eteronomia di coloro che
esercitano l’ordinamento costrittivo rispetto a coloro che sono assoggettati. Qui
l’ordinamento costrittivo risponde, pertanto, sempre all’interesse specifico di un gruppo
appartenente alla comunità. Nell’ipotesi in cui viceversa esista una omogeneità di
interessi vitali, come accade in assenza di conflitti economici tra le classi,
l’ordinamento costrittivo si trasforma nell’autonomia di coloro che stanno in essa:
esprime il loro interesse comune e sta al servizio di tutti. Indubbiamente in ambedue i
casi ogni singolo è assoggettato al dominio dell’ordinamento costrittivo, ma non è
assoggettato tutt’e due le volte allo stesso modo, la differenza decisiva consiste nel
fatto che l’ordinamento costrittivo in un caso si configura in termini di dominio,
nell’altro appare come libertà. Questa differenza noi marxisti la esprimiamo, riservando
il
Página 178
concetto di Stato alla prima forma di organizzazione costrittiva, e adoperando un
termine preferibilmente diverso da quello di Stato per la seconda forma, per
evidenziare in essa la radicale trasformazione della funzione della organizzazione
costrittiva. Non si parla dunque per niente del fatto che la società comunista, per il solo
fatto che non è più uno Stato, sarebbe anche priva di costrizione. La soppressione dello
Stato esprime appunto in Marx qualcosa di diverso che in Kelsen, perché ciò di cui
parla Marx non è ‘lo Stato in sé’, bensí lo Stato di classe, e sotto questo aspetto, sia
dello Stato capitalistico sia di quello proletario di classe. Sulla distinzione tra
omogeneità ed eterogeneità degli interessi vitali si appuntava, come sappiamo, la
stessa differenza tra democrazia politica e democrazia sociale, vale a dire tra
democrazia apparente e democrazia reale. Abbiamo anche visto come la democrazia
reale è possibile solo dopo il superamento dello Stato di classe, vale a dire anche di
quello proletario. Se pertanto Kelsen afferma ad un certo punto in tono di derisione che
una democrazia reale non è, in base alla concezione marxista, uno Stato (p. 42 [78] ),
(vale a dire uno Stato di classe), con questa proposizione, assolutamente esatta, ma
da lui ritenuta un’assurdità, testimonia semplicemente come la particolare terminologia
che egli adopera sia destinata a girare a vuoto in un circolo infinito intorno al
significato dei concetti marxisti.
Non può accadere niente di diverso se si definisce, come fa Kelsen, il pensiero
fondamentale, che risale a Saint-Simon, della trasformazione del governo, da un
dominio su persone in un’amministrazione di cose, come una rappresentazione, « la cui
apparenza seducente non può celare, ad un esame più approfondito, l’intima
insostenibilità » (p. 54 [96]). Siamo ansiosi di scoprire in che cosa debba risiedere
l’intima insostenibilità di un pensiero che l’intera storia teorica del socialismo moderno
ha trattato come una tra le nozioni più significative e stimolanti. La risposta è
stupefacente: tutto il contrasto tra una amministrazione di cose e un governo di uomini
è soltanto’ apparente. Infatti per Kelsen
non vi è alcuna amministrazione di cose, che non sia un’amministrazione di uomini,
cioè la determinazione di una volontà umana da parte di un’altra; non vi è alcuna
guida di processi produttivi, che non sia governo su delle persone, cioè motivazione di
una volontà umana da parte di un’altra (p. 55 [97]).
Innanzi tutto, abbiamo qui la riprova che invece di stabilire delle concrete distinzioni,
si continua a giocare con le parole, come veniva fatto sin dall’inizio con l’ambiguità
prodotta tra i termini kelseniani di Stato e dominio. Non resta che chiamare governo la
direzione dei processi produttivi e immediatamente ci troveremo
Página 179
di fronte a « una medesima realtà » che, come governo, dovremc incontrare ad
esempio nella Russia zarista, nella Germania gugliel mina, nell’Inghilterra e nella
Francia dell’imperialismo e nella società socialista. Ovunque ci imbattiamo — come si
dice? — nella « motivazione di una volontà umana ad opera di un’altra » In questo
modo sicuramente ogni distinzione tra governo e amministrazione viene superata ’
attraverso la vuotezza di un concetto formale che si adatta ad ogni convivenza umana.
Ma pet ,ancorare più saldamente la confutazione della distinzione tra ur governo su
uomini e un’amministrazione di cose, non è sufficiente a Kelsen il fraintendimento
formale-giuridico; deve mettere in gioco anche l’equivoco materialistico del marxismo.
Per Kelsen la differenziazione tra un governo su uomini e una amministrazione di
cose ha nel complesso le sue radici più profonde nel materialismo economico. Nella
misura in cui cioè
l’economia diviene, per il marxismo, un processo impersonale di produzione, un
movimento di « forze produttive » e di « rapporti di produzione » ipostatizzati, essa si
libera — in questa astrazione condensata in una realtà fittizia — dagli uomini e dalle
loro relazioni di motivazioni, cioè dalle loro relazioni di dominio, che, in quanto sistema
politico, in quanto diritto e Stato, apparentemente conducono un’esistenza separata.
E invece Kelsen crede di dover insegnare a noi marxisti: «Le cose e i processi
produttivi non si adattano, in quanto tali, all’ordinamento economico. Suo oggetto sono
soltanto le volizioni e gli atteggiamenti umani » ,(p. 55 [97]).
In nessun luogo affiora più chiaramente di qui che la critica kelseniana del marxismo
non è penetrata nello spirito di questa dottrina, ma ritiene di poter lavorare solo su
singole citazioni, sebbene numerose, le quali del resto sono rimaste per essa un
possesso del tutto frammentario. Diversamente infatti non le poteva sfuggire che
proprio ciò rispetto a cui pretende di fornire degli insegnamenti al marxismo,
rappresenta il punto nodale e l’ele mento teorico decisivo dell’opera di Marx.
Appartiene ai pensieri fondanti dell’analisi del processo di produzione capitalistico ciò
che Marx sintetizza nel famoso capitolo sul « carattere feticistico della merce » del
primo libro del Capitale. Proprio ciò che Kelsen rimprovera al marxismo come una
ipostatizzazione ’ del processo produttivo e dei rapporti di produzione, viene chiamato
da Marx il carattere feticistico dei processi economici all’interno dell’economia
capitalistica, perché essi simulano una indipendenza oggettiva, e le relazioni sociali tra
gli agenti della produzione, tra gli uomini che stanno dietro di esse, si rivelano come il
suo segreto.
Página 180
L’arcano della forma di merce consiste dunque, semplicemente nel fatto che tale
forma, come uno specchio, restituisce agli uomini la immagine dei caratteri sociali del
loro proprio lavoro, facendoli apparire come caratteri oggettivi dei prodotti di quel
lavoro, come proprietà sociali di quelle cose, e quindi restituisce anche l’immagine del
rapporto sociale tra produttori e lavoro complessivo, facendolo apparire come un
rapporto sociale tra oggetti esistente al di fuori di essi produttori. [...] Quel che qui
assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il
rapporto sociale determinato che esiste fra gli uomini stessi. [nota 2]
Già nel saggio popolare Lavoro salariato e capitale si può trovare attuata, in forma
più concisa e tuttavia magistrale, la dissoluzione dell’apparenza oggettiva del modo di
produzione capitalistico. E, a proposito dei rapporti di produzione ivi si dice: « Per
produrre, essi [gli uomini] entrano gli uni con gli altri in determinati legami e rapporti,
e ...] la produzione ha luogo soltanto nel quadro di questi legami e rapporti sociali ». E,
come la produzione stessa può essere compresa soltanto come processo di natura
umana, ma sociale, cosí anche i mezzi di produzione non sono affatto semplici ‘cose’.
I mezzi di sussistenza, gli strumenti di lavoro, le materie prime di cui il capitale è
costituito, non furono essi prodotti e accumulati in determinate condizioni sociali, in
determinati rapporti sociali?
Il capitale non è dunque soltanto una somma di prodotti materiali; esso è una
somma di merci, di valori di scambio, di grandezze sociali. E...] Soltanto il dominio del
lavoro accumulato, passato, materializzato, sul lavoro immediato, vivente, fa del
lavoro accumulato capitale. [nota 3]
A questo punto non è più possibile soffermarsi ulteriormente sul modo in cui l’analisi
economica di Marx dissolve il feticismo dei rapporti economici del mondo borghese,
operazione che Kelsen chiama l’astrazione condensata in una realtà fittizia. Marx
dimostra come il modo di produzione capitalistico costringa ogni lavoro sociale ad
apparire al suo interno come un lavoro privato e come, per questo motivo, il nesso
sociale specifico della produzione debba rimanere celato sia ai capitalisti che agli
operai. Attraverso i concetti di lavoro sociale e di valore di scambio, l’ultimo dei quali
manifesta e al tempo stesso nasconde la natura sociale del lavoro,
Página 181
l’analisi economica marxiana attua la soppressione del carattere fantasmagorico di una
vita indipendente dei fenomeni economici e, lungi dal separare í rapporti di produzione
e le forze produttive dall’uomo, conduce entrambi in una relazione molto stretta, che
dev’essere caratterizzata in modo preciso, con l’agire e l’essere motivato dell’uomo.
Solo grazie alla motivazione economica le ‘cose’ ottengono nel processo di produzione
la loro efficacia in quanto forze produttive e rapporti di produzione.
Una macchina filatrice di cotone è una macchina per filare il cotone. Soltanto in
determinate condizioni essa diventa capitale. Sottratta a queste condizioni essa non è
capitale, allo stesso modo che l’oro in sé e per sé non è denaro e lo zucchero non è il
prezzo dello zucchero. [nota 4]
Ma si dovrebbe trascrivere l’intero Capitale per ovviare agli equivoci che si trovano
nella critica di Kelsen. Rispetto al nostro obiettivo i riferimenti già forniti sono
sufficienti a evidenziare come il modo di pensare di Kelsen si lasci sfuggire nel suo
complesso quello di Marx ed Engels. A questo punto risulta chiaro che per il marxismo
la distinzione tra governo e amministrazione è cosí importante, proprio in quanto non
gli può essere addebitato di inostatizzare i rapporti economici, che al contrario
contribuisce a dissolvere. Viene dimostrato che questa ipostatizzazione è un’illusione
necessaria nella società borghese di classe, la quale, dietro la condizione impersonale e
anarchica dell’economia, in ciò molto simile a uno stato di natura, occulta il carattere
umano e sociale dei fenomeni economici. Al contrario, con l’eliminazione di questa
anarchia, vale a dire con la subordinazione della produzione al controllo della società,
sparirà sempre piti anche l’apparente naturalità della produzione ed emergerà il suo
carattere umano e sociale. Si passerà in misura crescente da un processo che domina
gli uomini a un processo che viene dominato da essi. Ciò potrà attuarsi pienamente
però soltanto attraverso la soppressione dei conflitti di classe e la organizzazione
conforme a un piano della produzione, collocandosi dal punto di vista del fabbisogno
della totalità. Allora sparirà anche l’ultima categoria, apparentemente contraddittoria, il
valore di scambio, al posto del quale subentreranno la valutazione e la distribuzione
sociali. La produzione si sarà trasformata completamente da uno strumento col quale
una parte della società domina le altre, in un processo attraverso il quale la totalità
sociale conserva e soddisfa se stessa. Questo pensiero è formulato da Engels nel brano
citato anche da Kelsen, nel quale si dice che Saint-Simon ha anticipato a livello di
pensiero
Página 182
la totale conversione della politica in economia, e viene sin tetizzato in un altro brano
con le parole famose:
L’organizzazione in società (Vergesellschaftung) propria degli uomini, che sinora
stava loro di fronte come una legge elargita dalla natura e dalla storia, diventa ora loro
propria libera azione. Le forze obiettive ed estranee che sinora hanno dominato la
storia passano sotto il controllo degli uomini stessi. Solo da questo momento gli uomini
stessi faranno con piena coscienza la loro storia, solo da questo momento le cause
sociali da loro poste in azione avranno prevalentemente, e in misura sempre crescente,
anche gli effetti che essi hanno voluto. t questo il salto dell’umanità dal regno della
necessità al regno della libertà. [nota 5]
Com’è naturale anche il marxismo non mette in dubbio un istante quanto Kelsen
ritiene di dover obiettare contro di esso, e cioè che « un dominio della natura da parte
degli uomini non è possibile senza un dominio degli uomini su stessi, senza, cioè, la
subordinazione a un ordinamento umano » (pp. 55-6 [98]). Al contrario Marx ed
Engels ci hanno insegnato a vedere proprio nella sfera economica, che è poi una sfera
sociale, l’ambiente attraverso il quale per la prima volta diviene possibile una forma di
dominazione della natura. Ma ciò che conta è per l’appunto questo ambiente
economico, o, per esprimerci nel linguaggio di Kelsen, il tipo « di subordinazione degli
uomini a un ordinamento umano ». Kelsen stesso dev’essere consapevole che non
tutte le forme di subordinazione sono equivalenti, in quanto aggiunge incidentalmente
una frase che, dal suo punto di vista, appare marginale: « II dominio ’ dell’uomo non
dev’essere naturalmente un asservimento ’ basato sullo sfruttamento » (p. 56 [98]).
Anche qui la critica di Kelsen nel suo complesso si insabbia in concetti del tutto formali.
La « subordinazione » degli uomini a un ordinamento umano per lui comprende sia
l’amministrazione di un’economia collettiva, sia l’asservimento basato sullo
sfruttamento, ambedue le cose sono per Kelsen « dominazione », e in questo modo di
vedere, che rinuncia a ogni caratterizzazione sociologica, sicuramente la distinzione tra
un governo su uomini e un’amministrazione di cose deve ridursi a un pensiero « privo
di consistenza interna ». Infatti in questo vuoto concettuale, corrispondente a una «
dominazione di uomini » assolutamente indeterminata, non esiste effettivamente
nessun punto stabile che possa fornire un appiglio.
A rendere pii difficile la soluzione degli equivoci di una teoria si aggiunge il fatto che
esiste una logica propria degli equivoci,
Página 183
attraverso la quale dai suoi errori si sviluppa un sistema nella cui interna coerenza il
fraintendimento iniziale si consolida in un modo tanto piú stringente in quanto, grazie
alla logica delle conclusioni, ci si illude riguardo alla erroneità del punto di partenza. In
questa occasione abbiamo visto infatti come l’inesattezza nella interpretazione del
significato del concetto di Stato in Marx risulti confermata e rafforzata dalla falsa teoria
circa una presunta ipostatizzazione dei processi economici e politici — un modo di
vedere che per un marxista è assolutamente inconcepibile, perché ogni processo
economico è per lui contemporaneamente un fenomeno riguardante la vita giuridica e
statale, e proprio nel marxismo ogni processo economico ha la sua sovrastruttura
ideologica. Ora questa strana interpretazione del marxismo si rafforza ulteriormente in
Kelsen attraverso la conclusione, che per lui naturalmente sembra scaturita dallo stato
reale delle cose, mentre è solo il prodotto dei suoi errori, secondo la quale nella
ipostatiz zazione dell’economia si trova « la radice teorica della scissione, così
caratteristica del marxismo, tra teoria politica e teoria economica ». In questa
prospettiva ambedue le teorie devono alla fine sfociare in quella contrapposizione
secondo la quale « la dottrina economica di Marx conduce a una rigida organizzazione
dell’economia, collettivistico-centralizzata — cioè, però, conduce tuttavia agli uomini
che fanno economia; mentre la dottrina politica, evidentemente, aspira a un ideale
anarchico-individualistico » (p. 55 [97-8]). Questa conclusione è esatta quanto lo sono
le premesse: la contraddizione tra ciò che Kelsen chiama teoria economica e teoria
politica del marxismo si fonda unicamente su una comprensione assolutamente
inadeguata, che Kelsen rivela, in generale, circa la teoria economica marxista e in
particolare circa la concezione materialistica della storia, come avevamo avuto modo di
constatare già a sufficienza. Non modifica granché la situazione il fatto che Kelsen si
sia richiamato nella sua interpretazione a un’opinione comune, diffusa sicuramente solo
presso gli studiosi borghesi, riguardo al ‘materialismo’ economico in Marx ed Engels.
Ciò dimostra soltanto che il marxismo viene criticato molto pitl di quanto non sia capito
e che si crede sempre che, in base a un numero oiuttosto esteso di citazioni tratte
dalle opere di Marx ed Engels, ci si possa risparmiare lo studio della loro dottrina nel
suo insieme.
Per quanto riguarda l’opinione, sostenuta ancora pi ú frequentemente da Kelsen nel
suo libro, riguardo alla contraddizione esistente in Marx ed Engels tra un collettivismo
economico e un anarchismo politico — un pensiero questo che non costituisce solo
un’osservazione casuale, bensí il risultato specifico in cui deve sfociare la critica
kelseniana — bisogna dire che un tale esito
Página 184
è divenuto possibile non solo attraverso i fraintendimenti cui si è accennato circa
l’analisi economica e la concezione materialistica della storia in Marx ed Engels; a ciò si
aggiunge però anche una rappresentazione non molto chiara del contrasto specifico
esistente tra socialismo e anarchismo. Solo cosi Kelsen poteva far russare il concetto
marxista di libertà come ‘anarchico’. Poiché a tale riguardo neppure tra i socialisti
regna la dovuta chiarezza, vogliamo fornire la possibilità di una valutazione piú
approfondita di questo problema [nota 6].
Página 185
Capitolo quindicesimo
Excursus sull’anarchismo
1. La negazione della costrizione, della legge e dell’autorità
Che l’anarchismo non sia equivalente a una dottrina dell’assoluta mancanza di ordine
e di totale arbitrio viene oggi comunemente riconosciuto anche dalla critica dotta
avversaria. Una testimonianza particolarmente significativa di come una tale veduta
non sempre sia esistita, e di come ancora oggi non sia del tutto bandita una certa
opinione popolare borghese, la quale vede nell’anarchismo semplicemente la
soppressione di ogni ordinamento, ci viene fornita da Karl Diehl, che nelle sue lezioni
molto utilizzate su Sozialismus, Kommunismus una’ Anarchismus ritiene necessario
respingere esplicitamente l’opinione secondo la quale « l’anarchismo rappresenta solo
una setta di criminali, priva di ogni programma politico e sociale »
[Nota 1] Ma, in generale, a partire dallo scritto di Stammler [Nota 2], che ha esercitato
un influsso molto profondo sul giudizio relativo all’anarchismo, si ammette che anche
l’anarchismo sia una dottrina dell’ordinamento sociale, solo tale da escludere la
costrizione e da fondarsi sulla semplice convinzione. Se questa distinzione abbia una
qualche validità dovrà essere stabilito in seguito. Ma se è una constatazione indiscussa
che anche l’anarchismo è una dottrina dell’ordinamento sociale, ad essa generalmente
si accompagna la rappresentazione, secondo la quale l’anarchismo comunque nega la
costrizione. E, nella misura in cui non si ha una rappresentazione chiara di che cosa
significhi questo rifiuto della costrizione, per cui non si solleva affatto la domanda
intorno al genere di costrizione che l’anarchismo rifiuta, se cioè il concetto,
Página 186
di costrizione non sia in questo caso qualcosa di specifico, che non viene caratterizzato
in modo sufficientemente chiaro dal termine costrizione, sorge quella confusione nel
modo di vedere, a causa della quale il concetto di anarchismo deve alla fine apparire
nuovamente come un concetto pienamente contraddittorio. Infatti non si può pensare
da ultimo un ordinamento senza costrizione messa in atto contro la minaccia di
disordine. Il rifiuto, pertanto, di ogni costrizione mette in dubbio la serietà della volontà
di instaurare un ordinamento anche nella società anarchica. E sicuramente questa
contraddizione è molto diffusa anche nella propaganda popolare dell’anarchismo, ché in
generale, anzi, l’approfondimento rigoroso dei suoi concetti e delle sue intuizioni non è
tra le virtú dell’anarchismo.
Ciononostante è vero che anche l’anarchismo aspira a un ordinamento e perciò non
rifiuta la costrizione in quanto tale, ma soltanto la costrizione che scaturisce
dall’antagonismo di classe su cui si basa un ordinamento di dominio. L’anarchismo
difende l’assenza di leggi solo nel senso che respinge la legge intesa come volontà di
potenza codificata di una classe sociale sulle altre. L’ordinamento che scaturisce al
contrario dalla comunità solidale di interessi e di lavoro delle persone unificate da essa,
non solo l’anarchismo lo riconosce in quanto tale, lo designa persino molto spesso
come legge, ma è anche deciso a difenderlo con tutti gli strumenti di potere messi a
disposizione dalla società solidale. Per un’esatta comprensione dell’anarchismo e — ciò
che ad essa è collegato —, del suo rapporto col socialismo, l’elemento essenziale
consiste nel non restare legati a concetti puramente formali e di non rassicurarsi con la
frase, che l’anarchismo rifiuta ’la costrizione ’. Ci si deve piuttosto chiedere: che tipo di
costrizione viene rifiutato? A questa domanda non si può rispondere da un punto di
vista formale-giuridico, ma solo attraverso l’analisi della diversa natura sociale che la
costrizione rappresenta, a seconda che sia esercitata in una società di classe o in una
senza classi. Se consideriamo in questa prospettiva la cosa, risulta che propriamente
nessuno dei teorici riconosciuti come anarchici ha negato la costrizione nella società; e
ciò vale invero non solo per i teorici di orientamento comunista, ma anche per quelli di
tendenza individualistica. Cosí Proudhon non rifiuta affatto la regolamentazione della
vita sociale attraverso leggi e, ciononostante, dice di sé: « Sebbene io sia
assolutamente un amico dell’ordine, sono anche anarchico nel significato pieno della
parola » [Nota 3]. Egli pone il quesito: L’autorità
Página 187
dell’uomo sull’uomo è giusta? Tutti rispondono: No, l’autorità dell’uomo non è che
l’autorità della legge, la quale dev’essere giustizia e verità » [Nota 4]. E ambedue
questi termini non significano per lui una semplice enunciazione etica, ma, come viene
chiarito soprattutto nell’ultimo capitolo dell’opera citata in precedenza, il
riconoscimento critico e sociale che in un ordinamento della società, che in luogo della
diseguaglianza economica ha posto l’uguaglianza delle condizioni di benessere per
ognuno, le leggi non si presentano piú come un esercizio di potere da parte di alcuni
uomini contro altri uomini, bensí come regole della loro esistenza, che scaturiscono
dalla natura della società e che si producono grazie all’esplorazione scientifica della
medesima.
Tutto ciò che è materia di legislazione e di politica è oggetto di scienza, non
d’opinione: il potere legislativo appartiene solo alla ragione metodicamente
riconosciuta e dimostrata. [...] Giustizia e legalità sono altrettanto indipendenti dal
nostro assenso che la verità matematica. [...] Il popolo è il custode della legge, il
popolo è il potere esecutivo. Ogni cittadino può affermare: Questo è vero; quello è
giusto; ma la sua convinzione impegna lui solo: affinché la verità ch’egli proclama
divenga legge, occorre che sia riconosciuta. Ora, che cosa vuol dire riconoscere una
legge? vuol dire verificare un’operazione di matematica o di metafisica: vuol dire
ripetere un esperimento, osservare un fenomeno, constatare un fatto. Solo la nazione
ha il diritto di dire: Prescriviamo e ordiniamo. [Nota 5]
Come si vede Proudhon non mette di fatto in dubbio che anche la società anarchica
avrà un ordinamento e delle leggi, che potranno essere imposte con la forza, ma vuole
soltanto richiamare l’attenzione sul fatto che questa costrizione ha un carattere diverso
da quella esistente in una società classista. Essa si trasforma, da una costrizione di
uomini contro uomini, in una costrizione dell’ordinamento oggettivo su tutti, allo stesso
modo in cui le leggi matematiche o fisiche esercitano una costrizione nei confronti di
tutti. Una tale legge, « risultando dalla scienza dei fatti e di conseguenza fondandosi
sulla stessa necessità, non urta mai l’indipendenza » [Nota 6]. Tra parentesi dobbiamo
osservare come il pensiero di Saint-Simon, trattato così sprezzantemente da Kelsen, e
che riguarda la trasformazione del governo sugli uomini in un’amministrazione di cose,
ritorni qui, in Proudhon, in una forma autonoma, e come esso domini anche l’intero
sviluppo del pensiero socialista. Questa intuizione fondamentale della sostituzione del
governo con un’amministrazione, non solo non esclude, com’è naturale, l’appliPágina 188
cazione della forza contro coloro che turbano questa amministrazione, ma esso è
appunto uno dei còmpiti dell’amministrazione stessa. Ma, probabilmente, un tale
cambiamento totale del carattere dell’ordinamento elimina a tal punto le occasioni in
cui esso può essere turbato che, queste ultime, effettivamente, potranno essere
piuttosto, quasi esclusivamente, di natura patologica o criminale. In un’opera
successiva Proudhon adopera l’espressione « mutualismo » per indicare il carattere
cambiato del nuovo ordinamento costrittivo. A ognuno s’impone la domanda se egli
vuol rispettare le regole, « che unicamente, secondo la natura delle cose, sono in
grado » di garantire nel massimo grado il benessere e la libertà di tutti. « Se dici di no,
sei un selvaggio. Ti sei staccato dalla comunità e ti sei reso sospetto. Niente può
proteggerti. Per la piú piccola offesa chiunque ti può uccidere e lo si può al massimo
rimproverare di crudeltà gratuita verso una bestia feroce » [Nota 7]. Ovviamente non
ci interessa stabilire, né in Proudhon, né in qualsiasi altro anarchico successivo, il modo
in cui si sono raffigurati il futuro ordinamento della società, bensí soltanto dimo strare
come ad essi non sia mai venuto in mente di ipotizzare una società in Cui non
risultasse possibile applicare la costrizione contro coloro che fanno resistenza.
Anarchismo significa per essi assenza di dominio, ma non di autorità e di costrizione.
Assolutamente affine è la dottrina di Bakunin. Egli ritiene necessario chiarire
esplicitamente, in che senso intende essere anarchico: soltanto nel senso che vuole
abolire ogni ordinamento giuridico basato su privilegi.
In una parola, noi respingiamo tutte le legislazioni, autorità c sistemi di influenze
(Beeinflussung), basati su privilegi, brevettati, ufficiali e legali, anche se sono scaturiti
dal suffragio universale, giacché siamo persuasi che si possono volgere sempre a
vantaggio di una minoranza dominante e sfruttatrice contro gli interessi della
stragrande maggioranza asservita. In questo senso siamo effettivamente anarchici.
Ma, in un altro brano leggiamo:
Da ciò deriva forse che io respingo ogni autorità? Questo pensiero è lungi da me. Se
mi occorrono degli stivali, mi rivolgo all’autorità del calzolaio, se si tratta di una casa,
di un canale, o di una ferrovia, interpello l’autorità dell’architetto o dell’ingegnere. Per
una qualsiasi scienza specialistica mi rivolgo a questo o a quell’uomo di cultura. [Nota
9]
Página 189
Cosí vanno le cose nella vita quotidiana. Ma anche nella vita sociale esiste un’autorità
che garantisce un ordine stabile della società.
L’unica grande e onnipotente autorità, al tempo stesso naturale e razionale, l’unica
che possiamo rispettare, sarà quella scaturita dallo spirito collettivo e pubblico di una
società fondata sulla eguaglianza e la solidarietà e il rispetto umano reciproco di tutti i
suoi membri. [Nota 10]
Del tutto in accordo con ciò, ma in modo ancora piú evidente, viene affermato
un’altra volta:
Per quanto sono un nemico di ciò che in Francia si chiama disciplina, così riconosco
nondimeno che una disciplina uguale, non automatica, ma volontaria e meditata, tale
da accordarsi con la libertà degli individui, è e resterà sempre necessaria; e
precisamente ogni volta che molti individui uniti spontaneamente vorranno svolgere
qualche lavoro o azione in comune. Questa disciplina non è quindi niente altro che
l’accordo spontaneo e meditato tra tutti gli sforzi individuali per il raggiungimento di un
obiettivo comune. Nell’istante dell’azione, nel mezzo della lotta, com’è naturale, i ruoli
si scindono, in base alle capacità di ciascuno, valutate e giudicate dall’intera comunità:
gli uni dirigono e comandano, altri eseguono gli ordini. [...] In questo sistema non
esiste un vero e proprio potere. Il potere risiede nella comunità (Gerneinschaftlichkeit)
e diventa la autentica espressione della libertà di ognuno, la leale e sincera
realizzazione della volontà di tutti; ognuno obbedisce solo perché colui che dirige gli
ordina ciò che egli vuole fare.
Se, in relazione alla comprensione della distinzione, comune anche al socialismo, tra
sottomissione (Unterwerfung) e subordinazione (Unterordnung), sembra che essa, in
Bakunin, risulti riferita principalmente soltanto alla disciplina della lotta rivoluzionaria,
tuttavia non vi è alcun dubbio che egli con ciò vuole caratterizzare l’essenza di un
ordinamento sociale in generale, in cui l’esercizio della costrizione non si basi sul
dominio di un uomo sugli altri, ma sulla solidarietà di tutti. Anche per gli anarchici
esiste dunque obbedienza a comandi e a leggi, solo che questi saranno costituiti
internamente in modo diverso dalle leggi attuali. Ciò è confermato esplicitamente da
Bakunin:
Che cos’è libertà? Che cos’è schíavitú? La libertà consiste forse nella ribellione alle
leggi? No, se si tratta di leggi naturali, economiche e sociali, che non vengono imposte
in modo autoritario, ma stanno nelle
Página 190
cose, nelle relazioni, nelle situazioni stesse, di cui esprimono lo sviluppo. Sí, se
viceversa sono leggi politiche e giuridiche che vengono imposte da uomini a altri
uomini, sia arbitrariamente col diritto della forza, sia ipocritamente, in nome di una
qualche religione o dottrina metafisica, sia infine in virtù di quella finzione, di quella
bugia democratica che è il suffragio universale. (Nota 12)
Certamente l’anarchismo già nella propaganda bakuninista e a partire da essa, quasi
sempre, fino ai giorni nostri ha fatto a tal punto della lotta contro ogni autorità e
legalità semplici parole d’ordine per la mancanza di giudizio e i puri istinti di potere
delle masse, che da tutto ciò si è sviluppata quella forma retorica e contraddittoria che
è a tutt’oggi l’anarchismo. Infatti nella sua forma concettuale esso vive ormai solo nei
libri. Ma che proprio a questa forma concettuale non sia estranea la costrizione contro
coloro che fanno resistenza può essere desunto con chiarezza da una circostanza molto
interessante e significativa, dal punto di vista storico-letterario e storico in generale.
Infatti solo cosí è stato possibile a Marx ed Engels dimostrare, attraverso la critica del
bakuninismo, resasi necessaria sulla base della lotta interna all’Internazionale, che
proprio da questo socialismo, che vuole apparire cosí antiautoritario ’, scaturisce un
richiamo addirittura imperioso all’autorità, sia nella lotta rivoluzionaria, che nella nuova
società che dev’essere fondata ex novo”. Cosí si legge nelle Pubblicazioni della società
’Il Giudizio Popolare ’, che erano al servizio del movimento bakuninista, in un articolo
intitolato Principi fondamentali dell’ordine sociale futuro, che, dopo la rivoluzione, tutti i
mezzi di sussistenza diventeranno immediatamente di proprietà comune. Viene
annunciato il lavoro obbligatorio per tutti, la fondazione di società operaie (arteli) e
viene abbozzato un piano di lavoro. Nel corso di un certo tempo,
ogni individuo deve entrare nell’uno o nell’altro artel’, a sua scelta. coloro che saranno
rimasti isolati o non si saranno aggregati a gruppi operai senza una ragione valida, non
avranno diritto di acc né alle mense comuni, né ai dormitori comuni, né a qualunque
edificio destinato al soddisfacimento dei differenti bisogni dei fra
Página 191
lavoratori, o agli edifici che contengono prodotti, materiali, viveri o strumenti destinati
ai rami della società operaia costituita; in breve, chi senza una ragione valida non ha
aderito a un artel’, rimane senza mezzi di sussistenza. Tutte le strade, tutti i mezzi di
comunicazione gli saranno interdetti; non gli rimarrà che l’alternativa tra il lavoro o la
morte. [Nota 14]
Negli stessi termini si esprime Kropotkin, in relazione a coloro che vorranno turbare
l’ordine basato sulla libera associazione dei gruppi produttivi confederati: « Dal
momento che volete porvi sotto particolari condizioni ed evitare le file dei compagni, è
molto probabile che nelle vostre quotidiane relazioni con gli altri cittadini farete la
seguente esperienza. Vi si tratterà come un fantasma della società borghese e vi si
sfuggirà (...)» (Nota 15). Per Kropotkin non è affatto in questione che la solidarietà
dei compagni che fanno parte dei gruppi, nei casi rari in cui, secondo la loro opinione,
sarà turbato in modo malevolo e irragionevole l’ordine, potrà fare ricorso a strumenti di
costrizione che di sicuro non dovranno avere niente in comune con quelli adoperati
dall’attuale diritto penale. A tale riguardo ci sarà ancora qualcosa da dire.
Se cosí stanno le cose presso gli anarchici di tendenza comunista, è molto
interessante vedere come l’atteggiamento degli anarchici individualisti, rispetto
all’ammissione di una costrizione per garantire l’ordine sociale, sia di gran lunga più
deciso. Max Stirner combatte contro lo Stato, in nome della libertà, della particolarità
(Eigenheit). In seguito ci occuperemo ancora di questo concetto fondamentale per la
comprensione del rapporto fra socialismo e anarchismo. Stirner non prova nessun
interesse per la libertà pura, come se la rappresenta la borghesia.
Non ho nulla da obiettare contro la libertà, ma ti auguro qualcosa in più che non la
sola libertà; tu non dovresti semplicemente essere libero, sciolto da ciò che non vuoi,
dovresti anche avere ciò che vuoi, non dovresti essere soltanto ’libero ma anche
proprio (Eigner). (Nota 16)
Per salvaguardare questa particolarità (Eigenheit) al posto dello Stato subentra
l’associazione degli egoisti. Ciò non significa però che per Stirner venga a cadere ogni
eventuale regolamenatzione costrittiva. « Sarebbe stolto pretendere che non sia
esercitato alcun potere su ciò che è mio. Soltanto che l’atteggiamento che mi imporrò
nei suoi confronti sarà radicalmente diverso, rispetto a quello
Página 192
avuto nell’epoca religiosa » (Nota 17), alla quale, secondo Stirner, appartiene anche la
nostra epoca con il suo dogma della « sacralità della legge ». Suona invero molto
anarchico ’, allorché Stirner dice: « Se io ho o non ho diritto, non c’è nessun giudice
che possa stabilirlo, all’infuori di me stesso ». Ma questa frase esprime appunto
dunque soltanto il mutato atteggiamento interiore del è singolo rispetto al concetto di
diritto, in base al quale esso non è più concepito come un potere estraneo, esteriore e
persino misterioso, posto al di sopra di lui, ma con ciò non si nega affat un legame
effettivo con esso. Infatti subito Stirner aggiunge: Suciò gli altri possono soltanto
giudicare e valutare, se essi sono d’accordo col mio diritto e se questo sussiste anche
per essi come diritto » (Nota 18). Il « diritto di tutti », il « diritto della umanità », viene
respinto da Stirner solo nella misura in cui esso è uno strumento per opprimere il
singolo in nome di una comunità che non abbraccia anche lui. « Non lo difenderò come
un diritto di tutti » (dunque ciononostante si parla di un difendere) « ma come il mio
diritto [... ]» (Nota 19). È assolutamente sbagliato dunque ritenere che la «
associazione degli egoisti » rappresenti unicamente un gruppo sciolto giacché all’unico
è consentito in fin dei conti tutto ciò che vuole. La questione è intesa in termini
completamente diversi da Stirner.
« Troverò mai in una qualche società una libertà cosí illimitata di potere (Diirfens)?
Sicuramente no.» E se colui che sostiene lo Stato pensa trionfante che in questo modo
si ritornerà all’antico Stirner risponde:
« Niente affatto! Si tratta di una cosa comp
tamente diversa se io faccio capo ad un io o ad un popolo, ad universale » (Nota 20).
Si vede con molta evidenza qui che per Stirner l’importante non è negare
l’ordinamento costrittivo, in quanto tale, bensí mostrare il carattere profondamente
mutato che assumerà dopo la soppressione della organizzazione sociale di classe
esistente e dopo la soppressione della ideologia statale, che deriva da essa, di una
legge universale ’. Soltanto ora si comprendono interamente le seguenti frasi che
illuminano con estrema chiarezza l’atteggiamento degli anarchici verso la questione
della costrizione’.
Vi è una differenza se attraverso una società è la mia libertà o la mia particolarità
(Eigenbeit) ad essere limitata. Nel primo caso la società è un’associazione, un
accordarsi reciproco, un’unione; ma quando minaccia il tramonto della particolarità, la
società rappresenta un potere per sé, un potere che sta al di sopra di me [...]. In
relazione alla libertà, però, lo Stato e l’associazione non sottostanno a una diversità
Página 193
senziale. La seconda può sorgere ed esistere senza che la libertà sia mítata, altrettanto
poco quanto lo Stato si concilia con una libertà limitata. E...] Certo, l’associazione non
solo offrirà un grado maggiore di libertà, ma, in particolare, potrà essere ritenuta una
nuova libertà ’, ..rché, grazie ad essa, ci si sottrae ad ogni costrizione tipica della vita
atale e sociale; ma tuttavia essa conterrà ancora abbastanza illibertà mancanza di
volontarietà. Perché, appunto, il suo scopo non è . libertà, che essa al contrario
sacrifica alla particolarità (Eigenbeit), La tuttavia soltanto alla particolarità. (Nota 21)
Non si può esprimere il fatto che anche l’ordinamento sociale ‘anarchico’ sarà, nella
sua forma molto individualistica, un ordinamento costrittivo, in modo piú drastico di
quando si dice, come fa Stirner, che nei confronti dell’arbitrio del singolo non ci si
comporterà diversamente dallo Stato.
Prendiamo infine Benjamin Tucker. In una conferenza a carattre propagandistico,
destinata a esporre il contenuto essenziale della sua dottrina, dice:
Ci si chiede: ”che cosa dovrà accadere con quegli individui che sicuramente
continueranno a infrangere la legge, aggredendo i loro vicini? ”. Gli anarchici
rispondono che la soppressione dello Stato lasscerá sussistere un’unione difensiva che
non si fonderà più a lungo su una base di tipo costrittivo, ma su una volontaria e che
contrasterà gli aggressori con tutti gli strumenti di cui sarà necessario avvalersi. Ma si
tratta per l’appunto di ciò che già abbiamo ”, è la risposta. Essi (gli anarchici) vogliono
in fondo dunque solo un cambiamento i nome ”. Non precipitiamo le cose, per favore.
Si può affermare anche per un solo istante con serietà che lo Stato, perfino quale
esiste si qui in America, sia una istituzione puramente difensiva? Sicuramente no,
eccetto per quelli che vedono dello Stato solo la sua manifestazione piú tangibile — i
poliziotti agli angoli della strada. [...] Indaghino pure i codici. Troveranno che ben i
nove decimi di tutte le leggi esistenti, servono non ad attuare quella fondamentale
legge sociale, ma ,[...] a far sorgere e a conservare monopoli di proprietà commerciali,
industriali, finanziari, i quali derubano il lavoro di una grossa fetta
Dell’utile che verrebbe ricavato in presenza di un potere completamente libero. (Nota
22)
Trasferito dal linguaggio impreciso di Tucker in concetti chiari, ciò significa che si può
parlare di un’associazione difensiva che subentra allo Stato, soltanto nel caso in cui si
fondi, invece che sul conflitto tra le classi, sulla solidarietà economica, la quale pone, in
luogo della « base di tipo costrittivo », vale a dire dell’ordinamento
Página 194
istituito dalla classe dominante, un ordinamento volontario basato quindi sulla
solidarietà di interessi tra i membri della comunità. E cosí anche Tucker conclude con
quel brano di Proudhon, citato precedentemente, in cui si minacciano coloro che
turbano questo ordinamento, di essere esclusi dalla società e di essere trattati da
selvaggi (Nota 23.)
Nella sua opera principale Instead of a Book. A Fragmentary Exposition of
Philosophical Anarchism (New York 1893), si trova espresso in modo ancora pili chiaro
di qui il punto di vista indicato. Purtroppo non ho potuto procurarmi questo libro. Ma il
Dr. Paul Eltzbacher, nel suo scritto Der Anarchismus, che riferisce in modo molto
obiettivo sull’argomento, ha fornito estratti cosí ampi di questo libro, da restituire con
chiarezza il carattere della dottrina di Tucker nella sua globalità. Questo anarchico
insegna dunque:
La resistenza contro un’aggressione esterna non è a sua volta un’aggressione, bensí
una difesa. É anche giustificato impedire tali violazioni. Inoltre è indifferente se questa
resistenza Proviene da un singolo contro altri singoli, oppure da parte di una comunità
contro un criminale per impedirgli di nuocere. Saranno valide pertanto anche
nell’ordinamento anarchico delle norme giuridiche, vale a dire norme che riposano su
una volontà generale, e la cui osservanza viene imposta con tutti i mezzi, anche con la
prigione, la tortura e la pena di morte. Di fronte alla violazione della persona o della
sua proprietà legittima gli anarchici sono decisi a rendere impossibili innanzitutto le
cause di queste violazioni (Verletzungen); bensí ”di fronte ad esse non rifuggiamo
neppure da alcuna disposizione violenta (Gewaltmassregel) che sembri consigliata dalla
ragione e dalle circostanze ”. ” L’anarchismo riconosce il diritto di arrestare, di
perseguire, di condannare e punire il delinquente. ” Con ciò non viene esercitato un
dominio, dominio infatti è l’assoggettamento di un uomo pacifico a una volontà
estranea. Al contrario il perseguire (Verfolgung) in questo caso è la difesa contro un
uomo aggressivo, che interferisce nella volontà solidale dei suoi compagni, e il suo
assoggettamento. ”Non esiste nessun principio della nostra vita associata il quale ci
impedisca di difenderci in ogni modo da un’aggressione ”. Su tutti questi casi si
pronunceranno le corti d’assise, ma non in conformità a una legge rigida, bensí
attraverso una libera scoperta del diritto in ogni singolo caso. (Nota 24)
La visione esatta, secondo la quale il concetto di anarchia non significa disordine ma
solo assenza di dominio, dev’essere ampliata, pertanto, nel senso che esso non solo
non esclude ma comprende anche il concetto di un ordinamento costrittivo della vita
sociale,
Página 195
solo che esso insegna appunto il mutamento sociologico di questo carattere della
costrizione, in seguito al quale le persone ad esso assoggettate non l’avvertiranno più
come una costrizione. Se gli anarchici negano il diritto ’ e ’la legge ’, si tratta sempre
del ritto e della legge di una società di classe, è sempre quel genere di imposizione di
norme sociali che si rivolge il singolo come una realtà estranea, ostile ai suoi interessi
vitali. Ciò lo abbiamo già visto in Bakunin e Stirner e cosí leggiamo in modo addirittura
esemplare in Kropotkin.
La legge è un prodotto relativamente moderno; infatti l’umanità è esistita per secoli e
secoli senza ima legge scritta. [...] Le relazioni reciproche tra gli uomini a quel tempo
erano regolate in base a consuetudini e a costumi, che la ripetizione continua rende
sacri e ognuno nella propria infanzia ha assimilato. [...] Ma non appena la società
incominciò a scindersi sempre più in due classi contrapposte — di cui l’una cerca di
imporre il proprio dominio all’altra, l’altra cerca di sottrarvisi — iniziò la lotta. Il
vincitore di oggi si affretta a rendere immutabile il fatto compiuto. [...] La legge fa la
sua apparizione, benedetta dai preti, con le armi dei soldati al suo servizio. (Nota 25)
Gli anarchici negano questa legge, questo diritto, che una volta Holderlin ha definito
acutamente « il dispotismo della legge, l’ingiustizia sotto le specie del diritto », e a
proposito del quale egli aggiunge con amarezza che « il figlio del Nord lo sopporta
senza riluttanza ». Perché, se l’orientale — per una sorta d’impulso all’ossequio —
sopporta il suo dispotismo dell’arbitrio, « nel Nord si crede troppo poco alla vita pura e
libera della natura, per non attaccarsi con superstizione a ciò ch’è legale » (Nota 26) . t
questa forma contraddittoria, in cui si manifestano la legge e il diritto, ad essere
combattuta dagli anarchici, ma non un vincolo legale e giuridico, che, al contrario,
vogliono per la prima volta realizzare socialmente, come emanazione di una giustizia e
di una solidarietà reali (Nota 27).
Página 196
Per esaminare ciò in modo abbastanza chiaro, non ci resta che sottolineare infine come
la costrizione di un ordinamento costrittivo della vita sociale non debba attuarsi
necessariamente nelle forme in cui si sviluppa oggi, vale a dire in una società che si
basa sull’antagonismo di classe, nella quale l’ordinamento giuridico è effettivamente
una costrizione per intere fasce della popolazione, limitate nei loro interessi sociali da
essa. In che cosa consiste dunque la costrizione ’ dell’ordinamento giuridico? In minima
parte nel fatto che qualcuno viene costretto direttamente a fare qualcosa,
Página 197
per lo piú soltanto nell’indurlo a desistere da un certo modo di agire o di non agire, da
lui altrimenti auspicato. La costrizione giuridica ottiene l’esecuzione di certe prestazioni
che sono consentite dal diritto, oppure la omissione di azioni vietate, da un lato,
attraverso l’inflizione di pene per colui che disubbidisce, dall’altro attraverso
l’esecuzione (Execution), vale a dire imponendo un risarcimento statale a seconda dei
mezzi del debitore. Ambedue le forme che garantiscono in modo costrittivo
l’ordinamento giuridico non solo sono possibili anche in una società anarchica, ma sono
persino contenute nel suo concetto di un ordinamento che si conserva grazie
all’interesse unitario e solidale di tutti. Solo che il carattere degli strumenti di
costrizione ha subito una profonda trasformazione corrispondentemente al livello di
civiltà di questo ordinamento sociale. Oggi, anzi, non conosciamo neppure le sanzioni
penali (Stralmittel) della C.C.C., dell’ordinamento penale del tribunale criminale
(Halsgericht) di Carlo V, senza le quali la giurisprudenza progredita di allora — e quella
carolina costituiva un progresso — non era certamente in grado d’immaginarsi una
organizzazione costrittiva del diritto. Ma si tratta pur sempre di una punizione, sia che
s’imprigioni colui che ha trasgredito un ordinamento sociale, sia che lo si escluda dal
godimento della società. (Nota 28) E finché un membro della società resta e vuole
restare
Página 198
nel suo seno, può essere sempre reso responsabile, con ciò che è in suo possesso, dei
danni e dell’inadempienza di contratti stipulati. Non potrà accampare pretese nei
confronti della società, non rivendicherà il diritto di acquistare beni, di utilizzare istituti
scientifici e culturali, di visitare i teatri ecc.; e non costituisce forse una punizione se la
società gli sottrarrà tali pretese o gli proibirà siffatti godimenti, fino a quando non avrà
adempiuto ai suoi impegni? Ma si tratta tuttavia evidentemente di un tipo di costrizione
diverso rispetto a quello dell’ordinamento giuridico esistente perché l’applicazione di
una tale costrizione si presenta come un semplice provvedimento volto a garantire un
interesse amministrativo comune ai membri della società, il che significa che mira a
salvaguardare un ordinamento nel quale non sussiste nessun conflitto di interessi, ma
che può essere turbato nel caso specifico solo per stoltezza, o per le passioni o la
criminalità di un singolo. Com’è naturale anche in questo ordinamento può svilupparsi
un nuovo conflitto di interessi, a noi ancora sconosciuto, il quale produrrà un nuovo
raggruppamento norl solidale dei membri della società. Quindi anche questa società
sarà posta davanti a un nuov problema sociale di cui oggi però non possiamo ancora
occuparci (Nota 29).
Página 199
2. Ordinamento giuridico e ordinamento convenzionale
Molto ha contribuito al fondamentale equivoco circa l’obiettivo anarchico della società
concepito nei termini di un ordinamento sociale non solo privo di dominio, ma anche di
costrizione, la determinazione concettuale (Begriffsbestimmung) che di esso ha dato
Rudolf Stammler nella sua esposizione critica dell’anarchismo (Nota 30).
Sulla base della sua presentazione l’anarchismo invero non aspira affatto al disordine,
ma al contrario a un nuovo ordinamento sociale, tale però da non essere piú regolato
attraverso il diritto. Esistono cioè, insegna Stammler, due tipi di ordinamento esterno
della vita sociale, per i quali si deve completamente prescindere dalla eticità intesa
come una imposizione di norme (Norrnierung) che si rivolgono alla interiorità
dell’uomo: statuizione (Satzung) giuridica e regole convenzionali (Konventionalregel).
La distinzione non risiede all’incirca nel fatto che la prima regolamentazione prende le
mosse dallo Stato, la seconda no. Il diritto, piuttosto, può svilupparsi anche in
organismi non statali, ad esempio in un’orda, in un popolo nomade o in una comunità
come la Chiesa. La distinzione consiste esclusivamente in ciò: il diritto « avanza la
pretesa di obbligare, del tutto indipendentemente dall’approvazione di coloro che sono
assoggettati al diritto. [...] La regola convenzionale, nel suo significato specifico, vale
solo in virtú consenso di colui che è assoggettato », sia che questa (regola)
Página 200
venga espressamente seguita oppure riconosciuta attraverso una tacita obbedienza
(ivi, pp. 23-4). L’anarchismo è la teoria di un ordinamento della vita sociale
caratterizzato dal rifiuto di principio della costrizione, e che si basa semplicemente su
regole convenzionali.
Contro questa differenziazione già Kelsen ha formulato l’obiezione decisiva, secondo
la quale essa è assolutamente insufficiente dal punto di vista logico, perché adopera il
concetto di validità (Geltung) della regolamentazione in modo ambiguo e pertanto qui
del tutto indeterminato. La validità di una norma può significare prima di tutto che essa
effettivamente è valida, cioè viene di fatto seguita, ma in secondo luogo che essa deve
essere seguita. Se si verifica il primo caso abbiamo che per il diritto il consenso o il
riconoscimento da parte di chi vi è sottoposto è altrettanto essenziale quanto lo è
l’essere seguite per le regole convenzionali. Al contrario nella seconda ipotesi — ed è
quella che maggiormente ci interessa, infatti soltanto questo significato di validità è
rilevante per l’esame delle forme di regolamentazione - il riconoscimento o - il
consenso di coloro che sono assoggettati a delle regole sono, anche per le regole
convenzionali, cosí poco essenziali quanto per le regole giuridiche. « Infatti anche
quelle debbono essere osservate a prescindere dal fatto che il soggetto desideri o
ritenga utile ciò. » Molto giustamente Kelsen dice che l’esempio fornito da Stammler
per una norma convenzionale: « Chi non dà soddisfazione si trova fuori del codice
d’onore cavalleresco », non dimostra affatto quanto Stammler si proponeva di fare,
che cioè le norme convenzionali, da questo momento in poi, mancando un
riconoscimento da parte del vigliacco ’, non hanno piú alcun valore per costui.
L’esempio dimostra, bensí, proprio il contrario. Il codice cavalleresco perderebbe anzi
ogni significato se potesse essere privato della sua efficacia per il mancato
riconoscimento arbitrario da parte di colui che lo trasgredisce. « Nel disprezzo che
colpisce chi nega la soddisfazione si palesa chiaramente che anch’egli sottostà al codice
d’onore ». Non si potrebbe anzi neppure parlare della violazione di una regola
convenzionale, se, chiunque non la seguisse, si ponesse per ciò stesso al di fuori della
medesima (Nota 31) . Ora, in che cosa scorge Kelsen la differenza fra regola giuridica
e regola convenzionale? Al riguardo egli non si è espresso in maniera particolare,
perché, chiaramente, egli non attribuisce affatto a questa differenza lo stesso
significato che le dà Stammler. Solo occasionalmente Kelsen ritiene che la differenza
fra queste due regolamentazioni stia proprio là dove va cercata la differenza fra leggi
giuridiche e leggi etiche, in particolare, nel fatto
Página 201
che le seconde devono semplicemente essere seguite, mentre le
prime possono
anche essere applicate. Il diritto è un complesso di norme, che non devono
semplicemente valere, ma la cui validità viene portata a compimento anche in caso di
disobbedienza. La differenza della statuizione giuridica rispetto alla regola
convenzionale consiste appunto « nella sua specifica possibilità d’applicazione ». La
regola convenzionale può essere violata senza che colui che l’ha violata venga colpito,
« come avviene invece nel caso del diritto, da un’organizzazione creata a questo scopo,
con le conseguenze dell’ingiustizia da lui commessa ». Ciò che pertanto distingue l’una
e l’altra regolamentazione è il fatte che la statuizione giuridica può essere non solo
seguita, ma anche applicata, che essa ha dunque una possibilità di validità, per dir
meglio: una possibilità di efficacia in piú rispetto alla regola convenzionale, e che ad
essa è essenziale — proprio a causa della sua possibilità di applicazione —
un’organizzazione esterna: il tribunale — in senso piú ampio, lo Stato. (Nota 32).
Anche questa differenziazione di Kelsen dev’essere considerata come assolutamente
insufficiente,
e
la
indicazione
della
sua
incompletezza
ci
introduce
contemporaneamente alla conoscenza dell’elemento essenziale, di cui qui si tratta per
la comprensione dell’anarchismo e del suo rapporto col socialismo: vale a dire che tra
regole convenzionali e regole giuridiche non esiste in generale nessuna distinzione di
ordine concettuale, ma sono soltanto diverse formazioni storiche dell’ordinamento
costrittivo in generale.
Prescindiamo qui per il momento completamente dall’imposizione di norme etiche
(sittlichen Normierung), con la quale Kelsen ha messo in cosí stretta connessione la
regolamentazione convenzionale, ma consideriamo immediatamente il presunto tratto
distintivo tra regole convenzionali e regole giuridiche. Se appartiene all’essenza della
regola giuridica il fatto che possa essere applicata ciò vale altrettanto per la regola
convenzionale. L’importante è che si ponga in una relazione precisa l’applicazione con
la norma a essa corrispondente. L’applicazione di una norma significa che per il
violatore possono essere messe in atto delle conseguenze per la sua trasgressione
della norma. Ma questo è ciò che si verifica in tutte le regolamentazioni di tipo
convenzionale. O si incorre in una multa convenzionale, o si produce un’esclusione
dalla comunità convenzionale, oppure il violatore viene punito con la revoca della stima
e dell’accettazione sociali che altrimenti gli spetterebbero. Un” emarginazione’ e un
’boicottaggio’ permanenti sono forse conseguenze dell’infrazione di una norma meno
sensibili di
Página 202
una pena pecuniaria di mille corone o di ventiquattr’ore d’arresto? E non è neanche
giusto che alla regola convenzionale manchi l’organizzazione per portare a compimento
queste conseguenze dell’infrazione di una norma, né quelle originarie, né quelle create
a questo scopo. La comunità degli uomini che fungono da portatori della regola
convenzionale è essa stessa l’organizzazione originaria, non diversamente da com’è la
comunità giuridica che amministra il diritto come semplice esercizio. E non di rado le
regole convenzionali prevedono addirittura l’insediamento di tribunali arbitrali, cioè di
un’organizzazione costituita per la loro applicazione. Se il violatore non si sottopone a
questo tribunale arbitrale, ad esempio a un tribunale d’onore, ciò ostacola il
funzionamento e il giudizio del tribunale tanto poco quanto accadrebbe se il
delinquente o colui contro cui è intentato un processo non si presentasse, nonostante
la citazione, davanti al tribunale dello Stato. La regola convenzionale non si distingue
pertanto dalla regola giuridica né per la pretesa di validità, né per la possibilità di
applicazione. Ambedue le regolamentazioni hanno una medesima essenza; come
risulta anche dal fatto che continuamente regole convenzionali confluiscono, sotto
forma di usi (Usancen) o di diritto consuetudinario, nel diritto, nella misura in cui
vengono applicate da tribunali. Se ciò è possibile solo perché delle disposizioni positive
della legge lo consentono, questa possibilità tuttavia dimostra che non sono elementi
contenuti nell’essenza della regolamentazione convenzionale, bensí in primo luogo
l’imposizione di norme (Normierung), voluta dalla legislazione, ad aver ricacciato la
regolamentazione convenzionale in un ruolo puramente sussidiario. Ma esiste bensí
una distinzione all’interno della regolamentazione sociale in generale, vale a dire a
seconda dell’ampiezza e del significato dello scopo, da cui essa scaturisce. Ogni
regolamentazione persegue un fine e viene da esso determinata. Dallo scopo che sta
alla base del gioco di carte fino a quello dell’assicurazione e accrescimento della vita,
si dischiude una serie innumerevole di scopi dei quali ognuno stabilisce il suo sistema
di regolamentazione specifico. E a seconda della finalità la regolamentazione può
essere di estensione piú o meno ampia. Esistono scopi, che si presume siano posti in
ognuno, perché sono i fini etici. E da essi scaturisce un certo numero di regole sociali,
che hanno un’estensione molto ampia, che abbracciano tutti gli uomini, valgono per
tutti coloro che vogliono essere membri della comunità sociale. Ciò significa che la loro
autoesclusione dalla comunità viene già colta come una violazione di questo sistema di
regolamentazione. L’idea di una validità universale della regolamentazione, in quanto
fondata su scopi, che ciascuno deve avere, è la vera e propria idea del diritto,
propriamente detta. Essa comprende dunque le regole
Pàgina 203
convenzionali, aventi uno scopo necessariamente universale, dalle quali si distinguono
le altre regole convenzionali, per il fatto che i loro fini sono indifferenti dal punto di
vista morale, e perciò sono rimesse a un atto arbitrario con cui possono essere istituite
oppure no. Ciononostante anch’esse rientrano nella medesima categoria di
regolamentazione, perché, una volta fissato il loro scopo, si immergono (per cosí dire)
nell’idea di diritto. Ciò è testimoniato dal fatto che innanzitutto anche il contenuto di
queste regolamentazioni non può mai entrare in conflitto con l’idea di diritto, e in
secondo luogo, una volta che è stato stabilito lo scopo, la norma che scaturisce da
esso, vale anche se uno di coloro che partecipano dello scopo non vuole attenersi a
esso, anzi piuttosto questo comportamento d’ora in poi sarà considerato come cattivo’,
persino nel senso delle regole convenzionali. Non è affatto ingiusto non proporsi come
fine il gioco delle carte, ma barare al gioco non è semplicemente una violazione della
convenzione del gioco delle carte, bensí è anche un’ingiustizia.
Non considero affatto una carenza di quest’analisi, ma al contrario un utile
chiarimento della essenza di quella struttura peculiare che noi abitualmente
contrapponiamo, in quanto diritto, alla morale, il fatto che in questo modo l’idea di
diritto appaia alla fine fondata sulla morale. Questo contrasto tra morale e diritto —
come immediatamente dovrà essere dimostrato —, va spiegato in base alla
trasformazione (Umformung) storica che la regolamentazione convenzionale deve
sperimentare in una formazione sociale, che si basa sul conflitto di classe e che cosí
rende possibile a una classe di imporre i suoi interessi parziali come interessi
universali. La profonda distinzione istituita da Kant tra diritto e moralità resta
ciononostante valida. Infatti costituirà sempre una differenza, se l’osservanza della
norma scaturisce dal dovere o da altri motivi. Ma proprio perché la distinzione tra
moralità e diritto consiste nel fatto che il comportamento ispirato dalla legge può fare a
meno del sentimento del dovere (Pflichtgesinnung), non si può ignorare nondimeno
che ogni legalità deve poter essere anche adempimento del dovere, e che una legalità,
la quale non possa essere ciò (adempimento del dovere), viene avvertita sempre come
una contraddizione rispetto all’idea di diritto. Rientra perciò nell’essenza del diritto il
poter essere seguito in modo etico e il divario tra moralità e legalità è solo una realtà
di ordine psicologico, ma non una diversità concettuale. La cosiddetta eteronomia del
diritto non riguarda la sua essenza normologica, anzi viene piuttosto esclusa da
questa, ma semplicemente il modo in cui esso si manifesta sul piano psicologico. Anche
il diritto come insieme di norme che debbono essere universalmente seguite, senza
riguardo al fatto che il singolo le riconosca anche di fatto, può
Página 204
avanzare questa pretesa, solo perché il singolo deve riconoscere queste norme, il che
significa non seguirle semplicemente, ma riconoscerle come un dovere. Ma il dovere
può derivare soltanto dall’autodeterminazione autonoma della coscienza etica.
Ciò che occulta ogni volta questo carattere della regolamentazione giuridica è che nel
diritto positivo, nella legislazione statale dunque, è contenuta tanta ‘validità’ la quale
sicuramente non è né etica, né autonoma. Rappresenta però l’inizio del chiarimento di
questa discussione cosí intricata, riguardante il diritto e la morale, il comprendere
infine che il diritto positivo non è innanzitutto e in primo luogo né diritto né morale, ma
lo strumento di potere di un’organizzazione di dominio, e che pertanto non si può
prendere le mosse dal diritto vigente, se si vuole cogliere l’essenza normologica del
diritto, ma si può soltanto chiedere come mai sia possibile che il carattere di diritto
possa essere attribuito a un ordinamento che contraddice il suo concetto.
Risulterà allora che la distinzione all’interno di ogni regolamentazione sociale
esteriore, vale a dire, tra una regolamentazione i cui fini sono necessari dal punto di
vista morale e un’altra i cui fini sono moralmente indifferenti, è diventata significativa
sul piano storico nella misura in cui determinati fini risultano provvisti di un potere cos
í grande, da trovarsi in condizione d’imporre a ognuno il proprio sistema di
regolamentazione. E solo a partire da questo momento si profila la distinzione tra
regole giuridiche e regole convenzionali, nel senso comune del termine, che è per
l’appunto solo di carattere storico-sociologico, vale a dire esprime il fatto che diventa
diritto quella regolamentazione che prende l’avvio dallo Stato, cioè da una struttura
sociale, in cui una classe dominante può fare del contenuto di proprie o di determinate
regolamentazioni convenzionali un comandamento universale. E a questo punto
sorgerà naturalmente una poderosa differenza tra i due tipi di regolamentazioni, in
quanto il diritto ’ può essere imposto non grazie alle istituzioni create da esso, cioè dai
membri della convenzione, per ottenere la sua applicazione, bensí grazie ai mezzi di
potere creati e utilizzati dalla classe dominante. In questo modo il diritto ’ diviene
quella struttura contraddittoria, che sicuramente si fa beffe di ogni elaborazione
teorica, nel senso che dal punto di vista formale sembra possedere una validità
universale, mentre sul piano del contenuto esprime solo una volontà parziale dei
membri della comunità (Nota 33)
Página 205
Ora anche da questo lato è stato posto in risalto che la distinzione specifica tra regole
convenzionali e regole di diritto positivo, si riduce a quella esistente tra una
regolamentazione che poggia sulla solidarietà di interessi e un’altra che, viceversa, si
basa sul conflitto di interessi, e che l’apparenza per cui nella prima non esiste
costrizione giuridica, consiste solo nel fatto che presso di essa è escluso dal punto di
vista concettuale il carattere di eteronomia della regolamentazione, sebbene nel
singolo caso essa possa risultare eteronoma sul piano psicologico. La negazione e la
soppressione dello Stato, inteso come un dominio di classe e come strumento per
applicare (Anwender) un ordinamento giuridico, il quale perciò dev’essere
necessariamente un ordinamento di dominio, e la sua sostituzione per mezzo della
regolamentazione convenzionale dei membri della comunità non significa in nessun
modo quindi la negazione di una costrizione giuridica, ma unicamente il totale
mutamento sociologico del suo carattere.
3. La distinzione specifica tra anarchismo e socialismo
Forse Kelsen a questo punto della nostra esposizione ci obietterà che in realtà
abbiamo soltanto portato acqua al suo mulino, essendoci data premura di provare la
sua tesi, secondo la quale tra marxismo e anarchismo non esiste nessuna differenza di
principio per quanto riguarda l’obiettivo sociale (p. 42 [ 78]). A ciò si deve rispondere
che l’affermazione di Kelsen è certamente esatta, ma in un senso completamente
diverso da quello che egli le attribuisce. In effetti non esiste nessuna distinzione di
principio tra socialismo e anarchismo per quanto concerne l’obiettivo sociale, ma non
perché il socialismo è in fondo anarchismo, bensí perché anche l’anarchismo è pur
sempre socialismo, il che significa che è stato ed è un’organizzazione solidale della
società. A prescindere
Página 206
da ciò sussiste però un’enorme differenza tra le due direzioni, soltanto che si tratta
essenzialmente di una distinzione attinente alla tattica, e che sicuramente, presso i
singoli teorici dell’anarchismo, risale a una diversità delle concezioni di fondo riguardo
all’essenza dell’unione
(Verband) sociale e al modo di agire della legalità sociale.
Sotto questo aspetto soltanto si può e si deve parlare di una diversità di principio tra
anarchismo e marxismo. Il punto di partenza dell’anarchismo, concepito come teoria
sociale, è l’individuo, quello del marxismo la società. L’anarchico costruisce la società
sulla base del comportamento individuale, interpretato in un certo modo, sia che si
tratti dell’egoismo cosciente di se stesso, di Stirner o di Tucker, oppure della
reciprocità di Proudhon e di Kropotkin, o dell’amore di Tolstoj. Il marxismo viceversa
conosce l’individuo solo come un membro della connessione sociale, dalla quale è
interamente destinato all’odio e all’amore, all’egoismo e alla reciprocità; e questi ruoli
caratteriali e la loro ampiezza gli vengono ogni volta assegnati in base alla sua
posizione all’interno del processo produttivo.
Ma questa diversità che esiste reallente in linea di principio tra marxismo e
anarchismo, non si manifesta nell’obiettivo della trasformazione sociale, ma appunto
nella via che essi considerano indispensabile per il raggiungimento di questo obiettivo,
cioè nel tipo di percorso dello sviluppo sociale che essi espongono. Nel marxismo la
volontà rivoluzionaria delle masse matura in relazione a questo obiettivo all’interno
dello sviluppo economico, il quale progressivamente deve condurre strati sempre phi
estesi della, società in conflitto con l’ordinamento economico e giuridico esistente. La
ribellione della coscienza è la conseguenza di un processo economico. Nell’anarchismo
questa ribellione è la prima cosa che dev’essere creata, anche se soltanto in un piccolo
gruppo di uomini decisi, i quali, come capi, trascineranno con loro le masse e
susciteranno in esse la volontà rivoluzionaria. Il marxismo vede prodursi in modo
necessario la rivoluzione (Umwalzung) sociale, l’anarchismo ritiene che prima avviene
meglio è.
Per la comprensione dell’essenza specifica del socialismo e del suo rapporto con
l’anarchismo mi sembra indispensabile diventare pienamente consapevoli — malgrado
la diversità in linea di principio del punto di partenza teorico — di questa diversità
puramente storico-tattica delle due direzioni per quanto concerne l’obiettivo, la quale
sicuramente ha condotto, nell’immagine storica del movimento operaio, a enormi
conflitti che hanno diviso in modo fatale la forza del socialismo. Ma dobbiamo
guardarci, da un lato, dal sottovalutare il livello ideale (Ideenhöhe) dell’anarchismo e il
suo significato per il socialismo stesso, dall’altro, dal rinsecchire il socialismo attraverso
la eliminazione del pensiero della libertà e
Página 207
dello sviluppo individuali, che è anche suo proprio, facendone un ideale produttivo,
puramente economico, quale esso non è mai stato né sarà mai, in quanto movimento
che vive nelle masse.
Se gettiamo uno sguardo nella storia del socialismo, emerge che ciò che Kelsen
chiama la tendenza anarchica del marxismo, la negazione dello Stato e l’accentuazione
della libertà dell’individuo, di cui dovremo ancora discutere specificamente, ha
rappresentato sin dall’inizio una componente essenziale di ogni sistema di pensiero
socialista. In tal senso i grandi utopisti come Fichte e Weitling sarebbero tanto
anarchici quanto Bakunin o Tucker A Saint-Simon risale il pensiero fondamentale, che
Kelsen invero a torto (p. 178 di questo libro) ha presentato come una tesi tanto
costante quanto inconsistente della concezione anarchica, secondo la quale il governo
deve trasformarsi da un dominio sugli uomini in un’amministrazione di cose. In Robert
Owen troviamo un disinteresse, che impronta tutto il suo modo di agire e che si
accorda pienamente con l’anarchismo, troviamo anzi un rifiuto cosciente della lotta per
i diritti politici, per la qual cosa si comportò, com’è noto, in modo assolutamente
passivo di fronte al movimento cartista. Egli definisce ripetutamente leggi e governi
come le fonti del male. Cosí dice una volta in un brano programmatico, che agli uomini
viene imposta un’organizzazione sociale imperfetta attraverso « una trinità del potere
». Questa consiste: « in primo luogo, in religioni rivelate, escogitate dagli uomini; in
secondo luogo, in leggi che sono in contrasto con le leggi della natura; in terzo luogo,
in governi, basati sull’ignoranza e l’egoismo degli uomini [...] ». Al loro posto
subentreranno
ordinamenti per la produzione e la distribuzione della ricchezza, i quali sostengono se
stessi, poggiano su una base scientifica, senza il ricorso al sistema barbarico e ingiusto
finora adottato di punizioni personali e di ricompense personali. Questi nuovi
ordinamenti consisteranno in istituti, ognuno dei quali è destinato all’assorbimento e
alla conservazione di una comunità di 500-2000 anime nel consueto rapporto tra
uomini, donne e ragazzi; tali comunità si reggeranno grazie all’aiuto del loro sapere piú
avanzato e del loro zelo professionale diretto con cura, e si sosterranno attraverso gli
ausili illimitati della chimica e della meccanica, che saranno applicate per liberare gli
uomini da tutte le incombenze dannose alla salute e spiacevoli. (Nota 34)
Il discorso di Owen concorda quasi alla lettera con la descrizione di una comune
‘anarchica’ di Bakunin o di Kropotkin.
Fourier, infine, a maggior ragione di Proudhon dovrebbe essere
Página 208
chiamato il padre dell’anarchismo. Egli appartiene insieme a Stirner ai filosofi
dell’anarchismo, senza cessare con ciò di essere annoverato tra i più brillanti precursori
del socialismo. Il suo pensiero conduttore, infatti, è lo sviluppo completamente libero
dell’individuo attraverso il dispiegamento di tutti gli impulsi naturali, guidato da
nessun’altra potenza all’infuori di quella della « naturale attrazione ». « La scelta
completamente libera del lavoro, determinata dagli impulsi, è la destinazione dell’uomo
». Essa raccoglie gli uomini in « serie » e « file » di bisogni lavorativi, che si uniscono
nei falansteri, all’interno dei quali in questo modo la produzione non è più organizzata
attraverso una costrizione economica o politica, bensí « come lavoro organizzato su
base societaria (sozietar)». Una rete di siffatti falansteri dissolve, nello scambio e nel
sostegno reciproci, le precedenti aree economiche organizzate statalmente, la cui
essenza Fourier non si stanca di caratterizzare come un sistema di violenza
(Vergewaltigung) nei confronti della stragrande maggioranza dei suoi membri. Lo stato
civilizzato, che cos’è? « Una minoranza, i dominatori, arma degli schiavi, che tengono a
freno una maggioranza di schiavi disarmati » (Nota 35).
Storicamente, dunque, la negazione dello Stato e della costrizione di dominio non
costituisce una differenza all’interno della storia del socialismo. A partire da Godwin
tutti i pensatori della rivoluzione sociale rappresentano più o meno questo punto di
vista, e l’elemento decisivo è stato piuttosto unicamente la negazione dell’ordine
economico capitalistico, e l’esigenza di un nuovo ordinamento della produzione e della
distribuzione delle merci. Anche tra i pensatori che fanno parte dei precursori spirituali
dell’anarchismo, con un’unica caratteristica eccezione, nessuno, né Godwin, né Fourier,
né Stírner, si è dichiarato anarchico; questi ultimi due
Página 209
hanno al contrario definito l’ordine economico capitalistico come la vera e propria
anarchia e se stessi come coloro che lottano contro di essa. L’eccezione riguarda
Proudhon il quale già nel suo scritto Che cos’è la proprietà? si è presentato
esplicitamente come un anarchico. Ma proprio in questo caso è assolutamente chiaro
che egli con ciò intende la negazione e la soppressione dello Stato e del diritto di
classe, e infatti anche Marx, nella sua ampia e appassionata requisitoria contro
Proudhon, non menziona affatto in genere il suo anarchismo’, inteso come obiettivo,
cioè come sostituzione dell’ordinamento di dominio con una libera associazione fondata
sulla reciprocità, poiché ciò non costituiva un elemento differenziante rispetto al
socialismo. Ma certamente già nella Miseria della filosofia Marx combatte quelle
rivendicazioni tattiche che dovevano sfociare nell’indirizzo assunto da certe direzioni
dell’anarchismo posteriore, in particolare il rifiuto della lotta politica ed economica dei
lavoratori, in vista di un successo parziale all’interno della società esistente. Marx
caratterizza questa tattica, che concepisce la rivoluzione proletaria come un
rovesciamento (Umwalzung) esclusivamente sociale, senza nessuna via traversa
(Umweg) politica o economica, come una sorta di utopismo, come lo sforzo « di
lasciare da parte l’antica società per potere entrare tanto meglio nella nuova società »
(Nota 36). Di fronte a ciò Marx già in quest’opera giovanile richiama l’attenzione sul
fatto che nel mondo basato sui conflitti di classe non può darsi ancora una rivoluzione
sociale che non sia anche politica, e che anche la coalizione economica dei lavoratori,
oltre agli scopi puramente economici, deve assumere, attraverso l’acquisizione di
potere che essa conferisce alla classe operaia, un carattere necessariamente politico.
Non si dica che il movimento sociale esclude quello politico. Non vi è mai un
movimento politico, che non sia anche contemporaneamente un movimento sociale.
Soltanto in un ordine di cose, in cui non vi saranno più classi e conflitti tra le classi, le
evoluzioni sociali cesseranno di essere rivoluzioni politiche. (Nota 37)
Questa è dunque la critica di Marx all’ ‘ anarchismo ’ di Proudhon; essa si riferisce
esclusivamente alla via scelta per raggiungere l’obbiettivo, e né Marx né Engels hanno
considerato Proudhon altrimenti che un socialista, solo, certo, alquanto utopista e
piccoloborghese. Successivamente Proudhon ha sostituito, com’è noto, la
denominazione di anarchismo ’ con quella di mutualismo ’. Ed è interessante il fatto
che, dopo che l’anarchismo si è presentato come partito autonomo, esso non abbia
voluto — come fra poco
Página 210
sentiremo dire da Kropotkin — essere chiamato, sin dall’inizio e proprio riferendosi a
Proudhon, anarchismo ’, per evidenziare il fatto che non voleva essere identificato con
quello. In particolare si dovrebbe pensare, con ciò, al rifiuto, da parte di Proudhon,
della lotta rivoluzionaria e alla sua propensione utopistica a favore di uno sviluppo
pacifico in direzione della reciprocità (Gegenseitigkeit) grazie all’organizzazione del
credito.
La differenziazione tra socialismo e anarchismo si sviluppa per la prima volta in
concetti chiari e di partito a cominciare dall’attività svolta da Bakunin contro
l’Internazionale diretta da Marx e, perfino quest’attività, non significava ancora una
distinzione per quanto riguardava il fine, bensí, in questo caso, e proprio ora,
significava una distinzione semplicemente per quanto riguardava la via attraverso cui
raggiungere questo fine, per quanto riguardava la tattica e le forme del movimento
proletario. Era emersa con ciò una tendenza del socialismo, diversa da quella marxista,
e che inizialmente non chiamava affatto se stessa anarchica. Ed è significativo che
anche Marx ed Engels, proprio nei loro scritti polemici pubblicati in quel periodo contro
i fondatori di questa tendenza parlino di essi non come di anarchici, ma come di «
socialisti antiautoritari ». La denominazione di anarchico per questo movimento veniva
adoperata in effetti più dagli avversari borghesi, che sotto la pressione della «
propaganda » nichilista « dell’azione », facevano, a dire il vero, di ogni erba un fascio e
denunciavano ogni lotta contro l’ordine esistente come « anarchica ». Per il piccoloborghese, anche se non necessariamente ignorante, ancora ai giorni nostri anarchico e
socialista sono una medesima cosa. Riguardo alla origine di questa denominazione di
partito (Parteibezeichnung) Kropotkin dice:
Ci si rimprovera di aver scelto, come nostra denominazione, il termine anarchia, che
incute timore a tanta gente. [...] Prima di tutto dobbiamo osservare che un partito di
lotta, il quale si fa portavoce di nuove aspirazioni, raramente ha la possibilità di
scegliere autonomamente il proprio nome. Non sono i mendicanti di Brabante, ad
avere inventato questo nome, che più tardi divenne coti popolare. [...] La stessa cosa
’è accaduta agli anarchici. Allorché in seno all’Internazionale sorse un movimento che
negava la legittimità dell’autorità allo interno dell’associazione e si ribellava a ogni
forma di autorità in generale, questo gruppo prese — all’interno dell’Internazionale —
dapprima il nome di tendenza federalistica, più tardi antistatale o antiautori tana. In
quel periodo esso evitò persino di chiamarsi anarchico. La parola
An-archia, cosí si
scriveva allora, sembrava avvicinare troppo il nuovo gruppo ai seguaci di Proudhon, le
cui idee di riforma economica venivano, in quella fase, combattute dall’Internazionale.
Ma proprio per provocare confusione gli avversari si compiacquero di adoperare
Página 211
questo nome; del resto esso permise loro di sostenere che le uniche aspirazioni del
nuovo partito erano quelle di provocare disordine e caos, senza pensare alle
conseguenze. Il movimento anarchico si
affrenò ad adottare il nome che gli era
stato dato. All’inizio esso
insisteva ancora sul trattino tra an e archia, in quanto
metteva in evidenza che in questa forma An-archia, derivata dal greco, significa senza
dominio e non disordine; tuttavia ben presto assunse il nome, cosi come era, senza
cercare di dare lavoro supplementare ai correttori di bozze e una lezione di greco ai
propri lettori. (Nota 38)
Nello scritto polemico di Marx Un complotto contro l’Internazionale vediamo che gli
anarchici sono combattuti semplicemente in quanto rappresentano una tendenza
retorica, poco chiara a se stessa e contraddittoria, del socialismo; essi vengono definiti
membri dell’Alleanza della democrazia socialista (Allianzisten), anti autoritari,
rivoluzionari sleali ’, ma non anarchici. Piuttosto, il concetto di anarchia viene difeso da
Marx contro di essi. Scrive Marx nella circolare interna dell’ultimo Consiglio generale
dell’Internazionale:
L’anarchia, ecco il grande cavallo di battaglia del loro maestro Bakunin che di tutti i
sistemi socialisti ha ripreso soltanto le etichette. Per anarchia, tutti i socialisti
intendono quanto segue: una volta raggiunto lo scopo del movimento proletario:
l’abolizione delle classi, il potere dello Stato che serve a mantenere la grande
maggioranza dei produttori sotto il giogo di un’esigua minoranza di sfruttatori, si
dissolve e le funzioni governative si trasformano in semplici funzioni amministrative.
L’Alleanza affronta il problema al capo opposto. Proclama l’anarchia nei ranghi proletari
[...].(Nota 39)
Marx rivendica qui espressamente per tutti i socialisti il concetto di anarchia, inteso
come assenza dello Stato, il che significa sempre in lui la soppressione del dominio di
classe. La sua polemica concerne solo la tattica contraddittoria e disonesta, che divide
e confonde il proletariato, mediante la quale gli ‘ Alleanzisti ’ mirano a questo obiettivo,
la loro lotta retorica contro l’autorità, mentre contemporaneamente, in associazioni
segrete, pongono le basi per un’autorità illimitata del comitato centrale, e il putschismo
con cui essi vogliono persuadere i lavoratori che lo Stato può essere abolito ’ dall’oggi
al domani.
Del tutto analogamente la critica di Engels verso gli anarchici nel suo scritto, apparso
nel 1873, I bakuninisti al lavoro sfocia soltanto nella dimostrazione che la tattica
raccomandata da Bakunin come l’unica effettivamente rivoluzionaria, non solo non ha
raggiunto
Página 212
il suo obiettivo, ma è destinata al fallimento. Egli non rimprovera agli anarchici il fatto
di essere tali, cioè la loro volontà di distruggere lo Stato, — anch’egli si propone una
cosa del genere — ma che, imboccando la strada del putschismo, non potevano affatto
restare anarchici. « Invece di sopprimere lo Stato, essi hanno tentato piuttosto di
creare una moltitudine di nuovi e piccoli Stati. » Egli dimostra che gli anarchici avevano
una visione cos í poco realistica delle necessità economiche e politiche della lotta di
classe del proletariato, che furono costretti, « non appena si trovarono di fronte a una
vera situazione rivoluzionaria, a gettare a mare tutto il loro programma precedente »
(Nota 41), prima di tutto il rifiuto di partecipare all’attività politica, in particolare alle
elezioni, quindi il disinteresse nei confronti di una rivoluzone che non conduca a
un’immediata emancipazione (Ernanzipation) del proletariato, e infine il rifiuto di
entrare a far parte di governi borghesi rivoluzionari. L’intera critica di Engels si riferisce
sempre unicamente a questa forma, contraddittoria sia dal punto di vista teorico che
tattico, del movimento operaio bakuninista, ma in nessun luogo a’un rifiuto del suo
obiettivo anarchico. Ciò affiora con particolare evidenza nel risultato finale riassuntivo:
« In breve i bakuninisti in Spagna ci hanno fornito un esempio insuperabile di come
non va fatta una rivoluzione » (Nota 41). E per questo ancora nel 1894, nella
Prefazione alla riedizione del suo saggio contro i bakuninisti, cfefinisce l’azione degli
anarchici una « caricatura del movimento operaio » In compenso anche Engels, e
quasi negli stessi termini di Marx, difende contro gli anarchici il concetto di « anarchia
», vale a dire l’abolizione dello Stato. In un articolo apparso nel 1874, e diretto contro i
seguaci italiani di Bakunin, che N. Rjazanov ha reso di nuovo disponibile nella « Neue
Zeit », leggiamo:
Tutti í socialisti sono d’accordo nel ritenere che lo Stato e con esso l’autorità politica
spariranno in seguito alla rivoluzione sociale futura; che cioè le funzioni pubbliche
perderanno il loro carattere politico e si trasformeranno in funzioni amministrative che
soprintendono agli interessi sociali. Ma gli antiautoritari pretendono che lo Stato
politico sia soppresso in un sol colpo, ancor prima che siano aboliti i rapporti sociali che
lo hanno prodotto. (Nota 43)
Página 213
Anche qui la critica di Engels nei confronti degli antiautoritari è riferita al lato
contraddittorio e deleterio della loro tattica. Infatti subito dopo ciò prosegue:
Essi pretendono che il primo atto della rivoluzione sociale debba essere l’abolizione
dell’autorità. Ma hanno mai visto una rivoluzione, questi signori? Una rivoluzione è
indubbiamente la cosa più autoritaria che vi sia, un atto attraverso il quale una parte
della popolazione impone la sua volontà all’altra parte con fucili, baionette e cannoni,
tutti mezzi quindi molto autoritari; e il partito che ha vinto, deve conservare il suo
dominio attraverso il terrore che le sue armi incutono ai reazionari. [...] Dunque o una
cosa o l’altra: o gli antiautoritari non sanno essi stessi che cosa dicono e in tal caso
provocano solo confusione, o lo sanno e tradiscono la causa del proletariato. In
ambedue i casi favoriscono solo la reazione. (Nota 44)
D’altra parte Engels nella lettera sull’abbozzo del Programma di Gotha, che Bebel
ha pubblicato, davanti alla pretesa, formulata nell’abbozzo, del « libero Stato
popolare » ha energicamente respinto, com’è noto, questo tipo di discorso e proprio
in riferimento al fatto che con ciò si dava inutilmente agli anarchici la possibilità di
criticare l’adorazione dei socialisti per lo Stato.
Si dovrebbe lasciar cadere tutte le chiacchiere intorno allo Stato — scrive Engels — in
particolare a partire dalla Comune che già non era più uno Stato propriamente detto.
Lo Stato popolare » ci è stato gettato in faccia fino alla nausea, da parte degli
anarchici, sebbene già lo scritto di Marx contro Proudhon, e successivamente il
Manifesto comunista, affermino direttamente che con l’introduzione dell’ordine sociale
socialista lo Stato si dissolve da se stesso e scompare.
(Nota 45)
Non si può sottolineare con maggiore evidenza che l’obiettivo dell’anarchismo è lo
stesso di quello del socialismo marxista. E ogni critica che Marx ed Engels rivolgono
agli anarchici mira soltanto a dimostrare, come abbiamo visto, sempre di nuovo che
l’anarchismo è da un lato una direzione di pensiero assolutamente utopistica, ma
dall’altro che con la sua teoria individualistica e, ancor più, con la sua azione insensata,
ha compromesso e reso
Página 214
sospetto ai lavoratori l’obiettivo importante e necessario dal punto di vista economico
del raggiungimento di una società senza Stato [Nota 46].
4. Socialismo e individualismo
Come risultato delle analisi precedenti possiamo forse indicare l’esatta comprensione
del fatto che, per quanto riguarda l’obiettivo, socialismo e anarchismo rappresentano
soltanto due vie diverse per un medesimo punto d’approdo, la società senza classi, la
dissoluzione dello Stato. Questa conoscenza è un presupposto fondamentale per una
migliore comprensione del rapporto storicospirituale tra queste due direzioni,
storicamente differenziate, della lotta di classe del proletariato, e in tal modo ci si
sottrae una volta per tutte alla tentazione di scorgere, in ciò che Kelsen chiama la
componente ‘anarchica’ del marxismo, una contraddizione interna rispetto alla sua
visione di fondo socialista. Piuttosto questi elementi ‘anarchici’ solo nel marxismo
ricevono il loro consolidamento teorico, nella misura in cui essi non si presentano come
una semplice protesta contro la costrizione statale, ma come un prodotto dello sviluppo
economico. Lo Stato non viene ‘soppresso’, ma ‘si estingue’, vale a dire: nel corso di
un grande processo storico di sviluppo, nel quale sia le condizioni di vita esteriori, sia
gli uomini, che stanno in esse, vengono cambiati, anche l’ordinamento costrittivo della
società si trasforma radicalmente.
Ma per consolidare questa valutazione piú esatta delle relazioni tra socialismo e
anarchismo, è indispensabile fare ulteriore chiarezza su un punto che non solo nella
polemica di Kelsen, ma, anche al di là di essa, nelle frequenti discussioni su socialismo
e
Página 215
individualismo richiede una qualche delucidazione. Si tratta cioè dell’ambiguità relativa
al concetto di individualismo e di libertà individuale. In particolare tutto ciò che Kelsen
afferma riguardo al presunto ‘individualismo’ degli scritti giovanili di Marx, è vittima di
questa ambiguità.
Vorrei sin dall’inizio, sulla base di alcuni criteri generali evidenziare questa ambiguità
e annullarla attraverso una rigorosa separazione dei due significati. Individualismo può
significare in un caso l’affermazione (Durchsetzung) senza limiti del proprio Io,
nell’altro semplicemente il dispiegamento (Entfaltung) onnilaterale del proprio Io. La
prima volta individualismo significa un assoluto atomismo del punto di vista in base al
quale il singolo, in quanto vive in una condizione di isolamento, vede il mondo, e il
prossimo, per cosí dire, solo come il campo — disteso intorno a sé — delle sue
aspirazioni egoistiche, ma nell’altro caso rappresenta una tendenza verso
l’approfondimento (Verinnerlichung) e il perfezionamento della propria personalità, la
quale, in quanto tale, non conduce alla frattura rispetto agli altri uomini, ma sente
l’armonica fusione con essi come un elemento del proprio coerente sviluppo vitale.
L’individualismo nel primo significato è un tendere verso l’autogodimento, nell’altra
accezione è un tendere verso l’autoformazione; l’obiettivo del primo tipo di
individualismo è il dispotismo della persona, quello dell’altro l’autodisciplina della
personalità; il primo lascia l’individuo libero di fare, l’altro lo pone sotto la guida di una
individualità. Ibsen, che cosí di frequente è stato screditato come un profeta
dell’individualismo, mentre fu solo lo straordinario apostolo di una teoria della
individualità, ha rappresentato stupendamente le due aspirazioni, che cosí spesso gli
uomini confondono, in quanto la piú bassa assume la maschera di quella piú elevata,
nelle due figure di Peter Gynt e Brandi, i quali nelle loro sentenze che denotano scelte
di vita (Lebenswahlsprüche) tracciano con insuperabile plasticità il carattere
fondamentalmente diverso delle due direzioni: “sii sufficiente a te stesso” suona il
motto dell’individualismo, “sii fedele a te stesso” quello dell’individualità.
Se chiamiamo individualismo l’aspirazione alla formazione (Bildung) di una
personalità e individualità libere, che sviluppano pienamente se stesse, ci adeguiamo
con ciò a un uso linguistico invero molto diffuso, ma tale da risentire abbondantemente
della imprecisione del linguaggio popolare, vale a dire che non si propone una
differenziazione concettuale, ma soltanto di esprimersi appunto in modo sbrigativo e
irriflessivo. Per un esame scientifico e una critica di teorie e prese di posizione sociale,
un tale uso linguistico è del tutto inadeguato. In questo senso Fichte, ad esempio,
sarebbe un ‘individualista’, addirittura estremo, e, se quePágina 216
sto individualismo conduce inevitabilmente all’anarchismo, anche un anarchico, in
quanto egli era effettivamente persuaso «che lo scopo di ogni governo è quello di
rendere superfluo il governo». Infatti tutti i suoi scritti prescrivono il libero
dispiegamento della personalità; e tuttavia nessuno ha non soltanto identificato con piú
vigore di lui tale libero sviluppo con l’assoggettamento al dovere etico, ma, oltre a ciò,
esposto il concetto di un individuo incentrato in se stesso, come una semplice
apparenza paralogica [Nota 47].
Proprio quest’ultima circostanza richiama la nostra attenzione sul fatto che il tendere
al dispiegamento della personalità, nella libertà di tutte le sue facoltà, è pienamente
compatibile con un punto di vista universalistico, (volendo adoperare questa
espressione altrimenti — in particolare dal punto di vista gnoseologico — molto
ingannevole). Se per universalismo si intende la intuizione, secondo la quale l’individuo
non va considerato come un atomo, che può esistere in modo autonomo, ma soltanto
una componente indisgiungibile di una connessione che oltrepassa l’essere individuale,
allora Fichte è l’esempio piú illuminante del fatto che il tendere verso l’individualità non
solo non è necessariamente in conflitto con tale universalismo, ma addirittura lo
presuppone. E in quanto questa aspirazione verso l’espressione (Ausprägung) della
propria personalità viene definita molto frequentemente anche individualismo, bisogna
tener presente che esiste un tipo di individualismo, che non sta in conflitto con il
cosiddetto universalismo.
La diversità tra le due direzioni, celata sotto lo stesso nome di individualismo, affiora
in tutta la sua evidenza se ci si sofferma sull’altro concetto che si trova in una relazione
molto intima con quello di personalità, il concetto di libertà. Infatti anche questo
termine designa un duplice contenuto. Da un lato può significare la mancanza di ogni
vincolo (Gebundenheit), dunque l’assoluta assenza di limiti e di leggi; dall’altro, al
contrario, proprio l’assoggettamento della volontà a una legge, che però non è altro
che quella della volontà stessa, quindi il vincolo (Gebundenheit) del volere attraverso
l’autodeterminazione. È superfluo discutere piú a lungo sul fatto che soltanto l’ultimo
significato dà un concetto di libertà realmente non contraddittorio. E questo non è
all’incirca soltanto il concetto di libertà della filosofia classica tedesca — la quale ha
tentato di fondarlo su un piano puramente gnoseologico — ma quella rappresentazione
della libertà alla quale fa ricorso anche il semplice pensare di ogni giorno, se soltanto
comincia a rendersi conto del contenuto di ciò che pensa. È vero,
Página 217
al primo sguardo, la coscienza comune ritiene che la libertà consista nell’assenza di
ogni genere di limiti, nel poter fare dunque ciò che a ognuno piace. Ma se si richiama
l’attenzione sul fatto che questo ‘piacere’ una volta è un capriccio che fa smarrire ogni
altra considerazione, un’altra volta è una impetuosa agitazione, di cui si è vittima, in
un terzo caso è un calcolo egoistico di cui internamente ci si vergogna, un’altra volta,
infine, è una totale mancanza di senno e solo di tanto in tanto una risoluzione che
proviene realmente da un intimo convincimento, appare immediatamente chiaro che in
ognuno di questi piaceri individuali il volere non era affatto ‘libero’, l’agente non faceva
affatto ciò che gli riusciva gradito, bensí ciò che la situazione, in cui veniva
precisamente a trovarsi, desiderava per mezzo suo. A questo punto viene fuori
l’autentico e il solo possibile significato di libertà, che è quello di obbedire si, ma
soltanto a se stessi, di riconoscere invero una legge, ma di eseguire soltanto un
comando che sale dalla propria interiorità.
È immediatamente chiaro che i due significati del concetto di libertà vengono a
coincidere con i due significati del concetto di individualismo. Quel primo significato in
cui l’individualismo corrispondeva pienamente a un’affermazione totale e senza riguardi
dell’individuo, fa propria l’opinione, secondo la quale la libertà è per l’appunto assoluta
mancanza di limiti. L’altro significato, secondo il quale l’individualismo comporta la
espressione della individualità della personalità, del proprio carattere, richiede
apertamente, come suo completamento, il concetto di libertà nel senso
dell’autodeterminazione, la quale — si tratta di un elemento che non occorre
sviluppare, perché rappresenta lo straordinario esito della filosofia classica tedesca —
non può essere niente altro che un’autodeterminazione etica, in quanto è la sola ad
essere possibile in modo non contraddittorio.
E in relazione al nostro oggetto è particolarmente importante trarre da ciò
un’ulteriore conclusione: la libertà nel senso dell’autonomia della volontà è un concetto
assolutamente sociale. Appartiene ai piú gravi equivoci, di cui è stata ed è ancora
vittima la filosofia kantiana, cosí spesso fraintesa, il fatto che essa viene concepita
come una filosofia individualistica, perché ha ricercato, apparentemente, sia la legalità
del processo conoscitivo che di quello volitivo, solo nel singolo individuo e in
riferimento a esso, viceversa è sembrata non avere alcuna considerazione per il dato di
fatto (Faktum) costituito dalla società. Ma non si presta sufficiente attenzione a come
in Kant e, quindi, in tutta la filosofia classica tedesca posteriore, l’individuo sia soltanto
una forma fenomenica, in cui si dispiega un contenuto il cui significato, che va oltre
l’individuo e raccoglie spiritualmente gli individui in valori validi uniPágina 218
versalmente, costituisce anzi esattamente il problema nodale della filosofia critica. Già
una volta ho fatto perciò rilevare che, sebbene il concetto di sociale da Kant fino a
Feuerbach non sia stato, in quanto tale, ancora coniato dal punto di vista
terminologico, tuttavia questa filosofia nella sua globalità dev’essere caratterizzata
come il primo importante tentativo di una fondazione gnoseologica del nesso sociale,
una caratteristica che spero di esporre presto dettagliatamente. Nell’ambito del nostro
discorso bisogna sottolineare come già in Kant la legge fondamentale dell’autonomia
del volere, l’imperativo categorico, attraverso la sua formula: “agisci in modo che tu
possa volere che la massima delle tue azioni diventi legge universale”, stabilisca, tra il
singolo individuo e tutti gli altri che lo circondano, una connessione che non è niente
altro appunto che la connessione sociale. Il concetto di libertà come autonomia del
volere è del resto possibile in modo non contraddittorio solo in un sistema di volere, il
che significa però in un sistema sociale: e perciò la libertà in questo senso è possibile,
proprio come si è già visto in relazione all’individualità, solo da un punto di vista
universalistico.
Nel disconoscimento di questo rapporto, nella scarsa chiarezza circa il diverso
significato nel quale si può discutere di individualismo e di libertà, risiedono le effettive
contraddizioni e le incomprensioni che sono proprie principalmente della tendenza
individualistica dell’anarchismo, come si fa sentire con particolare intensità nella
agitazione popolare attraverso opuscoli e giornali. Anzi in generale la concezione di
fondo della vita sociale è il vero e proprio errore fondamentale di questa tendenza nel
suo complesso, la quale però nel suo rappresentante piú geniale, Max Stirner, di fatto
è piú un rifiuto delle sublimazioni del nesso sociale, inteso nel senso di vincoli in sé
sacri del diritto, della legge e dello Stato, anziché una dissoluzione di questi vincoli
stessi [Nota 48].
Infatti è oltremodo istruttivo vedere che proprio questo individualista estremo ha
avuto uno scarsissimo interesse per «la libertà illimitata». La sua opera principale non
si intitola “Il
Página 219
libero e la sua proprietà”, bensí L’unico e la sua proprietà. E l’intero libro si è sforzato
di sottolineare questa distinzione.
Si legge nell’importante capitolo sulla ‘particolarità’ (Eigenheit).
Non ho nulla da obiettare contro la libertà, ma ti auguro qualcosa in piú che non la
sola libertà; tu non dovresti semplicemente essere libero sciolto da ciò che non vuoi,
dovresti anche avere ciò che vuoi, non dovresti essere soltanto ‘libero’, ma anche
‘proprio’ (Eigener).
E subito dopo:
Che differenza tra la libertà e la particolarità! Di molte cose è possibile liberarsi, ma
non già di tutte. [...] Al contrario la particolarità (Eigenheit) costituisce la mia essenza
ed esistenza, ciò che io stesso sono. Libero sono da ciò da cui mi distacco, sono
proprietario (Eigner) viceversa di tutte le cose che ho in mio potere e su cui esercito un
potere. Mio proprio lo sono sempre e in tutte le circostanze in cui comprendo di
possedere me stesso e non mi degrado in qualcosa d’altro. [Nota 49].
In conclusione:
Che una società, ad esempio lo Stato, restringa la mia libertà mi indigna poco. Debbo
consentire che la mia libertà sia limitata da potenze di ogni genere, da chiunque risulti
píú forte, anzi da ogni uomo che mi circonda e se fossi lo zar di tutte le Russie non
godrei di un’assoluta libertà. Ma la particolarità è ciò che non voglio lasciarmi sottrarre.
[Nota 50]
Pertanto l’individuo, radicalmente trasformato, di cui parla Stirner, si chiama un
«unico», perché deve svilupparsi in una individualità che sia sempre qualcosa di unico.
La unicità di Stirner non indica un isolamento, ma particolarità, specificità, e la
proprietà dell’unico non è un possesso materiale, bensí il possesso di se stessi,
un’autodeterminazione. Solo che in Stirner questa grandiosa condotta di pensiero, con
la quale si è attestato come uno schietto discendente della filosofia classica tedesca, ha
assunto quella svolta, in virtú del suo tratto ‘antimetafisico’, in termini di estremo
individualismo, quella svolta che forse è piú verbale che oggettiva, ma che ad ogni
modo ha continuato ad agire nel primo significato. Ma, per quanto riguarda la cosa
stessa nessuno
Página 220
ha rappresentato l’individuo che pensa puramente a se stesso, l’egoismo ottuso e
‘maniaco’, la misera sfera dell’utile personale e il meschino isolamento da ogni altra
cosa, in una cosí brillante caratterizzazione psicologica, vedendo in essi una forma di
mancanza di libertà e di «ossessione», come ha fatto appunto Stirner [Nota 51].
Cosí si dimostra che anche nel piú estremo individualismo l’obiettivo non è la libertà
come assenza di limiti, che non tollera alcuna costrizione, ma la particolarità, la quale,
dove lo ritenga utile, cioè nei casi in cui scaturisce dalle sue condizioni di vita e di
sviluppo, impone a se stessa l’autolimitazione come sua propria volontà e come suo
proprio vincolo.
Esiste una differenza — dice Stirner — a seconda che attraverso una società è la mia
libertà o la mia particolarità ad essere limitata. Nel primo caso sorge solo
un’associazione, un’intesa, un’unione; ma se è la particolarità ad essere minacciata di
morte, la società è una potenza per sé, una potenza su di me [...]. [Nota 52]
In conclusione possiamo dunque dire: il concetto di individualismo è duplice, in
quanto può significare tanto l’affermazione senza riguardi dell’individuo, quanto la
tendenza perseverante verso la formazione della propria personalità; sia la libertà
senza limiti, che sicuramente è solo una libertà immaginaria, sia anche la libertà
dell’autodeterminazione della personalità. Il nucleo effettivo dell’individualismo resta
indubbiamente la concezione fondamentale del primato del singolo nei confronti della
società, in modo tale che questa sorge soltanto come risultato dello stare insieme e del
cooperare dei singoli; e nei limiti in cui il marxismo, che prende le mosse dalla
socializzazione dell’individuo, non conosce un individuo, esistente per sé, che si unisca
ad altri individui solo per formare la società, si trova in linea di principio in conflitto con
ogni individualismo. Ma i concetti di libera individualità e di libera autodeterminazione,
al contrario, non sono tali da essere collegati necessariamente con quella intuizione di
fondo individualistica, né come suo presupposto, né come suo risultato. Piuttosto essi
in ciascuna delle due tendenze, pensate fino in fondo, eliminano il presupposto
fondamentale dell’individualismo, il che non impedisce che si trovino di fatto molto
spesso collegati col modo di pensare individualistico e sembrino addirittura fornire ad
esso una giustificazione etica. In ogni singolo caso in cui si discute di libertà dell’uomo,
di autodeterminazione da parte dell’Io, di liberazione della personalità, bisogna sempre
indagare prima di che tipo di individualismo e di quale libertà si parla e si vedrà poi
Página 220
che non di rado l’esposizione individualistica racchiude un contenuto universale, per cui
condannando un ragionamento in quanto individualistico viene messa a nudo soltanto
la propria mancanza di chiarezza concettuale. Ma l’apice della confusione viene
pienamente raggiunto, allorché si equipara individualismo a anarchismo, per cui le
rappresentazioni universalistiche di libertà e individualità appaiono addirittura
ridicolizzate, come un tendere verso una libertà di tipo ‘anarchico’.
Con ciò può dirsi senz’altro concluso, in questo contesto, un excursus sull’anarchismo,
che si è protratto un po’ a lungo. Non si è trattato di una difesa dell’anarchismo: la sua
essenza storica specifica, la sua tattica contraddittoria, sconcertante e dannosa della
lotta di classe in generale non è da difendere, ma unicamente da combattere. Ma
proprio questa lotta può risultare vincente solo se su una serie di concetti e
rappresentazioni, — abolizione dello Stato, soppressione dell’autorità, eliminazione
della costrizione, libertà dell’individuo ecc. — i quali sono comuni sia al socialismo che
all’anarchismo, esisterà una maggiore chiarezza. In questa ‘difesa’ dell’anarchismo si è
trattato esclusivamente della dissoluzione dell’apparente collegamento di questi
concetti con l’anarchismo e di evitare, sulla base di ciò, i fraintendimenti in cui incorre
la critica kelseniana, la quale parla di un anarchismo della concezione marxista, il che
sarebbe possibile in essa solo a patto di una mortale autocontraddizione — si è trattato
dunque soltanto di una migliore comprensione del socialismo marxista. Questa migliore
comprensione la si dovrà ora applicare.
Página 222
Capitolo sedicesimo
Il presunto anarchismo del marxismo
1. L’idea di liberazione
Se vogliamo soffermarci piú dettagliatamente sulle affermazioni fatte da Kelsen
riguardo alla contraddizione di fondo, anarchica, presente nel marxismo, conviene
prendere le mosse immediatamente dal punto in cui ci siamo fermati nell’ultimo
capitolo, dall’idea di libertà. In questa idea, che gioca sicuramente un ruolo importante
nel marxismo, Kelsen scorge particolarmente accentuata la tendenza anarchica del
pensiero marxista — cioè, in Kelsen, la tendenza alla organizzazione non costrittiva
della società. A suo avviso il socialismo conduce da un lato, sulla base dello sviluppo
economico, a un sistema di economia regolata con criteri rigorosamente razionali,
dall’altro si presenta nella coscienza di Marx ed Engels in primo luogo come una
liberazione dell’individuo. Questa concezione ‘anarchica’ Kelsen la trova già formulata
negli scritti giovanili di Marx, e principalmente il mio saggio su L’idea socialista di
liberazione in Karl Marx [Nota 1] gli ha fornito il materiale per un’affermazione del
genere. Solo che egli ha compreso cosí poco i principi marxiani, là presenti, nel
contesto globale da cui provengono, che l’idea sociale di emancipazione in Marx gli si è
trasformata immediatamente «nella idea individualistica di libertà» (p. 20 [51]);
l’elemento caratterizzante di quest’ultima consiste per Kelsen nel fatto che da essa
scaturisce, come senso dello sviluppo sociale, la liberazione della società, dunque uno
stato di libertà che è in contrasto con i precedenti vincoli economici e politici (p. 21
[52-3]). Per Kelsen dunque uno stato di libertà equivale all’anarchia, soltanto perché
esso ‘evidentemente’ significa la soppressione dei vincoli sia politici che economici. Ma
lo stesso Kelsen in quel brano accenna al fatto che già dal giovane Marx
Página 223
questa soppressione è concepita come un movimento storico, ma non procede
all’applicazione di una tale affermazione. Egli non si avvede che in Marx non si tratta di
uno sviluppo che da «una situazione vincolante (Gebundenheit) in generale» conduca a
uno stato in cui non esistono vincoli, tale da non essere neppure piú uno stato sociale,
ma del superamento di una determinata situazione storica vincolante attraverso un
nuovo ordinamento sociale predisposto a livello economico, il quale solo in relazione
all’ordinamento precedente deve apparire piú libero, perché in esso non può esistere
piú un potere di classe.
Del resto è straordinario e molto istruttivo per la comprensione della psicologia della
ricerca, vedere come anche un pensatore critico e acuto possa nondimeno restare cosí
irretito nel suo schema di pensiero da non riuscire semplicemente, al di là di esso, a
pervenire alla stessa valutazione dei nessi che apertamente non si adattano a questo
schema. Cosí Kelsen, in modo addirittura inconcepibile, ha frainteso nel suo complesso
il significativo concetto di emancipazione, che svolge un ruolo essenziale nelle opere
giovanili di Marx e nel quale si trova espresso per la prima volta, sebbene in forma
ancora ideologica, il punto di vista sociale marxiano, nella misura in cui un tale
concetto viene interpretato semplicemente come una parola d’ordine di liberazione
individuale. E questo fraintendimento appare tanto piú incomprensibile in quanto il mio
saggio, citato in precedenza, cui si richiama anche Kelsen, è dedicato interamente al
chiarimento di questo concetto e in particolare alla differenza decisiva istituita da Marx
tra emancipazione politica e emancipazione umana. Su questa analisi complessiva
Kelsen non si è soffermato neppure di sfuggita e vedremo come da ciò scaturisca la
polemica, che manca completamente il bersaglio, contro il concetto marxista dello
«Stato politico». Non posso qui ripetermi e pertanto mi limiterò a quel tanto che è
necessario dire in questa occasione. Il concetto di emancipazione non è in Marx, già a
partire dagli scritti giovanili, un concetto di redenzione (Erlösung) individuale, ma
senz’altro una categoria storico-sociale. In base a ciò si spiega l’insistenza con la quale
Marx sottolinea che l’emancipazione non è possibile come un atto di liberazione
individuale, ma solo su una base sociale, in virtù del fatto che di volta in volta «una
determinata classe, muovendo dalla sua situazione specifica, intraprende
l’emancipazione generale della società» [Nota 2]. Per questo motivo l’idea di
emancipazione, quale finora si è manifestata, era contraddittoria. Nei casi in cui cioè la
situazione specifica della classe emancipatrice contiene essa stessa ancora elementi di
dominio e di oppressione, come accade ad
Página 224
esempio nella emancipazione della borghesia, anche l’emancipazione è soltanto
parziale. Perciò Marx distingue questa emancipazione, in quanto puramente politica, da
quella universalmente umana, che non avrà per risultato la libertà del borghese, bensí
la libertà dell’uomo. L’emancipazione umana può dunque attuarsi solo muovendo dal
punto di vista di una classe le cui condizioni di libertà siano tali da avere un carattere
universale, «di una sfera, che non si può emancipare senza emanciparsi da tutte le
restanti sfere della società e con ciò emancipare tutte le rimanenti sfere della società»
[Nota 3] — in breve dal punto di vista del proletariato. Come si vede la emancipazione
umana, nel giovane Marx, non è un anelito verso una redenzione individuale
(Erlösungssehnsucht), ma nient’altto che la rivoluzione sociale del Marx maturo. E la
definizione della emancipazione come un’emancipazione umana doveva addirittura
porre l’accento — indubbiamente sotto l’influsso di Feuerbach, che proprio in quel
periodo aveva svolto la sua azione di stimolo — sul lato generico (Gattungsmässige),
sull’elemento sociale di tutte queste idee di libertà, lotta e rivoluzione, per cui già si
annuncia il passo in avanti di Marx rispetto a Feuerbach. Infatti in quest’ultimo il lato
generico, l’uomo, è un’astrazione filosofica, mentre in Marx una formazione concreta
va compresa sempre nel contesto storico — di classe, cui appartiene.
L’«idea di liberazione» non è dunque in Marx un pensiero individualistico ma un
processo sociale-storico, che, da un’ideologia ‘politica’, nella quale la lotta è finalizzata
ancora a un semplice cambiamento giuridico, spinge verso una ideologia ‘umana’, nella
quale si combatte per il mutamento delle forme sociali di vita. Per questo motivo per
Marx la rivoluzione politica è soltanto un’emancipazione parziale, l’emancipazione
umana viceversa è totale. In ambedue i casi però si tratta di processi sociali, la cui
essenza comporta che il singolo si ritrovi proprio nella prima ipotesi isolato, in quanto
libero cittadino, e proprio nell’altra solo come membro di una comunità umana può
sperare di diventare libero.
Il singolare disconoscimento di questa natura assolutamente sociale del concetto di
emancipazione umana, che comprende l’individuo solo all’interno del genere, e il suo
capovolgimento in un principio individualistico di redenzione, conducono Kelsen ad una
conclusione quasi grottesca per ogni marxista, in quanto egli individua nella frase di
Marx: «La natura umana è la vera comunità umana» [Nota 4] l’ammissione di un...
individualismo estremo «che nella sua applicazione pratica al problema sociale non
indietreggia affatto
Página 225
davanti all’audace conseguenza dell’anarchismo» (p. 26 [57] ). Non si sa davvero che
cosa dire di fronte a una tale affermazione! Tanto può allontanarsi dalla intima verità
del pensiero marxiano, il quale in realtà non è facilmente disconoscibile in base alla
connessione dell’intero, una critica che ritiene di poter esercitare la propria funzione in
relazione a singole parti di questo lavoro concettuale, a proposizioni assunte
isolatamente, per giunta con delle proprie rappresentazioni e non con quelle
dell’oggetto criticato. Kelsen ha evidentemente identificato la frase precedente con la
espressione di Protagora, secondo la quale l’uomo è la misura di tutte le cose. Poi,
però, egli ha tuttavia trascurato il fatto che lo stesso concetto è tradotto
dall’individualismo dei grandi sofisti nell’universalismo di Feuerbach. La proposizione
bollata da Kelsen come anarchica proviene sicuramente da Feuerbach, filosofo
entusiasta, che finora nessuno ha mai giudicato come un individualista, e ancor meno
come un anarchico. Ma se si sa che Marx si esprime qui completamente al di fuori della
concezione di Feuerbach, allora si vede subito che l’essenza umana, di cui Marx qui
parla, non è l’io sovrano dell’individualista ma l’essenza generica dell’uomo, cioè ciò
che Marx ha chiamato piú tardi la sua essenza socializzata; in particolare, il dato di
fatto sociologico fondamentale, che l’individuo in tutti i suoi modi di agire ‘individuali’,
nel pensare, sentire e volere, è in relazione sin dal principio con gli individui della sua
specie, e, nella sua manifestazione storica, sin dall’inizio può esistere solo all’interno di
rapporti sociali. In tal modo diviene chiaro perché l’essenza umana è «la vera
comunità» degli uomini. Ogni legame sociale infatti, ogni Stato, qualsiasi forma di
comunità ha già il suo presupposto in questa originaria socialità del singolo uomo, sia
come fondamento concettuale, sia come fondamento reale.
2. Forze politiche e forze sociali. Lo ‘Stato politico’
Sicuramente Kelsen, prigioniero — come in un cerchio magico — dei suoi pregiudizi
individualistici riguardo a Marx, non sa che farsene di questo concetto marxiano di ente
generico (Gattunswesen). Esso costituisce per lui motivo d’imbarazzo ed egli rimane
perplesso di fronte alla frase famosa, secondo cui l’emancipazione umana è compiuta
solo quando «il reale uomo individuale [...] nel suo lavoro individuale, nei suoi rapporti
individuali è divenuto ente generico, soltanto quando l’uomo ha riconosciuto e
organizzato le sue ‘forces propres’ come forze sociali, e perciò non sePágina 226
para piú da sé la forza sociale nella figura della forza politica» [Nota 5]. Per questo
Kelsen ritiene che, in particolare, poiché lo Stato tuttavia non è niente altro che una
organizzazione delle forze sociali, la distinzione della forza sociale da quella politica può
significare soltanto che, in quest’ultima, sia stata organizzata una parte delle forze
sociali; per cui la divisione della forza sociale da quella politica verrebbe superata o
perché tutte le forze sociali vengono organizzate politicamente, o perché scompare
ogni organizzazione politica delle forze sociali. Nella prima ipotesi la società viene
completamente statalizzata, nell’altra cessa di esistere lo Stato, cioè ogni forma di
organizzazione costrittiva. Marx avrebbe sostenuto questa seconda ipotesi e il rilievo
conferito all’essenza generica, con il contemporaneo rifiuto dello Stato, si spiega solo in
base al fatto che «egli ha in mente la libera associazione degli individui» (pp. 25-6
[57]).
A questo punto si può vedere ancora una volta in azione il formalismo dei concetti
kelseniani che sovrappone di volta in volta questi ultimi al senso specifico del loro
oggetto. Per funzioni politiche, quindi anche per forza politica, Kelsen intende sempre
una funzione dello Stato, in quanto organizzazione costrittiva in generale. Perciò per lui
le funzioni politiche e le funzioni statali coincidono e l’espressione «Stato politico», che
si ritrova in Marx ed Engels, è un controsenso (p. 44 [84]). Ma proprio questo uso
linguistico avrebbe dovuto richiamare l’attenzione di Kelsen sul fatto che una tale
assurdità esiste solo nel suo pensiero e che per il marxismo in fin dei conti ha ancora
un senso parlare di uno Stato non politico, perché il concetto di politico ha in questo
caso un significato specifico, vale a dire è in una determinata antitesi rispetto
all’elemento sociale. Marx infatti già negli scritti giovanili col termine Stato non intende
l’organizzazione costrittiva, in quanto tale, ma lo Stato borghese, dunque un dominio
di classe storicamente determinato. In base a ciò per lui atti politici e forze politiche
sono fenomeni storici, nei quali appunto la loro natura sociale, in quanto tale, è ancora
dissimulata dietro la forma particolare, attraverso la quale si presentano come
esercizio di interessi statali. Nello Stato borghese le sue funzioni non appaiono, né
possono farlo, come funzioni sociali perché non rappresentano il punto di vista della
società, bensí quello di una sua parte, della classe che domina la società. Certo lo
Stato, come dice Kelsen, non è nient’altro che un’organizzazione assolutamente
determinata delle forze sociali, ma non ancora un’organizzazione sociale, in quanto in
essa le forze sono organizzate solo in vista del dominio di classe, pertanto anche qui le
forze sociali non sono comprenPágina 227
sibili, per il singolo, come le sue proprie funzioni generiche, ma come potenze che gli
sono estranee, oggettivatesi contro di lui.
Il concetto di «Stato politico» compare in Marx già negli «Annali franco-tedeschi» e
costituisce per lui una prima, anche se molto felice, espressione per indicare la
fondamentale nozione sociologica secondo la quale la forma statale è solo una forma di
vita storica della società e, precisamente, una forma tale che in essa la conflittualità
interna viene occultata dietro l’esteriore forma solidale di un preteso interesse
pubblico. Perciò Marx, nel famoso carteggio che apre sul piano programmatico gli
«Annali franco-tedeschi», afferma che lo Stato politico, inteso come una forma
dell’interesse generale, presuppone invero «ovunque la ragione come realizzata», ma
che «altrettanto ovunque incorre nella contraddizione tra la sua destinazione ideale e i
suoi presupposti reali». E prosegue: «Da questo conflitto dello Stato politico con se
stesso si può pertanto sviluppare ovunque la verità sociale» [Nota 6]. Già qui
incontriamo quel pensiero fondamentale della conoscenza e critica sociologiche, che
doveva dispiegarsi nella concezione materialistica della storia, che consiste nel mettere
a confronto le forme politiche fenomeniche della vita sociale con la struttura sociale
stessa che sta a loro fondamento, che esse per cosí dire dissimulano, e da cui
scaturisce immediatamente il loro conflitto interno: l’antitesi tra la loro forma ideale e
universale e il loro contenuto particolare. Una tale contraddizione non è assolutamente
casuale ma deve necessariamente affiorare in questa forma sociale di vita. Infatti,
come Marx dichiara in un’analisi che, al di là della forma ancora puramente ideologica,
penetra a fondo nell’essenza della società borghese, «lo Stato politico perfetto
rappresenta, secondo la sua essenza, la vita generica dell’uomo, in contrasto con la
sua vita materiale» [Nota 7], vale a dire staccato dalle particolari condizioni materiali
di esistenza degli uomini che vivono in questo Stato. «Tutti i presupposti di questa vita
egoistica continuano ad esistere all’esterno della sfera statale, nella società civile, ma
come caratteristiche della società civile». Che i cittadini siano imprenditori o lavoratori,
possidenti o nullatenenti, sazi o affamati, con diritto alla pensione o privi di assistenza
— tutto ciò resta una loro faccenda privata, che non riguarda la sfera politica dello
Stato, il quale comprende solo gli ‘interessi pubblici’ non quelli ‘egoistici’ del singolo
cittadino. Questa singolare struttura della vita sociale è caratterizzata da Marx con
l’espressione «Stato politico», che non è affatto un pleonasmo, come Kelsen ritiene,
ma deve porre l’accento su una
Página 228
profonda contraddizione radicata nel concetto di Stato, che sicuramente non emerge
sulla base di una considerazione giuridica, ma solo di una considerazione sociologica. E
proprio il fatto che per Kelsen l’espressione «Stato politico» è un pleonasmo, mentre
per il marxismo con questo termine si discopre la grande prospettiva storica della
politica (Politik) intesa come una lotta per lo Stato verso la politica (Politica) nel senso
di un’amministrazione solidale della società, è la riprova che nel marxismo i medesimi
termini designano concetti del tutto diversi che in Kelsen e ogni critica la quale non si
soffermi sul loro significato, è fatica sprecata.
Nello Stato ‘politico’ le forze politiche debbono presentarsi scisse da quelle sociali,
perché in primo luogo la forma politica comprende solo una parte delle relazioni sociali,
appunto quelle che servono gli interessi dominanti, e, in secondo luogo, la sfera di
interessi sociali esclusa, che concernono in particolare il sistema attraverso il quale la
vita del singolo è assistita nella sua globalità, in base a questa esclusione dalla sfera
politica in generale non viene compresa nella sua natura sociale, ma si configura come
interesse privato dell’individuo. L’intera discussione, penetrante e critica, di Marx sulla
duplice vita che nello Stato borghese ogni individuo, in quanto cittadino e uomo
privato, conduce proprio in relazione ai suoi rapporti sociali [Nota 8], è stata ignorata
da Kelsen, al pari dell’analisi dettagliata di questo rapporto, svolta nel mio saggio
[Nota 9]. In fal modo viene sicuramente tralasciato il contesto, in cui la separazione
della forza politica dall’interesse privato da un lato, e dalle forze sociali dall’altro,
acquista in Marx il suo significato specifico, che consiste appunto nel fatto che
entrambi, sia l’interesse privato, sia la forza politica, sono per Marx delle forme di
coscienza che mistificano se stesse, in quanto si riferiscono a un contenuto che in
realtà va compreso esclusivamente sul piano sociale. Questa falsa coscienza può, anzi
deve, scomparire, solo quando l’uomo individuale, come dice Marx, sarà diventato
anche nei suoi rapporti, soltanto in apparenza individuali, essenza generica, il che vuol
dire quando sarà pervenuto a un ordinamento sociale in cui attraverso l’organizzazione
sociale consapevole della produzione e della distribuzione, diventerà chiaro a tutti che
anche l’attuale sistema ‘individuale’ che garantisce l’esistenza (Lebensfürsorge) e la
soddisfazione dei bisogni, è un atto strettamente connesso all’esistenza e al lavoro del
genere — una dimostrazione questa che, per quanto riguarda l’attuale fase
capitalistica, con la sua apparenza di agenti della produzione isolati e di una
distribuzione puramente privata, è stata fornita, com’è noto, dall’analisi
Página 229
economica del Capitale. Ciononostante il contrasto che oppone datori di lavoro,
apparentemente indipendenti, e prestatori d’opera, anch’essi liberi, e la concorrenza
sul mercato tra possessori di merci, in apparenza del tutto autonomi, in breve tutta
questa «soggettivizzazione dei fondamenti materiali della produzione, che caratterizza
l’intero modo di produzione capitalistico» [Nota 10], fa sí che in questo agire di fattori
solo apparentemente del tutto autonomi, la loro connessione sociale può imporsi
«unicamente come una soverchiante legge naturale contrapposta all’arbitrio
individuale» [Nota 11]. Senza alcun dubbio lo Stato politico, in particolare nella sua
forma compiuta, nella democrazia, rappresenta una forma di liberazione da strutture
piú antiche dello Stato non politico, nelle quali, come accadeva nell’assolutismo, nel
feudalesimo, o persino nella teocrazia i vincoli sociali tra cittadini, le loro relazioni
umane con l’intero, ciò che Marx chiama le esigenze di una emancipazione umana,
scompaiono completamente dietro il carattere di potenza soggettiva degli interessi di
dominio individuali che reggono e costituiscono lo Stato. Qui la conflittualità,
caratteristica dello Stato politico, tra il suo riferimento all’universalità (interessi
pubblici) e la sua effettiva struttura economica, non solidale, non può ancora affatto
esprimersi, perché lo Stato viene a trovarsi, per cosí dire, nella sfera di proprietà del
signore, dunque ha assolutamente un carattere apolitico. Perciò Marx dice:
«L’emancipazione politica costituisce decisamente un grande progresso, essa non è
propriamente l’ultima forma dell’emancipazione umana in generale, ma l’ultima
all’interno della visione del mondo finora dominante» [Nota 12]. Al di sopra di essa c’è
ancora soltanto il passo verso la compiuta emancipazione umana, attraverso il
superamento dello Stato politico, il che vuol dire attraverso una coincidenza tra le forze
politiche e quelle sociali, in una società senza classi e che è diventata per questo
motivo solidale.
Un medesimo fraintendimento circa il concetto di politico, per cui la soppressione
della forma politica in Kelsen significa anarchia, mentre in Marx significa l’eliminazione
delle forme ancora illusorie in cui si esprime la connessione sociale stessa, si ripete in
un passo successivo, in un modo ancora piú increscioso, vale a dire nella critica del
Manifesto del partito comunista. In quest’ultimo Kelsen scorge addirittura proclamato
l’anarchismo. Infatti la conquista del potere politico da parte del proletariato, il quale in
questo modo crea innanzitutto uno Stato proletario, cioè una organizzazione costrittiva
proletaria, viene presentata qui da Marx,
Página 230
cosi dichiara Kelsen, unicamente come una transizione alla società senza classi. Una
volta che questo obiettivo sia stato raggiunto, «il Manifesto del partito comunista
ritiene di poter fare a meno dell’ordinamento coercitivo». In esso tuttavia si legge:
«Quando, nel corso dell’evoluzione, le differenze di classe saranno sparite e tutta la
produzione sarà concentrata nelle mani degli individui associati, il potere pubblico
perderà il carattere politico» [Nota 13]. Ma l’espressione «carattere politico del potere
pubblico» è, per Kelsen, un pleonasmo. Infatti «il potere pubblico è politico, perché e
nei limiti in cui è un potere pubblico, cioè un ordinamento costrittivo» [p. 47]. Perciò
l’affermazione che il potere pubblico perde il suo carattere politico può significare in
effetti solo che esso cessa di esistere, in quanto tale. Può sembrare, invero, che il
Manifesto del partito comunista per potere pubblico intenda innanzitutto soltanto il
dominio di classe. Ciononostante esso in realtà guarda al cessare di ogni forma di
potere pubblico. Le parole conclusive del capitolo decisivo suonano infatti: «Al posto
della vecchia società borghese con le sue classi e con i suoi antagonismi di classe
subentra un’associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è condizione per il
libero sviluppo di tutti» [Nota 14]. Per Kelsen questo richiamo alla forma futura di
società resta poco chiaro, ma una cosa tuttavia è certa, a favore della quale parla il
duplice rilievo dato all’elemento della libertà, che la meta del socialismo è vista in una
«associazione libera in opposizione a un ordinamento costrittivo, a una organizzazione
di dominio, al sistema di un pubblico potere, in breve, in opposizione allo Stato» (pp.
16-8 [48]) [Nota 15].
Dunque anche nel Marx maturo, nel Manifesto del partito comunista Kelsen individua
lo stesso dilemma di prima: in conclusione la separazione della forza politica dalle forze
sociali — visto che è negato, in via di principio, il trapassare di tutte le forze sociali
nello Stato — può consistere solo nella dissoluzione di ogni potere politico nella libertà,
cioè nella assenza di costrizione. Ma noi già conosciamo lo scambio tra concetti, di cui
è vittima la criPágina 231
tica kelseniana. Fa parte dei molteplici equivoci del formalismo concettuale di Kelsen il
fatto che per esso il termine ‘politico’ sia sempre equivalente al termine ‘statale’, e
quest’ultimo a sua volta si identifichi con ‘interesse generale’ o ‘interesse pubblico’. In
Marx viceversa l’espressione ‘politico’ significa esattamente il contrario, vale a dire che
il meccanismo dello Stato di classe comporta necessariamente che in forma politica
compaiano sempre soltanto dei contenuti di parte della connessione sociale, i quali
però si spacciano per contenuti universali, sia che si costituiscano come interessi di
dominio e attraverso la legislazione statale vengano imposti come universali, sia che si
costituiscano come interessi rivoluzionari e nella ideologia della classe che aspira a
sollevarsi si presentino come universali. Per Marx, dunque, interessi politici, forze
politiche e potenza politica, in sé e per sé, non coincidono mai tout court con interessi
e forze generali e col potere pubblico. Perciò è falso dire, come fa Kelsen, che è
pleonasmo discutere del carattere politico del potere pubblico. Per il suo punto di vista
formale, per il quale carattere politico, potere pubblico e Stato sono dei concetti del
tutto identici e soltanto delle espressioni differenziate per indicare l’«organizzazione
costrittiva», espressione che di per sé è assolutamente indeterminata, una tale
affermazione è sicuramente esatta. Ma per il punto di vista sociologico di Marx c’è un
senso pregnante, anzi c’è per la prima volta il senso veramente grandioso della sua
teoria dello sviluppo sociale nell’affermare che, sulla base della trasformazione
economica, nelle fondamenta della società da lui indicata, il potere pubblico perde il
suo carattere politico, cioè il suo carattere di antagonismo di classe, con la necessaria
conseguenza che nello Stato possa presentarsi come potere pubblico, dunque come
potenza politica, ciò che è in realtà soltanto un potere di parte e contrapposto
all’interesse pubblico. È assolutamente vero che per un istante Kelsen ha rivelato una
visione piú lucida, affermando che può sembrare che per potere politico il Manifesto del
partito comunista intenda il dominio di classe. Ma subito lascia cadere questa premessa
iniziale che unicamente renderebbe possibile la comprensione. Ora non solo sembra
cosí, ma è cosí di fatto. Se Kelsen non restasse semplicemente legato a singole
citazioni e se avesse attinto, viceversa, alle ricche fonti del marxismo nella loro
globalità, saprebbe che già Marx, poco tempo prima del Manifesto del partito
comunista, ha chiarito i concetti di libera associazione e di trasformazione del potere
politico proprio nella connessione in cui sono stati esposti in precedenza da noi. Egli
dice:
La classe lavoratrice sostituirà, nel corso dello sviluppo, all’antica società civile
un’associazione che escluderà le classi e il loro antagonismo,
Página 232
e non ci sarà piú un potere politico propriamente detto, perché il potere politico è
precisamente l’espressione pubblica del conflitto di classe all’interno della società civile.
[Nota 16]
Giova ad esplicitare, contemporaneamente, il contrasto tra forze politiche e forze
sociali, di cui si è discusso prima, cosí come a far affiorare ancora una volta in modo
inconfondibile l’uso linguistico marxiano del termine ‘politico’, quando leggiamo oltre il
passo già citato:
Non esiste un movimento politico che non sia contempolaneamente anche sociale. È
solo in un ordine di cose, in cui non vi saranno piú classi né antagonismo di classe, che
le rivoluzioni sociali cesseranno di essere rivoluzioni politiche. [Nota 17]
La eliminazione della scissione tra forze sociali e forza politica non si trova affatto
davanti al dilemma posto da Kelsen, per cui essa deve produrre come effetto o il
confluire della società nello Stato, o l’anarchia, ma rappresenta piuttosto il passaggio
da una socialità inconsapevole e sottratta perciò a ogni regola, ad una socialità
cosciente e regolata. Perciò il nuovo Stato diviene sia per Marx che per Engels una
condizione di libertà, concetto che Engels ha espresso nella frase famosa, secondo la
quale sarebbe questo il salto dal regno della necessità a quello della libertà; ciò non
avviene perché in questo nuovo assetto l’ordine costrittivo della società venga dissolto,
ma perché tutti i legami sociali dell’individuo non gli si contrappongono piú come una
potenza incomprensibile, per cosí dire esteriore, bensí scaturiscono dai propri rapporti
vitali, che sono diventati del tutto trasparenti e che vengono costituiti in modo
consapevole insieme con i suoi compagni stessi. Marx del resto nella fase ‘della
maturità’ ha fornito espressamente dei chiarimenti, anche per coloro che erano ancora
bisognosi di un tale commento, sul modo in cui dev’essere interpretata questa libertà,
su come va pensata effettivamente la «libera associazione», in quanto forma di
produzione sociale, tanto sospettata da Kelsen di anarchismo.
Il regno della libertà comincia di fatto solo là dove cessa il lavoro determinato dalla
necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della
produzione materiale vera e propria, [...] La libertà in questo campo può consistere
soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano
razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il loro
comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca;
Página 233
che essi eseguono il loro compito con il minore impiego possibile di energia e nelle
condizioni piú adeguate alla loro natura umana e piú degne di esse. Ma questo rimane
sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità
umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire
soltanto sulle basi di quel regno della necessità. [Nota 18]
In tal senso dunque nella costruzione cosciente dell’essenza generica dell’uomo non si
verifica una dissoluzione di ogni ordinamento costrittivo, ma solo il mutamento
indubbiamente imponente del suo carattere sociologico, che da non solidale diviene
solidale, e ciò trasforma la costrizione, da una funzione di dominio, in un criterio di
misura della finalità e nello stesso grado la limita a un minimo necessario. E sulla base
di ciò, ma sicuramente anche solo in questo contesto, diviene sempre piú esplicito il
significato assolutamente non individualistico, ma grandiosamente sociale della frase,
secondo la quale l’essenza umana è la vera comunità dell’uomo. Senonché Kelsen ha
ricavato da essa non solo l’individualismo, ma perfino una tendenza all’anarchismo. Ma
come si perviene a ciò? Egli vede tracciato questo esito nelle seguenti parole di Marx:
La rivoluzione in generale — il crollo del potere esistente e la dissoluzione degli
antichi rapporti — è un atto politico. Il socialismo non può dunque realizzarsi senza una
rivoluzione. Esso esige questo atto politico, in quanto ha bisogno della distruzione e
della dissoluzione. Ma non appena inizia la sua attività organizzatrice, non appena
emergono la sua finalità immanente, la sua anima, allora il socialismo si scrolla di
dosso il suo involucro politico. [Nota 19]
A tale riguardo Kelsen osserva che la rivoluzione politica in Marx, poiché fa ancora
ricorso alla violenza, è pura distruzione, il socialismo al contrario è un’attività
costruttiva e organizzatrice, in quanto annuncia l’ideale della società liberata dal mezzo
politico, cioè dalla costrizione statale (p. 26 [57]). Kelsen avrebbe dovuto alla fine fare
attenzione in questo brano al fatto che il concetto di politico, contrapposto a quello di
sociale, indica in Marx qualcosa di diverso dal contrasto dello Stato, nel senso di
un’organizzazione costrittiva in generale, rispetto a una vita sociale non statale,
liberata da ogni costrizione. In genere il contrasto, da cui muove Marx nel pensiero
precedente, non è tra l’organizzazione politica e quella sociale, ma tra rivoluzione e
socialismo. In relazione alla prima egli dice che è sempre un atto politico e distruttivo,
perché ogni rivoluzione è l’azione di una parte della società
Página 234
contro le altre, al fine di condurre l’intera società in una forma di piú ampia e
consapevole socialità; il politico qui, come sempre in Marx, è quella forma storica della
società, nella quale essa, a causa dell’antagonismo dello Stato di classe, può apparire
per l’appunto solo come una lotta tra le sue componenti, aventi interessi divergenti sul
piano economico. E il socialismo può spezzare questo involucro, non perché dissolva la
organizzazione costrittiva, ma in quanto «la sua attività organizzatrice» d’ora in poi
fonda tale costrizione sulla volontà cosciente e concorde di tutti i membri della
comunità, liberati dai conflitti di classe, e in tal modo trasforma radicalmente il
carattere sociale della «costrizione» la quale resta sempre formalmente ancora una
costrizione contro i trasgressori.
3. La rottura della macchina statale
Se ci si rende conto del grave danno che l’adozione di concetti ambigui arreca in
Kelsen, si può anche comprendere per quale motivo Marx ed Engels non vedevano di
buon grado che si adoperassero il concetto di Stato per indicare il nuovo assetto
sociale auspicato dal socialismo, e, rispettivamente, predisposto dallo sviluppo
economico. Ciò non dipende, come Kelsen pensa, dalla tendenza a occultare il fatto
che anche la società socialista non può fare a meno della costrizione, ed è quindi pur
sempre uno ‘Stato’ (p. 40 [76]), ma per porre l’accento sulla radicale trasformazione
del carattere della costrizione. Questo dato viene fuori anche nel caso in cui si
definisca, al pari di Kelsen, la società socialista assolutamente come uno Stato, se è
vero che si tratta appunto di uno Stato cosí totalmente diverso dallo Stato di classe di
oggi, e anche dallo Stato proletario di domani. L’essenziale è la comprensione
sociologica di questo ‘totalmente diverso’, sul piano economico, psicologico, morale e
perciò, da ultimo, anche organizzativo, e non la circostanza, in base alla quale, com’è
naturale, anche in questo assetto sociale esisteranno assoggettamento e
subordinazione, organi e competenze e rapporti cui potrà applicarsi naturalmente, dal
punto di vista formale, il concetto di diritto, di costituzione e di legge.
Marx vuole esprimere questo totale mutamento sociologico dell’ordinamento sociale,
allorché scrive a Kugelmann della necessità di non «trasferire da una mano ad un’altra
la macchina burocratica e militare, come è avvenuto fino ad ora, ma di spezzarla»
[Nota 20]. Kelsen, naturalmente, in questa rottura della macchina statale scorPágina 235
ge soltanto o una rappresentazione poco chiara oppure una forma di anarchismo. Egli
dice:
Se si domanda che cosa si possa intendere con l’immagine della rottura della
macchina statale in generale, allora, detto senza metafore, s’intende o che al posto del
vecchio ordinamento statale ne viene posto uno nuovo, ma tuttavia pur sempre un
ordinamento statale; oppure che non viene posto alcun ordinamento, cioè viene creata
una situazione di anarchia; oppure che, semplicemente, al posto degli organi che
realizzavano il vecchio ordinamento, vengono ordinati altri uomini come esecutori;
oppure che, con un nuovo ordinamento statale — quindi, con un cambiamento
fondamentale delle norme statali di organizzazione — viene collegato anche un
completo cambiamento degli organi statali (pp. 32-3 [68-9]).
Kelsen distingue pertanto fra quattro casi, che possono essere cosí elencati: 1)
anarchia; 2) forma statale non diversa in linea di principio da quella precedente; 3)
mutamento in linea di principio della precedente forma statale, con un cambiamento
completo degli organi statali; 4) semplice ricambio dei precedenti organi statali. È
chiaro che, rispetto alla trasformazione ipotizzata da Marx, soltanto il terzo caso è
preso in considerazione. Se dello Stato di classe non sussisteranno né le sue
precedenti forme di organizzazione, cioè i rapporti di classe che al suo interno
determinano le funzioni statali, né i suoi organi, le istituzioni destinate all’esercizio del
potere di classe, ma questi saranno soppressi nel corso di una lotta storica in cui si farà
piú o meno ricorso alla violenza da parte della classe rivoluzionaria, un tale processo
viene chiamato da Marx la rottura della macchina statale, anche se il nuovo ordine non
è, naturalmente, un’anarchia, ma disporrà di un suo proprio ordinamento costrittivo
che scaturirà dai suoi compiti e interessi. Infatti viene spezzata appunto la macchina
dello sfruttamento e dell’oppressione di una classe da parte dell’altra, ed è questo
l’elemento essenziale nel senso sociologico. In questa prospettiva non cambia niente il
fatto che lo Stato proletario stesso sia ancora uno ‘Stato’, nel significato attribuitogli da
Marx, cioè uno Stato di classe. È solo il segno del formalismo assolutamente sterile di
Kelsen, che dissolve confusamente ogni possibilità di comprensione, se, insistendo
nell’apparenza della sua rigida definizione, fa carico al marxismo della contraddizione di
parlare contemporaneamente della rottura della macchina statale, mentre il
proletariato costruisce lo Stato proletario e del fatto che Marx ed Engels non
definiscono piú la Comune parigina come un vero e proprio Stato, mentre dall’altro lato
la descrivono, ciononostante, come la dittatura del proletariato, il che significa però
come lo Stato sotto il dominio del proletariato. La distinzione decisiva tra
Página 236
lo Stato proletario e quello capitalistico, che indubbiamente non può essere colta in
una considerazione puramente giuridica, ma solo riferendosi alla funzione sociologica di
entrambi, deve sfuggire completamente a Kelsen: il fatto che lo Stato capitalistico
vuole essere una forma duratura della organizzazione sociale, mentre lo Stato
proletario ha sin dall’inizio la consapevolezza di essere una forma di transizione
(Uebergangsform) e di avere in ciò il principio organizzativo del suo esistere e del suo
agire. Ed è per questo motivo che Marx ed Engels riguardo alla Comune parigina
affermano che essa non era uno Stato vero e proprio, il che non significa che non
disponesse di nessun ordinamento costrittivo, e fosse dunque pressappoco una forma
di anarchismo, ma che essa aveva come obiettivo quello di eliminare, attraverso la
soppressione dei rapporti di classe, la forma statale, cioè il dominio di una classe sulle
altre, in questo caso dunque anche il suo proprio dominio. Gli stessi avversari politici
ed economici della Comune erano ben consapevoli che essa non era piú «un vero e
proprio Stato». Perciò veniva accusata di distruggere la cultura borghese da parte dei
sostenitori di quest’ultima.
La Comune — scrisse Marx —, essi [gli avversari] esclamano, vuole abolire la
proprietà, la base di ogni civiltà! Certo, signori, la Comune voleva abolire quella
proprietà di classe che fa del lavoro di molti la ricchezza di pochi. Essa voleva
l’espropriazione degli espropriatori. Voleva fare della proprietà individuale una realtà
trasformando i mezzi di produzione, la terra e il capitale, che ora sono essenzialmente
mezzi di asservimento e di sfruttamento del lavoro, in semplici strumenti di lavoro
libero e associato. [Nota 21]
Ma, il giurista, di tutta quest’intenzione della Comune non scorge nulla, e neanche
gl’interessa. Egli bada semplicemente al mutamento della forma della sua amata
organizzazione costrittiva, cercando di scoprire se continua ad esistere e, in tono
trionfante, domanda:
Orbene, che cosa accade nella Comune di Parigi, cioè quali sono — nell’esposizione di
Marx — i processi essenziali? Essi possono essere esaustivamente riassunti nel fatto
che al posto di una forma statale monarchica fu data una costituzione democraticorepubblicana, fusa con alcuni elementi di democrazia diretta e che fu realizzato un
cambiamento degli uomini che attuavano l’ordinamento statale (p. 33 [69]).
Effettivamente? Ed esaustivamente? Ed è veramente questo l’elemento essenziale
nell’esposizione di Marx? È un po’ come se uno, cui venga raccontato che un oratore
che scoppiava di spirito e di vita si è improvvisamente abbattuto al suolo, colpito da un
Página 237
colpo apoplettico, dicesse che niente di essenziale è mutato nell’ordine in cui sono
disposte le molecole che compongono il corpo dell’oratore per il fatto che, al posto di
una forma vivente, è subentrata una morta combinazione (Verfassung) permeata da
certi elementi di rigidità, la quale tuttavia rappresenta pur sempre una forma di
ordinamento degli elementi corporei, con la sola differenza che prima era rivolta alla
coesione del corpo e ora alla sua disgregazione.
Nel riassunto ‘esaustivo’, fatto da Kelsen, della esposizione marxiana non viene
considerato proprio ciò che Kelsen in verità cita, ma che non sa adoperare altrimenti
che come utilizza i suoi ripetuti equivoci formali. Marx, il quale naturalmente sapeva
molto bene che la Comune di Parigi era ancora uno Stato nel senso politico del
termine, la chiama «una forma politica eminentemente capace di espansione, mentre
tutte le precedenti forme di governo erano state essenzialmente repressive». Questa
capacità espansiva consiste nel superamento della forma di oppressione. Infatti
il suo vero segreto fu questo: che essa fu essenzialmente un governo della classe
operaia, il prodotto della lotta della classe che produce contro la classe usurpatrice, la
forma politica finalmente disvelata, nella quale poteva compiersi finalmente la
liberazione economica del lavoro. [Nota 22]
Dunque il dato essenziale non consiste per Marx, come ritiene Kelsen, nel fatto che
anche la Comune sia stata una forma politica, perciò, come Kelsen aggiunge con aria di
trionfo, «un governo», una «repubblica», quindi uno Stato (pp. 33 [69]), ma che si sia
costituita come una siffatta forma politica in cui poteva giungere a compimento la
soppressione della forma politica dello Stato stesso. Questo ‘residuo’ della esposizione
marxiana della Comune sta sicuramente al di sotto del riassunto ‘esaustivo’ di Kelsen,
cosí come la realtà in generale sparisce per colui che si intrattiene in castelli in aria.
È inutile soffermarsi dettagliatamente sulla critica che Kelsen rivolge alla Comune e
che approda ovunque alla dimostrazione che anche la Comune non fu «una anarchia»,
il che vuol dire che non rinunciò a una qualche forma di organizzazione costrittiva. La
estenuante confusione tra concetti il cui significato giuridico-formale viene applicato, in
espressioni come rappresentanza popolare, parlamentarismo, polizia, governo ecc., a
contenuti completamente diversi sul piano sociale, rende la lettura di questa critica
tanto incresciosa quanto sterile; una sua confutazione dettagliata non apporterebbe
niente di nuovo in linea di principio e può pertanto essere affidata a tutti coloro che
hanno seguito la nostra analisi.
Página 238
4. L’estinzione dello Stato
Come l’espressione marxiana «rottura dello Stato» non significa anarchismo nel senso
di una distruzione della organizzazione costrittiva della vita sociale, bensí soltanto nel
senso della distruzione di un’organizzazione di dominio, lo stesso vale anche per l’altra
immagine, adoperata da Engels, dell’ «estinzione dello Stato». Essa non si riferisce alla
forma di società in quanto tale, ma semplicemente al tempo (Tempo) della sua
trasformazione, ed è formulata polemicamente nei confronti degli anarchici, che
pretendono di abolire lo Stato ‘tutto d’un colpo’. In tal senso, l’espressione engelsiana
dell’«estinzione dello Stato» fa riferimento unicamente al fatto che la trasformazione
dell’organizzazione costrittiva della società, da una forma di dominio in una forma di
amministrazione sociale, è un lungo processo storico, nel quale sia le vecchie istituzioni
sia gli uomini di un tempo sono destinati a perire, prima che la nuova forma di società
possa effettivamente sviluppare la sua vera e propria essenza. Concepita in forma
polemica contro gli anarchici di allora, molto opportuna verso i sindacalisti e bolscevichi
di oggi, l’espressione engelsiana dell’«estinzione dello Stato», tuttavia, non è molto
felice, e va di gran lunga posposta all’espressione marxiana della distruzione della
macchina statale. Ma non perché, come ritiene Kelsen, lo Stato in generale non possa
estinguersi, ma in quanto una tale espressione ha lo strano sapore che la
trasformazione e il rovesciamento dello Stato di classe in una società senza classi
possano avvenire in modo graduale e senza un abbattimento violento degli antichi
rapporti, delle vecchie istituzioni e delle vecchie forme di coscienza. L’idea della
«estinzione» dello Stato spinge troppo vicino la realizzazione del socialismo a quel
concetto seducente, e che, tuttavia, falsifica grossolanamente tutto il senso dello
sviluppo economico, che si realizza solo attraverso l’azione degli uomini, di una pacifica
‘transcrescenza’ della società capitalistica in quella socialista. Quest’ultima cresce
all’interno della società capitalistica solo allo stesso modo in cui nel ventre materno
cresce il bambino, il quale deve pur sempre essere distaccato dal cordone ombelicale,
e lo Stato si estingue, al pari della placenta, solo dopo che da esso si è staccato il
nuovo organismo. L’estinzione, in questo caso, e la transcrescenza (Hineinwachsen), in
quel caso, sono, ambedue le volte, metafore imperfette di un processo che,
essenzialmente, non è processo organico, bensí un processo della vita sociale, e il
quale scorre in quella forma che il processo della vita sociale deve assumere al livello
non solidale quale è esistito finora, cioè nella forma della lotta.
Página 239
Capitolo diciassettesimo
Il ‘miracolo’ della organizzazione senza Stato
Ma Kelsen giudica l’affermazione marxista della necessaria soppressione dello Stato,
dopo l’eliminazione dei conflitti di classe, non solo contraddittoria, ma anche
assolutamente arbitraria e indimostrabile perfino all’interno della concezione marxista.
Egli ritiene che la conclusione cui perviene il marxismo, in base alla quale là dove non
esistono conflitti di classe non esiste piú neppure uno Stato — e questo significa, in
Kelsen, come sappiamo, che non c’è alcuna organizzazione costrittiva — è del tutto
insostenibile. Infatti, a suo avviso, non viene cercata
neanche l’ombra di una dimostrazione per il fatto che insieme con lo sfruttamento
economico e con l’opposizione di classe scompariranno anche tutti quei fenomeni
sociali che — del tutto indipendentemente dal mantenimento o dall’eliminazione
dell’opposizione di classe e dello sfruttamento — rendono necessario un ordinamento
costrittivo, un potere pubblico ovvero un dominio politico (p. 18 [48]).
È proprio vero che in un ordinamento economico comunista non ci sarà piú niente che
possa far ribellare gli uomini, spingerli a proteste e sollevazioni? Non esiste realmente
nessun’altra forma di opposizione a un ordinamento sociale che non sia quella di classe
(p. 80 [pp. 127-8])? Ma, a prescindere da ciò: l’eliminazione dello sfruttamento
trasformerà cosí radicalmente la natura umana che ognuno eseguirà spontaneamente il
lavoro assegnatogli, anche se con ciò, come accade sempre in una pianificazione
centralizzata del lavoro, non sempre potranno essere soddisfatti i suoi bisogni
individuali? Non dovrebbe essere consentito a un ordinamento sociale, che non potrà
essere tuttavia un semplice ordinamento economico, di proteggersi, con minacce di
costrizione, da tali turbamenti? E altrettanto per prevenire l’insorgere di nuovi conflitti
di classe? E l’ipotesi secondo la quale nell’ordinamento
Página 240
comunista non esisteranno pericoli di questo genere non è l’esempio classico di
un’utopia non scientifica (p. 18 [49])? E infine si chiede Kelsen: è possibile un
ordinamento economico, rispondente a un piano, che possa rinunziare ad una
costrizione?
Non è piú che paradossale il fatto che lo Stato che, nella sua trasformazione
dell’apparato costrittivo borghese in quello proletario, aumenta in maniera insospettata
quanto a potenza e competenza, proprio nello istante in cui raggiunge l’apice di questo
sviluppo, debba scomparire, dissolversi misteriosamente nel nulla? [...] No, qui c’è un
miracolo: abbiate solo fede! (p. 19 [49]).
Sí, qui c’è un miracolo, abbiate solo fede, ma non quello ipotizzato da Kelsen e che gli
appare solo come il frutto di una immaginazione fertile, libera da tutti i vincoli del
pensiero scientifico, bensí al contrario si tratta di quel miracolo, cui si presta molto
meno attenzione, che riguarda il modo in cui anche il pensiero scientifico piú rigoroso
non è in grado, di tanto in tanto, di sottrarsi ai vincoli dei concetti e dei modi di vedere
abituali, quando si tratta dei vincoli dell’ideologia della classe borghese. Se non si è in
grado di rappresentarsi lo Stato, i cittadini e il loro rapporto reciproco, in un modo
diverso rispetto alle forme dell’attuale conflittualità di classe, modificabili solo sul piano
giuridico, è inevitabile che si giunga a considerare la teoria sociale marxista non solo
come un cumulo di contraddizioni, ma a scorgere in tutto ciò che essa afferma riguardo
alla diversità e alla novità delle sue condizioni sociali e degli uomini una sorta di utopia
pura e di favole per fanciulli che s’interessano di politica.
Ciò che Kelsen espone qui riguardo al ‘carattere paradossale’ del marxismo, alla sua
mortale contraddizione, in base alla quale, da una parte, esso estenderebbe,
nell’organizzazione comunista della società, l’organizzazione costrittiva della società in
maniera inaudita rispetto allo Stato odierno e, tuttavia, dall’altra parte, esso parla di
una scomparsa dello Stato, dobbiamo considerarlo confutato dalle nostre precedenti
argomentazioni, allo stesso modo in cui lo sono state le affermazioni kelseniane sulla
necessità di una costrizione anche all’interno dell’ordinamento comunista della società.
Già nel corso della discussione sull’anarchismo abbiamo constatato a sufficienza quanto
sia sbagliato identificare la soppressione del carattere di dominio con l’organizzazione
costrittiva in generale. Ma, se questa ‘costrizione’ viene posta in una contraddizione
interna rispetto alla libertà, diviene necessario, di fronte al disconoscimento, tipico
dell’ideologia borghese, dell’assenza specifica della ‘costrizione’, soffermarci piú da
vicino sulla sua natura.
Già nel Manifesto del partito comunista, tra le misure immediate che i comunisti
devono adottare, allo scopo di convertire l’ordiPágina 241
namento sociale esistente nel nuovo ordinamento, si richiede: «Uguale obbligo di
lavoro per tutti e istituzione di eserciti industriali» [Nota 1]. Sicuramente questa
affermazione, in sé e in connessione con tutte le altre richieste, avanzate in quella
occasione, in direzione di una centralizzazione dell’economia, sta a indicare
semplicemente un provvedimento transitorio, ma non nel senso che esso vuole
condurre da un’economia organizzata in base a un piano a un’altra totalmente
disorganizzata e priva di costrizione, bensí, da una forma ancora piena di residui
dell’economia e dell’ideologia borghese e, quindi, necessariamente inadeguata, a un
modo di produzione completamente rivoluzionato nelle istituzioni e negli uomini. Nel
Capitale Marx descrive, una volta, la trasparenza raggiunta dai rapporti economici, in
quanto relazioni umane, all’interno di un’economia comunista, con le seguenti parole,
che fanno pensare a Stirner: «Immaginiamoci infine, per cambiare, un’associazione di
uomini liberi che lavorino con mezzi di produzione comuni e spendano coscientemente
le loro molte forze-lavoro individuali come una sola forza-lavoro sociale» [Nota 2]. Egli
ritiene superfluo aggiungere che questa società, benché non sia uno Stato, ma una
associazione di uomini liberi, naturalmente può lavorare solo socialmente, in quanto
essa si subordina alla costrizione che scaturisce oggettivamente dalla natura della
produzione comune e sicuramente renderà adeguatamente inoffensivi tutti coloro che
turberanno questa costrizione, cioè il lavoro stesso. Come se non bastasse anche
Engels ha sviluppato questo punto e proprio contro la parola d’ordine dei bakuninisti
dell’annullamento di ogni autorità. Nell’articolo, già in precedenza menzionato, apparso
sulla rivista «La Plebe», scrive:
Dovunque, l’azione combinata, la complicazione dei procedimenti, dipendenti gli uni
dagli altri, si mette al posto dell’azione indipendente degli individui. Ma chi dice azione
combinata, dice organizzazione; ora, è possibile avere l’organizzazione senza
l’autorità? [Nota 3]
Engels chiarisce tale impossibilità ricorrendo all’esempio di un cotonificio e al
funzionamento di una ferrovia, e, in questo, il nucleo centrale delle delucidazioni
consiste sempre nel mostrare l’emergere del momento costrittivo di cui si tratta in
questo caso, dell’autorità che agisce in questo caso, a partire dalle necessità oggettive
della collaborazione. In tal senso egli dice:
Página 242
L’automata meccanico d’una grande fabbrica è molto piú tiranno di quanto lo siano
mai stati i piccoli capitalisti che impiegano operai. Almeno per le ore di lavoro si può
scrivere sulle porte di queste fabbriche: Lasciate ogni autonomia, voi ch’entrate! Se
l’uomo con la scienza e il genio inventivo si sottomise le forze della natura, queste si
vendicano su lui sottomettendolo, nel mentre ch’egli le impiega, a un vero dispotismo,
indipendente da ogni organizzazione sociale. Voler abolire l’autorità nella grande
industria, è voler abolire l’industria stessa; distruggere la filatura a vapore per
ritornare alla conocchia. [Nota 4]
Autorità e subordinazione non vengono concepiti piú come concetti attinenti allo
Stato, bensí come concetti puramente economici e tecnici, delle cose, per l’appunto,
che, «indipendentemente da ogni organizzazione sociale, s’impongono a noi colle
condizioni materiali nelle quali noi produciamo e facciamo circolare i prodotti» [Nota
5].
Non si può dire pertanto che l’ordinamento sociale socialista neghi o anche soltanto
disconosca la necessità di una costrizione che scaturisca dalle condizioni del lavoro
sociale. Cosí, già nel commento al Programma di Erfurt, Karl Kautsky scrive che la
produzione socialista «è inconciliabile con la completa libertà del lavoro, cioè la libertà
del lavoratore di lavorare dove e come egli vuole». Poiché la socialdemocrazia
non può eliminare la dipendenza del lavoratore dal meccanismo economico di cui
costituisce una rotellina, ma al posto della dipendenza del lavoratore da un capitalista,
i cui interessi sono opposti ai suoi, porta la sua dipendenza da una società di cui egli
stesso è membro, una società di compagni che godono gli stessi diritti e hanno gli
stessi interessi. [Nota 6]
Ma non si può vedere in questa organizzazione costrittiva una contraddizione rispetto
all’obbiettivo di libertà propugnato dal socialismo, come accade fin troppo spesso,
allorché si parla, in riferimento a ciò, di un ordinamento di tipo casa di correzione, di
un’istituzione di lavori forzati e cose del genere. Se si adoperano siffatti argomenti in
un dibattito politico, ciò può risultare funzionale solo agli scopi di coloro che non sono
interessati alla ricerca della verità, ma a gettare il discredito sull’avversario. Ma ciò che
provoca stupore è il fatto che rappresentazioni di tal genere si manifestino anche nelle
critiche a Marx che si presentano in veste scientifica e ivi prendano se stesse molto sul
serio. Cosí, per esempio, Degenfeld-Schonburg, in uno scritto per il resto molto
stimolante sui motivi economici del marxismo, ritiene che quaPágina 243
si tutti i pensatori marxisti vengano a trovarsi, davanti alla questione di dover decidere
se la società futura sarà costruita sulla libertà o sull’autorità, «in un dissidio interno»,
che è fin troppo comprensibile. Infatti, poiché essi non possono negare la necessità
della costrizione per quanto riguarda il lavoro, si trovano — secondo DegenfeldSchonburg — in imbarazzo col problema della libertà. E anche questo autore, per il
resto molto ponderato, ritiene necessario richiamare l’attenzione sul fatto che ogni
lavoro costrittivo costituisce la tomba dell’attività produttiva e sul fatto che «la
costrizione, che sarebbe necessaria per dare a tutta la nostra economia una direzione
centralizzata, dovrebbe essere di una pesantezza in sospettata e opprimente» [Nota
7].
Innanzi tutto vorrei chiedere: un impiegato delle ferrovie o uno delle poste si è mai
sentito in balia di un’insopportabile costrizione, non parlo naturalmente del lavoro
straordinario che oggi è costretto a svolgere, ma perché lavora in una delle aziende
maggiormente centralizzate? È veramente credibile che l’impiegato di una rete
ferroviaria, che viene collegata ad altre, finora indipendenti, in vista di una nuova e
unica amministrazione, si senta, in seguito a questa concentrazione, piú avvilito di
quanto fosse prima? L’errore concettuale è, in questo caso, il medesimo di quello che
ricorre in tutte queste ‘critiche’ alle istituzioni future di una società completamente
nuova. Si trasferiscono le attuali rappresentazioni, immutate, in un ambiente
completamente diverso dal punto di vista psicologico ed economico e poiché oggi
l’ordinamento del lavoro, all’interno di una fabbrica, è tale da contrapporsi agli operai,
è loro imposto dall’industriale e tiene conto semplicemente o tuttavia innanzi tutto dei
suoi interessi, ci s’immagina allo stesso modo anche l’ordinamento futuro del lavoro.
Ma, tutto ciò che nella società socialista sarà ordinamento costrittivo, scaturirà dalla
volontà comune degli interessi. E, come già oggi i consigli d’azienda, nella fabbrica
capitalistica, possono trasformare in modo decisivo l’ordinamento costrittivo ivi
dominante, nelle sue funzioni e, alla fine, anche nella sua portata, allo stesso modo la
situazione futura del lavoro in generale dipenderà, nelle grandi come nelle piccole cose,
soltanto da un tale sistema di tali consigli dell’economia. Un ordinamento, che
scaturisce soltanto dalle necessità obbiettive della produzione e della distribuzione e
viene posto dagli uomini che vivono e attuano queste necessità, resta senza dubbio
un’organizzazione costrittiva. Ma definirlo un ordinamento da casa di correzione o
parlare, in generale, della sua «pesantezza» è un po’ come dire che la costrizione che
consiste nel
Página 244
muovere ambedue i piedi quando si cammina è una violenza arrecata alla mia libertà e
grava, ad ogni mio passo, con una pesantezza insopportabile.
A ciò si aggiunge ancora il fatto che la questione fino a che punto quest’ordinamento
economico esige una centralizzazione di tutto il processo lavorativo stesso e non,
semplicemente, una statistica centrale della produzione e una distribuzione centrale
della produzione, non è affatto una questione di principio per il socialismo, ma essa
riceverà una risposta sulla base delle necessità e utilità del processo di produzione
stesso. E, infine, non si può dimenticare che la ‘costrizione al lavoro’ si presenterà,
anche esternamente e internamente, in maniera notevolmente diversa dalla costrizione
al lavoro in una istituzione odierna per il lavoro coatto, anzi addirittura soltanto in una
fabbrica odierna. Infatti, senza abbandonarci a profezie, che sono superflue, è proprio
dell’essenza della società socialista e, quindi, dell’essenza dei suoi concetti una
riduzione considerevole dell’orario di lavoro, un miglioramento delle condizioni
soggettive e oggettive del lavoro e una delimitazione a pochi anni dell’obbligo di
lavorare. Ora, ci s’immagini uno statuto del lavoro (Arbeitsverfassung) con un tempo di
lavoro giornaliero di otto ore, nelle condizioni della società socialista, che destinerà
ognuno al lavoro per cui egli si senta piú portato o, per lo meno, non per lavori tali per
cui egli sia inadeguato e che debbano risultargli sgradevoli, inoltre, una durata del
lavoro che lasci completamente libero ogni membro della società, con trent’anni, dopo
circa un decennio di periodo di lavoro — chi definisca un tale ordinamento una
‘costrizione insopportabile’, anzi, chi lo definisca soltanto una contraddizione rispetto
alla libertà, solo perché questo ordinamento, per un tempo limitato, sottopone ogni
singolo agli scopi da lui stesso voluti, chi fa questo, non fa altro che giocare con le
parole costrizione e libertà. La stragrande maggioranza dell’umanità, che quasi
soggiace all’odierno tormento del lavoro e all’odierno stato di necessità, anela a una
tale ‘costrizione’, a un tale ‘attentato alla sua libertà’. Non si può quindi parlare di una
oscillazione circa il rapporto di costrizione e libertà nel socialismo, né per quanto
riguarda Marx e Engels, né per quanto riguarda i marxisti. Ci si ricordi dell’espressione
di Marx a proposito del regno della necessità, al di là del quale soltanto può svilupparsi
il regno della vera libertà della persona. Degenfeld-Schonburg stesso rinvia alle parole
di Kautsky, con cui egli una volta ha condotto questo ‘problema’ in una formula
risolutiva: costrizione per quanto riguarda il lavoro, al di fuori del lavoro libertà [Nota
8].
Página 245
Ma quando egli aggiunge che «questa è, naturalmente, solo una perifrasi per
esprimere il dato di fatto di un’economia completamente costrittiva» [Nota 9], con
quest’ultima proposizione egli dà soltanto spazio alle associazioni d’idee píú volgari ed
acritiche, che si stabiliscono nel caso della parola costrizione, e rinunzia a ogni
consapevolezza della distinzione che, dalla casa di correzione fino alla cooperazione
minuziosamente regolata di un’organizzazione economica corporativistica, sussiste sia
nel modo di essere oggettivo sia nel modo in cui soggettivamente viene avvertita
l’organizzazione costrittiva [Nota 10].
Página 246
In conclusione, bisognerebbe far riferimento, nel contesto del nostro discorso, al fatto
che la caratterizzazione di ogni vincolo dell’arbitrio individuale, attraverso norme che si
contrappongono ad esso, è già una formulazione indeterminata, ma, al tempo stesso,
pericolosa, perché trascura completamente la struttura sociologica e psicologica di
questo vincolo. Come sul piano sociologico la questione decisiva consiste nello stabilire
se l’individuo, soggetto a vincoli, li vive come le sue forme necessarie e indispensabili
di vita e di lavoro, cosí, anche sul piano psicologico bisogna stabilire se l’individuo
assume su di sé i vincoli o se si contrappone ad essi. Nel primo caso, si compie la
trasformazione caratteristica della ‘costrizione’ in un ‘autorità’ riconosciuta. Ci si
rammenti, tuttavia, come anche presso i teorici dell’anarchismo questo tipo di autorità,
che scaturisce dalla natura della cosa, non solo non è affatto negata, ma, al contrario,
l’abbiamo vista caratterizzata come l’unica vera autorità [Nota 11]. Ed è solo uno dei
molteplici modi di giudicare superficiali, particolarmente diffusi riguardo a questa
questione, ritenere che l’autorità, che si basa sul riconoscimento di una necessità
ammessa, di una superiorità riconosciuta e fors’anche rispettata, costituisca una
contraddizione rispetto alla libertà, una pura costrizione. Il riconoscimento dell’autorità
di un ordinamento, che s’impone come ovvio perché utile, o di un capo, di un
organizzatore, di un maestro, è anch’esso un atto di libertà da parte di colui che opera
il riconoscimento. Nelle sue ricerche sui fenomeni di sub-ordinazione e di sovraordinazione sociale, Georg Simmel nota molto acutamente che, per l’analisi sociologica
di questi rapporti, è della massima importanza chiarire il grado di spontaneità e di
partecipazione del soggetto subordinato, di contro al suo frequente occultamento,
operato dal modo di rappresentare superficiale. Ciò che ad esempio si chiama ‘autorità’
presuppone una libertà da parte di colui che è assoggettato all’autorità in una misura
maggiore di quanto non si sia abitualmente disposti a concedere, «essa non è fondata,
neppure nei casi in cui sembra ‘opprimere’ colui che è assoggettato, su una costrizione
e su un semplice doversi piegare». Un’autorità si attua — per Simmel — solo in virtú
del fatto che o una personalità oltrepassa il
Página 247
suo significato puramente soggettivo per esprimere un’istanza oggettiva, per cosí dire
sovraindividuale, o, viceversa, una potenza sovraindividuale, lo Stato, la Chiesa, la
famiglia, conferiscono a una singola personalità un tale valore. In quest’ultimo caso il
significato sovrapersonale si è per cosí dire trasmesso dall’alto ai singoli; nella prima
ipotesi, al contrario, esso è scaturito dalle sue caratteristiche intrinseche.
Nel punto in cui si attua questo passaggio e capovolgimento deve subentrare
visibilmente la fede, piú o meno volontaria, da parte di colui che è assoggettato
all’autorità; infatti lo spostamento tra il valore sovrapersonale e il valore della
personalità, che aggiunge a quest’ultima un di più, anche se ancora minimo, rispetto a
quanto le spetta in modo dimostrabile razionalmente, viene compiuto proprio dalla
fede nell’autorità stessa, è un evento sociologico, che richiede la collaborazione
spontanea anche dell’elemento subordinato. [Nota 12]
Anche ciò che Max Weber ha definito dominio carismatico, che dal punto di vista
contenutistico è piú una dipendenza basata sull’amore e la fiducia anziché una
sottomissione, sebbene anche in esso la costrizione non sia minore che in quest’ultima,
è la prova di quanto sia scarsamente rilevante dal punto di vista sociologico affermare
che non è possibile nessuna subordinazione senza costrizione [Nota 13].
Ora, non si può indicare nessun motivo valido per cui anche nella società socialista,
anzi, qui piú facilmente che altrove, visto l’innalzamento culturale in essa reso
possibile, non debbano sorgere in tutti i campi dell’attività sociale siffatti vincoli
carismatici e autoritari, derivanti dalla natura della cosa e dall’attività di determinate
persone, i quali vincoli manterranno in piedi un ordinamento altrettanto saldo, ma non
cosí oppressivo come quello esistente nello Stato attuale, il quale semplicemente pone
al posto dell’autorità riconosciuta (Autorität) l’autorità imposta dall’esterno (Obrigkeit)
e, al posto del carisma, la violenza (Gewalt). Sicuramente, per coloro che non sentono
l’autorità o il carisma del nuovo ordinamento di vita e di lavoro, la costrizione che
scaturisce da esso avrà il significato di un’oppressione e, nel caso di trasgressione, si
opporrà anche ad essi come violenza. Ma in questa occasione essi, tuttavia, non sono
spinti a questa contrapposizione da rapporti che stanno al di fuori della loro volontà,
come accade sempre oggi. Essi suscitano contro di sé la violenza, attraverso la loro
stessa violenza, rivolta contro la solidarietà degli altri.
Página 248
Ma, prescindendo completamente da ciò, si può dire che per i marxisti non è affatto
paradossale e ancor meno è un miracolo il fatto che ‘lo Stato’, al culmine della potenza
che l’‘apparato costrittivo’ raggiungerà e deve raggiungere nella società socialista,
debba dissolversi ‘in modo misterioso’ nel nulla, come ritiene Kelsen, perché il culmine,
cui si fa riferimento qui, non è affatto il culmine dello Stato odierno, che non esisterà
piú, bensí un livello dell’organizzazione sociale, a partire dal quale quello dello Stato di
classe non sarà piú visibile, sarà sparito nei bassopiani della storia, dai quali il
cammino ha condotto in alto fino ad esso.
A questo punto potremmo interromperci e porre fine al nostro tentativo di districare
le argomentazioni critiche avversarie, che in ogni caso si è protratto abbastanza. Ma
siamo stati spinti a fare ciò dalla necessità: infatti, è sempre sùbito pronto il
fraintendimento grazie al quale acquista per se stesso e per altri il valore psicologico di
verità. La sua risoluzione costa infinitamente piú fatica e richiede complicati
accorgimenti, come abbiamo avuto modo di vedere. Ma, per quanto ciò sia stato già
fatto, resta ancora un aspetto da trattare, che ha procurato alla confutazione kelsiana
dell’ordinamento marxista dello Stato e della società una cosí forte risonanza: il fatto
cioè che Kelsen si sia unito al rimprovero prediletto e consolidato circa il carattere
assolutamente utopistico del socialismo e abbia collegato questo argomento trito e
ritrito in un nesso molto stretto e che per questo motivo appare convalidato sul piano
scientifico, con la sua interpretazione individualistica e anarchica della immagine
marxista della società. A tale riguardo dobbiamo fare ancora, in conclusione, alcune
considerazioni.
Página 249
Capitolo diciottesimo
L’utopismo in Marx ed Engels
Utopismo! non poteva mancare, qui, questa, che è l’ultima parola della critica borghese
alla teoria politica del marxismo. Comunque, per Kelsen, questo carattere utopistico
del socialismo deriva in maniera del tutto ovvia dalla sua interpretazione anarchica del
medesimo. Poiché con la soppressione dello Stato cessa ogni organizzazione
costrittiva, la nuova società diverrà possibile solo se gli uomini cesseranno di essere
violenti, cattivi, folli, ribelli, o anche soltanto pigri e trascurati, in breve, se la natura
umana si trasformerà in modo fondamentale. «Ma, se una cosa può chiamarsi
utopismo, è proprio la fede in un mutamento radicale della natura umana» (p. 56).
Tuttavia sia Marx sia Engels basano le loro intuizioni riguardo alla società futura su un
tale ottimismo sociale, che è sopito nel fondo della loro anima; in tal senso Marx parla
di processi storici «che trasformeranno le circostanze e gli uomini completamente» (p.
56 [102]), e Engels spera in «una nuova generazione, cresciuta in condizioni sociali
nuove, libere», che possa scrollarsi di dosso «tutto il vecchiume dello Stato» (p. 56
[102]). «Ed è comprensibile: perché, senza una tale ipotesi psicologica, la teoria
dell’estinzione dello Stato rimane appesa per aria» (p. 57 [104]). Sicuramente questa
ipotesi trova un sostegno nel fatto che il marxismo rende scarsamente conto della
forma concreta che assumerà la società futura e, riguardo a essa, dice soltanto, in
modo del tutto generico, che al suo interno non esisterà piú né sfruttamento né
oppressione. Ma, ammesso che ciò sia giusto, viene con ciò detto che in tale
ordinamento sociale niente potrà far ribellare gli uomini o spingerli a proteste e
sollevazioni? «Lo sviluppo verso forme piú elevate e migliori di società in generale e di
economia in particolare dovrebbe essere definitivamente precluso con il comunismo?».
E perché questo sviluppo dovrebbe compiersi diversamente da come si è compiuto
finora, cioè in forma di opposizione? «Veramente non c’è nessun’alPágina 250
tra opposizione contro un ordinamento sociale se non una opposizione di classe [...]?»
(p. 80 [pp. 127-8]).
In queste argomentazioni di Kelsen ritroviamo le due obiezioni contro il socialismo,
che fanno parte delle battute che circolano nelle assemblee popolari contro i socialisti:
1) per realizzare il socialismo gli uomini dovrebbero prima diventare degli angeli; 2) il
socialismo si ritiene il regno dei cieli, al di là del quale non v’è piú alcuna beatitudine.
Da ciò scaturisce che, poiché nell’àmbito di questo discorso gli uomini non solo non
vengono presentati come angeli, bensí come diavoli, e la terra come una valle di
lacrime, che, per necessità naturale, in virtú di qualche esigenza metageologica non
può non restare la stessa valle di lacrime, risulta chiaro che il socialismo è una
rappresentazione buona per bambini grandi e piccoli, ovvero, volendo esprimerci in
termini scientifici, è una dottrina chiliastica.
Ma come stanno, in realtà, le cose col socialismo? Ciò che nel pensiero marxista
costituisce propriamente il suo progresso, per cui esso si vede separato — in quanto
socialismo scientifico — dal socialismo utopistico, è il fatto che esso considera il fine
socialista non altrimenti che come un prodotto di uno sviluppo storico concreto, che
quindi dev’essere raggiunto e configurato soltanto grazie agli uomini, quali sono ora.
Ma naturalmente ciò non significa — come ritengono, con una conclusione
insolitamente ingannevole, quasi tutti i critici di Marx — che gli uomini debbano per
questo restare uguali. È significativo: nel medesimo istante in cui ci s’indigna o in cui ci
si prende gioco del marxismo, perché esso giungerebbe all’assurdità di una condizione
finale immutabile della società, gli si contrappone una ‘natura umana’ eterna,
immutabile, per la cui mancata considerazione le sue speranze di sviluppo dovrebbero
diventare miseramente motivo di scandalo. Ma se prescindiamo dapprima da qnesto
elemento della famosissima immutabilità della natura umana, il senso specifico del
socialismo marxista è esattamente questo, di mostrare come sia possibile, sulla base
dello sviluppo economico, un ordinamento sociale per l’uomo in tutta la sua
peccaminosità, il quale rende innocua questa ‘peccaminosità’, perché limita ad un
minimo le necessità delle trasgressioni e le possibilità delle loro manifestazioni. Esso è
qui del tutto d’accordo con Kant, il quale già si doveva lamentare del fatto che, di
contro alla sua idea di una costituzione repubblicana degli Stati e alla lega dei popoli
che ne scaturiva, «molti affermano che dovrebbe essere uno Stato di angeli: infatti gli
uomini, con le loro tendenze egoistiche, non sarebbero capaci di una costituzione di
forma cosí sublime». E a ciò Kant risponde:
Página 251
Il problema della costituzione di uno Stato è risolvibile, per quanto l’espressione possa
sembrare dura, anche da un popolo di diavoli, purché siano dotati d’intelligenza. Il
problema si riduce a questo: come ordinare una moltitudine di esseri ragionevoli, che
desiderano tutti assieme di sottoporsi per la loro conservazione a pubbliche leggi, alle
quali ognuno nel segreto del suo animo tende a sottrarsi, e come dare a esseri di
questa sorta una costituzione tale che, malgrado i contrasti derivanti dalle loro private
intenzioni, queste si neutralizzino l’un l’altra, di maniera che essi, nella loro condotta
pubblica, vengano a comportarsi come se non avessero affatto cattive intenzioni. [Nota
1]
Per il socialismo d’impronta marxista il nuovo ordinamento sociale non è affatto,
innanzi tutto, un problema morale, e del resto neanche per Kant questo problema
significava «il miglioramento morale degli uomini», bensí un problema di
organizzazione sociale, la questione fino a che punto possa venir utilizzato il
meccanismo della natura nelle disposizioni degli uomini, quali sono ora, per realizzare
un ordinamento sociale piú armonico. Sicuramente l’ordinamento socialista della
società e, ancor prima, la propaganda e l’insegnamento socialisti ce la metteranno
tutta per suscitare le forze morali dell’uomo, per rafforzarle e mobilitarle per le sue
idee. Ma il socialismo non fonda la sicurezza interna del nuovo ordinamento sociale su
una nobilitazione o su una moralizzazione, bensí sul fatto che esso limiterà gli impulsi
verso azioni immorali e criminali in maniera essenziale rispetto all’ordinamento
odierno. La società odierna rende difficile ai poveri — e piú del novanta per cento si
trovano oggi in questa situazione — vivere in modo virtuoso, anche soltanto nel senso
esteriore del termine, cioè in modo conforme ai comandamenti della morale e del
diritto. La nuova forma della società vuole, al contrario, fare della costrizione sociale al
comportamento illegale e immorale un’eccezione. Si rifletta solo un istante a quanti
crimini e atti immorali, che oggi fanno apparire la ‘natura umana’ cosí ‘diabolica’,
vanno imputati alle condizioni sociali, anzi addirittura alle leggi esistenti. Indigenza,
corruzione, ignoranza, alcolismo, generano la quasi totalità dei delitti, di cui la società
attuale soffre, e a questi si aggiungono ancora i ‘criminali’ come tali considerati per
legge, per esempio coloro che si rendono colpevoli di procurato aborto, o di
omosessualità, o di vilipendio della religione, o di vagabondaggio o di cose del genere
[Nota 2]. Quanto poco si faccia affidamento, nell’idea marxista di una nuova società,
sull’angelicità degli uomini, vorrei chiarirlo preferibilmente con una metafora. Che cosa
si fa oggi in un
Página 252
luogo nel quale circolano molti uomini, che hanno per lo piú l’amabile consuetudine di
non chiudere la porta alle proprie spalle? Ci saranno quelli che diranno: si applichi una
targhetta con la richiesta: “Per favore, chiudere la porta!”. Benissimo: ma questo
significa voler migliorare gli uomini, cioè fare affidamento sulla loro gentilezza, sul loro
riguardo, anzi anche sulla loro attenzione, in breve: fare affidamento sul fatto che essi
sono ‘angeli’. E il risultato dimostra che ciò non giova a nulla. No, l’unico rimedio per
tenere la porta chiusa è... installare un sistema di chiusura automatica e mettere una
targhetta: “Non chiudere!”, e in tal modo non si dipenderà piú dalla buona volontà dei
singoli né dalla loro malvagità o negligenza e la porta resterà ugualmente ogni volta
chiusa.
E questo è il senso in cui l’ordinamento socialista riflette sulla natura degli uomini:
creare istituzioni le quali cessino, per quanto è possibile, di fare affidamento sulla
buona o addirittura disinteressata volontà, ma, a questo fine, eliminino anche i motivi
che possono provocare una contraddizione rispetto all’ordinamento sociale, ponendo in
questo modo la società sulla base di un meccanismo economico capace di funzionare,
per le sue necessità obbiettive, in modo formalmente automatico, anche se
naturalmente mantenuto in azione sempre attraverso lo spirito e la volontà dei suoi
membri. Solo che questo spirito e questa volontà non hanno nessun motivo per
turbare il meccanismo economico, piuttosto sono interessati a promuoverlo, perché
non ne sono le vittime, bensí i suoi beneficiari.
Ovviamente anche nell’ordinamento comunista della società esisteranno motivi di
turbamento che non si radicheranno nei rapporti di produzione e di distribuzione, ma si
tratterà di turbamenti derivanti dalla sfera sessuale, o che risulteranno da moti
dell’animo di ogni genere, come ira, gelosia, odio, o, infine, da predisposizioni
patologiche. Ma già oggi i delitti che derivano esclusivamente da una siffatta situazione
personale degli autori e non da quella sociale costituiscono una minoranza esigua
all’interno della criminalità di un paese. Ed è evidente per chiunque sia in grado
soltanto di trasferirsi — per cosí dire — dalle condizioni oggi dominanti nell’ambiente
sociale, completamente diverso, del nuovo ordinamento, che, anche a prescindere del
tutto dalla trasformazione che inevitabilmente dovrà prodursi nello spirito e nei
sentimenti, tali turbamenti di natura puramente personale dell’ordinamento dovranno
diventare, in misura maggiore rispetto a oggi, dei casi isolati e delle eccezioni. Si deve
ancora prendere in considerazione l’influenza che sul piano educativo eserciterà il
nuovo modo di vivere, la crescita del livello culturale generale, la trasformazione delle
relazioni reciproche tra i sessi in direzione di una facolPágina 253
tà decisionale fattasi internamente piú libera e esteriormente piú facile, la formazione
di nuovi costumi popolari, e in generale, l’assuefazione a una nuova ideologia sociale.
La supposizione che la criminalità si ridurrà a tal punto da divenire un’eccezione, una
sorta di patologia sociale, nell’àmbito di un ordinamento sociale radicalmente diverso,
che avrà eliminato in primo luogo tutte le cause della criminalità che nascono dalla
lotta per l’esistenza e derivano dalle forti differenze della situazione sociale: tale
supposizione non è affatto un utopismo non scientifico e una forma di ingenuo
millenarismo. Al contrario: in questa direzione si muove ogni lotta contro la criminalità
che vada presa sul serio, la quale, a partire da Tommaso Moro — che,
significativamente, è insieme il primo teorico del comunismo — prende le mosse dalla
consapevolezza che il crimine può essere combattuto effettivamente solo eliminando le
cause del medesimo. «Si stabiliscono», scrive Moro nel suo libro vecchio piú di
quattrocento anni, ma tuttavia ancora cosí attuale, «infatti, per chi ruba, pene gravi,
pene terribili, mentre meglio era provvedere a qualche mezzo di sussistenza, acciocché
nessuno si trovasse nella spietata necessità, prima, di rubare, e poi di andare a morte»
[Nota 3]. Il modo di pensare che spinge ad aspettarsi dalla società comunista una
percentuale quasi evanescente di criminalità rispetto alla situazione attuale, non ha
quindi niente a che vedere con la fede acritica in una trasformazione fantastica della
natura umana, ma, al contrario, scaturisce dalla concezione molto empirica,
convalidata sul piano statistico, secondo la quale l’uomo e, in particolare, la sua
criminalità sono un prodotto delle circostanze in cui vive. Se già da un pezzo si è
sperimentato che il furto si trova in una relazione determinata con il livello del prezzo
del grano, è realmente cosí utopistico che, tranne singoli casi, il furto sarà eliminato
non appena non esisterà piú un prezzo del grano? Proprio se, secondo l’opinione di
Kelsen, si ritiene di fatto «piú prudente», «nell’àmbito della scienza sociale empirica —
soprattutto se si tratta di una profezia — fondarsi non sulla speculazione della
dialettica, ma sull’esperienza positiva» (p. 19 [49]), si dovrà considerare questa
scomparsa della criminalità come fenomeno sociale di massa e la sua trasformazione in
casi individuali eccezionali come un fenomeno probabile e da attendersi in base al
determinismo sociale. E l’atteggiamento opposto porrebbe proprio la riflessione
positiva direttamente di fronte a un enigma inesplicabile.
Ma a ciò si aggiunge che questa «fede nel cambiamento della natura umana»,
considerata da Kelsen e non solo da lui — vi è qui uno dei cavalli di battaglia della
critica professorale a Marx —
Página 254
cosí ironicamente, possiede un contenuto reale, anzi esatto, che proprio sulla base
empirica non va trascurato, che serve da ovvio presupposto di tutte le nostre misure di
pedagogia sociale e di politica sociale. Se non ci fosse consentito ammettere che
attraverso mutate condizioni di vita e influenze diverse anche delle nature
completamente corrotte possono cambiare, a che scopo allora tutte le nostre case di
correzione, gli istituti di rieducazione, quelli contro l’alcolismo, e tutte le istituzioni che
mirano ad aprire nuove strade in vista di un lavoro socialmente utile a tutti coloro che
sono sviati dal punto di vista morale e penale? Il modo di pensare derivante dalla
concezione del materialismo delle scienze naturali è andato avanti, in questa ‘fede’,
fino a una sorta di fanatismo, in cui non riconosceva piú alcuna funzione alla natura
umana nella formazione del suo carattere — rimanendo fedele del resto alla sua
negazione dell’anima in generale — ma la considerava completamente soltanto come
un pezzo di cera, che assumeva, sotto le pressioni delle relazioni, qualsiasi forma. In
modo particolarmente significativo ciò viene espresso da Robert Owen, che prende le
mosse dal materialismo, allorché afferma:
Contro il principio che il carattere dell’uomo sia il prodotto di influenze esterne si è
sollevata la obbiezione che ogni uomo possiede una coscienza innata [...]. La verità è
questa: la coscienza,viene fabbricata esattamente come un tessuto di cotone o una
qualsiasi altra merce. Per un indú possiamo apprestare una coscienza da indú, per un
cannibale una coscienza da cannibale ecc. [...] Mi si dia un bambino e mi si consenta di
condurlo in un ambiente qualsiasi e gli fabbricherò, a seconda dei casi, una coscienza
ebrea, una coscienza cristiana, una coscienza indú, una coscienza maomettana ecc.
[Nota 4]
Ora, proprio il marxismo è ben lungi da una fiducia cosí ingenua nella possibilità di
plasmare in modo passivo la natura umana, come invece sembrava quasi ovvio al
materialismo che nega l’anima e, con essa, ogni autonomia delle leggi psichiche. E,
proprio riferendosi a Owen, Marx scrive, già nelle sue tesi su Feuerbach, il concetto
fondamentale per la sua concezione materialistica della storia:
La dottrina materialistica per cui gli uomini sono prodotti dell’ambiente e
dell’educazione, e per cui, pertanto, uomini mutati sono prodotti di un altro ambiente e
di una mutata educazione, dimentica che sono proprio gli uomini che modificano
l’ambiente e che l’educatore stesso deve essere educato. Essa quindi finisce per
necessità col separare la società in due parti, una delle quali è sollevata al di sopra
della società. (Per es. in Robert Owen). La coincidenza del variare
Página 255
delle circostanze dell’attività umana, può essere concepita o compresa razionalmente
solo come prassi rivoluzionaria. [Nota 5]
Per Marx, dunque, la trasformazione della natura umana non è un miracolo
incomprensibile, ma un momento necessario di un processo sociale, nel quale questa
trasformazione scaturisce dall’attività degli uomini, con la quale essi, per lo piú
inconsapevolmente, trasformano il loro ambiente sociale e che, naturalmente, a sua
volta, viene non solo limitata, ma anche suscitata dalla situazione sociale di volta in
volta esistente. Concordando completamente con questa concezione, Marx, già nella
Miseria della filosofia — di contro all’opinione che le idee e i principi fanno la storia e
che ogni principio ha il suo secolo, in cui si manifesta — domanda perché un principio
si è manifestato, per esempio, nell’Undicesimo o nel Diciottesimo secolo, e non in
un’altra epoca, e risponde che, per comprendere questo, ci si trova costretti
a esaminare minuziosamente quali fossero gli uomini dell’XI, quali quelli del XVIII,
quali fossero le rispettive necessità, le loro forze produttive, il loro modo di produzione,
e quali fossero i rapporti fra uomo e uomo, risultanti da queste condizioni di esistenza.
Ora, approfondire tutte queste questioni, non significa [...] rappresentare questi
uomini come gli autori e contemporaneamente gli attori del loro dramma? [Nota 6]
E Kelsen cita anche il principio — dell’epoca matura della teoria marxista — che
concorda con queste concezioni fondamentali, nel quale Marx dice che la classe operaia
«dovrà passare per lunghe lotte, per una serie di processi storici che trasformeranno
completamente le circostanze e gli uomini» [Nota 7]. A questo punto deve tanto piú
apparire un’ispiegabile incomprensione della teoria marxista dello sviluppo sociale
quando Kelsen, attraverso la sottolineatura dell’espressione «trasformeranno
completamente», e tralasciando invece la sottolineatura della parola «circostanze»,
scorge un miracolo. Se qui c’è un mistero, esso è stato già risolto da Marx, ancora una
volta, nelle penetranti tesi su Feuerbach, ove si legge: «La vita sociale è
essenzialmente pratica. Tutti i misteri che sviano la teoria verso il misticismo trovano
la loro soluzione razionale nella prassi umana e nella comprensione di questa prassi»
[Nota 8]. Una tale comprensione è assente ogni qual volta si ritiene che circostanze,
istituzioni e funzioni completamente mutate non debbano aver mutato niente
nell’habitus psichico degli uomini che vivono in esse, anzi da esse sono prodotti.
Página 256
Del resto l’intera critica di Kelsen è, a questo punto, tanto piú incomprensibile, e
spiegabile solo in base al bisogno polemico di ricorrere a un argomento cosí
ingannevole e di sicuro successo com’è la presunta dimostrazione dell’utopismo e della
fede acritica nei miracoli, in quanto alla fine leggiamo, nel nostro critico stesso, la
seguente ammissione:
Certo, un ordinamento costrittivo che garantisca la produzione comunista dopo molto
tempo produrrà dei costumi di pensiero e di volontà comunisti allo stesso modo in cui
lo Stato del capitalismo ha fatto penetrare nella carne e nel sangue il rispetto per la
proprietà privata (p. 79 [127]).
Se si pensa inoltre che non si tratta semplicemente di ‘abitudini’, ma di tutto un
sistema dell’ideologia, che rielaborerà e rappresenterà necessariamente la nuova
condizione di vita nelle forme delle idee della ragione, della morale, del diritto,
dell’arte, della religione, si avranno allora appunto quegli uomini trasformati del
Ventunesimo o del Ventiduesimo secolo, che, in maniera assolutamente certa, saranno
uomini diversi, cosí come noi oggi siamo uomini diversi da quelli dell’Undicesimo
secolo, e che tanto piú saranno diversi, in quanto il fondamento economico della loro
vita — senza lotte di classe, senza preoccupazioni per l’esistenza individuale — è
mutato come non si è mutato ancora da secoli [Nota 9].
Página 257
Kelsen si sarebbe sicuramente stupito di meno per il ‘miracolo’ della trasformazione
degli uomini nel futuro, se non avesse interpretato la concezione materialistica della
storia — che sta al fondamento, in questo punto, come in ogni punto, del pensiero
marxista — in modo appunto cosí inguaribilmente ‘materialistico’, come per lo piú
accade. Infatti egli non avrebbe avuto nessun motivo per individuare una
contraddizione del marxismo nel fatto che la concezione ‘materialistica’ fondamentale
della estinzione dello Stato diventa — a suo avviso — comprensibile solo attraverso
una «ipotesi psicologica» (p. 57 [104]), e che il marPágina 258
xismo è costretto a introdurre, se vuole realizzare la sua concezione della società
‘senza Stato’, un «fattore psicologico», vale a dire, la «nuova generazione»,
l’«abitudine» alle nuove condizioni (p. 70 [119]). I brani di Marx, citati in precedenza,
nei quali sono svolti contemporaneamente i concetti portanti della sua concezione
materialistica della storia, dimostrano come anche per Marx il «fattore psicologico» sia
un elemento integrante della sua concezione materialistica della storia. Questo punto
l’ho esposto cosí spesso e dettagliatamente, anche in questo libro, che posso
accontentarmi semplicemente di farvi riferimento [Nota 10]. Il cosiddetto fattore
psicologico non compare nel marxismo soltanto nel futuro, per il quale — secondo
l’opinione di Kelsen — vale chiaramente la frase: «non si sa nulla di certo», per trarre
d’impaccio, in questo modo, come un deus ex machina, lo ‘Stato del futuro’ trovatosi in
gravi difficoltà, ma per chiunque citi i passi di Marx non semplicemente usandoli
singolarmente, bensí li comprenda sulla base dello spirito vivente della sua concezione
complessiva, non si può intendere neanche una parola della critica economica del
passato fatta valere da Marx, non è comprerigibile in generale neanche un concetto
della sua concezione della storia, se non si pensa sempre insieme l’uomo, l’essenza
attiva, nella cui testa il processo materiale dev’essere innanzi tutto trasferito, per
diventare processo economico e storico. La ‘fede’ nel ‘fattore psicologico del futuro’ non
è nient’altro che l’ammissione di quell’elemento necessario di una legalità sociale, la cui
sottovalutazione nel passato e nel presente viene cosí spesso imputata alla concezione
materialistica della storia come peccato mortale e gravissima ignoranza. Ma, ciò che
per il passato e il presente è una virtú e una condizione di scientificità, può tuttavia
essere un vizio e una fonte di non scientificità per il futuro? I nostri critici non potevano
contraddirsi davvero in maniera piú madornale.
Non occorre dunque che ci occupiamo piú diffusamente, in quanto può considerarsi
liquidata, dell’obiezione — tanto non scientifica quanto acritica — secondo cui il
marxismo potrebbe costruire come possibile il suo nuovo ordinamento sociale solo
nella fede
Página 259
ingenua in un’umanità rinnovata e nobile al di là di ogni esperienza. Resta dunque
ancora l’altro rimprovero, relativo al fatto che, secondo il socialismo, nella nuova
società dovranno sparire tutte le imperfezioni, e cesserà di fatto, dunque, ogni
sviluppo. È interessante considerare un po’ piú da vicino, in questa occasione, il
meccanismo della critica dotta che entra in campo contro il marxismo e constatare
come anch’esso lavori in modo contraddittorio. Da un lato, ci viene rimproverato di non
tener conto dell’immutabilità della natura umana, dall’altro, di supporre l’immutabilità
del nuovo ordinamento. Se si tratta del fatto che diciamo che nuovi rapporti
produrranno uomini nuovi, allora siamo degli incorreggibili fanatici dello sviluppo; se
diciamo invece che, inoltre, i nuovi rapporti si trasformeranno senza lotta di classe,
solo per mezzo dell’attività sociale consapevole, per cui raggiungeranno un livello
elevato di stabilità solidale, allora neghiamo lo sviluppo.
In realtà, al marxismo non è mai venuto in mente — com’è naturale — di affermare
che con l’eliminazione dei conflitti di classe cesserà lo sviluppo e sarà raggiunta una
condizione di armonia assoluta e di equilibrio statico. Solo la forma dello sviluppo
sociale viene trasformata. Esso finora si è svolto come una lotta tra le classi, cioè è
emerso dal contrasto di sfere di esistenza che non solo si combattevano
reciprocamente, ma che anche si escludevano nella loro pretesa di dominio. La società
umana è esistita ed esiste, finora, ancora non come una realtà solidale, bensí — e del
resto questa è stata la sua configurazione storica — come una struttura scissa, fin dalle
fondamenta, in interessi vitali opposti, in cui ogni interesse parziale ha potuto ottenere
la sua partecipazione al godimento dei vantaggi sociali solo attraverso la lotta e la
violenza esercitata contro gl’interessi di parte contrapposti. Ogni progresso nel senso di
una maggiore socialità, di una piú vasta solidarietà, di una piú completa coincidenza
fra il concetto d’ideale della società e la sua effettiva esistenza, in breve, ogni sviluppo
sociale è stato, finora, per cosí dire, soltanto il risultato involontario della lotta di
classe: in quanto ogni classe oppressa, con la sua vittoria, eliminava la sua
oppressione, il torto che l’opprimeva, l’irrazionalità dei rapporti che l’opprimeva,
contemporaneamente scompariva una parte di questa oppressione, di questo torto e di
questa irrazionalità in generale dalla vita sociale. Poiché il modo di esistenza finora
esistente della società non è stato e non è quello della solidarietà, bensí quello della
lotta delle sue classi l’una contro l’altra, la forma, finora esistente, dello sviluppo
sociale, è stata ed è anche quella della lotta di classe [Nota 11].
Página 260
Ma da ciò non deriva che con l’abolizione delle classi sparirà lo sviluppo, bensí
soltanto la lotta di classe. Ovviamente non è affatto necessario chiedersi, come fa
Kelsen, se nella società senza classi gli uomini non si agiteranno piú per niente e se
non saranno spinti piú da niente alla ribellione. Avremmo, al contrario, sicuramente
ancora a sufficienza cose del genere. Infatti, proprio quando saranno sparite le
preoccupazioni,
assolutamente comuni,
per l’esistenza,
quando l’interesse
propriamente ancora animale — per il nutrimento, i vestiti, la casa, per la cura di
allevare e tirare su i giovani — non assorbirà piú la fetta principale di ogni interesse,
sentimento e lavoro degli uomini, allora avrà avuto inizio l’epoca in cui gli uomini
saranno diventati per la prima volta maturi per una reale delicatezza di sentimenti, e
forse allora diverranno insopportabili parecchie cose che oggi sembrano del tutto
sopportabili persino a persone colte, come ad esempio l’indifferenza in questioni
riguardanti le visioni del mondo. Anzi si può ipotizzare che
Página 261
nelle questioni della metafisica, della religione, dell’arte, si svilupperanno dei contrasti
della cui intensità, che coinvolgerà realmente gli uomini, non abbiamo oggi né
l’esempio né il presentimento. Non è dunque neppure vero che lo sviluppo dovrà
cessare di svolgersi in modo conflittuale, bensí soltanto che non si tratterà
necessariamente di conflitti di classe. Ci saranno contrasti d’opinione che formeranno
l’intera scala, dalle semplici partizioni all’interno delle diverse organizzazioni
amministrative fino alle grandi prese di posizione in fondamentali questioni culturali
(Kulturfragen), ma senza che tali conflitti si estendano fino alla minaccia o anche solo
alla restrizione dell’esistenza personale che, attraverso la nuova struttura economica, è
sin dall’inizio esclusa da questi conflitti, e la cui garanzia, ugualmente sufficiente per
tutti, sarà quindi una cosa ovvia, un senso comune sociale (ein soziales Adiaphoron),
tanto quanto lo è stato finora, anche nelle piú violente lotte di classe, la comunanza
dell’aria da respirare (certo non nelle abitazioni, ma) nella libera natura. Senza dubbio,
è in sé ipotizzabile che anche dei conflitti riguardanti visioni del mondo possano essere
decisi col ferro e col fuoco; le guerre di religione lo dimostrano. Ma, in primo luogo,
bisogna tener presente che non ci sono stati mai, in generale, nella storia, dei puri
conflitti tra visioni del mondo, ma che, per esempio, proprio le guerre di religione
erano le forme puramente ideologiche, in cui erano decisi poderosi conflitti economici e
politici, cosí che dall’asprezza delle questioni di potere e di esistenza di coloro che
lottavano derivava la furia e la crudeltà nel modo di condurre la guerra, che, in fondo,
contrastava addirittura con lo spirito delle dottrine religiose, che dovevano fornire la
copertura. Ma, in secondo luogo, già il fatto che ripugna alla nostra attuale coscienza
giuridica e sociale — per quanto il fanatismo possa ancora vivere nella massa — il
decidere con la violenza le diversità di confessione religiosa, di fede e di visione del
mondo, mostra in quale direzione si muove lo sviluppo spirituale. E ci si può
immaginare quale successo dovrà avere, se non sarà piú semplicemente una
menzogna ufficiale, bensí un’inclinazione culturale pura, resa per la prima volta
possibile grazie all’educazione, alla formazione del carattere, all’esempio dato con
l’esercitarla pubblicamente e, innanzi tutto, grazie all’eliminazione del suo intreccio con
aspirazioni di potere, di carattere economico e politico. Una tale trasformazione
spirituale non solo sarà possibile, ma, fino a un certo livello, si realizza già all’interno
del mondo capitalistico ed è ancora in grado di crescere in esso. Ma soltanto in un
ordinamento socialista si realizzerà in modo completo. Applicare a una tale previsione il
luogo comune già pronto dell’ottimismo e dell’utopismo non significa altro che dare un
nome piú gradito al proprio tradizionalismo e, inoltre, chiudere gli occhi davanti a ciò
che si sviPágina 262
luppa intorno a noi e in vista del quale lavorano i migliori del nostro tempo:
l’elevamento, in verità lento, ma tuttavia non inutile, del livello culturale di ampie
masse.
Il rimprovero di utopismo, rivolto al marxismo di recente, assume volentieri una veste
moderna, nella misura in cui si ammanta di una veste di psicologia della religione e
cerca di ‘spiegare’ il marxismo come una forma di millenarismo religioso. Al riguardo è
stato addirittura scritto un libro da Fritz Gerlich, intitolato Der Kommunismus als Lehre
vom tausendjährigen Reich, che è una raccolta degli equivoci piú tendenziosi sul
marxismo e sulla concezione materialistica della storia. Quanto l’autore sia profondo
nella sua critica del marxismo, lo si può dedurre dal fatto che egli cita, come teste
principale a favore della fede marxista nell’«opera di redenzione e nella capacità di
riscatto del proletariato», il comunista Weitling, poiché questi nel 1842 annunciava un
nuovo messia [Nota 12]. Qui non c’è lo spazio né la necessità di controbattere nel
dettaglio la concezione di Gerlich. Soltanto perché presso la dotta critica a Marx è
divenuta molto diffusa la caratterizzazione del marxismo come una sorta di
millenarismo ci sia consentito fare ancora le seguenti osservazioni al riguardo. Se si
definisce il marxismo e il socialismo in generale millenarismo, non vengono
sufficientemente distinte l’una dall’altra due cose che devono essere tenute
rigorosamente separate: il marxismo e il socialismo come movimento e il marxismo e il
socialismo come teoria. Se si pensa che i seguaci del socialismo marxista vi aderiscono
con una sorta di entusiasmo religioso e che essi sperano nel e aspirano al fine del
socialismo — la società senza classi dell’umanità solidale — con lo stesso fervore con
cui i primi cristiani speravano nel e aspiravano al regno millenario e tutti i bisognosi di
riscatto aspirano all’epoca del messia, con ciò si esprime solo una verità che concerne
il carattere psicologico di ogni grande rivoluzione. Ma questa psicologia, che vuol
apparire cosí critica, viene meno proprio dove inizia ciò che di caratteristico vi è nel
marxismo e ciò attraverso cui esso si distingue dai precedenti movimenti millenaristici:
il fatto, cioè, che appartiene precisamente al suo habitus psicologico fondare le sue
speranze non su una fede puramente fanatica, ma su un’indagine oggettiva sociologica
e economico-politica. Il marxismo è ‘millenaristico’ solo in virtú della coincidenza delle
sue fredde analisi teoriche e dell’interesse del proletariato per lo sviluppo, interesse
che esso non ha creato, ma semplicemente indagato. Non è il marxismo in quanto tale
ad essere un millenarismo, ma le sue teorie si sposano, in modo necessario, nel
proletariato, il quale le ha comprese, col suo
Página 263
originario millenarismo, allo stesso modo in cui, per esempio, altrettanto
necessariamente, in un Fritz Gerlich, si congiungono col suo originario
conservatorismo, che in ogni millenarismo teme immediatamente una «fonte di
sovvertimento» [Nota 13]. Il socialismo, in quanto movimento, è una corrente di
azione, di prese di posizione e di valutazioni attive. In esso l’idealismo può e addirittura
deve avere un ruolo di guida. Tutto ciò, e persino la fede fanatica e la dedizione piena
di convincimento ad una grande speranza, in quanto semplici forme necessarie in cui
deve presentarsi da un punto di vista psicologico il movimento, non dimostrano affatto
che esso è millenaristico anche oggettivamente, cioè che il suo fine è un semplice
sogno. Il ritenere che, poiché il socialismo marxista, in quanto movimento di massa,
mostra molti tratti che concordano psicologicamente con i movimenti millenaristici del
passato, proprio per questo debba necessariamente essere esso stesso una forma di
millenarismo, è una delle conclusioni piú superficialmente ingannevoli che si possano
trarre. Al contrario, è proprio il marxismo come teoria a chiarire non solo i tratti
millenaristici del marxismo come movimento, ma a darci anche la chiave esplicativa del
motivo per cui questo movimento non è un puro millenarismo e per cui i primi
movimenti millenaristici non potevano non restare un puro millenarismo. È proprio la
concezione materialistica della storia a metterci in condizioni di comprendere i
millenarismi di tutte le epoche storiche, nella loro realtà sociale, e di superare la
interpretazione assolutamente improduttiva di questi movimenti come semplici moti di
fanatismo e profezie infondate, delle quali il gusto sazio della concezione borghese non
può soddisfarsi.
In tal modo, il marxismo dev’essere definito addirittura come la teoria del
millenarismo. E se il millenarismo si configura come sogno del regno millenario, il
marxismo, in quanto teoria, porta a compimento, rispetto a esso, l’opera di
interpretazione di sogni (Traumdeutung), attraverso la quale rende manifesto il nucleo
reale di questo sogno e lo solleva alla coscienza degli strumenti e dei fini chiari, in base
ai quali diviene, da sogno millenario, la realtà divenuta matura di un futuro vicino.
Con la rappresentazione barocca, in base alla quale la dottrina marxista della
soppressione dei conflitti di classe e del venir meno delle lotte di classe equivale alla
fine dello sviluppo e del progresso sociali in generale, è connessa ancora un’altra
opinione, tanto notevole quanto strana, che non si presenta, è vero, esplicitamente, in
Kelsen, ma che è forse da lui condivisa. E poiché talvolta una tale opinione la s’incontra
persino nello schieramento marxista, vorrei qui soffermarmi brevemente su di essa.
Talvolta
Página 264
si sente dire, cioè, che la concezione materialistica della storia è contraddittoria, in
quanto fa dipendere lo sviluppo storico dai rapporti economici e, in particolare, dalla
lotta di classe. Se, pertanto, venisse raggiunta una condizione sociale, in cui non vi
fossero piú lotte di classe, la concezione materialistica della storia non avrebbe piú
alcun valore. Questo modo di vedere identifica le lotte di classe con le condizioni
economiche della vita sociale in generale, cioè, identifica una struttura storica della
base economica della società con questa base stessa. Ma tuttavia è chiaro che anche in
una società socialista saranno pur sempre i suoi rapporti economici a costituire, qui
come dappertutto, il fondamento e l’elemento determinante in ultima istanza delle sue
forme di vita e di cultura. Solo in tal senso è giusto dire che i rapporti economici nella
società socialista non avranno piú quell’importanza che costituisce, per cosí dire, un
fato, nel senso cioè che essi soggiacciono alla regolamentazione consapevole. Ma
proprio per questo, anzi, essi rendono possibile e determinano il carattere
completamente diverso di questo ordinamento sociale, la sua struttura intellettuale e
morale completamente diversa, in breve: la sua mutata sovrastruttura ideologica. Se
già oggi notiamo come la fantastica industrializzazione della nostra produzione, il
dominio favoloso dello spazio e del tempo, ha completamente trasformato il ritmo di
vita degli uomini della civiltà (Kulturmenschen) odierna, allora è chiaro che la poderosa
trasformazione dell’uomo sociale di un ordinamento sociale razionale del futuro sarà la
conseguenza non certo di una manna miracolosa che scende sulla terra dal paese di
Utopia, bensí sarà la conseguenza dei mutati rapporti economici, in cui poi gli uomini
vivranno. La concezione materialistica della storia, pertanto, ovviamente, vale anche
nell’ordinamento socialista della società, perché essa è anzi una teoria sociologica e
non una teoria di economia politica. I princípi teorici dell’economia politica, che si
riferiscono ai fenomeni dell’economia privata, perdono la loro validità non appena non
vi sia piú nessuna economia privata. I concetti dell’economia politica sono appunto —
come Marx ha sempre messo in rilievo — categorie storiche, e l’economia politica,
nonostante il suo metodo astratto, è la scienza di un oggetto storicamente dato e
storicamente transeunte. La sociologia, invece, è la scienza della vita della società in
generale, la quale vita, in quanto tale, in verità ha avuto inizio una volta e una volta
finirà, con il che, però, non scomparirà semplicemente l’oggetto di una scienza, bensí
ogni scienza in generale. In tal senso, i concetti sociologici non sono categorie storiche
e le conoscenze che essi offrono non sono semplicemente delle verità storicamente
delimitate, ma costituiscono i presupposti della conoscenza di tutte le configurazioni
storiche della vita sociale in generale. E cosí anche la concezione materiaPágina 265
listica della storia — quale noi l’intendiamo e quale l’abbiamo di continuo esposta in
questo libro — è una teoria sociologica, che comprende la vita sociale prima e dopo
delle lotte di classe, e che anzi spiega non solo perché le lotte di classe sono dovute
nascere, ma anche quando esse possono venir superate. E, pertanto, essa rimane,
anche nella società senza classi, la teoria dello sviluppo sociale; il fatto che gli uomini
piú fortunati di quel tardo futuro avvertiranno i loro rapporti economici meno di noi, il
fatto che, presso di essi, la bella espressione di Theodor Vischer, secondo cui
«l’elemento morale si comprende sempre da sé», varrà anche per l’elemento
economico, non cambia la legge sociologica della concezione materialistica della storia,
allo stesso modo che il dato di fatto, per cui noi normalmente non avvertiamo la
pressione dell’aria, non elimina le leggi della pressione atmosferica.
Página 266
Capitolo diciannovesimo
Perché non veniamo compresi?
Se ora, alla fine delle nostre ricerche, diamo uno sguardo complessivo al tentativo,
operato da Kelsen, di fornire al marxismo una critica immanente della sua concezione
dello Stato e della società, vediamo con chiarezza per quale motivo un’impresa del
genere non poteva riuscirgli: egli ha criticato singole frasi di Marx e Engels, ma non è
penetrato nell’intima sostanza di questa teoria, ne è rimasto letteralmente al di fuori e,
di fatto, è rimato sempre all’interno del suo punto di vista. Egli sperimenta soltanto su
se stesso ciò che per lui, e per molti dotti, è un vuoto e monotono slogan di partito
della socialdemocrazia, il fatto cioè che esiste una distinzione tra scienza borghese e
scienza proletaria, ed egli stesso ne è un esempio illuminante. Questa distinzione, che
Marx e Engels hanno sottolineato sempre nel modo piú energico possibile, non ha
niente a che vedere con la svalutazione della scienza a livello di lotte tra partiti, come
una critica non immanente è sempre pronta ad affermare con grande enfasi e sdegno
morale. Ma anch’essa è soltanto una differenziazione sociologica, assolutamente
oggettiva, vale a dire, corrisponde alla constatazione dei limiti, che, anche per quanto
riguarda la scienza apparentemente imparziale e apartitica, sono tracciati nella
coscienza del pensatore, a seconda che egli si sia liberato o meno delle barriere della
visione borghese del mondo. Chi pensa nelle categorie del mondo borghese, come se
esse costituissero gli elementi effettuali (Seinselemente) della vita sociale in generale,
deve costruire una ‘scienza’ dei fenomeni della vita sociale completamente diversa da
quella di colui, nel cui modo di pensare la interpretazione di tutte le attuali forme
sociali di vita, in quanto fenomeni puramente storici, è diventata un elemento
imprenscindibile del suo pensare, anzi della sua esperienza vissuta. Questo è ciò cui
pensano molti marxisti, allorché parlano del marxismo nei termini di una concezione
del mondo (Weltauffassung). Nel senso stretto del termine, indubbiamente, esso non
Página 267
è una concezione del mondo, perché, in generale, non è filosofia, ma teoria, sociologia.
Esso non è neppure però — come lo considera Kelsen — una teoria singola, isolata nel
pensiero dei suoi sostenitori, che possa essere compresa interamente strappando via
singoli concetti o proposizioni. Cosí come le conoscenze della moderna scienza della
natura si sono unificate nello spirito di colui che è cresciuto in esse fino a formare una
immagine del mondo; cosí come esse costituiscono la nostra concezione della natura;
allo stesso modo, i pensieri del marxismo compongono per il marxista la sua immagine
sociale del mondo e gli consentono di esperire la storia e la società solo nel quadro di
questa concezione globale. Cosí come è impossibile che un uomo dell’antichità, con la
sua immagine del mondo cosmica, completamente diversa, possa rivolgere una critica
immanente al concetto di natura quale è stato elaborato per la prima volta dalla
moderna scienza della natura — egli dovrebbe infatti porsi al di fuori della sua
costituzione spirituale antica e diventare un uomo moderno — allo stesso modo è
impossibile, alla luce di una concezione globale essenzialmente borghese, criticare in
modo immanente la concezione marxista. E non si dica — cosa che forse Kelsen
obietterà — che una teoria deve essere nondimeno comprensibile a tutti e che con i
princìpi della logica, i quali valgono allo stesso modo per tutti, può essere rivolta contro
tutti una critica ugualmente valida. Certo, la logica del pensiero è uguale per tutti, ma
non cosí la psicologia del pensiero. Se la logica fosse la produttrice della verità, allora
Kelsen avrebbe ragione, ma essa è puramente uno strumento del processo produttivo
della verità e, circa il modo in cui dev’essere applicato questo mezzo, decide la
psicologia della ricerca. È questa a porre al singolo ricercatore i confini per l’uso della
sua logica, i quali non devono affatto contemporaneamente i limiti della logica stessa.
È la psicologia della ricerca, in ultima istanza, a tracciare non solo i limiti della logica
personale del ricercatore, ma ad agire già prima nella scelta dei problemi da trattare.
Che, ad esempio, un ricercatore come Kelsen ritenga già pienamente risolto il
problema del diritto e dello Stato nell’indagine giuridico-formale su entrambi, il fatto
che egli si accontenti di un’ontologia giuridica, la quale da ultimo sfocia in un
positivismo giuridico, che trasforma addirittura in un imperativo di questa tendenza
scientifica il caratterizzare tutte le questioni relative alla trasformazione
dell’ordinamento giuridico concreto, come esterne alla scienza giuridica, come
questioni metagiuridiche, tutto ciò è soltanto una riconferma molto significativa di un
orientamento caratteristico, precedente a ogni ricerca, dal quale, sebbene
naturalmente in modo inconsapevole, scaturisce appunto il pensiero borghese. Il
marxismo chiama
Página 268
scienza borghese un tipo di ricerca e proletaria l’altro tipo, non perché siano proletari e
borghesi coloro che vengono presi in considerazione in quanto portatori della scienza.
Questo, per lo piú, non si verifica affatto, almeno per quanto concerne i proletari, che
non hanno avuto l’opportunità di studiare, e anche i dotti borghesi non sono sempre
dei borghesi. Ancor meno questa distinzione si riferisce al fatto che la ricerca in un
caso viene svolta consapevolmente nell’interesse borghese, nell’altro consapevolmente
nell’interesse del proletariato. Ma questo termine non indica altro che la tendenza della
costituzione spirituale dello scienziato, il fatto, cioè, se essa è tale da esser cresciuta
formalmente insieme con l’ordinamento sociale esistente, per cui non è in grado di
pensare nulla al di fuori delle categorie del medesimo e, giunto ai suoi limiti, il quieto
pensiero logico viene subito staccato dalle manifestazioni d’affetto verso le serie di
concetti che conducono al di là di esso, oppure il fatto se appartiene alla sua coscienza
scientifica stessa questa capacità di pensare al di là della parzialità storica del presente
e del passato. E soltanto perché il proletariato appare come portatore sociale di una
condizione della vita sociale richiesta da questa capacità di pensare al di là
(Hinausdenken), e soltanto perché questo proletariato, d’altra parte, è determinato
nella direzione del pensare al di là dalla sua situazione sociale, solo a causa di questa
coincidenza, sociologicamente data, del pensare al di là e dell’andare al di là della
società presente, solo a causa di questa coincidenza nel proletariato Marx e Engels
definivano questo modo di pensare come il modo di pensare proletario e la scienza da
esso guidata scienza proletaria. Sarebbe stato meglio indicare quest’opposizione come
un’opposizione fra scienza stazionaria e evolutiva. L’altra definizione, però, perlomeno
ha il vantaggio di far emergere insieme anche la determinazione sociale di queste
forme diverse della scienza e, quindi, di richiamare l’attenzione sul fatto che, in questo
caso, non si tratta di una suddivisione logica delle scienze, bensí di una distinzione
storica, di psicologia sociale, fra l’una e l’altra scienza [Nota 1].
Cosí, anche nelle controversie di questo libro, in fondo, erano i grandi contrasti
esistenti tra la concezione sociale borghese e quella proletaria a guidare
preliminarmente l’interesse teorico, anzi, a determinare addirittura i limiti della sua
estensione. Ma, proprio ciò ha condotto il confronto con le acute opinioni critiche del
nostro autore a un risultato che ha oltrepassato di gran lunga l’intenzione della sua
critica. Poiché non solo ci ha convinto — conPágina 269
ducendoci necessariamente dalla frammentarietà di singoli problemi alla concezione
complessiva del marxismo — della compattezza interna di questa teoria, ma ha reso
chiaro, sulla base di un eccellente esempio, che si può bensí essere di un’opinione
diversa da quella del marxismo, ma che però questo non basta ancora per confutarlo.