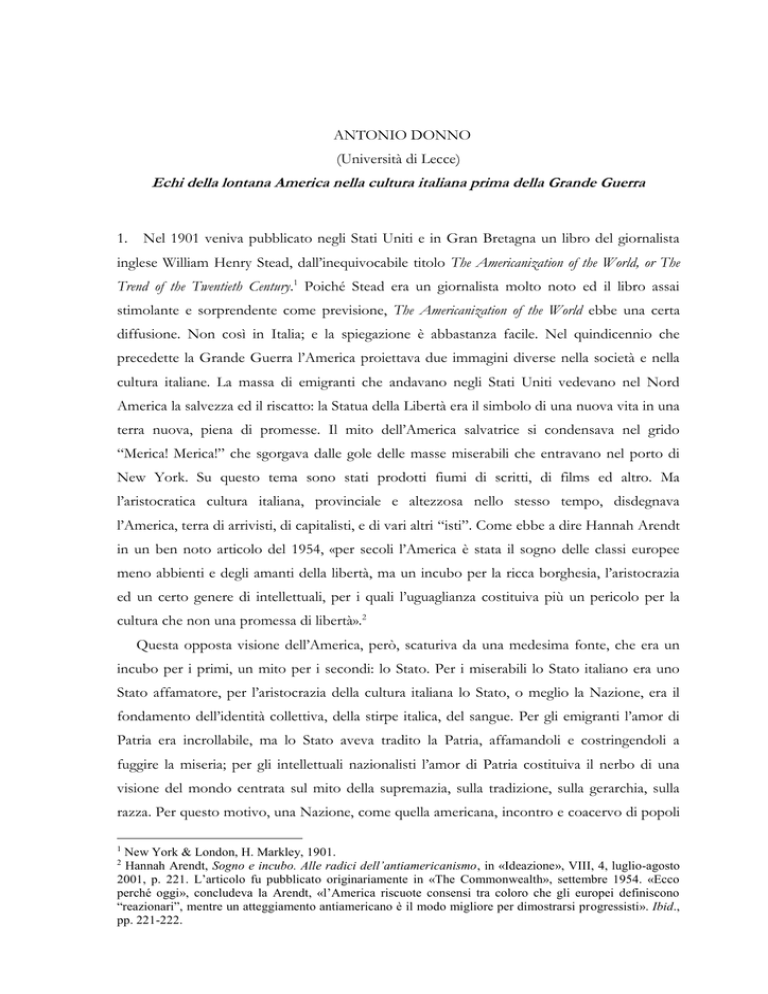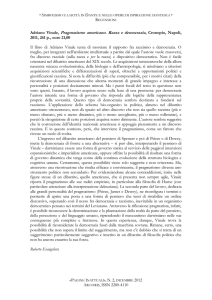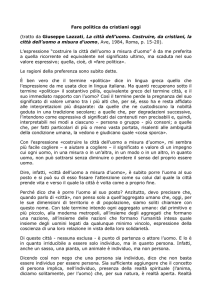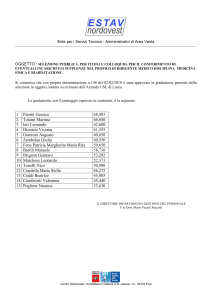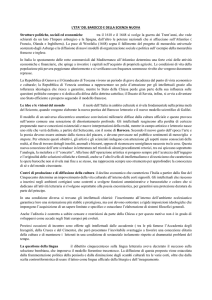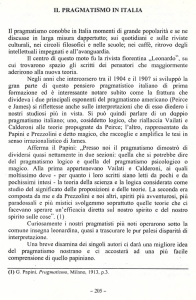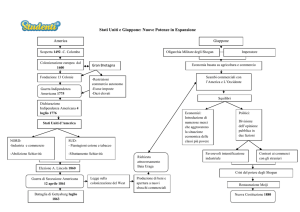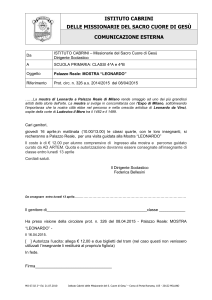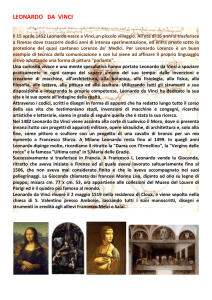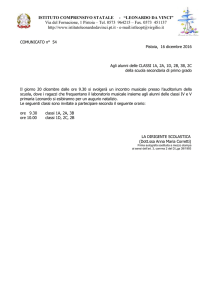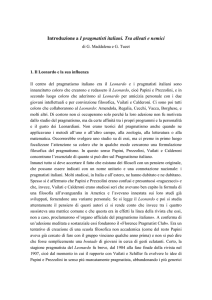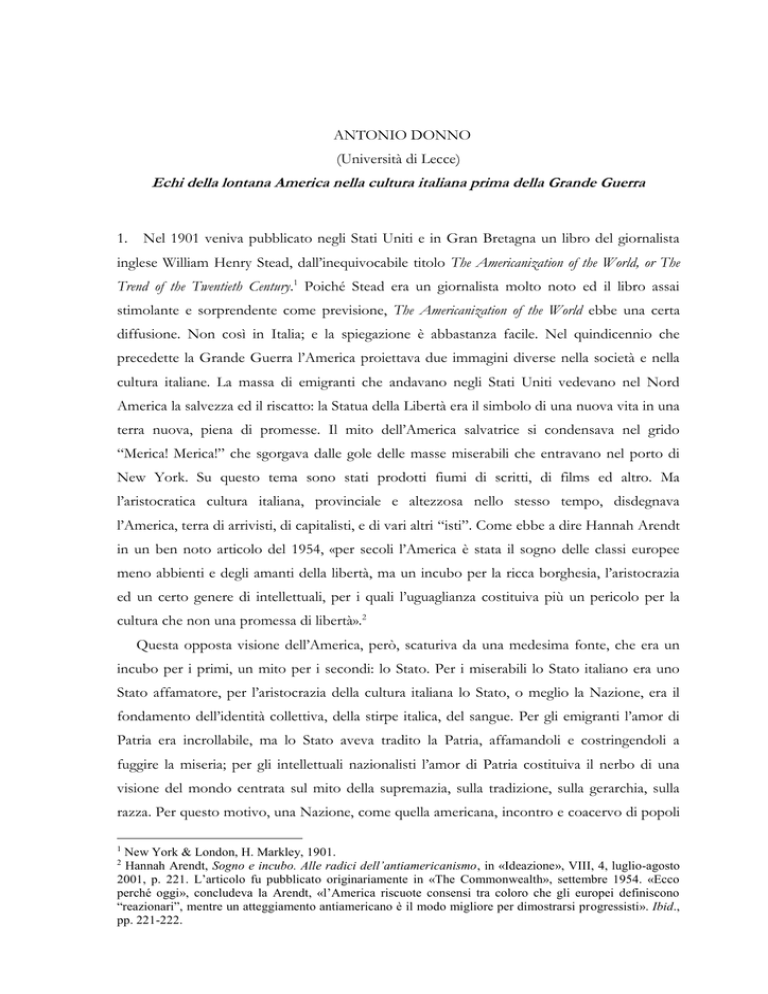
ANTONIO DONNO
(Università di Lecce)
Echi della lontana America nella cultura italiana prima della Grande Guerra
1.
Nel 1901 veniva pubblicato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna un libro del giornalista
inglese William Henry Stead, dall’inequivocabile titolo The Americanization of the World, or The
Trend of the Twentieth Century.1 Poiché Stead era un giornalista molto noto ed il libro assai
stimolante e sorprendente come previsione, The Americanization of the World ebbe una certa
diffusione. Non così in Italia; e la spiegazione è abbastanza facile. Nel quindicennio che
precedette la Grande Guerra l’America proiettava due immagini diverse nella società e nella
cultura italiane. La massa di emigranti che andavano negli Stati Uniti vedevano nel Nord
America la salvezza ed il riscatto: la Statua della Libertà era il simbolo di una nuova vita in una
terra nuova, piena di promesse. Il mito dell’America salvatrice si condensava nel grido
“Merica! Merica!” che sgorgava dalle gole delle masse miserabili che entravano nel porto di
New York. Su questo tema sono stati prodotti fiumi di scritti, di films ed altro. Ma
l’aristocratica cultura italiana, provinciale e altezzosa nello stesso tempo, disdegnava
l’America, terra di arrivisti, di capitalisti, e di vari altri “isti”. Come ebbe a dire Hannah Arendt
in un ben noto articolo del 1954, «per secoli l’America è stata il sogno delle classi europee
meno abbienti e degli amanti della libertà, ma un incubo per la ricca borghesia, l’aristocrazia
ed un certo genere di intellettuali, per i quali l’uguaglianza costituiva più un pericolo per la
cultura che non una promessa di libertà».2
Questa opposta visione dell’America, però, scaturiva da una medesima fonte, che era un
incubo per i primi, un mito per i secondi: lo Stato. Per i miserabili lo Stato italiano era uno
Stato affamatore, per l’aristocrazia della cultura italiana lo Stato, o meglio la Nazione, era il
fondamento dell’identità collettiva, della stirpe italica, del sangue. Per gli emigranti l’amor di
Patria era incrollabile, ma lo Stato aveva tradito la Patria, affamandoli e costringendoli a
fuggire la miseria; per gli intellettuali nazionalisti l’amor di Patria costituiva il nerbo di una
visione del mondo centrata sul mito della supremazia, sulla tradizione, sulla gerarchia, sulla
razza. Per questo motivo, una Nazione, come quella americana, incontro e coacervo di popoli
1
New York & London, H. Markley, 1901.
Hannah Arendt, Sogno e incubo. Alle radici dell’antiamericanismo, in «Ideazione», VIII, 4, luglio-agosto
2001, p. 221. L’articolo fu pubblicato originariamente in «The Commonwealth», settembre 1954. «Ecco
perché oggi», concludeva la Arendt, «l’America riscuote consensi tra coloro che gli europei definiscono
“reazionari”, mentre un atteggiamento antiamericano è il modo migliore per dimostrarsi progressisti». Ibid.,
pp. 221-222.
2
2
e culture, era disprezzata. Lo stesso Prezzolini, sbarcato negli Stati Uniti nel 1923, iniziò ad
inviare le sue corrispondenze da New York per «Il Tempo» nel 1945; nonostante i venti anni
di soggiorno negli Stati Uniti, Prezzolini non si sottrasse all’obbligo tutto europeo di scrivere i
primi articoli sul perché l’America non capisse l’Europa, sul perché tutto lì si valutasse in
dollari, sul perché gli americani fossero ignoranti di politica internazionale (lasciando
intendere che gli europei fossero molto più edotti in materia), ed altri consimili stereotipi.3 Gli
americani, diceva Prezzolini, sono ricchi perché vogliono essere ricchi, perché ci pensano
continuamente, a differenza, per esempio, del popolo messicano, che non penserebbe,
secondo Prezzolini, alla ricchezza.4
Questi stereotipi erano ancor più radicati, come è ovvio, nei primi anni del secolo; ed anzi,
lo erano per la sostanziale, diffusa ignoranza di che cosa fosse l’America. Era un’ignoranza
oggettiva ma anche voluta. Gli Stati Uniti non erano considerati perché la loro ricchezza
generava invidia; e la mancanza di capacità nel raggiungere la ricchezza causava frustrazione e
senso di impotenza. La reazione a questo stato di cose, materiale e psicologico, era il rifiuto, il
rifugio nella presunta “superiorità” europea in fatto di saggezza, cultura, equilibrio. Una
vecchia storia, attuale ancor oggi. Diceva la Arendt: «I ricchi hanno sempre avuto la sfortuna
di essere alternativamente adulati ed ingiuriati, rimanendo comunque impopolari a
prescindere dalla loro generosità».5
Se questo è il quadro generale, non sarebbe giusto, tuttavia, ignorare le aperture verso ciò
che proveniva dall’America. Spesso queste aperture si verificavano senza citare esplicitamente
il paese nord-americano, per motivi che impegnerebbero un’analisi di diversa natura dalla
presente, ma nondimeno sprazzi d’America cominciarono ad apparire nella cultura italiana del
tempo. Certo, nessuno degli intellettuali italiani di quel tempo ebbe la capacità di capire la
futura realtà del XX secolo come Stead: non ne avevano la libertà intellettuale e gli strumenti
culturali, e forse prevedere il XX secolo come “secolo americano” sarebbe stato inaccettabile
per una cultura autoreferenziale come quella italiana.
Tuttavia, come detto, qualcosa
cominciò a muoversi. Gli intellettuali di «Leonardo» (1903-1907), nei primi anni del secolo,
posero grande attenzione ad una corrente filosofica, il pragmatismo, non solo per ragioni
squisitamente culturali, ma perché il pragmatismo poneva delle problematiche ed un metodo
di interpretazione della realtà che erano giudicati assai utili per svecchiare la cultura italiana e
Solo a mo’ d’esempio: Errori organici dell’America, Perché l’America non capisce l’Europa, In America
gli uomini si valutano in dollari, ora in Giuseppe Prezzolini, America in pantofole, Firenze, Vallecchi, 2002
(I ed., 1950).
4
Cfr. Prezzolini, Perché l’America è ricca?, in America in pantofole, cit., pp. 57-59.
3
3
per contribuire ad un’analisi più efficace dei problemi della società italiana del tempo. 6 I
redattori di «Leonardo» (Giovanni Papini, lo stesso Prezzolini, Adolfo de Karolis, Giuseppe
A. Borgese, Giovanni Vailati, Mario Calderoni, Giovanni Amendola, ed altri) si gettarono a
capofitto nella diffusione della filosofia pragmatista di provenienza americana, dedicandovi
numerosi articoli, organizzando convegni, favorendo la traduzione delle più importanti opere
di Charles Sanders Peirce e di William James, fondando associazioni per la diffusione del
pragmatismo. Vailati intrattenne rapporti con la «Rivista di psicologia» fondata nel 1905 da
Giulio Cesare Ferrari, il quale, nel 1901, aveva tradotto in italiano i Principi di psicologia di
William James. Prezzolini ebbe un atteggiamento inizialmente sospettoso, tanto che giudicò il
pragmatismo «[…] una filosofia ignota come sono le pullulanti sètte protestanti di America
[…]».7 Nonostante il giudizio di Prezzolini, il «Leonardo» ebbe l’indubbio merito di essere il
portavoce italiano della filosofia americana.
Che cosa vedevano i leonardiani nel pragmatismo americano? Calderoni sosteneva che
esso rappresentava un’iniezione di buon senso nella filosofia professionale dei filosofi europei. Il
filosofo di professione era un retaggio del passato: occorreva una capacità di sperimentazione
da cui soltanto potevano scaturire idee chiare «[…] nella soluzione delle questioni, ma anche nella
scelta delle questioni da trattarsi; a versare nelle parole, che sono l’oggetto delle nostre
controversie, il loro contenuto pratico e sperimentale allo scopo di evitare confusioni e
sofismi».8 In questo senso, la rivista si dichiarava contro la filosofia pura, contro l’analisi
astratta avulsa dal terreno delle problematiche umane da risolvere. Essa suggeriva il seguente
metodo: «[…] Dati certi fini vi consiglio di adoprare certi mezzi piuttosto che certi altri».9 Le
implicazioni di questa premessa erano evidenti. Al di là delle ingenue semplificazioni sulla
funzione della filosofia, gli intellettuali di «Leonardo» si ponevano in rottura con la tradizione
filosofica italiana; e lo facevano attingendo ad una filosofia americana che a loro pareva
innovativa, forse rivoluzionaria rispetto alla tradizione europea.
Qui il tema della rivoluzione è centrale, non solo per «Leonardo» ma per la gran parte
dell’intellettualità italiana dei primi del secolo. I giovani intellettuali che facevano capo a
«Leonardo», «Lacerba», «Hermes», «Il Regno», «La Voce», ed altre riviste, si dichiaravano, chi
5
Arendt, Sogno e incubo, cit., p. 221.
Sulla breve vicenda di «Leonardo» cfr. Paolo Casini, Alle origini del Novecento. «Leonardo», 1903-1907,
Bologna, Il Mulino, 2002.
7
Giuliano Il Sofista [Giuseppe Prezzolini], Le varietà del pragmatismo (Risposta a Mario Calderoni), in
«Leonardo», II, 3, novembre 1904, seconda serie, p. 8.
8
Mario Calderoni, Le varietà del pragmatismo, in «Leonardo», II, 3, novembre 1904, seconda serie, p. 5 (il
corsivo è nel testo).
6
4
più chi meno, rivoluzionari, ma era difficile individuare lo sbocco della loro rivoluzione. Per la
gran parte di loro rivoluzione era innovazione, rottura, anticonformismo. Nel caso di
«Leonardo» il pragmatismo di provenienza americana era l’arma per combattere l’idealismo, lo
spiritualismo, l’hegelismo, il positivismo, e in politica il socialismo, la democrazia; e poi ancora
il cristianesimo e il concetto stesso di eguaglianza che vi è sotteso: ciò che questi giovani
intellettuali definivano spregiativamente l’armamentario del vecchio secolo. Nell’articolo di
presentazione di «Leonardo», L’ideale imperialista, Papini scriveva: «Chiamo imperialismo quella
corrente, varia di forme e di nomi, quasi omogenea di significato, che si contrappone nel
pensiero e nella vita di questi giorni, alla corrente democratica, socialista, umanitaria, cristiana
o cristianeggiante».10
Che cosa c’entri tutto questo con il pragmatismo americano, è arduo valutare. In realtà, il
vitalismo dei giovani intellettuali d’inizio secolo vedeva nel pragmatismo una filosofia
dell’azione, il che, come è noto, non era. E dell’America, da cui essi importavano la filosofia
pragmatista, ignoravano proprio il fondamento: la democrazia, che essi detestavano sopra
ogni altra cosa, e il liberalismo, parola che quasi non esisteva nel loro vocabolario. È per
questo motivo che essi parlavano (e spesso straparlavano) di pragmatismo, senza mai citare
l’America: l’America era il contrario del loro elitismo antidemocratico. Inoltre,
l’individualismo dei giovani intellettuali italiani del tempo aveva poco a che vedere con
l’individualismo americano di matrice liberale. Per loro, l’individualismo era un concetto
avulso dalla realtà, era una sorta di superomismo che prescindeva dalla naturale competizione
tra gli uomini che è l’anima del liberalismo americano. Essi rifiutavano il mercato, la
concorrenza, l’industrialismo, la tecnica: cioè, le basi stesse del mondo moderno, che poi era e
sarà l’America in carne ed ossa.11 Per Prezzolini, il pragmatismo era un metodo per potenziare
la creatività spirituale dell’individuo: un concetto piuttosto vago, alquanto romantico, di quella
filosofia.12 In definitiva, il pragmatismo in Italia finì per divenire, nelle pagine delle riviste
fiorentine di quegli anni, qualcosa che non aveva nulla a che fare con l’America, piegato a
sostenere il velleitarismo antimoderno, anarcoide, antidemocratico degli intellettuali ribelli del
9
The Florence Pragmatist Club (Giovanni Papini), Il pragmatismo messo in ordine, in «Leonardo», III, 2,
aprile 1905, seconda serie, p. 47.
10
Gian Falco (Giovanni Papini), L’ideale imperialista, in «Leonardo», I, 1, 4 gennaio 1903, p. 1.
11
Cfr. Oscar Ewald, Il Romaticismo e il presente, in «Leonardo», IV, 4, ottobre-dicembre 1905, terza serie,
pp. 257-269.
12
Cfr. Giuliano Il Sofista, Pragmatismo e occultismo, in «Leonardo», IV, 4, ottobre-dicembre 1905, terza
serie, pp. 354-356.
5
tempo;13 e lo stesso William James l’apostolo di una visione del mondo che era ben lontana
dai suoi pensieri.14
In sostanza, il “New Thought” americano, di cui i leonardiani si erano invaghiti, si riduceva
in parole altisonanti come ottimismo, infinita “trasformabilità” dell’esistenza grazie alla will to
believe, potere assoluto della coscienza individuale, possibilità di «[…] acquistare […] delle facoltà
completamente nuove, di divenire esseri completamente diversi dagli uomini ordinari».15 Il pragmatismo
americano veniva totalmente sradicato dal tessuto culturale in cui era nato e si era sviluppato:
la democrazia liberale americana. Anzi, era trasformato nel suo opposto: una filosofia
nietzscheana in cui il superuomo prendeva il posto del cittadino. È grottesco considerare
come il “secolo americano”, che è stato il secolo dell’“uomo comune”, sia divenuto, grazie
all’uso distorto di una corrente culturale tipicamente americana, una filosofia dell’“uomo
eroico” nelle concezioni degli intellettuali italiani d’inizio secolo. Nelle parole di presentazione
del pragmatismo, tuttavia, non si rinunciava all’esposizione compiaciuta dei noti stereotipi
sull’America: «Nell’America yankee, che siamo soliti a considerare come la sede del più
sfrenato industrialismo e del più rabbioso arrivismo, che citiamo solo per i suoi sky-scrapers a
venti piani, i suoi trusts, la sua Tammany Hall, è sorto un vasto movimento intellettuale, rivolto
esclusivamente allo studio pratico dei più importanti problemi dello spirito».16 Il messaggio
poteva essere il seguente: estrapolato dal rozzo e volgare contesto americano, da cui pur
proviene, il pragmatismo può estrinsecare tutte le sue potenzialità in favore dell’uomo solo in
un nuovo contesto culturalmente ricco, sofisticato e di profonda tradizione intellettuale come
quello europeo e produrre risultati straordinari altrimenti impossibili nella materialista e
prosaica America.
2.
Che questa fosse l’aspirazione dei giovani intellettuali italiani d’inizio secolo è evidente
nell’articolo di presentazione della rivista «Hermes»: «Del resto noi rinunceremmo volentieri
all’ambiguità della parola aristocratica, se fossero molti anzi che pochi a comprendere quando
un poeta sia riuscito ad esprimere e quando sia fallito. […] Dovremmo chiamarci pagani perché
prediligiamo i forti sentimenti le virtù eroiche e l’intensità della vita? Esteta, pagano, superuomo e
Papini asseriva che il pragmatismo era un metodo di indagine che poteva produrre «[…] delle vedute
suggestive che incoraggiano a immaginare e a sperare cose straordinarie». Giovanni Papini, Introduzione al
pragmatismo, in «Leonardo», V, 1, febbraio 1907, terza serie, p. 36.
14
Basti leggere di William James Le energie degli uomini, in «Leonardo», V, 1, febbraio 1907, terza serie,
pp. 1-25, per comprendere la differenza tra il pensiero dell’americano e quello dei nostri intellettuali.
15
Roberto Grego Assagioli, Il “Nuovo Pensiero” americano. Il “New Thought”, in «Leonardo», V, 2,
aprile-giugno 1907, terza serie, p. 206. Il corsivo è nel testo.
16
Ibid., p. 201.
13
6
così via sono vocaboli che chiamerei meretricii: concedono a tutti i flosci fianchi. E, se la
significazione di pagano verrà così limitata, ci chiamino pure pagani».17 Prezzolini, nel
presentare il coevo «Il Regno», compì, invece, una radicale revisione rispetto agli
sdilinquimenti di «Hermes». Secondo lo scrittore toscano, la nuova rivista «sarebbe un
giornale fuori di posto in Inghilterra o in America, dove le borghesie non hanno ancora le
midolla così rammollite da fornire d’armi i loro svaligiatori futuri».18 L’affermazione di
Prezzolini rappresentava una svolta rispetto all’aristocraticismo delle posizioni culturali
precedenti. Negli articoli de «Il Regno», ma più ancora di «Lacerba» e de «La Voce», il ruolo
della borghesia acquisterà un nuovo significato, la civiltà industriale verrà rivalutata ed
appariranno per la prima volta i termini “liberismo” e “liberalismo”. Non bisogna, tuttavia,
credere che Prezzolini, e molti con lui, avessero ripreso a stimare i principi della democrazia
parlamentare. Nel rivalutare il ruolo della borghesia, Prezzolini non faceva mistero della sua
speranza segreta: «È mancato finora un esempio e una voce: cioè un uomo».19
Quest’ambiguità di fondo non verrà mai meno. Come si vedrà, dall’America i giovani
intellettuali italiani del tempo mutueranno, con il passar degli anni, molti dei principi
dell’economia capitalistica, il loro avvicinamento alla modernità americana si farà sempre più
convinto, il loro elitismo aristocratico ed eroico cederà il passo ad una più borghese
considerazione della realtà. Ma la democrazia sarà sempre per loro un concetto oscuro, spesso
minaccioso; e perciò, la democrazia americana resterà sempre il regno della plebe, dell’“uomo
comune”, cioè dell’anti-Uomo. Se, da una parte, si apprezzava lo sforzo dell’America «[…] di
raggiungere presto una civiltà industriale, più progressiva e stimolante […]», dall’altra si
esaltavano gli insegnamenti di Vilfredo Pareto e «la dottrina del liberismo [che] è una dottrina
essenzialmente individualistica e come tale più conforme agli ideali della rivista». 20 Il problema
di fondo era che cosa quegli intellettuali intendessero per individualismo e quale fosse il
rapporto di quest’ultimo con la democrazia. Fu Enrico Corradini a svelare l’equivoco della
sua, come di molti altri, concezione della libertà. In occasione della guerra russo-giapponese, a
New York furono organizzate gite per osservare da vicino il teatro della guerra. Così
commentò il fatto Corradini: «In questo realismo dell’affare e della crudeltà umana che ricerca
un circo di spettacolo straordinariamente più vasto e terribile di quelli romani […] sta un
Prefazione, in «Hermes», I, 1904, ora in La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste. Vol. I:
«Leonardo», «Hermes», «Il Regno», a cura di Delia Frigessi, Torino, Einaudi, 1960, pp. 370-371.
18
Giuseppe Prezzolini, La Borghesia può risorgere?, in «Il Regno», I, 7, 1904, ora in La cultura italiana,
vol. I, cit., p. 469. Si tratta della risposta di Prezzolini ad una lettera di Vilfredo Pareto.
19
Ibid., p. 470.
17
7
segno della modernità spregiudicata, liberata da ogni sorta di scrupoli e di civili ipocrisie,
sincera e pratica».21 Corradini, in effetti, non si discostava dai precedenti giudizi sull’America –
un paese rozzo, volgare, cinico, affaristico – ma coglieva in tutto ciò i tratti di una possibile
rigenerazione dell’Europa nel segno della virilità, della forza, della guerra. In sostanza, egli
estrapolava le pulsioni dell’opinione pubblica americana dal loro naturale contesto, la libertà,
in virtù della quale ogni cittadino americano poteva o non poteva partecipare alle gite
organizzate sul teatro della guerra, a seconda delle sue preferenze, i suoi principi morali, i suoi
interessi, le sue disponibilità finanziarie, e si potrebbe andare avanti all’infinito. Al contrario,
per Corradini, dall’America proveniva un impulso generale e totalizzante: «Tutte le quali cose
per concludere significano che i sentimentalisti, gli umanitaristi, gli evangelisti dell’amore e
della pace, i dottrinari delle classi e delle culture cosmopolite, sono addirittura contrari allo
spirito del nostro tempo […]».22 L’Europa, dunque, doveva rigenerarsi inserendosi nello
spirito del tempo, uno spirito spregiudicato, talvolta crudele, ma virile, guerresco: qualità, a
detta di Corradini, che provenivano dalla giovane, orgogliosa America. Corradini non sapeva
nulla dell’America, ne coglieva grossolanamente solo gli aspetti superficiali utili al suo
discorso; non sapeva che il liberalismo americano era qualcosa di ben diverso dal suo
nazionalismo; o meglio, che il nazionalismo americano si radicava nei principi liberali, non
nelle visioni eroiche di una stirpe, quella italica, che invocava il suo “posto al sole”.
Ma, a parte le posizioni di Corradini, l’influenza di Pareto ebbe un certo ruolo nel riorientare molte delle precedenti idee di Prezzolini e compagni. In particolare, Prezzolini
cominciò ad apprezzare e sostenere una visione anti-statalista e liberista in linea con la
tradizione politica ed economica americana. Affermava: «Lo stato […] non è la parte vitale
della nazione; la parte vitale è la gente che produce, che smercia, che vince». 23 Pareto era
ancora più drastico nel giudizio. Attaccando i socialisti e tutti coloro che sostenevano il ruolo
dello Stato come panacea per i mali della società, egli rivendicava il ruolo essenziale dei
produttori, ridicolizzando tutti coloro che ritenevano che «[…] i beni economici spunta[ssero]
come funghi, che i tordi cad[essero] arrosto dal cielo, che basta[sse] fare una buona legge sulla
protezione degli operai, od altra simile, per fare godere le genti di tutto quel bene d’Iddio».24 In
sostanza, «Il Regno» ebbe una funzione di rottura rispetto alle tradizionali concezioni dei
20
Mario Calderoni, Nazionalismo antiprotezionista?, in «Il Regno», I, 8, 1904, ora in La cultura italiana,
vol. I, cit., p. 475.
21
Enrico Corradini, La guerra, in «Il Regno», I, 14, 1904, ora in La cultura italiana, vol. I, cit., p. 485.
22
Ibid.
23
Giuseppe Prezzolini, Le due Italie, in «Il Regno», I, 26, 1904, ora in La cultura italiana, vol. I, cit., p. 501.
8
giovani intellettuali italiani d’inizio secolo: l’esasperato nazionalismo ed aristocraticismo si
stemperò in una valutazione più prosaica ma effettiva della realtà, dove all’odiata borghesia,
prima giudicata mollacciona ed anti-nazionalista, venne riattribuito il suo ruolo storico di
motore del progresso capitalistico. In questo senso, l’influenza del modello americano parve
essere importante, tanto che Mario Calderoni, interpretando il pensiero dei suoi sodali e con
l’entusiasmo tipico dei neofiti, affermò senza mezzi termini che «capitalismo e borghesia sono
[…] fenomeni eterni della società umana […]».25
Ma era sincera questa “nuova” posizione? O sopravviveva una radicata concezione antidemocratica al fondo delle revisioni cui si è fatto cenno? Nel momento di chiudere, «Il
Regno» riaffermava la sua convinzione che il parlamentarismo fosse «bastardo e degenere»;26 e
nel secondo numero di «Lacerba», la prima pagina conteneva una serie di aforismi di Karl
Kraus, tra cui spiccava il seguente: «Il parlamentarismo è l’accasermamento della prostituzione
politica».27 Siamo, come si vede, all’opposto dei principi della democrazia americana. In realtà,
non v’era alcuna nuova posizione. I giovani intellettuali italiani d’inizio secolo, facenti capo
prevalentemente alle riviste fiorentine, erano ideologicamente avversari irriducibili della
democrazia parlamentare, semplicemente perché essi detestavano il volgo. Il loro
nazionalismo era un nazionalismo senza popolo, perché aborrivano il popolo; e verso la stessa
borghesia nutrivano un sentimento ambiguo ma, nella sostanza, di spregio. Ne «La Voce» si
incontrano qua e là eccellenti articoli in cui i principi dell’economia liberista di matrice
americana sono evidenti, come nel caso dello scritto di Luigi Einaudi sull’emigrazione
meridionale in America e sulla nuova mentalità che molti meridionali acquisivano oltreoceano
e che intendevano, e spesso riuscivano, a diffondere nel Sud dopo il loro ritorno;28 o anche
nel caso, in verità assai meno importante, di un articolo di Prezzolini sul liberismo, esempio
della camaleontica personalità del toscano, sempre pronto ad abbracciare nuove idee e
correnti, ma in modo alquanto superficiale.29 Ne fu prova la risposta che egli dette ad Einaudi,
autore di un’equilibrata lettera di valutazione della politica di Wilson, in cui Prezzolini non
andava al di là di alcune pungenti battute che dimostravano la sua sostanziale estraneità
24
Vilfredo Pareto, Umanitari e rivoluzionari, in «Il Regno», I, 49, 1904, ora in La cultura italiana, vol. I,
cit., p. 523.
25
Mario Calderoni, La necessità del capitale, in «Il Regno», II, 2, 1905, ora in La cultura italiana, vol. I,
cit., p. 537.
26
La Rivista, Agonia politica, in «Il Regno», II, 14, 1905, ora in La cultura italiana, vol. I, cit., p. 541.
27
Karl Kraus, Aforismi, in «Lacerba», I, 2, 15 gennaio 1913, p. 1.
28
Cfr. Luigi Einaudi, Le speranze del Mezzogiorno, in «La Voce», III, 11, 1911, ora in La cultura italiana,
cit., vol. II: «La Voce» (1908-1914), a cura di Angelo Romanò, pp. 316-324.
29
Cfr. Giuseppe Prezzolini, Il liberismo come azione morale, in «La Voce», V, 27, 1913, ora in La cultura
italiana, cit., vol. II, pp. 554-558.
9
rispetto alla figura ed all’opera del presidente americano, ma alla politica americana in
generale.30
Con l’ingresso roboante del futurismo sulla scena letteraria italiana furono più evidenti i
debiti verso la cultura americana. Walt Whitman, con le sue innovative intuizioni ed il suo
linguaggio del tutto fuori dai canoni tradizionali della poesia, fu uno degli ispiratori della
letteratura futurista.31 Il suo cantare l’America della modernità dette alla poesia futurista uno
slancio ed una convinzione che provenivano dal centro mondiale del moderno. I futuristi
cantavano la necessità della rivoluzione in ogni aspetto della vita individuale e sociale 32 e forse
l’America fu per loro un esempio interessante: «Nausea della linea curva, della spirale e del
tourniquet. Amore della retta e del tunnel. Abitudine delle visioni in scorcio e delle sintesi
visuali create dalla velocità dei treni e degli automobili che guardano dall’alto città e
campagne. Orrore della lentezza, delle minuzie, delle analisi e delle spiegazioni prolisse.
Amore della velocità, dell’abbreviazione, e del riassunto. “Raccontami tutto, presto, in due
parole!”».33 Qui è l’America. Ma anche in questa concisa esposizione dei principi della pittura
futurista: «Le nostre tele esprimeranno quindi anche le equivalenze plastiche dei suoni, dei
rumori e degli odori del Teatro, del Music-Hall, del cinematografo, del postribolo, delle
stazioni ferroviarie, dei porti, dei garages, delle cliniche, delle officine, ecc. ecc.».34
Ma nulla dei principi della democrazia americana fece breccia negli intellettuali delle riviste
fiorentine d’inizio secolo. La democrazia era il loro nemico numero uno. I principi liberali
erano considerati la morte della Nazione. «La democrazia», sosteneva con enfasi Papini, «[…]
non è che un paravento ideologico-parlamentare per ricoprire gli affari dei veri poteri –
soprattutto del Denaro che su tutti gli altri primeggia».35 Gli Stati Uniti erano il regno del
Denaro, il Suffragio Universale la mistificazione del vero potere, quello – appunto – del
Denaro. L’America, per concludere, restava un mondo sconosciuto, persino minaccioso.
30
Cfr. Apologia di Wilson, in «La Voce», VI, 21, 13 novembre 1914, pp. 34-44. Sotto questo titolo sono
unite la lettera di Einaudi e la risposta di Prezzolini. In questo caso cito dall’edizione anastatica edita da
Forni.
31
Cfr. Raffaele de Grada, Introduzione a Lacerba, Milano, Mazzotta, 1970, s.i.p.
32
Giovanni Papini, La necessità della rivoluzione, in «Lacerba», I, 8, 15 aprile 1913, pp. 73-77.
33
Filippo T. Marinetti, L’immaginazione senza fili e le parole in libertà, in «Lacerba», I, 12, 15 giugno
1913, p. 122.
34
Carlo Carrà, La pittura dei suoni, rumori, odori. Manifesto futurista, in «Lacerba», I, 17, 1° settembre
1913, p. 186.
35
Giovanni Papini, Freghiamoci della politica, in «Lacerba», I, 19, 1° ottobre 1913, p. 213.