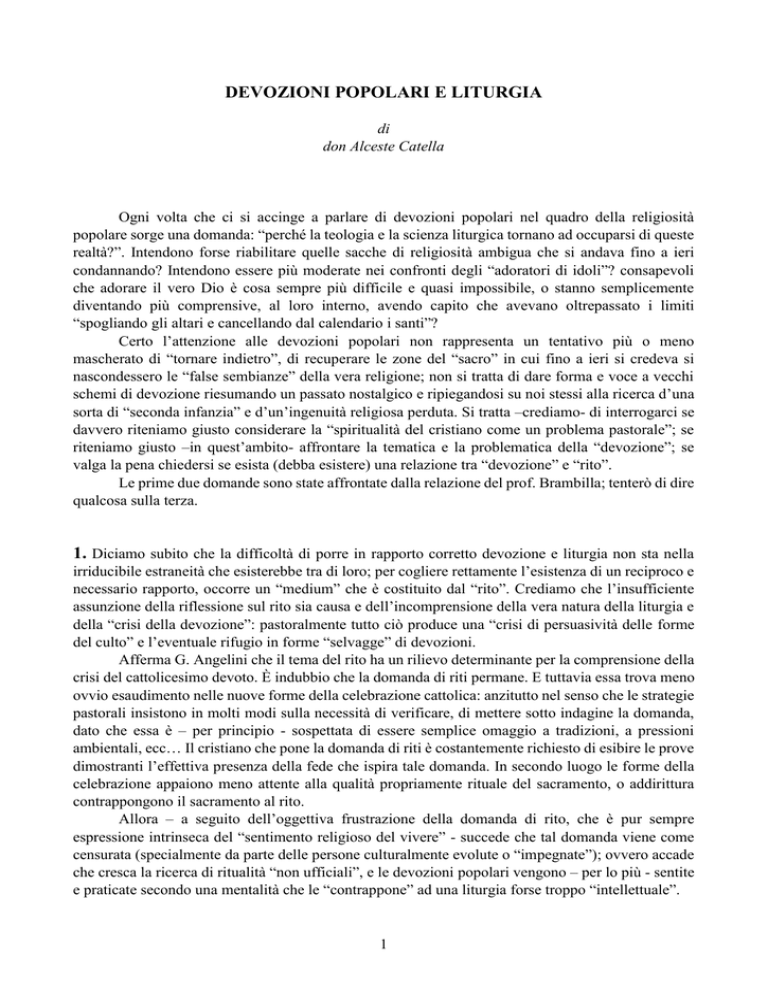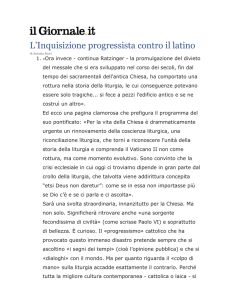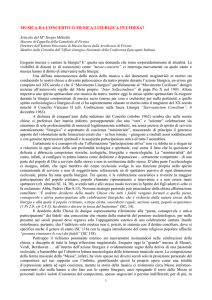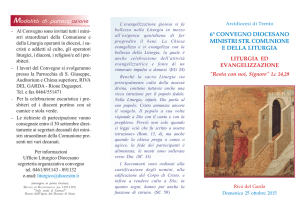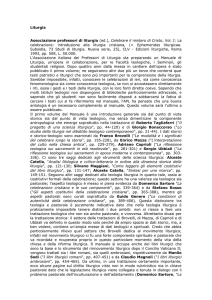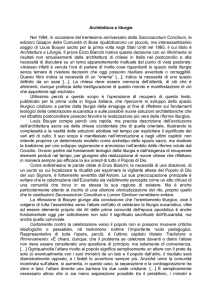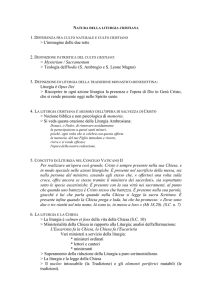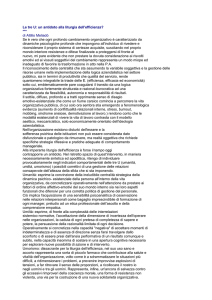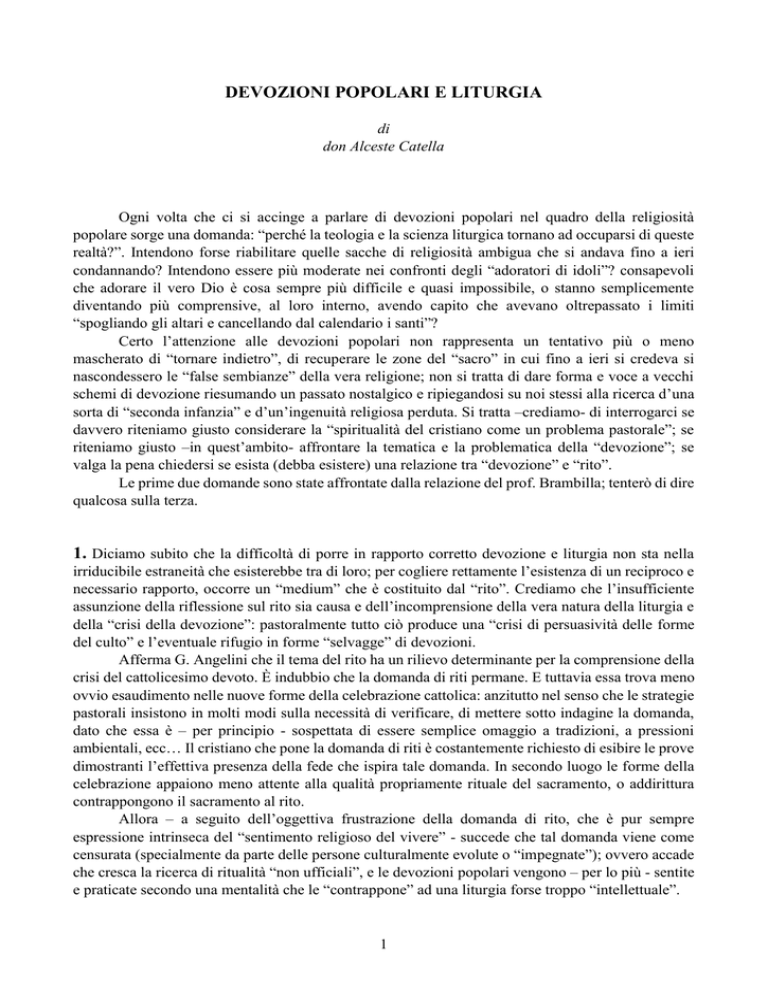
DEVOZIONI POPOLARI E LITURGIA
di
don Alceste Catella
Ogni volta che ci si accinge a parlare di devozioni popolari nel quadro della religiosità
popolare sorge una domanda: “perché la teologia e la scienza liturgica tornano ad occuparsi di queste
realtà?”. Intendono forse riabilitare quelle sacche di religiosità ambigua che si andava fino a ieri
condannando? Intendono essere più moderate nei confronti degli “adoratori di idoli”? consapevoli
che adorare il vero Dio è cosa sempre più difficile e quasi impossibile, o stanno semplicemente
diventando più comprensive, al loro interno, avendo capito che avevano oltrepassato i limiti
“spogliando gli altari e cancellando dal calendario i santi”?
Certo l’attenzione alle devozioni popolari non rappresenta un tentativo più o meno
mascherato di “tornare indietro”, di recuperare le zone del “sacro” in cui fino a ieri si credeva si
nascondessero le “false sembianze” della vera religione; non si tratta di dare forma e voce a vecchi
schemi di devozione riesumando un passato nostalgico e ripiegandosi su noi stessi alla ricerca d’una
sorta di “seconda infanzia” e d’un’ingenuità religiosa perduta. Si tratta –crediamo- di interrogarci se
davvero riteniamo giusto considerare la “spiritualità del cristiano come un problema pastorale”; se
riteniamo giusto –in quest’ambito- affrontare la tematica e la problematica della “devozione”; se
valga la pena chiedersi se esista (debba esistere) una relazione tra “devozione” e “rito”.
Le prime due domande sono state affrontate dalla relazione del prof. Brambilla; tenterò di dire
qualcosa sulla terza.
1. Diciamo subito che la difficoltà di porre in rapporto corretto devozione e liturgia non sta nella
irriducibile estraneità che esisterebbe tra di loro; per cogliere rettamente l’esistenza di un reciproco e
necessario rapporto, occorre un “medium” che è costituito dal “rito”. Crediamo che l’insufficiente
assunzione della riflessione sul rito sia causa e dell’incomprensione della vera natura della liturgia e
della “crisi della devozione”: pastoralmente tutto ciò produce una “crisi di persuasività delle forme
del culto” e l’eventuale rifugio in forme “selvagge” di devozioni.
Afferma G. Angelini che il tema del rito ha un rilievo determinante per la comprensione della
crisi del cattolicesimo devoto. È indubbio che la domanda di riti permane. E tuttavia essa trova meno
ovvio esaudimento nelle nuove forme della celebrazione cattolica: anzitutto nel senso che le strategie
pastorali insistono in molti modi sulla necessità di verificare, di mettere sotto indagine la domanda,
dato che essa è – per principio - sospettata di essere semplice omaggio a tradizioni, a pressioni
ambientali, ecc… Il cristiano che pone la domanda di riti è costantemente richiesto di esibire le prove
dimostranti l’effettiva presenza della fede che ispira tale domanda. In secondo luogo le forme della
celebrazione appaiono meno attente alla qualità propriamente rituale del sacramento, o addirittura
contrappongono il sacramento al rito.
Allora – a seguito dell’oggettiva frustrazione della domanda di rito, che è pur sempre
espressione intrinseca del “sentimento religioso del vivere” - succede che tal domanda viene come
censurata (specialmente da parte delle persone culturalmente evolute o “impegnate”); ovvero accade
che cresca la ricerca di ritualità “non ufficiali”, e le devozioni popolari vengono – per lo più - sentite
e praticate secondo una mentalità che le “contrappone” ad una liturgia forse troppo “intellettuale”.
1
Conclude G. Angelini annotando l’incapacità, o più cautamente la ridotta capacità, della
pastorale diffusa ad intendere e a realizzare il momento rituale della religione e ciò costituisce
proporzionale motivo di minor idoneità della pastorale stessa a plasmare la devozione del cristiano1.
2. Convinti che la “questione della qualità propriamente rituale della liturgia” sia il punto cardine per
una pastoralità capace di armonizzare devozione e liturgia, intendiamo offrire alcuni spunti di
riflessione attorno alla suddetta questione; tenendo – come sullo sfondo - i connotati tipici e distintivi
della devozione popolare, verificabili quasi in ogni sua espressione: la spontaneità, la festività,
l’espressione della povertà radicale dell’uomo e dell’apertura al Trascendente tramite il linguaggio
simbolico, la “memoria” e la condivisione. L’animo “povero”, l’esperienza del vissuto, l’espressività
simbolica (spesso altamente poetica) aprono alla “comunione”.2
La liturgia ha costituito il tema della riforma pastorale sul quale più tempestivo è stato
l’accordo e quindi la deliberazione conciliare; è stata anche l’oggetto della riforma più sicuramente e
tempestivamente realizzata.
Tale constatazione ha di che sorprendere: nel senso che la crisi di evidenza dei segni cristiani
per la coscienza contemporanea sembra colpire in misura peculiare proprio la celebrazione. La più
pervasiva crisi dell’appartenenza ecclesiale trova per lo più esattamente nella cessazione della pratica
dei sacramenti (Eucaristia e Penitenza in specie) il proprio innesco.
Di fatto questo processo di disaffezione nei confronti della liturgia non sembra essere stato
significativamente rimediato dalla riforma liturgica. Nasce spontaneo il dubbio che tale riforma si sia
affidata a criteri insufficienti, che mancano di considerare le matrici più profonde del distacco tra
forme della coscienza diffusa e forme della celebrazione.
I criteri in questione sono stati:
- la lingua moderna;
- la centralità della Parola e quindi l’attenzione per una più abbondante e precisa presenza del
testo biblico nella celebrazione;
- la semplificazione del rito, e cioè l’eliminazione di appesantimenti poco pertinenti introdotti
in secoli di scarsa sensibilità liturgica, e in generale poco plausibili per la moderna sensibilità
secolare.
Sembra invece essere macroscopicamente mancato un momento di carattere creativo, per
quanto riguarda i testi eucologici, per quanto riguarda i gesti rituali, e infine anche per quanto
riguarda le forme musicali. Sembra ancora che sia mancata, a livello più fondamentale, una
consistente riflessione di carattere teorico (teologico) circa il generale significato
antropologico-religioso del rito, e quindi circa lo stesso significato che il rito assume nel quadro della
fede cristiana; riflessione quest’ultima che per sua stessa natura si confonde con quella sui sacramenti
della fede; riflessione contigua a quella circa quelle peculiari “attuazioni della fede in comportamenti
umani” che sono le devozioni popolari.
1
G. ANGELINI, Devozione e secolarizzazione. Per una riformulazione del problema, in La spiritualità del cristiano come
problema pastorale (Quaderni di studi e memorie, 9), Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1991, pp. 53-109.
2
G. AGOSTINO, Pietà popolare, in S. DE FIORES – S. MEO (a cura di), Nuovo Dizionario di Mariologia, Edizioni Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 1986, pp. 1111-1121.
2
Talvolta (o spesso!) tale elusione viene affrettatamente giustificata mediante l’appello al tema
del “culto spirituale”, e cioè di un culto che non verrebbe realizzato nelle forme del rito, ma nelle
forme della vita morale e/o rispettivamente nelle forme della preghiera.
Segno di tale difetto di riflessione sul significato della celebrazione nell’economia della vita
credente sono le strategie compensative di fatto facilmente praticate nell’intento di rimediare
all’obiettivo difetto di evidenza del significato del rito. Esse sembrano per lo più privilegiare il
registro didascalico, e in specie la parafrasi moraleggiante del significato dei riti. Oppure, in
alternativa, vanno nella direzione della spettacolarizzazione del rito, quasi esso potesse imporsi
all’attenzione unicamente attraverso le risorse della seduzione.
La buona qualità della celebrazione cristiana non si misura attraverso gli indici di gradimento
(che comunque sembrano restare piuttosto bassi): la determinazione di un più pertinente criterio esige
che si mostri perché la fede ha bisogno del rito, e di quale rito abbia bisogno.
Pensiamo ad una problematica ricorrente: quella circa la musica nella liturgia (analoga, per
tanti aspetti, a quella del rapporto tra devozioni e liturgia). L’assenza di un pensiero teologico circa
canto e musica non sarebbe da ascriversi prima di tutto all’estraneità reciproca dei due mondi
(canto/musica e teologia) e delle relative competenze. Più a fondo questa estraneità andrebbe
riconosciuta come l’esito macroscopico di un più generale difetto di attenzione ai valori della
ritualità, e ad una globale disattenzione per l’esercizio del simbolico che in essa tipicamente prende
forma3. In realtà, non appena si voglia andare un poco più in là di tanti luoghi comuni, si spalancano
immediatamente ampi spazi di riflessione, che porterebbero facilmente al centro di questioni
tutt’altro che marginali per la coscienza cristiana.
Ma facciamo un passo indietro, e parliamo più in generale della catechesi e dell’educazione
che riguardano l’impegno per formare ad una celebrazione più intensa e vitale. Per “purificare” – si
dice - le devozioni e renderle più “liturgiche”. Ebbene, per essere coinvolti nell’importanza e
nell’intensità della celebrazione, che qualità si debbono avere? Si deve “essere credenti e conoscere il
cristianesimo”. Certo. Si deve essere seriamente intenzionati a “riconoscere l’importanza della
celebrazione e aderirvi con tutto il cuore”. Non c’è dubbio. Ma anche per coloro che si sono dedicati
ad una certa preparazione, che hanno avuto spiegazioni almeno sufficienti “sulla” Messa, “sulla”
Bibbia, “sulla” necessità di impegnarsi nella vita, non è poi così ovvio trovarsi in consonanza con il
ritmo della celebrazione, entrare in risonanza con i suoi contenuti, armonizzare l’esecuzione degli atti
richiesti dal rito con il senso delle cose sapute a suo riguardo? È dunque solo perché non si è studiato
abbastanza? Forse. Per la generalità delle persone esiste certamente un problema di educazione
(ri-educazione) al senso della liturgia sacramentale cristiana. Ma a loro favore sarebbe necessario
porre una buona volta anche la questione di una riabilitazione del rito medesimo: ovvero di un regime
d’esercizio capace di restituirlo al profilo forte della sua funzione simbolica (sovente spontaneamente
rinvenuta nella pratica devota).
3. Che cosa pare emergere dal cammino della recezione della Costituzione conciliare Sacrosanctum
Concilium esattamente a proposito dell’istanza sopra espressa? Vorremmo illustrarlo con l’ausilio di
due citazioni.
La prima è di uno studioso che appartiene alla generazione di chi non ha vissuto il periodo
pre-conciliare, e si è trovato a vivere e a riflettere nel post-Concilio: “La riforma liturgica ha
riguardato innanzi tutto le lingue, la teologia e la struttura dei riti cristiani”. Questo è certamente
molto, ma non è e non può essere tutto! Ciò che inevitabilmente è mancato allora a questo progetto di
Si veda l’interessante studio di P.A. SEQUERI, Estetica e teologia. L’indicibile emozione del sacro: R. Otto, A.
Schönberg, M. Heidegger, Glossa, Milano 1993.
3
3
riforma, consiste in una riflessione complessa sul rapporto tra liturgia e teologia. Tale relazione,
infatti, riguarda essenzialmente il corpo, la fisicità, la materialità dell’uomo, nella sua decisiva
capacità di essere luogo inaggirabile e necessario di relazione con Dio e con il prossimo. (E qui
intersechiamo non solo la “questione liturgica”, ma pure quella della “spiritualità” e della
“devozione”). Così il passaggio dall’idea di “riforma” all’idea di “iniziazione” si verifica oggi sotto la
pressione della nuova evidenza dell’incapacità più radicale dell’uomo moderno: quella di assumere le
“liturgie riformate” nella loro piena natura di riti da celebrare. Il corpo non è qui essenzialmente il
tema di un contenuto del messaggio cristiano o della visione concettuale del sacramento, ma piuttosto
la “forma” con cui entriamo nella liturgia. Ciò significa, in sostanza, che o entriamo nella liturgia
anche con il corpo, oppure ne restiamo irrimediabilmente fuori.
Dobbiamo “diventare sempre più coscienti che nella liturgia si tratta prima di una urghìa (di
un’azione rituale) che di una loghìa (di un discorso su…). Affermare che la liturgia abbia bisogno di
essere “assunta dai corpi” oltre che dalle menti (è questo il senso vero di “iniziazione” rispetto a
quello di “riforma”) mi pare sia la miglior garanzia contro ogni caduta ideologica del cristianesimo, e
non la minaccia nei confronti di una sua presunta purezza spirituale. Poiché spirituale, per il
cristianesimo, non significa semplicemente “mentale”, “intellettuale”, “teorico”, “astratto”,
“moralistico: significa anzitutto relazione, anche e necessariamente corporea, con lo Spirito”.4
Un altro studioso, il cui campo di riflessione è la teologia fondamentale, osserva: “Certo, se la
parola “estetica” potesse evocare prima di tutto l’antica dottrina della aisthesis che presiede alla
tradizione patristica e cristiana dei sensi spirituali, si dovrebbe qui parlare del problema estetico come
della questione essenziale per la restituzione del rito all’efficacia della sinergia simbolica di cui esso è
depositario…E che cos’è il rito cristiano, se non l’esercizio di questo ascolto e di questo sguardo:
orientati entrambi dalla memoria del comandamento del Signore alla percezione e all’assimilazione
di ciò che è prima di tutto e dopo tutto necessario cercare nelle molte parole e nelle molte azioni della
vita quotidiana della Chiesa…? La struttura formale della ritualità, e del suo modo di porre in atto
l’energia del simbolico, è appunto caratterizzata da una schematizzazione tipica del fondamento che
vi è oggettivamente evocato, e da una peculiare stimolazione dell’esistenza che intenzionalmente vi si
raccorda… La forma della parola, il gesto della comunione, la postura della preghiera, l’intenzione
dello sguardo, la sequenza di approssimazione e di distanza, le operazioni del lavare e del nutrirsi, del
toccare e del non toccare, del parlare e del tacere, del riempire di suoni e dello svuotare nel silenzio,
alludono alle molte figure dell’esistenza quotidiana e dei sensi in essa ripetutamente giocati. Eppure li
evocano in modo sintetico, con cadenze non funzionali e con volumi rarefatti: perché appunto il loro
senso ultimo e il loro fondamento originario vengano simbolicamente all’evidenza come differenza,
trascendenza, mysterion. E in tale simbolica spoliazione essi possano ricevere l’impressione del loro
legame con il senso ultimo e il fondamento originario della presenza di Dio nella vita quotidiana”5.
Il faticoso cammino della recezione di Sacrosanctum Concilium attesta la logicità e
l’intrinseca necessità di un rigoroso discorrere dal “che cosa” al “perché” e al “come” si celebra, dato
che “la liturgia è “esercizio dei sensi spirituali”; è “simbolo in azione””.
4. Alla teologia della liturgia si dischiude, allora, un interessante campo di studio: quello sul “come si
celebra”. Crediamo che la riflessione su questo tema possa avere una notevole “ricaduta pastorale” sia
A. GRILLO, Dalla riforma all’iniziazione liturgica. La liturgia e il corpo, in Il Regno 43 (1998), pp. 242-243; ID.,
Liturgia e cultura: una “nuova” inculturazione della liturgia, in Credere Oggi 17/98 (1996), pp. 96-98.
5
P.A. SEQUERI, La musica “rituale” fra liturgia e teologia, in Quaderni della Segreteria Generale CEI – Ufficio
Liturgico Nazionale 5 (1998), pp. 9-26.
4
4
per quanto attiene l’azione celebrativa liturgica sia per quanto attiene quelle peculiare azioni
celebrative che si suole chiamare “devozioni popolari”.
Dunque: “come si celebra?”. Una risposta a questo quesito può essere: si celebra con il “corpo
vissuto”, ovvero si celebra con la totalità del proprio essere e del proprio agire situato nel tempo e
nello spazio.
a) Il tempo liturgico – generalmente inteso - è il tempo vissuto come “incontro celebrativo” tra
l’uomo e l’evento della salvezza che è storico. Dunque un primo rapporto fra tempo e liturgia
è dato dalla natura storico-salvifica del mistero che essa celebra: in questo senso la liturgia è
momento sacramentale che attua il tempo salvifico.
Ma la liturgia è anche un “tempo speciale” che simbolicamente sospende (rallenta) il
fluire del tempo: sotto questo profilo possiamo dire che il tempo liturgico genera il tempo
dell’esistenza in quanto permette all’uomo di cogliere il senso e il valore dei giorni nei quali è
chiamato a “lavorare”. Proprio il tempo sabbatico è fonte e culmine del tempo operoso.
Questo tempo (potremmo chiamarlo la “festa”), che si inserisce e costituisce il tempo
dell’esistere dell’uomo, si presenta come esperienza che ha la capacità di trasformare il
tempo; esso è una sorta di “modificazione simbolica” per cui non è tanto un altro tempo, ma
un “tempo altro”, qualitativamente diverso. Crediamo sia a partire da qui che trova
giustificazione il fatto che la Chiesa possa e debba privilegiare, nel contesto dell’intera
esistenza cristiana, un giorno (la domenica) e dei tempi (liturgia delle Ore e anno liturgico). Il
tempo liturgico, in realtà, predica/celebra il mistero di Cristo in una situazione festiva: vale a
dire, in una situazione di assoluta e indeducibile alterità e novità. E questo tempo giudica e
sovverte ogni progetto che si oppone alla signoria di Dio.
Proprio per questo il tempo della celebrazione, si offre, dicevamo, come apertura e
disponibilità all’incontro; come momento capace di mostrare la struttura dell’uomo come
“essere che decide”. Nel tempo della celebrazione il tempo cronologico viene come assunto
per essere abitato dall’appello di Dio e dalla responsabile e obbediente decisione dell’uomo6.
b) Anche per quanto concerne il rapporto tra spazio e liturgia possiamo partire dalla
constatazione che originariamente questo rapporto si fonda sulla connaturalità tra la struttura
della salvezza e quella della celebrazione liturgica. La salvezza è una realtà che, non solo si
realizza nel tempo, ma anche nello spazio: nello spazio cosmico e nello spazio che l’uomo
costruisce e abita. In qualche modo la liturgia è l’ambiente dell’attuale donarsi dell’evento
salvifico, l’ambiente ove è data la possibilità all’uomo di incontrarlo e di accoglierlo.
Ma la liturgia origina – così come per il tempo - una sorta di “spazio altro”: le chiese
che con la loro struttura e il loro arredo sono quella “sala superiore ben adornata” che non solo
contiene, ma anche dice il mistero che ivi si fa presente. E quello spazio – in quanto “fatto”
(abitato) da ognuno e dall’assemblea - è capace di dire la natura e i compiti di ciascuno e
dell’assemblea tutta; anzi, in realtà, è l’assemblea la vera chiesa, il vero spazio, il vero luogo
dove l’evento della salvezza si attua sacramentalmente.
È alla luce di queste osservazioni che può trovare fondamento la riflessione sui “luoghi
di culto”, sull’altare, sui “programmi iconografici”, sull’arredo…; sulla via pulchritudinis che
va percorsa nei santuari, nella “oggettistica devozionale”; nei testi e nei gesti che “abitano” i
luoghi della devozione popolare.
Cfr. A. RIZZI, Categorie culturali odierne nell’interpretazione del tempo, in AA.VV., L’anno liturgico (Studi di liturgia
– Nuova serie, 11), Marietti, Casale Monferrato 1983, pp. 11-22.
6
5
c) Le azioni liturgiche, in quanto azioni celebrative (simboliche e rituali), constano di diversi
elementi, quali le parole, i gesti, i suoni, i silenzi, i movimenti… Nella loro umana ricchezza e
povertà essi sono il “modo liturgico” (e/o “devoto”) di esperire e di “aver parte” al mistero
della salvezza.
Un elemento che appare massicciamente presente nella celebrazione liturgica è
certamente la “parola”. Possiamo elencare svariate situazioni di parola: uno legge da
un libro davanti a tutti e, correlativamente, tutti ascoltano; uno rivolge a Dio la
preghiera a nome di tutti e, correlativamente, tutti partecipano e aderiscono; tutti
dicono una parola che può essere di risposta, di adesione, di proclamazione, di lode, di
invocazione… Osserviamo come le situazioni di parola, quando non siano analizzate
singolarmente ma nel loro intrecciarsi e nel loro provenire dal silenzio (o andare verso
il silenzio), in realtà si strutturano come una vera e propria esperienza di ascolto e
risposta: un’esperienza di “dialogo”.
Rinveniamo qui quella che potremmo chiamare una costante della celebrazione
cristiana: ogni struttura celebrativa appare come realtà dialogica, come dialogo tra Dio
che parla e il popolo che ascolta e risponde. Questo è motivato dal fatto che di natura
dialogica è tutta la storia della salvezza (Alleanza). Possiamo inoltre dire che si
evidenzia anche un significato teologico sotteso a questa costante. Dio solo ha
l’iniziativa della salvezza; lui solo si manifesta e convoca gli uomini a partecipare alla
sua rivelazione. In realtà l’assemblea cristiana si riunisce ed esiste proprio grazie a
questa “convocazione”.
Abbiamo qui, forse, un punto su cui esercitare una grande “vigilanza”: sia per
quanto riguarda gli atti liturgici, sia per quanto riguarda gli atti “devoti”.
Un modo analogo (eppure diverso) di “situazione di parola” è dato dal canto e dalla
musica. La Costituzione Sacrosanctum Concilium giustifica la presenza del canto e
della musica nella liturgia adducendo tre motivi: dare maggior gusto alla preghiera,
favorire l’unanimità, rendere più solenne i riti (cfr. n. 112).
È sorprendente osservare che questi tre motivi sono, in realtà, tre fondamentali valori
presenti nella pratica umana del cantare e del suonare: cantare insieme è esperienza
che esprime e rafforza l’unità di un gruppo; il rivestimento musicale e canoro della
parola è capace di strappare un testo dal suo solo contenuto informativo o concettuale
per scoprirne e valorizzarne la carica poetica ed affettiva, che permette a chi canta o
ascolta di penetrare e vivere molteplici risonanze; infine il canto e la musica – in
quanto parte del “linguaggio della festa” - fanno parte costitutivamente del tempo e
dello spazio celebrativo. Secondo P.A. Sequeri, la connessione tra musica, canto sacro
e rito è garantita dall’ascolto. Il gioco musicale del suonare e ri-suonare educa
all’ascolto che, attraverso l’intenzionalità della fede, consente di “sostare nei pressi
della Parola e del Gesto di Dio”7.
Crediamo valga la pena accennare al fatto che il fondamento di tutto questo è
costituito da quel “confesserai con la bocca che Gesù è il Signore” (Rm 10,8-10). È qui
che trova fondamento ogni riflettere teologico sulla voce della Chiesa quale si esprime
P.A. SEQUERI, Una teologia del “sacro in musica”, in Rivista Liturgica 75 (1987), pp. 453-466; cfr. G. BONACCORSO,
Carattere denotativo/connotativo della musica. Ragione o emozione?, in A.N. TERRIN (a cura di), Musica per la liturgia.
Presupposti per una fruttuosa interazione (Caro salutis cardo – Contributi, 12), Edizioni Messaggero – Abbazia S.
Giustina, Padova 1996, pp. 77-103.
7
6
e si attua nelle assemblee liturgiche e nelle devozioni che hanno per soggetto il popolo
di Dio. Voce santa e sacra perché procede dal sacerdozio battesimale messo in opera
–nella diversità dei ministeri e dei carismi- dai christifideles in atto celebranti
(partecipanti). Questa vox Ecclesiae viene come “iconizzata” in e attraverso la fidei
canora confessio: e la presenza di Colui che viene confessato in e con il canto non va
cercata altrove: essa si realizza là e quando la fidei canora confessio si dipana.
Come non ricordare gli inni pre-paolini? Non ci parlano di una dimensione
radicalmente innodica della professio fidei christiana? E il fatto di aver accolto nella
liturgia cristiana tutta la complessa dinamica del salmeggiare, non ha nulla da dire?
Dinamica di bocca, orecchio, cuore, dinamica di ascolto e risposta. La confessio fidei
non teme di assumere i tratti della lirica salmica: la tenerezza e la violenza; la fiducia e
l’affidamento dell’orante; ma insieme anche il suo avvertire l’assenza, il silenzio di
quel Dio chiamato in causa, revocato in questione…Tutto questo non è –forseautenticamente “popolare”? E il concreto configurarsi di gesti rituali, di ministeri, di
sequenze rituali, la loro lettura e interpretazione, non ci dice del farsi strada di un’acuta
coscienza del fatto che per tale via “figurale” del dire, del fare, dell’abitare uno spazio
e un tempo, del cantare e dell’ascoltare, del suonare e risuonare…, si dà
l’appropriazione – in senso passivo ed attivo - dei santi misteri?8 Che la liturgia – così
intesa e vissuta - non sia più “popolare” di quanto sovente si crede?
“È stato scritto che Fatima è la vittoria dei semplici (religiosità popolare) e dei carismatici contro gli
intellettuali e contro la gerarchia. Può darsi, ma è ai semplici che Dio riserva il triduo pasquale, i
discorsi di Gesù nel vangelo di Giovanni nonché la retorica e i rimandi al Levitico contenuti nella
Lettera agli Ebrei.
È stato scritto che Fatima è una nuova antropologia, che va oltre l’uomo solo pensante, verso
l’altruismo. Può darsi, ma è da sempre che la liturgia non si preoccupa di insegnare teorie, ma fa
ripetere parole, fa cantare, partecipare, attuare nella vita a favore degli altri i misteri vissuti nella fede.
È stato scritto che Fatima spinge la Chiesa verso la profezia. Ma quale profezia? Non la
descrizione esatta del futuro… Il messaggio di Fatima è simbolico e rimanda al ministero della Parola
(Lc 11,49; Mt 23,34; At 13,1; Rm 12,6; 1Cor 14; ecc…) e al custodire la testimonianza di Gesù che “è
lo spirito di profezia” (Ap 19,10). Lo Spirito fa prendere parte al mistero del sacramentale di Cristo
(CCC 1091-1112) e, con i suoi gemiti (Rm 8,22-23), attira la liturgia verso il ritorno del Signore
(CCC 1130). Dunque ogni liturgia, ogni omelia, ogni servizio ai poveri, ogni discernimento cristiano
del progresso sono profetici perché orientano il mondo e tutti gli uomini al compimento futuro e
definitivo del regno. Se ne sono accorti quanti hanno scoperto la profezia dopo la rivelazione della
terza parte del segreto?”9.
8
9
Cfr. J.Y. HAMELINE, Pour un cérémonial du chant, in La Maison Dieu 199 (1994), pp. 13-28.
R. BARILE, Da Fatima nessuna fantateologia, in Vita Pastorale 88/8-9 (2000), p. 5.
7