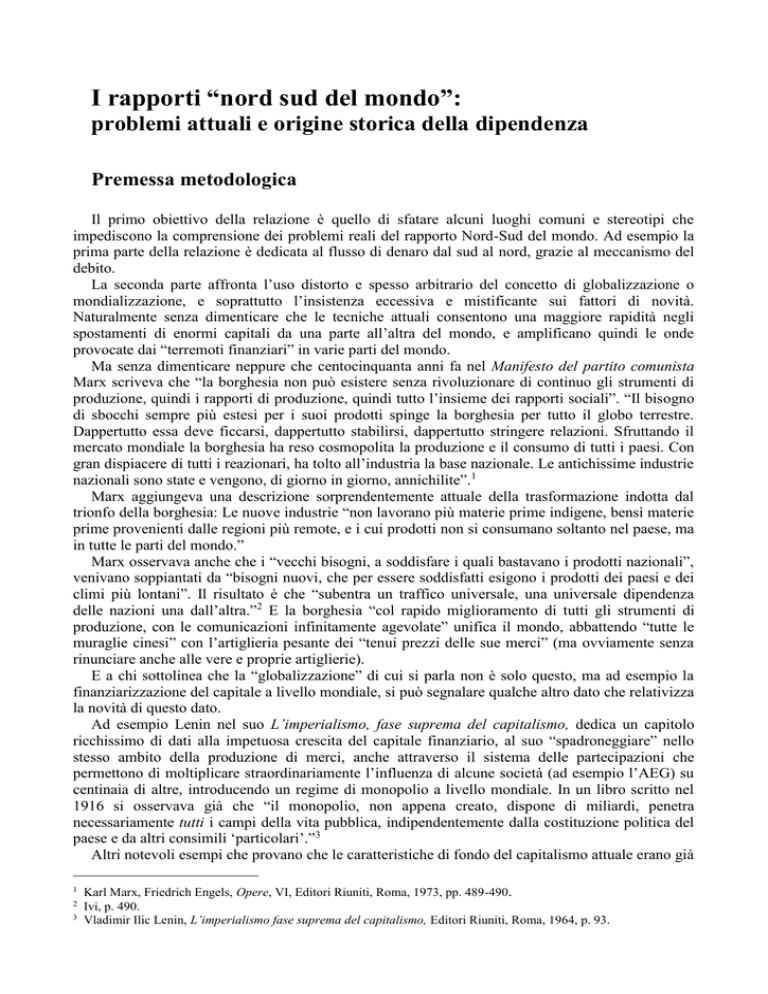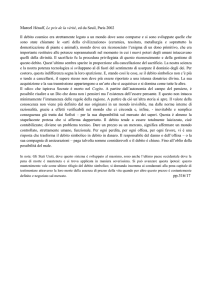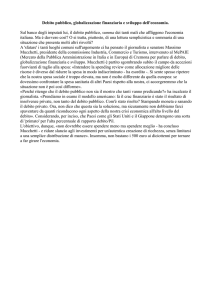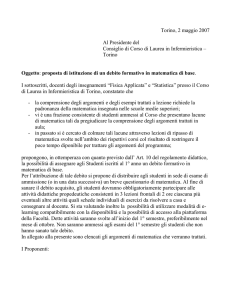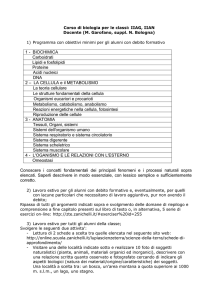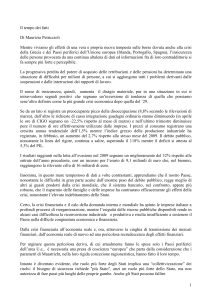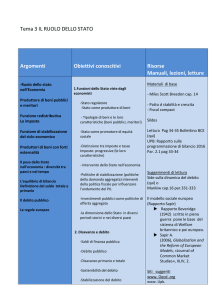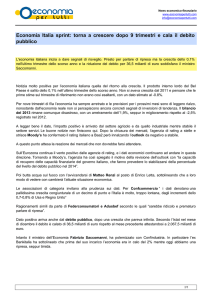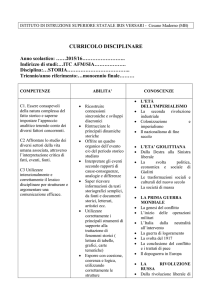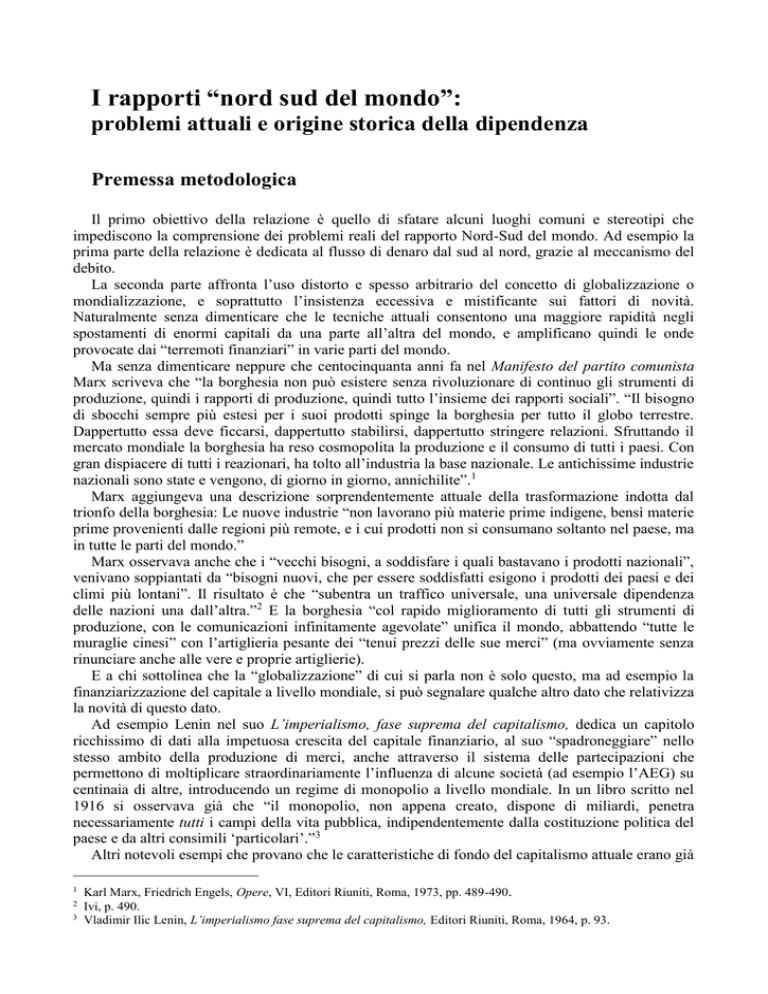
I rapporti “nord sud del mondo”:
problemi attuali e origine storica della dipendenza
Premessa metodologica
Il primo obiettivo della relazione è quello di sfatare alcuni luoghi comuni e stereotipi che
impediscono la comprensione dei problemi reali del rapporto Nord-Sud del mondo. Ad esempio la
prima parte della relazione è dedicata al flusso di denaro dal sud al nord, grazie al meccanismo del
debito.
La seconda parte affronta l’uso distorto e spesso arbitrario del concetto di globalizzazione o
mondializzazione, e soprattutto l’insistenza eccessiva e mistificante sui fattori di novità.
Naturalmente senza dimenticare che le tecniche attuali consentono una maggiore rapidità negli
spostamenti di enormi capitali da una parte all’altra del mondo, e amplificano quindi le onde
provocate dai “terremoti finanziari” in varie parti del mondo.
Ma senza dimenticare neppure che centocinquanta anni fa nel Manifesto del partito comunista
Marx scriveva che “la borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di
produzione, quindi i rapporti di produzione, quindi tutto l’insieme dei rapporti sociali”. “Il bisogno
di sbocchi sempre più estesi per i suoi prodotti spinge la borghesia per tutto il globo terrestre.
Dappertutto essa deve ficcarsi, dappertutto stabilirsi, dappertutto stringere relazioni. Sfruttando il
mercato mondiale la borghesia ha reso cosmopolita la produzione e il consumo di tutti i paesi. Con
gran dispiacere di tutti i reazionari, ha tolto all’industria la base nazionale. Le antichissime industrie
nazionali sono state e vengono, di giorno in giorno, annichilite”.1
Marx aggiungeva una descrizione sorprendentemente attuale della trasformazione indotta dal
trionfo della borghesia: Le nuove industrie “non lavorano più materie prime indigene, bensì materie
prime provenienti dalle regioni più remote, e i cui prodotti non si consumano soltanto nel paese, ma
in tutte le parti del mondo.”
Marx osservava anche che i “vecchi bisogni, a soddisfare i quali bastavano i prodotti nazionali”,
venivano soppiantati da “bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei
climi più lontani”. Il risultato è che “subentra un traffico universale, una universale dipendenza
delle nazioni una dall’altra.”2 E la borghesia “col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di
produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate” unifica il mondo, abbattendo “tutte le
muraglie cinesi” con l’artiglieria pesante dei “tenui prezzi delle sue merci” (ma ovviamente senza
rinunciare anche alle vere e proprie artiglierie).
E a chi sottolinea che la “globalizzazione” di cui si parla non è solo questo, ma ad esempio la
finanziarizzazione del capitale a livello mondiale, si può segnalare qualche altro dato che relativizza
la novità di questo dato.
Ad esempio Lenin nel suo L’imperialismo, fase suprema del capitalismo, dedica un capitolo
ricchissimo di dati alla impetuosa crescita del capitale finanziario, al suo “spadroneggiare” nello
stesso ambito della produzione di merci, anche attraverso il sistema delle partecipazioni che
permettono di moltiplicare straordinariamente l’influenza di alcune società (ad esempio l’AEG) su
centinaia di altre, introducendo un regime di monopolio a livello mondiale. In un libro scritto nel
1916 si osservava già che “il monopolio, non appena creato, dispone di miliardi, penetra
necessariamente tutti i campi della vita pubblica, indipendentemente dalla costituzione politica del
paese e da altri consimili ‘particolari’.”3
Altri notevoli esempi che provano che le caratteristiche di fondo del capitalismo attuale erano già
1
2
3
Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, VI, Editori Riuniti, Roma, 1973, pp. 489-490.
Ivi, p. 490.
Vladimir Ilic Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma, 1964, p. 93.
fondamentalmente presenti all’inizio del secolo possono essere ricavati dalle fotocopie dei capitoli
de L’accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg distribuite al seminario precedente (dicembre
1996) e che possono ovviamente essere richieste al CISS.
La terza parte della relazione fornisce molto brevemente alcuni cenni storici sui rapporti tra
“nord e sud del mondo”,soprattutto per smontare argomenti razzisti o pseudoscientifici che tendono
ad attribuire a cause “naturali”, biologiche, climatiche, psicologiche o altro l’origine della
dipendenza, che va invece ricercata nella storia degli ultimi secoli. Peraltro qualsiasi insegnante
dovrebbe avere già gli elementi per combattere i pregiudizi eurocentrici partendo dalla storia antica
che ha visto le prime grandi civiltà sorgere in aree oggi emarginate e impoverite e svilupparsi
economicamente e culturalmente assai prima che in Europa comparissero le prime forme di
organizzazione sociale.
a) Alcuni dati sul debito del “terzo mondo”
Proprio nei Quaderni del Sud editi dal CISS, alcuni anni fa è apparso un testo molto utile a cui
ovviamente rinvio, accennando qui solo ad alcuni aspetti che possono essere particolarmente utili
sul piano didattico.4
Contrariamente ai luoghi comuni, sono i paesi poveri (detti ipocritamente paesi in via di
sviluppo, PVS) che per decenni hanno finanziato quelli “ricchi”, come si può ricavare dalla
seguente tabella:
Tabella 1. Debito complessivo PVS dal 1980 al 1992
1980
1986
1992
567. miliardi $
1086 miliardi $
1419 miliardi $
Quindi nel corso degli anni 1980-1992 i PVS hanno pagato:
per interessi 771 miliardi $
per rimborsi capitali. 890 mld $
totale rimborsi 1662 mld $
In definitiva i PVS in dodici anni hanno pagato una somma tre volte superiore a quanto avevano ricevuto:
1662 mld $ contro 567 mld $, e sono rimasti ancora debitori per 1419 mld $.
Il debito è ripartito variamente. Quello dei paesi più grandi viene sostenuto periodicamente con
forti iniezioni di nuovi crediti, come è accaduto al Messico dopo il crollo del dicembre 1994 (30
miliardi di dollari forniti dagli Stati Uniti, 20 da altri paesi tra cui il nostro, ovviamente non per
filantropia, ma per evitare che una vera e propria bancarotta trascinasse tutta la finanza
internazionale che aveva investito nei redditizi tesobonos messicani (qualcosa di simile ai nostri
BOT, ma con un tasso d’interesse molto più elevato e in dollari). Lo stesso sta avvenendo per
bloccare la crisi della Corea del Sud (dovuta peraltro soprattutto a cause strutturali e non al debito in
quanto tale), senza grandi risultati.
Altre sanatorie dei debiti sono avvenute per ragioni eminentemente politiche: ad esempio al
momento della Guerra del Golfo i debiti sono stati abbonati alla Somalia e all’Egitto per
ricompensarli dell’adesione alla crociata contro l’Iraq.
Ma nessuna sanatoria è stata concessa di norma a paesi il cui debito è in cifra assoluta
modestissimo, per cui potrebbe essere anche cancellato senza gravi conseguenze per i paesi
creditori, ma è comunque impagabile perché rappresenta una quota enorme del PIL di ciascun paese
(spesso il solo interesse sul debito incide pesantemente sulle misere esportazioni). Questo vale
soprattutto per numerosi paesi dell’Africa subsahariana.
I dati dell’indebitamento complessivo di questi paesi sono sconcertanti. Già nel 1980 il debito
4
Alberto Sciortino, Il debito in via di svikuppo, Quaderni del Sud, CISS, Palermo, 1991.
2
estero complessivo di questi paesi rappresentava il 38,6% del PIL e il 147,9% dei ricavi delle
esportazioni, ma appena 7 anni dopo il debito estero era arrivato al 69% del PIL e al 325,1% dei
ricavi delle esportazioni.
Il rapporto tra debito ed esportazioni arriva nel 1987 al 1562% nel Sudan, al 1783% nella Guinea
Bissau, al 1988% in Somalia. Anche altri paesi, che hanno percentuali apparentemente meno
sconvolgenti (447% nello Zaire, 996,4% in Tanzania, 369% Nigeria), si trovano in gravi difficoltà
perfino per pagare gli interessi senza estinguere il debito.
I problemi di questi paesi sono spesso solo in parte dipendenti dal meccanismo del debito, che
tuttavia si ingigantisce per effetto del deteriorarsi delle ragioni di scambio. Il caso tipico è quello del
Senegal, la cui crisi profonda (di cui ci arrivano gli effetti con una forte corrente migratoria verso
l’Italia) è dovuta all’impossibilità di sganciarsi dalla monocoltura ereditata dal periodo coloniale.
Ancor oggi, dopo decenni di sforzi per ridurre il peso della monocoltura ad arachidi (dopo il crollo
del prezzo internazionale delle arachidi nel 1977 e nel 1983), questo tipo di produzione impegna il
40% delle terre coltivate e rappresenta i due terzi delle esportazioni.
L’indebitamento è stato legato sia ai tentativi di diversificazione delle produzioni (soprattutto nel
settore minerario) sia al disavanzo della bilancia commerciale, perché l’utilizzo della terra per le
arachidi ha ridotto gli spazi per altre attività agricole, inducendo una forte dipendenza da
importazioni alimentari (riso). Alcuni fattori climatici (in particolare la siccità che investe un’area
africana assai più vasta del Senegal), hanno portato il debito a superare enormemente le entrate
delle modeste e variabili esportazioni. Il debito nel 1989 superava di quattro volte l’intero bilancio
dello Stato. L’anno successivo è stato ridotto a un quarto, grazie a un intervento del Club di Parigi
dei paesi creditori e del governo francese, ma senza risolvere nulla, anche perché le misure di
aggiustamento imposte hanno distrutto sanità e scuola, e provocato una crisi occupazionale
gravissima, senza incidere minimamente sulle cause strutturali della dipendenza.
Tra i paesi indebitati c’è anche un grande produttore di petrolio come la Nigeria. Ci sono due
spiegazioni, entrambe importanti: in primo luogo, nonostante il luoghi comuni, il petrolio non
risolve i problemi di nessun paese produttore (tranne di quelli fittizi e desertici come l’Arabia
Saudita e gli Emirati), per cui dall’Algeria al Messico al Venezuela il debito cresce
ininterrottamente, anche perché tutte le attrezzature per l’estrazione, trasporto, ecc. sono importate e
si succhiano gran parte del ricavato dalle esportazioni. Inoltre negli anni di grande rialzo del prezzo
del petrolio la Nigeria ha conosciuto una forte anche se squilibrata industrializzazione, che ha
provocato un’urbanizzazione caotica e l’abbandono delle campagne. Le successive brusche
flessioni del prezzo del petrolio, coincidenti con l’aumento dei tassi di interesse sul debito, hanno
provocato veri e propri terremoti sociali (compresa la brutale cacciata degli immigrati arrivati da
altri paesi al momento del boom).Il debito nel 1980 era ancora sul 30% delle entrate, mentre appena
cinque anni dopo superava il 140% dei redditi da esportazioni. Negli anni Novanta la situazione è
diventata incontrollabile e ha determinato un inasprimento della repressione.
Abbiamo visto che in alcuni casi ci sono stati interventi che hanno portato a una sanatoria totale
o comunque sostanziale per ragioni politiche, come è accaduto durante la Guerra del Golfo, o che
hanno portato a dimensioni meno folli il debito del Senegal, o che hanno impiegato decine di
miliardi di dollari (tirati fuori non solo dal FMI e dalla BM, ma direttamente dalle casse dei
principali paesi capitalistici, Italia compresa) per puntellare il Messico nel 1995 e la Corea del Sud
nel 1997.
Perché non è stato fatto nulla per risanare la situazione di decine di paesi, il cui debito
complessivo è al tempo stesso catastrofico per loro e insignificante per i paesi sviluppati e le grandi
banche? Anche in questi casi, esattamente per ragioni politiche, naturalmente ben diverse. I
“salvataggi” vanno a vantaggio delle principali multinazionali che hanno investimenti cospicui in
quei paesi, mentre sono addirittura superflui i commenti sull’abbuono del debito concesso nel 1990
ad alcuni paesi africani o arabi che dovevano consentire con la loro presenza poco più che simbolica
di presentare come “missione internazionale” l’impresa imperialista nel Golfo persico.
Va sottolineato comunque che non esiste nessun serio motivo economico che renda impossibile
3
un intervento risanatore dal costo assolutamente tollerabile per le economie dei paesi sviluppati. Ad
esempio un intervento modestissimo in Albania sarebbe stato sufficiente per bloccare la grave crisi
sociale innescata dal fallimento a catena delle finanziarie. Era sopportabile dalla sola Italia, non solo
perché più direttamente coinvolta nello scandalo delle “piramidi” ma anche perché particolarmente
interessata ad arginare nel modo più naturale i flussi migratori. Sarebbe costato assai meno di
quanto è costata (ovviamente agli ignari contribuenti) la partecipazione al cartello di salvatori del
Messico, della Thailandia o della Corea del Sud, ma anche la spedizione militare in Albania, il
pattugliamento dell’Adriatico e la stessa accoglienza ai naufraghi e ai rifugiati.
Ma appunto quei salvataggi, come quelli che forse saranno presto necessari per altri paesi asiatici
come l’Indonesia, o per il Brasile, o di nuovo per il Messico, sono solo salvataggi dei nostri stessi
investitori fuori dei confini, imprudenti ma assai importanti. In Albania invece erano andati
imprenditori di terz’ordine, poco più che magliari, e degli albanesi (come dei coreani, o dei
messicani) nessuno si preoccupa.
Scheda
Il caso di Cuba
Va sottolineato che gli effetti del debito colpiscono in misura quasi uguale paesi assai cauti nell’uso delle
proprie risorse e paesi che hanno usato i crediti per costruire insensate opere pubbliche o per arricchire
ulteriormente il gruppo dirigente.
Persino Cuba, che certamente non figura tra i paesi che hanno utilizzato i crediti per attività improduttive
o per il lusso del gruppo dirigente, si è trovata nel corso degli anni Ottanta in gravi difficoltà con i creditori
occidentali. Cuba, come tanti altri paesi, aveva accettato i crediti “generosamente” offerti dalle grandi banche
europee sature di petrodollari accumulati con il rialzo del prezzo del petrolio successivo alla guerra del
Kippur del 1973 e che non aveva senso investire nei paesi capitalistici afflitti da una grave crisi di
sovrapproduzione.
Cuba pensava di poter utilizzare questi crediti per aumentare la sua indipendenza nei confronti dell’URSS
e del Comecon, diversificando i suoi rapporti economici e modernizzando le sue strutture produttive con una
forte iniezione di tecnologia occidentale. Il progetto era realistico: il debito, in sé modesto, avrebbe dovuto
essere pagato vendendo quote maggiori di zucchero sui mercati europei. In realtà nel giro di pochissimi anni
il prezzo dello zucchero sul mercato mondiale si era ridotto a un ottavo (da 64 a 8 cents per libra) di quello
del 1975 per effetto della massiccia introduzione dei dolcificanti sintetici nell’industria dolciaria e delle
bibite, mentre il tasso di interesse sul debito si era moltiplicato rapidamente per cinque in base alla clausola
che doveva essere agganciato al tasso medio di un consorzio londinese di banche.
Questa situazione è stata inoltre aggravata dalle fluttuazioni al ribasso del prezzo del petrolio, dato che
Cuba, pur essendo un produttore modestissimo, aveva un accordo con l’URSS che le consentiva di rivendere
la quota di petrolio risparmiata (il livello di importazione era fissato non in base ai bisogni ma in rapporto
fisso con le esportazioni di zucchero).
Tuttavia la catastrofe economica di Cuba ha cause più politiche che economiche: infatti Cuba verso la
metà degli anni Ottanta ha tentato di promuovere un fronte di tutti i paesi debitori, in primo luogo
latinoamericani, ma anche africani ed asiatici, per ottenere una riduzione e una moratoria sul debito. Il
tentativo è fallito per l’ovvia ragione che la maggior parte dei paesi debitori erano e sono governati da agenti
dei creditori, e il tentativo di Cuba di proclamare una moratoria unilaterale è stato punito con un blocco totale
di ogni agevolazione creditizia da parte delle banche europee. Così Cuba è stata costretta ad aumentare
l’interscambio con l’URSS e i cosiddetti paesi “socialisti”, (gli unici che le concedevano crediti) proprio a
partire dal 1985, quando per molti aspetti i rapporti politici con l’URSS si stavano raffreddando e anzi
avrebbero visto con la rectificación un crescendo di critiche e di polemiche. Indipendentemente da questo
raffreddamento politico, gli scambi con quei paesi, che nel 1985 non superavano il 70% del totale, già due
anni dopo, alla vigilia del crollo, avevano superato l’88%.
L’attuale situazione di Cuba è stata provocata proprio da questo forzato sbilanciamento dei suoi rapporti
economici internazionali, che l’ha resa più vulnerabile al crollo dell’URSS e del suo sistema, e poi
all’inasprimento del blocco statunitense con la legge Torricelli e quella Helms-Burton.
[Per ulteriori dati, si veda Antonio Moscato, Breve storia di Cuba. Le ragioni di una resistenza, Data
News, Roma, 1996 e soprattutto Janette Habel, Cuba tra continuità e rottura, Erre emme, Roma, 1996.]
4
b) Alcune considerazioni sul mito della “globalizzazione”
Affronto qui uno dei luoghi comuni diffusi non a caso dai mass-media, per dimostrare
l’impossibilità di qualsiasi cambiamento, e soprattutto di qualsiasi rivendicazione dei lavoratori. C’è
la “globalizzazione” dell’economia, si dice, e serve a “spiegare” (di fatto a considerare inevitabile)
la realtà dei bambini pakistani o coreani che cuciono i palloni o le scarpe della Nike o di altre
marche mondiali, ma soprattutto a escludere da noi qualsiasi riduzione d’orario, “perché altrimenti
il lavoro verrà spostato altrove”. C’è stato chi spudoratamente ha teorizzato che la riduzione
d’orario deve essere realizzata simultaneamente in tutti i paesi, almeno europei. Chissà perché la
Germania ha orari inferiori ai nostri e non è in crisi per questo, ma solo per i grossi problemi
dell’assorbimento della ex RDT. E poi perché allora non allineare i nostri orari a quelli coreani, che
(senza impedire affatto la crisi) sono in media superiori alle 70 ore settimanali? E perché non a
quelli delle raccoglitrici di the dell’India, che stanno chiedendo la riduzione a 16 (sedici!) ore al
giorno?
Per quanto riguarda l’orario, basterebbe ricordare qual’era la situazione anche in Europa alle
origini del capitalismo. La riduzione è stata il frutto di una durissima lotta di classe, su cui è nato il
movimento operaio organizzato a livello internazionale (ad esempio il 1° maggio era la giornata
mondiale di lotta per le 8 ore e di commemorazione dei martiri di Chicago caduti in questa lotta).
Ogni volta che veniva chiesta una anche modesta riduzione, o veniva introdotta per legge una
limitazione dell’orario almeno per i minori, i capitalisti giuravano di essere sul punto di
soccombere. Non è accaduto, e nessuno è stato ad aspettare che tutti si muovessero insieme e
simultaneamente per la stessa rivendicazione. Casomai è accaduto che una conquista importante in
un paese abbia costretto altri capitalisti a cedere (le 8 ore vengono conquistate per la prima volta nel
1917 in Russia tra la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre, e subito dopo vengono concesse in
Francia e altri paesi). Il coordinamento della campagne da fare è utilissimo, ma non è una
condizione indispensabile per affrontare il problema dove ci sono rapporti di forza che lo
consentono.
E’ bene d’altra parte non dimenticare che ogni conquista è stata contrastata o anche cancellata
appena le condizioni mutavano, perché la tendenza di ogni capitalista, appena poteva, era quella di
allungare l’orario di lavoro per aumentare i propri profitti e utilizzare al massimo le macchine. Marx
nel primo libro de Il capitale ricostruisce alcuni casi esemplari. Ne riporto qui una parafrasi tratta da
un mio recente articolo sull’orario di lavoro:
Il 14 gennaio 1860, nel palazzo comunale di Nottingham, si tenne una contrastata riunione per
discutere della situazione nelle manifatture di merletti. Vari fabbricanti si alzarono a protestare
contro ogni discussione, ma alla fine si riuscì a preparare una “petizione affinché il tempo degli
uomini sia limitato a diciotto ore quotidiane”. Dalle denunce fatte in assemblea risultò che anche
fanciulli di 9 o 10 anni venivano svegliati molto prima dell’alba e fatti lavorare fino a notte inoltrata.
Eppure già nel 1833 in Inghilterra era stata varata la prima legge per regolamentare l’orario di
lavoro: la “giornata lavorativa ordinaria di fabbrica nel settore tessile ”doveva “cominciare alle
cinque e mezzo di mattina e finire alle otto e mezzo della sera”; il lavoro dei fanciulli “dai nove ai
tredici anni venne limitato a otto ore al giorno”, ma nell’arco delle quindici ore (quindi in caso di
ispezione si fingeva che fossero appena entrati in fabbrica). I fabbricanti del settore della seta
peraltro avevano chiesto subito una deroga sull’età minima, asserendo che “la delicatezza del tessuto
esige nelle dita una leggerezza di tocco” che si perde con gli anni. La legislazione inglese dal 1833 al
1864 impose, tra le grida di protesta degli industriali, successive limitazioni all’orario legale, che
furono tuttavia sistematicamente aggirate perché il parlamento votava la legge ma non stanziava
fondi per creare un efficace ispettorato del lavoro.5
Il mio articolo è stato scritto per la rivista “Rifondazione” e dovrebbe uscire nel febbraio 1998. Gli esempi sono tratti
da Karl Marx, Il capitale, libro primo, Editori Riuniti, Roma, 1964, pp. 278-279, 306, 313-319, 329 e passim.
5
5
A quanto pare i bambini pakistani che cuciono i palloni non sono una novità! E d’altra pare ci
sono anche le dodicenni di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi o quelle di Lizzanello vicino
a Lecce. C’erano state per decenni, non c’erano più venti o .venticinque anni fa, per effetto delle
lotte operaie e della resistenza diffusa all’arbitrio, ci sono di nuovo perché è sparita nella pratica e
nella coscienza della gente l’idea stessa della necessità di organizzarsi, di difendersi dai soprusi, di
pretendere un salario decente e un orario che lasci un po’ di forze.
E’ sparita non perché “ora c’è la globalizzazione”, non perché solo ora i capitalisti hanno pensato
che “potrebbero spostare il lavoro altrove” se non ottengono tutto quel che vogliono, ma perché è
sparita, in Italia e in gran parte del mondo, l’organizzazione sindacale dei lavoratori (con lo stesso
nome di sindacato ci sono organismi che si preoccupano di tutt’altro e sono impegnati anzi
soprattutto a diffondere tra i lavoratori le ideologie dei padroni...).
Ma vediamo in che cosa consisterebbe questa globalizzazione di cui si parla tanto. Il mondo
ultimamente sarebbe stato unificato in modo tale, che la concorrenza schiaccerebbe oggi i paesi
come ieri accadeva alle imprese. Ogni paese sarebbe ricco o povero a seconda degli spazi che riesce
a sottrarre o meno ad altri paesi. Da qui la necessità di contrarre continuamente i costi di produzione
e in particolare i salari, di allungare gli orari, di contrarre le spese sociali per “aumentare la
competitività”.
Un economista americano tutt’altro che progressista, ma infastidito dallo scarso rigore delle tante
chiacchiere “scientifiche” in proposito, Paul Krugman, ha scritto un libro per confutare quello che
gli sembra un pericoloso errore analitico, cioè l’analogia tra la situazione delle singole imprese sul
mercato e quella delle economie nazionali.6
Gli argomenti sono solidi: perfino negli Stati Uniti, il paese imperialista per definizione, il
commercio internazionale incide per appena il 10% sul prodotto complessivo. Anche una variazione
notevole o la perdita di posizioni su un mercato importante finiscono col pesare molto
marginalmente sulle condizioni di vita dei propri cittadini. Se queste peggiorano lo si deve a scelte
soggettive, non a una fatale imposizione del mercato. E come peggiorano! Dopo sette anni di
crescita ininterrotta dell’economia nordamericana, il 13,7% secondo alcune statistiche, il 19%
secondo altre, vive al di sotto dei livelli di povertà ufficialmente dichiarati. Secondo l’UNICEF un
bambino su quattro è alla fame.
Colpa del Giappone, come insinuano spesso i mass-media statunitensi? Neppure per sogno, dato
che l’esito della concorrenza tra i due massimi paesi imperialisti è tutt’altro che determinante per le
condizioni di vita dei cittadini: infatti solo il 2% del reddito statunitense è speso in beni prodotti in
Giappone. Se queste importazioni aumentassero o calassero anche del 50% (cosa del tutto
improbabile) praticamente non ci sarebbe nessuna ripercussione nel paese. Nel decidere la
situazione interna di ciascun paese, conta più l’innovazione tecnologica che non la competizione
globale.
La drastica riduzione dell’occupazione industriale, per lo stesso economista è dovuta solo
all’incessante aumento della produttività e all’automazione, non alla perdita di competitività sui
mercati mondiali. La leggenda di folle immense di disperati del Terzo Mondo pronti a sostituire i
lavoratori statunitensi o europei se non rinunciano ai loro diritti, o quella di un’invasione di prodotti
a buon mercato provenienti da quelle aree, sono ugualmente mistificanti. Naturalmente in ogni
paese sviluppato, nonostante i muri di acciaio e vetro sul confine col Messico o le navi che
pattugliano l’Adriatico, un contingente di disperati viene fatto entrare per ampliare e dequalificare il
mercato industriale di riserva, e ogni multinazionale fa fare una parte dei suoi prodotti nei paesi “in
via di sviluppo”. In realtà nel 1990 appena l’1,2% del prodotto complessivo dei paesi
6
Paul Krugman, Un’ossessione pericolosa. Il falso mito dell’economia globale, Etas Libri, Milano, 1997.
6
industrializzati è stato speso nell’acquisto di manufatti provenienti da quelle aree, che sono invece
state saturate di prodotti provenienti dalle metropoli imperialiste.
E anche la leggenda della fuga di capitali verso il Terzo Mondo, oltre ad essere contraddetta dai
dati che segnalavamo nella prima parte (il sud che finanzia il nord, come profitti di ritorno, o fughe
di capitali locali), è smontata da un dato riportato da Krugman: l’intero boom negli investimenti nei
paesi “emergenti” dal 1990 in qua ha sottratto ai paesi industrializzati appena lo 0,5% del loro stock
di capitale. Se non ci fosse stata questa corsa, ci sarebbe stato quindi appena uno 0,5% di capitali in
più. Chi se ne sarebbe accorto?
Che il mercato mondiale fosse già unificato sostanzialmente (sia pur con sacche di economia
primitiva, precapitalistica che d’altra parte sussistono ancora in diverse parti dell’Africa,
dell’America Latina e dell’Asia) lo si poteva desumere dalle analisi sviluppate da Rosa Luxemburg
nell’Accumulazione del capitale (1913) e da Lenin nell’Imperialismo fase suprema del capitalismo
(1916). Sono molto “fuori moda”, ma esattamente per scoraggiarne una lettura che potrebbe aiutare
a capire i processi attuali molto più di tante presunte novità spacciate dagli ideologi del capitalismo.
L’errore di Krugman è quello di polemizzare con le affermazioni correnti, come se fossero frutto
di errori casuali, o di incapacità soggettiva di cogliere i processi da parte di questo o
quell’accademico.
In realtà le teorie sulla globalizzazione come novità travolgente dei nostri tempi appartengono
alla sfera dell’ideologia, che per Marx è falsa coscienza, ma non del tutto arbitraria, e ha una
funzione precisa, permette agli uomini di concepire il conflitto. Per Marx, ovviamente, assai prima
dell’attuale fase di onnipervasività dei mass-media mondializzati nell’era delle TV satellitari e della
trasmissione di informazioni monopolizzata dai detentori della ricchezza, l’ideologia dominante
anche tra le masse subalterne è quella delle classi dominanti. E il mito della globalizzazione come
fattore determinante che rende obbligata ogni scelta è essenziale ad esempio per far accettare la
disoccupazione. Paul Krugman polemizza con Delors per aver usato la figura della globalizzazione
per spiegare (e giustificare) la disoccupazione europea, che egli invece attribuisce all’insostenibilità
dello Stato sociale. Ma non coglie che è assai più efficace credere e far credere che ci sia una realtà
esterna a cui piegarsi (la concorrenza altrui sul mercato mondiale visto come un Moloch), che
attribuire i sacrifici da sopportare a un’interpretazione soggettiva della situazione sociale, ecc.
c) Le premesse storiche del rapporto “Nord-Sud del mondo”.
Abbiamo spesso accennato al fatto che i rapporti di sfruttamento da parte delle metropoli
imperialiste (fondamentalmente i paesi europei, più la loro appendice nordamericana e la singolare
riproduzione del modello in Giappone, su cui ritorneremo) nei confronti dei paesi del resto del
mondo hanno caratteristiche costanti che si presentano in forme solo parzialmente diverse già alla
fine del secolo scorso.
Preferiamo non usare che in minima misura e “tra virgolette” la dizione corrente “nord e sud”,
che crediamo sia meno efficace, ingeneri alcune confusioni pericolose, e soprattutto occulti dietro
una definizione geografica inevitabilmente un po’ neutra la sostanza dello “scambio ineguale” e
dello sfruttamento imperialista delle risorse del mondo.
Le premesse dirette dei rapporti attuali sono state fondamentalmente poste nel secolo scorso.
Basta pensare a quel che era la posizione dell’Europa rispetto al resto del mondo nel 1492, data
convenzionale che è tuttavia assai utile per il confronto: la maggior parte delle ricchezze erano
concentrate nel mondo arabo islamico, nella “favolosa India”, in Cina, negli imperi di quella che di
lì a poco sarebbe stata definita America, primo segno anche linguistico di una spietata e distruttiva
7
conquista. Il 1992 ha dato luogo a molte celebrazioni, alcune vuote e retoriche, altre stimolanti, che
hanno sottolineato il carattere di rapina e di sterminio che ha assunto la dominazione europea nel
“nuovo mondo”. Più raramente si è parlato del ruolo che le ricchezze rastrellate con maggiore
facilità nei territori degli imperi azteco, maya e inca che in altre parti del mondo (dove c’erano
strutture statali in grado di resistere meglio alla conquista) hanno avuto nello sviluppo dell’Europa e
nelle sue stesse trasformazioni sociali, dalla “rivoluzione dei prezzi” alla formazione di robusti Stati
nazionali. Lo sviluppo capitalistico in Inghilterra, Olanda, Francia ha avuto cause molteplici, ma si
è alimentato con l’oro e l’argento predato sugli oceani dai loro corsari.
Se ancora nel corso del XVII secolo le città d’Europa apparivano austere e povere a confronto
con Damasco, Bagdad, Alessandria, Delhi, e perfino Timbuctù, il rapporto comincia a modificarsi
nel secolo successivo. Anche militarmente, ancora nel 1683 Vienna aveva tremato sotto l’assedio
delle truppe ottomane, rispetto alle quali non c’era affatto quella supremazia tecnologica che aveva
permesso di sbaragliare in pochi anni gli imperi precolombiani (anche se nel nuovo continente gli
spagnoli ebbero come alleati preziosi sia i popoli appena sottomessi da quegli imperi, sia le più
banali malattie diffuse in Europa, che falcidiavano gli indigeni sprovvisti di anticorpi).
Che i rapporti di forza anche militari (riflesso tuttavia delle trasformazioni sociali, e non solo
delle innovazioni tecnologiche) tra l’Europa e i grandi imperi asiatici fossero profondamente mutati
lo si capì nel 1798-1799, quando l’avventurosa spedizione di Napoleone in Egitto e Palestina
mise in evidenza che il “terribile impero ottomano” era entrato in una crisi profonda e forse
irreversibile. Dietro a questo mutamento, c’erano molti processi consolidatisi nel corso del XVIII
secolo, in cui non furono più le guerre da corsa e di rapina a fornire i capitali, ma la nuova attività,
ancor più criminale, che dissanguò l’Africa di decine di milioni di uomini per alimentare le
piantagioni e le miniere delle Americhe. Milioni di giovani robusti e di ragazze belle e sane vennero
razziati, lasciando villaggi spopolati con vecchi e malati. Durante la selezione si uccideva chi
tentava di resistere, ma anche i bambini staccati dal seno materno. Alcune potenze europee avevano
accumulato ricchezze in questo commercio dell’oro nero, che aveva distrutto o messo in crisi quasi
tutte le strutture statuali africane, e grazie ad esse avevano potuto iniziare il loro decollo industriale.
Nel 1798 Napoleone comunque pensava solo a conquistare un punto essenziale per bloccare o
rendere difficile il rapporto del nemico britannico con l’India, non ancora completamente
conquistata ma già essenziale per la potenza inglese, tuttavia la verifica dell’inconsistenza delle
truppe ottomane incoraggiò molti altri pretendenti.
In primo luogo fu lo stesso Mohamed Alì, che governava l’Egitto per conto del sultano di
Costantinopoli, ad autonomizzarsi e a tentare di rompere l’immobilismo con una serie di misure
radicali, dalla riorganizzazione dell’esercito sul modello francese, all’introduzione di un catasto e
all’apertura della prima tipografia e del primo giornale. Cominciò a costruire una flotta moderna,
commissionandola ai migliori cantieri europei, e fino al 1840, quando fu fermato dall’intervento
congiunto delle flotte dei maggiori paesi europei, riuscì a sviluppare un embrione di stato nazionale
egiziano, esteso tuttavia alla Palestina e con una presenza in Grecia.
Inoltre da un lato la Russia, dall’altro l’Austria cominciarono a ritagliarsi pezzi del territorio del
“grande malato”.
Una presenza dimostrativa della flotta inglese poi costrinse il sultano nel 1839 a promuovere una
serie di riforme, e soprattutto ad aprire i suoi porti alle merci europee. Negli stessi anni, tra il 1839 e
il 1842 la prima “guerra dell’oppio” apriva i porti cinesi a tutte le merci occidentali e in particolare
all’oppio, prodotto in grande quantità dagli inglesi in India e dai francesi in Indocina. Già da anni
8
l’oppio rappresentava più del 50% delle esportazioni britanniche in Cina. Nel 1856-1860 la seconda
guerra dell’oppio avrebbe imposto all’impero cinese la perdita della sovranità su porti e fiumi
navigabili, e l’umiliazione della stupida e vandalica distruzione del meraviglioso Palazzo d’Estate a
Pechino (ma già nel 1842 le truppe britanniche si erano distinte nel saccheggio della Pagoda di
porcellana a Nanchino, e avevano preteso perfino “riscatti” di città non occupate, che equivalevano
a un’indennità per ...”mancato saccheggio”).
Nello stesso periodo, con gli stessi metodi, l’ammiraglio Perry impone nel 1853 l’apertura dei
porti del Giappone alle navi e alle merci degli Stati Uniti, che saranno seguiti a ruota da varie
potenze europee. Se il Giappone sfugge alla sorte degli altri imperi, occupati in proprio o in
“condominio” come nel caso della Cina, lo si deve, oltre alla geniale intuizione del suo nucleo
dirigente (che non condivide il disprezzo cinese per i “barbari europei” ma si preoccupa di imitarli e
di utilizzare la loro tecnologia riproducendo per molti aspetti il loro modello di organizzazione
politica e sociale) al fatto che la Cina appare un boccone troppo grosso per le potenze che
partecipano alla sua colonizzazione. La Cina d’altra parte è molto lontana, e per reprimerne più
tempestivamente le frequenti ribellioni il Giappone viene associato alla spartizione. Specialmente al
momento della rivolta detta dei Boxer il Giappone avrà un ruolo militare determinante, e al tempo
stesso getterà le premesse per una sua diretta penetrazione, che avverrà al termine della prima
guerra mondiale ereditando le legazioni extraterritoriali e gli interessi della Germania sconfitta, per
poi tramutarsi negli anni Trenta in vera e propria guerra di conquista.
La Guerra di Crimea, sempre nel 1853-1856, anni di grande attivismo europeo su scala
mondiale, rappresenta un’eccezione solo apparente, perché grandi e piccole potenze (compare
anche il Regno di Piemonte) si coalizzano contro la Russia in difesa dell’integrità dell’impero
ottomano. Ma si tratta solo di evitare che una potenza contigua e potenzialmente forte dal punto di
vista militare come la Russia si ritagli una fetta troppo grande di bottino. E’ solo un rinvio della
spartizione a tempi successivi, per la concorrenza tra i predoni.
Intanto vanno avanti le “pacifiche penetrazioni economiche” che Rosa Luxemburg ha descritto
magistralmente e che abbiamo esposto ampiamente nel seminario del 1996 soprattutto per quanto
riguarda l’Egitto. Sono ovviamente pacifiche solo dov’è possibile, dove non c’è una resistenza
apprezzabile. La spartizione dell’Africa gronda di nuovo sangue, dopo quello sparso con la tratta
degli schiavi nei secoli precedenti. Basti pensare alla conquista e alla colonizzazione del Congo da
parte del Belgio, o meglio, nella prima fase, della multinazionale presieduta dal suo sovrano
Leopoldo II, con il suo terribile strascico di lavori forzati, di taglio della mano o di un piede a chi
tenta di sfuggire ad esso, di distruzione dell’agricoltura tradizionale che garantiva la sussistenza
della popolazione, per far posto alla monocoltura del cotone o del caucciù o di altri prodotti, a
secondo del clima di ciascuna parte dell’immenso territorio. Ma ogni paese si è distinto su questo
terreno: i libri di Del Boca documentano ampiamente i crimini del colonialismo italiano in Eritrea,
Somalia e poi in Libia.
Anche in America Latina gli interessi imperialisti (dapprima della Gran Bretagna, e solo
successivamente degli Stati Uniti), vanificano presto le indipendenze strappate al momento della
crisi della Spagna durante le guerre napoleoniche. Dovunque l’imperialismo punta in primo luogo
alla distruzione dell’economia tradizionale di sussistenza, separando la terra da chi la lavora e l’ha
lavorata da generazioni, per creare una delle premesse dello sviluppo di un’economia capitalistica.
Il processo è ineguale e non senza consistenti sacche di resistenza soprattutto nelle zone più
periferiche. Ancor oggi il processo non è completato in diverse parti del mondo, come l’Amazzonia
9
e lo stesso Messico meridionale. La lotta dei Maya del Chiapas, guidata dall’EZLN, sorge proprio
dalla resistenza all’espansione dell’economia capitalistica, che aveva già cacciato molte comunità
indigene sospingendole in zone impervie e disabitate, e che rischia di essere accelerata dall’entrata
del Messico nel Nafta, il trattato di “libero commercio” con Stati Uniti e Canada.
Ormai la lotta per la conquista di territori e di mercati diventa incessante. Combattuta spesso con
braccia di altri, investe gli ultimi brandelli dell’impero spagnolo, con la guerra ispano-americana
che impedisce a Cuba, Portorico e Filippine di beneficiare della sconfitta che stanno infliggendo
alla Spagna. L’Italia fascista tenterà, per ultima, la conquista insensata dell’ultimo Stato
indipendente africano, l’Etiopia, e grottescamente perfino del più povero lembo d’Europa,
l’Albania. Ma ormai la lotta per la conquista ha innescato il secondo e più terribile conflitto
mondiale, che avrà come effetto imprevisto quello di accelerare i processi di decolonizzazione, che
in larga misura arriveranno al successo nel quindicennio successivo. [vedi Appendice]
Una decolonizzazione, tuttavia, che non porterà a nessuna indipendenza reale. L’imperialismo ha
fatto tesoro dell’esperienza della dominazione indiretta di Stati formalmente indipendenti, in primo
luogo nell’America Latina ma anche in Asia e in Medio Oriente, cosicché gli squilibri nella
ripartizione delle ricchezze tra paesi “ricchi” e paesi “poveri”, tra “Nord e Sud del mondo” si sono
addirittura aggravati dopo la grande ondata di decolonizzazione. Quasi ovunque gruppi dirigenti
famelici e corrotti svolgono i compiti più turpi per conto dei veri padroni, che non sono sempre i
vecchi (ad esempio la Francia prende il posto del Belgio nel Congo, nel Rwanda e nel Burundi, a
volte da sola, e più spesso associata agli Stati Uniti). Anche i paesi come l’Algeria, il Burkina Faso,
l’Etiopia, l’Angola, il Mozambico, che avevano tentato strade diverse, e avevano inizialmente
gruppi dirigenti sinceramente preoccupati del bene del loro popolo, sono stati riportati nei ranghi da
colpi di Stato, o dall’influenza di quella che era apparsa un’alternativa all’imperialismo, l’URSS.
Guevara aveva colto già alla metà degli anni Sessanta il pericolo della riproduzione del modello
burocratico, ma anche che i “paesi socialisti” non rappresentavano una vera alternativa ed erano
anzi oggettivamente complici dell’imperialismo. E nel 1965, quando Guevara pronuncia queste
parole, il processo di degenerazione della burocrazia sovietica doveva fare ancora molti passi.
Quando questo processo involutivo ha avuto le sue manifestazioni più tragiche, nel corso degli
anni ’80 e ’90, l’unica eccezione allo sprofondamento sembravano essere quei paesi dell’Asia in
fuga verso il benessere, che venivano presentati come un esempio positivo che assolveva
l’imperialismo e in genere i paesi più sviluppati da ogni responsabilità, o almeno come eccezioni
talmente clamorose che impedivano di ricavare qualsiasi regola generale dai processi in atto. Ma si
trattava solo di qualche paese aggregato a uno dei carri dei paesi dominanti, e la vicenda più recente
della Corea del Sud, della Thailandia, dell’Indonesia, ecc. rivela che quei tentativi non hanno avuto
esiti migliori. Non solo quei paesi vengono risospinti brutalmente indietro dalla grande crisi
monetaria che sconvolge tutto il mondo capitalistico. Gli interventi per puntellarne le monete e le
borse sono analoghi a quelli già fatti nel 1995 per il Messico, hanno la stessa finalità di evitare crolli
a catena degli investitori statunitensi o europei, e confermano comunque il carattere artificiale e
dipendente di quei presunti “miracoli economici” tanto reclamizzati negli anni scorsi.7
7
Un effetto secondario imprevisto dei crolli delle economie presentate come miracoli del capitalismo è proprio quello
di aver spazzato via molte sciocchezze degli apologeti del capitalismo: la durezza dei ritmi, la lunghezza incredibile
degli orari di lavoro, lo sfruttamento spietato dei minori, la persecuzione dei sindacati autorganizzati, tutto ciò non è
servito ad evitare i crolli di quelle economie. Ma soprattutto è evidente, anche dall’ampiezza dei salvataggi, che quei
paesi non erano che appendici del Giappone, degli Stati Uniti, dell’Europa, non paesi che imboccavano autonomamente
una strada originale allo sviluppo.
10
Bibliografia
In nota ho segnalato i testi “classici” a mio parere ancora molto utili per inquadrare il problema,
in particolare il libro di Rosa Luxemburg, L’accumulazione del capitale. Contributo alla
spiegazione economica dell’imperialismo, Torino, Einaudi, 19682, che è piuttosto arduo nella prima
parte, ma leggibilissimo nella seconda, quella appunto che affronta in chiave storica il problema
della distruzione dell’economia tradizionale, del meccanismo dei crediti internazionali e
dell’asservimento attraverso il debito, ecc. (fotocopie disponibili presso il CISS).
Sempre nel corso del seminario del 1996-1997 avevo letto e distribuito fotocopie del discorso di
Guevara al secondo seminario economico afroasiatico di Algeri del febbraio 1965, sulla questione
dello scambio ineguale e della responsabilità e complicità dei paesi “socialisti”. Il discorso è
comunque presente in tutte le raccolte di Opere di Guevara (Erreemme, Einaudi, Feltrinelli).
Sui problemi specifici del “terzo mondo” e del debito esiste una larga pubblicistica a cura di
diverse ONG, che sicuramente sono disponibili presso il CISS più che in libreria. Ad esempio i
quaderni di Mani tese e del CRES (centro ricerca educazione allo sviluppo). Tra le moltissime
pubblicazioni segnalo, sempre a cura di Mani Tese, ma presso l’editore Bulgarini di Firenze Wilma
Beretta Podini, Fame e squilibri internazionali, e Prodotti del sud - consumi del nord, a cura di
Giovanna Daviddi, COSPE, Firenze. Sta per uscire da Piero Manni editore in Lecce un testo curato
da Vinicio Russo del CTM Movimondo, di cui ho visto le bozze ma non conosco ancora il titolo
definitivo. Penso comunque che la rete tra le ONG faccia circolare rapidamente questi testi, che
potranno essere reperiti appunto presso il CISS.
Per una conoscenza generale dell’Africa nera prima della colonizzazione (ma ovviamente anche
durante e dopo) è fondamentale il libro di Joseph Ki-Zerbo, Storia dell’Africa nera. Un continente
tra preistoria e futuro, Einaudi, Torino, 1977. Ma esistono anche libri più agili e divulgativi tra cui
uno di Basil Davidson, L’Africa nel mondo contemporaneo, SEI, Torino. Davidson è autore di un
importante libro sulla tratta, Madre nera. L’Africa nera e il commercio degli schiavi, Einaudi,
Torino.
Sul colonialismo italiano nel Corno d’Africa e in Libia sono essenziali i libri di Angelo Del
Boca, che è troppo lungo elencare (sono più di dieci) tutti pubblicati da Laterza.
Sulla conquista dell’Asia è ancora prezioso il libro dell’indiano Kavalam M. Panikkar, Storia
della dominazione europea in Asia, dal cinquecento ai nostri giorni, Einaudi, Torino, 1958.
Sul Vicino e Medio Oriente rinvio a Antonio Moscato, Jacob Taut, Michel Warshawsky,
Sionismo e questione ebraica. Storia e attualità, Sapere 2000, Roma, 1984; Antonio Moscato,
Israele, Palestina e la guerra del golfo, Sapere 2000, Roma, 1991; Antonio Moscato, Libano e
dintorni. Integralismo islamico e altri integralismi, Sapere 2000, Roma 1993.
P.S. Altre letture sono segnalate nei miei ultimi libri, Il “capitalismo reale”. Origini e storia,
Teti, Milano, 1999 e L’Italia nei Balcani. Storia e attualità, Piero Manni, Lecce, 1999.
11
Appendice
La seconda metà del secolo
relazione di Antonio Moscato, Roma, Liceo Morgagni, 7 maggio 1997
Per capire i problemi di questa seconda metà del secolo, bisogna risalire molto indietro. A
seconda degli angoli di visuale lo spartiacque può essere retrodatato al 1914 (inizio della “grande
guerra”, con la conseguente separazione del movimento operaio internazionale nei due tronconi
socialdemocratico e comunista) o al 1917 (rivoluzione russa e consolidamento del solco tra
riformisti e rivoluzionari), o piuttosto al 1929, che segna la fine delle illusioni sullo sviluppo
illimitato e armonico del capitalismo, e crea le premesse della seconda guerra mondiale.
La grande crisi economica mondiale del 1929 non si limita a gettare sul lastrico decine di
milioni di lavoratori (allora senza nessuna protezione salariale) ma distrugge in poche settimane
tutti gli accordi per la spartizione pacifica dei mercati. Tutti i paesi erigono pesanti barriere
protezionistiche, e i paesi imperialisti con un mercato interno ristretto sono spinti a cominciare i
preparativi per abbattere a cannonate tali barriere, mentre quelli che come la Gran Bretagna o la
Francia dispongono di un enorme retroterra nelle colonie (accresciute da quelle tedesche che sono
state spartite tra loro al termine della guerra, lasciando alcune briciole a Belgio e Giappone)
accelerano anch’essi la corsa agli armamenti per fronteggiare il pericolo.
È questo che sospinge già all’inizio degli anni Trenta il Giappone alla conquista della Manciuria
e poi dell’intera Cina, e che convince la borghesia tedesca nel suo insieme, al di là delle opinioni
politiche e del credo religioso, a sostenere Hitler. Il partito nazional-socialista si trasforma in pochi
mesi da gruppuscolo che nel 1928 non aveva avuto neppure i voti sufficienti per eleggere il suo
capo nel parlamento a grande forza nazionale sostenuta da tutta la stampa “indipendente”, finanziata
dalle associazioni degli industriali, armata e protetta da polizia ed esercito.
L’ascesa di Hitler non era irresistibile, né il suo esito finale imprevedibile: lo aveva intuito
lucidamente Trotskij, e d’altra parte il programma di espansione ad est e la stessa “soluzione finale
della questione ebraica” erano indicate a chiare lettere nel Mein Kampf, scritto fin dal 1923. Ma la
cecità dell’URSS di Stalin, che impose al movimento operaio tedesco (e non solo) una sciagurata
equidistanza tra nazismo e socialdemocrazia (ribattezzata socialfascismo), e le complicità delle
potenze europee che volevano sospingere la Germania contro l’URSS facilitò il compito di Hitler.
Fino a tutto il 1934 l’URSS e l’Internazionale comunista sottovalutarono il pericolo fascista,
poi quando cominciarono a intuire il pericolo passarono da un eccesso all’altro, cercando ad ogni
costo l’intesa con Francia e Gran Bretagna, anche al prezzo di sacrificare la rivoluzione che si
delineava in Francia e in Spagna, imponendo al movimento operaio di quei paesi un’alleanza
subalterna con le rispettive borghesie nei Fronti Popolari.
Nel 1936 un’eccezionale ondata di scioperi ed occupazioni di fabbriche in Francia, e la poderosa
risposta operaia al golpe di Franco furono deviate nella prospettiva della collaborazione di classe.
Nel 1938 la sconfitta della rivoluzione era già maturata in entrambi i paesi, e nel 1939 era diventata
catastrofica e definitiva.
In quegli anni erano avvenute trasformazioni profonde nelle colonie francesi e britanniche, ma i
movimenti di liberazione, quasi ovunque influenzati inizialmente da comunisti e socialisti, erano
stati delusi dalla politica di quei partiti che avevano rinunciato ad appoggiare le loro rivendicazioni
per non rompere con le rispettive borghesie. Da allora, quasi ovunque, i movimenti di liberazione
sarebbero passati sotto direzioni nazionaliste e anticomuniste, con la sola eccezione della
penisola indocinese. In Vietnam una coalizione di stalinisti e trotskisti (caso più unico che raro in
quegli anni) aveva vinto le elezioni nel 1936, ma il governo di fronte popolare aveva inviato come
governatore un generale di destra che nel 1940 si schiererà con il governo collaborazionista di
Petain-Laval e aprirà quindi le porte ai giapponesi (per questo i comunisti vietnamiti potranno
cominciare la loro lunghissima lotta di indipendenza in nome dell’antifascismo, mentre in altre
colonie francesi e britanniche ogni movimento indipendentista veniva subito bollato come fascista).
12
Abbiamo anticipato queste notizie sul Vietnam, perché la sua lotta sarà successivamente il
catalizzatore di tutti i processi di decolonizzazione.
Nel 1939 la guerra mondiale inizia sotto i peggiori auspici: Francia e Gran Bretagna si
schierano nominalmente a fianco della Polonia, ma non si impegnano a fondo (è la drôle de guerre,
la strana guerra), mentre l’URSS ha firmato con la Germania il Patto Ribbentrop-Molotov che
assicura ai nazisti la sicurezza del fronte orientale. In realtà l’URSS collabora perfino militarmente,
e si assicura nella prima delle spartizioni che accompagneranno la II guerra mondiale la metà della
Polonia e i Paesi Baltici, alle spalle dei loro popoli (con conseguenti risentimenti antisovietici in
quei paesi, che contribuiranno cinquant’anni dopo al crollo del cosiddetto “socialismo reale”.
Intanto, per non perdere di vista l’Italia, in quello stesso 1939, il regime di Mussolini e Vittorio
Emanuele III aveva aggredito a tradimento la piccola Albania, che da circa trent’anni era un
protettorato italiano di fatto (cioè riconosciuto dalle grandi potenze ma non dagli albanesi),
trascinandola l’anno successivo nell’invasione della Grecia, che si risolverà in una catastrofe per
l’Italia, ma anche per l’Albania, che diverrà campo di battaglia di una guerra certamente non voluta.
È bene ricordarselo oggi che nuovamente l’Italia rimette piede in Albania...
Nel 1940 la Germania, tranquilla sul fronte orientale, può gettare tutte le sue forze sulla Francia
piegandola in poco tempo. La Germania era anche intervenuta nei Balcani per riparare i danni
provocati dalla maldestra iniziativa di Mussolini, occupando Jugoslavia e Grecia per proteggere il
fianco sud dell’offensiva già prevista verso l’URSS.
Stalin si illude fino all’ultimo sulla lunga durata dell’alleanza con la Germania nazista, senza
ascoltare i molteplici segnali d’allarme. Per questo l’attacco sferrato a tradimento il 21 giugno
1941 da Hitler coglie impreparata l’URSS, che perde in pochi mesi molti milioni di militari e di
civili, e gran parte dei suoi arsenali.
Ma la ferocia dell’oppressione nazista facilita la resistenza spontanea della popolazione e dei
soldati rimasti dispersi e senza ordini, sicché l’URSS assume il ruolo principale nella lotta al
nazifascismo. Gli alleati d’altra parte lasceranno sull’Unione sovietica il peso principale della
guerra, ritardando l’apertura di un secondo fronte. Speravano che Germania e URSS si
dissanguassero reciprocamente. Le colpe di Stalin verranno dimenticate quando la controffensiva
sovietica iniziata dopo la battaglia di Stalingrado porterà l’Armata Rossa nel cuore della Germania.
Una nuova spartizione del mondo assicurerà l’estensione del sistema sovietico a molti paesi
dell’Europa centro-orientale indipendentemente dalla volontà dei loro popoli, mentre come
contropartita i partiti comunisti collaboreranno a ristabilire l’ordine capitalista dalla Grecia alla
Francia, dall’Italia alle colonie britanniche e francesi. Sono i cosiddetti “Accordi di Yalta”. Per i
comunisti di tutto il mondo ciò sembra confermare la giustezza della politica di Stalin, ma
l’estensione del sistema sovietico a popolazioni che non lo volevano prepara le basi delle crisi
che si susseguiranno dal 1953 (Berlino Est), 1956 (Polonia e Ungheria), 1968 (Cecoslovacchia),
1970 e 1980 (Polonia).
L’unica eccezione alla spartizione dell’Europa è la Jugoslavia, che ha seguito una tattica diversa
e ha dimostrato che era possibile vincere senza che gli alleati, prostrati dalla guerra, potessero
intervenire, ma nessuno ne terrà conto, anche perché il partito comunista jugoslavo verrà presto
“scomunicato” e messo al bando come “fascista” per la sua indipendenza di giudizio.
In realtà, in un’altra parte del mondo, anche il Vietnam e la Cina seguono una strada
rivoluzionaria. Il partito comunista cinese, che si è rafforzato nel corso della guerra antigiapponese,
perché non ha ascoltato i consigli di Stalin e ha rifiutato di sciogliere la sua armata popolare, arriva
a liberare la Cina continentale nel 1949, e il partito comunista vietnamita, che ha tentato
inizialmente senza successo la strada della conciliazione con la Francia, riprende la lotta contro i
tentativi di riportarlo allo stato di colonia, e sconfigge l’esercito francese a Dien Bien Phu nel
1954, incoraggiando tutti i movimenti di liberazione nelle colonie e nei protettorati francesi, e in
particolare nell’Algeria, che arriverà all’indipendenza dopo una cruentissima guerra nel 1962.
Intanto nel 1953 in una piccola isola caraibica, Cuba, “giardino d’ingresso” agli Stati Uniti, un
giovane avvocato, Fidel Castro, ha sfidato il dittatore Batista iniziando una lotta che si concluderà
13
con una stupefacente vittoria il 2 gennaio 1959. Al gruppo iniziale si è unito un giovane medico
argentino, Ernesto Che Guevara, che è diventato un rivoluzionario in base all’esperienza vissuta nel
Guatemala, dove un modesto tentativo di riforma agraria del governo Arbenz è stato soffocato nel
1954 con un’invasione di mercenari, senza che il governo e lo stesso PC locale osassero armare le
masse. Quella di Cuba è la prima rivoluzione socialista in occidente, ed è stata portata alla vittoria
da una nuova avanguardia sorta al di fuori del partito comunista ufficiale, che ha invece
predicato prudenza e condannato “l’avventurismo” dei barbudos.
Nel 1956 la rivoluzione anticoloniale aveva ricevuto nuovo alimento dalla nazionalizzazione
della Compagnia del Canale di Suez effettuata da Nasser, e dalla resistenza egiziana all’aggressione
anglo-franco-israeliana.
Nel 1960 gran parte dei paesi dell’Africa (escluse le colonie portoghesi, che dovranno lottare
fino al 1975) ottengono l’indipendenza, spesso concessa improvvisamente senza nessuna
preparazione per poterla cancellare subito dopo, come nel Congo ex belga, che vede l’intervento dei
paracadutisti belgi (coperti poi dall’ONU) per deporre il legittimo capo del governo Patrice
Lumumba, assassinato dai mercenari nel 1961.
Per fronteggiare il pericolo di una “ricolonizzazione” dell’Africa che avrebbe dato ancora
qualche decennio di vita all’imperialismo, Ernesto Che Guevara tentò nel 1965 di fornire un aiuto
tecnico ai guerriglieri lumumbisti, ma dovette ritirarsi per l’inesistenza di una forza organizzata (i
dirigenti “acculturati” - tra cui l’attuale leader Laurent Kabila - con cui avrebbe dovuto organizzare
l’esercito dato che erano gli unici che parlavano francese, stavano tutti a godersi i finanziamenti dei
paesi “socialisti” negli alberghi di lusso all’estero). Il risultato è che il Congo, ribattezzato poi Zaire
da Mobutu, pur dotato di immense ricchezze naturali, è oggi uno dei paesi più poveri dell’Africa.
Nel 1967 Guevara, che non ha più da qualche anno fiducia nei paesi socialisti, che considera
“complici dell’imperialismo”, ha tentato di organizzare una scuola politico militare della
rivoluzione latinoamericana nella selva boliviana, ma viene abbandonato dal PCB che avrebbe
dovuto mantenere i contatti con il resto del paese. Rimasto isolato in una zona disabitata, adatta per
preparare quadri, ma non per la guerriglia, viene circondato, catturato e ucciso.
Il 1968 vede emergere in molti paesi una nuova avanguardia giovanile, studentesca ma anche
operaia, che si muove fuori dalle tattiche tradizionali, anche se con comprensibili errori dovuti
all’inesperienza. Dalla Francia al Messico, dall’Italia alla Polonia agli stessi Stati Uniti, si
sviluppano su tematiche diverse lotte senza precedenti da anni, mentre in Cecoslovacchia il più
interessante tentativo di autoriforma democratica portata avanti dal locale partito comunista viene
represso dai carri armati sovietici.
Le masse giovanili europee e mondiali sono polarizzate dalla critica maoista all’URSS, e
l’appoggio di Castro all’invasione della Cecoslovacchia fa declinare insieme al prestigio di Cuba
anche l’influenza di Guevara, che verrà dimenticato per anni, nonostante la lucidità con cui aveva
previsto il declino e crollo dell’URSS. Guevara aveva anche sollecitato un impegno maggiore di
tutto il movimento operaio e anche dei “paesi socialisti” nei confronti del Vietnam, che verrà
invece lasciato in una “tragica solitudine”. Gli Stati Uniti, sostanzialmente sconfitti nel Vietnam già
nel 1968, avranno il tempo di preparare la loro ritirata distruggendo il paese dalle fondamenta con
napalm e defolianti, in modo che quando nel 1975 lasceranno la penisola indocinese, questa sarà un
cumulo di rovine, che scoraggerà qualsiasi altra rivoluzione nell’area.
Il lento declino dei paesi che si autodefiniscono ormai del “socialismo reale” preparerà le
condizioni per i crolli del 1989 (Muro di Berlino, Cecoslovacchia, Romania, ecc.) e per la
dissoluzione dell’URSS. La rivoluzione sandinista in Nicaragua, che nel 1979 aveva suscitato
grandi speranze in America Latina, è stata soffocata e sospinta a scelte sbagliate dai suoi sostenitori
esterni e verrà sconfitta nelle elezioni nel 1990.
Tutto sembra perduto, si parla di “fine della storia”, di “mondo unipolare”, ma il 1° gennaio
1994, nel Chiapas, uno degli stati più poveri del Messico, un’insurrezione contadina e indigena
dimostrerà che “la storia non è finita”, e che un mondo basato sull’ingiustizia non può essere
stabile.
14