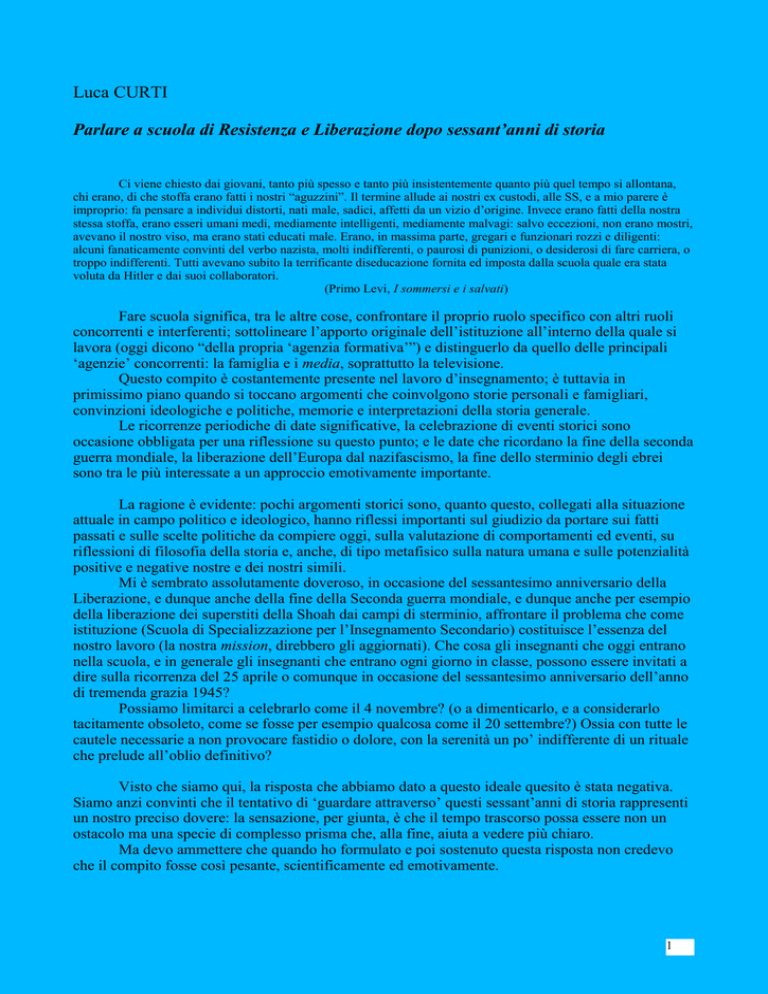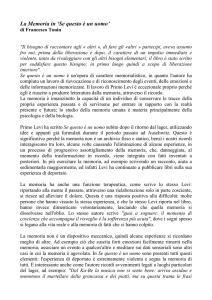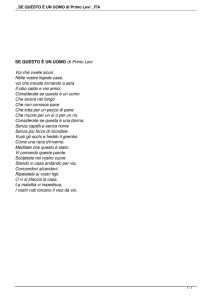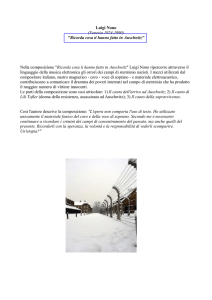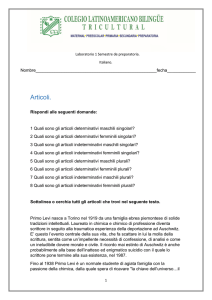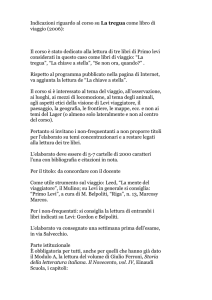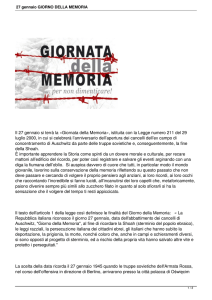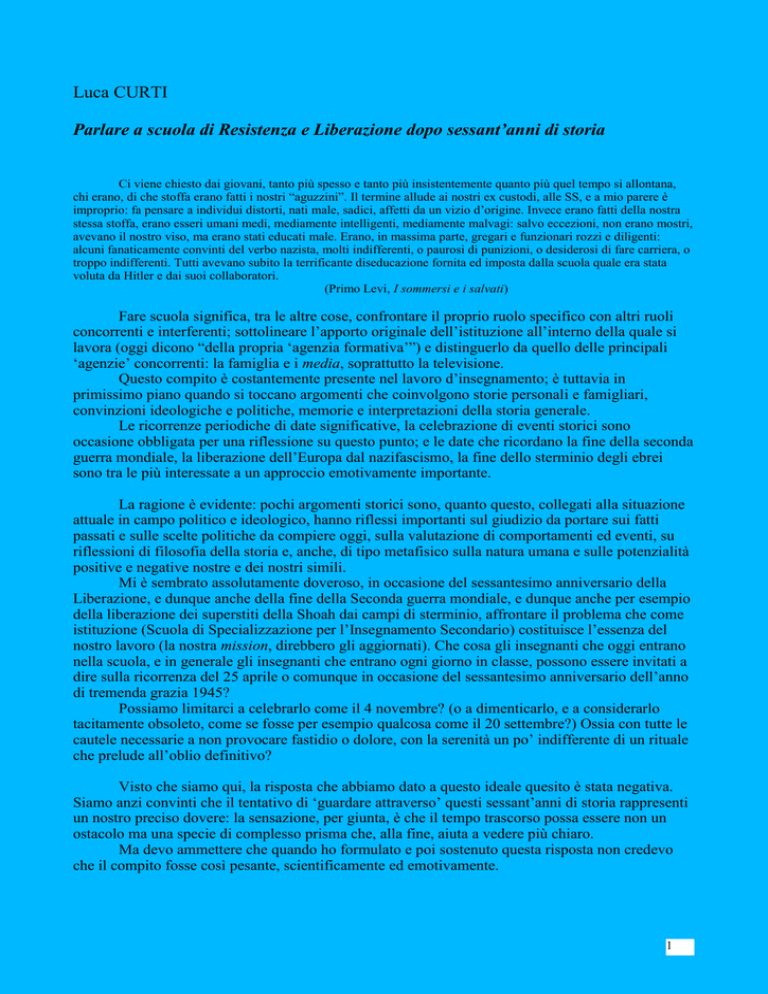
Luca CURTI
Parlare a scuola di Resistenza e Liberazione dopo sessant’anni di storia
Ci viene chiesto dai giovani, tanto più spesso e tanto più insistentemente quanto più quel tempo si allontana,
chi erano, di che stoffa erano fatti i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle SS, e a mio parere è
improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio d’origine. Invece erano fatti della nostra
stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri,
avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano, in massima parte, gregari e funzionari rozzi e diligenti:
alcuni fanaticamente convinti del verbo nazista, molti indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o
troppo indifferenti. Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata
voluta da Hitler e dai suoi collaboratori.
(Primo Levi, I sommersi e i salvati)
Fare scuola significa, tra le altre cose, confrontare il proprio ruolo specifico con altri ruoli
concorrenti e interferenti; sottolineare l’apporto originale dell’istituzione all’interno della quale si
lavora (oggi dicono “della propria ‘agenzia formativa’”) e distinguerlo da quello delle principali
‘agenzie’ concorrenti: la famiglia e i media, soprattutto la televisione.
Questo compito è costantemente presente nel lavoro d’insegnamento; è tuttavia in
primissimo piano quando si toccano argomenti che coinvolgono storie personali e famigliari,
convinzioni ideologiche e politiche, memorie e interpretazioni della storia generale.
Le ricorrenze periodiche di date significative, la celebrazione di eventi storici sono
occasione obbligata per una riflessione su questo punto; e le date che ricordano la fine della seconda
guerra mondiale, la liberazione dell’Europa dal nazifascismo, la fine dello sterminio degli ebrei
sono tra le più interessate a un approccio emotivamente importante.
La ragione è evidente: pochi argomenti storici sono, quanto questo, collegati alla situazione
attuale in campo politico e ideologico, hanno riflessi importanti sul giudizio da portare sui fatti
passati e sulle scelte politiche da compiere oggi, sulla valutazione di comportamenti ed eventi, su
riflessioni di filosofia della storia e, anche, di tipo metafisico sulla natura umana e sulle potenzialità
positive e negative nostre e dei nostri simili.
Mi è sembrato assolutamente doveroso, in occasione del sessantesimo anniversario della
Liberazione, e dunque anche della fine della Seconda guerra mondiale, e dunque anche per esempio
della liberazione dei superstiti della Shoah dai campi di sterminio, affrontare il problema che come
istituzione (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) costituisce l’essenza del
nostro lavoro (la nostra mission, direbbero gli aggiornati). Che cosa gli insegnanti che oggi entrano
nella scuola, e in generale gli insegnanti che entrano ogni giorno in classe, possono essere invitati a
dire sulla ricorrenza del 25 aprile o comunque in occasione del sessantesimo anniversario dell’anno
di tremenda grazia 1945?
Possiamo limitarci a celebrarlo come il 4 novembre? (o a dimenticarlo, e a considerarlo
tacitamente obsoleto, come se fosse per esempio qualcosa come il 20 settembre?) Ossia con tutte le
cautele necessarie a non provocare fastidio o dolore, con la serenità un po’ indifferente di un rituale
che prelude all’oblio definitivo?
Visto che siamo qui, la risposta che abbiamo dato a questo ideale quesito è stata negativa.
Siamo anzi convinti che il tentativo di ‘guardare attraverso’ questi sessant’anni di storia rappresenti
un nostro preciso dovere: la sensazione, per giunta, è che il tempo trascorso possa essere non un
ostacolo ma una specie di complesso prisma che, alla fine, aiuta a vedere più chiaro.
Ma devo ammettere che quando ho formulato e poi sostenuto questa risposta non credevo
che il compito fosse così pesante, scientificamente ed emotivamente.
1
Primo Levi e il bambino saputo
L’episodio è noto, e lo riporto nella versione più spoglia che ne dà una recente biografa di
Primo Levi, Myriam Anissimov:
I giovani, senza aver letto Faurisson e Nolte, dubitano della realtà, di quello che gli racconta Levi, il superstite.
Non ci credono, semplicemente perché i giornali, la televisione, li hanno abituati a pensare che tutto può essere
fantasmagorico. Hanno visto gli stessi autori protagonisti in Olocausto e in una serie dedicata a Re Artù, per esempio.
Levi ha raccontato la storia – nello stesso momento deliziosa, esilarante e terrificante, di un bambino di una scuola dove
era andato a spiegare cosa erano stati i campi nazisti, il quale gli aveva esposto, nel modo più serio del mondo, come
avrebbe dovuto comportarsi per evadere, impegnandosi a non dimenticare le sue raccomandazioni nel caso in cui si
fosse presentata di nuovo la stessa situazione.1
L’incredulità è stato uno degli ostacoli più crudeli di fronte ai quali si siano trovati gli
scampati dai campi di sterminio. Chi ha letto i libri di Levi non ha bisogno di ulteriori rimandi.
Recentemente è tornata sull’argomento Simone Veil, in una testimonianza che è resa
particolarmente toccante dall’allusione al tempo presente, a sessant’anni di distanza dai fatti:
“Non valeva neanche la pena di provare a parlare: ci interrompevano subito! Cambiavano argomento. […] E
per i nostri cari era troppo doloroso parlare di quelle cose. Noi raccontavamo delle cose spaventose, loro vedevano in
che stato eravamo tornate: per loro, che ci amavano, era insopportabile. E lo è ancora oggi, peraltro, sessant’anni dopo.
Una mia cognata è stata deportata anche lei, quando vogliamo parlarne ci vediamo da sole”.2
Non commettiamo l’errore di credere che il rischio sia cancellato, sessant’anni dopo gli
eventi: è senz’altro più forte. Soltanto dando conto criticamente di tutta questa storia saremo
credibili, e non correremo il rischio di essere ascoltati con sufficienza, per condiscendenza, come
chi racconti la favola dell’orco (magari con la buona intenzione di spingere i ragazzi alla
democrazia).
Gita ad Auschwitz
Abbiamo preso la coincidenza per Auschwitz come tre teddy boys fuori tempo massimo rispetto a se stessi.
[…] A un certo punto scendiamo per proseguire a piedi. Accanto ai binari c’è un sentiero sassoso diviso in due dalla
striscia d’erba. Percorrendolo ho avuto l’impressione di essere finalmente giunto dove volevo. Come sapevano i greci,
si scopre solo quello che già conosciamo, si parte sempre per ritornare. Raccogliamo il testimone di chi ci ha preceduto
facendo sì che l’illusione del senso non vada smarrita. Sul terriccio dove è morto un uomo, dopo gli insetti, arrivano
croci, scarpe, stivali, si pronunciano nuove parole. Qualcuno getta via le sagome storte per rifare altre formazioni, nuovi
schieramenti.
(Eraldo Affinati, Campo del sangue)
Avevo dodici anni quando, per la prima volta, vidi le immagini dei campi di sterminio
nazisti: in un volumetto edito da Feltrinelli in economica, Il flagello della svastica, autore Lord
Russel.
Fu mio padre a consigliarmene l’acquisto: ricordo il dettaglio perché in qualche modo può
servire a retrodatare la sensibilizzazione dell’opinione pubblica al problema. Era l’anno 1960. Il
sentimento fondamentale, non solo mio, di fronte a quelle immagini fu di sbigottimento. Vivevo
allora nella mia città d’origine, Reggio Emilia. Mio padre era un ‘comunista democratico’: nel ’56,
dopo il ‘ventesimo congresso’, aveva approvato la denuncia antistalinista di Krusciov ed era un
convinto sostenitore della sua linea. Conservava però, in una cartellina di cartone, le copie
dell’Unità listate a lutto per la morte di Stalin (1953); lo considerava il principale vincitore della
guerra in Europa (sono sicuro che ancora oggi, se potesse leggere queste mie righe, mi inviterebbe a
ricordare che la battaglia decisiva, quella che spezzò lo slancio delle armate di Hitler, fu l’infernale
battaglia che si combattè in una città che oggi porta l’anodino nome di Volgograd ma che allora si
1
MYRIAM ANISSIMOV, Primo Levi o La tragedia di un ottimista (1996), trad. it. Milano, Baldini & Castaldi 1999,
p. 604.
2 AGATHE LOGEART, Simone Veil: noi scampati uccisi due volte, “La Repubblica”, 16 gennaio 2005, pp. 26-27.
2
chiamava, e che la storia dovrà chiamare per sempre, Stalingrado); e certamente non immaginava
neppure, nel fondo dei suoi incubi più neri, la realtà dei gulag e delle deportazioni in Siberia con le
caratteristiche che, non molto tempo dopo, si sarebbero imposte alla coscienza di tutti.
E’ bene che i ragazzi (e non solo loro, ma noi cominciamo da loro) sappiano che i lager sono
fisicamente esistiti, e che ne possano osservare i resti materiali. Ma il compito degli educatori non
può fermarsi qui.
Leggo su “Le Monde” del 18 gennaio scorso questo titolo: “Le sanzioni prese contro due
liceali di Montreuil dopo un viaggio ad Auschwitz sono esaminate in appello”. Traduco e sintetizzo.
L’affare comincia mercoledì 24 novembre 2004; c’è un viaggio ad Auschwitz di circa 150
studenti dei licei dell’Ile de France. Un gruppetto di studenti del liceo Jean Jaurès si fa notare per il
suo comportamento; al ritorno i professori chiedono sanzioni. Secondo alcuni, i ragazzi hanno corso
per il campo e sulla rampa dei deportati, si sono abbandonati a una battaglia di palle di neve e hanno
preso fotografie choccanti (una ragazza si è fatta fotografare con la sciarpa in testa davnti a una
vetrina che presentava gli scialli da preghiera ebraici, i talleth.” Secondo altri, uno degli studenti
avrebbe detto la frase “hanno fatto bene a bruciarli”; l’interessato dice che non sa se ha detto
veramente la frase, la sua famiglia si dichiara “distrutta”, i suoi compagni di classe producono una
testimonianza scritta che esclude che il ragazzo sia, o sia mai stato, antisemita…
Difficile esprimere un giudizio sereno e compiuto; i francesi hanno preso la cosa molto
seriamente, certo è deplorevole l’accaduto…
Difficile anche non concludere che portare i giovani sui luoghi della memoria è certo
importante ma non è detto che sia di per sé sufficiente. Scrive, in un suo comunicato, la Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme:
studenti sempre più giovani e mal preparati sono condotti su quei luoghi che esigono da ciascuno una fase
importante sia intellettuale che psicologica. Abbiamo oggi il diritto di temere che tali viaggi siano controproducenti.
La polemica cresce.3
I buoni e i cattivi
Uno dei problemi più elementari (nel senso di ‘basilari’) da affrontare oggi in una classe,
parlando di Resistenza e Liberazione, è certamente posto dalla dislocazione di un grande numero di
persone, nazioni, entità varie rispetto al punto nel quale il nostro lavoro di rievocazione le colloca.
Tutti i ragazzi (quelli almeno dotati di maturità sufficiente per affrontare l’argomento) sanno
che poche settimane fa è stata firmata, a Roma, una Costituzione europea; e tra i Paesi che hanno
aderito ci sono la Francia, la Germania, la Polonia… A scuola verosimilmente è stato fatto qualche
cenno all’evento ma, di certo, ne hanno larghissimamente parlato i media, con dirette tv altamente
spettacolari e solenni. In prossimità del 25 aprile, invece, il quadro che sarà obbligatoriamente
rievocato appare totalmente sconvolto: la Germania, sotto la guida di Hitler, è la nazione demoniaca
che ha invaso la Polonia e la Francia, seminando devastazione e strage; la Francia, piegata al primo
urto e anch’essa invasa, viene retta per molto tempo da un governo collaborazionista, cioè filonazista, che si fa complice perfino della deportazione degli ebrei francesi nei campi di sterminio.
Come ridurre tutto questo ad una dimensione anche di pura e semplice comprensibilità?
3
MARTINE LARONCHE, Les sanctions décidées contre deux lycéens de Montreuil après un voyage à Auschwitz sont
examinées en appel, “ Le Monde ”, 18 gennaio 2005, p. 11.
3
Stalin, per esempio
Recentemente un sondaggio di incerta fonte ma assolutamente credibile ha stabilito che per i
giovani italiani di media cultura Stalin è stato un tiranno assassino peggiore dello stesso Hitler. Non
è difficile individuare le radici di questo giudizio: sono le informazioni sempre più dettagliate che
dagli archivi dell’ex - Unione Sovietica confermano le voci sugli inauditi crimini staliniani contro la
popolazione civile e contro tutti gli oppositori, individuati anche all’interno dello stesso partito
comunista; sono, risalendo il corso della storia, gli esiti della frattura violentissima provocata dal
tentativo di Gorbaciov di ‘aprire’ all’esterno la Russia sovietica sconfessando, per esempio, la
politica staliniana nei confronti delle repubbliche baltiche; e ancora prima la spinta, sempre più
forte, del dissenso interno che ebbe come punta di lancia il narratore dei gulag, Soljenitsin; e
all’origine fu certamente la prima ‘de-stalinizzazione’ avviata da Krusciov al ventesimo congresso
del PCUS. Era il 1956: Stalin era morto da tre anni, la guerra era finita da undici.
Qualche anno prima in Europa si combatteva la seconda guerra mondiale; al suo interno, la
Resistenza. Sulla Resistenza ha scritto un libro magnifico lo storico Claudio Pavone. Discorrendo
della scelta che portò molti italiani a combattere nei fronti nemici della guerra civile, e del
giuramento fatto alle opposte bandiere, Pavone riferisce un suo personale ricordo:
L’onore cui fanno appello i militari […] è certo qualcosa di diverso dal moto che doveva attraversare l’animo
del sedicenne Walter Atti quando, mentre dal carcere di Castelfranco Emilia veniva condotto alla fucilazione, salutava
con queste parole: “Mi portano al muro perché ho giurato fedeltà a Stalin” 4
Benché non sia facile ammetterlo, si tratta dello stesso Stalin.
Non possiamo (infamia a parte) considerare Walter Atti un ragazzo ingenuo che aveva
creduto alla propaganda: è invece certamente uno dei giovani padri della nostra libertà democratica
e combattè fino alla morte perché dalla lotta uscissero vincitrici la libertà di pensiero, di stampa, di
opinione i valori fondanti della modernità il liberalismo economico la religione della libertà
individuale.
Tutte cose di cui Stalin si faceva certamente le più sincere beffe, se pure non le considerava
entità nemiche, e per le quali tuttavia combatteva, sia direttamente sia attraverso militanti eroici e
devoti come Walter Atti, e dando anzi un contributo decisivo al loro trionfo.
La liberazione di Auschwitz
Per chi ha visto il film di Francesco Rosi, La tregua, l’immagine della liberazione del campo
di sterminio di Auschwitz è indimenticabile: i cavalieri sovietici, colbacco e stella rossa, che nella
luce gelida del mattino legano una fune al cancello principale del lager e lo abbattono.
L’immagine deriva abbastanza fedelmente dal testo di Primo Levi che porta lo stesso titolo:
La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fummo Charles
e io i primi a scorgerla: stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Sòmogyi, il primo dei morti fra i nostri
compagni di camera. Rovesciammo la barella sulla neve corrotta, ché la fossa era ormai piena, ed altra sepoltura non si
dava: Charles si tolse il berretto, a salutare i vivi e i morti.
Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la
strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide
[…]. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi (la strada era più alta del campo) sui loro enormi cavalli, fra
il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo.
[...] quattro uomini armati, ma non armati contro di noi; quattro messaggeri di pace, dai visi rozzi e puerili sotto i
pesanti caschi di pelo.5
Nessun problema vero, a prima vista. Solo che le cose non andarono così. Nell’inserto
domenicale della “Repubblica”6 del 16 gennaio 2005 possiamo leggere il racconto di uno dei pochi
4
CLAUDIO PAVONE, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri
1991, p. 56.
5 PRIMO LEVI, La tregua, Torino, Einaudi 1993, pp. 157-158.
4
testimoni oculari ancora in vita: si chiama Yakov Vincenko, ha 79 anni. Raggiunse il campo di
sterminio con la divisione di fanteria dell’Armata Rossa numero 322, Fronte ucraino. Aveva 19
anni.
“Ho passato il primo filo spinato alle 5 di mattina - racconta -: era buio, sabato 27 gennaio 1945. Non era
gelido, solo tracce di neve marcia. La sera prima, nella notte, il combattimento aveva preteso molte vite. Temevo i
cecchini lasciati di guardia. Al riparo di un bidone ho visto il maggiore Shapiro, un ebreo russo del gruppo d’assalto
della centesima divisione, spalancare un grande cancello. Dall’altra parte un gruppo di vecchi minuti, ma erano
bambini, ci ha sorriso”. Solo dopo anni ha appreso di avere assistito allo schiudersi dell’ingresso dell’inferno, sotto la
scritta ‘Arbeit macht frei’. “Mi sono alzato per avanzare. Ho guardato nel bidone: era colmo di cenere, emergevano
frammenti di ossa. Non ho capito che erano resti di chi era stato là dentro” 7
E’ semplice osservare le differenze tra le versioni, e non è certo inutile notare che la
memoria di Levi si riferisce non ad Auschwitz ma alla ‘dipendenza’ di Buna-Monowitz; e anche
che la letteratura – come il cinema - ha un obbligo, semmai, di fedeltà emotiva alla cronaca, non
certo di fedeltà letterale, ecc.
Forse, tuttavia, è più interessante osservare, anziché le differenze, gli elementi che sono
comuni a tutti questi racconti. A partire da quello fondamentale, che è il ruolo dell’Armata Rossa.
Questo ruolo è storicamente definito: ora abbiamo anzi appena letto una testimonianza personale di
uno che ‘c’era’. Ma il ruolo dell’esercito ‘comunista’ era da tempo, e rimase a lungo, coronato di
una significazione simbolica che eccedeva di molto la realtà dei fatti. Questo (solo questo) spiega il
tono della ricostruzione fatta da Levi; e a sua volta Levi come fonte non spiega tutto quello che c’è
nel film di Rosi, girato ancora molto tempo dopo, quando tutto si era consumato, illusioni e
prospettive, e restava la nostalgia per ciò che una volta era stata una speranza, e il desiderio di
rievocare il ruolo glorioso della stella rossa, dell’esercito del popolo, dei vincitori di Hitler e
liberatori degli schiavi di ogni genere.
Ho parlato prima di mio padre e del suo contributo alla conoscenza della Shoah da parte
mia. Ho pochi dubbi sul fatto che considerasse la liberazione di Auschwitz come una gloria
dell’Armata Rossa, e anzi una gloria per così dire ovvia, in quanto era un ovvio dovere, per
l’Unione Sovietica, quello di ripristinare anche ad Auschwitz la dignità umana così bestialmente
schiacciata. Ma assai più probante è l’opinione di Primo Levi, non solo quella ‘implicita’ che
emerge dal racconto della liberazione del campo di sterminio ma anche quella esplicita da lui
affidata all’Appendice di Se questo è un uomo, stesa nel 1976 e non più smentita.
In questo testo Levi risponde a domande da lui stesso formulate ma tali da rappresentare una
sintesi di quelle che più frequentemente si sentiva rivolgere, nelle scuole, da studenti e insegnanti ai
quali era invitato a illustrare la propria testimonianza. Alla domanda “Perché Lei parla soltanto dei
Lager tedeschi, e non anche di quelli russi?”, Levi rispondeva, tra l’altro, così:
non parlo generalmente dei Lager russi: per mia fortuna non ci sono stato, e non potrei che ripetere le cose che
ho letto, cioè quelle che sanno tutti coloro che a questo argomento si sono interessati. E’ chiaro che tuttavia con questo
non voglio né posso sottrarmi al dovere, che ha ogni uomo, di farsi un giudizio e di formulare un’opinione. Accanto ad
evidenti somiglianze, fra i Lager sovietici e i Lager nazisti mi pare di poter osservare sostanziali differenze.
La principale differenza consiste nella finalità. […] In questo lugubre confronto fra due modelli di inferno
bisogna ancora aggiungere che nei Lager tedeschi, in generale, si entrava per non uscirne: non era previsto alcun
termine altro che la morte. Per contro, nei campi sovietici un termine è sempre esistito: al tempo di Stalin i ‘colpevoli’
venivano talvolta condannati a pene lunghissime (anche quindici o venti anni) con spaventosa leggerezza, ma una sia
pur lieve speranza di libertà sussisteva. [---] i campi sovietici rimangono pur sempre una manifestazione colpevole di
illegalità e di disumanità. Essi non hanno nulla a che vedere col socialismo, ed anzi, sul socialismo sovietico spiccano
6
Mi capiterà ancora di citare articoli e contributi dai giornali che leggo più abitualmente: chi legga altri giornali
utilizzerà altre fonti, e darà con ciò stesso un utilissimo contributo all’approfondimento di una prospettiva critica sui
fatti e sulle opinioni.
7 GIAMPAOLO VISETTI, “La notte che ho liberato Auschwitz”. Il 27 gennaio del 1945 il soldato dell’Armata Rossa
Yakov Vincendo spalanca il portone con la scritta ‘Arbeit macht frei’ e scopre l’orrore. Ecco il suo racconto e le
testimonianze dei sopravvissuti, “La Repubblica”, 16 gennaio 2005, pp. 25-27. Tutta la testimonianza di Vincenko è
straordinariamente interessante sotto diversi profili, ivi compreso quello delle sue personali vicende nel periodo di
guerra che precede questo episodio conclusivo.
5
come una brutta macchia […] Ma è possibile, anzi facile, rappresentarci un socialismo senza Lager: in molte parti del
mondo è stato realizzato. Un nazismo senza Lager invece non è pensabile. 8
Non è facile commentare serenamente, dalla posizione nella quale ci troviamo oggi, un testo
come questo, dove convivono quelle che ancora appaiono come brucianti verità e quelle che ormai
sappiamo essere niente altro che disperate illusioni. Possiamo solo prendere atto, ed è nostro dovere
farlo, del ‘punto’ (punto nautico, sul mare della storia) nel quale questo testo si situa.
Nel 1976 erano passati vent’anni da quando Krusciov aveva denunciato i crimini di Stalin,
trentuno dalla liberazione di Auschwitz; da otto anni era attivo, almeno nel ricordo, lo spirito di
quella che era stata la rivolta ‘del Sessantotto’, che aveva visto il sistema sovietico contestato (in
nome del socialismo!) dai giovani di mezza Europa e che nell’Est europeo aveva conosciuto la
‘primavera di Praga’, il ‘socialismo dal volto umano’, la restaurazione imposta con la forza dai carri
armati del Patto di Varsavia… Ebbene, a quel punto della nostra storia, un uomo della levatura
morale e intellettuale di Primo Levi sperava ancora nel socialismo.
Perché dovremmo dubitare delle motivazioni che, più di trent’anni prima, avevano guidato
la scelta di ‘fedeltà a Stalin’ del sedicenne Walter Atti con tanta forza da accompagnarlo fino alla
morte?
Il fenomeno (diciamo così, per sdrammatizzare) non interessa solo la Germania nazista e
Stalin, ossia il comunismo, ma anche gli eredi del fascismo italiano che hanno rinnegato il regime e
le leggi anti-ebraiche, il Giappone dell’attacco a Pearl Harbour e dei massacri in Cina, la Spagna
della Guerra civile e poi della transizione democratica e ora nella Comunità europea…
Come è possibile reagire a questa che ho chiamato dislocazione, a questa ridistribuzione di
forze e valori sullo scacchiere della politica e della storia? Forse non è facile trovare una risposta,
ma credo che trovarla sia necessario: perché, ancora e d’altronde, come è possibile illudersi che
senza neppure accennare a questo fenomeno si possa parlare, ai ragazzi di oggi a proposito di quella
storia, un linguaggio che abbia un minimo di senso?
Anche perché, come usa dire, la storia va avanti e accadono fatti nuovi, o almeno si
riscoprono vecchie verità che appaiono, nel nuovo tempo, in una luce mai vista.
La memoria dei vinti (i tedeschi, gli italiani...)
E’ molto recente la pubblicazione in traduzione italiana di un libro di W.G. Sebald intitolato
Storia naturale della distruzione 9. Si tratta di un libro impressionante che racconta i
bombardamenti alleati sulla Germania, nell’ultima parte della Seconda guerra mondiale, dal punto
di vista e con le testimonianza di chi li subì, cioè della popolazione civile tedesca.
C’è davvero l’imbarazzo della scelta, all’interno dell’orrore. Scelgo il resoconto della
‘tempesta di fuoco’ su Amburgo, luglio 1943. E’ stato leggendo questo libro che ho imparato che
questa espressione può essere usata in un preciso senso ‘tecnico’.
La cosa andò così. I bombardieri anglo-americani scatenarono l’attacco all’una di notte:
Seguendo una tecnica già sperimentata, in primo luogo si scardinarono e si distrussero tutte le porte e le
finestre mediante bombe dirompenti da poco meno di due tonnellate l’una, quindi con piccoli ordigni incendiari si
appiccò il fuoco ai solai, mentre in contemporanea bombe incendiarie capaci di raggiungere i quindici chilogrammi
penetravano fin nei sotterranei. Nel giro di pochi minuti, sui circa venti chilometri quadrati dell’area attaccata,
scoppiarono ovunque giganteschi incendi e si propagarono così rapidamente che, già un quarto d’ora dopo la caduta
delle prime bombe, l’intero spazio aereo divenne – a perdita d’occhio – un unico mare di fiamme. E in capo ad altri
cinque minuti, all’una e venti, si scatenò una tempesta di fuoco così intensa che nessuno mai, fino a quel giorno,
l’avrebbe creduta possibile. Il fuoco, levandosi nel cielo in vampe alte duemila metri, attirava a sé l’ossigeno con una
violenza tale che le correnti d’aria raggiunsero la forza di uragani e rintronarono come poderosi organi nei quali fossero
stati tirati all’unisono tutti i registri. L’incendio continuò così per tre ore. Giunta al culmine, la tempesta prese a
PRIMO LEVI, Se questo è un uomo – La tregua, Torino, Einaudi 1993 (Einaudi Tascabili Letteratura, 2), pp. 339-40.
W. G. SEBALD, Storia naturale della distruzione, Milano, Adelphi 2004 (titolo originale: Luftkrieg und Literatur,
“Guerra aerea e letteratura”, 2001; la traduzione italiana è di Ada Vigliani).
8
9
6
sollevare i cornicioni e i tetti delle case, fece mulinare nell’aria travi e intere file di pannelli pubblicitari, sradicò alberi e
trascinò con sé esseri umani trasformati in fiaccole viventi. Dietro le facciate che crollavano, lingue di fuoco alte come
palazzi salivano al cielo: simili a una mareggiata, si riversavano nelle strade a una velocità di oltre centocinquanta
chilometri all’ora, come rulli di fuoco rotolavano con ritmo anomalo su piazze e luoghi aperti 10
Nessuno, ancora oggi, sa quante persone furono annientate in quel rogo immane. Resta il
ricordo di episodi che a stento si osa riferire. Ne cito uno solo:
In una cantina a prova di bomba un gruppo di persone finisce per cuocere vivo, in quanto le porte si sono
bloccate e nei locali adiacenti le riserve di carbone hanno preso fuoco. “Le pareti scottavano e tutti avevano cercato
rifugio al centro della stanza. Li ritrovarono lì, stretti l’uno contro l’altro, gonfiati dal calore” 11
La lettura di questo libro, oltre allo sbigottimento per il contenuto dell’informazione, suscita
una strana emozione, emozione mista; tra un senso di novità e, per chi ha la mia età (sono nato nel
1948) una sensazione di già confusamente noto.
Quest’ultimo dato è il più semplice da chiarire. Quando io sono nato la guerra era già finita
ma il suo ricordo era drammaticamente vivo. Passeggiando coi miei parenti, nella città qua e là
ingombra di macerie e coi muri che portavano ancora, molto ben definita, la scritta bianca
“Rifugio” (con relative frecce direzionali), era naturale chiedere e ascoltare spiegazioni e racconti.
Nel ricordo, erano racconti non troppo drammatici, piuttosto inclinanti al grottesco quando mi si
raccontava di quella casa che alla vista sembrava ancora intatta, e invece, oltre la facciata esterna,
tutto si era dissolto nello spazio di una notte; o della incredibile potenza delle bombe d’aereo che
uccidevano col solo spostamento d’aria, al punto che di una persona, scagliata contro una rete
metallica, era rimasto il solo contorno formato dai resti del suo corpo che era, maggioritariamente,
‘passato di là’.
E ora, a distanza di tanto tempo, credo di capire la ragione di questa curiosa ‘leggerezza’
(dove si potrebbe pensare che fosse invece facile evocare in me l’orrore e la compassione): era
l’impossibilità di rispondere al quesito, troppo complesso, su come mai un tale orrore si fosse
scatenato contro di noi e come mai quegli spaventosi assassini di massa fossero, in realtà, i nostri
amici inglesi e americani.
Di fronte a un libro come questo di Sebald sono stato infatti costretto a riflettere anche su un
altro dato. L’autore, oltre che dalla violenza dei fatti descritti, è turbato da un quesito che gli appare
insolubile: come è stato possibile tacere su tutto ciò per tanto tempo? perché le testimonianze su
queste indicibili sofferenze sono così rare e quasi semiclandestine, prodotte da autori
anticonformisti e coraggiosi?
La ragione e il torto
L’atteggiamento stilistico scelto da Sebald vuole essere quello di un cronista non coinvolto o
addirittura quello di un naturalista impassibile. E tuttavia spesso, come quando parla delle
motivazioni che spingevano ad agire Sir Arthur Harris, capo del Bomber Command della RAF (un
uomo che “credeva nella distruzione per la distruzione”) l’indignazione lo prende:
una simile offensiva aerea […] possedeva a tal punto una sua dinamica interna da escludere in pratica
restrizioni e aggiustamenti di tiro a breve termine […] Abbandonare lì, inutilizzati, sui campi d’aviazione
dell’Inghilterra orientale, i materiali ormai prodotti, ovvero gli aerei con il loro carico prezioso, era un’idea cui si
ribellava il sano istinto economico.12
E a questo punto devo dare conto di un’altra mia reazione, questa volta di innegabile fastidio
e anzi irritazione di fronte a questi ‘lamenti’: ma non se la sono voluta? (e anche, riferendomi a noi,
noi italiani, i miei parenti e la mia città bombardata: non ce la siamo voluta?).
SEBALD, Storia naturale…, pp. 37-8.
SEBALD, Soria naturale…, p. 59.
12 SEBALD, Storia naturale…, pp. 29-30.
10
11
7
Credo di essere riuscito a razionalizzare questa mia reazione e a studiare una virtuale
‘composizione’. Sì che se la sono (che ce la siamo) voluta, ma la pretesa che ‘lascino perdere’ con
le ‘lamentele’ deriva da un pensiero che è l’anticamera dell’oblio: il pensiero che la Germania
democratica di oggi e la Germania nazista siano due cose radicalmente diverse (passo primo) e che
quella che esiste veramente è quella di oggi (passo secondo) e che forse quella di ieri non è mai
veramente esistita (passo terzo e ultimo).
E allora possiamo provare a rispondere al quesito che inquieta Sebald (e anche noi): perché
per tanto tempo si è taciuto? E anche all’altro quesito complementare, che viene spontaneo
associargli: perché in questo momento il divieto e rievocare queste pagine appare cancellato?
La risposta mi pare questa: i tedeschi, i miei parenti, tutti hanno taciuto finché è stato
possibile considerare quella storia come qualcosa che riguardava solo il passato.
Nel passato, la Germania era stata sconfitta e per giunta era colpevole di avere scatenato la
guerra e gli orrori che l’accompagnarono: da essa bisognava prendere le distanze, e potevamo farlo
perché non ci riguardava, era una storia ‘separata’
Ora che la Germania e l’Inghilterra e la Francia, e noi, siamo diventati (o desideriamo
diventare, o siamo avviati a diventare) un ‘paese’ solo (l'Europa, con la sua moneta e la sua
Costituzione) dobbiamo fare i conti con tutta la nostra storia.
Per avviarci su basi serie verso una storia unitaria non possiamo continuare a pensare che
alcuni di noi sono buoni e altri sono mostri.
La Germania è una sola, è quella che contro tutti ha seguito Hitler e che ora, con noi, ha
sottoscritto la Costituzione europea.
La dislocazione va ‘ridotta’, ossia spiegata con la massima trasparenza.
E il solo modo per ‘ridurla’ è farne correttamente la storia, tutta, non solo quella dei
vincitori.
Naturalmente, raccontare tutta la storia non può voler dire riscriverla a piacere,
modificandone il senso. Se il libro di Sebald tendesse a questo scopo non rivestirebbe per noi
interesse alcuno. Invece su questo punto l’autore è estremamente limpido anche se, abile scrittore,
aspetta la pagina finale per chiarire la sua posizione. Il libro si conclude così:
La maggioranza dei tedeschi oggi sa – almeno si spera – che fummo proprio noi a provocare la distruzione
delle città nelle quali vivevamo allora. Oggi quasi più nessuno dubiterebbe che, se le sue risorse tecniche glielo avessero
permesso, il maresciallo Goering avrebbe raso al suolo Londra. Speer riferisce che nel 1940, durante una cena alla
cancelleria del Reich, Hitler diede libero sfogo alle sue fantasie su una completa distruzione della capitale dell’Impero
britannico: “- Ha mai dato uno sguardo a una carta di Londra? Le case sono così fitte che basterebbe il focolaio di un
solo incendio per distruggere l’intera città, come già è accaduto duecento anni fa […] Questa di Goering è l’unica idea
giusta, le bombe dirompenti non servono, ma con le bombe incendiarie lo si può invece fare: distruggere totalmente
Londra! […]”. L’ebbrezza prodotta da questa visione devastante è tutt’uno con il fatto che anche le operazioni
pionieristiche compiute nell’ambito della guerra aerea - Guernica, Varsavia, Belgrado, Rotterdam – vanno ascritte ai
tedeschi. E nel pensare alle notti di fuoco a Colonia, ad Amburgo e a Dresda, dovremmo anche ricordarci che già
nell’agosto del 1942 – quando la Wehrmacht, con le avanguardie della sesta armata, aveva raggiunto il Volga e non
pochi fra i soldati fantasticavano del tempo in cui, finita la guerra, si sarebbero stabiliti in una tenuta di campagna con
un bel giardino di ciliegi sulle rive del placido Don – la città di Stalingrado, in quei giorni traboccante di profughi come
più tardi Dresda, veniva bombardata da milleduecento aviatori e che, durante quell’attacco capace di suscitare
sentimenti di giubilo fra le truppe tedesche attestate sull’altra sponda, quarantamila persone persero la vita.13
Sebald, i pochi autori che lo hanno preceduto (Boell e Enzensberger, tra gli altri), i
sopravvissuti che ora ricordano, non pretendono minimamente di avere o di avere avuto ‘ragione’
sul piano politico, o meno ancora su quello ideologico.
SEBALD, Storia naturale…, pp. 103-4. E riporto qui un’opinione di Joachim Fest, storico di sentimenti
moderatamente ‘revisionisti’:
“I neonazisti paragonano la Shoah all’ ‘Olocausto delle bombe alleate’. Che ne dice?
“Folle e fuorviante, stupidi slogan. Moralmente si possono avere molte difficoltà a definire precisamente le
differenze. Ma la discriminante è politica: furono i tedeschi a cominciare la guerra, a seguire Hitler su quella strada e
quindi a pagarne poi le conseguenze. Quegli orribili bombardamenti non nacquero dal nulla, ma dal sì di molti, troppi
tedeschi alla guerra di Hitler” (da un’intervista a Joachim Fest, “La Repubblica” 9 febbraio 2005).
13
8
Affermano soltanto che il loro debito, per quanto era in loro potere di fare, è stato pagato.
Chiedono, da concittadini, pari dignità per la loro sofferenza.
Willy Brandt
La Germania è una sola, e la sua storia è molto complessa.
La vita di un tedesco piuttosto straordinario, come d’altronde molti tedeschi nel tempo, aiuta
a capire. Si chiamava Herbert Frahm, era nato a Lubecca nel 1913. Educato dal nonno paterno agli
ideali socialisti, fuggì in Danimarca nel 1933, all’avvento di Hitler; assunse il nome di battaglia di
Willy Brandt e continuò fino alla fine della guerra, dai paesi scandinavi dove a lungo risiedette, la
sua opposizione al nazismo. Poi rientrò in patria e si impegnò nella politica attiva nelle file della
socialdemocrazia. Divenne universalmente noto come borgomastro di Berlino Ovest, nel 1961
condannò la costruzione del Muro che tagliava in due la città.
Nel 1969 è cancelliere della Repubblica federale tedesca. Il 7 dicembre 1970 è in visita a
Varsavia: davanti al monumento agli eroi del ghetto ebraico raso al suolo si inginocchia e chiede
perdono per le colpe del suo popolo.
E così si espresse, l’anno successivo, nel discorso per l’accettazione del Nobel per la pace:
Dico qui quello che dico in Germania: un buon tedesco non può essere un nazionalista. Un buon tedesco sa che
non può respingere un appello europeo. Attraverso l’Europa, la Germania ritorna a se stessa e alle forze costruttive della
sua storia. La nostra Europa, nata dall’esperienza di sofferenza e debolezza, è la missione imperativa della ragione.
Se la Germania non fosse una sola, se ce ne fossero due, una buona e una cattiva, Willy
Brandt non avrebbe avuto alcuna ragione di farsi carico, come rappresentante della Germania, di
colpe che egli, in quanto individuo, non aveva mai e in nessun modo condiviso. E la sua
implorazione di perdono a nome dell’intero popolo tedesco non avrebbero alcun senso, e nessun
significato storico la sua visione che comprende sia la Germania di ieri sia quella che, oggi,
concorre a fondare l’Europa.
La guerra che non vuole finire
Dopo tante pagine scritte, anche da me, sulla Resistenza e sulle atrocità compiute dai tedeschi e dai fascisti, mi
è sembrato giusto far vedere l'altra faccia della medaglia. Ossia quel che accadde ai fascisti dopo il crollo della
Repubblica sociale italiana, che cosa patirono, le violenze e gli assassinii di cui furono vittime.
In tutte le guerre, e specialmente nelle guerre civili, chi perde paga. È una regola spietata che abbiamo visto
applicare anche in Italia. I vinti del 1945 hanno pagato poco o troppo? Ecco un dilemma che lascio alla coscienza e alla
memoria del lettore.
(Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti)
Il libro dal quale ho tratto la citazione che precede14 ha suscitato polemiche anche aspre (in
parte giustificate); e per chi, come noi, ha un'opinione alta della Resistenza e del suo significato
storico è particolarmente duro da leggere. Credo però che sia necessario farlo.
L'autore racconta la lunga serie di uccisioni, solo in parte giustificabili come punizione per
efferatezze compiute al riparo del potere fascista, da parte di combattenti partigiani ancora molti
mesi dopo la fine 'ufficiale' della guerra; la costituzione di vere bande autonome e non controllabili
(a volte, colpevolmente non controllate) di ex-combattenti che non deposero le armi il 25 aprile e
che continuarono una loro guerra privata, talora con la copertura ideologica della rivoluzione
14
GIAMPAOLO PANSA, Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile, Milano, Sperling &
Kupfer 2003.
9
comunista ma spesso senza alcuna copertura; e la fine di questo massacro strisciante imposta dalla
dirigenza nazionale del Partito Comunista, con l'impegno personale e diretto di Palmiro Togliatti.
Bisogna leggere questo libro per almeno tre ragioni.
La prima, e la più importante, è che dice la verità, o almeno una parte della verità, quella più
a lungo taciuta: doveva dirla e noi dobbiamo conoscerla.
La seconda ragione è che, come ho osservato a proposito del libro di Sebald, c’è un tempo
nuovo che si apre, e non solo tra nazione e nazione ma anche all’interno delle singole nazioni,
soprattutto di quelle – e sono molte in Europa – che sono state attraversate da una guerra civile: è
bene che ciascuno si presenti alle nuove generazioni con la propria immagine completa, con tutta la
propria storia, bene e male.
La terza, vitale ragione è che questo libro spiega, con evidenza crudele, che la guerra non è
un confronto leale in cui importa che vinca il migliore, e che si chiude senza rancori, come una
partita di calcio al fischio di chiusura. I nostri ultimi sessant’anni di pace e benessere, sorte
rarissimamente se non mai toccata, nella storia umana, a una parte tanto grande, varia e significativa
di popolazione, non devono farci dimenticare che cos’è la guerra, quella vera, dove le persone
cercano di non essere uccise, molto spesso uccidono chi le vuole o le potrebbe uccidere e non
sempre riescono a perdonare i nemici che gli hanno ucciso e cancellato, fatto scomparire per sempre
il figlio, la moglie, la famiglia. Le guerre non finiscono il giorno ufficiale della loro conclusione,
neppure quando a vincere sono ‘i buoni’: neppure quando a vincere siamo noi, o ciò che resta di noi
dopo una guerra.
E’ bene che a scuola questo venga spiegato con estrema chiarezza.
Eroismo
Partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del
vento nero, sentendo com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partì
si sentì investito – nor death itself would have been divestiture – in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in
ogni modo al fascismo, a giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di
potere, ma infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto
(Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny)
Ho citato più sopra, con la commozione che merita, la breve storia di Walter Atti. Si tratta
certamente, oltre a tutto il resto, di un episodio eroico. E tuttavia, tra le insidie maggiori di una
rievocazione che sia solo celebrativa c’è, di sicuro, la tentazione di vedere, nella Resistenza e nella
guerra civile, l’eroismo e il valore da una parte sola, la viltà e la paura sempre dall’altra parte.
Non può essere andata così, naturalmente.
Posso sbagliare, è chiaro, ma mi sembra che la letteratura italiana sulla Resistenza abbia
prodotto non moltissime cose di buon livello e una sola veramente grande. Questa sola, a mio
parere, è Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, col corredo dei suoi scritti minori legati allo
stesso tema e alla propria personale esperienza della guerra partigiana.
Tra le ragioni che rendono grande questo scrittore c’è sicuramente la sua capacità di vedere
le cose con estrema limpidezza; e vede anche la propria paura, per esempio durante il rastrellamento
del ’44, e (ancora più difficile da vedere e da dire) la ferocia che dalla paura deriva. E vede il valore
degli altri (per esempio, in Una questione privata, il terrore che gli incute un reparto scelto nemico,
il battaglione San Marco):
sentì sulla strada dietro lo sperone il fragore della colonna che rientrava a Canelli dalla puntata a Santo Stefano.
A giudicare dal rumore, i camions erano lanciati alla massima velocità lungo la strada sfondata. “Sono in gamba”, pensò
con tristezza. Il rombo si spense rapidamente nel fondovalle, ma per riprendere a salire Milton aspettò che gli si fosse
completamente scaricato lungo la spina dorsale il tremito messogli dentro dal rumore dei nemici. Aiutò quello scarico
con un languido scrollo di tutto il corpo e ripartì. 15
15
BEPPE FENOGLIO, Una questione privata, in Romanzi e racconti, Torino, Einaudi 2001, p. 1100.
10
E naturalmente questo c’è anche nel libro di Pansa: quando tutto è perduto, e ormai le
divisioni partigiane entrano nelle città il 25 aprile del ‘45, numerosi fascisti si rifugiano sui tetti e
sparano sui vincitori, a volte per giorni, fino all’ inevitabile cattura e alla morte certa.
L’eroismo non ha partito. Dobbiamo insegnare che non vale nulla? (non è una domanda
retorica).
Dobbiamo ripetere la frase del Galileo di Brecht: ‘felice quella terra che non ha bisogno di
eroi’?
Fare scuola seriamente comporta pesantissime responsabilità.
Conclusioni
Gli eventi storici, per permettere nel frattempo la ricarica del dispositivo degli obbrobri, consentono riesami
finalmente “sereni ed equanimi” della Shoah. Spinti da questa serena equità del revisionismo storico, molti ebrei stanno
facendo come me la valigie: seppelliscono, prima che sia troppo tardi, le loro memorie nelle menti degli altri per
preservarle dalle ingiurie del tempo e di chi le intende volontariamente ingiuriare. Come tanti Ringelblum a Varsavia,
sotterriamo i nostri bauletti di ferro, pieni di documenti e ricordi, in attesa che gli archeologi cognitivi del futuro, in tuta
antiradiazioni, scoprano nel pensiero dei posteri le tracce dei nostri pericolosi messaggi, al comando di Amos Oz.
Oz è lo scrittore israeliano che ha definito la pericolosità del ricordo quando altera coi suoi veleni la percezione
del presente. Ma noi, nella notte che scende nera dietro le nostre spalle, mentre facciamo gli ultimi passi di corsa senza
fiato per tentar di restare nella zona illuminata, sentiamo che qualcuno approfitta del buio per fare scempio delle lapidi
dei nostri cimiteri.
(Aldo Zargani, Per violino solo)
La memoria - condivido lo spirito del passo che ho citato in epigrafe a queste conclusioni - è
necessaria: non vogliamo dimenticare. E la memoria non può finire: almeno nel nostro desiderio, è
infinita.
La celebrazione è giusta: ha vinto la sola parte che poteva consentire anche agli sconfitti di
partecipare dei vantaggi dell’ordine politico uscito dalla vittoria.
La memoria, però, deve essere completa, compiuta. La guerra è stata combattuta, è stata
vinta. Non può proseguire, all’infinito, nella memoria.
E perché è necessario non fermarsi alla celebrazione?
Limitarsi a celebrare vuol dire, oggi, contribuire a cancellare. Perché solo una storia
compiuta può dare conto della dislocazione delle persone, delle nazioni, dei valori. Solo così,
ricostruendo e leggendo – e ‘riducendo’ - la dislocazione, si può riconoscere, in quello che vediamo
oggi, ciò che è stato ieri. E valutare la differenza tra ieri e oggi non in termini metafisici (‘lotta del
Bene contro il Male’ e noi siamo naturalmente, una volta per sempre, il Bene) o metastorici (chi ha
sbagliato una volta non avrà mai remissione), ma in termini di decisioni politiche, di motivazioni
psicologiche, di scelte ideologiche: non obbligatorie ed eterne ma suscettibili di essere respinte,
corrette, modificate.
Solo così potremo evitare il rischio di raccontare ai giovani una specie di ‘favola nera’, una
vicenda nella quale i nomi hanno perso ogni contatto con la realtà che conosciamo, con ciò che oggi
quei nomi rappresentano; nella quale la Germania cattiva non è – non può essere - la Germania di
oggi, che è buona; l’Italia fascista non è l’Italia di oggi, che è democratica; dunque forse (poiché
certo, come abbiamo visto, non esistono due Germanie, due Italie) non è mai esistita.
La favola nera rende molto più facile il lavoro dei negazionisti e dei revisionisti storici.
Per compiere il nostro dovere di formatori e il nostro dovere di cittadini cercheremo di
lavorare perché gli insegnanti possano, nelle loro classi, svolgere un compiuto lavoro di
ricostruzione storica che è contemporaneamente lavoro di costruzione civile della nuova Europa.
11