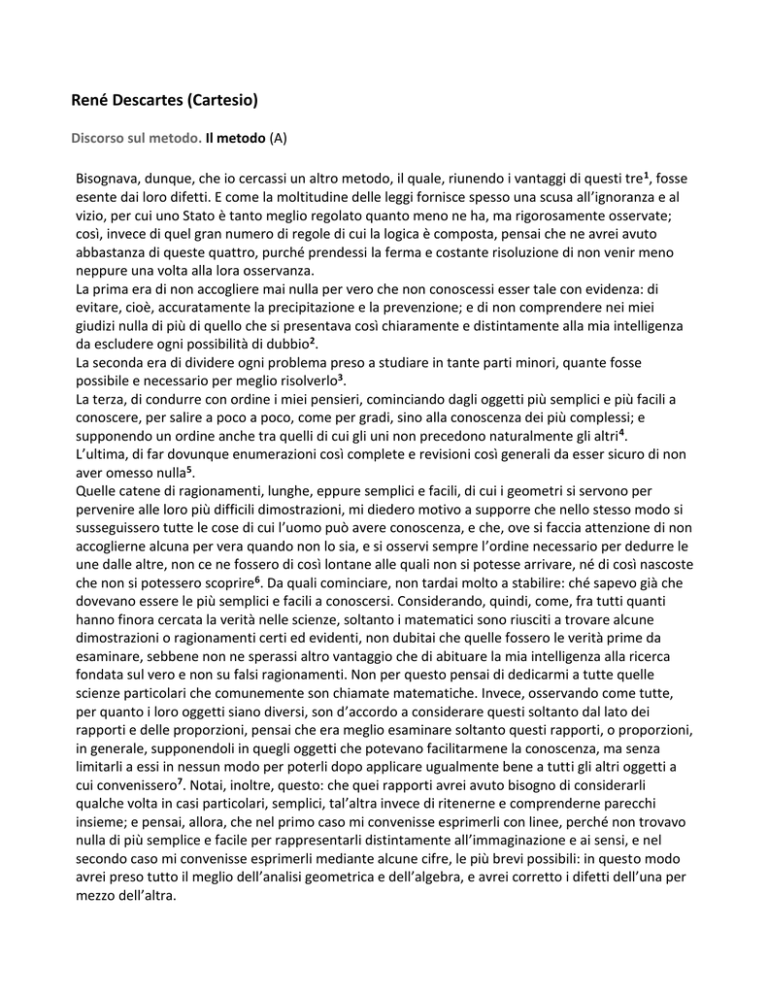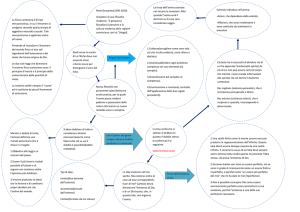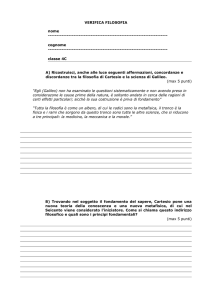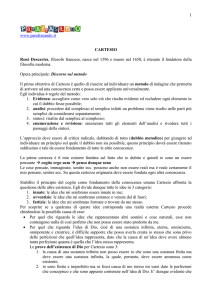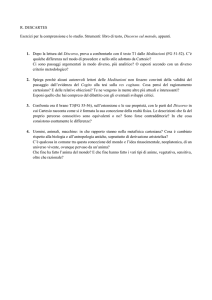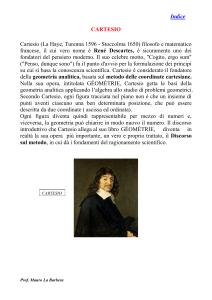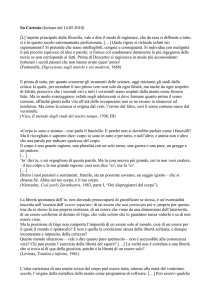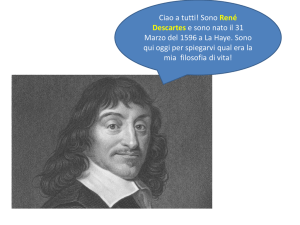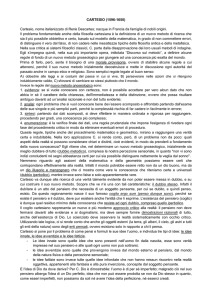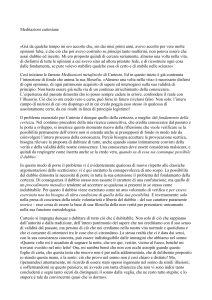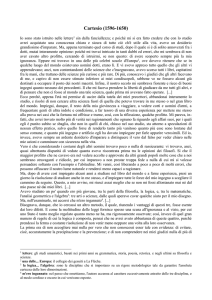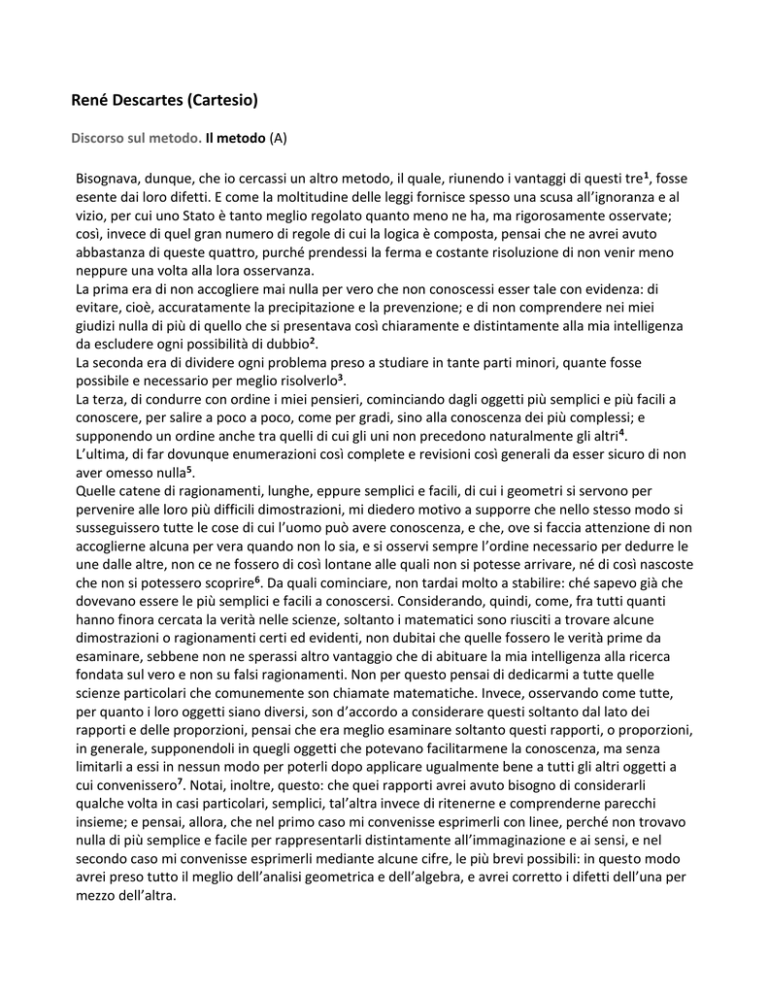
René Descartes (Cartesio)
Discorso sul metodo. Il metodo (A)
Bisognava, dunque, che io cercassi un altro metodo, il quale, riunendo i vantaggi di questi tre 1, fosse
esente dai loro difetti. E come la moltitudine delle leggi fornisce spesso una scusa all’ignoranza e al
vizio, per cui uno Stato è tanto meglio regolato quanto meno ne ha, ma rigorosamente osservate;
così, invece di quel gran numero di regole di cui la logica è composta, pensai che ne avrei avuto
abbastanza di queste quattro, purché prendessi la ferma e costante risoluzione di non venir meno
neppure una volta alla lora osservanza.
La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi esser tale con evidenza: di
evitare, cioè, accuratamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei
giudizi nulla di più di quello che si presentava così chiaramente e distintamente alla mia intelligenza
da escludere ogni possibilità di dubbio2.
La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante parti minori, quante fosse
possibile e necessario per meglio risolverlo3.
La terza, di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti più semplici e più facili a
conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei più complessi; e
supponendo un ordine anche tra quelli di cui gli uni non precedono naturalmente gli altri 4.
L’ultima, di far dovunque enumerazioni così complete e revisioni così generali da esser sicuro di non
aver omesso nulla5.
Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i geometri si servono per
pervenire alle loro più difficili dimostrazioni, mi diedero motivo a supporre che nello stesso modo si
susseguissero tutte le cose di cui l’uomo può avere conoscenza, e che, ove si faccia attenzione di non
accoglierne alcuna per vera quando non lo sia, e si osservi sempre l’ordine necessario per dedurre le
une dalle altre, non ce ne fossero di così lontane alle quali non si potesse arrivare, né di così nascoste
che non si potessero scoprire6. Da quali cominciare, non tardai molto a stabilire: ché sapevo già che
dovevano essere le più semplici e facili a conoscersi. Considerando, quindi, come, fra tutti quanti
hanno finora cercata la verità nelle scienze, soltanto i matematici sono riusciti a trovare alcune
dimostrazioni o ragionamenti certi ed evidenti, non dubitai che quelle fossero le verità prime da
esaminare, sebbene non ne sperassi altro vantaggio che di abituare la mia intelligenza alla ricerca
fondata sul vero e non su falsi ragionamenti. Non per questo pensai di dedicarmi a tutte quelle
scienze particolari che comunemente son chiamate matematiche. Invece, osservando come tutte,
per quanto i loro oggetti siano diversi, son d’accordo a considerare questi soltanto dal lato dei
rapporti e delle proporzioni, pensai che era meglio esaminare soltanto questi rapporti, o proporzioni,
in generale, supponendoli in quegli oggetti che potevano facilitarmene la conoscenza, ma senza
limitarli a essi in nessun modo per poterli dopo applicare ugualmente bene a tutti gli altri oggetti a
cui convenissero7. Notai, inoltre, questo: che quei rapporti avrei avuto bisogno di considerarli
qualche volta in casi particolari, semplici, tal’altra invece di ritenerne e comprenderne parecchi
insieme; e pensai, allora, che nel primo caso mi convenisse esprimerli con linee, perché non trovavo
nulla di più semplice e facile per rappresentarli distintamente all’immaginazione e ai sensi, e nel
secondo caso mi convenisse esprimerli mediante alcune cifre, le più brevi possibili: in questo modo
avrei preso tutto il meglio dell’analisi geometrica e dell’algebra, e avrei corretto i difetti dell’una per
mezzo dell’altra.
Note:
1. I tre procedimenti precedentemente considerati sono quelli della logica, o dialettica, della geometria e
dell’algebra.
2. L’evidenza è la caratteristica di quelle che poi Cartesio chiamerà le «idee chiare e distinte», le quali sono
oggetto di intuizione, cioè di conoscenza immediata, indipendente dall’esperienza sensibile.
3. Qui Cartesio allude, in modo molto generico, all’«analisi», corrispondente a quello che Galilei chiamava
«metodo risolutivo», consistente nel partire dagli effetti e scoprire, mediante deduzione da un’ipotesi, le loro
cause.
4. Questa è la «sintesi», corrispondente a quello che Galilei chiamava «metodo compositivo» e consistente nel
dimostrare gli effetti deducendoli dalle loro cause.
5. La quarta regola è l’«enumerazione», cioè il controllo del procedimento seguito nell’analisi e nella sintesi.
6. Qui è evidente l’estensione dell’analisi geometrica alla conoscenza di tutta la realtà, cioè alla filosofia intesa
come scienza universale.
7. Ulteriore conferma che il metodo della matematica è applicato a tutta la realtà.
Guida alla lettura:
L’altro grande iniziatore della filosofia moderna, insieme con Bacone, è Cartesio. Anche Cartesio,
come Bacone, propose alla filosofia un fine eminentemente pratico, cioè l’instaurazione del dominio
dell’uomo sulla natura, e ritenne che tale fine potesse essere realizzato adottando anzitutto per la
filosofia un nuovo metodo. A differenza di Bacone, tuttavia, e a somiglianza di Galilei, Cartesio
desunse il metodo direttamente dalla matematica. Nel Discorso sul metodo (1637), da cui è tratto il
brano che presentiamo, Cartesio narra d’aver scoperto il metodo nel 1619, e lo riassume in quattro
regole apparentemente neutrali, non nascondendone la derivazione dalla matematica.
Discorso sul metodo. Il dubbio, il «cogito», l'anima e Dio
Non so se debbo intrattenermi su le prime meditazioni ch’io feci allora1, poiché esse sono talmente
metafisiche e così poco comuni che forse pochi le troveranno di loro gradimento; pure, son costretto
a parlarne, affinché ognuno possa giudicare se sono abbastanza ben fondati i principi posti a base
della mia filosofia. Dianzi ho spiegato la ragione per cui nei costumi è talvolta necessario adottare e
seguire anche le opinioni più incerte come se fossero certissime: questo l’avevo notato da gran
tempo. Ma, poiché io allora intendevo di dedicarmi soltanto alla ricerca della verità, ritenni
necessario far tutto il contrario: rigettare, cioè, come interamente falso tutto ciò in cui potessi
immaginare il menomo dubbio, per vedere se, così facendo, alla fine, restasse qualcosa, nella mia
credenza, di assolutamente indubitabile2.
Intanto: poiché i nostri sensi talvolta c’ingannano, volli supporre non esserci nessuna cosa che fosse
quale essi ce la fanno immaginare. E poiché ci sono uomini che cadono in abbagli e paralogismi
ragionando anche intorno ai più semplici argomenti di geometria, pensai ch’io ero soggetto ad errare
come ogni altro, e però respinsi come falsi tutti i ragionamenti che avevo preso sin allora per
dimostrazioni. In fine, considerando che gli stessi pensieri, che noi abbiamo quando siam desti,
possono tutti venirci anche quando dormiamo benché allora non ve ne sia alcuno vero, mi decisi a
fingere che tutto quanto era entrato nel mio spirito sino a quel momento non fosse più vero delle
illusioni dei miei sogni3. Ma, subito dopo, m’accorsi che, mentre volevo in tal modo pensare falsa
ogni cosa, bisognava necessariamente che io, che la pensavo, fossi pur qualcosa. Per cui, dato che
questa verità: Io penso, dunque sono, è così ferma e certa che non avrebbero potuto scuoterla
neanche le più stravaganti supposizioni degli scettici, giudicai di poterla accogliere senza esitazione
come il principio primo della mia filosofia4.
Poi, esaminando con attenzione ciò che ero, e vedendo che potevo fingere, sì, di non avere nessun
corpo, e che non esistesse il mondo o altro luogo dove io fossi, ma non perciò potevo fingere di non
esserci io, perché, anzi, dal fatto stesso di dubitare delle altre cose seguiva nel modo più evidente e
certo che io esistevo; laddove, se io avessi solamente cessato di pensare, ancorché tutto il resto di
quel che avevo immaginato fosse stato veramente, non avrei avuto ragione alcuna per credere di
esser mai esistito: ne conclusi esser io una sostanza, di cui tutta l’essenza o natura consiste solo nel
pensare, e che per esistere non ha bisogno di luogo alcuno, né dipende da cosa alcuna materiale.
Questo che dico «io», dunque, cioè, l’anima, per cui sono quel che sono, è qualcosa d’interamente
distinto dal corpo, ed è anzi tanto più facilmente conosciuto, sì che, anche se il corpo non esistesse,
non perciò cesserebbe di esser tutto ciò che è5.
Dopo di ciò considerai quel che si richiede in generale perché una proposizione sia vera e certa: io ne
avevo trovata una, proprio in quel momento, che sapevo esser tale, e però pensai di dover anche
sapere in che consiste tale certezza. Notai, allora, che in questa affermazione: io penso, dunque sono,
non c’è nulla che me ne assicuri la verità eccetto il vedere chiaramente che per pensare bisogna
essere: giudicai, quindi, di poter prendere per regola generale che le cose, le quali noi concepiamo in
modo del tutto chiaro e distinto, sono tutte vere; e che, se c’è qualche difficoltà, è solo nel ben
determinare quali sono quelle che noi concepiamo distintamente6.
In séguito a ciò, riflettendo sul fatto che io dubitavo, e che chiaramente vedevo essere maggiore
perfezione il conoscere del dubitare, per cui l’esser mio non era del tutto perfetto, mi proposi di
cercare donde avessi appreso a pensare a qualcosa di più perfetto ch’io non fossi; e conobbi con
evidenza che doveva essere da una natura realmente più perfetta di me.
Dei pensieri riguardanti le molte e varie cose fuori di me, come il cielo, la terra, la luce, il calore e
mille altre, non mi preoccupavo molto di sapere donde mi fossero venuti, perché, non notando in
essi nulla che sembrasse renderli superiori a me, potevo ritenere che, se veri, dipendessero da me in
quanto la mia natura aveva qualche perfezione; se falsi, mi venissero dal nulla, ossia fossero in me
per quel che in me era di manchevole. Ma lo stesso non poteva essere per l’idea di un essere più
perfetto del mio, poiché derivarla dal nulla era cosa manifestamente impossibile; e, d’altra parte,
poiché a voler far dipendere il più perfetto dal meno perfetto non v’è minore difficoltà che dal nulla
ricavar qualcosa, io non la potevo derivar neppure da me stesso. Essa doveva, dunque, esser stata
messa in me da una natura realmente più perfetta di me, e tale, anzi, che avesse in sé tutte le
perfezioni di cui io potevo avere qualche idea, cioè, per dirla con una parola sola, che fosse Dio 7.
Note:
1. «Allora», come si evince da quanto precede questo passo, significa otto anni prima di scrivere il Discorso sul
metodo, cioè nel 1629, dunque molto tempo dopo la scoperta del metodo matematico, che secondo questa
stessa opera avvenne nel 1619.
2. Si noti come il dubbio sia qui adottato non come atteggiamento definitivo (dubbio sistematico), ma come
mezzo per la ricerca della verità (dubbio metodico). Esso tuttavia non è una semplice sospensione del giudizio,
ma è un giudicare falso tutto ciò che è soggetto a dubbio.
3. Il dubbio metodico investe sia le conoscenze derivanti dai sensi, sia quelle derivanti dai ragionamenti, anche
matematici (non il metodo matematico in quanto tale, ma la possibilità di un uso scorretto di esso), sia tutti i
pensieri che abbiamo nello stato di veglia. Quest’ultimo argomento, cioè la possibilità di scambiare la veglia
col sogno, al tempo di Cartesio era molto diffuso: ad esso Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) aveva
dedicato il dramma La vita è sogno (1635).
4. Dall’esercizio del dubbio risulta come indubitabile l’esistenza del dubbio stesso, cioè del pensiero, dell’«io»
che pensa. È questo il famoso argomento con cui Cartesio dimostra l’innegabilità del cogito, su cui si fonda la
sua metafisica (non il resto della sua filosofia, che si fonda invece sul metodo matematico).
5. Dalla dubitabilità del corpo, congiunta all’indubitabilità del pensiero, Cartesio conclude che l’«io», cioè il
soggetto del pensiero, è una sostanza, cioè una realtà indipendente dal corpo. Qui egli scambia la separabilità
logica del pensiero dal corpo, cioè la possibilità di pensare il pensiero senza pensare il corpo, per una
separabilità reale, cioè per la possibilità che il pensiero esista senza che esista anche il corpo. In tal modo il
soggetto del pensiero si trasforma in una «sostanza» essenzialmente pensante, la famosa res cogitans, nella
quale consiste per Cartesio l’anima.
6. Cartesio recupera attraverso il cogito la prima regola del suo metodo, cioè l’evidenza; non però la seconda e
la terza, cioè l’analisi e la sintesi, che derivano dalla matematica e restano indipendenti dal cogito.
7. A rigore, dal dubbio, cioè dal fatto che noi dubitiamo, possiamo ricavare soltanto la certezza che siamo
imperfetti. Il ricavare poi l’esistenza di Dio dal fatto che noi possediamo l’idea della perfezione, la quale non
può derivare da noi stessi, perché siamo imperfetti, presuppone che da un’idea si possa ricavare l’esistenza del
suo oggetto, il che non è affatto evidente. Cartesio non considera infatti la possibilità che l’idea della
perfezione possa derivare, per negazione, dall’idea dell’imperfezione. In ogni caso è dal dubbio, non dal
metodo, che egli ritiene di poter ricavare le due tesi fondamentali della sua metafisica, cioè l’immortalità
dell’anima e l’esistenza di Dio.
Guida alla lettura:
Nel Discorso sul metodo, da cui è tratto il brano che presentiamo, dopo avere esposto le regole del
metodo scoperto nel 1619 e la cosiddetta «morale provvisoria», Cartesio racconta come, dieci anni
più tardi, adottò l’atteggiamento del «dubbio metodico», il quale gli consentì di pervenire alle
certezze fondamentali della sua metafisica, cioè l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio. Il dubbio
risulta infatti indubitabile e quindi rivela immediatamente l’esistenza, anzi l’innegabilità, del
pensiero, cioè dell’«io» (cogito, ergo sum).
Da questa certezza Cartesio ricava, con un discutibile ragionamento che scambia la separabilità logica
per una separabilità reale, la sostanzialità dell’anima (res cogitans), cioè la sua indipendenza dal
corpo, vale a dire la sua immortalità. Dallo stesso dubbio, attraverso un altro discutibile
ragionamento che da un’idea argomenta l’esistenza del suo oggetto, egli ricava l’esistenza di Dio. In
tal modo, mediante il dubbio metodico, egli enuncia le tesi fondamentali della sua metafisica (che
riesporrà più ampiamente nelle Meditazioni metafisiche). A questo punto, salvaguardati i preamboli
della fede cristiana, Cartesio è pronto ad applicare il metodo matematico, adottato
indipendentemente dal dubbio, all’intera realtà, costruendo quella «matematica universale» che
vagheggiava sin dal tempo delle Regulae e che risulterà poi essere la sua fisica matematica.
Meditazioni metafisiche. Tre tipi di idee
Tra i miei pensieri, alcuni sono come le immagini delle cose, e a quelli soli conviene propriamente il
nome d’idea: come quando mi rappresento un uomo, o una chimera, o il cielo, o un angelo, o Dio
stesso1. Altri poi hanno anche altre forme: così, quando io voglio, temo, affermo o nego, concepisco
qualche cosa come oggetto dell’atto del mio pensiero, ma aggiungo anche altro, per mezzo di
quest’azione, all’idea di quella cosa; e di questo genere di pensieri, gli uni sono chiamati volontà o
affezioni, e gli altri giudizi2.
Ora, per ciò che concerne le idee, se noi le consideriamo solo in se stesse, senza riportarle ad altro,
esse non possono, a parlar propriamente, essere false; poiché, sia che immagini una capra o una
chimera, immagino l’una non meno che l’altra3.
Egualmente, non bisogna temer falsità nelle affezioni o volontà; perché sebbene io possa desiderare
cose cattive, o anche cose che non furono mai, tuttavia non è perciò meno vero che io le desidero.
Così restano i soli giudizi, nei quali debbo badare accuratamente a non ingannarmi. Ora il principale e
più ordinario errore che vi si possa trovare consiste in ciò, che io giudico che le idee, le quali sono in
me, siano simili o conformi a cose che sono fuori di me; poiché certamente, se considerassi le idee
solamente come modi o maniere del mio pensiero, senza volerle riportare ad altro, ben difficilmente
mi potrebbero dare occasione di errare.
Ora, di queste idee alcune mi sembrano nate con me [innatae], altre estranee e venute dal di fuori
[adventitiae], altre ancora fatte ed inventate da me stesso [factitiae]. Infatti la facoltà di concepire
una cosa, una verità, o un pensiero, sembra non venirmi da altro che dalla mia natura 4; ma se odo
adesso qualche rumore, se vedo il sole, se sento caldo, fino ad ora ho giudicato che queste sensazioni
provenissero da cose esistenti fuori di me5; ed infine mi sembra che le sirene, gli’ippogrifi e tutte le
altre simili chimere siano finzioni ed invenzioni del mio spirito6.
Note:
1. In senso lato si può chiamare idea qualsiasi contenuto mentale. In senso più stretto questo nome è riservato
a quelle rappresentazioni che si presentano come immagini di cose esterne: il che non vuol però dire che
questa corrispondenza sia reale, come Cartesio dimostrerà subito dopo (cfr. nota 3).
2. Le volizioni o i sentimenti sono contenuti mentali che non rinviano a una cosa esterna (come le idee in
senso proprio) e che hanno una natura semplice, cioè non comportano la connessione di più pensieri tra di
loro. Viceversa i giudizi sono contenuti mentali costituiti dalla congiunzione di almeno due pensieri, uno che
funge da soggetto l’altro da predicato.
3. Se consideriamo un’idea in se stessa (cioè come semplice oggetto interno del pensiero), essa è sempre vera.
Come semplice contenuto mentale, infatti, l’idea non pretende di rappresentare qualcosa al di fuori di sé.
Pertanto, in questo senso, l’idea dell’ippogrifo è un contenuto mentale altrettanto vero quanto l’idea della
capra che vedo davanti a me. Ovviamente tutt’altra cosa è il problema della realtà della corrispondenza delle
idee con le cose reali, che non ha nulla a che vedere con la realtà e la verità delle idee in se stesse, come
semplici contenuti mentali. Soltanto qui può intervenire l’errore, che tuttavia non è da imputarsi alle singole
idee, ma al giudizio di realtà che il soggetto esprime su di esse, come emerge dal capoverso successivo.
4. Le idee innate sono quelle che io trovo già presenti nella mia mente perché mi sono state poste da altri
(l’idea di Dio), o semplicemente perché le posso scoprire in virtù delle mie facoltà razionali (come i concetti di
pensiero, di corpo, di estensione, di movimento, delle entità matematiche): queste sono le «cose semplici», le
nozioni immediatamente chiare all’intuito razionale.
5. Le idee avventizie sono quelle che, essendomi date dall’esperienza, sembrano giungere (ad-venire)
dall’esterno (l’idea di una casa, di un albero).
6. Le idee fattizie sono quelle che la mente produce artificialmente. Si tratta di una vera e propria invenzione,
che può avvenire o in maniera arbitraria e fantastica (l’idea dell’ippogrifo, dell’unicorno), oppure in funzione
euristica nel campo delle scienze (come una teoria astronomica).
Guida alla lettura:
In una lettera a Mersenne del 16 giugno 1646 Cartesio scrive: «Col termine idea io intendo tutto
quello che può essere nel nostro pensiero, e che ho distinto in tre categorie, cioè: alcune sono
”avventizie” come l’idea che si ha volgarmente del sole; altre sono fatte o ”fattizie”, fra cui si può
mettere quella che gli astronomi si fanno del sole con i loro ragionamenti; altre sono innate, come
l’idea di Dio, della mente, del corpo, del triangolo, e in generale tutte quelle che rappresentano
essenze vere, immutabili ed eterne». Lo stesso tema viene ripreso nella terza delle Meditazioni
metafisiche.
Meditazioni sulla filosofia prima. Dall'io a Dio
Ora, fra queste idee, oltre quella che mi rappresenta a me stesso, della quale non può esservi qui
nessun dubbio, ve n’è un’altra, che mi rappresenta un Dio; altre, delle cose corporee ed inanimate;
altre, degli angeli, altre, degli animali; ed altre, infine, che mi rappresentano degli uomini simili a me.
Ma per ciò che riguarda le idee che mi rappresentano altri uomini, o animali, o angeli, io concepisco
facilmente che esse possono essere formate dalla mescolanza e dalla composizione delle altre idee,
che io ho delle cose corporee e di Dio, benché fuori di me non vi siano altri uomini nel mondo, né
animali, né angeli. E per ciò che riguarda le idee delle cose corporee, non vi riconosco nulla di così
grande, né di così eccellente, che non mi sembri poter venire da me stesso; perché, se le considero
più da vicino, [...] scopro che non vi si trovano che pochissime cose, che io concepisca chiaramente e
distintamente: e cioè, la grandezza, ovvero l’estensione in lunghezza, larghezza e profondità; la
figura, che è formata dai termini e dai limiti di questa estensione; la situazione, che i corpi
diversamente figurati serbano tra loro; ed il movimento o il cambiamento di questa situazione; alle
quali si possono aggiungere la sostanza, la durata e il numero. Quanto alle altre cose, come la luce, i
colori, i suoni, gli odori, i sapori, il caldo, il freddo e le altre qualità che cadono sotto il tatto, esse si
trovano nel mio pensiero con tanta oscurità e confusione, che ignoro perfino se esse siano vere o
false e solo apparenti, cioè se le idee, che io concepisco di queste qualità, siano in effetti le idee di
cose reali, oppure se non mi rappresentino che esseri chimerici, i quali non possono esistere.[...]
Non resta, dunque, che la sola idea di Dio, nella quale bisogna considerare se vi sia qualche cosa che
non sia potuta venire da me stesso. Con il nome di Dio intendo una sostanza infinita, eterna,
immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente, e dalla quale io stesso, e tutte le altre cose che
sono (se è vero che ve ne sono di esistenti), siamo stati creati e prodotti. Ora, queste prerogative
sono così grandi e così eminenti, che più attentamente le considero, e meno mi persuado che l’idea
che ne ho possa trarre la sua origine da me solo. E, per conseguenza, bisogna necessariamente
concludere, da tutto ciò che ho detto per lo innanzi, che Dio esiste; poiché, sebbene l’idea della
sostanza sia in me per il fatto stesso che sono sostanza, non avrei, tuttavia, l’idea di una sostanza
infinita io che sono un essere finito, se essa non fosse stata messa in me da qualche sostanza
veramente infinita.
Né debbo supporre di concepire l’infinito, non per mezzo di una vera idea, ma solo per mezzo della
negazione di ciò che è finito, così come comprendo il riposo e le tenebre per mezzo della negazione
del movimento e della luce: poiché, al contrario, vedo manifestamente che si trova più realtà nella
sostanza infinita che nella sostanza finita, quindi che ho, in certo modo, in me prima la nozione
dell’infinito che del finito, cioè prima la nozione di Dio che di me stesso. Perché come potrei
conoscere che dubito e che desidero, cioè che mi manca qualche cosa, e che non sono del tutto
perfetto, se non avessi in me nessuna idea di un essere più perfetto del mio, dal cui paragone
riconoscere i difetti della mia natura?
Guida alla lettura:
L’io si è scoperto come sostanza, res cogitans: ma alla certezza della sua affermazione si accompagna
la coscienza della sua finitezza. Esso non possiede ancora la garanzia che a ciò che i suoi pensieri
rappresentano con evidenza corrisponda qualcosa di reale: l’io vuole la verità, vuole che la realtà e il
suo stesso corpo, ancora sospesi sotto il regime del dubbio, gli siano veramente dati. Ma questo è
altamente problematico, perché potrebbe darsi che sia l’io stesso a produrre le rappresentazioni
contenute nelle idee. A meno che non si scopra un’idea che, con tutta evidenza, non sia un prodotto
della mia attività di pensiero.
È così che, nella III Meditazione, Dio fa il suo ingresso sulla scena del pensiero, perché l’io si accorge
dell’eccedenza e della precedenza dell’idea di infinito nel cogito. Questo Dio garantirà poi che alle
nostre idee chiare e distinte corrisponda la vera sostanza del mondo fuori di noi.