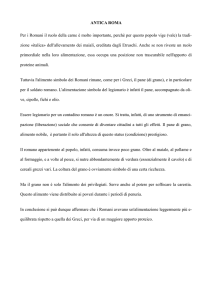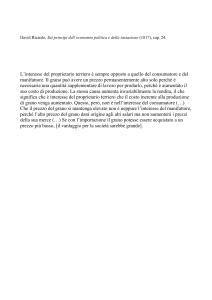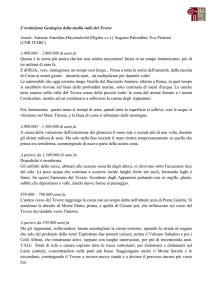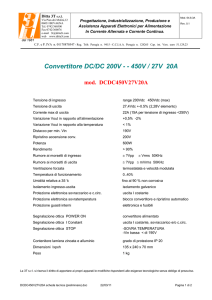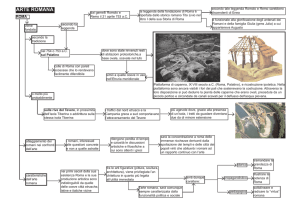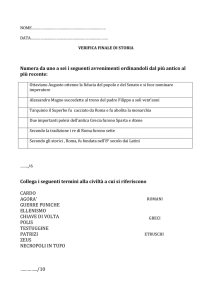XV I molini di Roma
Molti sono gli illustri autori che si sono occupati del Tevere,
“l’ex biondo fiume” che traversa la città di Roma, sviscerandone la storia, spesso arricchita con particolari che, pescando abbondantemente nell’aneddotica, rendono anche
più gustoso il racconto.
Molto spesso è stato trattato (compreso dallo stesso autore)
il tema inerente i monumenti del fiume, specie i ponti, a cominciare dai più antichi, scomparsi o manomessi, sovente irriconoscibili rispetto alla antiche descrizioni, passando poi
all’isola Tiberina, con la sua antichissima tradizione sanita149
Racconti Romani
ria. Ma nessuno o quasi, se non per puro caso, ha mai steso
un capitolo riguardo i molini galleggianti sul Tevere, figurarsi
sugli altri sparsi lungo i corsi d’acqua che solcavano il territorio romano e laziale.
Certo non rientrano nel capitolo Belle Arti quegli enormi barconi, così rustici e solidi, che saldamente ancorati con robuste catene agli argini o ai ponti, assolvevano magnificamente
ad un ruolo semplice, per quanto importante, che purtroppo
i romani d’oggi ignorano quasi totalmente, anche se gli stessi
molini hanno fatto parte della vita e del paesaggio dell’Urbe
per oltre tredici secoli. Che i molini fossero familiari ai romani di ieri lo testimonia il sempre citato Gioacchino Belli
con un sonetto nel quale un popolano addirittura confonde,
sovrapponendole, una ‘mola a grano’ con la “Mole Adriana”,
tanto da commentare:
Mascina pprima er grano pe la gola
Eppoi pell’occhi fà girelli e ffume!
E a questo proposito sarà bene precisare che in romanesco
non si dice mai ‘mulino’ ma bensì ‘molino’, termine che deriva
direttamente dal latino molendinum. È altrettanto vero che
il molino è di solito indicato come ‘mola’, parola che in dialetto equivale a ‘macina’, dal nome della pietra che stritola il
grano. La grande importanza che rivestivano i molini nella
società, lungo il correre del tempo, è legata essenzialmente
al fatto che il pane era l’elemento fondamentale, nonché indispensabile, della dieta giornaliera degli abitanti.
Erano quelli i tempi del ‘pane a bajocco’, in altre parole del
prezzo calmierato di tale alimento; per legge se ne prescriveva anche il peso minimo garantito (che poteva essere variato in tempi di carestia), sorvolando poi sulle sofisticazioni
150
I molini di Roma
effettuate dai fornai che, sostituendo la farina con ogni sorta
d’ignobile surrogato, si accaparravano così grandi guadagni
a scapito della qualità del prezioso genere primario.
Il pane divenne così la maggior preoccupazione dei governi
romani di ogni tempo, anche perché la mancanza di tale alimento (quasi sempre l’unico) provocava tensioni e tumulti
sociali che, la storia ci insegna, sono tra i più pericolosi da
domare. Chiaro che per panificare occorresse la farina, che
per macinare il grano la forza dell’acqua fosse la risorsa gratuita e primaria, per questo il Tevere pullulava di molini; ve
n’erano anche sui corsi d’acqua minori che un tempo traversavano Roma, mentre oggi questi sono incanalati e sono
scomparsi dalla superficie della città. Inoltre vi erano anche
altri molini destinati alla macina di materie prime industriali,
quali indaco, guado, robbia e dei colori per la tintura dei tessuti, ma la storia delle mole del grano è sicuramente la più
interessante e merita una maggiore conoscenza.
Le prime notizie sulle mole da grano, azionate ovviamente
ad acqua, risalgono al I o, addirittura, al II secolo a.C. Per
quanto ne sappiamo, queste nacquero probabilmente nel vicino Oriente: il loro funzionamento non era dissimile da
quello delle nostre, tanto che la descrizione del mulino del
palazzo di Mitridate nel Ponto, in funzione nel 18 a.C., potrebbe essere stata scritta per quelli che ancora alla fine
dell’Ottocento erano in funzione sul Tevere. Vitruvio ne descrive il meccanismo e chiama la macchina Hydroleta a conferma della sua origine orientale.
Quest’invenzione, come altre nell’industria primaria, trovò i
suoi cantori; tra questi Antipatro di Salonicco che, al tempo
di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) e di Tiberio (14-37), scriverà “[...]
lascia di macinare il grano, o donna, che fatichi il mulino,
151
Racconti Romani
resta a dormire”1. nessuna meraviglia dunque se, una volta
diffusa l’invenzione, i corsi d’acqua fossero aggiogati a tal esigenza, addirittura con la costruzione d’appositi acquedotti,
come ad Arles dove sono stati trovati resti di un gruppo di
mulini serviti da una condotta costruita, si ritiene, ai tempi
di Diocleziano (284-305). Si è addirittura calcolato che tale
impianto potesse servire all’alimentazione di ben 80.000
persone.
I perfezionamenti apportati dagli ingegneri romani (alla fine
del I secolo) avevano fatto sì che un solo molino, quello sul
Volturno nei pressi di Venafro – dotato di una mola del diametro di 2,10 metri che volgeva ad una velocità di 46 giri al
minuto – macinasse 150 chilogrammi di grano ogni ora, ben
oltre una tonnellata per ogni giornata lavorativa. Per semplice curiosità aggiungiamo che una mola manuale, azionata
da due schiavi, macinava solo sette chilogrammi di grano
ogni ora!
Chiaro quindi che la proprietà di un molino fosse un affare
molto appetibile, tanto che in Francia nel Trecento si costituirono delle ‘Società per azioni’ a partecipazione diffusa per
gestire i molini ad acqua.
Tornando a Roma, la Tòlle-Kastenbein riferisce che in tarda
età imperiale era in funzione un molino presso le Terme di
Caracalla, ma quel che è assolutamente certo è che a partire
dall’età di Traiano esistevano molini sul Gianicolo in corrispondenza della pendice che occupa l’attuale area della
chiesa di S. Pietro in Montorio, in direzione del Tevere. Le
mole sfruttavano la potenza dell’acqua deviata dalla zona dei
Sabatini tramite l’acquedotto che sarà ripristinato da Papa
Paolo V Borghese (1605-1621), a cui si aggiungeva l’acqua
1
MARIOTTI BIAnChI 1996, p. 10.
152
I molini di Roma
proveniente dal lago di Bracciano. Data la portata idrica e la
rapida caduta dovuta alla pendenza, i molini producevano
una parte rilevantissima della farina consumata a Roma. Una
loro forzata inattività fu la molla che fece nascere le mole sul
Tevere. nel 537 Roma era assediata dai Goti di Totila i quali,
per accelerare la resa della città, pensarono bene di tagliare
gli acquedotti, privando così la città di un bene indispensabile come l’acqua2. Si fermarono in questo modo i citati molini del Gianicolo.
Procopio di Cesarea, lo storico che aveva partecipato al conflitto e che quindi ne era testimone oculare, racconta che Belisario, comandante bizantino al tempo dell'Imperatore
Giustino I (518-527), ebbe subito l’idea di sfruttare la corrente del Tevere. Fece infatti collocare una coppia di barche,
unite fra di loro, nonché una grossa ruota azionata dalla corrente del fiume mediante la quale far girare le macine ospitate nelle barche stesse. Visto il risultato eccellente ottenuto
si ripropose lo stratagemma, talché comparve una lunga teoria di molini galleggianti ancorati saldamente alle sponde, al
fine di risolvere il problema annonario.
A questo punto, i Goti cercarono di fracassare i molini utilizzando la corrente del fiume per trasportare grossi tronchi
d’albero, ma Belisario, facendo costruire numerose palafitte
a monte delle mole, sviò il pericolo: in questa maniera i tronchi deviati passarono oltre senza arrecare alcun danno. Grazie a questo ingegnoso espediente, di cui lungo il Tevere
permangono ancora delle tracce, i molini restarono sul fiume
per più di 1300 anni.
2
Si ritiene, a ragione, che Roma imperiale ricevesse oltre un milione di metri cubi di acqua al giorno,
la maggior parte indirizzata verso le case patrizie tramite condotte in piombo. Gli acquedotti erano
una dozzina, a cielo aperto, con gli ultimi 16 chilometri sopraelevati per aumentarne la pressione.
153