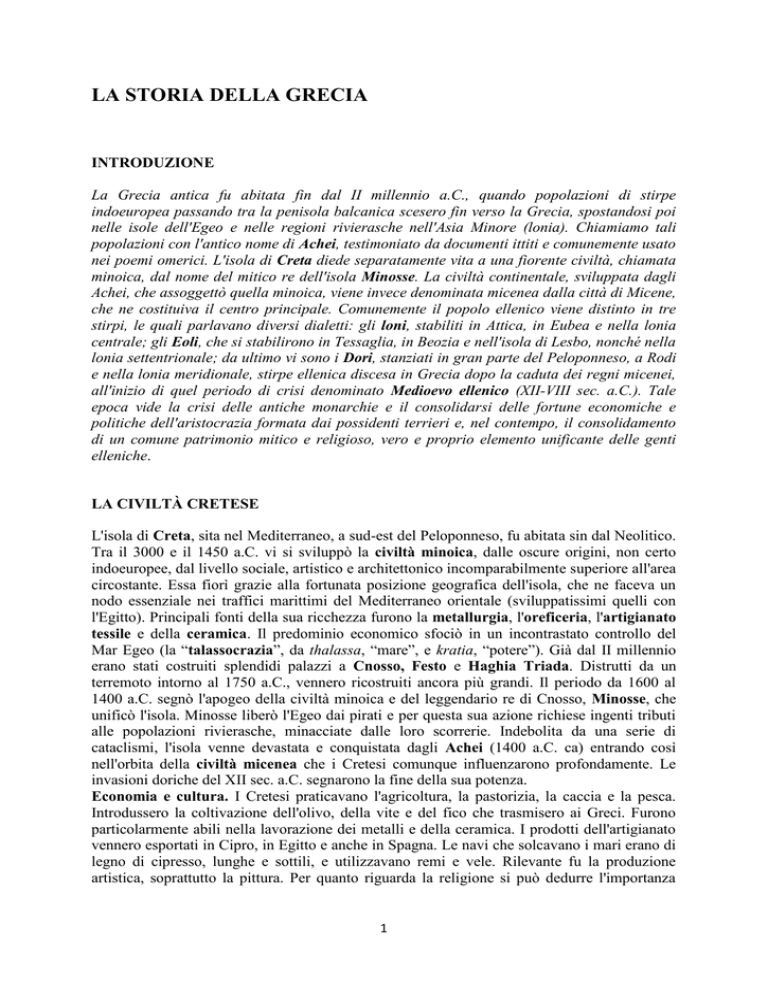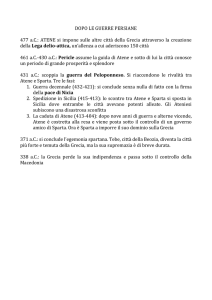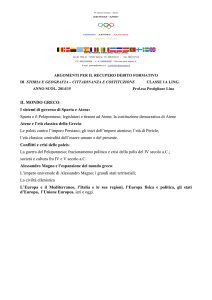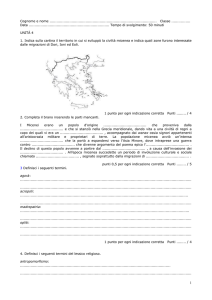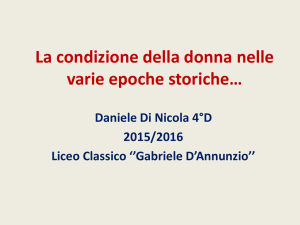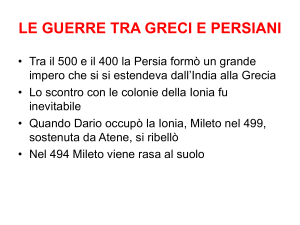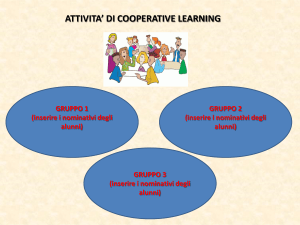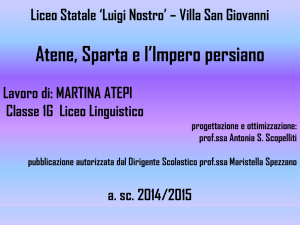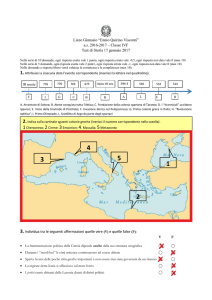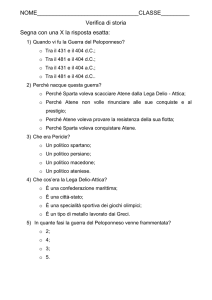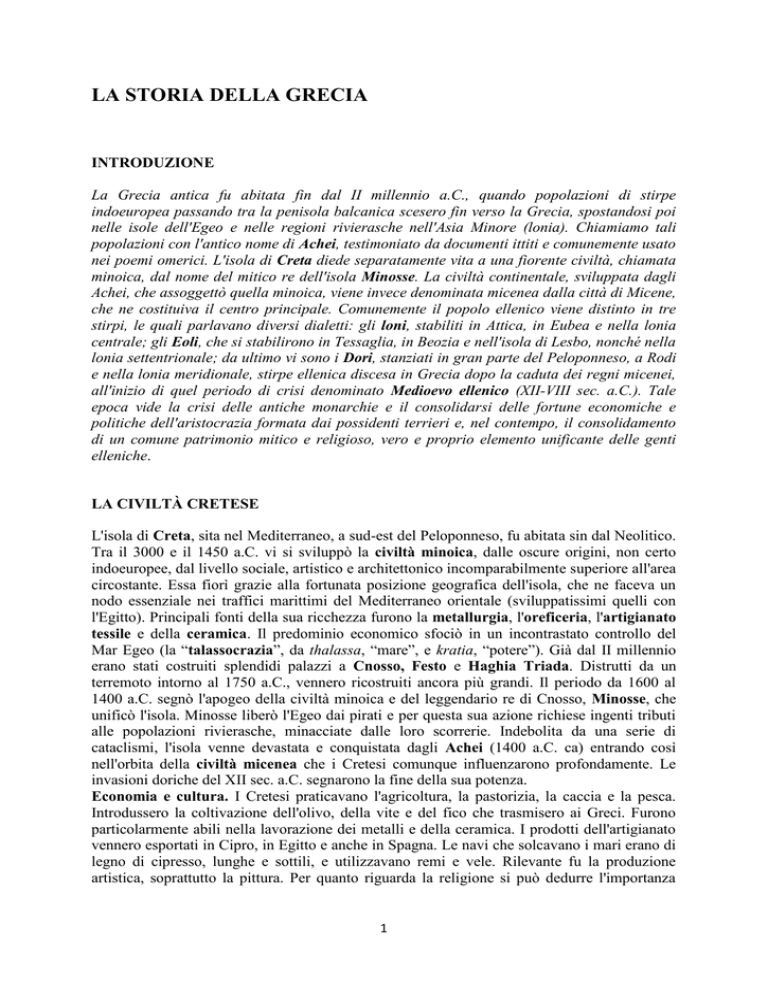
LA STORIA DELLA GRECIA
INTRODUZIONE
La Grecia antica fu abitata fin dal II millennio a.C., quando popolazioni di stirpe
indoeuropea passando tra la penisola balcanica scesero fin verso la Grecia, spostandosi poi
nelle isole dell'Egeo e nelle regioni rivierasche nell'Asia Minore (lonia). Chiamiamo tali
popolazioni con l'antico nome di Achei, testimoniato da documenti ittiti e comunemente usato
nei poemi omerici. L'isola di Creta diede separatamente vita a una fiorente civiltà, chiamata
minoica, dal nome del mitico re dell'isola Minosse. La civiltà continentale, sviluppata dagli
Achei, che assoggettò quella minoica, viene invece denominata micenea dalla città di Micene,
che ne costituiva il centro principale. Comunemente il popolo ellenico viene distinto in tre
stirpi, le quali parlavano diversi dialetti: gli loni, stabiliti in Attica, in Eubea e nella lonia
centrale; gli Eoli, che si stabilirono in Tessaglia, in Beozia e nell'isola di Lesbo, nonché nella
lonia settentrionale; da ultimo vi sono i Dori, stanziati in gran parte del Peloponneso, a Rodi
e nella lonia meridionale, stirpe ellenica discesa in Grecia dopo la caduta dei regni micenei,
all'inizio di quel periodo di crisi denominato Medioevo ellenico (XII-VIII sec. a.C.). Tale
epoca vide la crisi delle antiche monarchie e il consolidarsi delle fortune economiche e
politiche dell'aristocrazia formata dai possidenti terrieri e, nel contempo, il consolidamento
di un comune patrimonio mitico e religioso, vero e proprio elemento unificante delle genti
elleniche.
LA CIVILTÀ CRETESE
L'isola di Creta, sita nel Mediterraneo, a sud-est del Peloponneso, fu abitata sin dal Neolitico.
Tra il 3000 e il 1450 a.C. vi si sviluppò la civiltà minoica, dalle oscure origini, non certo
indoeuropee, dal livello sociale, artistico e architettonico incomparabilmente superiore all'area
circostante. Essa fiorì grazie alla fortunata posizione geografica dell'isola, che ne faceva un
nodo essenziale nei traffici marittimi del Mediterraneo orientale (sviluppatissimi quelli con
l'Egitto). Principali fonti della sua ricchezza furono la metallurgia, l'oreficeria, l'artigianato
tessile e della ceramica. Il predominio economico sfociò in un incontrastato controllo del
Mar Egeo (la “talassocrazia”, da thalassa, “mare”, e kratia, “potere”). Già dal II millennio
erano stati costruiti splendidi palazzi a Cnosso, Festo e Haghia Triada. Distrutti da un
terremoto intorno al 1750 a.C., vennero ricostruiti ancora più grandi. Il periodo da 1600 al
1400 a.C. segnò l'apogeo della civiltà minoica e del leggendario re di Cnosso, Minosse, che
unificò l'isola. Minosse liberò l'Egeo dai pirati e per questa sua azione richiese ingenti tributi
alle popolazioni rivierasche, minacciate dalle loro scorrerie. Indebolita da una serie di
cataclismi, l'isola venne devastata e conquistata dagli Achei (1400 a.C. ca) entrando così
nell'orbita della civiltà micenea che i Cretesi comunque influenzarono profondamente. Le
invasioni doriche del XII sec. a.C. segnarono la fine della sua potenza.
Economia e cultura. I Cretesi praticavano l'agricoltura, la pastorizia, la caccia e la pesca.
Introdussero la coltivazione dell'olivo, della vite e del fico che trasmisero ai Greci. Furono
particolarmente abili nella lavorazione dei metalli e della ceramica. I prodotti dell'artigianato
vennero esportati in Cipro, in Egitto e anche in Spagna. Le navi che solcavano i mari erano di
legno di cipresso, lunghe e sottili, e utilizzavano remi e vele. Rilevante fu la produzione
artistica, soprattutto la pittura. Per quanto riguarda la religione si può dedurre l'importanza
1
della civiltà cretese nella formazione delle tradizioni della Grecia dal fatto che, secondo il
mito, Zeus nacque a Creta da Rea e da Crono e qui passò la fanciullezza.
LA CIVILTÀ MICENEA
Gli Achei, giunti nella Grecia continentale nel II millennio, si imposero facilmente sulle
popolazioni locali. Il massimo splendore fu raggiunto nel periodo 1450-1250 a.C.; intorno al
1400 a.C. circa essi attaccarono Creta e, sconfittala, ne fecero una loro base marittima e
militare. Cominciarono poi le loro conquiste nell'Egeo: fondarono colonie a Rodi e nelle
Cicladi e in Asia Minore fondarono le città di Cnido e Alicarnasso. In seguito si spinsero
verso ovest, a Siracusa, nelle isole Eolie, a Ischia e nelle vicinanze di Taranto. Famosa,
nell'epopea micenea, è rimasta la Guerra di Troia , città dell'Asia Minore affacciantesi sulle
acque (Dardanelli) che portavano al Mar Nero di cui controllava le rotte commerciali. La
guerra, guidata dal re Agamennone, fu difficoltosa per gli Achei che solo dopo dieci anni di
assedio riuscirono a distruggerla (1200 a.C. ca). Usciti però molto indeboliti da questo
conflitto, gli Achei subirono l'invasione dei Dori (1150 a.C.), evento che li portò al tracollo.
L'organizzazione politica, economica e sociale. Il re, il consiglio degli anziani e
l'assemblea popolare erano gli organi politici micenei. Il re, detto wánax, era un monarca
autocrate. Egli teneva i contatti con gli altri sovrani, comandava l'esercito e presiedeva al
culto delle divinità. Il trono era ereditario. Per le decisioni importanti sentiva il parere dei
personaggi più in vista (i basilewes) e cercava anche il consenso del popolo. Il consiglio degli
anziani era formato da membri delle famiglie nobili. Dava consigli se convocato dal re e a
volte si opponeva alla sua politica. L'assemblea popolare era costituita dagli uomini che
potevano far parte dell'esercito. Se consultati dal re, potevano esprimere il loro parere ma
senza parlare, solo con acclamazioni o rumori che identificassero assenso o dissenso. Al
vertice della struttura sociale vi erano i nobili che erano abili combattenti e partecipavano alla
vita del palazzo reale. Schiavi, agricoltori e allevatori erano liberi ma vivevano in povere
condizioni. Gli artigiani, gli araldi, gli indovini, i guaritori vivevano meglio e potevano
prestare la loro opera nei palazzi dei nobili o in quello reale. Elementi principali
dell'economia micenea erano l'agricoltura, la lavorazione della lana e dei metalli.
I DORI E IL MEDIOEVO GRECO
I Dori, popolazione di origine indoeuropea, invasero la Grecia da nord, agli inizi del I
millennio a.C. Dalle regioni montuose settentrionali si spinsero nell'Acaia e in tutto il
Peloponneso e, da lì, distruggendo parzialmente la civiltà micenea, in Asia Minore e nelle
isole dell'Egeo. Con potenti armi di ferro e carri da combattimento sparsero il terrore ovunque
arrivarono. Il carattere conservatore e militarizzato delle loro istituzioni politiche avrà in
Sparta l'esempio più significativo. Con l'invasione dorica iniziò quel periodo di decadenza e
oscurità denominato Medioevo greco. Il territorio si divise in tanti piccoli regni governati da
sovrani che conducevano una vita molto semplice basata sulla pastorizia e sulla raccolta di
legna. Talvolta i sovrani riunivano in assemblea i capi delle famiglie più importanti (detti
áristoi, i “migliori”) per prendere decisioni in caso di pericolo o di guerra. In questo periodo
vennero comunque introdotte anche novità come la lavorazione del ferro, la costruzione di
templi dedicati agli dei e l'alfabeto fenicio.
2
LA POLIS VERSO LA DEMOCRAZIA
INTRODUZIONE
Il termine greco polis, che significa “città”, indica la forma di governo tipica del mondo
greco antico: la città-Stato. Espressione dell'innata tendenza alla frammentazione politica
del mondo greco antico, la polis era formata in genere da un insediamento urbano, in cui
avevano sede le strutture istituzionali, e da una fascia di territorio agricolo circostante. In
tutte le poleis vi erano un'assemblea primaria dei cittadini e un'assemblea ristretta che aveva
il compito di discutere preliminarmente i temi da dibattere pubblicamente. A questi due
organi si affiancava un certo numero di magistrature con funzioni prevalentemente esecutive.
I magistrati erano scelti per elezione diretta; le cariche più alte, che comportavano
responsabilità economiche, erano in genere limitate ai cittadini più ricchi. L'evoluzione della
polis fu caratterizzata dalla nascita e dall'intrecciarsi di diverse forme di governo, oltre che
dalla diffusione di legislazioni scritte. Persa l'unità politica che aveva caratterizzato il
Medioevo greco, il popolo ellenico manteneva tuttavia una certa unità tradizionale che si
esprimeva anche in raduni periodici di tutte le città quali quello dei giochi panellenici (le
Olimpiadi, dal sec. VIII a.C.) e soprattutto nei pellegrinaggi ad alcuni santuari come quelli di
Delfi (che divenne il centro spirituale della cultura greca dove si trovava l'omphalos, o
“ombelico del mondo”), di Delo e di Olimpia. Nacquero inoltre le prime forme di
associazione tra abitanti di centri limitrofi che sostenevano culti influenti in tutto il territorio
greco, le anfizionie; queste in alcuni casi assunsero anche valore di federazioni politiche.
L’EVOLUZIONE DELLA POLIS
La nascita della polis è uno dei problemi più dibattuti dalla storiografia contemporanea. Gli
storici attuali tendono a riconoscere già nei poemi omerici le prime tracce di un
organizzazione di questo genere. Durante il periodo del Medioevo greco il potere dei sovrani
era andato via via indebolendosi ed erano emersi i nobili che li affiancavano, gli áristoi (i
“migliori”), da cui il termine aristocrazia (“governo dei migliori”, che Platone e Aristotele
identificheranno con i saggi, i sapienti). La città-Stato nacque dalla loro esigenza di trovare
luoghi, diversi dal palazzo reale, dove riunirsi e prendere decisioni governative. Vennero
scelti territori in posizioni vantaggiose per il commercio e facilmente difendibili in caso di
invasioni. Questi nuovi nuclei urbani comprendevano una parte bassa dove risiedeva il popolo
e una più elevata, l'acropoli, sede della classe dirigente. Grande importanza aveva l'agorà, la
piazza dove si svolgeva il mercato e dove i cittadini si incontravano per trattare affari e per
partecipare alle assemblee. Vennero inoltre costruiti templi, sede del culto, e tribunali.
La polis nella colonizzazione: la Magna Grecia. Un deciso incremento della popolazione
complessiva originò contrasti sociali relativi al fabbisogno di terre, dando impulso, tra il 750 e
il 650 a.C., alla nuova colonizzazione. Le poleis greche fondarono quindi una serie di
insediamenti (apoikìaisulle coste del Mediterraneo. Gli abitanti di Lesbo, della Focide e di
Megara fondarono colonie sull'Ellesponto, in Asia Minore e sul Bosforo (Bisanzio). Gli
abitanti di Calcide colonizzarono la costa meridionale della Macedonia che da allora si
chiamò Penisola Calcidica e alcune città dell'Italia meridionale (Cuma, Napoli, Reggio) e
della Sicilia (Messina, Milazzo, Catania). La popolazione di Corinto fondò colonie sulla costa
Adriatica (Corfù, Ambracia ed Epidamno) e in Sicilia (Siracusa, Agrigento, Selinunte). I
Milesi, gli abitanti della fiorente Mileto, fondarono diverse colonie tra cui Abido, sullo stretto
dei Dardanelli, Sìnope e Trapezunte, sulla costa asiatica del Mar Nero, e Nàucrati in Egitto.
Le colonie fondate in Italia vengono comunemente fatte rientrare nella denominazione di
3
Magna Grecia. Il termine comparve per la prima volta in un passo di Timeo di Tauromenio,
storico greco vissuto in Sicilia nel sec. IV-III a.C., ma rimase piuttosto inusuale per le fonti
antiche che di regola chiamavano “italioti” i Greci d'Italia e “sicelioti” quelli di Sicilia. Dai
resti di ceramiche e altri materiali si è dedotto che i Greci frequentarono le coste italiane già in
età micenea (secc. XVI-XI a.C.). Alla prima metà del sec. VIII a.C. risale l'insediamento
sull'isola di Ischia che aprì la prima fase della colonizzazione greca d'Italia. Mentre le città di
nuova fondazione originavano a loro volta nuovi insediamenti, le popolazioni indigene
venivano cacciate o ridotte a forza-lavoro dipendente.
Dall'aristocrazia alla tirannide. Il commercio e la colonizzazione avevano intaccato il
monopolio fenicio e diffuso un'economia monetaria che comportò l'ascesa di nuove classi
benestanti che non erano di origine nobile. Alcune città acquisirono una supremazia
regionale: Atene in Attica, Argo nell'Argolide e Sparta in Laconia. L'ascesa di queste nuove
classi fu favorita anche dalla riforma dell'esercito. Nel VII sec. a.C. venne adottata la falange
oplitica, uno schieramento formato da alcune file di fanti (opliti) che avanzavano a piedi,
armati di lancia e spada e protetti da scudo e corazza. Poiché anche queste nuove classi
arricchite potevano permettersi queste armature, la preponderanza dei nobili (di solito
inquadrati nella cavalleria) nell'esercito cominciò a venire meno. Il malcontento del popolo,
soprattutto dei contadini, poveri e oppressi dai debiti, favorì l'ascesa di uomini politici di
queste nuove classi, che, in cambio dell'appoggio popolare, promettevano riforme. Presero
così il potere, imponendosi spesso con la forza, i tiranni (650 a.C. a Corinto; 510 a.C. ad
Atene), da cui il termine tirannide (governo autocratico e assoluto). In questo periodo divenne
sempre più frequente la redazione di legislazioni scritte.
Dalla tirannide alla democrazia. Le tirannidi rappresentarono generalmente periodi di
prosperità, pace e crescita culturale. I tiranni che vivevano in corti sfarzose si assunsero la
protezione di diversi artisti, poeti, pittori ecc. Il popolo aveva però preso coscienza della sua
forza e dell'importanza del suo appoggio alla classe dirigente. Con il V sec. a.C. quasi
ovunque le tirannidi risultarono sostituite da governi oligarchici (oligarchia significa
“governo di pochi”, genericamente distinti dalla moltitudine) o democratici (democrazia è la
forma di governo in cui la somma del potere viene riconosciuta al popolo). Nei secc. V-IV
a.C. l'assetto della polis si era ormai assestato in due modelli canonici. Da un lato le
democrazie, dove tutti i cittadini, indipendentemente dal censo, avevano accesso all'assemblea
primaria e al consiglio, i cui membri erano eletti o sorteggiati. Dall'altro le aristocrazie, dove i
membri del consiglio ristretto erano cooptati e in genere rimanevano in carica a vita.
L'opposizione tra queste due forme di governo fu tale che la Guerra del Peloponneso (431-404
a.C.) finì per essere uno scontro tra poleis democratiche, schierate con Atene, e poleis
oligarchico-aristocratiche, alleate con Sparta.
L'età ellenistica e il tramonto della polis. L'età ellenistica vide il tramonto della polis come
entità politica autonoma. Schiacciate dal superiore peso militare delle monarchie, le poleis
vennero progressivamente assorbite dai Regni ellenistici e dal dominio romano al cui interno
sopravvissero solo come unità amministrative, custodi di quell'eredità culturale e politica che
il mondo romano aveva adottato.
SPARTA E ATENE
INTRODUZIONE
Sparta e Atene furono le due città-Stato greche che raggiunsero il più alto grado di sviluppo e
che arrivarono a scontrarsi per il predominio sulla Grecia. La loro contrapposizione si
poteva notare anche nelle loro forme di governo e di organizzazione militare e sociale.
4
Sparta era uno Stato militare retto da una ristretta classe di cittadini a pieno titolo, mentre
Atene passò gradualmente dalla repubblica aristocratica alla democrazia e fu sede di diverse
riforme costituzionali, a partire da Solone (594 a.C.). Tra l'VIII e il VI sec. a.C. Sparta,
attraverso guerre e alleanze, riuscì a ottenere l'egemonia nel Peloponneso costituendo la
Lega peloponnesiaca cui aderirono città che le erano politicamente vicine. Atene invece, dal
477 a.C., entrò a far parte della Lega delio-attica, insieme all'Eubea, alle Cicladi e alle città
greche della costa traco-macedone e dell'Asia Minore. Lo scopo dichiarato di questa Lega,
che ebbe sede nel santuario di Apollo a Delo e poi ad Atene, era la lotta contro i Persiani, ma
divenne ben presto strumento della politica imperialista di Atene contro Sparta e fu sciolta
solo nel 404 a.C. alla fine della Guerra del Peloponneso.
SPARTA
Sparta era la città-Stato greca capitale della Laconia, nel Peloponneso. Nel X sec. a.C. i Dori,
penetrati nel Peloponneso, crearono 5 insediamenti (Limne, Pitane, Mesoa, Cinosura e
Amicle), unificati dal re Teleclo nel sec. VIII nella città di Sparta. Nei secc. VIII-VI a.C. gli
Spartani conquistarono l'intera Messenia, nella parte orientale del Peloponneso. Dopo la
Messenia, Sparta cercò di conquistare la regione di Tegea, ma, non essendovi riuscita dopo
lunghi combattimenti, fece in modo che divenisse sua alleata. Attraverso le alleanze Sparta
formò, nella seconda metà del VI sec. a.C., la Lega peloponnesiaca, che univa la maggior
parte delle poleis della penisola con l'eccezione di Argo. Le città alleate conservavano la loro
autonomia e non pagavano tributi; avevano il solo obbligo di fornire l'esercito federale in caso
di pericolo, sottostando al comando spartano. La Lega dette un contributo decisivo alla
sconfitta di Serse nella II Guerra persiana, dopo la quale Sparta non seguì Atene nel tentativo
di sottrarre al dominio persiano le città greche dell'Asia. Lo scontro con Atene per l'egemonia
caratterizzò il V sec. a.C.: la Guerra del Peloponneso (431-404 a.C.) sancì il predominio di
Sparta che durò fino all'ascesa di Tebe la quale sconfisse la rivale con i generali Pelopida ed
Epaminonda nel 364 e 361 a.C. Durante il dominio macedone Sparta rimase in disparte, per
rientrare nella politica greca nell'età dei diadochi, con il rango di potenza minore.
La società spartana. Tutta la popolazione era suddivisa nelle tre classi degli spartiati, dei
perieci e degli iloti. I primi costituivano la casta militare: unici a godere dei pieni diritti
politici, erano obbligati alla vita comunitaria, con la proibizione di qualsiasi attività produttiva
e del possesso personale di denaro. La loro educazione militare era molto severa, aveva inizio
all'età di sette anni e terminava a trenta, ma fino a sessanta gli spartiati dovevano sottostare
agli obblighi militari. I perieci erano cittadini liberi, ma erano esclusi dal servizio militare e
quindi privi di diritti politici attivi; si dedicavano alle attività commerciali. Gli iloti erano di
condizione servile, seppur non propriamente schiavi in quanto non soggetti a vendita, e
lavoravano le terre di proprietà degli spartiati con l'obbligo di cedere ai padroni due terzi del
raccolto.
L'ordinamento politico. La tradizione fa risalire la struttura costituzionale di Sparta
all'attività legislativa di Licurgo (ca. secc. VIII-VII a.C.). Istituzionalmente il potere
esecutivo era affidato a due re (diarchia) affiancati dalla gherusia, il consiglio di anziani che
discuteva le questioni poi sottoposte all'assemblea generale degli spartiati, l'apella. Dalla fine
del sec. VI a.C. le funzioni giuridiche vennero affidate a 5 efori, ossia “ispettori” eletti
dall'apella.
5
ATENE
Attorno al centro di Atene, capitale dell'Attica, era avvenuta in epoca tardomicenea
l'unificazione dei centri minori della regione (o sinecismo, da syn, “insieme” e oikéo, “abito”),
ascritta dalla tradizione al re Teseo.
L'Atene arcaica e aristocratica. Dopo una fase arcaica di regime monarchico, seguì nel sec.
VIII a.C. un governo aristocratico, che ebbe inizialmente la sua magistratura principale negli
arconti. Inizialmente erano tre, con le funzioni rispettivamente di sacerdote, capo dell'esercito
e magistrato esecutivo e duravano in carica 10 anni; in seguito furono portati a 9 ed eletti
annualmente. Usciti di carica, gli arconti diventavano membri dell'areopàgo, organo che
vigilava sugli altri magistrati e giudicava i reati di sangue. Al 624 a.C. risale la prima
codificazione di leggi ateniese, a opera di Dracone.
Da Solone a Clistene. I secc. VII e VI a.C. furono percorsi da forti tensioni sociali e crisi
agrarie, con un contrasto tra coltivatori e aristocrazia fondiaria. Solone, arconte nel 594-593
a.C. intervenne in favore dei piccoli contadini: annullò i debiti e introdusse un sistema politico
di tipo timocratico, basato cioè su classi di reddito. L'opera di Solone fu un passo verso la
democrazia, ma i contrasti riesplosero e portarono alla tirannide di Pisistrato (560 a.C.). Sotto
di lui ad Atene si sviluppò la piccola proprietà, prosperarono i commerci e si ebbe un periodo
di benessere. I suoi successori, i figli Ippia e Ipparco, accentuarono invece una pratica
personale del potere, portando in evidenza gli elementi di degrado insiti nel regime tirannico.
L'uccisione di Ipparco e l'espulsione di Ippia da Atene nel 510 a.C. furono opera soprattutto di
aristocratici fuoriusciti che intendevano riconquistare il potere. Una soluzione politica che
accontentava le classi medie fu proposta da Clistene (arconte nel 508-507 a.C.), che, con
riforme radicali, avviò Atene a un assetto costituzionale decisamente democratico, su base
quasi esclusivamente territoriale, con magistrature assegnate tramite un'articolata
combinazione di elettività e sorteggio (solo la carica di stratega, che richiedeva provata
competenza militare, restava esclusivamente elettiva), capace di garantire a tutti i cittadini la
partecipazione alla vita politica.
L'imperialismo ateniese. La democrazia ateniese, rapidamente consolidatasi, subì un
rovescio quando appoggiò la rivolta delle città elleniche della Ionia (la zona dell'Asia Minore
che si affaccia sull'Egeo: 499-494 a.C.). Essa assunse un ruolo guida per l'intera Grecia nelle
due Guerre persiane (490 e 480-479 a.C.), causa peraltro di sempre maggiori attriti con
Sparta. La vittoria sui Persiani segnò l'inizio di un fervido cinquantennio detto pentecontetìa.
Nel 477 a.C. Atene entrò a far parte della Lega delio-attica al cui interno assunse l'egemonia
politico-economica. Il controllo sull'organizzazione dei tributi, l'introduzione della moneta
ateniese nelle città soggette, l'appoggio dato ai regimi democratici indicano il livello
raggiunto dalla potenza della città. Protagonista di questi anni e promotore dello sviluppo
economico, politico e artistico-culturale fu Pericle, presidente del collegio degli strateghi per
diversi anni. Nel 431 a.C. i due sistemi, ateniese e spartano, entrarono in un rovinoso conflitto
che si protrasse per 27 anni e dal quale Atene uscì sconfitta e rovinata demograficamente ed
economicamente. Per un anno fu soggetta a un regime oligarchico filospartano (i Trenta
tiranni).
Dall'età ellenistica ai Romani. Nel sec. IV a.C. Atene riprese vigore e svolse una politica di
equilibrio, prima appoggiando Tebe che contrastava il dominio di Sparta, poi, dopo
l'affermazione del primato di Tebe (battaglia di Leuttra, 371 a.C.), legandosi alla potenza
dorica. L'opposizione contro l'espansionismo macedone naufragò a Cheronea (338 a.C.).
Sotto l'influenza macedone e poi sotto il dominio romano, rimase un grande centro di cultura,
celebrato fino alla tarda antichità.
6
LE GUERRE PERSIANE
INTRODUZIONE
Mentre Atene e Sparta andavano consolidando il loro potere in Grecia, l'Impero persiano
espandeva i suoi confini, comprendendo tutta l'Asia Minore e volgendosi verso l'Europa. Il re
Dario I aveva già occupato la Tracia e stabilito rapporti con la Macedonia. La presenza dei
Persiani costituiva un problema per i commerci e la navigazione delle poleis greche lungo le
coste asiatiche. Il desiderio di Dario era quello di costruire un grande Impero e ottenere la
supremazia su tutte le civiltà conosciute. Nel 499 a.C. Dario aveva tentato di conquistare,
senza riuscirvi, Nasso, una città delle isole Cicladi. Questo episodio mise in fermento le altre
città ioniche, colonie greche, che si ribellarono ai Persiani, appoggiate da Atene. Domata la
rivolta dopo sette anni, Dario si propose di sottomettere l'intera Grecia. Ebbe così inizio il
conflitto che tra il 490 e il 449 a.C. oppose Greci e Persiani. Per questa lotta le città greche
abbandonarono i conflitti interni e insieme affrontarono il comune nemico.
IL CONFLITTO
La rivolta delle città ioniche fu capeggiata da Aristagora, tiranno di Mileto, che confidava
nell'aiuto degli stati greci. Solo Atene ed Eretria intervennero con un piccolo corpo di
spedizione, ma la potenza persiana riuscì ad avere la meglio. Dopo la rivolta, nel 492 a.C.,
Dario inviò contro Atene ed Eretria una spedizione punitiva che ebbe esito negativo.
La prima spedizione persiana e la battaglia di Maratona. In seguito Dario invitò le cittàStato greche a sottomettersi a lui, minacciando di portare loro guerra. Quasi tutte le città, tra
cui Tebe, accettarono la richiesta. Atene, decisa l'alleanza con Sparta, affidò il comando
dell'esercito allo stratega Milziade. Nella primavera del 490 a.C. Dario portò la guerra in
Grecia. I Persiani dapprima ebbero la meglio, sottomettendo le Cicladi e la città di Eretria
nell'Eubea. Sbarcati a Maratona, però, dopo essersi accampati, si videro venire incontro le
truppe di Milziade che avevano chiesto aiuto a Sparta. Quando i Persiani seppero che si era
mosso anche l'esercito spartano, attaccarono gli Ateniesi che non si lasciarono sorprendere e a
loro volta contrattaccarono, portando a termine vittoriosamente la battaglia. Il generale
persiano Dati pensò di attaccare Atene, sguarnita, con la flotta, ma Milziade fece in tempo a
riportare indietro l'esercito e a sventare l'attacco. Dopo aver liberato le Cicladi, Milziade
ottenne l'incarico di una spedizione navale che però fallì. Tornato in patria, venne denunciato
dai suoi avversari politici con l'accusa di aver tradito il popolo e, incarcerato, morì per le ferite
riportate durante un combattimento.
La seconda spedizione. Alla morte di Dario, il figlio Serse iniziò i preparativi per una nuova
spedizione. Organizzò un esercito di circa 200 000 soldati e oltre 700 navi. Nel frattempo
anche Atene aveva rafforzato la potenza militare. Temistocle, arconte nel 483 a.C., fortificò il
Pireo e fece costruire una nuova flotta. Tutta la Grecia era preoccupata dei preparativi di
Serse; Atene e Sparta riconfermarono la loro alleanza e, con altre 29 città-Stato, costituirono
la Lega panellenica nel 480 a.C. Il comando dell'esercito fu affidato allo spartano Leonida.
Nella primavera del 480 Serse si mosse puntando velocemente verso Atene. L'esercito greco
lo aspettava alle Termopili. Leonida, in attesa di rinforzi, riuscì a resistere per breve tempo,
poi, vistosi sopraffatto, mandò indietro molti dei suoi uomini e rimase a combattere
strenuamente con meno di mille soldati, fino alla sconfitta. Questo sacrificio ritardò l'avanzata
dei Persiani e rafforzò la volontà di combattere dei Greci. Temistocle ottenne che Atene fosse
sgombrata, fece riparare il popolo sull'isola di Salamina e lasciò che la città fosse devastata.
Si preparò però a difendere la Grecia con la flotta, appostata davanti al Pireo. La flotta
7
persiana cercò di penetrare in questo braccio di mare ma le navi greche, più agili, ebbero la
meglio. Serse si ritirò ma programmò una nuova invasione per l'anno seguente. Nel 479 a.C.,
però, l'esercito persiano che era rimasto in Tessaglia fu sconfitto a Platea dal re spartano
Pausania. La flotta greca, invece, sconfisse contemporaneamente quella persiana a Micale,
liberando le isole egee.
La ripresa del conflitto. Dopo la vittoria sui Persiani, tornarono a manifestarsi in Grecia le
rivalità tra le fazioni democratiche capeggiate da Atene e conservatrici sostenute da Sparta.
Quando Sparta, avendo allontanato Pausania per il suo atteggiamento autoritario, rinunciò al
comando della flotta della Lega panellenica, Temistocle ne approfittò per per proporsi quale
suo ammiraglio. Nel 477 a.C. assunse anche la guida della Lega navale attica che venne detta
delio-attica. Temistocle condusse una politica antispartana, appoggiando le rivolte di alcune
città, ribelli alle antiche alleanze con Sparta, e accordandosi con i Persiani per un periodo di
tregua. L'opposizione interna riuscì però a esercitare l'ostracismo nei confronti di Temistocle,
il quale morì esule presso la corte del re persiano. Ad Atene gli subentrò Cimone, figlio di
Milziade, favorevole alla pace con Sparta. Egli riprese anche la guerra contro i Persiani,
liberando la Tracia meridionale (470 a.C.). Internamente, non era gradita la politica moderata
e filo-spartana di Cimone; guadagnava sempre più consenso il democratico radicale Pericle.
In seguito a una insurrezione della Messenia, Cimone inviò aiuti a Sparta, ma questa dopo
pochi mesi rimandò a casa i soldati ateniesi. Cimone fu colpito dall'ostracismo. Nel 460 a.C.
salì al potere Pericle. Questi riprese le ostilità con la Persia, richiamando Cimone dall'esilio e
affidandogli il comando della flotta. Nonostante la morte del loro comandante, gli Ateniesi
riportarono una grande vittoria a Salamina Ciprica nel 449 a.C. Ci si avviò così finalmente
alla pace le cui trattative furono condotte dall'ateniese Callia (Pace di Callia nel 449 a.C.).
Le sorti dell'Impero persiano dopo la sconfitta. Persa la lunghissima battaglia con la
Grecia, l'Impero persiano conobbe la crescente crisi del potere centrale e la debolezza
dell'economia. Sopravvisse fino a quando non fece la sua avanzata Alessandro Magno, con il
grande esercito macedone. La Persia perse la sua indipendenza politica e si avviò un processo
di simbiosi con il mondo greco.
8