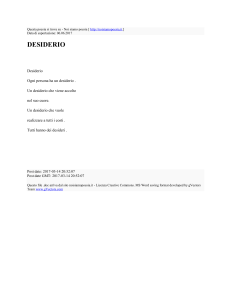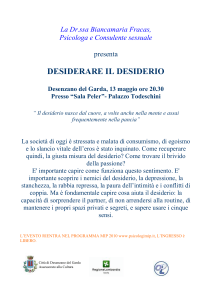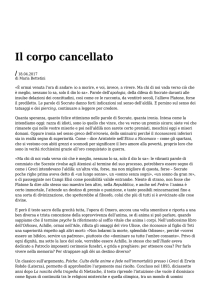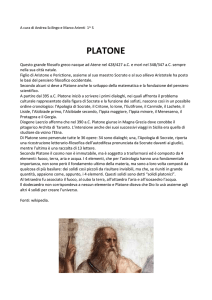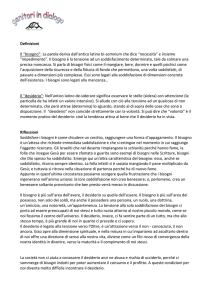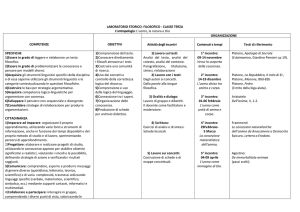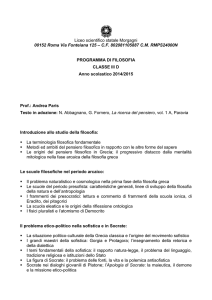VITA E OPERE DI PLATONE
Labirinti dell’Anima 2015 2016
FEDRO
di Platone
Versione scenica e regia Nuvola de Capua
Libretto di sala a cura di Claudia Braida
Venerdì 29 gennaio 2016
Ore 21.00
Platone nasce Intorno al 428 a.C. da famiglia ricca e di antica nobiltà: IL
suo vero nome è Aristocle e il nomignolo con cui diverrà
universalmente noto gli verrà dato, sembra, dal maestro di ginnastica,
per l’ampiezza delle spalle e della figura (plátos in greco significa
“ampiezza”). Divenuto a vent’anni allievo di Socrate, rimane con il
maestro fino alla morte di lui, nel 399 a.C., lasciando poi Atene,
profondamente segnato dall’esperienza del processo e della condanna
della propria guida filosofica. Dopo un soggiorno a Megara, viaggia
molto, sicuramente anche in Egitto e nella Magna Grecia, dove consce il
pitagorico Archita di Taranto. Lascia di nuovo Atene nel 388 a.C. per il
primo dei numerosi viaggi a Siracusa, dove tenta di indurre il tiranno
Dionigi I a realizzare il modello di Stato che va elaborando, anche grazie
all’appoggio del cognato di Dionigi, Dione, che diviene suo allievo.
Fallito questo primo tentativo, Torna ad Atene, fondandovi l’Accademia
(dall’eroe di guerra Academo, che aveva donato agli ateniesi un
terreno, divenuto giardino aperto al pubblico, dove Platone filosofava
con i suoi discepoli). Nel 367 a.C., dopo la morte di Dionigi I, fa ritorno a
Siracusa sperando di realizzare il proprio progetto politico con il nuovo
tiranno, Dionigi II, anche questa volta senza successo. Il terzo viaggio a
Siracusa, nel 361 a.C., rischia
addirittura
di
concludersi
tragicamente per l’ostilità di
Dionigi II che minaccia di
imprigionarlo,
e
soltanto
l’intervento di Archita di Taranto
gli consente di fare ritorno ad
Atene,
dove
si
dedica
all’insegnamento nell’Accademia
fino alla sua morte, avvenuta nel 347 a.C.
L’insieme degli scritti attribuiti a Platone si compone di 36 opere: 35
dialoghi e di una raccolta di 13 lettere, di cui solo una sicuramente
autentica. La classificazione delle opere principali può essere così
riassunta:
1. Dialoghi giovanili, o “socratici”, scritti fra il 395 e il 388 a.C.: Apologia
di Socrate, Critone, Ione, Eutifrone, Carmine, Lachete, Liside, Alcibiade
primo, Alcibiade secondo, Ippia maggiore, Ippia minore, Repubblica
libro I, Protagora, Gorgia, Menesseno, Cratilo, Eutidemo;
2. Dialoghi della maturità, scritti fra il 387 e il 367 a.C.: Menone, Fedone,
Simposio, Repubblica libri II-X, Fedro;
3. Dialoghi della vecchiaia, o “dialettici”, scritti dopo il 365 a.C.:
Parmenide, Teeteto, Sofista, Politico, Filebo, Timeo, Crizia, Leggi
(incompiuto).
perdersi in esercizi di recitazione fini a se stessi, si impegnano a
restituire ai personaggi la freschezza e l’intensità che li
contraddistinguono.
Al centro della scena un incontro, quello tra il giovane Fedro, assetato
di conoscenza ed entusiasta del mondo, e il maestro-amico Socrate, che
sa di non sapere ma ha fatto della ricerca il senso della propria
esistenza. In una giornata tiepida e luminosa, che invita ad uscire dalle
mura della città per godere colori e profumi della natura, all’ombra
delle fronde di un alto platano avviene lo scambio di pensieri, emozioni,
desideri, visioni che porta i due amici ad affrontare i grandi temi della
filosofia platonica. In questo senso si potrebbe definire il “Fedro”
un’esperienza di iniziazione dell’anima: all’eros, alla bellezza, al dialogo,
alla scrittura. In una parola, alla vita.
FEDRO
Quello che Nuvola De Capua ha condotto con il testo platonico è stato
un vero e proprio ‘corpo a corpo’, un lavoro di scavo, di perforazione
della parola originaria del filosofo alla ricerca dei significati più veri,
capaci di far pensare e vibrare ancor oggi il lettore e lo spettatore.
Questo lavoro drammaturgico si inserisce all’interno del percorso che
ormai da anni la regista conduce su alcuni dei più famosi dialoghi di
Platone, sviluppando in modo assolutamente personale l’eredità
artistica di Carlo Rivolta: “Apologia di Socrate”, “Critone”, “Fedone”,
“Simposio” e ora anche “Fedro”, fanno risuonare ancora oggi la voce
della sapienza socratica, perché
raggiunga e scuota giovani e
meno giovani. L’analisi e
l’interpretazione attente di ogni
pagina nascono anche dal
confronto che Nuvola De Capua
intrattiene costantemente con i
suoi attori, Luciano Bertoli e
Davide Grioni; essi, lungi dal
DAL TESTO
“Si raffiguri l’anima come la potenza
d’insieme d’una pariglia alata e di un auriga.
Ora, tutti i corsieri degli dei sono buoni e di
buona razza, ma quelli degli uomini sono un
po’ sì e un po’ no: L’auriga conduce la pariglia
e, dei due corsieri, uno è nobile e buono
mentre l’altro è tutto il contrario. Così
l’anima spazia nell’alto e governa il mondo;
ma quando un’anima perda le ali, essa
precipita fino a che non s’appiglia a qualcosa
di solido, dove si accasa, e assume un corpo
di terra che sembra si muova da solo, per
merito della potenza dell’anima. Questa
complessa struttura d’anima e di corpo fu chiamata essere vivente. […]
Solo la bellezza sortì questo privilegio, di essere la più percepibile dai
sensi e la più amabile di tutte le essenze. Così, chi abbia goduto di una
lunga visione lassù, quando scorga un volto d’apparenza divina, o una
qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, subito
rabbrividisce e rimirando questa bellezza la venera come divina; gli
subentra un sudore e un’accensione insolita perché, man mano che i
suoi occhi assorbono l’effluvio di bellezza, egli s’accende e col calore si
nutre la natura dell’ala. Affluendo il nutrimento essa diviene turgida e
lo stelo dell’ala riceve impulso a crescere su dalla radice, investendo
l’intera sostanza dell’anima.
Ecco, questo l’anima patisce quando cominciano a spuntarle le ali:
palpita, s’irrita e prova tormento mentre le spuntano. Quando dunque
contemplando la bellezza di un giovane, l’anima riceve le particelle che
da quello partono e scorrono (perciò si chiama ‘fiume di desiderio’), se
ne nutre, se ne riscalda, cessa l’affanno e gioisce. Ma quando sia
separata da quella bellezza l’anima inaridisce e le aperture attraverso
cui spuntano le penne disseccandosi si contraggono, sì da impedire i
germogli dell’ala. Poi, riassalendola il ricordo della bellezza, ringioisce.
Così, sovrapponendosi questi due sentimenti, l’anima se ne sta smarrita
per la stranezza della sua condizione e, non sapendo che fare, smania e
fuor di sé non trova sonno di notte né riposo di giorno, ma corre là
dove spera di poter rimirare colui che possiede la bellezza. […]
Questo patimento dell’anima, mio bell’amico, è ciò che gli uomini
chiamano amore”.
Platone, Fedro, in Opere complete, ed. Laterza
DIALOGO, DOXA E MAIEUTICA IN SOCRATE
Anche se è più che probabile che Socrate sia stato il primo a usare
sistematicamente il dialeghesthai (il discutere di qualcosa con
qualcuno), probabilmente, al contrario di Platone, non lo considerò
l’opposto e neanche la controparte della persuasione, e di certo non
contrappose i risultati di questa sua dialettica alla doxa, l’opinione. Per
Socrate, così come per i suoi concittadini, la doxa riguardava la
comprensione del mondo così come “si apre a me”. Non era fantasia
soggettiva e puro arbitrio, ma neanche qualcosa di assoluto e valido per
tutti. L’assunto era che il mondo si apre in modo diverso a ogni essere
umano, a seconda della posizione che ciascuno occupa in esso. La
“medesimezza” del mondo, il suo essere-in-comune (koinon, in greco:
comune a tutti), ovvero la sua ‘obiettività’, come diremmo noi nella
prospettiva soggettivistica della filosofia moderna, risiede nel fatto che
lo stesso mondo si apre a ognuno e che, malgrado tutte le differenze
tra gli uomini e tra le loro posizioni nel mondo, e di conseguenza tra le
loro doxai, “io e te, entrambi, siamo umani”. […]
Socrate chiamava maieutica, arte dell’ostetricia,
quella che più tardi Platone avrebbe chiamato
dialeghesthai. Voleva infatti aiutare gli altri a
partorire i loro pensieri, voleva aiutarli a trovare
la verità nella doxa. Questo metodo traeva il
proprio significato da un duplice convincimento.
Ogni essere umano ha la propria doxa, la
propria apertura al mondo, e per questo Socrate
doveva sempre cominciare con delle domande:
non potendo sapere in anticipo quale fosse il “mi pare” dell’altro,
faceva appunto delle domande per capire la posizione del suo
interlocutore nel mondo comune. D’altra parte, proprio come nessuno
può conoscere in anticipo la doxa altrui, così nessuno può conoscere da
solo, e senza sforzo ulteriore, la verità inerente alla propria opinione.
Socrate voleva portare alla luce la verità che ognuno potenzialmente
possiede. Se restiamo fedeli alla sua stessa metafora, la metafora della
maieutica, possiamo dire che Socrate voleva rendere la città più
veritiera facendo partorire a ogni cittadino la propria verità. Il metodo
per farlo è il dialeghesthai, ma quest’arte dialettica, che porta alla luce
la verità, non distrugge la doxa, l’opinione; al contrario, ne rivela la
veridicità. Il compito del filosofo, allora, non è quello di governare la
città, ma è quello di essere il suo “tafano”, di rendere i cittadini più
veritieri. […]
Questa modalità di dialogare, che non ha bisogno di una conclusione
per avere un significato, è la modalità più frequente e appropriata del
discorso tra amici. L’amicizia, in effetti, consiste in larga misura in
discussioni di questo tipo, riguardanti qualcosa che sta “tra” gli amici,
qualcosa che gli amici hanno “in comune”. Per il semplice fatto di
discuterne, quel qualcosa che sta tra loro diviene ancora più comune.
Non solo guadagna una sua specifica articolazione ma si sviluppa e si
espande, finché, con il passare del tempo e della vita, giunge a formare
un piccolo mondo a parte, che viene condiviso in amicizia. In altri
termini, politicamente parlando, Socrate cercò di fare dei cittadini
ateniesi degli amici.
H. Arendt, Socrate, ed. Laterza
IL DELIRIO DEL DESIDERIO
Possiamo chiederci senza troppi giri di parole: quando diciamo
“desiderio”, che genere di esperienza evochiamo? Di che cosa si tratta,
cosa è in gioco nell’esperienza umana del desiderio? Qual è il suo tratto
costitutivo?
Possiamo provare a fissare questa radice – che accomuna tutte le
diverse versioni del desiderio – nell’esperienza di sentirsi superati.
Questo significa che ogni volta che si dà esperienza del desiderio “io”
mi sento spossessato dal governo
sicuro di me stesso, mi sento
portato da una forza che mi
oltrepassa, che oltrepassa il
potere di governo e di controllo
dell’Io. Non è superfluo ricordare
che il desiderio di cui la
psicoanalisi parla non va confuso
con la motivazione o con il
controllo dell’intenzione. Questo
desiderio è inconscio, non è una proprietà del soggetto, non viene
all’esperienza a partire da un atto della volontà, non è determinato
dall’Io. Piuttosto, il desiderio in quanto desiderio inconscio, implica
sempre che “io”, o meglio l’Io, non ne sia mai il proprietario, il
detentore esclusivo. L’esperienza del desiderio è infatti un’esperienza
di perdita di padronanza, di vertigine, di qualcosa che si dà a me stesso
come “più forte” della mia volontà. Il desiderio in quanto forza che mi
supera non è qualcosa che “io” posso governare, non è a mia
disposizione, a disposizione del mio Io, ma è piuttosto l’esperienza di
uno scivolamento, di un inciampo, di uno sbandamento, di una perdita
di padronanza, di una caduta dell’Io. Il desiderio viene all’esperienza
come qualcosa che turba il mio Io e tutte le sue convinzioni consolidate.
Per questa ragione, l’elemento che accomuna i diversi ritratti del
desiderio consiste nella sua esorbitanza rispetto all’Io. Lo possiamo
affermare in modo radicale: non sono mai “io” che decido il “mio”
desiderio, ma è il desiderio che decide di me, che mi ustiona, mi
sconvolge, mi rapisce, mi entusiasma, mi inquieta, mi anima, mi strazia,
mi potenzia, mi porta via. L’esperienza del desiderio è l’esperienza di
una forza in eccesso, di una forza che proviene da me ma che trascende
l’Io che “io” (mi) credo di essere. Il desiderio è una potenza che
sovrasta e decentra l’Io. Per questa ragione Lacan associa sempre il
termine “desiderio” alla figura dell’Altro.
L’esperienza del desiderio non si può confinare, restringere, assimilare
a quella dell’Io-padrone, non è mai esperienza dell’identico, di ciò che
Io penso di essere, non è esperienza autoreferenziale e narcisistica
dell’Io. L’esperienza del desiderio è sempre esperienza di un’alterità e,
dunque, porta con sé sempre una quota di perdita dell’identità, una
disidentità, una non coincidenza, Lacan direbbe una divisione del
soggetto. Proviamo a dirlo ancora meglio: l’esperienza del desiderio non
è dell’Io ma è senza Io. Questo significa che il desiderio non è ciò che
rafforza l’identità irrigidendo i suoi confini, non è il cemento
dell’identità, ma è piuttosto ciò che la scompagina, la destabilizza, è un
fattore di perturbazione dell’identità.
M. Recalcati, Ritratti del desiderio, ed. Cortina