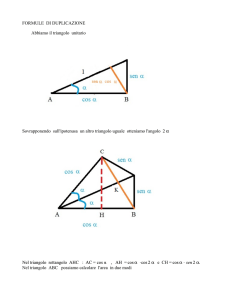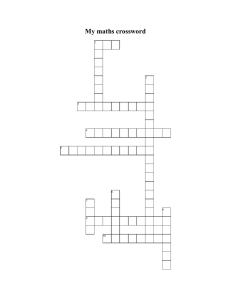VII
LE IDEE, ESSERE, VERITA', VALORE
Gorgia aveva sostenuto che non esiste alcuna realtà oggettiva; che se anche
esistesse, non sarebbe accessibile al nostro pensiero; che se anche lo fosse, non
sarebbe esprimibile nel linguaggio, per la radicale eterogeneità fra parola e
cosa. Veniva cosí negata ogni pretesa di verità del discorso; ogni forma di
discorso – compreso quello “scientifico” – non era che una variante della
persuasione retorica, intesa a produrre azioni e non conoscenze. Protagora dal
canto suo aveva argomentato la tesi che il soggetto (individuale o collettivo) è
l’unico “criterio” di descrizione e di valutazione dello stato e del valore delle
cose (qualcosa è “giusta” nella misura in cui appare tale a qualcuno, e finché gli
appare tale). La verità protagorea consisteva dunque nel negare che esistesse
alcuna verità oggettiva sul mondo e sui valori al di fuori delle opinioni che i
soggetti avevano intorno ad essi; il “criterio” per discriminare fra opinioni rivali
era anche qui di tipo pragmatico, consistendo nel valutare l’utilità di queste
opinioni in rapporto agli interessi dei soggetti che le condividevano.
Per Platone, gli argomenti di Gorgia e Protagora sarebbero risultati inconfutabili
se l’unica realtà esistente fosse quella che ci viene presentata dall’esperienza
sensibile. Il modo specifico di esistenza del mondo empirico è quello della
variabilità, dell’instabilità, dell’incessante deformazione spazio-temporale. Le
cose di questo mondo non sono mai identiche a se stesse perché mutano nel
tempo e perché le loro proprietà sono necessariamente relative; la conoscenza
che se ne può avere è dunque altrettanto instabile, opaca, condizionata dalla
soggettività della percezione e della valutazione.
Solo se fosse possibile individuare un livello di realtà diverso da quello
empirico – cioè dotato delle proprietà dell’invarianza, della univocità, della
trasparenza al pensiero – si potrebbero allora falsificare le tesi di Gorgia e di
Protagora, riaprendo un transito fra discorso, pensiero e verità, e sottrarre cosí le
nostre descrizioni e valutazioni del mondo ai vincoli del relativismo
soggettivistico, allo statuto della persuasione retorica, che essi avevano
imposto. Platone riteneva che la via di accesso a questo diverso livello di realtà
fosse implicita nella struttura del nostro linguaggio e che fosse inoltre
chiaramente indicata da un rilevante modello epistemico, quello offerto dai
saperi matematici – in primo luogo dalla geometria.
I teoremi della geometria costituiscono enunciati universali (non dipendono
cioè dalle opinioni soggettive) e necessari (cioè non controvertibili)
indipendentemente dalle circostanze in cui vengono dimostrati e dagli oggetti
materiali su cui viene condotta la dimostrazione. Il teorema di Pitagora non vale
soltanto per il triangolo disegnato dal matematico (che può essere grande o
piccolo, nero o rosso), anzi non vale propriamente per nessun triangolo
disegnato (ogni disegno presenta inevitabilmente imperfezioni che
falsificherebbero il teorema), bensí per il triangolo in generale nella sua
idealità. C’è dunque un “triangolo” per il quale il teorema è valido, diverso da
ogni sua rappresentazione empirica, che ne presenta le proprietà solo in modo
imperfetto. Questo “triangolo” possiede inoltre una proprietà interessante. Il suo
nome (“triangolo”) è convertibile perfettamente e senza residui nella sua
definizione (“figura con tre lati la somma dei cui angoli è uguale a 180°”). Il
triangolo ideale è sempre uguale a se stesso e non presenta alcuna variazione
nel tempo e nello spazio, e gli enunciati relativi ad esso non dipendono dalla
soggettività di chi li formula: sono perciò pienamente suscettibili di venire
giudicati oggettivamente veri o falsi.
Una generalizzazione del modello geometrico poteva, secondo Platone, venire
impiegata per mettere in luce la struttura soggiacente alle forme del linguaggio.
Noi formuliamo costantemente, intorno a cose e condotte, enunciati descrittivi o
valutativi del tipo: “Socrate” è giusto; “restituire i prestiti” è giusto; “obbedire
alla legge” è giusto. In generale, in questi enunciati noi applichiamo a una
pluralità di soggetti una stessa proprietà: (x) è F, (y) è F, (n) è F. Ora, nessuno di
questi soggetti è identico alla proprietà che gli viene attributa (Socrate non è “la
giustizia”), ognuno può possederla o meno (restituire un prestito o obbedire alla
legge in certe circostanze è ingiusto) e possiede inoltre altre proprietà (Socrate
può essere giovane o vecchio, vivo o morto e cosí via). Viceversa, in tutte questi
enunciati il predicato che viene attribuito a (x), (y), (n) risulta costante e
invariabile nel suo significato, cioè funge da standard universale di descrizione
o valutazione dei singoli soggetti cui viene attribuito: se questa attribuzione è
corretta (cioè vera) “Socrate”, “restituire i prestiti”, “obbedire alla legge”
risultano essere casi, o esempi (“istanziazioni”) della giustizia; se è falsa, no. Si
può dire allora che i predicati universali, del tipo “giusto”, “bello”
costituiscono nuclei di significato unitari e invarianti che possono venire riferiti
a una pluralità mutevole e instabile di soggetti e di circostanze.
Se tuttavia il loro contenuto potesse variare a seconda delle opinioni soggettive,
non si sarebbe ancora superata, secondo Platone, la minaccia del relativismo
sofistico. Questi predicati devono dunque venir pensati come descrizioni di un
referente primario, che possiede in modo oggettivo, assoluto e stabile la
proprietà che essi enunciano. Ogni F è dunque primariamente vero di un
oggetto Φ: la referenza di “giusto” è un oggetto che Platone chiamava “il giusto
in sé”, “la giustizia stessa” – insomma, l’idea (o la forma) di giustizia che ha
con le singole cose di cui si può predicare la proprietà della giustizia lo stesso
rapporto che il triangolo ideale dei matematici presenta con i singoli triangoli di
volta in volta disegnati.
Solo questo oggetto Φ possiede interamente, ed esclusivamente, la proprietà
descritta dal predicato F (solo l’idea di giustizia è perfettamente giusta e
nient’altro che giusta), dunque è immediatamente convertibile con quella
proprietà (se “giustizia” significa, secondo la definizione che Platone proponeva
nel libro IV della Repubblica, «fare ciò che spetta a ognuno», l’“idea di
giustizia” è descritta interamente, senza residui e senza possibili variazioni, da
questa definizione, cosí come l’“idea di triangolo” risulta perfettamente
convertibile con la definizione “figura con tre lati la somma dei cui angoli è
uguale a 180°”).
Platone riteneva che solo riferendo i predicati di tipo (F) in primo luogo a
oggetti ideali di tipo Φ fosse possibile uscire dal relativismo sofistico.
Platone escludeva – al contrario di quanto avrebbe fatto il pensiero moderno –
che le idee, cui si riferiscono predicati come “bello”, “grande” e cosí via,
potessero venir considerate come concetti o categorie interne al “pensiero”
(noemata): ogni pensiero, se è davvero tale, e non sogno o delirio, è sempre
pensiero di qualcosa, ha un referente esterno e oggettivo. Le idee dovevano
dunque essere per Platone enti ideali, oggetti autonomi, anche se i predicati che
ne esprimevano il significato costituivano in effetti norme o criteri di
descrizione o di valutazione del mondo, che noi impieghiamo quando diciamo
“questo albero è grande”, “Socrate è buono”, “questa azione è giusta”. Certo, il
modo di esistenza delle idee è diverso da quello delle cose (non si tratta, in altri
termini, di una sorta di “supercose”). L’idea di triangolo non è un triangolo
perfetto e l’idea di mela non è una mela eterna: si tratta piuttosto dell’insieme di
caratteri essenziali che rendono identificabili come tali, e diversi dalle altre
cose, ogni singolo triangolo e ogni singola mela. La forma di esistenza delle
idee è quella di criteri o norme di descrizione e valutazione vere degli oggetti e
delle azioni; nel caso delle idee, e solo nel loro caso, esistenza e verità
coincidono perfettamente.
C’è di piú. In virtú dell’“assioma di corrispondenza”, Platone riteneva che un
enunciato predicativo vero fosse quello che descrive una relazione reale tra
oggetti. Dire che “Socrate è buono”, “questa figura è un triangolo”, sarà vero
nel caso esista un rapporto fra gli enti (empirici) “Socrate”, “questo disegno” e
gli enti (ideali) “buono”, “triangolo”, falso se non esiste. Ma che cosa significa
questa relazione fra enti di livello ontologico diverso? Per risolvere questo
problema, Platone formulò uno dei suoi teoremi piú problematici, quello della
“partecipazione” (methexis) tra cose e idee. Le cose “partecipano” delle idee
che le descrivono e le valutano, sono in “comunanza” (koinonia) con esse; c’è,
in altri termini, una “presenza” (parousia) delle idee nelle cose. Per pensare il
rapporto di “partecipazione”, e il ruolo causale delle idee nel suo ambito (l’idea
di giustizia deve essere in qualche modo la causa del fatto che “Socrate è
giusto”, perché solo partecipando ad essa egli diventa tale), Platone introduceva
la nozione del rapporto fra “modello”, o “paradigma”, e “copia”. Le idee
venivano dunque concepite come modelli di cui le singole istanziazioni
empiriche risultavano riproduzioni o appunto “copie”, inevitabilmente
imperfette e instabili. Questo schema di pensabilità appariva dotato di
soddisfacenti capacità esplicative in molte situazioni – appunto quelle nel cui
ambito si era venuta costituendo la “teoria delle idee”. Si può dire ad esempio
che il geometra, quando disegna un triangolo, rende visibile il modello solo
pensabile del triangolo ideale, ne fa una “copia”. Si può dire che quando
costruisce un tavolo di legno, il falegname si ispira al modello ideale di
“tavolo”, trasferendolo nella materia. Si può dire, ancora, che il buon politico,
quando traccia la costituzione della città, ha di mira l’idea di giustizia, che tenta
di realizzare nelle circostanze storiche in cui opera.
Platone era categorico nel sostenere che il carattere proprio del filosofo degno
di questo nome doveva consistere nella «conoscenza di ogni cosa che è»,
dell’«essenza di ogni cosa», cioè di ogni idea. Era proprio da questa conoscenza
che il filosofo traeva la legittimazione del suo diritto al governo, perché grazie
ad essa egli poteva riferirsi a idee come il “giusto” e il “buono” valendosene
come di “paradigmi” e criteri per istituire le sue leggi nel mondo storicopolitico.