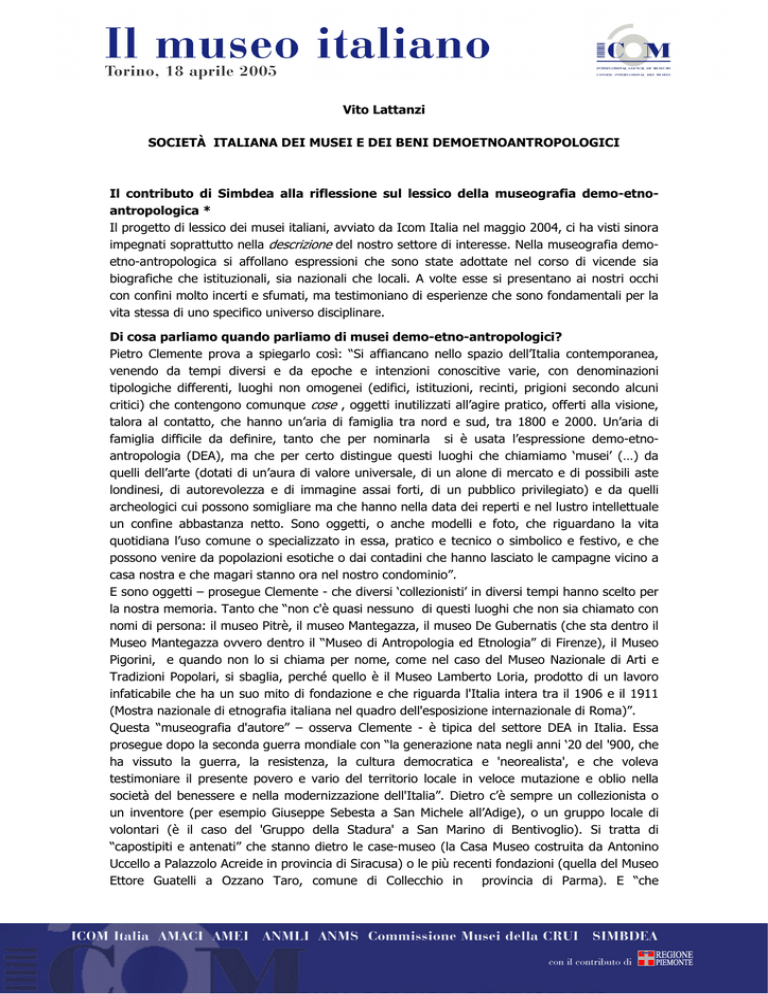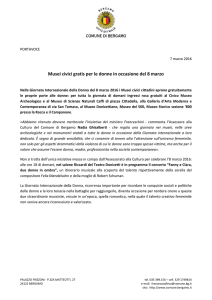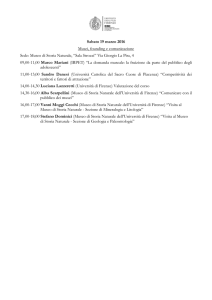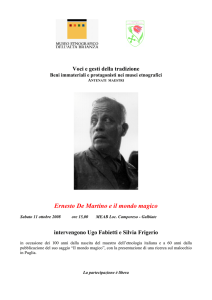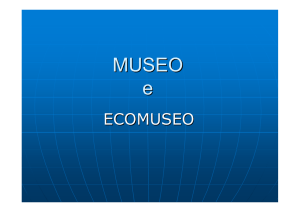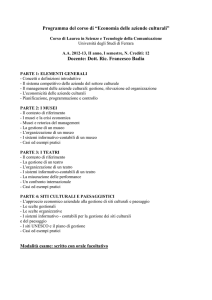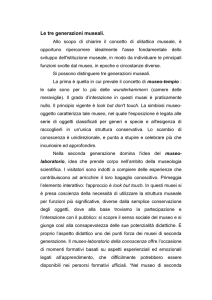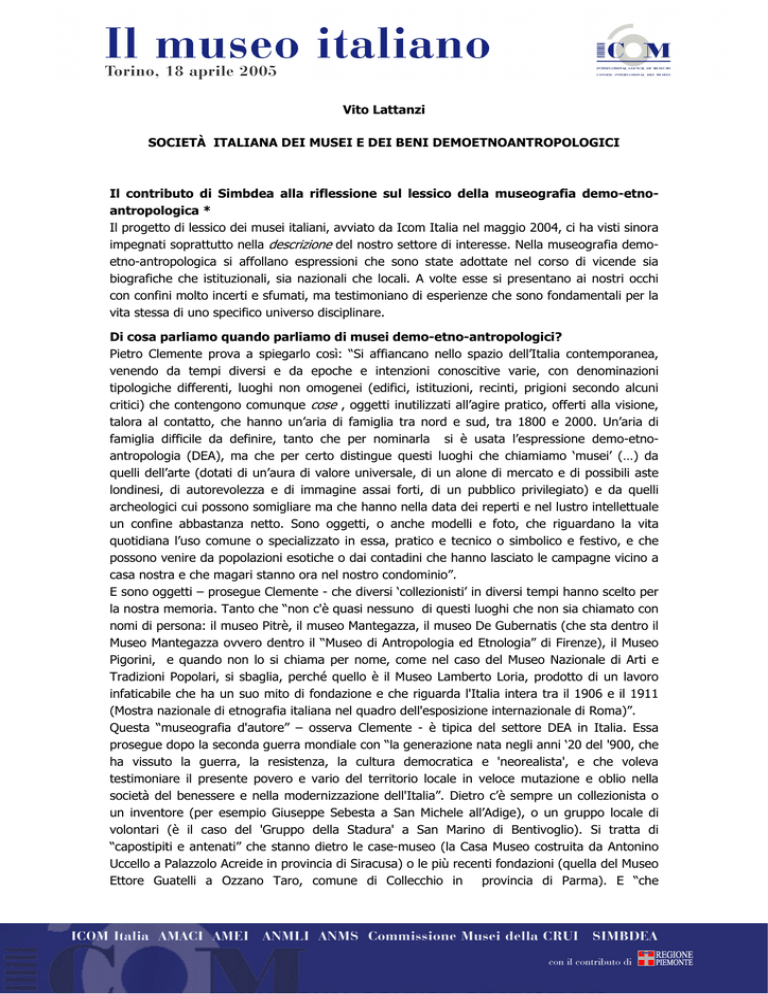
Vito Lattanzi
SOCIETÀ ITALIANA DEI MUSEI E DEI BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI
Il contributo di Simbdea alla riflessione sul lessico della museografia demo-etnoantropologica *
Il progetto di lessico dei musei italiani, avviato da Icom Italia nel maggio 2004, ci ha visti sinora
impegnati soprattutto nella descrizione del nostro settore di interesse. Nella museografia demoetno-antropologica si affollano espressioni che sono state adottate nel corso di vicende sia
biografiche che istituzionali, sia nazionali che locali. A volte esse si presentano ai nostri occhi
con confini molto incerti e sfumati, ma testimoniano di esperienze che sono fondamentali per la
vita stessa di uno specifico universo disciplinare.
Di cosa parliamo quando parliamo di musei demo-etno-antropologici?
Pietro Clemente prova a spiegarlo così: “Si affiancano nello spazio dell’Italia contemporanea,
venendo da tempi diversi e da epoche e intenzioni conoscitive varie, con denominazioni
tipologiche differenti, luoghi non omogenei (edifici, istituzioni, recinti, prigioni secondo alcuni
critici) che contengono comunque cose , oggetti inutilizzati all’agire pratico, offerti alla visione,
talora al contatto, che hanno un’aria di famiglia tra nord e sud, tra 1800 e 2000. Un’aria di
famiglia difficile da definire, tanto che per nominarla si è usata l’espressione demo-etnoantropologia (DEA), ma che per certo distingue questi luoghi che chiamiamo ‘musei’ (…) da
quelli dell’arte (dotati di un’aura di valore universale, di un alone di mercato e di possibili aste
londinesi, di autorevolezza e di immagine assai forti, di un pubblico privilegiato) e da quelli
archeologici cui possono somigliare ma che hanno nella data dei reperti e nel lustro intellettuale
un confine abbastanza netto. Sono oggetti, o anche modelli e foto, che riguardano la vita
quotidiana l’uso comune o specializzato in essa, pratico e tecnico o simbolico e festivo, e che
possono venire da popolazioni esotiche o dai contadini che hanno lasciato le campagne vicino a
casa nostra e che magari stanno ora nel nostro condominio”.
E sono oggetti – prosegue Clemente - che diversi ‘collezionisti’ in diversi tempi hanno scelto per
la nostra memoria. Tanto che “non c'è quasi nessuno di questi luoghi che non sia chiamato con
nomi di persona: il museo Pitrè, il museo Mantegazza, il museo De Gubernatis (che sta dentro il
Museo Mantegazza ovvero dentro il “Museo di Antropologia ed Etnologia” di Firenze), il Museo
Pigorini, e quando non lo si chiama per nome, come nel caso del Museo Nazionale di Arti e
Tradizioni Popolari, si sbaglia, perché quello è il Museo Lamberto Loria, prodotto di un lavoro
infaticabile che ha un suo mito di fondazione e che riguarda l'Italia intera tra il 1906 e il 1911
(Mostra nazionale di etnografia italiana nel quadro dell'esposizione internazionale di Roma)”.
Questa “museografia d'autore” – osserva Clemente - è tipica del settore DEA in Italia. Essa
prosegue dopo la seconda guerra mondiale con “la generazione nata negli anni ‘20 del '900, che
ha vissuto la guerra, la resistenza, la cultura democratica e 'neorealista', e che voleva
testimoniare il presente povero e vario del territorio locale in veloce mutazione e oblio nella
società del benessere e nella modernizzazione dell'Italia”. Dietro c’è sempre un collezionista o
un inventore (per esempio Giuseppe Sebesta a San Michele all’Adige), o un gruppo locale di
volontari (è il caso del 'Gruppo della Stadura' a San Marino di Bentivoglio). Si tratta di
“capostipiti e antenati” che stanno dietro le case-museo (la Casa Museo costruita da Antonino
Uccello a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa) o le più recenti fondazioni (quella del Museo
Ettore Guatelli a Ozzano Taro, comune di Collecchio in provincia di Parma). E “che
1
riconosciamo insieme a chi non ha mai 'firmato' un museo ma ne è stato concettualmente
'padre'” come Alberto Mario Cirese con il volumetto Oggetti segni musei.
Nell’universo dei beni DEA – spiega Clemente - la D (ora caduta “per una qualche idiosincrasia
ministeriale”) caratterizzava questi musei come 'demologici', espressione che ne sottolineava “la
componente italianistica, quella che nell'800 fu detta della poesia e della novellistica popolare, e
che poi si aprì alla cultura materiale e che a livello internazionale si chiamò folklore (e da noi
anche folclore) e nell'Università fu chiamata Letteratura e/o Storia delle Tradizioni Popolari”.
Per illustrare la molteplicità di definizioni che circondano questa particolare museografia, basta
riferirsi alle schede di censimento dei musei etnografici e dell’agricoltura compilate da Roberto
Togni, Gaetano Forni e Francesca Pisani nel 1997. Qui si può notare – osserva Padiglione - che
“Civiltà contadina”, “Arti e Tradizioni”, “Arti e mestieri”, “Usi e costumi” ed “Etnografico” restano
le denominazioni più diffuse. Stentano a diffondersi terminologie di Oltralpe, quale “Ecomuseo”.
Si notano in evidenza anche preferenze locali che segnalano politiche regionali, influenze
accademiche, contagi d’autore: es. “Museo Etno- antropologico” in Sicilia, “Museo Etnografico”
in Sardegna, “Museo storico etnografico” in Lombardia, “Museo del villaggio” in Trentino, e
termini in lingua locale nelle regioni di confine. Ancor più vario e in forte crescita è il panorama
dei musei dedicati già nel titolo ad una focalizzazione tematica: frammenti di forme di vita, cicli
agricoli (olivo, vino, canapa, pane ), alimenti di base (sale, pane, castagna, pasta), oggetti di
lavoro e d’artigianato (carro, chiodo, ombrello, zampogna), habitat (montagna, vale, palude,
bosco, mare, miniere), demarcazioni storico-culturali (emigrazione, malaria, bonifica)”.
I musei etnologici dalla guida Togni-Forni-Pisani sono esclusi. Per verificare le quotazioni del
termine “etnologico”, possiamo rivolgerci al sito www.museionline.it. Tra i musei DEA censiti,
esso vi compare in pochissimi casi, che tradiscono implicazioni naturalistiche o confessionali,
come vdremo, significative: il Pontificio Museo Missionario Etnologico dei Musei Vaticani, il
Museo Etnologico Missionario di Colle Don Bosco in provincia di Asti, il Museo di Antropologia ed
Etnologia di Firenze, il Museo Etnologico delle Apuane, la sezione etnologica del Museo dell’Alta
Val Serivia. L’attributo più ricorrente, anche qui – come nella guida prima citata -, insieme a
quello di “civiltà contadina” è “etnografico”. E del resto – va detto - è quest’ultima l’espressione
più diffusa a livello internazionale, adottata anche dalla sezione ICOM dedicata a tale tipologia
di musei: l’International Commity for Museums of Ethnography (ICME).
Dal nome al come. E’ possibile costruire per la “bizzarra mappa” dei musei DEA una legenda
che abbia un minimo di sistematicità? Quanto vale questo sforzo? Al di là delle denominazioni
esistenti può essere utile sul piano della fruizione pubblica trovare dei denominatori comuni?
Possiamo individuare, al di là delle etichette, una specificità antropologica che contraddistingue
l’universo della museografia dea? Come (e perché) musei connotati in modo così eterogeneo
possono essere ascritti all’ambito di competenza di una prospettiva (quella
demoetnoantropologica) ora riconosciuta nello statuto istituzionale dei beni culturali?
Nella
riflessione che si dipana a partire dal quadro appena illustrato (e dalle domande che ne
derivano) la condizione dell’antropologo museale è ben rappresentata da una recente
dichiarazione di Pietro Clemente, che sente di trovarsi “al punto di incontro di due processi
mentali, concettuali e disciplinari che vanno in prospettive opposte, una decostruttiva e l’altra
ricostruttiva”.
A noi antropologi, si sa, i lessici chiusi stanno stretti e provocano disagio, poiché varia e
mutevole è la realtà dei processi che ruotano attorno alle parole e alle cose del nostro specifico
settore di interesse, che di quella varietà e mutevolezza si alimenta. Per altro, delle varietà
interne alla dimensione museale - come afferma Padiglione - “siamo orgogliosi, in quanto le
2
consideriamo un elemento caratterizzante e rappresentativo di un patrimonio che nella
mediazione rivela la tracce ad un tempo della cultura osservata e di quella osservante, di
contatti e incontri di culture (…) I nostri musei sono concrezioni di storie e contesti diversi.
Veicolano approcci ed interprezioni al patrimonio non sempre battezzate dall’accademia. E
anche quando si rappresentano con forme anguste e povere, meritano attenzione in quanto
testimoni a loro modo di territori, epoche, genti e soggettività particolari”.
Ciò nonostante, però (ed è questo il rovescio della medaglia), ci rendiamo perfettamente conto
che la multiforme galassia museale DEA, fatta di istituzioni storiche e di collezioni singolari, di
musei nazionali e di esperienze spontanee, di raccolte civiche e di “musei che non sono
nemmeno musei”, di fronte al pubblico dei visitatori, alle politiche degli standard o alle
implicazioni della tutela, una qualche traccia di identificazione più precisa, ancorché debole e
aperta, deve provare a trovarla. Se non altro per dare al confine tra noi e gli altri quel senso
autenticamente antropologico di costruzione finalizzata alla comunicazione e allo scambio, e
poterci così intendere con la gente di museo o che frequenta il museo, alla quale bisogna pur
partecipare la particolare sensibilità con cui ci accostiamo alla differenza museale e di cui –
come si diceva – ci sentiamo orgogliosi.
L’obiettivo, come è evidente, non sarà certo “quello di fare ordine e pulizia”. Piuttosto – come
indica Padiglione -, è quello “di valorizzare pienamente la ricchezza delle varianti e delle
anomalie create in ambito museale dalla contemporaneità postmoderna”. E in questo
importante lavoro di riflessione a tutto campo, estraneo quindi alle censure e svolto sulla
frontiera che avvicina e separa le diverse esperienze museali, forse potremo arrivare a
riconoscerci in un comune obiettivo: quello “di costruire una slargata comunità di pratiche
offrendo argomenti di discussione e di possibile condivisione”.
In questo senso, però, bisogna anzitutto adottare insieme una prospettiva relativistica. “I nomi
dei musei - avverte infatti Padiglione - sono anche essi artefatti, parlano spesso più della cultura
osservante, dei saperi e delle ideologie dei conservatori, che della cultura in mostra”. Nella loro
molteplice denominazione, soprattutto in ambito DEA come abbiamo visto, “trova
rappresentazione per frammenti la storia della museografia e del collezionismo, l’accademia con
le sue scuole e i suoi conflitti, le vocazioni e le velleità, le resistenze e le invenzioni a livello
locale. “Usi e costumi”, ad esempio, rinvia alle indagine illuministe; “arti e tradizioni” evoca il
periodo romantico dei nostri studi; l’enfasi su “Genti” segnala una connotazione identitaria ed
etnica da tempo presente nell’antropologia e di recente rivitalizzata; ecc.”.
In questa giungla lessicale, dove ci siamo abituati ad apprezzare più le differenze che le
categorie di ordine generale, l’opera “ricostruttiva” non è certo agevole. E però se è vero come osservava tempo fa Alberto Mario Cirese - che il problema sono le cose designate e i nomi
vengono dopo, allora conviene anzitutto verificare quanto “etnografico” ed “etnologico”, le due
espressioni storicamente più accreditate, rinviino a una possano vantare una loro più marcata
“specificità” lessicale rispetto al quadro generale della realtà museale demo-etno-antropologica.
Riprendere alcuni nodi della storia degli studi può forse aiutare a semplificare il quadro. Poiché
è nelle pieghe di quella storia che le due espressioni guadagnano quell’ambiguità che ancora il
pubblico dei musei fa fatica a dirimere. “Etnologico” ed “etnografico” indicano la stessa cosa dal
punto di vista della prospettiva museale? Oltre che per lo “specifico” materiale conservato nei
musei, c’è qualcosa che ci induce distinguere (o a usare indifferentemente) le due espressioni?
Qual è il vantaggio che possiamo ricavare dall’analisi delle eventuali differenze di prospettiva?
Una eventuale semplificazione nominalistica potrà orientarci nella comunicazione professionale?
E, soprattutto, aiuterà il pubblico dei musei ad orientarsi nella selezione delle offerte culturali?
Tra etnografico ed etnologico. Intorno alla metà dell’Ottocento, il filologo piemontese
3
Giovenale Vegezzi Ruscalla tentò una sistematizzazione del campo disciplinare distinguendo
l’Etnologia (in quanto “scienza delle nazioni” separata dagli studi anatomici e razziali)
dall’Etnografia (cui assegnava un ruolo preliminare e di complemento, di disciplina descrittiva ed
idiografica). La distinzione di Vegezzi Ruscalla non si stabilizzò nei decenni successivi poiché si
scontrava con la preminente affermazione delle teorie evoluzioniste e positiviste, che in Italia
trovavano nel medico e antropologo Paolo Mantegazza uno tra i più eminenti rappresentanti.
L’antropologia per Mantegazza era una scienza naturale, la disciplina generale entro la quale si
dispiegavano sia l’etnologia, in quanto studio delle razze umane, sia l’etnografia, intesa come
studio dei popoli e delle loro culture. Fu esattamente in questa accezione che egli istituì il
Museo di Antropologia e di Etnologia di Firenze (1869), diede vita alla Società Italiana di
Antropologia ed Etnologia (1870) e promosse la prima inchiesta ufficiale per documentare i
caratteri fisici degli italiani (1871). Su questa stessa linea si attestò pure Luigi Pigorini, che nel
1875 costituì il suo Museo Nazionale di Preistoria e – appunto – Etnografia: intendendo
con questa espressione sia "quello che producono i selvaggi e i barbari viventi" (cioè gli oggetti
provenienti da società primitive ed esotiche) sia – come era nelle intenzioni dichiarate al
Ministro della Pubblica Istruzione nel 1881) le costumanze e i reperti di casa nostra cui avrebbe
voluto estendere le raccolte.
Se dunque ripercorriamo la storia dell’antropologia e delle istituzioni museali ad essa legate
scopriamo che l’espressione “etnologico”, pur presente nella qualificazione delle istituzioni
museografiche europee dal ’700 in poi (grosso modo a partire dalla distinzione fatta da
Alexandre César Chavannes fra un’antropologia somatologica e un’etnologia appartenente al
dominio delle scienze filosofiche e morali, viene abbandonata. Anche per le contaminazioni, le
implicazioni e le collusioni che questa “nuova scienza” aveva finito per avere con l’ambiente
degli antropologi fisici, prevalentemente composto da medici e da studiosi di scienze naturali.
In Italia la separazione tra antropologia (scienza naturale) ed etnografia (scienza storicosociale) si consumò definitivamente al Congresso di Etnografia Italiana del 1911 lasciando
nell’indeterminatezza – come pure ebbe a lamentare Loria in quell’occasione - i confini
dell’etnologia. Ancora per un trentennio gli studi etnologici si sarebbero detti studi etnografici e
l’etnologia avrebbe accompagnato solo in modo implicito le esperienze di studiosi appartenenti
all’ambito storico-geografico o giuridico (Renato Biasutti, Carlo Conti Rossigni, Enrico Cerulli).
Pertanto, quando agli inizi del Novecento (1902-1906) Aldobrandino Mochi e Lamberto Loria
danno vita al più importante progetto museografico a livello di patrimonio nazionale, chiamano
Museo di Etnografia italiana la loro raccolta di “oggetti, manufatti, di qualsiasi genere e
categoria, spontaneamente usati e fabbricati del popolo nostro meno civile” intese definire
questa collezione di, in diretta analogia con l’etnografia extraeuropea”.
La raccolta Mochi-Loria dopo il 1911 rimane a lungo nei magazzini e diventerà Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni popolari solo negli anni ’50. Nell’intitolazione del museo c’è ormai “un
retaggio di carattere estetico che segnerà l’ambiguità di questa istituzione per tutto il corso
della sua vita, compresa l’attuale stagione”.
Il secondo dopoguerra vede la presa di distanza dall’immagine cartolinesca e da operetta
costruita dal fascismo sul folklore – un’immagine di propaganda e di facciata, in verità
mascherata dal tributo pagato alla tradizione degli studi dalla legge di tutela del ‘39 (che incluse
tra i beni da tutelare anche quelli etnografici, oltre che quelli relativi alle “primitive civiltà”).
A partire dagli anni ’50 l’etnografia viene riconsegnata al lavoro di ricerca e di documentazione
sulla dura e misera vita delle gramsciane “classi subalterne”. “Della matrice originaria – ricorda
Padiglione - è rimasta l’idea che un’indagine etnografica si interessi di tratti culturali a lungo
permanenti ovvero che un museo etnografico esponga artefatti ‘tradizionali’ che, sebbene
4
prelevati nella contemporaneità, hanno vissuto una temporalità di lunga durata” e che
“un’antropologia devoluta al salvataggio spirituale deve salvare”.
Così – prosegue Padiglione -, quando negli anni ‘70 incomincia a farsi pressante e diffusa la
domanda di musei locali, la nozione di etnografia, da latente, si rende attiva, vale come marca
disciplinare (più formale che reale). Comunque risulta preferita dalla comunità accademica
rispetto ad altre espressioni, come per esempio “civiltà contadina”.
A partire dall’inedita esperienza di museografia rurale del Gruppo emiliano della Stadura,
culminata con la fondazione del Museo della Civiltà contadina di S.Marino di Bentivoglio (1985),
“cominciarono a moltiplicarsi in tutta Italia piccoli musei nati sulla base di collezioni di oggetti
poveri, senza spese di allestimento e per volontà di gruppi di base o di excontadini che più di
altri avevano avvertito gli effetti talora devastanti della modernizzazione.
Al successo di questa tipologia contribuì in modo significativo proprio l’invenzione del nome:
Museo della Civiltà contadina. Un nome inviso da subito anche a molti storici e antropologi
pure simpatetici verso l’iniziativa di S. Marino di Bentivoglio, come lo fu Alberto M. Cirese, che
per neutralizzare “la carica mitica” e più in generale la fallacia di assumere il mondo contadino
come “totalmente autonomo e chiuso in sé “ gli oppose la denominazione di museo della
condizione contadina”.
I promotori del Museo di Bentivoglio – ci ricorda Padiglione - mutuarono l’espressione “civiltà
contadina” dall’opera di Carlo Levi ma sull’onda del dibattito apertosi attorno a quella stessa
nozione, sentirono il bisogno “di connotarla in senso marxista, di formazione economico sociale,
sovrapponendo l’immagine di un popolo che lotta per la liberazione alla denuncia leviana di un
mondo che era rimasto escluso dal messaggio di emancipazione”.
“In pochi decenni i musei della civiltà contadina si sono moltiplicati, sorretti da un collezionismo
povero ed una museografia essenziale che si è avvalsa in modo intermittente di fonti
etnografiche e di storia agraria. Ne sono emersi musei spesso improbabili come servizio
culturale e centro di documentazione e interpretazione del territorio, che però si sono imposti
come istituzioni di affezione comunitaria, presidi della memoria rurale nei paesi, costruendo
poco a poco un’idea di patrimonio: un patrimonio culturale, frutto di condizioni sociali condivise,
di processi culturali elaborati nella distanza, nell’esclusione, nella resistenza”.
A questo riguardo – conclude Padiglione – si può in fondo condividere l’opinione di Pietro
Clemente, “che in una recente riabilitazione della nozione di Civiltà contadina, ne ha sottolineato
il pregio di essere una reinvenzione locale in grado di convocare museograficamente grani di
alterità culturale altrimenti negata”.
E i musei etnologici? Dopo il Congresso di Etnografia del 1911 la bandiera dell’etnologia tornò
ad essere sostenuta con determinazione da Raffaele Pettazzoni e da Ernesto de Martino, i quali
contribuirono a rilanciare gli studi etnologici italiani definendo “etnologiche” alcune loro
prospettive di ricerca. Raffaele Pettazzoni fu il primo a ricevere un incarico di etnologia
nell’Università italiana (a Roma nel 1937) e a fondare, sempre a Roma, l’Istituto per le Civiltà
Primitive poi rinominato Istituto di Etnologia Italiana. L’impegno di Pettazzoni in questa
direzione molto fu stimolato dall’antagonismo dichiarato per la scuola di Padre Wihlelm Schmidt,
il quale negli anni Venti aveva introdotto in Italia un’etnologia storico-culturale di stampo
confessionale: nel 1925 aveva aperto una sezione etnologica nel Pontificio Museo Lateranense e
nel 1931 aveva istituzionalizzato ufficialmente l’etnologia negli atenei ecclesiastici.
Negli anni Trenta, tuttavia, il problema terminologico era stato rilanciato dalla Società Romana
di Antropologia di Sergio Sergi con un’inchiesta internazionale i cui risultati furono pubblicati nel
1947 sulla Rivista della Società. Pettazzoni, nella sua risposta al questionario, tornò a
distinguere l’antropologia dall’etnologia (scienza naturale, l’una; udisciplina storica, la seconda)
5
e l’etnografia dall’etnologia (definendo questa come lo studio dei popoli, delle culture umane, da
un punto di vista comparativo, con un distanziamento tale da consentire confronti e svolgere
percorsi riflessivi; intendendo invece per etnografia lo studio di una cultura nei dettagli).
Un eventuale auspicabile recupero della qualificazione “etnologica” dei musei dea, dovrà
riagganciarsi la tradizione di studi che ha provato a fondare in Italia un’etnologia intesa come
scienza storico-comparativa dell’ethnos. Prendendo dunque le distanze dalla tradizione che
invece ha fortemente compromesso la disciplina, e l’aggettivo etnologico, con scuole e
orientamenti naturalistici, evoluzionisti, missionologici. La specificità della prospettiva etnologica
sta infatti nel valore comparativo di quella riflessione “noi-altri” che è del tutto tipica della storia
della disciplina a partire dal XVIII secolo.
Il museo etnologico, in questo senso, potrebbe essere da noi il museo che conserva ed espone
documenti relativi alle culture extraeuropee, e che, proprio in ragione di questa sua specifica
ricchezza pluriculturale, è votato a costruire – nelle forme “collaborative” predicate dalla
museografia internazionale - rappresentazioni centrate sul confronto “noi-altri” e piegate a
un’interpretazione critica e riflessiva di quanto quel confronto produce sul piano delle relazioni
interculturali del mondo contemporaneo.
Lo scenario, a questo proposito, è tuttavia tutt’altro che definito (e definibile). Come osserva
Pietro Clemente, è un flusso in costante movimento: “L’antropologia museale è in questo flusso,
ed è anche questo flusso, e per questo non è facile fermarla per descriverla, va descritta in
movimento guardando a un interlocutore che si sposti anche lui mentre ascolta la descrizione.
Magari entrambi su un cammello”.
Nell’epoca del postcolonialismo e della postmodernità, infatti, le tradizioni si vanno rimodulando
anche attraverso il museo etnologico, che sta vivendo una nuova stagione ancora in stato
nascente. Le forme museali dei paesi non occidentali (di quelli africani in particolare), spesso
irretite tra tensioni allo sviluppo locale e politiche del turismo, somigliano alle tante indisciplinate
manifestazioni della museografia locale di casa nostra; e anch’esse pongono al centro delle loro
ragioni la memoria e l’identità del territorio, intese però come “risorsa” culturale per il futuro e
non come immobile eredità del passato.
“Nell’antropolgia di oggi – afferma Clemente - il museo è un ‘iperluogo’ che ha potenzialità sia
di ‘nicchia’ che di ‘arena’”. Le cose vi trovano un loro senso locale e però immediatamente
offrono i propri significati alla negoziazione sociale. In questo processo, che assegna al museo
popolarità, ne moltiplica le tipologie e ne fa un’istituzione di successo (ora pure riconosciuta
dalla legge) la stessa impronta occidentale – conclude Clemente – “può essere riletta e mutata
o rivissuta e moltiplicata”. In fin dei conti, sarà lo sguardo dei musei degli “altri” ad aiutare “i
nostri a vedersi, non come meri luoghi della tutela conservativa, ma anche come agenzie, talora
urgenti, della formazione e della educazione collettiva, e insieme come luoghi che non sono
‘regge’, ‘tesori nascosti’ per facoltosi e raffinati uomini di gusto, né spettacoli di massa, las
vegas con la minuscola, ma cercano di connettersi con progetti di vita del territorio. Non sono la
cultura che congela la vita, ma la cultura che sta nella vita, che la arricchisce, anche di
prospettive materiali. I musei oggi sono luoghi aperti, comunicativi e dinamici”.
* Questo testo riprende, sintetizzandoli, i contenuti dei seguenti contributi, cui si rinvia per la
bibliografia:
V. Padiglione, Etnografico nome di museo, relazione al seminario di Orta il 21 maggio 2004 al
convegno “Presente e futuro dell’ecomuseo”.
V. Lattanzi, Per una definizione (e un possibile rilancio) del museo etnologico, relazione al
seminario di Orta il 21 maggio 2004 al convegno “Presente e futuro dell’ecomuseo”.
P. Clemente, “I dea-musei”, in SISSCO, Il mestiere di storico, Annale V/2004.
6
P. Clemente, “Le mappe bizzarre e promettenti dell’Antropologia Museale”, in E. Castelli, Il
museo del tamburo parlante, Catalogo, 2005.
7