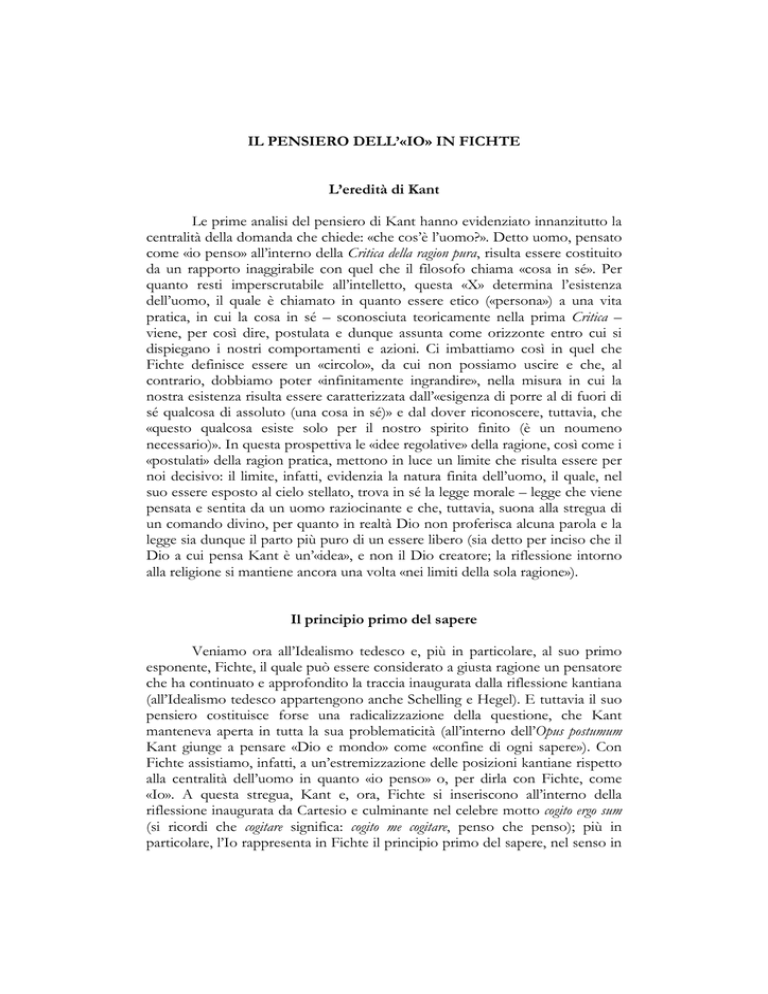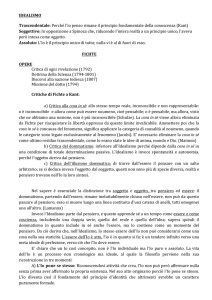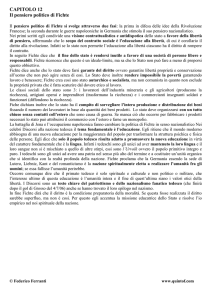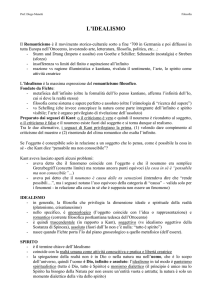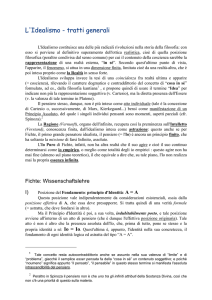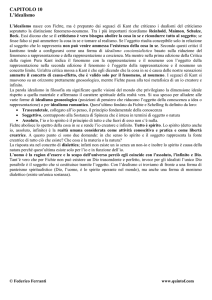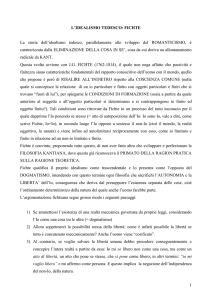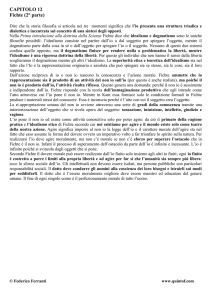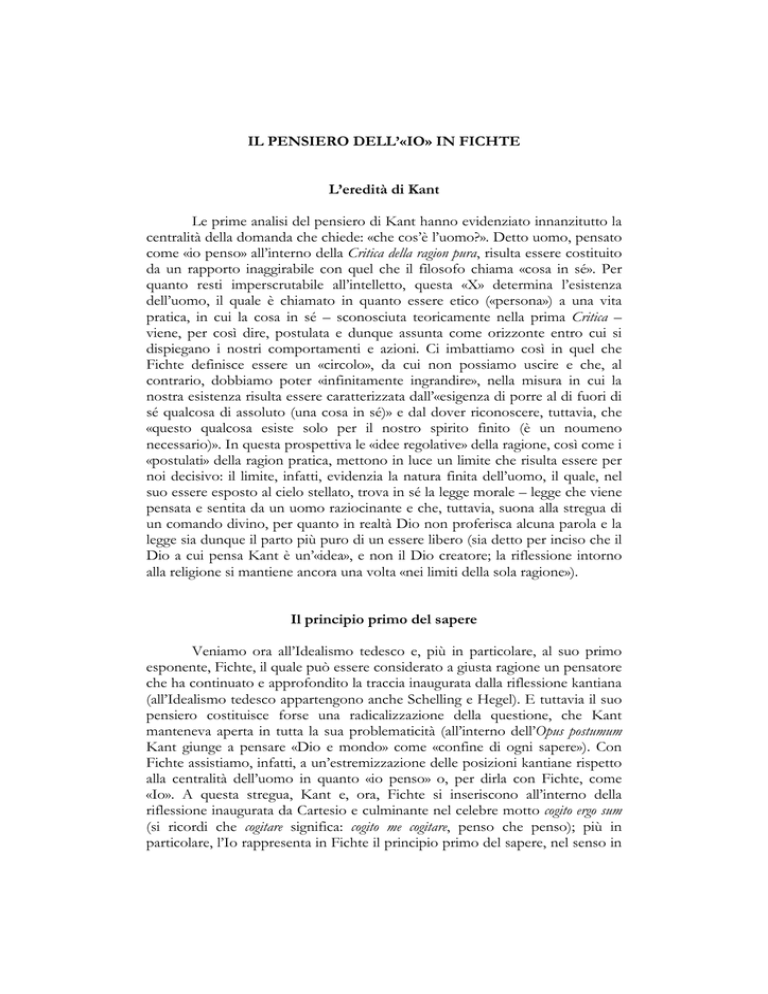
IL PENSIERO DELL’«IO» IN FICHTE
L’eredità di Kant
Le prime analisi del pensiero di Kant hanno evidenziato innanzitutto la
centralità della domanda che chiede: «che cos’è l’uomo?». Detto uomo, pensato
come «io penso» all’interno della Critica della ragion pura, risulta essere costituito
da un rapporto inaggirabile con quel che il filosofo chiama «cosa in sé». Per
quanto resti imperscrutabile all’intelletto, questa «X» determina l’esistenza
dell’uomo, il quale è chiamato in quanto essere etico («persona») a una vita
pratica, in cui la cosa in sé – sconosciuta teoricamente nella prima Critica –
viene, per così dire, postulata e dunque assunta come orizzonte entro cui si
dispiegano i nostri comportamenti e azioni. Ci imbattiamo così in quel che
Fichte definisce essere un «circolo», da cui non possiamo uscire e che, al
contrario, dobbiamo poter «infinitamente ingrandire», nella misura in cui la
nostra esistenza risulta essere caratterizzata dall’«esigenza di porre al di fuori di
sé qualcosa di assoluto (una cosa in sé)» e dal dover riconoscere, tuttavia, che
«questo qualcosa esiste solo per il nostro spirito finito (è un noumeno
necessario)». In questa prospettiva le «idee regolative» della ragione, così come i
«postulati» della ragion pratica, mettono in luce un limite che risulta essere per
noi decisivo: il limite, infatti, evidenzia la natura finita dell’uomo, il quale, nel
suo essere esposto al cielo stellato, trova in sé la legge morale – legge che viene
pensata e sentita da un uomo raziocinante e che, tuttavia, suona alla stregua di
un comando divino, per quanto in realtà Dio non proferisca alcuna parola e la
legge sia dunque il parto più puro di un essere libero (sia detto per inciso che il
Dio a cui pensa Kant è un’«idea», e non il Dio creatore; la riflessione intorno
alla religione si mantiene ancora una volta «nei limiti della sola ragione»).
Il principio primo del sapere
Veniamo ora all’Idealismo tedesco e, più in particolare, al suo primo
esponente, Fichte, il quale può essere considerato a giusta ragione un pensatore
che ha continuato e approfondito la traccia inaugurata dalla riflessione kantiana
(all’Idealismo tedesco appartengono anche Schelling e Hegel). E tuttavia il suo
pensiero costituisce forse una radicalizzazione della questione, che Kant
manteneva aperta in tutta la sua problematicità (all’interno dell’Opus postumum
Kant giunge a pensare «Dio e mondo» come «confine di ogni sapere»). Con
Fichte assistiamo, infatti, a un’estremizzazione delle posizioni kantiane rispetto
alla centralità dell’uomo in quanto «io penso» o, per dirla con Fichte, come
«Io». A questa stregua, Kant e, ora, Fichte si inseriscono all’interno della
riflessione inaugurata da Cartesio e culminante nel celebre motto cogito ergo sum
(si ricordi che cogitare significa: cogito me cogitare, penso che penso); più in
particolare, l’Io rappresenta in Fichte il principio primo del sapere, nel senso in
cui «non si può pensare assolutamente nulla senza pensare in pari tempo il
proprio Io come cosciente di se stesso».
In quest’ultima citazione è contenuta una chiara definizione di quel che
la filosofia moderna chiama «autocoscienza», qui pensata come «agire
ritornante in sé» (riflessione), grazie al quale l’Io – nel suo essere
«rappresentante» (nel suo rapportarsi alla realtà in termini di
«rappresentazione») e «intelligente» – si pone come «principio assolutamente
incondizionato di tutto il sapere umano». Più precisamente, il fenomeno
dell’autocoscienza si palesa a partire da quel che Fichte chiama «intuizione
intellettuale», nella quale l’uomo giunge ad accorgersi del proprio Io come
«fonte della vita», poiché «senza di essa [intuizione] è la morte». Va da sé che
l’intuizione di cui parla il filosofo non può essere dimostrata «per
ragionamenti», ma può essere colta a partire dall’esperienza che facciamo di noi
stessi in prima persona, dal momento che, come dice Fichte, non posso «fare
un passo, muovere una mano o un piede» senza «sapere di essere io a compiere
queste azioni»: è grazie a questa intuizione che posso distinguere «il mio agire, e
me in esso, dall’oggetto, in cui mi imbatto, dell’azione».
L’autoposizionalità dell’Io
Per riprendere il confronto con Kant, possiamo dire che l’Io fichtiano è
«principio assolutamente primo» – nel senso che «pone in assoluto e senza
fondamento», ossia «senza limitazione», in modo incondizionato (ecco il salto
compiuto da Fichte). In questo senso l’esperienza del limite rappresentato dalla
cosa in sé viene, per così dire, superata a partire dalla cosiddetta «autoattività» o
«autoposizionalità» dell’Io, secondo la quale, per dirla con Fichte, «L’io è quel
che esso si pone». In altre parole, l’Io è «l’agente e il prodotto dell’azione»: in
questo consiste la sua assolutezza – la sua «libertà». Libertà che, se in Kant si
limitava ad essere un postulato della ragion pratica, diviene qui piena
manifestazione dell’Io quale principio primo del sapere, nel senso che la realtà
è colta a partire dall’Io e dalla sua attività di «porre tutto ciò che è» – perché
«ciò che esso non pone, non è»!
Esplicitando il senso di questa frase, possiamo dire che l’essere e il non
essere sono determinazioni dell’Io; in breve, nulla è fuori dall’Io. A questo si
riferiscono i principi esposti da Fichte all’interno della sua Dottrina della scienza,
il cui compito era di fornire un «sapere assolutamente certo e infallibile» –
sapere che, a questo punto, non può che consistere nell’esposizione del
«sistema dello spirito umano». Così al principio che recita: «L’Io pone se
stesso», fa seguito il secondo principio: «L’Io pone un non-Io»: la realtà – intesa
da Fichte anche come «oggetto», «materia» o «ostacolo» – viene determinata a
partire dall’Io e, più in particolare, come ciò che è posto da esso e si trova in tal
modo a lui opposto: «non-Io». In altre parole, i primi due principi evidenziano
la natura autoattiva dell’Io, secondo la quale l’Io non pone soltanto e
innanzitutto se stesso, ma al contempo anche il non-Io come ciò che non è Io.
2
In questo senso il non-Io, nel suo essere posto dall’Io, è nell’Io: l’assolutezza
dell’Io appare qui nella sua infinità – infinità che viene ulteriormente ribadita e
specificata all’interno del terzo e ultimo principio, in cui Fichte determina, a
partire dall’Io infinito, sia l’io divisibile sia il non-io divisibile: «L’Io oppone
nell’Io ad un io divisibile un non-io divisibile».
Anche il terzo principio presenta pertanto un’attività dell’Io, nella
misura in cui è sempre nell’Io che l’Io oppone un io e un non-io divisibili, ossia
empirici. Ciò significa che la stessa divisibilità degli io e non-io empirici
presuppone quell’attività con cui l’Io si oppone al non-Io, trovando in
quest’ultimo un ostacolo contro cui urtare: è questa l’origine di una coscienza
«reale», non soltanto immaginata. Lungi dunque dall’esser ridotto a qualcosa di
semplicemente negativo, il non-Io diviene al contrario l’occasione affinché
nell’urto l’Io possa conquistare la propria libertà: il tratto della tensione con cui
l’Io tende alla propria infinità mette in mostra come il non-Io, proprio nel suo
costituire una resistenza, sia ciò che l’Io deve aver già sempre superato per
potersi autoporre come principio primo. Quel che possiamo aggiungere è che,
di fronte alla problematicità rappresentata dal non-Io e dalla sua eventuale
irriducibilità all’autoattività dell’Io (il non-Io è forse immagine della cosa in
sé?), Fichte, in quanto filosofo idealista (ossia non dogmatico), sembra preferir
sacrificare «l’autonomia della cosa [leggi: del non-Io]» a quella dell’Io,
ribadendo ancora una volta che nell’Io è posta «l’assoluta totalità della realtà».
Lo Stato di tutto il popolo
In linea con queste prime considerazioni di ordine metafisico,
dobbiamo osservare che la riflessione di Fichte giunge a riguardare – come già
in Kant – la dimensione etica o morale, dal momento che, scrive Fichte, «noi
agiamo perché conosciamo, ma conosciamo perché siamo destinati ad agire».
La riflessione che abbiamo espresso prima sul ruolo del non-Io e sulla sua
autonomia rispetto all’Io si traduce a questo livello in una determinazione del
mondo come ciò che sospinge l’attività dell’uomo al raggiungimento di quella
infinità che porta ognuno di noi a vedere nel mondo esclusivamente «l’oggetto
e la sfera dei miei doveri» – quasi che, come già detto, l’ostacolo incontrato
dall’Io costituisse una condizione posta dallo stesso Io per esercitare quello
sforzo di divenire infiniti. In questo senso il fine ultimo dell’uomo è quello di
«sottomettere ogni cosa irrazionale e dominare libero secondo la sola sua
legge».
Ma, a conferma della problematicità del non-Io, Fichte è costretto a
riconoscere che quel fine «non è affatto raggiungibile e tale deve eternamente
rimanere se l’uomo non deve cessare di essere uomo per diventare Dio». In
questo spirito di perfezionamento risiede dunque la «missione» dell’uomo e, in
primis, del filosofo, il quale funge da guida in questa faticosa ricerca da parte di
ciascuno di «divenire sempre migliore e rendere tale tutto ciò che
materialmente e moralmente lo circonda». E poiché il «dotto» (La missione del
3
dotto, 1794) è colui che guida ed educa gli altri, affinché «la nostra schiatta»,
composta di tanti io divisibili, «si unisca in un corpo unico, completamente
noto a se stesso in tutte le sue parti e progredito ovunque allo stesso modo» –,
Fichte pronuncia nell’inverno 1807-1808 quattordici discorsi presso
l’Accademia delle Scienze di Berlino: si tratta dei celeberrimi Discorsi alla nazione
tedesca, in cui il filosofo, in seguito all’occupazione napoleonica della Prussia
(1806), invita i propri ascoltatori e compatrioti a riflettere con decisione sul
destino del popolo tedesco.
L’unità di cui parla Fichte non potrà essere ottenuta grazie a un aiuto
dall’esterno (l’autoattività dell’Io è ugualmente centrale a livello politico), ma
solo attraverso «la creazione di un ordine di cose totalmente nuovo», un ordine
che potrebbe essere individuato solo sulla base di una «completa
trasformazione del sistema educativo fin qui vigente». Ciò significa che la
possibilità dell’unità di un popolo risiede nella propria disponibilità ad
impegnarsi per un sapere che sia – nel caso di Fichte – genuinamente tedesco,
affinché possano essere educati non solo gli appartenenti di un ceto particolare,
ma «l’intera nazione come tale e tutti i membri della medesima senza
eccezione» (ricordiamo che la nazione a cui si rivolge Fichte non coincide con
la Germania che giunse all’unità territoriale nel 1871: l’unità etica del popolo
tedesco non si basa su confini geografici, ma ha il proprio nucleo fondante nel
fenomeno della lingua madre, terreno comune in cui si radica un popolo e da
cui soltanto è possibile fare esperienza di qualcosa come una patria).
L’eccellenza dei Tedeschi
Sorge spontanea la domanda: di che genere è l’«educazione» a cui si
riferisce Fichte? Che cosa si intende qui con sapere? Esiste cioè un ordine
all’interno del sapere che permetta di individuare un sapere primo (per rango)?
La filosofia idealistica, proprio nella misura in cui è, come dice Fichte, «la
scienza che abbraccia l’eterno archetipo di ogni vita spirituale», deve essere
interpretata come il sapere guida capace di «porre e fondare, nell’animo di tutti
coloro che vogliamo annoverare come membri della nazione, un amore di altro
genere, il quale miri direttamente al bene voluto come tale in senso assoluto».
Ed è proprio questa cura della filosofia a distinguere il popolo tedesco e ad
assegnargli un primato all’interno dell’Europa, nella misura in cui la Germania
assume su di sé il compito di educare gli altri popoli, ossia di realizzare
«l’umanità tra gli uomini». Del filosofo Fichte scrive: «Egli vede non soltanto il
presente, ma anche il futuro, non soltanto il punto di vista attuale, ma anche la
direzione che l’umanità deve costantemente seguire se essa vuole percorrere la
via che la condurrà verso il suo fine ultimo senza smarrirsi o retrocedere».
Non dobbiamo fraintendere le intenzioni di Fichte, quasi che nel suo
pensiero fossero contenuti i germi della futura ideologia nazista. Come ribadito
da Hegel all’interno del suo Discorso inaugurale dell’insegnamento presso la cattedra di
filosofia dell’università di Berlino (22 ottobre 1818), l’«eccellenza dei Tedeschi»
4
risiede proprio nell’aver coltivato la filosofia – qui intesa come «centro di tutta
la cultura spirituale, di ogni scienza e verità». A ben vedere, infatti, continua
Hegel, «lo stato dello studio della filosofia e il significato di questo nome
presso le altre nazioni dimostrano che, sebbene il nome si sia conservato
ancora presso di loro, esso ha mutato il suo senso e la cosa si è corrotta ed è
scomparsa, tanto che sono rimasti a mala pena un ricordo e un vago sentore di
essa. Questa scienza si è rifugiata presso i Tedeschi e sopravvive solo in loro; a
noi è affidata la custodia di questa sacra luce, e la nostra missione è curarla e
nutrirla, badando che il bene più elevato che l’uomo possa mai possedere,
l’autocoscienza della propria essenza, non si spenga e non muoia».
5