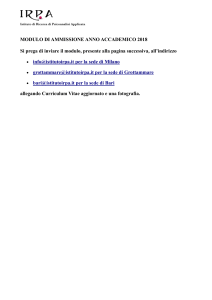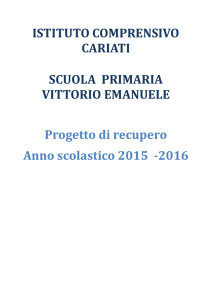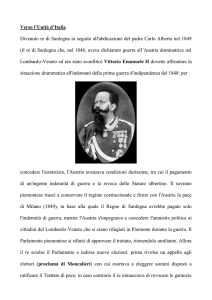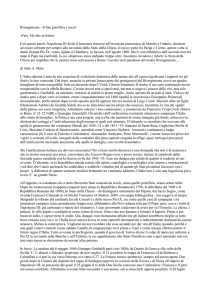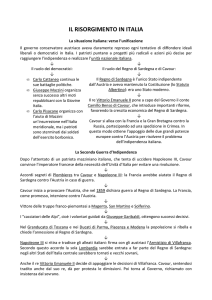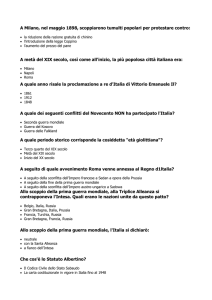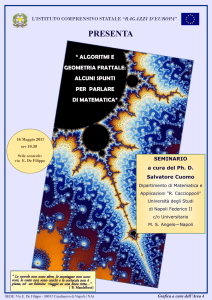S’ingorgano tanti pensieri, sfogliando finalmente questo volume di Atti. Si potrebbe ad esempio ragionare sull’indispensabile funzione “editoriale” che i Comuni
e, più in generale, gli Enti locali dovrebbero svolgere, dando la possibilità alle pubblicazioni significative, ma che non avrebbero un mercato sufficientemente ampio, di
nascere ugualmente; funzione che, come tante altre, rischia purtroppo di atrofizzarsi
in questi tempi di tagli e sacrifici economici - che altro non sono, poi, se non le conseguenze di una tendenza più ampia in atto, volta ad indebolire il più possibile le
potenzialità dello Stato, con inevitabili, drammatiche conseguenze sulla tutela dei
Beni Comuni e, in definitiva, sulla tenuta della Democrazia. Il discorso, però, ci
porterebbe lontano: basti in questa sede ricordare che il presente volume di Atti, così
importante non solo per la storia cittadina, ma in generale per la ricostruzione di un
episodio fondamentale del Risorgimento italiano, non avrebbe visto la luce, se non
fosse stato il Comune a promuoverne la pubblicazione e un concittadino innamorato
della sua Grottammare - il dottor Vittorio Laureati, che mai potremo ringraziare
abbastanza - non avesse deciso con generosità di partecipare all’impresa. Mai lo
avrebbe fatto il mercato della carta stampata, che avrebbe giudicato una spesa come
questa, nonostante tutto piuttosto esigua, comunque anti-economica.
È questo, tuttavia, un momento felice e di certo non giova rovinarlo con un trito
contemptus mundi; l’occasione piuttosto è propizia per riflettere a quattro anni di
distanza sulle Celebrazioni organizzate a Grottammare per il 150º anniversario
dell’Unità, soprattutto su cosa di quelle Celebrazioni resti ancora oggi e, forse, resterà in futuro. Avendole coordinate da Assessore alla Cultura, vi garantisco che
nessun discorso sulle Celebrazioni del 2011 sarebbe corretto se non si ricordassero
all’inizio i nomi del Sindaco Luigi Merli - che da subito affrontò la ricorrenza come
un appuntamento storico e simbolico per Grottammare - e di Alessandra Ghidoli, alla
cui pazienza, ampiezza di visione e capacità organizzative, generosamente volontarie,
vanno senz’altro ascritti tutti i successi più importanti conseguiti dall’evento. Manca
tuttora ai festeggiamenti di 4 anni fa un Attilio Pignocchi che accetti la sfida di raccontarli giorno per giorno, ma non è detto che mancherà anche nei prossimi anni…
queste poche righe potranno servire come punto di partenza per una cronaca più
ampia e, a dirla tutta, confidiamo che a qualcuno prenda questa voglia: non a caso al
termine del volume abbiamo pubblicato il calendario completo degli eventi organizzati per il 150º anniversario, affinché possa servire come le molliche per Pollicino.
Elaborato in circa tre mesi, il primo progetto delle Celebrazioni 2011 fu inviato
il 18 maggio 2010 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che con
slancio garantì subito un sostegno economico per realizzare parte delle iniziative
previste. Partimmo insomma con largo anticipo, anche perché l’obiettivo era ambizioso: avvicinarsi il più possibile alla maestosità delle Celebrazioni per il
Cinquantenario organizzate da Alceo Speranza, tentando di creare dei collegamenti
5
6
leggibili a distanza di cento anni. La ristampa anastatica del Natale della Patria
svolse, infatti, la funzione di indicare chiaramente la direzione che intendevamo percorrere. Già il 3 agosto del 2010 inviavamo al Presidente del “Comitato nazionale
dei Garanti per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia” la richiesta del riconoscimento ufficiale del nostro progetto; riconoscimento che ottenemmo dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 Novembre. Il primo risultato era stato
raggiunto: il valore nazionale delle nostre Celebrazioni veniva formalmente sancito,
privilegio che fino a quel momento era una speranza e che nell’immediato funse da
propellente, iniettando la motivazione necessaria per affrontare la sfida.
Con slancio, dunque, iniziammo a costruire i ponteggi dei progetti previsti.
Lavorammo ovviamente su più tavoli, su di uno in particolare: l’8 marzo del 2011
eravamo già pronti ad inviare al Ministro dell’Interno per il tramite della Prefettura
di Ascoli Piceno la complessa documentazione per l’ottenimento del titolo onorifico
di “Città”, che aveva richiesto quasi cinque mesi di preparazione. Volevamo che fosse mantenuta una promessa: Attilio Pignocchi nelle Onoranze cinquantenarie riferisce, infatti, che in occasione dei festeggiamenti del 1911 il Comitato organizzatore
iniziò le pratiche affinché Grottammare potesse ottenere questo titolo. L’On. Pavia,
intervenuto alle Celebrazioni in rappresentanza del Re e del Governo, non portò buone notizie ma assicurò ai membri del comitato questo riconoscimento, non appena il
Comune avesse raggiunto i diecimila abitanti. A distanza di un secolo a questo impegno bisognava dare un seguito! Molti cittadini lo attendevano; lo attendeva soprattutto l’amico e cultore di memorie locali Mario Petrelli, al quale più di ogni altro
quell’antica, astuta promessa non mantenuta non andava proprio giù… La fine dell’estate portò con sé la sorpresa: con una nota datata 19 settembre 2011 il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano conferiva a Grottammare il titolo di “Città”.
Non aggiungiamo altro, se non che questa onorificenza è il primo tesoro, forse il più
duraturo, che le Celebrazioni del 2011 hanno lasciato alla storia di Grottammare.
Il secondo patrimonio trasmesso in eredità è sicuramente l’insieme delle informazioni inedite, delle analisi, delle fonti e delle riflessioni accumulate con il
Convegno 12 ottobre 1860. Lo storico incontro di Grottammare e il suo contributo
all’Unità d’Italia. Se non avessimo stampato questo volume di Atti, l’eccezionalità di
quelle due giornate - il 4 e il 5 giugno del 2011 - sarebbe stata a poco a poco dimenticata, o comunque sarebbe rimasto un privilegio esclusivo dei partecipanti. Anche
questo progetto puntava molto in alto: intendeva soprattutto sottrarre l’incontro
grottammarese dalla dimensione locale per collocarlo in una posizione più corretta,
inserendolo senza il trionfalismo di una retorica strapaesana almeno tra gli episodi
più rappresentativi delle dinamiche in atto nel processo risorgimentale verso l’Unità.
E non è soltanto il riconoscimento ufficiale che il Presidente Napolitano inviò in
occasione dell’apertura dei lavori - una speciale targa commemorativa - che ci confermò il raggiungimento anche di questo obbiettivo, quanto piuttosto l’adesione prima e l’effettiva partecipazione poi di istituzioni e di studiosi prestigiosi che hanno
raccontato parti molto ampie della Storia d’Italia e che con la loro presenza e il loro
contributo hanno testimoniato interesse per un episodio, ancora poco conosciuto ma
per nulla marginale, accaduto in una piccola cittadina di provincia. Per il valore
scientifico e la prospettiva internazionale è stato indiscutibilmente l’evento più importante degli ultimi decenni organizzato nella nostra Città. Coloro che leggeranno
con attenzione questi Atti, sono certo, comprenderanno sin dalle prime pagine come
ciascun saggio presente nel volume rappresenti un punto di arrivo degli studi precedenti e al contempo un punto di partenza per gli storici che in futuro vorranno ulteriormente approfondire l’argomento.
A fine lettura, sono certo, sopravverrà a molti la mia stessa riflessione: non
sfuggirà infatti la ricchezza di episodi che hanno interessato la nostra Città nei cinquant’anni che separano l’Unità d’Italia dalla Grande Guerra. In un periodo relativamente contenuto Grottammare ospita personalità eccellenti come il Re Vittorio
Emanuele e il compositore Franz Liszt, è al centro della vicenda nazionale, elegge in
Parlamento rappresentanti come Alceo Speranza, assiste ai festeggiamenti del
Cinquantenario che attirano sulla Città le attenzioni dei protagonisti politici e culturali dell’epoca, vive - non dimentichiamolo - la più importante campagna di indagine
archeologica sul nostro territorio, gli scavi del sovraintendente Dall’Osso giustamente celebri e ancora oggi fondamentali. Questa attenzione tanto anomala per una
realtà relativamente piccola come la nostra fu vissuta con piena consapevolezza dai
protagonisti dell’epoca: lo dimostra, se non altro, il desiderio di raccontare la memoria cittadina, con una nuova visione e con maggiore ambizione, presente ad esempio nella Guida di Grottammare (1889) di Giuseppe Speranza, riferimento insuperato per gli storici successivi, la cui genesi non può essere disgiunta, credo, dal sentimento di orgoglio che afferma il privilegio di vivere in un luogo non marginale, periferico soltanto geograficamente, poiché attraversato anch’esso dai grandi e dalla
grande storia. Nulla accade per caso e anche di questi cinquant’anni memorabili in
futuro bisognerà precisare meglio le ragioni con gli adeguati strumenti scientifici.
Possiamo, però, essere certi sin da ora del ruolo che in questa aurea stagione di
Grottammare svolsero le famiglie dei Laureati, degli Speranza, dei Palmaroli, dei
Fenili, artefici e al contempo catalizzatori di importanti avvenimenti, che per intraprendenza, preparazione culturale e passione civile sempre operarono affinché si
trasferisse alla Città gran parte dei benefici che il loro prestigio e la loro posizione
sociale generavano.
Per il resto del secolo fino ad oggi soltanto la straordinaria ascesa di Pericle
Fazzini ha fatto provare nuovamente a Grottammare l’emozione di sentirsi al centro
di qualcosa di molto, molto più grande. Accantonate tuttavia l’inevitabile nostalgia
e la frustrazione tipica degli epigoni, spetta a noi il compito di non interrompere il
racconto di quegli anni, anzi di approfondirlo, di arricchirlo, di svolgere al meglio il
ruolo di compilatori e analisti che la storia ci ha assegnato, un ruolo comunque indispensabile per la maturazione della coscienza cittadina, affinché le presenti e le
future generazioni siano preparate ad essere protagoniste di chissà quali altre stagioni felici della Città.
Enrico Piergallini
Sindaco della Città di Grottammare
7
Debbo innanzitutto ringraziare, per l’invito a partecipare a questa manifestazione, il Sindaco, l’Amministrazione comunale e, soprattutto, la professoressa Ghidoli
con la quale tra l’altro siamo stati colleghi per lungo tempo, all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, e della quale ho sempre apprezzato le doti di studiosa.
Vorrei iniziare il mio intervento con una considerazione più generale relativa al
programma di iniziative previsto per questo anniversario, mettendolo a confronto con
quello attuato per le ricorrenze precedenti, cioè quelle del cinquantenario e del centenario. A differenza di queste ultime, ci siamo avviati a ricordare il compimento dei
150 anni dell’Unità senza sviluppare una riflessione generale che riguardi l’odierna
classe politica e l’assetto dello Stato. Quanto vi era nelle celebrazioni precedenti,
tendeva a mettere in risalto lo sviluppo di quelli che erano stati i fondamenti posti con
l’Unità, perché quando noi diciamo unità e indipendenza dobbiamo sempre pensare
come dal punto di vista sostanziale tali concetti si esprimono nel tipo di Stato che si
è creato con il loro apporto. Stato, che riuscì lentamente ad amalgamare il paese e a
unificarlo intorno alle pubbliche istituzioni.
Il primo cinquantenario cadde in un momento cruciale della storia d’Italia. Il
processo d’industrializzazione si era avviato, nel 1913 saremmo passati al suffragio
universale, ancora parziale nel senso che era un suffragio universale maschile ed
escludeva gli analfabeti che erano ancora numerosissimi. La grande campagna di alfabetizzazione avverrà, infatti, dopo la prima guerra mondiale e porterà l’Italia a
percentuali di alfabetizzazione simili a quelli di altri paesi europei. Le vere elezioni a
suffragio universale saranno così quelle del 1919 quando non si poté davvero escludere alcuno, poiché gli analfabeti avevano combattuto in trincea come gli altri, sul
Carso, nel Trentino, e il diritto di voto non poteva essere loro negato. Fu questo un
nodo fondamentale perché segnò, nel nostro Paese, quel passaggio da uno Stato ad
una democrazia liberale che portò alla frattura del dopoguerra. Passaggio non riuscito e da quella rottura di continuità emerse infatti il fascismo che spezzò, tra le altre
cose, quello che era nato come un infrangibile binomio, che legava l’idea di patria a
quella di libertà. Non vi è nostro precursore, padre fondatore, prima del fascismo, che
non unisse questi due termini saldamente.
La seconda guerra mondiale ci ha riportato la libertà e la democrazia, tuttavia ad
essa si è accompagnato un sentimento di patria logorato dal processo di enfatizzazione nazionalista e dai risultati, così negativi e drammatici, di questo. Inoltre il concetto di Patria e di Nazione soggiacque allora ad altre fedi più forti che erano fedi con-
11
trapposte proprie, se non della generalità del popolo italiano, delle classi dirigenti dei
diversi partiti di allora.
12
Nel 1960, il centenario si compì, comunque, tenendo ferma l’idea della continuità
con il passato e cercando di rendere più solido il legame con le origini risorgimentali
della nostra storia unitaria.
Oggi, nella ricorrenza del centocinquantesimo, le parole di Nazione e di Patria
appaiono assumere un significato più generale e questo io credo avvenga perché, in
questi anni, avendo lasciato alle spalle antichi contrasti, andiamo rimisurando quelli
che sono i legami profondi che ci uniscono come unità nazionale.
A questo proposito debbo far cenno, per aver partecipato a tante manifestazioni
come quella di oggi e, per essere stato membro della commissione scientifica per il
centocinquantesimo, a come la risposta del Paese sia stata inaspettata e straordinaria.
Ovunque, nelle scuole, nei comuni, nelle associazioni culturali, si è avuta una mobilitazione che non è stata politica ma che è partita dalla società civile, come avvenuto
nel caso di Grottammare, anche attraverso le sue espressioni politiche. Di qui una
prima considerazione che riguarda il perché è importante l’episodio di Grottammare,
quando Vittorio Emanuele II, alla testa dell’esercito piemontese, si fermò ed aspettò
la delegazione napoletana, per entrare nel Regno delle due Sicilie. In fondo ad
Ancona aveva già ricevuto una delegazione abruzzese che portava l’adesione di un
numero considerevole di comuni al costituendo Regno d’Italia e all’impresa che egli
si accingeva a compiere di unificazione della penisola.
Cavour non era d’accordo a che il Re si fermasse qui in quei giorni. Voleva che
affrettasse il passo andando incontro a Garibaldi; e forse Vittorio Emanuele, proprio
in vista dell’incontro con Garibaldi, volle avere anche dalla sua parte i voti della
città di Napoli ed un preciso segnale di adesione da parte di essa.
Qui è stato accennato al problema della divaricazione che esisteva nelle popolazioni meridionali, soprattutto tra il ceto contadino e gli altri ceti sociali e in particolare quello che si chiamava il ceto civile che comprendeva gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti, farmacisti, ingegneri, avvocati, magistrati, professori,
tutti coloro che costituivano l’ossatura della società civile. Questa spaccatura si è poi
colmata nella storia del nostro Paese e non sto ora a percorrere le tappe di questo
processo, ma ciò, com’è noto, si è verificato nel secondo dopoguerra con l’affermarsi della seconda fase di industrializzazione che ha trasformato l’Italia. Nel 1946 il
46% della forza lavoro era ancora dedita all’agricoltura; oggi è il 5%. Ma allora
questo contrasto era profondo e nell’Italia meridionale la classe che appoggiò l’impresa risorgimentale fu quella che, come ho accennato, si denominava il “ceto civile”.
Desta ancor oggi impressione leggere nella corrispondenza dell’ambasciatore
Venier, inviato alla vigilia della spedizione dei Mille da Napoleone III presso la corte
napoletana di Francesco II, una missiva nella quale si riferiva che il capo della polizia
del Regno di Napoli gli aveva segnalato che 100.000 erano le famiglie tenute sotto
controllo in quanto sospette, quindi almeno 400.000 persone considerate sospette.
Era il ceto civile, appunto, il quale dal 1848 aveva abbracciata la causa dell’Unità nazionale e soprattutto richiedeva una diversa protezione anche all’interno del
Regno. Richiedeva il rispetto della legge, dell’ordine pubblico, tutte cose che furono
poi garantite dallo Stato unitario, insieme ai processi di modernizzazione più elementari: dalla viabilità, alla struttura ferroviaria, alla rete delle telecomunicazioni e via
discorrendo.
Scorrendo i nomi dei componenti della delegazione napoletana che qui a
Grottammare venne ad incontrarsi con Vittorio Emanuele II, si notano quelli di
Ruggero Bonghi e di Luigi Settembrini. Quest’ultimo era il grande scrittore, studioso,
condannato all’ergastolo a Santo Stefano per le vicende del 1848, dove trascorse
dieci lunghi anni fino al 1858, quando Ferdinando II non poté fare a meno di cedere
alla pressione delle potenze straniere e liberare i detenuti politici. A tale riguardo, per
inciso, voglio anche ricordare quale era l’opinione dei governi europei circa l’amministrazione borbonica e quella pontificia. Francia e Inghilterra avevano effettivamente da tempo ritirato i propri ambasciatori dalla corte di Napoli. Credo a questo proposito che sarebbe utile ripubblicare le lettere di Gladstone sul Regno di Napoli, come
il resoconto dell’intervento di Clarendon, ministro degli Esteri della Gran Bretagna
alla conferenza di Parigi, tutto centrato sul Regno borbonico e sullo Stato Pontificio,
in particolare sulla situazione delle Marche e dell’Umbria, considerati casi estremi di
degenerazione civile e di regime politico inferiore e non degno di partecipare all’arengo europeo.
Dunque il significato primo di quell’attesa di Vittorio Emanuele II fu quello di
ricevere, dalla capitale del Mezzogiorno, il segno dell’adesione proprio del ceto civile: dei Bonghi, dei Settembrini, di molta nobiltà napoletana, tra cui i Pignatelli di
Strongoli, i Dentici di Accadia, i Caracciolo, cioè quell’area, peraltro minoritaria,
della nobiltà napoletana che aveva abbracciato la fede liberale insieme a larga parte
della borghesia. Questo segnale era essenziale per Vittorio Emanuele II anche nei riguardi di Garibaldi. L’ipotesi, infatti, che si costituisse nel Mezzogiorno un nuovo
Stato sotto la dittatura democratica di Garibaldi e poi si procedesse all’unificazione,
era un proposito diffuso tra i garibaldini, che poi non fu seguito dallo stesso Garibaldi
e che naturalmente aveva destato preoccupazioni nel partito moderato, e in Cavour in
primo luogo, per le conseguenze che avrebbe potuto avere sull’opinione pubblica
europea.
L’unificazione italiana ha proceduto, in quegli anni cruciali che vanno dal 1859
al 1861, sul filo di un rasoio. Fino al passaggio da parte di Garibaldi dello stretto di
Sicilia non vi era potenza europea disposta a puntare sulla carta dell’Unità italiana o
che desiderasse che tale unità si verificasse.
L’Inghilterra temeva l’influenza francese sul Regno delle due Sicilie. La Francia
temeva che la vicenda garibaldina si rivolgesse contro Roma, giacché Napoleone III
si reggeva in Francia su una larga maggioranza cattolica, e se Garibaldi avesse rivolto la sua marcia verso lo Stato Pontificio, tutte le conquiste fatte con l’appoggio decisivo della Francia sarebbero state messe in discussione. Cavour dovette così trovare una soluzione alle contraddizioni che si erano aperte con le potenze europee e garantire che l’Italia avrebbe costituito un elemento di equilibrio nel concerto europeo.
Cosa che l’Italia è stata fino alla Grande Guerra, quando poi l’Europa si divise nella
prima guerra mondiale.
La prima garanzia che allora occorreva dare, stava appunto nella capacità di fermare e concludere l’avanzata garibaldina, ristabilendo il rapporto con la parte democratica del paese che Garibaldi interpretava in modo così straordinario e con successi
13
così travolgenti. La soluzione adottata fu la discesa attraverso le Marche e l’Umbria
e l’ingresso nell’Italia meridionale, escludendo Roma e il Lazio, per non urtare con
le pregiudiziali francesi in difesa della Santa Sede.
14
Quello che vorrei in ultimo sottolineare è che vi è un altro elemento per il quale
i giorni passati da Vittorio Emanuele a Grottammare ebbero un significato che coinvolse tutti i comuni limitrofi. Grottammare divenne l’epicentro della partecipazione
dell’intera Regione alla vicenda unitaria. È stata per un momento il capoluogo delle
Marche.
Non dimentichiamo che Vittorio Emanuele lasciò la Romagna, staccando due
corpi d’armata dell’esercito piemontese, quindi indebolendo la linea di difesa nei
confronti dell’Austria, attestata sul Mincio. Quella linea di difesa, nei confronti del
nemico storico dell’Unità nazionale, non poteva essere ulteriormente indebolita. Era
dunque quella discesa verso il Mezzogiorno, anche per queste ragioni, una scommessa rischiosissima. L’esercito austriaco, molto più forte, era stato del resto possibile
sconfiggerlo a Solferino e San Martino solo grazie all’appoggio decisivo dell’esercito francese e se ne avrà conferma qualche anno più tardi con le battaglie di Custoza
e di Lissa, perdute dall’esercito italiano. Il Re scenderà nelle Marche, appoggiato dal
Corpo dei Cacciatori marchigiani e dei Cacciatori abruzzesi. La battaglia decisiva
avvenne il 18 settembre 1860 nella vicina Castelfidardo. Il delicatissimo passaggio
verso il Regno di Napoli si svolse quindi non attraverso l’ Umbria, dove Cavour aveva invitato le forze democratiche a non insorgere per scongiurare il pericolo che le
truppe pontificie ripetessero la durissima repressione di Perugia, ma attraverso le
Marche. La presa di Ancona è stata un episodio militare di non secondaria rilevanza.
Fu ad Ancona che si concentrò la flotta piemontese, contro la minaccia dell’Austria
di intervenire a sostegno della guarnigione pontificia. Poi Castelfidardo, con le truppe
di Pio IX che ripiegavano verso il mare e la reazione efficace dei patrioti marchigiani.
Non è stata dunque una pagina secondaria di storia quella che a Grottammare, da
un lato si concluse con la definitiva liberazione delle Marche, dall’altro dava luogo al
passaggio di Vittorio Emanuele II al di là del Tronto, per compiere l’ultimo atto
dell’unificazione italiana con la liberazione del Mezzogiorno.
Vorrei anzitutto ringraziare il Sindaco, l’Assessore alla cultura e gli organizzatori di questo convegno per avermi dato la possibilità di parlare come studioso in questa
deliziosa località, nella quale ero sinora venuto solo come turista, e di ascoltare i saluti delle autorità, che non sono stati dei semplici saluti di rito, ma dei veri e propri
interventi di apertura dei lavori. Ringrazio poi gli autori delle illuminanti relazioni
che hanno preceduto la mia, perché hanno semplificato molto il compito assegnatomi
dal programma, che prevede da parte mia una riflessione di carattere generale sul
significato storico del Risorgimento italiano e dell’inserimento del Mezzogiorno nello Stato unitario, in modo da definire parametri il più possibile adeguati a valutare
l’importanza dell’incontro di Vittorio Emanuele II con i notabili partenopei avvenuto
a Grottammare il 12 ottobre 1860.
Il Risorgimento italiano è un processo la cui portata storica, dopo l’esaltazione
agiografica dei primi decenni di vita unitaria, è stata a lungo e progressivamente
sminuita nel giudizio della storiografia sia italiana sia straniera. Ciò è avvenuto a
partire dall’onda emotiva suscitata da eventi storici sfortunati o negativi (come le
sconfitte di Lissa, Custoza, Dogali, Adua, Caporetto, l’esperienza del Ventennio fascista e il disastro della Seconda guerra mondiale), ma anche, e direi soprattutto, per
la delusione provocata dal lento e faticoso conseguimento da parte dell’Italia unita di
traguardi di sviluppo politico, economico e civile che i protagonisti del Risorgimento
avevano invece ritenuto a portata di mano e che altri paesi, Germania in testa, sembravano conseguire con ben altra rapidità ed efficacia che non l’Italia. Una valutazione del Risorgimento italiano basata più sulle insufficienze dello stato unitario che non
sui progressi che la sua nascita comunque rappresentava rispetto alla realtà preunitaria, caratterizzò d’altronde sin dall’inizio la storiografia d’ispirazione democraticomazziniana e successivamente quella nazional-fascista e quella marxista del XX secolo; tutto ciò ha finito per oscurare agli occhi dell’opinione pubblica nazionale e
internazionale l’innegabile natura progressista e rivoluzionaria dell’unità nazionale
rispetto non solo alla storia italiana preunitaria, ma rispetto all’intera storia europea
dell’età moderna, se non anche di quella medievale.
In questa sottovalutazione hanno finito per essere dimenticate cose che una volta
erano largamente conosciute sin dalla scuola elementare, mentre sono ascoltati con
ricezione incredibilmente acritica discorsi leghisti o neoborbonici infarciti di deformazioni arbitrarie e di autentici falsi storici, di fronte ai quali sono portato a chiedermi con angoscia a quale livello sia scaduto nel nostro paese il ruolo e la funzione
formativa dell’insegnamento della storia nelle scuole secondarie. Ma non vorrei iniziare polemizzando con le correnti vulgate antirisorgimentali, perché questo nuoce-
15
rebbe all’efficacia di una analisi pacata e scientificamente ben fondata degli avvenimenti di cui celebriamo il 150 anniversario e per la quale vorrei rimanere lontano sia
da commemorazioni vuotamente retoriche, sia da processi improvvisati all’evento
fondatore della nostra storia nazionale. Preferisco quindi iniziare sottolineando che
per valutare la vera importanza storica del passaggio a Grottammare dell’esercito
piemontese guidato da Vittorio Emanuele II, noi dobbiamo preventivamente tornare
a riflettere sulla portata storica della nascita nel 1861 dello Stato nazionale unitario
italiano. Per far ciò il modo più produttivo è quello di valutare quali erano nel 1861
le condizioni dell’Italia e del Mezzogiorno, inquadrate nel contesto della storia europea, e confrontarle col cammino effettuato dopo l’Unità.
16
Il torto più grande che è stato fatto al Risorgimento da molta parte della storiografia italiana e straniera è stato quello di aver in parte o del tutto dimenticato ciò che
esso rappresentò nella storia politico-territoriale d’Europa. L’Unità d’Italia e quella
della Germania cambiarono infatti gli equilibri di potenza del Vecchio Continente
come mai era avvenuto da almeno 5 o 6 secoli, e questo nell’Ottocento ebbe un’importanza storica molto maggiore di quella delle trasformazioni sociali ed economiche
che pure scaturirono dall’unificazione politica dei due paesi. Gli equilibri politicoterritoriali in Europa, a partire dalla metà del 1500 con la pace di Cateau-Cambresis
(1559) e poi con i trattati di pace di Westfalia (1648), di Utrecht e Rastadt (1713-14),
di Vienna (1738), di Aquisgrana (1748), e ancora di Vienna (1815), avevano infatti
visto sempre l’egemonia europea contesa, con esiti variati più volte nel corso dei
secoli, tra Spagna, Francia, Impero asburgico, mentre l’Italia e la Germania continuavano ad essere aree frammentate politicamente e militarmente e quindi subordinate
alla potenza egemone di turno. L’Italia era sin dal basso medioevo la più antica nazione linguistica d’Europa. La cultura italiana e quella tedesca nel corso dell’intera
età moderna furono tra le più prestigiose e ricche del continente, quanto meno allo
stesso livello di quella francese, di quella spagnola, di quella inglese, o di quella austriaca. Tuttavia Italia e Germania, a differenza di Inghilterra, Francia, Spagna,
Austria, non ebbero mai espressione politica unitaria. Con la pace di Westfalia del
1648 la Germania continuò a essere divisa in più di 300 stati, l’Italia in varie decine
di stati, e proprio sul presupposto di tale condizione di impotenza politico-militare
italo-tedesca, Francia e Austria si contesero nei due secoli successivi l’egemonia in
Europa. Questa realtà cambiò solo nel momento in cui l’Italia e la Germania divennero nazioni anche statual-politiche, oltre che linguistiche e culturali. Per quello che
riguarda l’Italia, la situazione era anche peggiore di quella della Germania, perché
dagli inizi del 1500 essa rimase costantemente sotto l’egemonia di una potenza straniera: dapprima della Francia, poi dal 1530 stabilmente della Spagna, dal 1713-14
dell’Austria, poi di nuovo della Francia durante il periodo napoleonico, infine ancora
dell’Austria dopo il Congresso di Vienna. In definitiva gli stati italiani non erano mai
stati, fino al Risorgimento, soggetti, ma sempre oggetto di storia.
Con il Risorgimento e con la nascita dello Stato italiano, seguita da quella dello
Stato tedesco, questa situazione cambiò in un modo che sino ai nostri giorni si è rivelato irreversibile. Questo ci spiega perché nessuna potenza europea nell’Ottocento
voleva veramente l’Unità d’Italia. La nascita di un grande stato italiano non conveniva all’Austria perché, conseguentemente, essa avrebbe perso la sua egemonia nella
penisola. La Russia era stata alleata dell’Austria contro la Francia napoleonica ed era
stata il soggetto promotore della Santa Alleanza a difesa dell’ordine costituito a
Vienna: protesa ad espandersi nei Balcani, non aveva alcun interesse a vedere sminuita la potenza austriaca in Italia e ancor meno ad aiutare il movimento nazionale
italiano, che nella sua veste più moderata si presentava come fautore di un regime
monarchico-costituzionale e liberal-moderato. Anche la Prussia faceva parte del blocco conservatore capeggiato da Vienna, e solo con l’avvento di Bismarck, e a unificazione italiana avvenuta, si decise ad attaccare l’Austria e poi la Francia. La stessa
Francia non voleva l’unità dell’Italia. Napoleone III a Plombières aveva ipotizzato
una federazione di stati da inserire nell’orbita francese dopo aver estromesso l’Austria
dalla penisola. Il suo disegno, com’è noto, era di semplificare la carta politica italiana,
creando un grande stato nell’Italia settentrionale retto dai Savoia, ma anche un altro
grande stato nell’Italia centrale da affidare ad un principe di sangue francese, anzi di
sangue bonapartista. Contestualmente sarebbe dovuta sorgere una confederazione di
questi due stati con ciò che sarebbe rimasto dello Stato Pontificio e con il Regno
delle Due Sicilie. Quest’ultimo, in caso di caduta della dinastia borbonica, sarebbe
stato eventualmente concesso a Luciano Murat, anch’esso un membro, sia pure acquisito, di Casa Bonaparte. Tutto ciò avrebbe significato di nuovo l’instaurazione dell’egemonia francese nella penisola, non la nascita di uno stato nazionale unitario libero
e indipendente. L’Inghilterra da parte sua temeva fortemente questo tipo di soluzione,
che avrebbe rilanciato in Europa quell’imperialismo bonapartista contro il quale aveva combattuto, alleata con l’Austria, una interminabile guerra vinta definitivamente
con la battaglia di Waterloo. E assieme all’Austria l’Inghilterra aveva concorso nel
Congresso di Vienna del 1815 a stabilire gli equilibri politici italiani. Quindi, anche
se nel corso dell’età della Restaurazione e in particolare dagli anni 1830-40 in poi non
erano mancati motivi di contrasti economici con la dinastia borbonica e si erano susseguite condanne formali fermissime da parte inglese del regime politico e civile del
Regno delle Due Sicilie, l’Inghilterra temeva fortemente l’indebolimento della potenza austriaca nella penisola. Questo avrebbe potuto creare le condizioni per un rilancio
dell’imperialismo francese bonapartista, cosa che l’Inghilterra temeva più di qualunque altra. Solo a impresa dei Mille conclusa, ossia quando fu del tutto sicuro che la
Francia non avrebbe avuto altro che Nizza e la Savoia, il governo inglese si precipitò
a riconoscere il fatto compiuto, puntando da quel momento a fare del nuovo stato
italiano un possibile baluardo contro l’imperialismo francese.
L’Unità d’Italia fu dunque un miracolo, un autentico capolavoro politico-diplomatico di Cavour, che con forze militari molto modeste riuscì a isolare l’Austria da
tutte le potenze europee e alla fine a far accettare all’Europa una soluzione che se da
un lato evitava una rivoluzione democratico-sociale, dall’altro sovvertiva radicalmente gli equilibri di potenza in Europa. Il Risorgimento italiano fu poi un miracolo anche
da un altro punto di vista. Esso non portò infatti alla nascita di un nuovo stato in
forza di un’azione esclusivamente diplomatica. Nell’unificazione politica dell’Italia
entrò in gioco e influì in modo decisivo anche un movimento nazionale che fornì a
tutta l’operazione risorgimentale una legittimazione popolare che si pose come un
fatto radicalmente rivoluzionario rispetto al tradizionale ricorso al diritto divino e al
principio d’autorità delle grandi potenze come unica vera fonte di legittimazione
della sovranità.
17
18
Chi aveva legittimato, ad esempio, nel Settecento l’avvento della dinastia borbonica nel Regno di Napoli? È una domanda che i nostalgici borbonici evitano accuratamente di porsi quando accusano i plebisciti, indetti da Garibaldi nel Mezzogiorno
per legittimare l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno di Vittorio
Emanuele II, di essere stati poco più che una farsa fraudolenta. Evitano di porsela
perché la risposta sarebbe che la conquista militare del Regno da parte di Carlo di
Borbone non fu legittimata mai da nessun plebiscito, né da alcun’altra espressione
legale della volontà popolare, ma dal trattato di pace sottoscritto a Vienna nel 1738
dalle potenze belligeranti della Guerra di successione polacca. Carlo di Borbone era
sceso nel Mezzogiorno alla testa di un esercito spagnolo e aveva vinto la battaglia del
Bitonto. Come è scritto in qualunque manuale di storia per i licei, le potenze europee,
che avevano riconosciuto nel 1738 come re di Polonia Augusto III di Sassonia invece
del pretendente francese, avevano deciso anche, per compensare la Francia, la concessione della Lorena al pretendente deluso - che era anche suocero del re Luigi XV Stanislao Leszczyński, con il contestuale passaggio in Toscana degli Asburgo di
Lorena. Alla morte di Leszczyński la Lorena sarebbe stata annessa alla Francia. Si era
inoltre concesso a Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese e del re di Spagna, il
riconoscimento del possesso dei Regni di Napoli e di Sicilia, conquistati durante la
guerra. Da allora i Borbone erano rimasti re di Napoli e Sicilia, tranne la parentesi
napoleonica, ma mai avevano avuto né cercato una qualche forma di legittimazione
popolare della loro sovranità, neppure dopo la reazione sanfedista del 1799, che pure
li aveva rimessi sul trono schiacciando la rivoluzione giacobina. Al contrario Cavour
e Vittorio Emanuele II ritennero di fondamentale importanza che vi fosse nella nascita del nuovo Regno d’Italia, oltre al concorso della forza delle armi e della diplomazia,
anche quello della volontà popolare espressa attraverso l’azione dei corpi armati volontari, i plebisciti e l’adozione di un ordinamento politico costituzional-liberale.
Cavour e la dinastia sabauda non agirono dunque isolatamente. Essi furono strettamente collegati a un movimento nazionale costituito dalla parte della popolazione
della penisola più colta, politicamente più avanzata ed economicamente più consapevole di quello che stava accadendo in Europa e nel mondo. Quel movimento si pose
l’obiettivo di creare uno Stato nazionale italiano prima e autonomamente da casa
Savoia. Le prime elaborazioni di teorie e strategie politiche unitarie nacquero nell’ambito del movimento giacobino italiano e non certo in ambiente sabaudo. La prima rivoluzione carbonara ebbe luogo nel Mezzogiorno nel 1820; quella piemontese del
1821 la seguì. Il Piemonte tornò poi a inserirsi nel processo unitario solo nel 1848,
dopo che i moti del 1831 e il successivo stillicidio di conati rivoluzionari falliti si
erano svolti del tutto autonomamente da Casa Savoia, quando non apertamente contro
di essa. È vero che il Risorgimento italiano trovò la forza per vincere solo quando
Casa Savoia e Cavour ne assunsero la guida, ma è stato posto definitivamente in chiaro da Rosario Romeo che, senza la spinta incomprimibile del movimento nazionale,
Cavour non avrebbe avuto le possibilità di successo diplomatico che invece ebbe.
Lo Stato italiano segnò dunque con la propria nascita una novità fondamentale
nella storia d’Europa, anche perché esso ebbe origine in virtù di una spinta ideale
della parte politicamente più attiva del popolo italiano, che lo portò ad assumere un
ordinamento politico liberal-costituzionale e a trovare la sua legittimazione non solo
nel diritto dinastico di Casa Savoia, ma anche nella libera espressione della volontà
popolare. Vittorio Emanuele II fu Re d’Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Per questo l’Unità d’Italia rappresentò non solo una rivoluzione degli equilibri di
potenza europei, ma anche un’avanzata altrettanto rivoluzionaria del principio della
sovranità popolare e del liberalismo contro i regimi politici assolutistici dominanti in
Europa da secoli.
Se questa fu la portata del Risorgimento italiano a livello di storia europea, ancora maggiore fu quella da esso avuta nell’orizzonte della penisola. Uno stato unitario
che la comprendesse per intero non esisteva in essa dal 569 d.C., anno dell’invasione
dei longobardi; la nascita del Regno d’Italia nel 1861 segnò un cambiamento senza
precedenti nella vita politica, sociale ed economica della popolazione che la abitava,
a prescindere da tutte le deficienze e incompiutezze che possano essere poi emerse
nella storia italiana successiva. Se infatti la penisola era rimasta divisa per secoli in
una molteplicità di stati piccoli e grandi, le ragioni non erano state solo quelle dettate
dagli interessi delle potenze straniere, ma anche quelle derivanti dai particolarismi
regionali e locali e dal ginepraio di entità politico-istituzionali, ordinamenti giuridici
e strutture economico-sociali che vi si erano radicate nel corso dei secoli. Già agli
occhi di Machiavelli si era stagliata quale principale ostacolo all’Unità politica dell’Italia l’esistenza di un grande Stato della Chiesa che divideva in due il Nord dal Sud
della penisola. Ma causa altrettanto ingombrante si era rivelato l’insieme dei pervicaci interessi di città-stato e signorie protese tutte alla gelosa difesa del proprio particulare. Mettere assieme un materiale tanto eterogeneo si era dimostrata per secoli impresa impossibile, mentre in Francia, Inghilterra, Spagna avevano preso corpo, tra
XV e XVI secolo, i grandi stati nazionali che avevano dominato e dominavano ancora nell’Ottocento la storia europea.
La creazione di un grande stato nazionale su scala peninsulare assume dunque
già di per sé una rilevanza che non può in alcun modo essere sottostimata. Ma per
valutarne a pieno la portata nella storia d’Italia è indispensabile soffermarsi attentamente sulla sua natura e sulle sue finalità istituzionali, misurandole alla luce del
grande processo di trasformazione politica, economica e sociale in atto nell’Europa
dell’Ottocento. Al riguardo si può dire, schematizzando, che in Europa, oltre a quello dell’emancipazione delle nazionalità oppresse, erano in atto a metà del XIX secolo altri due grandi processi: la progressiva democratizzazione degli ordinamenti politico-istituzionali e l’industrializzazione. Tra gli stati preunitari solo il Piemonte di
Cavour partecipava in una qualche misura al primo processo, perché, dopo la generalizzata concessione di carte costituzionali del 1848 e la sconfitta subita ad opera
dell’Austria nella Prima Guerra di Indipendenza, solo il Regno di Sardegna mantenne la Costituzione. I Savoia avranno in seguito, e soprattutto nella gestione dei rapporti con il movimento e il regime fascista, molti demeriti, però accanto al merito
fondamentale del concorso nella creazione dell’Unità d’Italia resta il dato di fatto
indelebile che il giovane Vittorio Emanuele II, chiamato nel 1849 a raccogliere la
pesantissima eredità della sconfitta subita da Carlo Alberto, ebbe il coraggio di non
cedere alle pressioni austriache e mantenere lo Statuto concesso dal padre l’anno
precedente. Per l’Austria quella Costituzione fu un’autentica spina nel fianco, perché
ad essa come possibile modello di ordinamento politico cominciarono a guardare i
ceti colti di tutta la penisola, per primi quelli dei suoi domini del Lombardo-Veneto.
19
20
All’altro capo d’Italia il divorzio della dinastia borbonica dal ceto civile del Regno
delle Due Sicilie, iniziato dal 1799, divenne definitivo dopo il 1848-49, quando per
la seconda volta dopo il 1820 la dinastia rinnegò la Costituzione appena concessa. Da
quel momento agli occhi del ceto civile meridionale e della parte più qualificata e
avanzata di coloro che sapevano leggere e scrivere, in un contesto in cui l’analfabetismo raggiungeva l’86% della popolazione in età scolare (nelle Marche e nell’Umbria era dell’82-83%), il Piemonte divenne il modello politico di riferimento e l’unica
speranza di ricongiungersi all’Europa più progredita. E così avvenne nel resto della
penisola. È emblematico al riguardo l’evolversi degli avvenimenti in Lombardia,
dove l’arciduca Massimiliano d’Asburgo fu inviato in sostituzione di Radetzky a ricucire un rapporto con la nobiltà e la borghesia milanesi, duramente colpite dopo il
1848-49 con la confisca dei beni degli esuli, con l’aggravamento dell’imposizione
fiscale, con la dilazione sine die della congiunzione della rete ferroviaria lombarda
con quella ligure-piemontese e il conseguente rallentamento dello sviluppo economico della regione. Massimiliano d’Asburgo, giunto a Milano, cominciò a offrire ricevimenti e onorificenze alla nobiltà, pensando che con questo avrebbe risolto il problema. In realtà dovette accorgersi ben presto che i milanesi chiedevano ben altro che
la semplice cessazione delle azioni repressive e del trattamento sussiegoso al quale
erano stati sottoposti sino ad allora. I milanesi vedevano che il Piemonte stava costruendo la più grande rete ferroviaria della penisola, aprendosi al commercio internazionale, mentre l’Austria non aveva alcuna intenzione di farlo. Nel frattempo
constatavano che in Lombardia si pagavano più tasse che in qualunque altra regione
dell’Impero e soprattutto comprendevano bene che, mentre in Piemonte il regime
assoluto era stato abolito a favore di un regime costituzionale con un Parlamento
elettivo, Massimiliano questo non avrebbe assolutamente potuto concederlo perché
Francesco Giuseppe non glielo avrebbe mai permesso.
Il passaggio all’Unità nel 1861 significò dunque in tutta la penisola l’avvento di
un regime di libertà politica superiore a quello precedente. Certo era un regime politico in cui votava solo il 2% della popolazione, ma era pur sempre uno dei regimi
politici più avanzati di Europa. Il Belgio e la Francia avevano un sistema elettorale
che prevedeva un maggior tasso di partecipazione al voto, anche se la Francia era
ormai ingabbiata nel sistema autoritario dell’impero bonapartista. Ma la cosa più significativa è che in Inghilterra, patria del liberalismo, con un Parlamento funzionante
a pieno regime sin dalla seconda metà del 1600, intorno al 1861 votava circa il 6%
della popolazione. Se si considera che quella inglese era per di più l’unica società del
mondo completamente industrializzata, allora il regime politico del Regno d’Italia,
con una società e un’economia quasi esclusivamente agricolo-commerciali, con il
75% di analfabeti contro il 30% dell’Inghilterra, poteva essere considerato a pieno
diritto nel ristretto gruppo dei regimi politici democraticamente più avanzati del continente e, comunque, portatore di un progresso indiscutibile rispetto alla situazione
degli stati italiani preunitari.
Resta infine da riflettere sul rapporto tra Risorgimento e industrializzazione, il
grande processo che stava cambiando la storia economica e sociale dell’Europa e di
fronte al quale gli stati preunitari erano rimasti tutti, Piemonte incluso, sostanzialmente emarginati. Nella penisola esistevano singole industrie sparse, anche nel
Mezzogiorno, e una rete diffusa di lavoranti a domicilio di prodotti tessili e di arti-
gianato per il fabbisogno familiare e per la rete mercantile di imprenditori che mediava con i mercati. Non esisteva però in nessuna regione, neppure in Piemonte,
Liguria, Lombardia un vero e proprio sistema industriale. Esemplificando si potrebbe
dire, come molti nostalgici borbonici, che a metà Ottocento Isola del Liri, nell’allora
provincia di Terra di Lavoro, era la Manchester italiana, perché dei suoi circa 5.000
abitanti la maggior parte erano operai delle cartiere e dei lanifici sorti nel periodo
murattiano e borbonico. Io però, superato il primo fremito di orgoglio meridionale,
perché sono nato a pochi chilometri da Isola del Liri, non posso non ricordare che la
Manchester vera in quegli anni aveva superato i 100.000 abitanti, che in Inghilterra
c’erano più di 10 nuove città “industriali” con oltre 100.000 abitanti e che più della
metà della popolazione inglese era addetta all’industria, mentre in Italia era l’agricoltura ad avere tra il 60 e il 70% del totale degli occupati, dividendosi il rimanente 30%
tra le attività terziarie e quelle secondarie all’interno delle quali erano inclusi gli
addetti all’artigianato e molti lavoranti a domicilio o stagionali. Gli addetti all’industria in senso stretto in tutta Italia ancora nel 1874 non raggiungevano le 400.000
unità su una popolazione vicina ai 28 milioni di abitanti. Come anche non possono
essere dimenticati altri dati d’ impatto anche maggiore. In Italia intorno al 1861 erano istallati 450.000 fusi per la filatura del cotone. Nello stesso tempo in Inghilterra
ce ne erano 30.000.000. Nella produzione siderurgica, 30.000 tonnellate di ferro
prodotte annualmente in Italia avevano in Inghilterra un corrispettivo di 3.700.000
tonnellate: un livello che l’Italia toccherà solo nel 1953. L’irrilevanza dell’industria
in senso stretto in tutta Italia era chiara a tutti, al Nord non meno che al Sud, con
buona pace di nostalgici asburgico-leghisti del Nord e di neoborbonici nel Sud.
Quando i leghisti vagheggiano di una grande realtà industriale del Nord-Italia al
momento dell’Unità, bisognerebbe far loro rileggere le lamentele continue che gli
industriali lombardi e veneti rivolgevano al governo asburgico contro la concorrenza
che le lane della Moravia e le cotonate e i prodotti siderurgici della Boemia facevano
alle industrie lombarde e venete nell’ambito del mercato protetto dell’Imperial Regio
Governo asburgico.
Il ceto civile meridionale, quello che emigrò dopo le repressioni del 1848-49 o che
comunque viaggiava liberamente nella penisola e in Europa, vedeva, oltre all’arretratezza industriale del Mezzogiorno, anche il fatto che, mentre il Piemonte costruiva
una rete ferroviaria di livello europeo, in Abruzzo, in Puglia, in Basilicata, in Calabria
e in Sicilia non c’era un solo chilometro di ferrovia. I pochi binari esistenti nel
Mezzogiorno erano tutti intorno a Napoli. Certo i neoborbonici si affannano a ricordare che la prima ferrovia in Italia era stata costruita per collegare Napoli a Portici;
dimenticano però che nel 1860, mentre l’Europa Nord-Occidentale procedeva speditamente sulla strada di una modernizzazione complessiva senza precedenti nei mezzi
di trasporto marittimi e terrestri (viabilità ordinaria, ma soprattutto naviglio, in ferro
e a vapore, e ferrovie), in Italia solo il Piemonte teneva parzialmente quei ritmi e il
Regno delle Due Sicilie restava assolutamente arretrato, con poco più di 100 km di
binari contro i quasi 700 del Piemonte, gli oltre 9.000 della Francia, i 14.000 dell’Inghilterra. Vedeva, inoltre, che mentre in Italia nel 1861 l’analfabetismo raggiungeva
il 75% della popolazione in età scolare, in Inghilterra e Galles quel tasso era solo del
30%, in Belgio, Francia e Impero asburgico del 40-50%, in Prussia e Scozia del 20%,
in Svezia del 10% e che le uniche tre regioni che in Italia si avvicinavano ai tassi
21
dell’Impero asburgico erano Lombardia, Piemonte e Liguria, che stavano all’incirca
sul 50%, mentre la stessa Toscana stava al 74% di analfabeti, l’Emilia Romagna attorno al 78%, il Veneto al 70%.
22
A questo stato di cose lo Stato unitario pose mano in una congiuntura interna e
internazionale difficilissima, estendendo il modello di sviluppo cavouriano all’intera
penisola. Certo, sia alla politica interna in materia di tenuta dell’ordine pubblico, sia
a quella economica attuata dallo Stato unitario, furono mosse, e non senza fondamento, critiche molto aspre sin dalla fine dell’Ottocento. Non che tutto, come già detto,
procedesse speditamente e senza sacrifici sulla strada della storia politica e dello
sviluppo economico e civile dell’Italia unita. Il Mezzogiorno, all’indomani dell’Unità, fu trattenuto nello Stato unitario solo grazie ad una dura azione repressiva della
gigantesca ondata di brigantaggio che impegnò per anni l’esercito piemontese in gran
parte delle regioni meridionali. Fu una repressione durissima, sulla quale ancora oggi
si insiste da parte di una disinformata letteratura giornalistica, che parla di oltre
100.000 morti (per qualcuno addirittura 800.000), vittime di una guerra civile combattuta tra meridionali e piemontesi. Al riguardo vorrei precisare che in realtà i morti
accertati dallo storico più attendibile in questa materia, ossia Franco Molfese, furono
poco più 5.000, che è ovviamente un numero enorme ma che non autorizza certo a
parlare di un genocidio perpetrato nei confronti dei meridionali da parte di uno Stato
che in realtà era chiamato a fronteggiare una sollevazione che metteva in pericolo la
sua stessa esistenza. Vorrei anche precisare che le ragioni più profonde del brigantaggio postunitario solo in poca parte potevano essere addebitate al nuovo regime. Non
c’è dubbio che tra le sue cause vi furono spinte politiche filo-borboniche, l’insofferenza per l’introduzione della leva militare obbligatoria, la reazione a un carico fiscale molto maggiore di quello dell’età borbonica, la sofferenza di molte produzioni
artigianali messe in crisi dalla concorrenza estera in seguito all’adozione del liberismo commerciale. Tuttavia è anche vero che il brigantaggio non può essere definito
come una guerra civile di meridionali contro i piemontesi, bensì come una guerra
civile combattuta da meridionali contro altri meridionali, cioè da contadini disperati
e affamati di terra che, quando nel passaggio da un regime all’altro si allentò il controllo dell’ordine pubblico, attaccarono il ceto dei galantuomini, colpevoli di avere
usurpato per decenni le terre dei demani pubblici. Era questa la più vera e potente
causa del brigantaggio: un malessere sociale che veniva da lontano e che aveva dato
luogo a sollevazioni analoghe anche sotto il regime borbonico. Era un problema risalente almeno all’epoca dell’abolizione della feudalità, realizzata da Giuseppe
Bonaparte nel 1806 e poi mantenuta dal governo borbonico, che l’aveva estesa anche
alla Sicilia negli anni 1820-30. Da allora si era sviluppata una pervicace azione della
borghesia terriera volta all’accaparramento di terre demaniali. Stante anche la contestuale abolizione degli usi civici esercitati dai contadini su quelle terre, si era instaurato nelle campagne un odio feroce tra cafoni e galantuomini che rischiava da tempo
di esplodere in furiose jacqueries. Una riprova di ciò è data dalle statistiche dei reati
commessi dai briganti. Nel 1863 furono rubati o uccisi dai briganti circa 10.000 capi
di bestiame; nel 1864 circa 11.000. Essi non appartenevano certo all’esercito italiano,
ma a proprietari e agricoltori meridionali i quali chiedevano il ristabilimento dell’ordine pubblico al nuovo Stato e non più alla dinastia borbonica nella quale avevano
smesso da tempo di credere. E questo è il punto decisivo nella valutazione storica del
brigantaggio: era un movimento di ribellione sociale che a livello di obiettivi politici,
quando ne esprimeva, proponeva puramente e semplicemente la restaurazione della
dinastia borbonica, ossia di quella dinastia che aveva relegato il Regno delle Due
Sicilie nelle condizioni politiche, sociali ed economiche che abbiamo poc’anzi illustrato. E non c’è alcun dubbio che al Mezzogiorno non convenisse tornare a quello
stato di cose, anche a costo di una repressione durissima quale indubbiamente fu
quella condotta nel segno della legge Pica e di una politica economica che per diversi decenni gli impose molti sacrifici e delusioni.
D’altro canto il superamento dell’arretratezza e della miseria della maggior parte
della popolazione richiese in tutta la penisola tempi più lunghi di quelli immaginati
dal ceto politico risorgimentale, Cavour in testa. La lotta all’analfabetismo nel
Mezzogiorno si dimostrò molto più difficile di quel che avevano creduto coloro che,
durante il Risorgimento, avevano visto il fenomeno soprattutto come il prodotto della volontà dei ceti privilegiati e delle classi dirigenti preunitarie di mantenere nell’ignoranza le plebi per meglio sfruttarle. Lo Stato unitario si dimostrò in questo campo
incapace di conseguire risultati omogenei in tutta la penisola, tanto che la differenza
percentuale degli analfabeti tra il Mezzogiorno continentale e il Settentrione nel 1921
risultava ancora di 31,8 punti percentuali contro i 24,8 del 1861, con un aumento
quindi dello squilibrio. E tuttavia non si può dimenticare che, in assoluto, nello stesso
arco di tempo gli analfabeti nell’intera Italia scesero dal 75% al 29% della popolazione in età scolare e che lo stesso Mezzogiorno continentale vide la propria quota percentuale diminuire dal ricordato 86% del 1861 al 46% del 1921, con un recupero
quindi di 40 punti, cosa che significava un accorciamento di distanze innegabile rispetto ai paesi europei più alfabetizzati.
Lo squilibrio territoriale tra Nord e Sud in termini di reddito pro-capite risulta
oggi più ampio di quello che esisteva al momento dell’Unità. Se le antiche tradizioni
comunali e cittadine si sono dimostrate per un verso un punto di forza della nostra
storia nazionale, per altro verso i localismi hanno costituito anche un punto di persistente fragilità della nuova compagine nazionale e i recenti, per quanto velleitari,
proclami secessionisti, sono lì a dimostrare quanto gli egoismi territoriali siano stati
e siano ancora duri a morire. E tuttavia la storiografia di ogni tendenza riconosce
ormai che le scelte di politica economica adottate dallo Stato liberale sin dall’indomani dell’Unità furono decisive per l’avvio di un processo di industrializzazione e di
complessiva modernizzazione incommensurabilmente più rapido ed efficace di quello realizzato dai caduti regimi preunitari. L’assoluta mancanza di carbon fossile ad
elevato tenore calorico costituì a lungo un handicap energetico formidabile per l’Italia, e tuttavia la politica agricola e commerciale dello Stato liberale fu in grado di
favorire in agricoltura grandi profitti e la formazione di eccedenze di capitali che
furono impiegate, grazie all’intervento statale, nel più grande sforzo di infrastrutturazione che la storia d’Italia ricordi. La strategia che nel decennio 1850-60 aveva dotato il Piemonte di una delle reti ferroviarie più progredite d’Europa fu estesa all’intera
penisola, nella quale nel giro di un trentennio fu costruita l’intera rete ferroviaria
nazionale a binario unico. Alla vigilia della Prima Guerra mondiale nel Mezzogiorno
c’era ormai lo stesso numero di chilometri di ferrovie per abitante esistente nel Nord.
L’inferiorità che oggi si registra nella rete dei trasporti del Sud si ricreò successiva-
23
24
mente alla Prima Guerra mondiale, quando si passò al raddoppio dei binari e all’elettrificazione delle linee.
Le ferrovie furono non solo il principale mezzo di trasporto dell’intera economia
nazionale, ma anche uno dei prerequisiti fondamentali dell’industrializzazione, che
solo in seguito alla creazione dello Stato unitario e alla sua politica economica ebbe
veramente inizio. Fu uno sviluppo industriale che rimase a lungo fortemente concentrato nelle tre regioni che già al momento dell’Unità erano meglio attrezzate infrastrutturalmente, ma che comunque sino ad allora, come abbiamo visto, erano rimaste
paurosamente arretrate sulla via dell’industrializzazione, anzi in taluni casi non erano
partite affatto. Il Mezzogiorno dopo l’Unità, pur sviluppandosi discretamente in campo agricolo e commerciale, rimase sostanzialmente emarginato dall’industrializzazione, che decollò invece impetuosamente nel Nord. Nel Mezzogiorno continentale e in
Sicilia, a parte l’apertura dello stabilimento di Bagnoli e il potenziamento della struttura industriale napoletana durante il fascismo, un vero sviluppo industriale fu avviato in modo significativo, e peraltro temporaneo, solo nella seconda metà del secolo
XX. Va detto anche che nell’insieme l’industrializzazione italiana non risparmiò alla
popolazione dell’intera penisola l’imponente ondata migratoria dell’età giolittiana e
a quella meridionale anche l’esodo del secondo dopoguerra. Ma va comunque ricordato che è stato quello stesso sviluppo industriale a consentire all’Italia di inserirsi nel
novero dei paesi più moderni e ricchi del mondo. Quanto alle regioni settentrionali
non va mai dimenticato che esse riuscirono ad avviare un vero processo di industrializzazione solo dopo essere entrate a far parte in posizione egemone di un grande
mercato nazionale comprendente il Mezzogiorno. Mezzogiorno che a sua volta, pur
con tutti i problemi e le insufficienze di sviluppo economico e civile che ancora lo
affliggono, non può ritenere che avrebbe avuto uno sviluppo migliore all’interno dei
limitati confini di uno Stato borbonico il cui territorio e la cui popolazione arrivarono
all’Unità d’Italia nelle condizioni che abbiamo qui sopra ricordato. La verità è che lo
Stato unitario anche sul piano economico e sociale, e sia pure in modo territorialmente diseguale, segnò per tutti, da Nord a Sud, una svolta di fondamentale, ineguagliata
importanza.
Sono queste le ragioni di ordine ideologico, politico, economico, sociale e civile
per cui la portata storica del Risorgimento giganteggia oggi più che mai nella storia
d’Italia e d’Europa. Nel miracolo politico-diplomatico che si realizzò nel 1859-61, la
spedizione di Vittorio Emanuele II nel Sud attraverso l’Abruzzo ebbe un ruolo fondamentale. Senza di essa molto probabilmente il Mezzogiorno non si sarebbe unito
all’Italia e senza Mezzogiorno non vi sarebbe stata Italia unita. A Grottammare
Vittorio Emanuele II ricevette l’ultimo e più importante appello dei maggiori esponenti della società civile meridionale, affinché entrasse nel Regno delle Due Sicilie
non come conquistatore ma come portatore di libertà a una popolazione soggetta a un
regime dispotico condannato dalla storia. Fu un momento cruciale, quindi, per il
successo del Risorgimento, ossia della pagina fondamentale della storia d’Italia e
d’Europa in età moderna e contemporanea.
La più diffusa manualistica storica risorgimentale non ha dato finora risalto agli
eventi che si svolsero tra l’estate e l’autunno del 1860 nell’ampio territorio che si
estende dalle Marche meridionali alla Campania settentrionale. Nei libri di storia di
medio taglio, quelli ai quali attinge conoscenza la massa degli individui negli anni di
scuola, le vicende dei mesi di settembre e ottobre di quell’anno sono presentate, in
genere, solo con l’accenno alla battaglia dei Piemontesi a Castelfidardo (18 settembre), seguita dall’espugnazione di Ancona (29 settembre) e una notizia più circostanziata della decisiva battaglia garibaldina del Volturno (1-2 ottobre), a cui si fanno
seguire il cosiddetto “incontro di Teano” (avvenuto in territorio di Vairano) tra il generale e Vittorio Emanuele il 26 ottobre e l’entrata di quest’ultimo a Napoli il 7 novembre.
Si salta in questo modo ogni riferimento ai complessi avvenimenti d’ogni genere
che si verificarono in quei due mesi nel vasto spazio tra Ancona e il confine della
Campania. Se il sovrano sabaudo poté lasciare Ancona, varcare il Tronto, attraversare rapidamente l’Abruzzo e il Molise e raggiungere Garibaldi in Campania, percorrendo in 15 giorni circa 400 chilometri in gran parte sulle vie impervie dell’Appennino, ciò si dovette all’evoluzione della situazione politico-insurrezionale dell’Abruzzo
fin dall’inizio di settembre e alla sconfitta definitiva inflitta dai Piemontesi all’esercito borbonico sulla montagna del Macerone, a Nord di Isernia, il 20 ottobre.
Quest’ultimo fatto d’armi, che vide impegnati circa 5.000 borbonici, al comando del
generale Luigi Scotti Douglas, e altrettanti sabaudi, guidati da Enrico Cialdini (con la
partecipazione anche di reparti garibaldini), fu davvero conclusivo dell’intera campagna e non può non entrare di peso nel quadro dell’epopea risorgimentale. Se ne ricordò bene Garibaldi, quando nel messaggio di congedo «ai compagni d’armi» (dell’8
novembre) si rivolse agli «Italiani di Calatafimi, di Palermo, del Volturno, d’Ancona,
di Castelfidardo, d’Isernia». Ma non minore importanza ha la cognizione del complesso dei fatti che si svolsero in quei mesi in quello scacchiere, pienamente al centro
dell’attenzione di tutti i manovratori dell’epocale rivolgimento in corso nella realtà
italiana.
Le Marche e l’Abruzzo sono divisi dal corso del fiume Tronto, che dalla metà
del secolo XII, quando si concluse la conquista normanna dell’intero Mezzogiorno
peninsulare, rimase ininterrottamente per sette secoli a segnare il confine tra lo Stato
della Chiesa e il Regno di Sicilia (di volta in volta detto di Napoli o delle Due
Sicilie). All’epoca dei nostri fatti, l’attraversamento del Tronto da parte dell’esercito
piemontese, già padrone delle Marche, rappresentava un passo di enorme significato
politico, con grandi riflessi nella diplomazia europea e soprattutto nei rapporti con la
Francia di Napoleone III, ancora deciso a salvare l’esistenza del Regno borbonico,
per quanto sbriciolato dalla fulminea spedizione di Garibaldi. Uno dei fattori di massima tensione che emergevano da quel quadro geografico era proprio, agli occhi
25
dell’Europa, la violazione di quel confine fluviale e si spiegano bene, perciò, le considerazioni che su di esso espresse, direttamente al suo Re, Cavour, in una lettera del
10 ottobre, dichiarando «Maestà! Il passaggio del Tronto è più importante del Ticino
del 1848» e il richiamo che Salvatore Tommasi fece, indicando al sovrano quel modesto fiume, al «Rubicone che questa volta si chiama Tronto».
26
Salvatore Tommasi, appunto: il personaggio, oggi pressoché ignoto ai più, che fu
al centro di tutta la rete di fatti che si andavano svolgendo in questa parte d’Italia, in
connessione diretta non solo con l’andamento delle trattative cavouriane in Europa,
ma con gli accesi contrasti tra le schiere liberal-monarchiche e quelle democratico-repubblicane, venute fortemente a confronto proprio in questa terra di mezzo, sospesa
tra l’esercito sabaudo e quello garibaldino.
Figlio di un agrimensore di Accumoli, temporaneamente residente a Roccaraso,
Salvatore Tommasi (fig. 1) nacque in questo paese (passaggio obbligato sulla “via
degli Abruzzi”) il 26 luglio del 1813, ma già all’età di tre mesi era tornato con la
madre nel paese paterno. Fece i suoi studi nel Seminario di Ascoli Piceno e poi nel
Liceo Universitario dell’Aquila, passando poi a Napoli dove si laureò in medicina nel
1834. Per la prima parte della sua vita mi limiterò ad aggiungere che presto si orientò verso i principi e i metodi della medicina più scientifica, arrivando a conquistare
nel 1845 la cattedra nell’Ateneo napoletano. Forse già all’Aquila, ma certo a Napoli,
si accostò ai circoli patriottici e nel 1848 fu eletto deputato del collegio abruzzese di
Cittaducale nel Parlamento napoletano; quando il Borbone ritirò, dopo pochi mesi, la
Costituzione, fu tra i firmatari della famosa protesta di Pasquale Stanislao Mancini,
cosa che gli costò la destituzione dalla cattedra, il carcere e l’esilio.
Sulle vie dell’esilio - da Genova a Parigi a Londra e infine a Torino - Tommasi si
immerse nella più avanzata cultura europea, nel campo medico ma anche in quello
più latamente scientifico e filosofico: aderì alle teorie di Darwin, che contribuì a diffondere poi in Italia (celebre la sua commemorazione dello scienziato inglese fatta a
Napoli nel 1882). Al suo rientro in Italia frequentò l’ambiente degli altri esuli convenuti a Torino, tra i quali erano gli abruzzesi Bertrando e Silvio Spaventa, Angelo
Camillo De Meis, Pier Silvestro Leopardi. Ebbe la cattedra di clinica medica all’Università di Pavia (19 ottobre 1859).
Si giunge così al momento della sua missione particolarissima nel quadro delle
operazioni politico-insurrezionali nel Napoletano, in concomitanza con l’avanzata di
Garibaldi. Il 4 agosto ebbe la cittadinanza piemontese, come forma di salvacondotto
per andare ad operare a Napoli e nella sua regione di origine, su preciso incarico di
Cavour. Il 9 partì da Torino, il 13 era giunto a Napoli. Da quel momento e per tre
mesi Tommasi fu il perno principale dell’azione progettata da Cavour per appoggiare
la spedizione dell’esercito piemontese (allora in movimento tra Toscana e Romagna)
e conseguire un quadruplice obiettivo: prevenire l’arrivo di Garibaldi a Napoli, ostacolare dappertutto l’azione del partito repubblicano, garantire sicurezza e favore
monarchico nelle regioni che il sovrano e il suo esercito avrebbero dovuto attraversare, procurare - e fu questo il colpo più mirato - una sorta di “preplebiscito” di adesione dell’Abruzzo e del Molise al Regno d’Italia. In tutte le direzioni si mosse Tommasi,
tenendosi in continuo contatto con la centrale torinese e riunendo intorno a sé i più
attivi liberali abruzzesi, quali Giuseppe Devincenzi, naturalista e agronomo di grande
27
fig. 1 - Salvatore Tommasi (Roccaraso 1813-Napoli 1888), medico, filosofo, patriota
28
valore, e Silvio Spaventa. Non riuscì a raggiungere il primo obiettivo, ma condusse
trattative dirette con Garibaldi, ormai padrone della Campania e prossimo a insediarsi a Napoli (vi entrò il 7 settembre), fronteggiando in una certa misura il concorrente
partito repubblicano: a Napoli erano infatti accorsi repubblicani da varie parti d’Italia
e d’Europa, con Mazzini in persona, affiancato dal suo più stretto seguace abruzzese,
l’aquilano Pietro Marrelli, e da altri personaggi del calibro di Cattaneo e Bertani, per
convincere il generale a non far entrare i Piemontesi nel Regno, a innalzare il vessillo rosso e a proseguire l’avanzata fino alla conquista di Roma. Garibaldi non aderì,
com’è noto, a queste proposte.
Ma negli altri tre obiettivi Tommasi riuscì in pieno. L’operazione più audace e
impegnativa fu quella del “preplebiscito”, che consistette nell’ottenere dai Comuni
delle due regioni ancora in bilico dichiarazioni di adesione al Regno d’Italia e quindi
di invito a Vittorio Emanuele ad entrare nel proprio territorio. In meno di un mese,
percorrendo freneticamente e tra continui pericoli le due regioni («Io sto viaggiando
gli Abruzzi dì e notte a palmo a palmo e vado nei singoli municipi […] e bisogna
essere pronti a maneggiare il revolver per non essere sopraffatti» scrisse in una lettera del 25 settembre al ministro Luigi Carlo Farini), Tommasi raccolse oltre 150 adesioni in Abruzzo e una trentina nel Molise. Il 7 ottobre era ad Ancona, a capo della
delegazione che consegnava queste dichiarazioni personalmente al Savoia. Cavour,
che ancora il 4 ottobre aveva telegrafato trepidante al Farini «pour l’amour de Dieu,
hâtez vôtre entrée dans les Abruzzes», aveva così in mano le carte per giustificare nei
confronti degli Stati europei l’intervento militare.
Dopo quei risultati, il teatro delle operazioni si spostò decisamente presso il confine del Tronto e Grottammare divenne il preciso luogo di un altro importante appuntamento: in questa cittadina il sovrano ricevette il 12 ottobre un’altra delegazione
legittimante, quella di alti esponenti napoletani quali Ruggero Bonghi, che ne era il
capo, e Luigi Settembrini (i Napoletani avevano compiuto un lungo tragitto, passando
da Livorno, raggiunta per mare, e di qui a Bologna e ad Ancona). Il 15, preceduto
dalle forze al comando di Cialdini, Vittorio Emanuele attraversò il Tronto e nei giorni successivi per Giulianova, Pescara, Chieti, Popoli, Sulmona, Castel di Sangro
(dove sostò il 21, giorno del Plebiscito di tutte le regioni meridionali), Isernia,
Venafro, raggiunse Vairano per puntare su Napoli. In tutto questo percorso lo affiancarono in carrozza Salvatore Tommasi, nominato colonnello dell’esercito regio, e
Giuseppe Devincenzi.
Non devo, in questa occasione, entrare nei dettagli di quella audacissima e veloce traversata degli Appennini compiuta dalle due armate piemontesi (la IV e la V) con
il Re Vittorio alla testa. Audacissima perché le strettoie delle montagne abruzzesi
presentavano rischi fin troppo evidenti; resa veloce e sicura dalla preparazione condotta dalla schiera coordinata da Tommasi, fortemente appoggiato da una gran parte
della borghesia della sua terra e, attraverso questo legame, perfino da una parte del
clero locale (che in molti luoghi si profuse in cerimonie religiose e Te Deum in onore
del Savoia e talora perfino di Garibaldi). Ma devo segnalare che quella preparazione,
soprattutto del “preplebiscito”, quell’ambiente divenuto largamente amico e accogliente dovettero impressionare in modo particolare la cerchia governativa e la corte
torinese, se a brevissima distanza da quegli avvenimenti proprio a Torino ci fu un
artista che scelse come soggetto di un suo quadro il favore popolare degli Abruzzesi
per il compimento dell’Unità italiana.
Si tratta di una tela (fig. 2) di notevoli dimensioni (cm 150x75) che, realizzata dal
pittore torinese Enrico Gamba (1831-1883) già nei primi mesi del 1861 e vincitrice
del Premio di Breme, fu acquistata dal principe ereditario Umberto di Savoia, passando poi al cadetto Oddone dal quale pervenne al Comune di Genova (ed è oggi conservata nella Galleria d’Arte Moderna della città). Riemersa, su mia segnalazione, è
stata esposta nella grande mostra torinese dei dipinti risorgimentali allestita a Torino
per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
La tela ha il titolo Il voto di annessione dell’Abruzzo, con riferimento chiaro al
voto del plebiscito del 21 ottobre 1860. L’interpretazione d’insieme del dipinto è oltremodo chiara: una coppia di tipici zampognari guida una piccola folla di persone
che si recano a votare per il plebiscito, esibendo in mano o sul cappello la scheda per
il “sì” (quello della scheda appuntata al cappello è un dettaglio confermato da fonti
aquilane). Il gruppo è formato in maggioranza da contadini, uno dei quali, il più giovane, issa e sventola il tricolore con lo stemma sabaudo, mentre altri due (uno all’inizio del corteo, l’altro sul carro che lo chiude) issano su dei bastoni l’effigie di
Vittorio Emanuele. Alcuni, con il braccio alzato, danno l’impressione di intonare
degli evviva o dei canti. A metà del corteo, leggermente distaccati dagli altri e strettamente affiancati tra loro, si distinguono chiaramente all’abbigliamento un sacerdote (con abito talare e tricorno), un borghese (con bombetta, gilet e polpe) e un aristocratico (con cilindro). Si aggiungono un mandriano a cavallo, che saluta togliendosi
il cappello, un carro trainato da buoi, addetto a trasportare persone e seguito da altri
personaggi sullo sfondo. Particolari che conferiscono colore e movimento sono un
bambino tenuto per mano da un adulto, con a fianco un cagnolino, e una donna portatrice di un’anfora d’acqua (poggiata sulla testa, com’è tipico di questa e d’altre regioni meridionali) con accanto una bambina, entrambe in costume da festa, dialoganti tra loro. Il paesaggio che fa da sfondo è occupato da un’alta montagna rocciosa, che
sembra adombrare il Gran Sasso, e da un declinare di colli che terminano su una
spiaggia marina: potremmo essere nell’entroterra di Giulianova.
Fig. 2 - Enrico Gamba (Torino 1831-1883), Il voto di annessione dell’Abruzzo, Genova, Galleria d’Arte Moderna
29
30
La rappresentazione della scena è studiatissima e mira a trasmettere l’idea di una
vivace e concorde partecipazione di popolo alla decisione politica. Si può supporre
che l’ispirazione per questo quadro sia venuta dai circoli torinesi in cui si erano mossi negli anni precedenti i rifugiati abruzzesi, tra i quali aveva primeggiato Tommasi.
Arrischio qui anche l’ipotesi che nel vestiario della donna che reca l’anfora d’acqua
vi sia un riferimento al tipicissimo costume di Pettorano sul Gizio (corsetto nero di
stoffa pesante, con largo aggetto anteriore; camicia e fazzoletto in testa, con lunga
ricaduta di scialle sulla schiena, in tela bianca): era questo il paese di origine della
moglie di Salvatore Tommasi, Emilia Luisa Organtini, morta a Napoli appena prima
dell’esilio dello scienziato patriota, il quale poi assunse, nei frangenti delle azioni
politiche, lo pseudonimo Gizio. Né si può trascurare il fatto che nei giorni precedenti al passaggio del Re da Pettorano (21 ottobre 1860) l’amministrazione del Comune
aveva commissionato al pittore sulmonese Panfilo Catenazzi un ritratto di Vittorio
Emanuele II, che fu mostrato al sovrano in una cerimonia particolarmente solenne
durante la sua sosta (oggi si conserva in una collezione privata). Non poteva non esserci, in tutto ciò, il segno del legame affettivo di quel paese con Tommasi.
Un’altra immagine va direttamente accostata a quella che ho appena presentato:
è l’incisione (fig. 3) che illustra l’arrivo di Vittorio Emanuele alla fortezza di Pescara,
il 17 ottobre, alle 8 di mattina. L’incisione, ricavata dagli schizzi di Raffaele
Pontremoli (1832-1905), venuto al seguito dell’esercito sabaudo, trasmessi a Torino
per il periodico Il Mondo Illustrato, ritrae il momento in cui il Re e il suo seguito
percorrono il ponte di barche sul fiume Pescara, tra i due archi trionfali allestiti all’inizio e alla fine del ponte. Oltre alle figure del Re e del suo seguito, tutti a cavallo, e
oltre al popolo acclamante, fatto di uomini e donne, popolani e borghesi, si distinguono la fanfara che apre il corteo e tre figure di sacerdoti in mantelli bianchi. Sul fondo,
verso la foce del fiume, da un vascello partono salve di cannone.
Fig. 3 - Vittorio Emanuele II e il suo seguito attraversano su un ponte di barche il fiume Pescara, per dirigersi alla
Fortezza (17 ottobre 1860). Incisione da Il Mondo Illustrato, sulla base degli schizzi di Raffaele Pontremoli
Infine, emana direttamente dalla società locale il disegno (fig. 4) che si trova nel
Libro dei Battezzati (anni 1860-1900) della Collegiata di Santa Maria del Colle di
Pescocostanzo, come immagine iniziale dell’anno 1862 (insieme con vari altri disegni contenuti nello stesso volume e nel Libro dei Matrimoni degli anni 1779-1900).
Si può anche supporre che il disegnatore sia stata persona diversa dal parroco che ha
redatto l’atto di battesimo immediatamente precedente e quello successivo, ma nulla
impedisce di credere che l’esecutore sia stato proprio lui. D’altronde, la registrazione
delle annotazioni di battesimo era un atto di notevole responsabilità e quindi è difficile pensare che qualcun altro riempisse liberamente con disegni pagine di quel libro
o potesse farlo senza la piena approvazione dei parroci.
31
Fig. 4 - Disegno a penna e inchiostro di china (di mano del parroco Francesco Antonio Zappi?) nel Libro dei
Battezzati - vol. 1860-1900, all’inizio dell’a. 1862, Pescocostanzo, Archivio Parrocchiale di Santa Maria del Colle
32
L’audacia del contenuto politico del disegno non deve sorprendere, perché tutte
le informazioni che si hanno sull’ambiente del Capitolo dei canonici di Pescocostanzo confermano che questi erano decisamente e combattivamente schierati per l’Unità
d’Italia: da memorie tramandate oralmente si apprende che, nei mesi decisivi degli
eventi che condussero all’unificazione, sull’altare maggiore della Collegiata furono
esposti i ritratti di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II. Quando il sovrano si trovava
a Sulmona e fu allestito un trono nella sede della Sottintendenza dove avrebbe ricevuto l’omaggio delle autorità cittadine, i canonici di Pescocostanzo inviarono, per
completare l’addobbo, la grande corona d’argento che si trova sul tabernacolo per
l’esposizione del Sacramento.
Il disegno propone una vera sintesi degli avvenimenti degli ultimi mesi del 1860
e almeno dei primi del 1861. Vi si osserva Vittorio Emanuele II in piedi su un cavallo nero in corsa sfrenata (simbolo ben noto della città di Napoli e, per estensione,
dell’ex-Regno delle Due Sicilie) che galoppa al di sopra dei resti di un esercito disfatto (cannoni, soldati, armi, bandiere con giglio borbonico, una torre, forse allusione
all’espugnazione dei forti di Gaeta e di Civitella del Tronto), disposti a formare il
numero 1862; il sovrano, issando il tricolore con stemma sabaudo e il nome ITALIA,
combatte con la sua spada contro una belva, che viene sorretta da due mani nere e
tenuta al guinzaglio da una mano con guanto bianco. La belva rappresenta il brigantaggio, sostenuto da truppe di Zuavi nordafricani (al servizio della Francia) e guidato
dal pontefice romano. Sul lato destro del disegno si legge: «Storia contemp.».
Si ammira la capacità di sintesi di una simile quantità di elementi e, sul piano
artistico, l’originalità del tratteggio che compone la figura della belva, in questo modo caratterizzata anche come qualcosa di misterioso e inafferrabile.
Riferimenti bibliografici
Si fornisce qui la bibliografia strettamente necessaria, limitata ad opere recenti relative al contenuto di
questo testo, dalle quali si può risalire ad opere più generali e alle fonti primarie (resoconti sincroni, epistolari, giornali dell’epoca).
- R. Aurini (a cura di), Salvatore Tommasi in Dizionario bibliografico della gente d’Abruzzo, vol. I, Ars et
Labor, Teramo, 1952, pp. 89-96.
- A. Silvestro e S. Silvestro, Da Ancona a Napoli, via Grottammare, con Raffaele Pontremoli, pittore di
battaglie. E qualcos’altro ancora, Tipografia Alda, Grottammare, 1991.
- R. Colapietra, Per la biografia di Salvatore Tommasi, Deputazione Abruzzese di Storia Patria, «Studi e
Testi», n. 28, Tip. Colacchi, L’Aquila, 2004.
- E. Mattiocco (a cura), Dal Tronto al Sangro. Una settimana in Abruzzo con Vittorio Emanuele II (ottobre
1860), Deputazione Abruzzese di Storia Patria - Università Sulmonese della Libera Età, Edizioni Libreria
Colacchi, L’Aquila, 2011.
- W. Capezzali (a cura di), «… Garibaldi rappresenta l’azione, come Vittorio Emmanuele l’idea …». Le
vicende del compiersi dell’Unità nazionale nelle pagine del giornale dei liberali. In occasione della riproduzione del bisettimanale La Guida. Giornale del Popolo edito dalla tipografia Aternina, L’Aquila 18601862, Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, 2011. Si segnalano ivi, in particolare, alle pp. 13-28 il saggio di Paolo Muzi, I democratici abruzzesi nella rivoluzione nazionale, e alle pp.
29-38 il saggio di Roberto Simari, Salvatore Tommasi, il patriota del 1860 (riedizione di un testo del 1962),
entrambi ricchi di indicazioni sulle fonti primarie.
Nell’associarmi ai complimenti per gli organizzatori di questa importante iniziativa, proporrei di tornare al primo dei due documenti iconografici appena visti, poiché
ci sono anche due figure femminili: se in Abruzzo le donne non hanno votato, nelle
Marche è accaduto l’esatto contrario. Nel collegio di Recanati, la patria di Giacomo
Leopardi, si presentò a votare per il plebiscito del 4-5 novembre del 1860 la poetessa
Maria Linda Bonacci, di origine umbre, che poi avrebbe rievocato questo suo momento davvero epocale nei propri scritti: la Bonacci, eccezionalmente ammessa al
seggio, votò per il sì e lo fece pochi minuti dopo che in cabina si era presentato Carlo
Leopardi, fratello di Giacomo, che esternò ai presenti una visibile scheda in favore
del no; ciò, peraltro, non precluderà al fratello di Giacomo Leopardi di diventare un
fedele impiegato del Regno d’Italia.
Il fatto che le le donne abbiano avuto nel corso di un momento così significativo
del processo risorgimentale un ruolo di una certa rilevanza è uno degli aspetti che
sono stati ricordati da ricerche e saggi che sono stati posti in essere nell’ultimo biennio. Parte di questo merito va al Comitato d’Ancona dell’Istituto per la storia del
Risorgimento, presieduto dal professor Gilberto Piccinini, che ha creduto in un mio
progetto di ricostruzione storica capace di aggiornare le vecchie cose scritte - anche
cento anni fa - sul processo di unificazione nazionale; ma non minor merito va agli
oltre venti studiosi che hanno accettato di indagare e ricostruire i temi più diversificati connessi al passaggio dei regimi sul finire del 1860: gli esiti di questo processo
di ricerca storica sono scaturiti in un volume che ha conosciuto quattro distinte edizioni tra 2010 e 2011.
Ho sentito delle relazioni molto significative, molto autorevoli, ho sentito tanti
dati. Ne vorrei aggiungere uno: nel 1863 viene compiuta una rilevazione del Regno
d’Italia secondo cui le Marche sono la seconda regione d’Italia, subito dopo la
Liguria, che ha una scuola per ognuno dei suoi Comuni. Ci potremmo chiedere che
cosa era successo, visto che il processo di unificazione nazionale si era concluso da
appena tre anni e soprattutto che le Marche erano state per secoli una periferia di
stretta osservanza papalina. Ho sentito evocare a lungo un anno particolare del processo risorgimentale, il 1848: il professor Teodori sa benissimo che io appartengo
alla schiera di coloro che preferiscono sottolineare il 1849, per un motivo semplicissimo, perché il napoleonide che diede il via libera ai piemontesi per la campagna
militare dell’autunno del 1860 era lo stesso che undici anni prima aveva schiacciato
la libertà della Repubblica romana, che era invece nata attraverso il suffragio universale dei cittadini dell’ex Stato pontificio e, saggiamente guidata da Giuseppe Mazzini,
si era posta come uno Stato legittimo, libero, laico, democratico e repubblicano, lanciando all’Europa monarchica e conservatrice la sfida di riprendere e completare,
sotto l’egida dei democratici, il processo di indipendenza nazionale. Numerose sono
le eredità della Repubblica romana, a cominciare dalla più citata, la Costituzione promulgata il 3 luglio del 1849, lo stesso giorno dell’ingresso dei francesi del generale
33
Oudinot de Reggio, colui che era convinto che gli italiani non si sarebbero battuti e
che aveva visto le proprie truppe farsi inseguire per diversi chilometri dal deputato
dell’Assemblea Costituente eletto nel collegio di Macerata, un certo Giuseppe
Garibaldi.
Senza fare troppi riferimenti, senza fare troppe analogie, cercherò di sintetizzarvi
in breve quelli che sono i risultati di questa stagione storiografica che si è compiuta
da poche settimane, perché le opere che si sono avvicendate, con un taglio innovativo
e originale, consentono a chi vi parla di proporre un quadro di massima; in realtà
questi volumi sono particolarmente densi, bisognerebbe leggerli e metterli a disposizione per dare luogo a un più articolato bilancio storiografico.
34
Il processo di unificazione nazionale passa per le Marche come combinazione di
quattro elementi sostanzialmente differenti. Il primo è già stato ampiamente citato ed
è la campagna militare piemontese che nelle Marche durò appena 18 giorni: ebbe
inizio l’11 settembre 1860 con il IV corpo d’armata piemontese che, alla guida del
generale Enrico Cialdini, valicò il fiume Tavollo, un torrente che nasce sui monti romagnoli, scorre per una decina di chilometri in territorio marchigiano per poi sfociare
tra Cattolica e Gabicce; allora come oggi veniva considerato una sorta di confine tra
il Pesarese e la Romagna. La campagna sabauda durò appena diciotto giorni, poiché
il 29 settembre Ancona, dove si era asserragliato il generale Lamoricière, comandante papalino, venne conquistata; l’esito scontato trova una più che valida motivazione
nello squilibrato rapporto di forze: 33.000 piemontesi, ben armati e di esperienza internazionale, contro circa 12.000 papalini. Tra l’altro i piemontesi sono un esercito
collaudato e ben equipaggiato, che ha avuto nella guerra di Crimea la sua ultima
esperienza internazionale, mentre i papalini sono un esercito mercenario e raccogliticcio, uniti dalla fedeltà alla Chiesa e a Pio IX che, però, nella circostanza, non riescono a sortire miracoli. La battaglia di Castelfidardo fu poco più che uno scontro
campestre in quanto durò neanche tre ore: iniziò alle 9 della mattina, con l’attacco
delle avanguardie di Cialdini, tutto intento a fare colazione con il suo stato maggiore,
e si concluse a mezzogiorno, lasciando sul campo 154 morti (88 pontifici e 66 piemontesi). Se pensiamo che sui campi lombardi della Seconda Guerra d’Indipendenza,
appena l’anno prima, erano decedute decine di migliaia di soldati, questi 154 morti
offrono la reale dimensione militare di questo scontro. Questo però non vuol dire che
la battaglia di Castelfidardo non abbia avuto un grande significato sul piano politico
e su quello simbolico. Aprì ai Piemontesi, come è noto, la strada verso il Sud e soprattutto fu l’unica campagna militare che i Savoia condussero vittoriosamente da soli;
non ci furono i francesi del 1859, né i prussiani di Bismarck del 1866 a tenere alte le
sorti di casa Savoia e della dinastia che dal 17 marzo 1861 diventò italiana.
Quindi il primo elemento è, appunto, questa campagna lampo che terminò con la
resa di Ancona. Passati i militari giunse, e questo forse è uno degli elementi più interessanti su cui la storiografia ha di recente insistito, l’amministrazione civile. Cavour
scelse un suo avversario politico, un liberale di sinistra, un parlamentare subalpino fin
dalla prima legislatura, un uomo dal percorso di vita e umano professionale assolutamente singolare. Sto parlando di Lorenzo Valerio, già governatore di Como, che ricevette l’incarico di Commissario straordinario generale per le province delle Marche.
Quale incarico venne offerto a Valerio? Un incarico di tutta importanza, poiché Valerio
fu chiamato a trasformare quella che era una delle periferie in cui era più forte il sentimento papalino in un insieme di province sabaude. Valerio ebbe poco tempo, dato
che si insediò il 17 settembre 1860 e se ne ripartì per Como il 19 gennaio 1861, ma in
questi quattro mesi di commissariato emanò qualcosa come 840 tra atti e decreti che,
potendo contare su dei poteri semi-dittatoriali, estesero alle Marche le leggi e gli istituti piemontesi; si trattò di un’opera di innovazione davvero radicale. Non c’è solamente l’estensione della legge Casati o della legge Rattazzi, ma un autentico cambiamento di cultura e di civiltà. Tra l’altro Valerio fondò, nell’ottobre 1860, un nuovo
giornale, che sarebbe stata la voce più autorevole del liberalismo marchigiano fino al
primo dopoguerra, il «Corriere delle Marche», alla cui direzione chiamò il poeta-patriota di Ripatransone Luigi Mercantini, che oggi è il più diffuso foglio marchigiano
con il nome di «Corriere Adriatico». Una volta licenziato dalle Marche, Valerio scrisse una relazione sull’incarico commissariale al ministro dell’Interno Marco Minghetti,
in cui ad un certo punto affermò di aver cercato di spiegare ai marchigiani che la libertà equivaleva sia al rispetto della legge, sia alla tutela della proprietà. Infatti uno
dei libri che si sono occupati in questi ultimi mesi di questo frangente si intitola non
casualmente Libertà e Proprietà. La libertà era quella del nuovo ordine, del moderno
regime liberale che i piemontesi introdussero, la proprietà era la garanzia offerta a chi
aveva le chiavi socio-economiche di questo territorio.
Con questo andiamo al terzo elemento, il plebiscito del 4-5 novembre 1860. Qui
si è parlato di suffragio universale maschile; bisogna forse sottolineare la contraddizione in virtù della quale le elezioni successive, quelle che portarono alla nascita del
primo Parlamento italiano, si tennero invece con un sistema censitario; la prima
comparsa del suffragio universale maschile in Italia era stata proprio alla vigilia della
Repubblica romana con l’elezione, nel gennaio 1849, dell’Assemblea Costituente e
queste elezioni nelle Marche avevano già smosso dei costumi sedimentati perché
andare al voto voleva dire acquisire un preciso diritto politico. Qui il gesto recanatese, che ho ricordato poco fa di questa poetessa di origini umbre, non sarebbe stato
senza seguito, perché le prime elettrici della storia italiana sono state, in virtù della
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Ancona, presieduta da un giurista del calibro
di Lodovico Mortara il 25 luglio 1906, dieci maestre marchigiane; si dovette attendere sei mesi prima che la Corte di Cassazione cassasse quel diritto femminile al voto
che avrebbe conosciuto definitiva sanzione nella penisola quaranta anni dopo. In sostanza, c’è tutto un particolare viatico della presenza femminile nel Risorgimento
marchigiano che va inquadrato, studiato e approfondito per capire come mai ogni
tanto emergano come un fiume carsico questi importanti casi di presenza femminile.
Torniamo al plebiscito. I marchigiani furono chiamati a solennizzare la carta d’identità della costituenda nazione italiana e intervennero in maniera concreta, dato che
quasi il 64% di essi andò a votare, di cui il 99% si espresse per il sì. Sapete benissimo,
si trattava di una sorta di referendum, bisognava dire sì o no all’adesione alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II: c’erano da tenere in debita considerazione le scomuniche papali e la forte pressione che i sacerdoti avrebbero svolto in senso
contrario all’annessione. Numerosi religiosi nella nostra regione, infatti, si rifiutarono
di consegnare gli Stati delle Anime che erano naturalmente l’elemento fondamentale
in un regime pre-anagrafico per compilare le liste elettorali. Anche qui accade che
molte donne non solo si presentano alle urne ma compilano, guidate dalle nobildonne
35
36
delle principali città marchigiane (Pesaro, Ancona, Fermo, Senigallia, Jesi, ma anche
in località più piccole), manifesti e appelli poi inviati a Vittorio Emanuele II, atti
peraltro ai quali il sovrano sabaudo non rispose. Resta il fatto che in tali appelli le
centinaia di donne marchigiane scrissero espressioni di questo tenore: «Non ci avete
chiamato al voto ma se lo aveste fatto avremmo votato in favore dell’annessione». Le
autorità piemontesi, a cominciare dal commissario straordinario Lorenzo Valerio,
coadiuvato da tutti gli altri commissari provinciali, fecero di tutto per agevolare il
concorso delle donne, dei giovani e di tutta una serie di categorie che non aveva diritto al voto. Liberali e democratici si recarono a votare e molti di coloro che nel 1860
si trovarono in prima linea, quel ceto di notabili pronto ad assumere con il consenso
di Torino il governo politico-amministrativo delle Marche, erano stati protagonisti nel
1849 della Repubblica romana. Erano transitati, come la stragrande maggioranza
degli italiani, dagli ideali mazziniani, repubblicani e democratici verso quelli liberal-moderati e cavouriani.
Ecco però un elemento a lungo sottaciuto, almeno per quanto riguarda la regione,
l’importanza del plebiscito sulla strada della civilizzazione, della nazionalizzazione,
una strada che nelle Marche, unica regione tutt’ora declinata al plurale nella penisola,
si sarebbe rivelata decisamente accidentata, contorta, complicata: il processo di regionalizzazione, avviato agli inizi dell’età contemporanea durante il periodo franco-napoleonico, sarebbe durato lungo tutto il Novecento e ancora oggi molti si chiedono se
questo processo di regionalizzazione sia effettivamente compiuto e concluso. Resta il
fatto che al commissario Valerio non sfuggì né l’importanza storica dell’atto costitutivo di un insieme di province che stava per essere annesso al Regno sabaudo in
procinto di diventare Regno d’Italia, né le implicazioni sul piano delle riforme che
con la sua amministrazione civile venivano poste in essere. Valerio comprese che sei
province per una sorta di regione erano troppe e non ebbe titubanze nell’applicare una
nuova ripartizione territoriale che, decisa dal governo di Torino, abolì le province di
Fermo e di Camerino. Le due città la presero malissimo: a Fermo si verificarono dei
tumulti alla vigilia di Natale del 1860 e nei mesi successivi furono redatte delle proteste ufficiali che raggiunsero gli uffici parlamentari e governativi, ma non trovarono,
in pratica, alcun seguito.
Alla luce della recente istituzione della provincia di Fermo, si può dire che questa
protesta è durata un secolo e mezzo; una protesta a suo modo significativa della scelta di fondo che prese il Commissario generale, Lorenzo Valerio, quella di governare
da solo senza corresponsabilizzare il ceto patriottico marchigiano, che pure vantava un
consistente curriculum organizzativo e anche una certa tradizione patriottica. Per quale motivo? Perché le Marche sono arrivate al processo di unificazione nazionale in
maniera stanca, come un insieme di province povere, indebitate, con una struttura
socio-economica tutta imperniata sul regime mezzadrile che già mostrava diverse
crepe. Soprattutto il liberalismo e il patriottismo marchigiano erano una cosa completamente diversa a Pesaro e ad Ancona, ad Ascoli Piceno e a Fermo, a Senigallia e a
Macerata, insomma il municipalismo era il vero e proprio target di queste periferie.
Valerio adottò una scelta di caratura essenzialmente politica: non responsabilizzò
della propria azione questo gruppo patriottico per un motivo semplicissimo. Nel
1859, è stato ricordato poco fa, quell’insurrezione che era riuscita in Toscana e in
Emilia Romagna, era fallita nelle Marche e in Umbria. Certo alcuni storici hanno
detto: in Toscana c’era Ricasoli, in Emilia c’era Farini e in Romagna c’era Marco
Minghetti. Da queste parti, invece, si poteva contare su Giacomo Ricci Petrocchini o
sui già citati Speranza e Laureati: una serie di persone che avevano in molti casi sofferto l’esilio dopo il biennio 1848-1849, avevano cercato di correlarsi con i due
centri di raccolta degli esuli di Bologna e Firenze, poi anche Torino, ma non vantavano credenziali rilevanti su cui scommettere nell’immediato. Tuttavia, quando questo
ceto di notabili, costituito per lo più da proprietari terrieri, si rese conto di venire
destabilizzato da Valerio, fece una scommessa precisa: non intralciare l’operato del
funzionario sabaudo in attesa della sua partenza, allorché sarebbe subentrato come
nuova classe dirigente. Furono infatti loro a governare questa regione per sessanta
anni fino all’avvento del fascismo, riuscendo a fronteggiare i modesti fenomeni di
destabilizzazione di una realtà che avrebbe accolto anarchici, repubblicani, sovversivi di diversa matrice. Questo notabilato liberale, diviso e sfilacciato nel 1860-61,
avrebbe poi dato prova di un certo cemento e di una concreta organizzazione politica
e ideologica, attraverso un patrimonio di ideali (fedeltà alla monarchia, liberalismo,
antitemporalismo, tutela della laicità e delle libertà civili, etc.).
Manca il quarto elemento, con cui concludo: le libere elezioni che si svolsero
nelle Marche tra il gennaio e il marzo 1861; liberi comuni, libere province, i rappresentanti al Parlamento nazionale.
Il 18 febbraio scorso mi trovavo a Forlì ospite del Sindaco Roberto Balzani, noto
contemporaneista dell’Università di Bologna; era un venerdì sera e la sala della
Camera di Commercio in Piazza Saffi si presentava stipata all’inverosimile, poiché
per loro è il 18 febbraio 1861 - quando a Torino si riunì in prima seduta il neocostituito Parlamento - l’atto di nascita dello Stato italiano e non il successivo 17 marzo,
che ha segnato la promulgazione della legge che ha conferito a Vittorio Emanuele II
e ai suoi discendenti il titolo di Re d’Italia. Qui si origina un lungo e frastagliato
percorso delle Marche verso la civilizzazione e la nazionalizzazione che si incentra
su un elemento, quello dell’educazione. Lo aveva detto, lo aveva scritto nelle stesse
settimane in cui Valerio operava nelle Marche, Giuseppe Mazzini nei Doveri dell’Uomo: «senza educazione non distinguerete giustamente il bene dal male». Vi ringrazio.
Riferimenti bibliografici
- N. Sbano (a cura di), Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana, Il
Mulino, Bologna, 2004.
- M. Severini (a cura di), Macerata e l’Unità d’Italia, Codex, Milano, 2010.
- Id. (a cura di), Le Marche e l’Unità d’Italia, Codex, Milano, 2010.
- Id., La Repubblica romana del 1849, Marsilio, Venezia, 2011.
- Id., Piccolo, profondo Risorgimento, Liberilibri, Macerata, 2011.
- Id. (a cura di), Memoria, memorie. 150 anni di storia nelle Marche, Il lavoro editoriale, Ancona, 2012.
- M. Guzzini, Passato quotidiano. Storia e storie del «Corriere Adriatico» dal 1860 al 1914, Liberilibri,
Macerata, 2011.
37
Già quando nel 1911 si tennero le solenni celebrazioni che Grottammare volle
dedicare al cinquantenario dell’Unità d’Italia e al memorabile incontro del Re sabaudo con la Deputazione napoletana che ne fu importante prodromo, tante ed interessanti furono le notizie e persino le testimonianze dirette che permisero di delineare
nei particolari lo storico episodio. Erano infatti ancora in vita alcuni protagonisti di
quei giorni lontani e non pochi furono quelli che ne avevano avuto in famiglia il
racconto vissuto, come lo stesso on. Alceo Speranza dal proprio genitore l’illustre
avvocato e storico Giuseppe. Si passava così dalla cronaca alla storia e si trasformava
un evento esaltante per il piccolo centro marchigiano in un tassello fondamentale per
la nascita di una nuova Italia unita sotto lo scettro dei Savoia.
In anni più recenti studi egregi hanno voluto approfondire con puntuale attenzione aspetti particolari e collaterali dell’evento, accrescendone lo spessore e consegnandolo definitivamente alla storia. Mi riferisco in particolare ai contributi di Alberto
Silvestro che in alcune interessanti pubblicazioni[1] ben riassumeva lo stato della
questione elencando accuratamente fonti e bibliografia precedente. Cos’altro aggiungere dunque? Qualcosa si può. Intanto è ora possibile disporre di nuovi documenti
reperiti presso l’Archivio Storico comunale di Grottammare e presso l’Archivio di
Stato di Torino che consentono di aggiungere utili tasselli di conoscenza alla ricostruzione storica della vicenda; in secondo luogo una ampliata lettura delle fonti e della
bibliografia contribuisce ad accrescere quanto finora sapevamo sugli eventi grottammaresi dell’11-15 ottobre 1860. Come sempre, però, se quando dalla cronaca si passa
alla storia si consolidano presunte certezze, quando dalla storia ci si riaffaccia alle
cronache e ai documenti contemporanei gli interrogativi si ripropongono e ne sorgono
di nuovi. Converrà dunque rivedere insieme lo storico episodio sabaudo-partenopeogrottammarese alla luce di qualche nuovo spunto ed esaminarlo con ordine per cercare di rispondere ai fondamentali interrogativi del chi, dove, quando e perché, anche
se non esattamente in questo ordine.
Cominciamo dunque dal dove. Forse non in tanti, parlando dell’incontro dell’ottobre 1860, si sono chiesti «perché Grottammare?». Perché Grottammare e non San
Benedetto del Tronto o Cupra, o Marano che dir si voglia? Perché non Fermo,
Civitanova o addirittura Loreto dove pure il Re si era devotamente fermato? Sappiamo
[1] Da Ancona a Napoli via Grottammare, con Raffaele Pontremoli pittore di battaglie. E qualcos’altro
ancora, Grottammare, 1991; Un episodio da non dimenticare. La Deputazione partenopea incontra a
Grottammare Vittorio Emanuele II, in Riviera delle Palme, luglio-ottobre 1999, pp. 6-8; Grottammare e
l’Unità d’Italia in Grottammare. Di storia in storia, Roma, 2011, pp. 313-319.
39
40
che la Deputazione napoletana, dopo un lungo e avventuroso viaggio
compiuto parte via mare per evitare
passaggi inopportuni in territori ancora saldamente pontifici o in quelli
ormai precariamente borbonici,
avrebbe dovuto essere ricevuta dal
Re in Ancona ma così non fu. Gli
eventi rischiavano di precipitare,
Cavour premeva in tutti i modi perché il “segnale” di adesione dei napoletani arrivasse forte e chiaro il
prima possibile onde evitare che
Garibaldi e i suoi potessero farsi
venire “strane” idee e, ascoltando
gli appelli e i richiami di Mazzini
prontamente arrivato a Napoli, decidessero di non consegnare a Vittorio
Emanuele i territori conquistati ma Lo storico e patriota Avv. Giuseppe Speranza
di instaurarvi invece la repubblica.
Molti, anche tra i più vicini a Garibaldi, premevano infatti in tal senso e Cavour,
grazie alla sua fitta rete di informatori, lo sapeva bene. In realtà avrebbe dovuto avere maggiore fiducia nella lealtà del Generale, che più volte si rifiuterà di ascoltare
quelli tra i suoi che gli suggeriscono di consolidare in forma repubblicana la sua dittatura. Garibaldi non lo farà, rifiuterà in ogni modo il rischio di accendere una nuova
guerra che veda gli italiani nemici tra loro, una vera e propria guerra civile. Ancora
sotto le mura di Capua o a Caserta, pronto a muovere incontro a quel Re che non era
neanche più il suo, avendo ceduto Nizza alla Francia, rifiuterà fermamente questa
ipotesi. Cavour però non si fidava; troppo diverso e spregiudicato era il suo agire che,
pur di conseguire lo scopo di unificare l’Italia sotto lo scettro sabaudo, non aveva
esitato ad usare qualsiasi mezzo e senza cedere ad “inutili” scrupoli di coscienza.
Dunque, secondo quanto previsto, il gruppo dei notabili partenopei, partito dal
porto di Napoli e arrivato via mare a Livorno, aveva attraversato la penisola, passando dopo una sosta a Firenze la dorsale appenninica e facendo tappa a Bologna per poi
arrivare finalmente ad Ancona. Qui, però, erano stati prevenuti che non avrebbero incontrato sua Maestà, già in movimento verso il confine del Tronto: il Re li avrebbe
infatti ricevuti a Grottammare e dunque bisognava rimettersi in viaggio per rincorrere
il sovrano e consegnargli finalmente l’auspicio di annessione dei napoletani, che di lì
a poco sarebbe stato plebiscitariamente sancito.
Che la tappa di Grottammare fosse stata fissata piuttosto all’improvviso e forse
con qualche casualità è stato ipotizzato ma non risponde al vero. Presso l’Archivio di
Stato di Torino esiste infatti più di un documento che attesta quali fossero le tappe
prefissate per il trasferimento del Re e del suo seguito, luoghi che, individuati con
precisione, distinguono le soste di semplice pernottamento da quelle di più lungo
soggiorno. Se infatti in una lettera del generale Morozzo della Rocca, spedita l’8 di
ottobre da Ancona, si legge: «S.M. parte domattina per Macerata ed il 10 sera avrà il
suo quartier generale a Civita Nuova. Il giorno 11 a Grottamare», senza ulteriori precisazioni, nell’elenco predisposto per l’organizzazione della trasferta sono indicate
tutte le varie tappe distinguendo tra quelle di solo pernottamento come «Porto di
Civitanova» o di passaggio come «Porto di Fermo» e quelle di più lunga permanenza
come la successiva «Grottammare» indicata appunto come «soggiorno»; l’ultimo del
Re in terra marchigiana. Ecco dunque che dopo il passaggio il 10 a Loreto, dove Sua
Maestà visita il Santuario e pranza con il Vescovo, cui dona un calice d’oro per la
Vergine e 50.000 franchi, accettati assai di buon grado, ci si dirigerà a Civitanova per
trascorrervi la notte. La mattina dell’11 si parte alle 7 antimeridiane per arrivare,
dopo una sosta al Porto di Fermo, finalmente a Grottammare. Sono circa le due e un
quarto del pomeriggio, quando Vittorio Emanuele e il suo seguito fanno il loro ingresso nella «piccola città ingombra di truppe», accolti cordialmente dalla «popolazione
vivace», come appunta nei suoi Ricordi[2] Michelangelo Castelli, aiutante di campo
del Re. Qui, è sempre Castelli che ce lo conferma, arriverà il giorno seguente anche
Cialdini ma ripartirà subito per Giulianova, dove dovrà organizzare il successivo
soggiorno che prevede il ricevimento di varie deputazioni tra l’entusiasmo più o meno spontaneo della popolazione. In effetti Cialdini era stato designato alla campagna
attiva nell’ex territorio borbonico deludendo le speranze del Generale Enrico della
Rocca, Comandante del 5° Corpo d’Armata, al quale viene esplicitamente rimproverato di non essere sufficientemente «spregiudicato» per combattere nel Napoletano
una «guerra semi-rivoluzionaria», come racconterà lui stesso nella sua Autobiografia
di un veterano.[3] Vedremo infatti dal ’61 con quanta spietata fermezza, quasi ferocia,
[2] L. Chiala, Ricordi di Michelangelo Castelli, Torino-Napoli, 1888, p. 328.
[3] Bologna, 1898, p. 66.
Ritratto di Vittorio Emanuele II tra due vedute simbolo dell’Italia unita
41
42
Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana Contessa di Mirafiori, sposata morganaticamente dal Re nel 1869
Cialdini si dedicherà alla repressione del brigantaggio nelle nuove province meridionali, un fenomeno di cui non può essere ignorata la sia pur minoritaria componente
legittimista.
Per tornare al nostro argomento, è in ogni caso chiaro che non poteva essere
minimamente lasciata all’improvvisazione tutta la complessa organizzazione dell’accoglienza non solo del Re e dei ministri, ma anche degli alti funzionari del suo seguito e di tutti quelli che con vari compiti e funzioni lo accompagnavano. C’era inoltre
da pensare ad una adeguata sistemazione per la compagna del sovrano, quella Bella
Rosina che da anni era al suo fianco in modo se non ufficiale, assolutamente palese e
consolidato e che aveva voluto seguirlo nella campagna delle Marche e poi fino a
Napoli. Non potendo formalmente la coppia alloggiare sotto lo stesso tetto, infatti, i
funzionari che avevano il compito di organizzare i trasferimenti di Vittorio Emanuele
dovevano anche reperire una idonea sistemazione per la sua compagna e tutto questo
non poteva certo essere improvvisato. Se poi non si trovavano consone occasioni
ospitali o se il Re voleva un po’ di libertà per i suoi svaghi e le sue avventure galanti
(anche in questo campo era un appassionato cacciatore), la Rosina veniva inoltrata
direttamente alla tappa successiva, cosa che - ma lo leggerete nel testo del professor
Piccinini - accadde forse anche a Grottammare. Non si immagini poi che risolto il
problema degli alloggi, una volta sistemato il Re con la Rosina e tutto il loro numeroso seguito, fosse finita lì, no di certo: il sovrano arrivava infatti alla testa di un
Corpo d’Armata di oltre 27.000 uomini da mettere al coperto e sfamare, senza contare i cavalli e i prigionieri nemici che pure di un minimo di ristoro avevano bisogno.
Come se non bastasse, tra i militari dei due eserciti si contavano ancora numerosi
feriti, reduci da Castelfidardo e da altri fatti d’armi, ed anche a questi si doveva pensare. Così se Grottammare si era poco prima dovuta far carico dei 500 pontifici catturati dai Cacciatori del Tronto il 19 settembre e che sono ivi, scrive Fanti a Cavour
in un dispaccio del 21 settembre, «custoditi dalla Guardia Civica, ma riottosi», adesso ci sono anche quasi 200 feriti e malati da ricoverare nel locale ospedale, curare,
nutrire, assistere. Dunque, altro che improvvisazione! Se si vuole avere un’idea di ciò
che significò per Grottammare l’arrivo del Re, si consideri che. contando all’epoca il
paese - compreso il contado - poco più di 3600 anime, fatte le debite proporzioni, è
come se oggi ne arrivassero all’incirca 125.000, tutte insieme, da sistemare, sfamare,
dotare di quanto indispensabile e di prima necessità, in primis viveri, legna per il
fuoco, paglia per giacigli e cavalli e un qualche riparo, poiché, come se non bastasse,
l’entrata di questa massa di gente venne a coincidere con lo scoppio di un violentissimo temporale. Grottammare, però, riuscì a far fronte a tutto e il soggiorno, sia nella
parte ufficiale sia in quella privata, dovette essere a tal punto gradito al sovrano che,
dopo aver lasciato il paese, così dispone dandone informazione il 16 ottobre da
Giulianova, tramite il Ministro Farini, «all’Onorevole Municipio di Grottammare.
Sua Maestà, volendo dare un’attestato della Sua sovrana soddisfazione per la prova
di devozione datagli da codesto Municipio e Cittadinanza, nonché per l’affetto che
dessi votavano alla causa nazionale, mi ha affidato il gradito incarico di partecipare,
aver Ella determinato, che a favore di codesto Comune sia pagata la somma di
Italiane L.10/m dieci mila da erogarsi per la prosecuzione, e compimento dei lavori
occorrenti per la nuova Chiesa della qual somma la metà sarà sborsata al ripigliarsi
dei lavori, l’altra metà entro l’anno». Un altro notevole dono sarà inviato, come si
43
dirà, alla chiesa di San Giovanni Battista, dove il Re aveva partecipato il 14 alla messa domenicale, né mancheranno inoltre, anche successivamente, i riconoscimenti e gli
attestati di benevolenza, come nel caso del permesso accordato al conte Carlo Fenili,
che aveva ospitato nella sua dimora lo Stato Maggiore del Re, di «inalberare il Reale
Stemma» sia sulla sua residenza (edificio tuttora esistente ma purtroppo molto alterato da successivi interventi) sia sullo stabilimento serico di sua proprietà. Non sappiamo se analoga richiesta fosse stata avanzata dal Marchese Laureati ma si ha motivo
di dubitarne se è vero, come è vero, che quando si era pensato di requisirne l’abita-
44
Minuta della concessione al Conte Fenili di inalberare lo Stemma Reale (Archivio di Stato di Torino)
zione per destinarla al soggiorno di
Sua Maestà, egli aveva orgogliosamente affermato non essercene alcun
bisogno: l’avrebbe messa lui stesso e
ben volentieri a disposizione del Re,
senza null’altro desiderare se non
l’onore di accoglierlo. Certamente un
attestato di apprezzamento il marchese dal Re dovette riceverlo e con tutta
probabilità si trattò di una onorificenza o insegna, dato che nel lasciare
Ancona lo stesso sovrano aveva voluto insignire dell’Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro il proprietario Croce dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
della villa in cui aveva risieduto. Si
racconta anzi che, poiché si era al momento sprovvisti della croce mauriziana né si
riuscì a trovarne una in città, il Re pensò che il Finali, allora Segretario del
Commissario regio, l’avesse e gliela fece chiedere dal Farini. Qualche tempo dopo,
rivedendo il Finali a Napoli in occasione della presentazione del plebiscito, il Re si
ricorderà del fatto della croce e, rinnovandogli il suo ringraziamento, dirà al Farini
con fare faceto: «Ora di croci ne abbiamo una cassa: faccia la restituzione a Finali!»[4]
Per tornare a Grottammare e alle straordinarie capacità di accoglienza di cui diede
prova, credo di aver, almeno in parte, anche chiarito il perché di una scelta che privilegiava un centro apparentemente minore o per lo meno non più importante di altri
vicini. San Benedetto, ad esempio, che già nel ’49 aveva in casa Neroni accolto
Garibaldi, non era forse ancora più prossimo al confine? Sì, ma forse troppo. Una
giusta distanza era consigliabile piuttosto che attendere così, quasi sulla soglia, il
momento opportuno per varcare l’antico limite, anzi u jemete, per dirlo in dialetto. E
attendere il voto dei napoletani prima di compiere il fatidico passo era necessario
anche perché a parte tutto il Re, a differenza di Cavour, qualche scrupolo nei confronti di Garibaldi se lo poneva. Se nel carteggio cavouriano di quei giorni appare ben
chiaro che Garibaldi è considerato, nella migliore delle ipotesi, un ingenuo pericoloso
per eccesso di buona fede - «l’ingenuo Dittatore» scrive il 25 settembre da Napoli il
cav. Leopardi - , non mancano nei suoi confronti espressioni ben più pesanti quali
«quello stupido di Garibaldi» o addirittura «l’Animale eroico» (lettera di Emanuele
Pes di Villamarina da Napoli del 26 settembre 1860) che, pur riferite alla comune
opinione dei napoletani, fanno comprendere come il Generale fosse ormai considerato dai vertici del Governo solo un intralcio da rimuovere il prima possibile. Il Re, però,
non se la sente di congedare tout-court chi ha permesso di annettere alla sua corona
territori che mai l’Europa gli avrebbe consentito di invadere e conquistare e per tacitare i suoi scrupoli - come si è detto, a differenza di Cavour lui qualcuno ne aveva avrebbe preferito che il Generale gli avesse manifestato in qualche modo il proprio
[4] G. Massari, Vita e regno di Vittorio Emanuele II di Savoia primo Re d’Italia, Milano, 1897, vol. II, pp.
350-351; S. Ghiron, Aneddoti della vita di Vittorio Emanuele …, Roma, 1903, p. 49.
45
46
assenso al disegno di annessione. In fondo gli si doveva gratitudine ed un minimo di
sia pur formale rispetto, perché quello che l’esercito sardo non avrebbe mai potuto
impunemente fare di fronte all’Europa - varcare i confini di uno Stato indipendente,
invaderlo in armi e deporne il legittimo sovrano - l’armata irregolare dei garibaldini,
poco più di mille uomini con la camicia rossa quale unica divisa, l’aveva fatto ed ora
gli consegnava un regno senza colpo ferire. Del resto, quando nel 1860 il Generale si
preparava all’impresa, Vittorio Emanuele aveva scritto al ministro Farini «Caro
Farini, faccia tutto quello che si può per contentare il Generale», ma lui per sé nulla
aveva chiesto e ora, a Caianello, prima di ritirarsi a Caprera tutto gli avrebbe consegnato con poche semplici parole: «Salute a voi, Re d’Italia». Vittorio, corrisponderà
solo con una dichiarazione di amicizia: «Salute a voi, il migliore de’ miei amici». Più
di quello e, successivamente, di un seggio al Senato non gli sarebbe stato accordato.
Eppure quanto sangue garibaldino era costata quell’impresa! Presto su ciò che avvenne da Quarto al Volturno si costruirà un mito ufficiale in cui non troveranno posto le
scomode verità, le umiliazioni subìte dal Generale e dai suoi, discriminati e messi da
parte dopo che lui aveva invece, come unica richiesta, domandato che fosse loro riconosciuto nell’esercito del Regno d’Italia il ruolo e il grado con cui avevano combattuto perché quello divenisse una realtà politica e geografica. Sempre nell’Archivio
di Stato di Torino ho trovato in tal senso un documento estremamente eloquente: alla
famiglia del capitano garibaldino Alberto Leardi, caduto a Milazzo, che tramite il
sindaco di Tortona chiede l’atto autentico di morte del congiunto, il Ministero della
Guerra risponderà di non aver «ingerenza di sorta in quella armata». L’epopea retorica dell’Unità metterà insieme il Padre della Patria, il Tessitore, l’Eroe dei due mondi… ma quanto lontani e diversi! «Aveva dato un Regno e gli mancava il pane»
commenterà amaramente Alessandro Dumas.
Dunque, il Re si trattiene a Grottammare perché qui aspetta un atto, un segno di
accettazione da Garibaldi che possa almeno in parte scaricarlo dal senso di disagio
che avverte, segnale che arriva quando il Generale, che dichiara con fermezza di non
volere la Repubblica se questa deve costare il sangue di una lotta fratricida, promulga
il plebiscito. Ci riferisce Alberto Mario che era con lui in quei giorni fatali - e che nel
1862 narrerà l’impresa dei Mille nel suo testo-memoriale La Camicia Rossa - che
Garibaldi non volle spostarsi con i suoi uomini alla conquista di Roma, come Mazzini
ed altri lo incitavano a fare, perché questo avrebbe significato uno scontro con i piemontesi e «la guerra civile… no!», mai. Vale a questo proposito ricordare che il 14
dicembre del ’60 Cavour scriverà invece a Farini, a proposito di istanze autonomiste
che giungevano dai nuovi territori: «se esitiamo a fronte dei partiti siamo fottuti.
Meglio la guerra civile che una irreparabile catastrofe». Quanta distanza da Garibaldi
che rifiuta anche solo l’idea di una nuova guerra tra italiani e, pur convinto repubblicano, si pronuncia per il plebiscito dichiarando: «la mia repubblica consiste nella
volontà della maggioranza» aggiungendo poi: «Se vedete Mazzini, riferitegli la mia
risposta». Il plebiscito nei territori ex borbonici, dunque, quello che Cavour voleva e
per il cui risultato già da tempo lavorava, si farà; c’è l’assenso di Garibaldi, ciò che
serviva al Re per tacitare gli scrupoli residui della sua coscienza e volgersi verso
Caserta, certo del felice esito del viaggio. Dunque, ecco cosa aspettava Vittorio
Emanuele a Grottammare, vicino al confine ma non troppo, e molto soddisfatto e
sollevato lo dice chiaramente a Salvatore Tommasi, notabile abruzzese che già in
Ancona gli aveva recato quasi duecento adesioni di municipi dell’Abruzzo e del
Molise e che lo accompagna nel viaggio: «Sa che Garibaldi ha ceduto? Si promulgherà subito il plebiscito. Son proprio contento. Mi sarebbe dispiaciuto assai di dover
47
Ruggero Bonghi in tarda età (la margherita all’occhiello dello studioso e statista è un segno della sua devota
ammirazione per la prima Regina d’Italia)
andare contro quel gran patriota». Per capire meglio quello che stava accadendo a
Napoli, citiamo Raffaele De Cesare quando afferma, nel suo importante testo La fine
di un Regno[5] che quelli «furono giorni di grande sgomento ad un sol passo dall’anarchia». Accadrà perfino, quel 12 ottobre, che Mazzini, assediato a Napoli nella sua
[5] Città di Castello, 1909
48
Luigi Carlo Farini in una incisione litografica di C. Perrin del 1860
casa, fosse minacciato di morte; lo salveranno i garibaldini. Con l’assenso di
Garibaldi, però, tutto sembra aver preso la piega giusta, ora si può ripartire, lasciare
con armi e bagagli, è proprio il caso di dirlo, Grottammare dove il Re ha trascorso il
tempo ricevendo la Deputazione di Napoli, andando ripetutamente a caccia, dilettandosi con procaci figlie di padri compiacenti e recandosi, per debito di coscienza, ad
assistere alla messa domenicale nella chiesa di San Giovanni Battista nel vecchio
incasato, accolto con tutti gli onori dal pievano don Gaetano Desideri. Arrivato l’11
a Grottammare, il Re il 15 ne ripartiva avendo raggiunto lo scopo prefissato di ottenere la legittimazione al suo primo ingresso nel regno che aveva appena strappato a
Francesco II, lo sfortunato Franceschiello che era oltretutto suo stretto parente in
quanto figlio di una principessa sabauda: l’infelice e pia Cristina di Savoia, regina
delle Due Sicilie, morta giovanissima in odore di santità. Nel lasciare tra il generale
tripudio Grottammare, il Re non poté non pensare con soddisfazione alla bella accoglienza che gli era stata offerta dai notabili e dalla popolazione del luogo. La nobile
famiglia Laureati, per prima, che lo aveva degnamente ospitato nella sua bella dimora dove gli era stato possibile ricevere il gruppo dei napoletani guidato da Ruggero
Bonghi ed organizzato di concerto con Cavour.
L’ospitalità del marchese Marino Laureati fu certamente all’altezza di una circostanza tanto eccezionale, che veniva anche a riconoscere l’importanza di quella famiglia che da tempo rivestiva ruoli di grande autorevolezza nel territorio di confine tra
lo Stato della Chiesa e il Regno duosiciliano, come attesta tra l’altro In chiave di
baritono, un breve romanzo quasi sconosciuto il cui autore è Antonio Ghislanzoni.
Questi, cantante e librettista noto per aver scritto per Giuseppe Verdi il libretto della
Aida, narra nel suo testo, vagamente autobiografico, di essere passato da Grottammare
nel fatidico anno 1849, dovendosi recare a Chieti per esibirsi nel locale teatro, e di
essere rimasto bloccato alla frontiera, essendo quella chiusa a causa dei rivolgimenti
politici in atto a Roma. Per risolvere la situazione il Ghislanzoni si indirizzerà proprio
all’influente marchese Marino Laureati che, in qualità di Vice Console del limitrofo
Regno, avrebbe dovuto mettere il visto al suo passaporto. Accogliendolo con garbo,
il marchese gli rappresenterà invece efficacemente le difficoltà del momento, invitandolo - con atteggiamento serio ma compassionevole - a desistere dall’idea di portarsi
in Abruzzo «essendo da due giorni rigorosamente vietato a quanti vengono dalla
Toscana e dagli Stati romani di entrare nel Regno di Napoli». Il Ghislanzoni a questo
punto «con una voce ed un’eloquenza che avrebbe commosso alle lagrime una cariatide» supplica il marchese di volersi adoperare in suo favore ed il Vice Console,
«uomo dabbene», indovinando come scrive l’autore «dal calore della mia eloquenza
la siccità del mio portamonete», gli consegnerà una lettera per il Commissario preposto alla guardia dei confini. «Presentatevi - gli dice - con questo foglio al
Commissario, e forse, stante la mia raccomandazione e la singolarità del caso, vi si
accorderà l’ingresso negli Stati di Sua Maestà umanissima». Purtroppo, invece,
quando l’indomani verrà fermato «cento passi da S. Benedetto» dalle guardie napoletane e condotto dal Commissario cui consegna la «lettera del signor marchese
Laureati suo ottimo amico e protettore…», il malcapitato si sentirà opporre un nuovo
rifiuto. Andare oltre «non è possibile» secondo il Commissario che, evidentemente
meno umano del suo umanissimo sovrano, crollando la testa e con linguaggio spiccio
e risoluto ribadisce: «gli ordini del Re sono precisi: nessuno ha da passare». Il
49
50
Ghislanzoni resterà così a Grottammare ancora un paio di settimane, per poi rientrare
avventurosamente a Roma. Avrà nel frattempo modo di consolarsi con la bellezza del
paese e l’aiuto della brava gente del luogo, ma Chieti dovrà rinunciare all’ascolto del
«baritono perfetto» che aveva scritturato.
Se dunque Ghislanzoni nel ’49 non poté attraversare il confine, nonostante i
buoni uffici del marchese Laureati, meglio andrà a Vittorio Emanuele II col quale
Cavour in una lettera del 10 ottobre 1860 così si esprime: «… Mi gode l’animo di
pensare che oggi o domani V.M. porrà il piede sul suolo napoletano. Passo magnanimo che supera in ardire il passaggio del Ticino nel 1848. Io mi lusingo che i faziosi
si dilegueranno come nebbia al sole». Questo scrive Cavour e allora ecco introdotto
uno degli interrogativi che avevamo finora lasciato da parte e, se si è cercato di dare
una risposta a quelli del dove e in qualche modo anche del perché, non meno importante è ora riflettere sul quando e sul chi.
«Oggi o domani», scrive Cavour, e sappiamo ormai quali fossero le ragioni
dell’incertezza, ma è del tutto assodato che il passaggio negli Abruzzi avvenne il 15
ottobre e che il Re, avendo dato udienza alle 6 del mattino a Fanti e a Farini, si era
alle 7 congedato da Grottammare e, dopo aver varcato il fatidico fluviale confine del
Tronto, era giunto intorno al mezzodì a Giulianova. Tutto chiaro, dunque: arrivato a
Grottammare l’11 nel primo pomeriggio, il Re era ripartito nelle prime ore del 15, ma
se prestiamo invece attenzione al giorno e all’ora indicati per l’incontro con i notabili napoletani, che particolarmente ci interessa, le cose si complicano un po’. La data
generalmente accettata, quella del 12 ottobre, ufficializzata anche nel dispaccio
dell’Agenzia Stefani del giorno seguente che dà notizia dell’evento, non risulterebbe
poter essere messa in discussione. Lo stesso 12 ottobre, infatti, Farini invia un dispaccio alle 3.15 del pomeriggio a Cavour per informarlo che «la Deputazione Napoletana
composta da 27 persone scelte fra i membri del Municipio di Napoli, i membri della
Magistratura e i cittadini notabili fu ricevuta da S.M. Il Re»; sempre il 12, poi, spedisce allo stesso Capo del Governo una più lunga e dettagliata lettera, in cui conferma
l’incontro conclusosi un paio di ore prima. Per inciso si osserva però che, poiché la
deputazione non giunse in modo compatto, se qualcuno della stessa fosse arrivato a
Grottammare già nella serata dell’11, cosa in fondo possibile, non sarebbe da escludersi che un informale abboccamento tra il sovrano e qualche membro della stessa
potesse esserci stato già la sera precedente e cioè l’11. Per muoversi su un terreno più
Vittorio Emanuele II, varcato il Tronto, si dirige verso Giulianova (incisione da Il Mondo Illustrato)
concreto, però, notiamo che, dello stesso tenore del dispaccio di Farini, quello dell’Agenzia Stefani del 13 ottobre, che riporta quanto ricevuto il 12 sera da Grottammare,
confermerebbe in modo incontrovertibile che l’incontro avvenne il giorno 12 ottobre
1860 e che probabilmente si svolse tra le ore 11 e le 13. Questa versione è avvalorata
anche dal citato Michelangelo Castelli che appunta nei suoi Ricordi pubblicati a cura
di Luigi Chiala:[6] «12 - … alle 11 antim. il Re ha ricevuto la Deputazione di Napoli,
composta di 22 persone delle primarie della città; il Re li trattenne quasi un’ora ed
uscirono entusiasmati, come arriva a tutti quelli che lo avvicinano la prima volta». In
definitiva sarà dunque avvenuto che l’incontro, in un primo tempo fissato per il 13
ottobre, si sia svolto prima, dato che - nonostante le difficoltà del viaggio che aveva
visto i Napoletani imbarcarsi a Napoli, sbarcare a Livorno e portarsi a Firenze,
Bologna, Pesaro e Ancona - la meta finale di Grottammare era stata raggiunta il 12
(ma per taluni è possibile addirittura l’11 sera) dal gruppo (arriveranno poi anche
Ranieri, Ferrigni e le sorelle Ranieri, Paolina ed Enrichetta, ritardatari forse per non
affaticare le signore, uniche donne del gruppo). A questo punto il Re, avvertito
dell’arrivo avrà voluto incontrare subito l’attesa deputazione e in ogni caso non è
pensabile che il Bonghi non si sia messo immediatamente a rapporto non appena arrivato. Così egli stesso - promotore, anima e protagonista della missione - scrive,
facendosene pure cronista, in un pezzo pubblicato anonimo il 21 ottobre sul supplemento al n.61 del Nazionale e intitolato Con la Deputazione di Napoli da Re Vittorio.
12 ottobre 1860, articolo che per la sua tempestività dovrebbe essere un precisissimo
resoconto dell’evento, ma che vuole in realtà porsi come versione ufficiale a suggello dell’operazione che Bonghi aveva contribuito in modo determinante a realizzare
per conto di Cavour e per la felice riuscita della quale sarà ampiamente ripagato.
[6] Torino-Napoli, 1888, p. 328.
Il salotto di casa Laureati dove ebbe luogo lo storico incontro
51
52
L’estrema urgenza di presentare all’Europa il voto di annessione di cui sono portatori i rappresentanti del Municipio di Napoli, della Magistratura e della sua nobiltà e
scelta borghesia, suggerì dunque con tutta probabilità di affrettare un primo abboccamento dei delegati con il sovrano in modo da poterne diramare quanto prima la notizia ufficiale. Come si è visto, infatti, questa, telegrafata nella serata del 12, veniva
diffusa il 13 mattina, mentre Re Vittorio riceveva nuovamente con modi cordiali, ma
anche con la solennità richiesta dallo storico momento, i napoletani finalmente al
completo. Successivamente una qualche confusione permarrà e se da un canto la
data asseverata dalla letteratura successiva e generalmente accolta è quella del 12
ottobre 1860, non manca talvolta di far capolino quella del successivo giorno 13.[7]
Sempre il Nazionale, però, aveva il 13 ottobre pubblicato il dispaccio che dava notizia
dell’incontro e questo, a meno che non si fosse trattato di un raro caso di precognizione, non poteva che essere riferito al giorno precedente. Insomma, un po’ di confusione, più o meno voluta, ci fu ma a noi piace pensare che il Re si sia intrattenuto più
di una volta con i napoletani a Grottammare: la prima certa il 12, che servì a far diramare subito la notizia, la successiva il 13, che consentì un più degno e prolungato
incontro con tutti i membri della deputazione e i loro accompagnatori.
Perlomeno Bonghi, poi, dovette avere qualche ulteriore e più privato abboccamento con il Re, che potrebbe avergli anche affidato il compito di riferire a Cavour
sull’esito della missione, ed in effetti fu deciso che il ritorno a Napoli sarebbe stato
“più sicuro” se avesse previsto una tappa a Torino. Lo stesso Cavour aveva senza
mezzi termini scritto a Farini: «Dica a Bonghi che deve venire subito a Torino» e
questi erano i fatti ma Bonghi spiegherà l’anomalo tragitto scelto per il ritorno dicendo che sembrava la strada migliore passare per Genova e che poi, visto che si era lì,
si sarebbe andati anche a Torino… Tra la perplessità di alcuni dei suoi membri, dunque, la Deputazione napoletana partiva da Grottammare per tornare a Napoli… passando per Torino. A questo punto sembrerebbe tutto chiarito ma ancora una volta è
Bonghi a confonderci le idee con la sua biografia di Cavour pubblicata nel 1860,
mentre il politico era vivente ed attivo, ed uscita l’anno seguente dopo la sua morte,
in una seconda edizione notevolmente accresciuta, che include anche il ringraziamento di Cavour per il testo dedicatogli e la sua esortazione ai napoletani affinché sappiano rendersi utili a Napoli. Per tornare al nostro dubbio, si osserva che in merito
all’annessione delle province dell’Italia centrale e meridionale Bonghi scrive:
«Il 9 ottobre Re Vittorio Emanuele era già entrato nel Napoletano, annunciando all’Europa che egli intendeva di assumere con mano ferma la direzione del moto nazionale, del quale era risponsabile lui; e alle popolazioni napoletane, che veniva tra loro a raffermare l’ordine, far rispettare la volontà
loro, e dar loro modo di manifestarla liberamente; veniva per iscongiurare il
pericolo, che, all’ombra di una gloriosa popolarità, di una probità antica
[chiaro riferimento a Garibaldi], tentasse di riannodarsi una fazione pronta a
sacrificare il vicino trionfo nazionale alle chimere del suo ambizioso fanatismo».
[7] si veda a tale proposito anche l’articolo di A. Silvestro del 1999 laddove cita un appunto conservato nel
Fondo Bonghi dell’Archivio di Stato di Napoli, che reca la frase «…Vittorio Emanuele, che fu incontrato
a Grottammare il 13 ottobre».
Dunque, pur di giustificare la ragion di Stato che ha drasticamente messo
nell’ombra il Generale, Bonghi non esita a cambiare le carte in tavola, alterando i
tempi ed i modi dell’arrivo del Re nel Napoletano. Anticipa infatti al 9 ottobre il
passaggio del Tronto che, per inciso, mai era stato o sarà in seguito tanto citato e con
53
Il dispaccio originale dell’Agenzia Stefani che conferma l’incontro di Vittorio Emanuele II con la Deputazione
napoletana avvenuto a Grottammare il 12 ottobre 1860
paragoni illustri che richiamano il Ticino e il Rubicone. Vero è che il 7 e l’8 c’era
stato ad Ancona un massiccio imbarco di truppe, che con il generale De Sonnaz e
parte dello Stato Maggiore venivano trasferite a Napoli, ma il 9 il Re partiva per
Grottammare, non era certamente «già entrato nel Napoletano».
Il palese anacronismo di Bonghi non rimarrà isolato, anzi c’è chi farà di meglio:
il principe Francesco Pignatelli di Strongoli, che giovinetto accompagnò il padre nel
viaggio a Grottammare, ricostruendo dopo quasi quarant’anni l’evento in un articolo
edito nel giugno del 1897, scrive che la Deputazione si imbarcò da Napoli il 12 ottobre 1860 all’ora del vespro e che si dovette fare un lungo giro per raggiungere il Re
a Grottammare dove si giunse quasi a sera (il giorno non è precisato). Aggiunge che
il gruppo napoletano fu ricevuto il mattino del giorno seguente e che l’emozione
dell’incontro fu tale che Luigi Settembrini proruppe in pianto, mentre Marino Turchi
vacillando cadde su una provvidenziale sedia. Insomma, il memorabile incontro era
destinato a rimanere «impresso nell’animo di tutti gli astanti»… non troppo nel suo,
però, se poi lo stesso Pignatelli, evidentemente influenzato da Bonghi, aggiunge che:
«Il 9 ottobre Vittorio Emanuele passando il Tronto cancellava per sempre tra Italia e
Italia ogni confine».
In definitiva, dopo questa forse poco utile disamina, conviene tornare al punto di
partenza ed accettare per convenzione che il ricevimento della Deputazione napoletana sia avvenuto il 12, con buona pace di tutti, chi c’era, chi non c’era e chi c’era ma
non se ne ricordò bene.
54
E a questo punto chiediamoci chi c’era. Di alcuni protagonisti, Vittorio Emanuele
II ad esempio, sappiamo già molto ed abbiamo comunque parlato, su altri - e ci riferiamo a Ruggero Bonghi o ai vari ministri o generali al seguito del Re - non è difficile reperire notizie; cerchiamo allora di presentare chi meno conosciuto ci risulta, ma
che vide nell’incontro di Grottammare un’occasione di passare alla storia, anche se in
qualche caso dalla porta di servizio. Cominciamo dunque dalla Deputazione, i cui
componenti non furono certamente scelti a caso ma furono, quasi per intero, designati da Bonghi di concerto con Cavour in quanto notabili, rappresentativi, significativi,
di fede certa alla monarchia sabauda e/o… desiderosi di mettersi in mostra con il
nuovo monarca ed acquisire utili benemerenze presso di lui. Non fu questo, certamente, il caso di tutti ma della maggioranza sì, indubbiamente, e il compenso in termine
di cariche ed uffici che ne ricevettero lo dimostra ampiamente ma… di Garibaldi ce
n’era uno e uno solo. Presentiamola dunque questa Deputazione napoletana, elencandone i componenti, sia della Municipalità sia della Magistratura, divisi per categoria
a seconda che fossero Eletti, Decurioni, Cittadini, Magistrati o personaggi di più o
meno alto significato, presenti come aggiunti o semplici accompagnatori. Diciamo
subito che gli Eletti erano i rappresentanti effettivamente eletti dei dodici quartieri di
Napoli, i Decurioni coloro che potevano fare le veci dei precedenti e che potevano a
loro volta essere sostituiti alla bisogna dai Cittadini. L’elenco che si dà di seguito
corrisponde a quello pubblicato con tutta probabilità dallo stesso Bonghi nel citato
articolo sul Nazionale n.61 del 21 ottobre e ripreso con minime varianti in altre cronache dedicate all’evento:[8]
[8] cfr. Il Natale della Patria, a cura di A. Speranza, Roma - Ascoli Piceno, 1911, p. 32.
Eletti
Ruggero Bonghi in rappresentanza anche del Sindaco di Napoli
Decurioni
Marino Turchi
Carlo Capomazza
Michele Baldacchini
Michele Persico
Giovanni La Pegna
Edoardo Pandola (non come effettivo ma come Aggiunto)
Cittadini
marchese d’Afflitto
marchese (Camillo) Caracciolo di Bella
Giuseppe Filioli (altrove Figlioli o Tisioli)
Giuseppe Romano
marchese Ulloa
Oronzo Di Donno
Luigi Giordano
Gioacchino Colonna
Antonio Dentice
marchese Atenolfi
Antonio Ranieri
barone (Angelo) Vetromile
Filippo De Blasio (altrove Di Blasio o De Blasis)
Gaetano Ventimiglia
Luigi Settembrini
Magistrati
Vacca
Ferrigni
Tra gli accompagnatori sappiamo poi esserci il principe di Strongoli Vincenzo
Pignatelli con il giovanissimo figlio Francesco e le sorelle di Antonio Ranieri,
Paolina, che come il fratello fu amica e confidente di Giacomo Leopardi, ed
Enrichetta, moglie del Ferrigni, che risultava così anche cognato di Ranieri. Il generale Guglielmo De Sauget invece, che pure era partito da Napoli, ammalatosi durante
il viaggio, era dovuto rimanere a Firenze. Sarà comunque nominato Senatore del
Regno e messo a Capo del Collegio Militare della Nunziatella dal 1861 al 1865.
Questo, si diceva, l’elenco secondo Bonghi ma fu proprio così? Se lui stesso era
stato fondamentale per la scelta dei componenti, non è detto che nel gruppo non vi
potesse essere anche qualche altro soggetto meno gradito sul quale tacere e, comunque, che qualche nome fosse successivamente messo in ombra probabilmente accadde. Del resto anche Ranieri non era stimato da Bonghi, il quale in più occasioni, come
si è detto, fornisce a Cavour informazioni e referenze sui membri della Deputazione
e altri «papabili» cosa che ben si evidenzia scorrendo il fitto rapporto epistolare intercorso tra i due. Eloquente in tal senso è anche una lettera scritta sabato 13 ottobre
1860 al ministro Farini da Loreto, sulla via del ritorno a Napoli, o meglio dell’andata
a Torino per fare de visu rapporto a Cavour. Ancora emozionato - ma non troppo - per
gli eventi appena trascorsi Bonghi così scrive:
55
56
«Gentilissimo Cav. Farini, Mi corre l’obbligo di darvi, colla mia usata
schiettezza, alcune informazioni su’ membri della deputazione che si è presentata al Re; acciocché nel caso vi potesse servire, conosciate il giusto
valore e l’effettivo credito delle persone, che ho avuto l’onore di presentarvi
in massa. I cinque decurioni Turchi, Baldacchini, Capomazza, Persico,
Lapegna sono cinque oneste e stimate persone. Nessuna di loro è persona
politica. Il Turchi è stato deputato al ’48; ed ha preso, se ben poca, pure
maggiore ingerenza che non hanno fatto gli altri, ne’ rivolgimenti ultimi del
paese. Il Baldacchini è un uomo di lettere di qualche merito; suo fratello
Saverio che non ha potuto venire, è una delle migliori teste, dei caratteri più
fermi di Napoli. Il Capomazza è un giudice riputato. Il Persico un negoziante, che ha fatto sempre prova di sentimenti probi e italiani. De’ notabili, non
son tutti notabili, giacché la deputazione s’è formata un po’ per iscelta e un
po’ a caso. Le persone di maggior rilievo sono il D’Afflitto, il Ventimiglia,
il Ferrigni, il Ranieri, il Caracciolo, il De Blasio, e più giù il Vacca. Hanno
avuto una parte politica più o meno importante Giuseppe Romano, fratello
di Liborio, Oronzio Di Donno, Giuseppe Tisioli, il Marchese Atenolfi, e
Gioacchino Colonna. Antonio Dentice si è compromesso al ’48 e non è più
tornato d’allora in poi a Napoli. è persona dabbene a cui piace viver bene. Il
Barone Vetromile è un buon proprietario che non ha nessuna significazione
di sorte. Eduardo Pandola è un giovane di buona indole che, dacché venuto
fuori alla vita civile, ha fatto sempre dimostrazione di buoni sentimenti italiani. Francesco Pignatelli è troppo giovine per potersene dir nulla. Resta, se
non isbaglio, il Principe Pignatelli Strongoli. Forse sarebbe stato meglio se
non fosse venuto. Era gentiluomo di camera di S.M. Francesco, e questo,
dopo essere stato emigrato e liberale. Dopo il suo rimpatrio s’è condotto
vilmente, e non è venuto, se non per voltare casacca a tempo. Non gode
nessun credito: ma sua moglie è una Baracco, e quantunque si sia destramente barcamenata è donna di maggior carattere e fermezza. Quanto a me
non gli farei segno d’onore, ma lo lascerei alla Corte. Dimenticavo il
Marchese Ulloa. è una persona stimata, che non ha valor politico. Lui e
Colonna vanno considerati perché rappresentanti della Guardia Nazionale;
ma non del pari: giacché il Colonna è maggior nome e persona di maggiori
spiriti. Vi ricordo Andrea Colonna, Sindaco, che non ha potuto venire. è uno
degli uomini che ha fatto prova di maggior ardire nel movimento anteriore
alla cacciata di Francesco II. è una delle più amate e stimate persone di
Napoli e bisognerà farle maggior onore, quanto meno di servirsene a qualcosa di elettivo. Di Carlo Poerio ho chiesto, e non potendo farlo Ministro
degli Esteri, che sarebbe il solo posto a cui potrebbe essere adatto, si potrebbe ripigliare il disegno del Ministero antecedente rispetto al Consiglio di
Stato e farlo Vice-Presidente di questo. Presidente è il Ministro di Grazia e
Giustizia. Non so ancora chi proporvi a Ministro dell’Interno; mi si conferma da parecchi che al Direttorato della Polizia Giuseppe Arditi potrebbe
restare. Filippo Blasio sarebbe un adattissimo Prefetto di Polizia: è uomo
giusto e di vigore. Vi proporranno Giuseppe Di Simone; e forse l’avrei fatto
anch’io prima di essere ritornato in Napoli dove n’ho sentito discorrere così
variamente che mi par meglio non adoperarlo per ora o non almeno a quel
posto. La sua nomina non credo che aggiungerebbe credito, quella di Filippo
Di Blasio piacerebbe a tutti. Io vi darò ancora alcune informazioni da Napoli
perché desidero…».
Questo il tenore della lettera da cui traspare benissimo il ruolo di Bonghi, degno
collaboratore del gran Tessitore! Centrale fu dunque nel delinearsi del primo governo
dell’Italia unita la figura dell’intellettuale e politico di origini lucerine che, comprendendo l’assoluta importanza dell’incontro di Grottammare, ne accrebbe vieppiù quel
risalto che forse non gli viene ancora pienamente riconosciuto. Pur significativi,
qualcosa da aggiungere ai giudizi del Bonghi comunque c’è, perché - forse non del
tutto immune dalle pecche di antico segno borbonico - anch’egli non si astenne dal
segnalare amici e parenti ed escludere o biasimare quanti per vario motivo gli risultavano sgraditi. Il Baldacchini, ad esempio, non poteva essergli estraneo, essendo
fratello di quel Saverio Baldacchini Gargano, deputato al parlamento napoletano nel
’48 e che sarà dopo il ’60 deputato e poi senatore in quello italiano. Bene, il letterato
purista Saverio Baldacchini, che non era potuto venire, altri non era che il patrigno di
Bonghi, avendone sposato la madre Carolina, rimasta precocemente vedova. Sempre
dai carteggi del Fondo Bonghi all’ASNA, si desume poi la confidenza della Signora
Bonghi Baldacchini con un barone Angelo Vetromile, forse il «buon proprietario»
dell’appena citata missiva, e questa conoscenza spiegherebbe perché sia stata inserita
in un così significativo consesso una persona definita dallo stesso Bonghi «senza significazione di sorte». Di Giovanni La Pegna possiamo aggiungere che era un avvocato e che nel 1864 pubblicherà un trattato di materia giuridica, dedicandolo al Re.
Eduardo Pandola, che sarà a Firenze come deputato nel Parlamento italiano, era stato
nominato “Aggiunto” da Garibaldi e, forse memore dei suoi trascorsi patriottici che
gli erano valsi il sospetto borbonico, sarà soldato volontario nelle campagne del 1866,
lasciando per questo la responsabilità della Conservatoria delle Ipoteche di Napoli,
«grossissimo boccone», affidogli secondo le maligne insinuazioni del De Sivo «in
premio d’esser ito a chiamar Vittorio».[9] Il giovane, anzi il «giovinastro» - sempre da
De Sivo - era in realtà un letterato ed uno dei più cari allievi di Francesco De Sanctis,
che gli scrive più volte iniziando le sue lettere con «mio carissimo Eduardo» o «mio
affettuosissimo» o anche «povero il mio Eduardo» quando gli ricorda la triste fine del
comune amico, e suo studente tra i più promettenti, Luigi La Vista, ucciso dalle truppe svizzere l’11 maggio del ’48 e caldamente rimpianto. Un altro personaggio della
deputazione vicino al De Sanctis e conosciuto dal Pandola era Antonio Ranieri, l’amico ed ospite napoletano di quel Giacomo Leopardi che De Sanctis aveva conosciuto nel 1836, quando il poeta, recatosi in visita alla scuola di Basilio Puoti, aveva
colpito in modo indelebile lo studente De Sanctis, lasciandogli «un solco profondo
nell’anima». A proposito di questi e della formazione culturale e civile che contribuì
a temprare gli animi di alcuni dei protagonisti della nostra vicenda, val la pena di ricordare che durante i moti del ’48, che erano costati la vita al giovane La Vista e a
tanti altri combattenti per la libertà, De Sanctis, arrestato dalla soldataglia svizzera e
tradotto in malo modo verso il luogo di detenzione, non cessava durante il tragitto di
[9] Storia delle Due Sicilie, Viterbo 1867, vol. IV, p. 259.
57
58
esortare i suoi carcerieri a seguire il nobile esempio del patriota svizzero Guglielmo
Tell, ricevendone in cambio un soprammercato di colpi e spintoni. Del decurione
Marino Turchi sappiamo che nel momento cruciale si lasciò vincere dall’emozione e
per poco non cadde a terra ma non fu il solo: anche l’anziano e provato Luigi
Settembrini, commosso, scoppiò in pianto ma dopo le infinite sofferenze patite, le
traversie subite ed oltretutto il disagio del recente viaggio questa reazione appare
comprensibile. Il Settembrini dovette, però, vergognarsene e scrivendo da Napoli
all’amico Antonio Panizzi il 16 novembre 1860, quindi a neanche due mesi dal fatto,
preferisce tagliar corto ed elencare piuttosto i disagi del viaggio che le circostanze del
fatidico incontro: «… Dieci giorni dopo che giunsi in Napoli mi fecero l’onore di
scegliermi come uno della Commissione napoletana, che andò ad invitare Vittorio
Emanuele ad entrare nel Regno. Andammo, corremmo per tutta Italia, viaggiando per
quindici giorni di e notte ed io tornai con quattrocento franchi di meno, e una malattia che m’è durata una settimana e mezzo». Sappiamo, però, che al ritorno a Napoli
al Settembrini era stato immediatamente trasmesso il decreto di nomina a Direttore
nel Ministero dei Lavori Pubblici, che egli però in coscienza rifiuta affermando di
«non essere uno di quei molti che pretendono di sapere tutto» e di non possedere «le
cognizioni tecniche necessarie» per assolvere all’incarico affidatogli.[10] In seguito
scriverà di essersi dovuto addirittura indebitare con un prestito per compiere quel
viaggio. Del Ferrigni si è detto essere il cognato di Antonio Ranieri, avendone sposato la sorella Enrichetta. Di lui Luigi Antonio Villari, tracciandone nel 1895 le note
biografiche nel testo Cenni e Ricordi di Giuseppe Ferrigni, cita alle pagine 70-71 la
partecipazione all’incontro di Grottammare. A tal proposito vi è da dire che Ferrigni,
persona stimata e di fiducia, già dal settembre aveva ricevuto ed accettato la nomina
a Vice Presidente della Corte Suprema di Giustizia (ibidem) e dunque sulla sua adesione non sembra esservi ombra d’interesse. Con l’arrivo di Farini a Napoli Ferrigni
avrà comunque parte attiva nella sua Luogotenenza, essendogli affidati gli Affari
Ecclesiastici nel Consiglio di questa, in cui Bonghi figura in veste di Segretario
Generale. Nello stesso Consiglio Gaetano Ventimiglia viene preposto all’Interno, responsabilità poi affidata a Rodolfo D’Afflitto, mentre il Marchese Camillo Caracciolo
di Bella, che aveva a suo tempo fondato con Bonghi il giornale Il Tempo, riceve la
nomina di Consigliere aggiunto. Insomma le “segnalazioni” di Bonghi a Cavour, a
Farini e magari direttamente al Re non tarderanno a dare i loro frutti. Non sono, però,
tutte positive perché del Ranieri Bonghi ha pessima opinione: «è uomo incapace di
lavoro, di risoluzione, di coraggio», scrive… evidentemente nella deputazione si
era… imbucato!
Queste succinte notizie ricavate soprattutto da documenti d’epoca hanno forse
dato qualche risposta all’interrogativo chi, ma non basta. Queste hanno infatti riguardato in gran parte gli ospiti ma anche tra i padroni di casa, i grottammaresi, c’erano
personaggi su cui si può dire qualcosa. L’aneddotica dell’avvenimento riassunta nel
testo Notiziette e Aneddoti dell’anonimo Contemporaneus[11] ci presenta qualche gustoso ritratto di personaggi tra il buffo e l’arguto che mai avrebbero altrimenti pensato di passare alla storia. Il Re li incontra andando a caccia, come suo solito in modo
[10] cfr. L. Settembrini, Epistolario, Napoli 1898, pp. 183-184.
[11] Il Natale della Patria, cit., pp. 49-51.
molto informale, ed anche Alberto
Silvestro nei suoi citati scritti sull’argomento ha avuto modo di soffermarsi sulla figura de lu Grillo, il
contadino che in poco tempo si conquista le simpatie del Re e che è forse
lo strano personaggio che lo accompagna verso l’Abruzzo facendogli da
battistrada con tanto di bandiera tricolore.[12] Altra simpatica figura è
quella del contadino al quale il Re,
incontratolo presso la costa di
San’Andrea, chiede se vi fossero
«buone nuove» ricevendone la lapidaria ed incontrovertibile risposta:
«Chi c’ha magna, chi non c’ha non
magna». Bei tipi, non c’è che dire.
Particolare dell’incisione di pag. 50 che mostra un curioso
Mettendo da parte le figure mac- personaggio che fa da battistrada al corteggio del Re
chiettistiche, sarebbe però giusto ricordare anche i tanti grottammaresi che dovettero all’improvviso far fronte a tutte le
necessità che l’arrivo del Re con un’armata di 27.000 uomini comportava. Con tempi
e risorse assolutamente esigui tutti dovettero collaborare ed è quasi commovente
scorrere nell’Archivio Storico di Grottammare le carte di quei giorni e constatare
quanto e come si poté far fronte ad una tanto significativa, estrema emergenza. Se ci
si riuscì fu solo perché tutti collaborarono, facendosi parte attiva del compito che si
doveva portare a termine e nel modo più degno, perché Grottammare tutta avvertiva
l’onore di una presenza e il peso di un momento che la metteva sulla ribalta della
storia. Nei registri comunali tutto viene annotato e, scorrendoli, possiamo constatare
in quanti abbiano dato alloggio e riparo agli uomini e ai cavalli: Pasquale Rivosecchi
detto Bellantò, ad esempio, o Rosa Ricciotti, Teresa ved. Capocasa, Andrea Fiori,
Annunziata Alojsi… C’è tanto da fare, si sono innalzati archi di trionfo e dappertutto
si sono messe bandiere, illuminazioni speciali, decorazioni di fiori e di carte colorate.
Il paese è bellissimo e accogliente e, pur nel disastroso ingresso sotto un violento,
improvviso temporale, tutti gli arrivati troveranno cibo e riparo, dal Re all’ultimo
stalliere. Ma questo fu possibile per la generale mobilitazione dei grottammaresi tutti, anche di quelli che poterono contribuire solo con qualche metro di corda o un po’di
colla o di chiodi. Di molti di questi i registri neanche riportano il nome e il cognome,
perché con le vere generalità chi li conosce? Je se dice Biancò, Caporà, Trabuscià,
Giugiù, Pisciò, Canepì e così sono annotati, e così li vogliamo ricordare.
Ripartito il Re, passata la buriana, tutti tirano un sospiro di sollievo: è andata! Il
sovrano è stato soddisfatto tanto da aver voluto inviare da Giulianova la promessa di
ben 10.000 lire per la chiesa di San Pio. Molto contento è anche don Gaetano Desideri, che ha strappato al Re l’assicurazione di un dono specialissimo: un bel paramentale per la chiesa di San Giovanni Battista su cui troviamo un interessante carteggio
[12] si veda in proposito Genova di Revel, Da Ancona a Napoli, Milano 1892, p. 61.
59
60
all’Archivio di Stato di Torino. «Ci manca tutto, avremmo bisogno di tante cose»,
aveva risposto il Desideri a Sua Maestà che, uscendo dalla chiesa dopo la funzione
domenicale, gli aveva chiesto se avesse qualche particolare necessità. Il Re non fu
sordo; diede subito incarico al canonico Stellardi, che lo accompagnava, di ordinare
a Torino un paramentale di moella bianca «del prezzo non minore di lire duemilla»
con «visibilmente ricamata la cifra dell’augusto nome del Re». Il paramentale, richiesto il 14 ottobre da Stellardi al conte Giovanni Nigra Ministro della Real Casa, dovrà
essere «intiero» cioè composto di «una pianeta due tunicelle e tre piviali, di un paliotto, cioè continenza, e di un controaltare alto e lungo come gli acclusi fili e che preferibilmente si desidererebbe di colore bianco nel fondo, ovvero, di tela d’oro». Il tutto,
che comprenderà anche tre stole, tre manipoli, un velo e una borsa e che viene realizzato con guarnizioni, galloni e merletto in oro fino e fodere in taffetà cremisi, è spedito da Torino il 9 novembre «franco di ogni spesa» e arriva prestissimo a
Grottammare. Eppure il Desideri, dimenticando che a caval donato non si guarda in
bocca, non ne è del tutto soddisfatto e dopo ben 20 giorni dalla ricezione, e solo perché richiesto da Torino di una conferma del regolare arrivo del paramento, si “affretta” a darne un “sollecito” riscontro. Il 12 dicembre scrive, dunque, al Nigra ringraziando ma precisando che:
«… in ordine poi alla Continenza permetta che le proponga una mia riflessione. Invece di quel telo lungo di moella come sopra guernito come sopra e
foderato come il tutto, in taffetà cremisi cui si è dato il nome di continenza,
della qual forma non si usa nelle nostre chiese, io mi aspettava di avere un
velo umerale, ossia quel velo di seta bianca guernito di ricami d’oro con
raggiera nel mezzo, quale si adopera nelle nostre chiese nel darsi le
Benedizioni e nelle Processioni del Santissimo od anche dal Suddiacono
nelle Messe Solenni. Se possedessi quivi questo, degno di un tanto apparato
il tutto sarebbe allora bene armonizzato e corrispondente».
Una bella faccia tosta, non c’è che dire, anche perché la missiva si conclude con
la seguente postilla: «Se è lecito per una mia norma gradirei conoscere l’importare
del valore di tutti i regalati oggetti, e perché siano sempre apprezzati e tenuti nel
dovuto conto». Alla inopportuna richiesta non verrà evidentemente dato seguito. Nel
citato testo Il Natale della Patria le pagine 58-62 sono dedicate al prezioso paramentale che, come vi si legge, per espressa e vincolante volontà del donatore, era e sarebbe stato in perpetuo di esclusivo uso della Parrocchia di San Giovanni Battista.
Purtroppo, per quello che si è potuto sapere, del raro manufatto - come del resto di
altre importanti testimonianze artistiche delle chiese di Grottammare - si sono da
tempo perse le tracce.
Per tornare al nostro paesello che avevamo lasciato il 15 ottobre 1860 in un clima
di esaltata confusione mentre si faceva l’Italia, vediamo ora cosa accadde e come fu
compensato del suo importante contributo.
Ritornata in qualche modo alla calma di una regolata quotidianità, la comunità
cominciò a fare i conti, avvedendosi di quanto fosse costato alle casse comunali il
fatidico passaggio e quanto ancora ne pesassero gli strascichi. I soldati ricoverati
nell’ospedale o ospitati, perché convalescenti, in case private, dovevano costituire un
aggravio non indifferente e lo Specchio dei viveri somministrati ai militi malati in
questo ospedale di Grottamare, documento conservato nell’Archivio Storico comunale, ne è prova. C’erano poi da pagare tutti i fornitori, gli operai, i fittacamere, fattorini, facchini, ecc. ecc. che avevano fatto sì che tutto potesse andare per il meglio e
qui i documenti contabili sono davvero vari, ampi ed eloquenti. Quando però le acque
si furono un po’ calmate e si stava tornando alla normalità, a qualcuno venne in mente che - come avevano fatto i preti di Grottammare, che in fondo il prezioso paramentale e la ripresa dei lavori per San Pio li avevano ottenuti - anche la Municipalità
qualcosa avrebbe potuto chiedere e cosa se non il porto, quel porto di Grottammare
che avrebbe dato un impulso decisivo ai suoi traffici commerciali e l’avrebbe fatta
definitivamente spiccare sulle limitrofe San Benedetto e Cupra? La vocazione marittima e imprenditoriale grottammarese quanto avrebbe potuto giovarsi di un proprio
adeguato porto potendone disporre! Da tempo ci si pensava e c’erano state anche
ispezioni in tal senso con tanto di relazioni di esperti, ma poi tutto si fermava e il
progetto in un modo o nell’altro non riusciva a trovare attuazione. Quella della presenza in paese del futuro Re di una nazione più grande e prospera era stata una occasione unica, insperata e… sciupata. Cominciarono le interrogazioni, le recriminazioni, il rimpallo delle responsabilità ma la realtà fu che era successo tutto così in fretta
e in modo tanto convulso che non c’era stato tempo di pensarci o, pur avendoci
pensato, di formulare la petizione al sovrano, peccato però per l’occasione perduta!
Si fecero poi i conti, perché come scrupolosamente erano state annotate le spese, così
si doveva procedere con il pagamento dei residui impegni e chiedere di tutto il rimborso al Ministero della Guerra, che si sarebbe fatto carico - era stato assicurato - di
tutto ciò che concerneva il vitto, l’alloggio, l’assistenza ai 27.000 militari che avevano accompagnato il Re. Ma chi lo aveva assicurato? Il Governo di Torino? Quello
italiano ancora non c’era e quando poco dopo ci fu, si guardò bene dall’adempiere a
tutti gli impegni assunti dal precedente. Insomma Grottammare avanzò e reiterò le
sue istanze ma né da Torino né, dopo il ’65, da Firenze, né tantomeno dopo il 1870
da Roma si ebbe una positiva risposta. Alle istanze di Grottammare fu anzi eccepito
che in quei giorni della permanenza di Sua Maestà le cose non erano state ben regolate e si erano distribuiti beni di proprietà comunale come paglia, legna e derrate di
vario genere senza un regolare scarico. Fu, dunque, contestato al Comune che i depositi contenenti quei beni erano stati svuotati in modo irregolare e questo costituiva un
danno erariale che Grottammare avrebbe dovuto risarcire e a nulla valse una dettagliata ed accorata memoria suggestiva della particolarità degli eventi, in cui veniva
accuratamente ricostruita l’eccezionalità del frangente, temporale compreso, che
aveva reso non gestibile la situazione. Si protestò la buona fede, l’onestà degli amministratori dell’epoca, si assicurò che l’impeto irrefrenabile dell’armata, fradicia e affamata, ben altri esiti disastrosi avrebbe potuto avere se non fermato con un immediato esaudimento delle richieste. Ci si appellò alla ingestibilità di una situazione non
ordinaria ma assolutamente eccezionale ed estrema. Ne nacque una vera e propria
causa, che si trascinò per oltre un ventennio e che fu salomonicamente chiusa con un
nulla a pretendere da entrambe le parti, essendosi alla fine valutato che il dare e l’avere potevano reciprocamente compensarsi. Si esaurivano così gli ultimi strascichi di
ordine pratico legati all’arrivo a Grottammare di Vittorio Emanuele II e della
Deputazione napoletana. Quanto invece a quelli legati allo studio dei fatti e dei personaggi, essi si sono nel tempo accresciuti. Questo fondamentalmente grazie ad Alceo
61
Speranza ed agli studiosi, giornalisti, eruditi che nel 1911 offrirono preziosi contributi di conoscenza alle Celebrazioni cinquantenarie che abbiamo più volte richiamato,
ma certamente anche ad appassionati ricercatori che ne hanno fatto successivamente
oggetto di specifiche indagini e, voglio sperare, un po’ anche grazie a noi, che abbiamo cercato in questa occasione di offrire nuovi ed ulteriori spunti ed approfondimenti a questa affascinante ricerca.
In conclusione, desidero ringraziare, per il fondamentale supporto e la preziosa
collaborazione prestatami nel corso delle mie ricerche presso l’Archivio Storico comunale di Grottammare, la Capo Area dell’Ufficio Cultura dott.ssa Fiorella Fiore e
la Responsabile dello stesso dott.ssa Tiziana Quinzi, nonché tutto il competente, solerte e partecipe personale della Biblioteca e dell’Archivio.
62
Cartolina realizzata per il Cinquantenario dell’Unità d’Italia e rievocante l’incontro di Villa Laureati