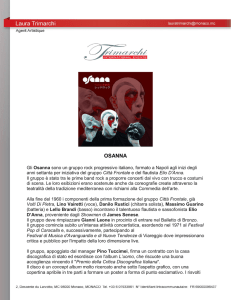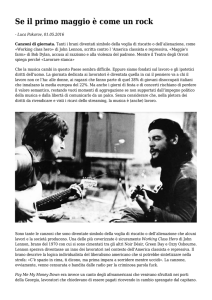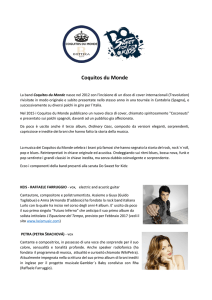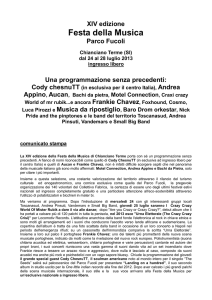digital magazine maggio 2009
N.55
Fonal
Records
[
]
Sami Sänpäkkilä, Islaja,
Kemialliset Ystävät,
Paavoharju, Lau Nau
Zombi, Golden Silvers, Elysian Fields,
Disrupt, Pink Mountaintops, El-Ghor, 33 ore
Cryptacize,
Wildbirds &
Peacedrums
C’è del marcio
nelle Marche
L leroy , J esus F ranco & T he D rogas ,
B utcher M ind C ollapse , B hava
Sentireascoltare n.55
Turn On
p. 6
Zombi
7
Golden Silvers
8
Elysian Fields
9
Disrupt
10
Pink Mountaintops
12
El-Ghor
14
33 ore
Rubriche
Tune In
112
Giant steps
16 Cryptacize
113
Classic album
20
Wildbirds & Peacedrums
114
La sera della prima
116
A night a the opera
118
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
24
Fonal Records
34 C’è del marcio nelle Marche
Recensioni
44
33 ore, Au, Blank Dogs, Dj Vadim, Gala Drop, Golden Silvers, The Horrors....
Rearview Mirror
104
Monks, Fridge, Lenny Kravitz, Funkadelic...
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Consulenti
alla redazione:
Daniele Follero, Stefano Solventi
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo,
Alessandro Grassi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu, Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali,
Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra,
Fabrizio Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
Sami Sänpäkkilä (Fonal Records)
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza
autorizzazione scritta di SentireAscoltare
News
a cura di Teresa Greco
I produttori Diplo e Switch insieme sotto il nome di Major Lazer per il debutto su
Downtown Records / Cooperative Music il 26
giugno prossimo. L’album sarà Guns Don’t Kill
People’s Lazers Do. La coppia ha prodotto MIA,
Santogold e Bonde Do Role oltre ad una sterminata
serie di singoli e remix (Gwen Stefani, Dj Shadow e
molti altri)…
A Steve Reich è andato il Premio Pulitzer
per la musica per la piece Double Sextet, completata
nell’ottobre 2007 e che ha avuto la sua premiere nel
marzo del 2008…
Robin Rimbaud aka
Scanner con Rockets, Unto the
Edges of Edges
mescola
tradizione e
field recordings.
Con
la partecipazione alla
chitarra di
Michael
Gira (Swans,
Angels
of
Light) nel brano
di apertura, Sans
Soleil…
A dieci anni dal loro
ultimo disco in studio, tornano
i Madness con un album celebrativo dei trent’anni
di carriera, The Liberty of Norton Folgate, che
è pubblicato il 22 maggio su Naive…
Esce in DVD il film documentario degli Arcade
Fire, Miroir Noir diretto da Vincent Morisset,
che documenta il making del loro album del 2007
Neon Bible, …
Su Youtube si può vedere il video di Shot in the
Back of the Head di Moby, anteprima dell’album
Wait For Me, in uscita il 30 giugno prossimo. A
dirigerlo David Lynch che ha influenzato l’intero
disco. Il singolo si può anche scaricare dal sito ufficiale (http://moby.com/download/1)...
John Foxx e Robin Guthrie insieme per un
album in uscita a maggio, Mirrorball, la cui idea
è nata quando i due si sono esibiti al concerto di
Harold Budd nel 2005
Il 19 giugno sarà pubblicato in Italia Animal,
l’album di debutto del duo (dj/produttori) AutoKratz su Kitsunè, dopo il mini dell’anno scorso,
Down & Out In Paris &London. Il disco sarà
supportato dal singolo Always More, che conterrà
remix di Yuksek e Shadow Dancer ed una cover di
Swastika Eyes (Primal Scream)…
A distanza di un
anno,torna il songwriting
dell’australiano
Scott Matthew,
rivelatosi l’anno scorso con l’album omonimo; sarà pubblicato
in Italia su Sleeping Star il nuovo disco dall’infinito
titolo: There Is An Ocean That Divides And
With My Longing I Can Charge It With A
Voltage Thats So Violent To Cross It Could
Mean Death…
Verrà pubblicato su City Slang il 12 giugno prossimo il nuovo disco di Cortney Tidwell, dal titolo
Boys. Originaria di Nashville e figlia di una cantante
country, ha collaborato anche con Kurt Wagner
dei Lambchop…
I Trail Of Dead tornano con il nuovo disco
The Century of Self…
Arrivano in Italia
per una data live Jeremy
Greenspan e Matthew
Didemus, alias Junior
Boys, per presentare il
nuovo album Begone
Dull Care, uscito l’11
maggio su Domino / Self
e preceduto dal singolo
Hazel. L’1 giugno saranno quindi allo Spazio 211 di
Torino…
A fine maggio, esce il nuovo lavoro di The
New Christs di Rob Younger (ex Radio
Birdman), dal titolo Gloria…
Novità in casa Chemikal Underground,
con il debutto di Lord Cut-Glass, nuovo pro-
getto di Alun Woodward (ex-Delgados).
Ritorna Nathan Fake con il nuovo album
Hard Islands, in uscita sempre su Border Community (James Holden). Si tratta di un nuovo formato,
con sei pezzi, che si colloca tra ep e mini-album…
L’ex Blur Graham Coxon esce a metà giugno
con The Spinning Top. Ospiti: Robyn Hitchcock
e Danny Thompson…
In attesa del settimo album della band previsto
per novembre 2009 (dal titolo Tohu-Bohu) tornano gli Ulan Bator; il 13 aprile è uscito infatti
un EP, SOLeils con cinque brani inediti sulla nuova
etichetta del leader Amaury Cambuzat, Acid Cobra
Records, distribuzione Venus. Ospiti James Johnston
(Gallon Drunk, Nick Cave & Bad Seeds, Lydia Lunch)
e Rosie Westbrook (Mick Harvey)…
Arrivano in Italia i Boss Hog, band di Cristina Martinez e di Jon Spencer (Blues Explosion e Heavy Trash), special guest Micragirls
(Finlandia). Saranno il 17 maggio a Torino- Spazio
211, il 18 maggio a Milano - Circolo Magnolia, il 21
maggio a Bologna - Locomotiv - Express Festival
(date a cura di Electricpriest)…
Dopo 4 anni di lavoro è ufficialmente fissata per
il 2 maggio l’uscita di Balera Metropolitana dei
Maisie, un doppio cd di ben148 minuti! Ospiti speciali: Amy Denio, Flavio Giurato, Mario Castelnuovo,
Deadburger, Aidoru, Gomma Workshop e tanti altri…
Sarà pubblicato solo in formato digitatale il
prossimo singolo dei volcano! dal titolo So Many
Lemons, il cui video girato a Chicago è già disponibile su Youtube…
Death Cab for Cutie fanno seguire a Narrow Stairs non un album ma un EP, The Open
Door, che è uscito digitalmente il 31 marzo e fisicamente il 14 aprile; include quattro pezzi inediti e
un demo di Talking Bird, già apparsa sul precedente
album…
Sarà pubblicato il prossimo 28 settembre da Rai
Trade Sunlit Silence il nuovo album degli italiani
Kiddycar, preceduto a giugno dal singolo C’est
Drole...
News /
5
zombi
decorative art 70s
Golden Silvers
Candido Feticismo per giovani blasé
Dalla Pennsylvania attraverso un buco nero che conduce agli anni Settanta in un
immaginario asse Londra-Berlino, tra tentazioni kraute e soluzioni prog.
S
teve Moore (chitarra, basso, synth) e A.E. Paterra
(batteria, synth) sono personaggi da tempo noti
in casa Relapse. Il loro debutto, Cosmos (Release Entertainment, 2004), ristampato su Aesthetics
nel 2007, uscì in tempi non sospettabili di seventies trend, segnando sulla mappa quelle che di lì a
poco sarebbero diventate le mete preferite dal duo
di Pittsburgh: il prog nostalgico e visionario, risolto
nella classica triade di tempi spezzettati, rapidi loop
melodici e uso di sintetizzatori vintage e un mantice spruzza-ambient come solo nel sogno tangerino
di Phaedra. L’immaginario di riferimento non era
rintracciabile che nell’estetica di un decennio che
celebrava il design d’interni, il cinema horror italostatunitense e la nascita dei videogiochi.
Con Surface To Air (Relapse, 2006) la componente prog avanzava su quella ambient (i cambi
di tonalità in Challenger Deep, con tanto di batteria sofferente di protagonismo), e si palesavano le
evidenti influenze di Alan Parsons, non ultima l’
idea del concept album, perseguita da Cosmos (incentrato, appunto, sulla cosmologia) fino al recente
Spirit Animal (costellato di riferimenti alla fauna
terrestre).
Dopo l’uscita di vari lp in edizione limitata, arri-
6
/ Turn On
viamo ai giorni nostri. A gennaio del 2009 è la volta di uno split con i Maserati e dell’opera terza,
Spirit Animal, che percorre ormai in tutta fluidità
la doppia corsia Tangerine Dream/Alan Parsons. Eventuali deviazioni pinkfloydiane sembrano
trovare un precedente recente negli Air di Virgin
Suicides, nonostante l’evidente diversità d’ intenti
ed esiti. Là dove i francesi sfoggiavano un ego ingombrante, pur flirtando col revival, gli Zombi si perdono tra le trame della storia, inghiottiti in un’ odissea
spaziale degna dei migliori incubi di Stan Brakhage.
Ed è il feticismo passatista, sommato a un indiscusso gusto per accordi e melodie malinconiche e
delicate, a costituire la cifra essenziale degli Zombi,
che limano ogni barocchismo prog, coniugandolo
col kraut in maniera quasi perfetta. E se è da qualche tempo che questi generi sono riaffiorati anche
in ambienti poco sospettabili (pensiamo ai Guapo e alla nuova generazione cosmica), Moore e
Paterra sono quelli che suggestionano di più, rievocando un tempo in cui Dario Argento e George Romero affidavano le loro colonne sonore
ai Goblin e c’era sempre qualche alieno pronto a
banchettare sotto un tavolo ovoidale.
Francesca Marongiu
Un trio di giovani belle speranze folgorato sull’iperstrada dell’informazione. O, se
preferite, pervaso d’insano, godurioso feticismo po-mo.
I
l Macbeth è un pub piuttosto in voga in zona East
London (70 Hoxton Street) che il terzo venerdì
di ogni mese diventa la location del Bronze Club,
serata a base di funk eighties e boogie electro con
ospiti live, tra i quali negli ultimi tempi spicca un
trio di giovani belle speranze. Si chiamano Golden
Silvers, sono londinesi, di età compresa tra i 23 e
i 25 anni - quindi non proprio di primo pelo per
gli standard anglosassoni - e sciorinano una formula
sonica sfaccettata e schizofrenica pur se britannicamente composta, affrontata col piglio blasé degli
intrattenitori consumati.
Ben supportato dal batterista Alexis Nunez e dal
bassista Ben Moorhouse, il leader - il cantante e tastierista Gwilym Gold - si disimpegna tra fantasie
pop-dance ed electro-soul, brume wave e carezze
doo-wop con estro visionario e timbro flemmatico, senza farsi mancare increspature stradaiole ed
inflessioni sciroccate. Nella prima metà del 2008 il
loro repertorio presentava già questo alternarsi di
situazioni a pronta presa e in strano e strutturato
derapage, un campionario di riferimenti sonici da
tirare fuori al momento opportuno quasi fosse il kit
edonistico del feticista rampante, per la gioia degli
astanti toccati nel vivo da questo impasto di candida
verginità e morboso citazionismo. Tutto ciò rappresentava un boccone ambitissimo per le fameliche
label inglesi, che iniziarono addirittura a sgomitare
quando il solito NME e l’occhiuta Radio 1 accesero
i loro occhiuti riflettori sul trio. Ad aggiudicarsi la
volata fu la XL, per i cui tipi esce quindi l’esordio
True Romances.
“Non credo sia giusto dire che siamo una indie band”,
ha dichiarato Gold. Non potrei essere più d’accordo.
Indie è ormai un termine fuori corso, buono semmai ad indicare un mood - un contropelo sbrigliato,
in romantica e finanche parallela divergenza rispetto al mainstream - che di certo i Golden Silvers non
praticano, sublimandolo con quelle pose da parvenu che la sanno lunga e larga, senza preclusioni da
snob alternativi. Oppure, se preferite, sembrano gli
ennesimi rappresentanti di una generazione di bombardati/miracolati sull’iperstrada dell’informazione,
dove l’accessibilità e simultaneità di ogni fenomeno
culturale catalogato rende possibili anzi necessarie
playlist in cui allegramente (?) convivono Ultravox
e Beach Boys, Style Council e Kajagoogoo,
Joe Jackson e Blur, Elvis Costello e Donald
Fagen, Hendrix e Smiths... Il problema e quindi
l’abilità dell’artista diventa togliere ciò che ingombra il percorso, sfrondare le ramificazioni nocive. Un
processo assieme facile e rischioso, che seguiremo
con attenzione. Magari godendone, nel frattempo.
Stefano Solventi
Turn On /
7
Elysian Fields
disrupt
Dancehall a 8 bit
© Keith Sirchio
Artigiani moderni
Apice di una carriera tormentata,The Afterlife prova a dar il lustro che compete ai
newyorchesi Elysian Fields.
L
a storia della musica è costellata di gente incompresa che, magari, ha faticato una vita raccogliendo solo briciole. Non andatelo a raccontare a
Jennifer Charles e Oren Bloedow, da quindici anni al centro degli Elysian Fields. Band di valore
marchiata da sostanziale indifferenza, della quale non
ti capaciti considerando il physique du role di Jennifer e le relative corde vocali da Hope Sandoval
rotonda e matura, da P.J. tutta sussurri e intarsio.
Soprattutto allorché presti orecchio al loro equilibrato incrocio di folk, rock e jazz cui dona aggiuntivo fascino l’aura intellettuale giammai pretenziosa.
Canzoni calde e appassionate le loro e il problema sta lì: nel non ostentare muscoli o supponenza, preferire mistero e lavoro di bulino scansando
il possibile campare di rendita sul look e le formule
annacquate. Meglio appagarsi trafficando con la crema sonora di New York e approdare in scioltezza a
un quinto lp maturo e splendido. Dietro il quale c’è
una storia tortuosa che parte da un contratto con
Radioactive/Universal che nei Novanta cagiona l’ottimo esordio Bleed Your Cedar con Steve Albini al
timone. La critica li esalta e un tour ne fa delle stelline oltralpe; pongono così le basi per un secondo
disco sempre con l’ex Big Black, tuttavia l’etichetta
lamenta un suono troppo oscuro e aspro; si rompe
8
/ Turn On
definitivamente nel 2000 e da allora il disco giace a
prendere polvere.
Ce n’era abbastanza da schiantare chiunque e
dove sarebbe la novità, ma i Nostri fanno quadrato
ed escono su Jetset con Queen Of The Meadow. Ancora l’Europa si mostra più ricettiva e lo stesso varrà tanto per Dreams That Breathe Your Name - edito
per i tipi PIAS sei anni or sono - che per Bum Raps
& Love Taps del 2005. Da lì avevamo perso di vista i
Campi Elisi, pensandoli tranquilli in casa a scrivere
e cacciare il naso fuori per andare a teatro oppure
in sala prove. Lo scorso mese è invece saltato fuori dal nulla, grazie ai buoni uffici della transalpina
Vicious Circe, The Afterlife (cfr. spazio Recensioni):
incantevole sin dalla copertina, avvolge tra strutture
articolate e arrangiamenti ricchi; senza leziosità, si
fa strada e seduce poco a poco. Occorre prestare
un po’ d’attenzione in più dell’usuale all’incontro tra
Tindersticks e Rachel’s Ashes In Winter Light,
all’esotica Only For Tonight e alla romanticissima The
Moment: presto s’imprimeranno nel cuore e il resto
verrà da solo, abbiate fede. Fossimo in Jennifer e
Oren, però, un bel colpo di nocche sul legno lo daremmo comunque…
Giancarlo Turra
Il ritorno di Jan Gleichmar scompagina le carte del dubstep e ci riporta in
Giamaica. Parola d’ordine: Dancehall
D
isrupt e la sua etichetta Jahtari sono il miscuglio nerd perfetto per questo 09 post-dubstep.
Dopo un decennio di esistenza, il ‘genere-non-genere’ tutto UK bas(s)ed si insabbia nel barocco e
si candida a far la fine del drum’n’bass: l’entusiasmo
‘old school’, le serate dubstep-based con i soliti DJ,
l’oblio e forse, tra qualche lustro, il ripescaggio. La
solita tiritera underground che siamo abituati a seguire travolgerà (o ha già travolto) il figlio ‘intelligent’ del grime.
Jan Gleichmar fa il botto nella scena dubstep
nel 2007 con un disco su Werk che sposta l’ago
della bilancia sul dub: Foundation Bit è appunto -come dice il titolo- una dichiarazione d’intenti
classica, quella lunga linea rossoverdegialla che dalla
Giamaica arriva in Europa e si trasforma con i synth.
In due anni ne cambiano di cose, e quindi il nostro si
stacca dal mainstream (se così si può dire) e fonda
un’etichetta indipendente che insiste sull’immaginario a 8 bit: Commodore 64, Atari, Spectrum e le
altre consolle che ci proponevano un mondo pixellato rigorosamente in quadricromia che viaggiava su
nastro e che in sè aveva un retaggio downtempo.
Non c’erano i giga, una volta si viaggiava con le cassettine e per i più fortunati con quei floppy discs
che oggi se li guardi ti scende la lacrimuccia.
Quella lentezza strutturale porta il ragazzo a interrogarsi sull’uso della tecnologia. E allora visto che
non ha tempo di ‘stare al passo con i tempi’, si mette
a rifare tutto da capo con un laptop. Lo stile lo-fi che
contraddistingueva le prove dei vari Mad Profes-
sor o di altri visionari fumati di erba, si innesta nel
continuum breakbeat resuscitato da Pritchard con
il suo progetto Harmonic 313. Se fai 2+2 arrivi
quindi all’altro spettro che si aggira da ormai 3 decadi: Kraftwerk. L’immaginario del gruppo di Düsseldorf con
i suoi robot che poi si faranno di E, si mixa con
il dancehall. Il risultato si chiama The Bass Has
Left The Building. Se scorri fra i titoli, ti accorgi
che la citazione è palese: It’s More Fun To Dubpute,
Hail The Robots e altri titoli sono la connessione con
quei suoni proto-hi-fi con la patina krauta di Ralf
& Florian. Ma non solo. Nel disco (uscito lo scorso
febbraio) c’è anche il ripescaggio della post-coin-op
generation: Sega Beats, Bruce Lee, Impossible Mission
III sono giochi o consolle che hanno segnato i polpastrelli di milioni di nerd. E in più, per finire c’è
pure il dancehall, quel levare che non sconfina mai
nell’acido ma che ti fa muovere il culo con la patina
da club. A differenza del reggae puro, il dancehall è
una cultura da nerd. Un’avventura club-based che
nei 70 in Inghilterra avrebbe (s)fondato interi sottogeneri, sempre a contatto con lo sballo. Ma se là ci
andavi di blue pills, qui oggi sembra ritornare l’individualismo da cameretta, ovviamente ereditato dal
dubstep (obbligatorio citare qui Benga che dice
di aver prodotto molte tracce solo con la Playstation...). Uno scarto dalla decadenza che si interroga
sulle radici e che ci piace. Sua maestà The Bass ha
definitivamente lasciato il palazzo dei bottoni.
Marco Braggion
Turn On /
9
Pink Mountaintops
© Jody Todac
DEVOTIONAL MUSIC: l’enigma Stephen McBean
Dopo il passo falso del secondo Black Mountain, Mr. Stephen McBean è tornato tra
noi in ottima forma con i Pink Mountaintops. Abbiamo provato a rilfetterci su...
D
ietro l’aspetto rilassato e il (non) look a mezza
via tra l’hippie di campagna e un membro pentito della “family” di Manson, il canadese Stephen
McBean - eminenza grigia di Pink Mountaintops e
Black Mountain - nasconde una sorta di schizofrenia artistica che lo rende una figura assai interessante. Sebbene un lavoro celebrato ovunque come
In The Future abbia fallito nell’impressionarci positivamente, quanto sin lì fatto mantiene una ragguardevole caratura, comprovata di recente dal terzo lp
10
/ Turn On
delle Cime Rosee, quell’Outside Love che prosegue
l’opera di (ri)mescolamento enciclopedico dello scibile “rock”. Pregevole e riuscito, si diverte con le tue
aspettative come un gatto col topo, come ogni artista di un certo livello sa o talvolta addirittura deve
fare. Perché da questa combinazione tra guardarsi le
scarpe e levarsele per correre nella prateria, da questa mescolanza di country, souledelia e molto altro
ancora emerge infine un’identità. Un seducente mostro di Frankestein composto da pezzetti e citazioni
di decine d’altre band e generi sovente distanti uno
dall’altro, nel quale le cuciture non si notano affatto.
Dagli Stooges e Velvet corretti da un approccio
qui new wave e là acid-rock dei primi due lavori ci si
è ora avvicinati di più ad albioniche lande e tuttavia
mai completamente, al punto che i “prestiti” sonori
si confondono coi relativi “pretesti”. In altre parole,
il quasi quarantenne McBean non nasconde i modelli cui s’ispira, paga ogni dovuto debito e fabbrica
una musica colma di devozione verso chi lo ispirò: il
felice paradosso è che, contando su decenni di sviluppo stilistico e del distaccato sarcasmo tipico della propria generazione, compie oltrepassa il mero
tributo e l’archivismo. Per quanto possibile oggidì,
possiede creatività. Fossimo negli anni Ottanta, i
Pink Mountaintops finirebbero a far compagnia per
attitudine (e ogni tanto anche per le sonorità…) ai
Flaming Lips e non ai Chesterfield Kings. Ricordate? Poiché l’industria delle ristampe era attiva
ma mai come da dopo l’imporsi del cd, occorrevano
formazioni che rifacessero tali e quali gli idoli del
passato per mantenerne la memoria storica a uso
dei posteri.
Da ammirare, anche se le basi delle commistioni a 360° del decennio successivo si ponevano giustappunto altrove e finiranno per sostenere un far
musica privo di pregiudizi, che cita e sovrappone le
pagine della Storia e, non di rado, rappresenta quanto di meglio offre l’attualità. Dunque sorprende ma
solo fino a un certo punto che, nelle tre fatiche di
studio sin qui pubblicate a nome Pink Mountaintops,
il richiamo alle fonti non scada in scopiazzatura; che
non si ascoltino passaggi e idee che annoiano perché chi le esegue ragiona già ragiona da vecchio,
affidandosi a opzioni comode e non caricandosi in
spalla un po’ di rischio. È l’osare che ha fatto Grande
tanta musica e, nei limiti di un oggi che procede per
piccoli gesti, la ricerca di incognite resta possibile.
L’epoca delle rivoluzioni è ormai dietro le spalle,
insomma, e ciò da lungi: ora ci basta chi abita luoghi confortevoli e li arreda con un tocco personale da reggere più di qualche educato passaggio di
prammatica sullo stereo e lasciarsi ricordare oltre il
momento fugace. Cosa che accade anche in Outside
Love, in occasione del quale McBean ha scomodato
una dozzina di musicisti ed è il loro “pedigree” a raccontarsi rivelatorio: oltre ai sodali che figurano pure
nei Black Mountain, spicca la presenza della sottovalutata e mistica musa “Americana” Jesse Sykes e del suo chitarrista Phil Wandscher (che
nei Whiskeytown masticò parecchio country: il
conto torna), di una Sophie Trudeau che, dritta
dagli A Silver Mt. Zion lavora con somma raffinatezza e un John Congleton che - incredibile
ma vero! - produce con misura per lui inedita.
L’aria da disco maturo e importante è, in ragione
di ciò restituita appieno, sottolineata dalla scrittura
e dalle atmosfere, intrise del sonic-gospel alla Jason Pierce se depurato dal frastuono, dell’oceanico e sognante indie-rock che presagì lo shoegaze
e di quella consapevolezza “roots” che oltre l’Atlantico non manca mai. I medesimi panorami di Axis
Of Evol, direte voi: sì “ma anche” no, giacché gli ultimi due ingredienti posseggono sapori più robusti
e penetranti. In gemme come Axis: Thrones Of Love
ed Execution percepisci l’Inghilterra noise-pop e il
respiro spectoriano dei primi ’60. A quel punto è
chiaro che McBean non divulga in quest’epoca dove
sappiamo già tutto; di come preferisca puntare il riflettore sui dettagli: ad esempio mostrare quanto
Jesus & Mary Chain adorassero Phil Spector
o, in Vampire, cavare di tasca l’anello che congiunge
Dylan e Neil Young. Persuadere che i Mazzy
Star più bucolici convivano in magica armonia a
fianco di Bill Callahan e del battito urbano appartenuto a Suicide e Modern Lovers. Accolgono così un senso del tutto nuovo e diverso quelle
dichiarazioni del Nostro che ricordano gli ascolti
a vent’anni di Dinosaur Jr., Meat Puppets e
Black Flag: non ci sono in questo album e nemmeno nella coppia che lo ha preceduto. In loro vece
rinvieni la medesima mentalità che animava costoro,
la volontà di riscrivere le regole dei dischi con cui
erano cresciuti e che amavano. Lo stesso discorso
valga per la strada verso gli “anta”, popolata di Royal Trux e Karen Dalton: a tutti tocca diventare grandi e non si scappa. Rimane un rebus in ogni
caso da decifrare, quest’uomo del British Columbia
che traffica con le rock band da che frequentava le
medie: senza impensierire granché circa il prossimo
Black Mountain (un altro pasticcio o la lezione sarà
stata assimilata?), offre la scintillante noncuranza
tramite la quale i rimandi al passato si intersecano
tra loro in un quadro di non indifferente bellezza.
Semplice e decorosa come quella dell’artigiano che
si trasforma in maestro e cesella le perle più fulgide
quando non si fa prendere da una serietà e non rincorre un’innocenza non più possibili. Che, in fondo,
stia davvero e soltanto facendo ciò che più gli piace
e siamo noi - pennivendoli con molto tempo da riempire pensando… - gli unici a non averlo capito?
Giancarlo Turra
Turn On /
11
primis, vi siete promossi produttori artistici, anche se Paolo Messere continua a
darvi una mano...
Si, sono cambiate moltissime cose dalla realizzazione del primo album, eravamo più giovani ed inesperti. Sicuramente l’esperienza in studio con Paolo
Messere, per Dada Danzè, è stata indispensabile
e molto formativa per la nostra crescita artistica.
Negli anni seguenti la prima esperienza, abbiamo
raggiunto un forte equilibrio artistico e non solo,
tanto è vero che le due labels che hanno prodotto
il disco hanno ritenuto opportuno affidarci anche la
produzione artistica di Merci Cucù.
C’è poi il pressoché totale abbandono
dell’idioma italico in favore del francese,
già presente nell’esordio però solo in tre
tracce. Cos’è accaduto?
Dopo aver realizzato in francese solo alcuni brani
del primo disco, ci siamo accorti che quella soluzione rappresentava e rappresenta la nostra dimensione ideale, e si sposa bene con la scelta estetica
che ha sempre accompagnato il gruppo. In questo
momento, reputiamo l’armoniosità di questa lingua
il sigillo della nostra sperimentazione musicale, ma
questo non esclude eventuali cambiamenti futuri…
Aspettatevi il prossimo disco in inglese o magari in
russo!
El-ghor
© Vincenzo Giamundo
sigillo french-touch
A due anni dal debutto Dada Danzé, album che sembrò spurgare da una ferita per
fare punto e accapo sulle macerie del cantautorato rock italiano, l’opera seconda dei
campani El-Ghor segna una sterzata decisa, forse decisiva. Ne abbiamo parlato
con Luigi Cozzolino, voce e chitarra della band.
Iniziamo... dall’inizio: cosa è accaduto in
quel fatidico dicembre del 2003 che ha visto nascere la band?
Io e Francesco, che avevamo già avuto esperienze
musicali in una stessa formazione precedentemente,
ci siamo ritrovati dopo un breve periodo di stasi a
12
/ Turn On
voler mettere su una band: nell’arco di poche settimane si è aggiunta Ilaria ed in seguito Luca. Tutto ha
avuto inizio da qui.
Il percorso tra Dada Danzé a Merci Cucù
ha segnato sostanziali cambiamenti. In
L’italianità è per così dire rinnegata anche
dal punto di vista musicale. C’è più spinta
direi punk-wave versante anglo-francese,
svanisce quasi del tutto la discendenza
rock-cantautoriale alla Marlene e Marco
Parente... Vogliamo intenderla come una
presa di distanza?
Ci teniamo a dire che siamo cresciuti con la musica
italiana e ci sentiamo italianissimi, non cerchiamo in
nessun modo di allontanarci da questa scena, anche perché la reputiamo, almeno negli ultimi anni,
estremamente interessante e prolifica. Quello che
realizziamo musicalmente, e che riteniamo assolutamente spontaneo, è il risultato del diverso modo di
vivere la musica di ogni elemento della band.
La tromba di Luca Fadda si sposa magnificamente col vostro sound. Tornerete a
collaborare?
Visto il grande rapporto di amicizia che ci lega e
che ci ha portato a questa collaborazione, sicuramente ci sono grosse possibilità che ciò riaccada.
Luca ha avuto da parte nostra piena fiducia ed ha
dato un grandissimo contributo in alcuni brani; ha
dimostrato, ciò che già sapevamo, di essere un artista originale e con grande senso musicale. Oltre a
quelli di Luca, sono stati importanti anche gli interventi di Davide Arneodo dei Marlene Kuntz, di
Francesco Di Bella dei 24 Grana e di tutti gli altri
musicisti.
Spendete molta energia nei videoclip,
infatti Danzé e Sans Lumière guadagnarono molti consensi all’epoca. Con Monsieur Paul mi sembra che la tradizione
prosegua... Ci sono altri clip in programma? Progetti video-cinematografici di più
ampio respiro?
Siamo molto felici che i due video del primo album
abbiano suscitato grosso interesse. Tra poche settimane sarà visibile il nuovo video Monsieur Paul,
primo singolo estratto da Merci Cucù, realizzato
dalla Mastofabbro Production e diretto da Pier Paolo Patti (videoartista già al lavoro con Retina.it,
Baba Sissoko e Remo Remotti tra gli altri,
ndi). Ci auguriamo che la nostra musica possa essere utilizzata anche in campo cinematografico, ma
per il momento non c’è nulla in programma. Si accettano proposte!
Non si inizia un’avventura come la vostra
senza ambizione. Mettete da parte ogni
discrezionalità e ditemi: in che misura
vorreste lasciare il segno nel librone del
rock’n’roll?
Beh, c’è ancora tanta e tanta strada da fare e speriamo di poter arrivare molto lontano. Artisticamente
siamo più che contenti di quello che stiamo vivendo,
vorremmo solo portare la nostra musica in giro il
più possibile.
Indicatemi quattro nomi - uno ciascuno,
se volete - che idealmente vorreste nominare quali vostri numi tutelari. Assieme al mio in bocca al lupo, per quel che
vale.
Per quanto mi riguarda, mi affascina ancora il mondo costruito da Ian Curtis e i Joy Division durante la loro breve carriera; per Ilaria è da sempre
Jim Morrison; per Luca è Ludovico Einaudi,
mentre Francesco è molto legato ad un altro grande musicista... Picasso. Crepi il lupo!
Stefano Solventi
Turn On /
13
33 ore
Solitudini e similitudini
Musicista d’esperienza e artista creativo, Marcello
Petruzzi esordisce come cantautore dopo un passato nei
Caboto e nei Franklin Delano. Una svolta che ha un nome
(Quando Vieni) e un presente in divenire.
- Edoardo Bridda e Fabrizio Zampighi
U
n vinile di De Gregori, Rimmel, ereditato dai genitori, e qualcosa di non ben precisato di Lucio
Dalla: questo il bagaglio minimo dichiarato da Marcello Petruzzi come influenza per le proprie canzoni. E qualcuno già insiste: Piero Ciampi. E lui, di Livorno come il tragico cantautore,
ovviamente nega. “È una sorta di buon fantasma cittadino”, dichiara. Noi ci accontentiamo. Sappiamo quanto
sia difficile fare un’analisi dei propri riferimenti, specie quando a questi sono arrivati altri prima di te e in
tempi non troppo lontani. Non voglio che Clara, Baustelle, i Cosi. È da un po’ di anni che c’è una Sanremo
14
/ Turn On
“buona” riscoperta e riamata. Una nuova sensibilità
che ha operato anche una piccola, grande rivoluzione: riavvicinare le nuove generazioni alla tradizione
musicale più genuina del nostro dopoguerra. Così,
arriva Marcello e, come direbbe Emidio Clementi,
c’è forza nelle sue parole. Il suo non è quel pane urlato e nemmeno la posa alt-qualcosa nascosta dietro a una presunta tradizione. Si sa, quando i cassetti
li apri con troppa forza rischi di interpretare poi Il
personaggio. Non Marcello, una vita silenziosa la sua:
prima Livorno e poi Bologna, madre (quasi) naturale
la prima, genitore in prestito la seconda. Con la città
felsinea arriva anche l’amore per certo prog molto
jazzato (i compianti ma non troppo, viste le carriere dei ragazzi, Caboto) e poi il folk (ex post) rock
americano dei Franklin Delano periodo di mezzo,
ovvero “maccaroni” e Califone. Ancora, quelli che
vanno in America a suonare proprio grazie alla band
di Rutili. E dunque, se con i Caboto il Marcello musicista si fa le ossa nei centri sociali improvvisando
senza cinture di sicurezza e mescolando rock, India
e contemporanea (ai bei tempi dell’Ex Mercato 24
facevano non poco effetto!), è con la band di Paolo
Iocca che il nostro impara, anche a proprie spese, la
durezza della vita on the road. Chilometri da macinare, junk food e tensioni dovute alla stanchezza. Al
ritorno dalla tournée l’abbandono della band e la
voglia di appartarsi un po’.
Del resto Petruzzi è un equilibrio di mitezza e
riflessione, in tutto e per tutto speculare a Iocca,
uno invece di nerbo e idee come squarci di luce dal
cielo. Lo caratterizza quel pallore lunare che dalla
faccia passa direttamente alle strofe. E di cui pause e
apprendimento sono la base. “Ho fatto sforzi tremendi per separarmi dal mio vissuto, temendolo ancora e
scongiurando l’imbarazzo di offrire, a risultato ottenuto,
solo un pugno di visuali trascinate e disilluse”, ci ha confessato in una bella chiacchierata. Ci viene ancora
da rubare frasi a Clementi, perché Quando Vieni
lavora sui bordi della quotidianità, è un canzoniere
che indaga rapporti umani e analizza i conflitti messi
forzatamente a tacere. Specie quelli che tornano a
sconvolgere il nostro quotidiano, incrinando certezze e trasformando sorrisi in ghigni ambigui.
Questo il nucleo fondante dell’opera, e attorno non c’è semplicemente una chitarra. Ci sono gli
amici. C’è un prezzemolo Bologna Violenta (Nicola Manzan, all’attivo anche sortite nel folk sublime di Alessandro Grazian), Francesco Brini,
Pietro Canali, Elia dalla Casa e soprattutto
Matteo Romagnoli ovvero 4fioriperzoe. Una
di quelle figure senza le quali la storia non sarebbe
stata la stessa. “Al contrario di me, è esperto in canzone d’autore italiana e in tanti episodi mi ha proposto
scelte e adattamenti che oggi reputo molto importanti”.
Sacrosanto, ma è Marcello ad aver operato il processo più difficile, “staccare i fatti e i loro racconti dalla
carne”. I luoghi e le immagini che poi tornano a galla,
mescolandosi al presente bolognese.
A proposito del capoluogo emiliano, riesce difficile paragonare 33 Ore ad altre realtà musicali della
città. Città che del resto è, ora più che mai, orfana
di quell’humus condiviso che la rendeva unica. Dicevamo dei Massimo Volume, le cui velleità letterarie ed esistenzialiste posseggono intensità simile,
ma raggio d’azione decisamente diverso. Bologna è
dentro Marcello ma dentro Marcello c’è anche un
misto di consapevolezza e ricerca. “Tendenzialmente
puoi considerarla una scelta “radicale”: quando il luogo
fisico acquerellato serve a descrivere un paesaggio emotivo oppure si fa specchio di uno sguardo. Il focus lo vedo
nell’ambiente ridotto, dove va in scena il rapporto tra un
personaggio e un qualsivoglia riverbero del suo spazio,
sia esso una valigia, il bordo di una finestra, le mattonelle
di una camera oppure un abitacolo. Ammetto una certa
vaghezza descrittiva sul generale, ma tutto si fa più nitido sul particolare per poi emergere sulla pelle e oltre. Un
blow-up sui piccoli gesti, rivelatori e affettivi, che hanno
residenza ovunque.”. Come accennavamo, quello del
Petruzzi è un percorso parallelo alla nuova ondata
di cantautori: il surrealismo melodico di un Dente,
il cut-up e la catarsi de Le luci della centrale elettrica, la vaghezza del ricordo filtrata dalla dimensione
onirica di un Adriano Modica: “Il tempo in cui tornano
le cose dopo che sono accadute. Cito Abilio Estevez: Un
vaso si rompe e arrivano i ricordi. Quando vieni è
sostanzialmente questo.”
Lui deve maturare, dice, per vedere che cosa è
diventato. E insiste sulla leggerezza. Non tanto nei
testi, ma nella vita stessa.Tradotto significa: zero immagine da maledetto o pose da cantautore che se
la tira. Come sottolineato anche dalla storia dietro
alla sigla 33 Ore: “È un soprannome rimasto da una
vecchia gara di resistenza giocata sulla volontà. Il fatto è
banale, mi è capitato molti anni fa e lo racconterò attraverso le tappe: Livorno-Firenze-Genova-Milano-Trieste-la
dogana slovena ancora extracomunitaria-Trieste-Milano-Bologna-Firenze-Livorno-rinnovo di carta di identità
in comune-Firenze-Bologna-Ancona-Croazia. Più o meno
in 33 ore. Ometto i particolari e occulto le immagini.”
Quale miglior modo per concludere un ritratto?
Turn On /
15
Hanno appena pubblicato il loro secondo lavoro, Mythomania, e ci hanno
decisamente lasciato a bocca aperta e mente vagante. Li abbiamo intervistati
cercando di andare a fondo delle loro storie – nonostante i loro nomi siano già noti e dei loro giochi con il pop del passato. Coordinate e sfumature dei Cryptacize.
Cryptacize
C oordinate
C
- Gaspare Caliri
16
/ Tune In
© Dennis Renshaw
Coordinate e sfumature
i sono le coordinate per definire una cosa.
Ci sono però anche bolle che seppure soggette alla definizione in qualche modo la
rifuggono, con piccole pause di riflessione. È facile dire chi sono Cryptacize, da dove vengono e
come sono arrivati a noi. Ma è la loro musica che
poi, in definitiva, ci fa guardare altrove.
La città dove Nedelle Torrisi (voce, chitarra,
synth), Chris Cohen (voce, chitarra), Michael Carreira (batteria) e Aaron Olson (basso) formano la
band di cui vi parliamo è Oakland, anche se presumibilmente presto diventerà Los Angeles. Nedelle
– di origini siciliane, verso le quali sente una grande
affinità - è nata e cresciuta nella Bay Area, più precisamente nella Inner East Bay; ora, ci dice, ha bisogno
di cambiare scenario. Chris è una vecchia conoscenza di chi segue e ha seguito le vicende musicali di
Frisco e dintorni. È stato membro dei Deerhoof, nonché una presenza fondamentale nel gruppo,
che ha orientato durante la sua permanenza verso
un suono più pop; probabilmente andava cercando
un’entità sonora che solo oggi, crediamo, sia riuscito a corteggiare e possedere pienamente. Di mezzo
c’è stata The Curtains, sua emanazione diretta,
un’arena dove spiegare la sua passione per la melodia e fare tentativi di ri-percorso pop.
È lì che Chris incontra Nedelle; il sodalizio musicale tra le loro due voci sembra da subito azzeccato,
qualcosa da valorizzare; ma solo nel 2007 diventa
materia per una nuova band. “Il passaggio è stato dolce; Nedelle e io abbiamo formato Cryptacize quando
abbiamo iniziato a scrivere insieme”, ci dice Chris. In
effetti la penna che confluisce in Dig That Treasure (Asthmatic Kitty), loro disco d’esordio, segna cambiamenti non indifferenti. Nedelle ci spiega
come anche il metodo di scrittura sia cambiato:
“Chris e io ci bilanciamo scrivendo insieme; è questione di chi è ispirato a scrivere in un dato momento.
Scrivere canzoni insieme può diventare difficile quando
si lavora a parti diverse di un pezzo contemporaneamente. Stiamo ancora lavorando per perfezionare il
processo. Riguardo alle melodie vocali, ci ritrovo i diversi
generi musicali in cui siamo immersi.
Tutto è pensato per seguire le evoluzioni melodiche di Chris e Nedelle. Aaron Olson e Michael
Carriera si sentono pochissimo; l’effetto d’insieme è
pastorale, gli strumenti quasi timidi. La complessità
vocale fa il paio solo con quella costruita dalla chitarra, che a tratti (The Shape Above) ricorda i Meat
Puppets di In A Car, in una versione ultrararefatta, che pecca di un po’ di dispersione. Tutto sommato Dig The Treasure non è altro che l’adattamento in studio delle prove live dei Cryptacize; ora,
racconta Chris, pensano prima a farsi il “palato” che
a suonare dal vivo.
S fumature
In Dig That Treasure fanno comunque la loro
comparsa quegli elementi che oggi, con Mythomania, possiamo affermare come tratti distintivi della
band. Voci a parte, inizia a sprigionare dalle tracce
anche quel tocco di chitarra peculiare a Chris, quasi desertico, memore comunque del post-punk più
docile (No Coins). E poi compaiono dei momenti in
cui il suono sembra spegnersi per ripartire successivamente; quelle pause, che daranno uno straordinario senso della stratificazione della struttura in
Mythomania.
“Le pause; un’osservazione divertente. Certo, usiamo le
pause, ma come tutti gli altri elementi musicali. Sembra
che la maggior parte della musica popolare abbia paura del silenzio. Noi no, se è funzionale alla riuscita di
una canzone.”
Ma sono anche i nomi d’altri che iniziano a pioverci addosso. Aldilà delle biografie, e definitivamente con lo splendido Mythomania (Asthmatic Kitty, 2009) l’ascolto dei Cryptacize che dischiude dei
mondi. Viene da pensare addirittura a scene intere,
più che a singole band. La loro musica si interfaccia
con la tradizione pop – possiamo dire soprattutto inglese – con la disinvoltura e la scafataggine di
Tune In /
17
57001²/101.+6*5&+/'05+105³
.2:%&
5176*'40.14&
5#8#6*5#8#.#5
24'(75'².#..#/#³
%&
5610'56*419
DIECI ANNI DI GLORIOSA ESISTENZA ED ORA UN ALBUM CHE DEFINISCE UNA VOLTA
PER TUTTE LE REGOLE DEL DRONE-DOOM, CALPESTANDO ANCHE L’EREDITÀ DEL
BLACK METAL. AL DISCO COLLABORANO JULIAN PRIESTER (TROMBONISTA GIÀ CON
SUN RA ED HERBIE HANCOCK), EYVIND KANG (JOHN ZORN, MIKE PATTON), DYLAN
CARLSON (EARTH), OREN AMBARCHI ED ATTILA CSIHAR.
ANCORA SCOTT HERREN (AKA PREFUSE 73), CON UN’ALTRA AVVENTURA SONICA
DEI SUOI SAVATH & SAVALAS. MELODIE DI STAMPO CATALANO E RITMI CHE
SANNO DI SUD AMERICA. I DUE NUOVI COLLABORATORI SONO PUYULEO MUNS E
ROBERTO CARLOS LANGE, ENTRAMBI MOSSI DALL’AMORE
PER SONORITÀ LISERGICHE.
&+54726
²6*'$#55*#5.'(66*'$7+.&+0)³
2+0-/1706#+06125²1765+&'.18'³.2%&
,#),#)79#4
STEPHEN MCBEAN OLTRE AD ESSERE IL LEADER DEI BLACK MOUNTAIN, È ANCHE
IL MAGGIOR COMPOSITORE DI QUEST’ALTRA FORMAZIONE CANADESE, CHE USA
TONI SICURAMENTE PIÙ RAFFINATI. PARTECIPANO MEMBRI DI A SILVER MT. ZION,
DESTROYER E JACKIE-O MOTHERFUCKER.
+06174/#))+141/#+0+6/#))+14#8'00#*#0#$+
(+4'10(+4'²6*'14%*#4&³
%&
;170))1&4'%14&5
#46*744755'..
²6*'5.''2+0)$#)5'55+105³
.2:%&
5.''2+0)$#)
$4#+0&1014²9#56'&(7<<':%'55+8'³
%&
$4#+0&10144'%14&5
*64-²/#44;/'610+)*6³%&
$.#56
(+4562'6+6'
+5+5²9#8'4+0)4#&+#06³
.2:%&
%1052+4#%;
5.''2;570²'/$4#%'³.2%&
#624'%14&+0)5
© Roger Collins
.2%&
,#*6#4+
911&'05*,+25²&15³
.2%&
*1.;/1706#+0
oggi. In questo – ma anche nei suoni – ci fa pensare
all’ambiente (più che a uscite precise) della prima
Creation, con quella capacità di restaurazione pop
con il filtro del dopo post-punk.
Soprattutto però abbiamo un doppio (e raddoppiato) input di cui parlare; non lo si focalizza subito ma i suoi sentori crescono con l’ascolto. È il
tepore freddo della Rough Trade degli inizi che si
sovrappone alla ricarica di quelle atmosfere che ci
hanno concesso i Beach House l’anno scorso.
Non solo; il suono Cryptacize non è simile in sé
alla Messthetics di allora; è come se quei principi di
dolce disordine – che mettevano sotto un’etichetta
Young Marble Giants e Raincoats - fossero
oggi riadattati per coprire non un elemento alla volta ma il modo stesso di comporre una canzone. Da
quello che ci dicono non era però questa la loro intenzione, “ma suona interessante” – ammette Chris.
E ciò ci direziona subito verso un bacino enorme
(e colmo) a cui fare riferimento nel caso in cui si
voglia sapere cosa ascoltano i Cryptacize. C’è il loro
blog - cryptacize.blogspot.com – dove è possibile
18
/ Tune In
ascoltare i mix che periodicamente il quartetto/
duetto pubblica. Un altro rione affollato. Una specie di podcast personale – o muxtape, per essere
più aggiornati coi tempi - che mescola soul (anima)
e ritmi (corpo), anche scorporati; un esempio è il
passaggio tra il calore di Pair Back Up Mass With di
The Bowling Hex e la psichedelia di Pixillation di
Gershon-Kingsley.
La chiave di lavoro sul revival ‘60 è insomma a tutto tondo, e comprende le origini come i discendenti
che già hanno fatto operazioni simili. Lo spettro di
ascolti del combo è davvero ampio; ora suoneranno
con un altro loro ascolto ricorrente, e stravagante
più degli altri, cioè Ariel Pink; e al tempo stesso
dall’EP che ci anticipano essere in uscita da qua a
uno o due mesi non ci aspettiamo altro che quelle
melodie quasi già sentite e però mai scontate; comunque isolate in una bolla di isolamento disperso
in una rete.
%.7'5²56³.2%&
%1056'..#6+104'%14&5
%4;56#.56+.65²#.+)*61(0+)*6³
.2%&
#0)7.#44'%14&5
ARRIVA LA VERSIONE EUROPEA DELL’ALBUM DI DEBUTTO
DEI CRYSTAL STILTS, UNA DELLE PIÙ FULGIDE REALTÀ
DELL’INDIE D’OLTREOCEANO. E’ L’INGLESE ANGULAR – LA
STESSA CHE TENNE A BATTESIMO KLAXONS, E BLOC
PARTY - A LICENZIARE IL LAVORO. JESUS & MARY CHAIN
INCONTRANO I VELVET UNDERGROUND CON LA BENEDIZIONE
DI IAN CURTIS?
+06174/#))+141/#%+4%1.1&').+#46+56+
/#))+14#8'00#*#0#$+/#))+1/+.#01
6$%/#))+1614+0152#<+1
41&4+)7'<²%1/+0)(41/4'#.+6;³
.2%&
.+)*6+06*'#66+%
LIGHT IN THE ATTIC PUBBLICA IL SECONDO ALBUM DEL
DYLAN ISPANICO RODRIGUEZ. COMING FROM REALITY
È STATA LA SUA ULTIMA CHANCE NELL’INDUSTRIA
DISCOGRAFICA, UN PERFETTO ALBUM POP, ARRANGIATO
IN MANIERA MAGISTRALE E AD OGGI ANCORA CAPACE DI
SCALDARE I CUORI.
70+%#&#6#+6#.+#0#)+7)0141/#%+4%1.1&').+
#46+56+
0'10²4+67#.5³%&
52+66.'4'%14&5
RISTAMPA RIMASTERIZZATA SU CD DEL PRIMO ED UNICO
ALBUM, ORIGINARIAMENTE USCITO NEL 1985, DEL GRUPPO
FIORENTINO, CAPOSCUOLA DELLA SCENA GOTHIC ITALIANA.
COPERTINA TIPO “LP MINIATURIZZATO APRIBILE”, GRAFICA
ORIGINALE E LIBRETTO DI 12 PAGINE CON LA RIPRODUZIONE
DI ARTICOLI DELL’EPOCA. CONTIENE TRE BONUS TRACKS: LE
VERSIONI 12’’ DI DARK AGE, LAST CHANCE E MY BLUES IS
YOU.
*,#.6#.+0²5.''2&470-5'#510³
%&
-+/+4'%14&5
8#²)#6*'4'&³.2
52+66.'4'%14&5
8#²$1&;5'%6+10³.2
52+66.'4'%14&5
FINALMENTE RISTAMPATE ANCHE SU LP, CON GRAFICA
ORIGINALE E IN EDIZIONE LIMITATA DI 300 COPIE,
QUESTE DUE PIETRE MILIARI DEL “NUOVO ROCK” ITALIANO
DEGLI ANNI 80. ORIGINARIAMENTE USCITE NEL 1982 E
1983, CONTENGONO, TRA GLI ALTRI, BRANI DI PANKOW,
DIAFRAMMA, LITFIBA . . .
NOSTRI ARTISTI IN TOUR A MAGGIO:
Á6*'2#+051($'+0)274'#6*'#468+8+#0)+4.531 MAGGIO: RAVENNA/HANA-BI - 01 GIUGNO: MILANO/CASA 139 Á25;%*+%68/#))+1$1.1)0#.1-1/16+8/#))+1614+0152#<+1
Á&#;51(56#6+%/#))+1/+.#01/#)01.+#/#))+1614+0152#<+1/#))+141/#+0+6
&+564+$7<+10'241/1<+10''&+<+10+
XKC(QTVGDTCEEKQ#4QOC
2KIPGVQ6GN(CZGOCKNKPHQ"IQQFHGNNCUKVYYYIQQFHGNNCUKV
YYYO[URCEGEQOIQQFHGNNCUFKUVTKDWVKQPPGYUUGORTGCIIKQTPCVGUWIQQFHGNNCUDNQIURQVEQO
8'0&+6#2'4%144+5210&'0<#1TFKPKVGNGHQPKEK1TFKPKXKCGOCKNOCKN"IQQFHGNNCUKV
4#&+#6+104'%14&5
%KTEPG%CUKNKPC
2KIPGVQ41/#
Tune In / 19
S
Wildbirds &
Peacedrums
la
regola
degli
opposti
Il jazz eurobianco ribelle ed iconoclasta:
tra adhan profani e spezzettamenti prog
- Francesca Marongiu
20
/ Tune In
ul duo di Goteborg che vi andremo a raccontare
già saprete tutto: vincitori di un premio svedese come miglior progetto jazz del 2007, beniamini della stampa, coppia d’arte e di vita, Mariam
Wallentin e Andreas Werliin hanno tutte le
carte in regola per meritare almeno un trafiletto
nelle pagine di storia riservate ai grandi. Percussionista androgino e vulcanico lui, algida, ma dall’ugola
che fonde il ghiaccio lei, si incontrano nell’Accademia di Teatro e Musica della loro città e dopo un po’,
stanchi di eseguire musica fortemente codificata, si
mettono in proprio servendosi degli strumenti che
hanno studiato per anni: voce e batteria. Ne vien
fuori una piccola pietra miliare dal nome significativo, Heartcore, dove uno spirito primigenio si va
ad incanalare nei solchi del blues del delta, dei roots,
del jazz più scomposto e tribale e di una vocalità
scura e sofisticata, ma mai leziosa. Pezzi come Doubt/
Hope o The Battle In The Water ben ricalcano la doppia personalità incendiario-intimista del duo, ma
c’è dell’altro: quel primo capitolo sembra tracciare
un simbolico punto della situazione su una serie di
esperienze “di coppia” venute alla ribalta negli ultimi
anni (dall’ avant-rock sensuale di Young People
alla proposta lirico-agogica dei Directing Hand,
fino ad arrivare ai nostri Camusi). La distanza da
quei progetti viene però marcata immediatamente
grazie ad una spiccata originalità, che non sacrifica
mai l’arte sull’altare della facile fruibilità, né tanto
meno su quello di ricerche matematiche fini a se
stesse. E, in tal senso, il paragone più appropriato
sarebbe forse quello col fenomeno Fiery Furnaces, anche solo per assecondare il piacere che
provocano gli opposti che si legano: là massimalismo e divertissement, qua minimalismo e filologia.
I due ad oggi di strada ne hanno fatta e, dopo aver
firmato con la Leaf, sempre attenta alle ricerche ad
ampio raggio tra eleganza e sperimentazione, hanno
dato alle stampe la loro opera seconda, The Snake, uscita lo scorso anno in Svezia per la Caprice
Records. Ed è soprattutto per parlare del nuovo
disco, in uscita il 13 aprile, che li abbiamo intervistati, scoprendo che i due, oltre ad essere musicisti
di talento, sono anche ben consapevoli del proprio
percorso artistico.
“La nascita del progetto, circa quattro anni fa’, è
stata fortemente liberatoria per noi: Mariam studiava
improvvisazione vocale ma era stanca di sottostare a
delle regole imposte dall’alto, così mi portò alcuni testi che aveva scritto e, a partire da quelli, iniziammo a
improvvisare. Lavoravamo su questi frammenti finché
non nascevano delle melodie o delle ritmiche che li sorreggessero. In questo processo solitamente tendiamo a
togliere anziché aggiungere elementi. Siamo profondamente convinti che la grande musica sia quella che non
dice tutto, che lascia spazio all’immaginazione di chi
ascolta. Una sorta di addizione nella sottrazione, che è
data anche da quello che l’ascoltatore può aggiungervi
mentalmente (una linea di basso, di piano e, perché no,
una chitarra stoner!)”.
è così che Andreas ci introduce nell’alveo creativo dei Wildbirds & Peacedrums, in cui ogni takes
rappresenta un passo in avanti nell’espressione di
ciò che la loro musica evoca. Anche The Snake ha
avuto una simile gestazione, che quando una formula
funziona tanto vale premere l’acceleratore e scrivere subito il seguito, tanto più che, grazie ai proventi
del premio svedese, i due hanno avuto la possibilità
di lavorare in uno studio ben attrezzato per tutto il
tempo necessario a comporre e registrare. “Questa
volta abbiamo avuto la possibilità di usare strumenti tradizionali del Sud America come la kalimba o lo steelpan,
ad esempio. In generale ci interessa molto il modo in cui
i vari timbri di cordofoni o idiofoni riescono a interagire
con quello della voce e delle percussioni (pensiamo ad
un pezzo come So Soft So Pink). Ma non siamo degli studiosi di etnomusicologia, né abbiamo la passione
per l’organologia, semplicemente cerchiamo di rievocare
istintivamente le radici da cui proviene la musica che ci
appartiene. La denudiamo, spogliando noi stessi di tutti
quegli orpelli che non permettono ad un artista di realizzare musica ‘coraggiosa’ e autentica”.
La voce di Mariam è stata oggetto di numerosi
dibattiti su carta e on line, accostata soprattutto alla
vocalità nera e viscerale di Abbey Lincoln e al
jazz sperimentale di Patty Waters. “Tra le due è
Abbey Lincoln ad avermi ispirato di più, la sua Freedom
Suite con Max Roach è un grandissimo disco. Per il resto
sono cresciuta ascoltando gente come Chet Baker, Nina
Simone, Aretha Franklin, Sarah Vaughan, Elvis Costello,
Mark Kozelek e molti altri. Ciò che mi influenza è un
mix di tutto ciò. Io amo le voci ‘libere’ come quelle di Lindha Kallerdahl, Sidsel Endresen, Diamanda Galas, Maja
Ratkje, voci che mi spingono a gridare o a cantare con
un filo di voce, ad andare in alto o molto in basso”. E,
per quanto riguarda gli inserti melismatici presenti
nel nuovo disco (penso a pezzi come Island o So Soft
So Pink ), Mariam ammette l’ influenza delle sue
origini mediorientali in certe coloriture vocali, ma al
di là dello studio di tecniche particolari: “Mio padre
Tune In /
21
è persiano e in qualche modo tutto ciò ha influenzato
la mia musica. D’altro canto io non ho mai studiato le
tecniche vocali nordafricane, semplicemente inserisco
degli abbellimenti ‘falsificando’ un certo tipo di vocalità!
Quello che faccio è sempre al servizio dell’efficacia evocativa del pezzo.”
Anche per la formazione di Andreas sono stati
fondamentali i grandi dischi che ascoltava il padre,
principalmente musica svedese degli anni Settanta,
dai National Teatern a Bo Hansson. E, a proposito degli artisti che lo hanno influenzato maggiormente, dichiara: “Io traggo ispirazione da molta
musica diversa e da altre forme d’arte. Ultimamente ho
capito che c’è un minimo comun denominatore nella
musica che mi piace: riesce ad essere senza tempo e ad
accogliere idee nuove, senza sacrificare l’onestà. Penso
agli Earth, a Miles Davis, ai Talk Talk, ai The Thing, ai My
22
/ Tune In
Bloody Valentine e a Micachu, ad esempio.”
Tornando al disco, se i testi di Heartcore descrivevano la tristezza, la speranza e l’illusione, in
The Snake si parla della famiglia, delle relazioni,
di frustrazioni, dubbi e ricerca. E se il vecchio disco
esprimeva un’urgenza forte ed erano le radici nere a
prevalere, nel nuovo la scrittura risulta più variegata.
Ascoltandolo, non si può non notare come la pietra
minimale rifletta le varie anime dei Wildbirds &
Peacedrums in maniera più netta che in passato:
a partire dalle terre desertiche di Island che tremano al grido di fragilità di My Heart, tra un intermezzo heartcoriano come There Is No Light e il vezzo
pop vagamente studentesco di Chain Of Steel. E loro
non si impongono a tutti i costi di essere attuali, nè
si confrontano troppo con ciò che li circonda. “Ci
piace la scena svedese, ormai florida da molti anni, e
ci sentiamo vicini a
tutti coloro che non
si accontentano di
percorrere strade
già battute. Il rischio
è un elemento essenziale nella nostra
musica”.
E se i Nostri non
stanno lì a guardare se somigliano
un po’ troppo a
questi o a quelli, noi ritroviamo
nelle maglie della
loro musica l’irriverenza e la permeabilità di gruppi
come Xiu Xiu,
Fiery Furnaces
o Indian Jewelry, coniugata ad
una rilettura iconoclasta del colto,
molto ricorrente
nei migliori artisti
degli ultimi anni
(Joanna Newsom, Hjaltalin,
gli ultimi Parenthetical Girls).
C’è poi la minimal
wave, rievocata so-
prattutto dalle melodie di Mariam, di quando in
quando posseduta dallo spettro di Siouxsie, che
è un elemento fondamentale per comprendere una
certa attitudine punk del duo. Un andirivieni spaziotemporale in cui i Wildbirds non corrono mai il rischio di spersonalizzarsi. E quando gli chiediamo se
è oggi necessario possedere un apprezzabile bagaglio tecnico per poter realizzare musica “coraggiosa”, Mariam incalza: “Non necessariamente! Ci sono
molti modi per diventare bravi ;). Penso però che per
entrambi sia importante avere il controllo sugli strumenti, così da poterci muovere più agevolmente in territori inesplorati. Noi amiamo i nostri strumenti e io amo
usare la voce in molti modi diversi che riflettono i miei
vari stati d’animo. Ma qualche volta mi piace anche fumare e suonare strumenti che non conosco bene, come
lo zither o lo steel drum (tamburo d’acciaio, n.d.r.)”.
In chiusura, chiediamo ai due se sono soddisfatti dei
risultati ottenuti fin’ora, sia a livello artistico che di
popolarità. “Siamo molto contenti, suonando in tante
città diverse abbiamo capito che abbiamo molto da
dare. La nostra musica è molto coinvolgente dal vivo e
ogni sera proponiamo qualcosa di diverso, in quanto non
rispettiamo in tutto e per tutto una scaletta prestabilita.
L’energia che riusciamo a comunicare e a ricevere dal
pubblico è un elemento fondamentale.”
E, a proposito del terzo album.“Ci stiamo pensando, sta iniziando a crescere lentamente. L’unica cosa che posso dirti è che sarà meraviglioso! Sia
Heartcore che The Snake erano più un documento di ciò che noi eravamo nel momento in cui li abbiamo scritti, impulsivi, passionali, onesti. Ma il terzo album scaverà più a fondo, o volerà più in alto!”
E a noi, a questo punto, non resta che rimanere in
attesa, che di gruppi così, negli ultimi anni, se ne
sono visti davvero pochi.
Tune In /
23
Fonal Records
Fonal Records, marchio che in maniera sintomatica rappresenta i nuovi assetti
del rock nordico. Sami Sänpäkkilä è il depositario della sigla, ragazzo minuto
con barba curatissima che vive ai margini della foresta di Tampere, lontano dal
trambusto del mondo occidentale.
- Luca Collepiccolo e Antonello Comunale
24
/ Drop Out
R
icordi sbiaditi di un vecchio calcio ancora
non assoggettato e piegato alle multinazionali, quando tutti gli stati del vecchio continente avevano almeno un rappresentante
nelle rispettive categorie UEFA, si fosse trattato di
Coppa Dei Campioni, Coppa Delle Coppe o Coppa Uefa. E spesso l’effetto esotico era proprio stimolato dalla presenza di squadre improponibili, non
solo belligeranti 11 dall’estremo oriente europeo,
ma anche formazioni con passaporto nordico. Ricordo proprio come in un fermo immagine secolare
la presenza dell’Ilves Tampere, una delle realtà più
gettonate del campionato finlandese, spesso vittima
sacrificale al cospetto di ben più blasonati team del
centro Europa o dell’ italietta pre-calciopoli. Ferma
restando la nota di colore, quel clima di docile e
trasparente scoperta pervade l’incontro mediatico
con Fonal Records, marchio che in maniera sintomatica rappresenta i nuovi assetti del rock nordico.
Sami Sänpäkkilä è il depositario della sigla, ragazzo
minuto con barba curatissima che vive ai margini
della foresta di Tampere, lontano dal trambusto del
mondo occidentale. La sua una visione antica, fortemente legata al territorio, solo parzialmente intaccata dalle urgenze del più sperimenale e visionario
rock anglofono. È importante collocare la label in un
territorio franco e nel corso della breve intervista
con Sami, la finalità è proprio quella di far emergere
un sentimento altro, distante dall’urgenza commerciale della musica indipendente contemporanea.
Tampere è la terza città della Repubblica di Finlandia (o anche Suomen tasavalta) e conta una popolazione che supera a malapena le 200.000 unità.
In Suomi tradizone classica e rock sono sempre andate a braccetto, generando ibridi anche fortunati
dal punto di vista commerciale, capaci di proiettare
l’intero paese sotto i riflettori dei media internazionali. Del gothic metal locale e di gruppi poster tipo
Nightwish od Him non abbiamo un’alta considerazione, del resto anche alla Fonal le chitarre distorte
non sono esattamente il piatto della casa, con l’eccezione dei prolifici Circle - che per l’etichetta hanno licenziato un singolo - l’estetica hard-rock non è
per nulla contemplata da queste parti. Vanno semmai recuperati altrove i punti cardine di una musicalità così eclettica, con oltre 60 numeri di catalogo ed
una vitalità per nulla circoscitta nei 14 anni di fiera
attività underground (l’etichetta nasce ufficialmente
nel 1995, come estensione ‘casalinga’ dello stesso
Sami). La musica classica di un gigante come Jean
Sibelius si scorge solo all’orizzonte, come del resto
le accattivanti geografie del jazz libero di due pesi
massimi locali quali Juhani Aaltonen (fiatista classe
‘35, per sentirlo in azione consiglio all’occorenza le
due belle ristampe su Porter del pianista elettrico
Heikki Sarmanto) ed Edward Vesala (leggendario
batterrista noto ai più per gli album su ECM e le
collaborazioni con mostri sacri quali il polacco Thomasz Stanko ed il norvegese Jan Garbarek).
Ma i veri antesignani del ‘collasso emotivo e
strutturale’ sono da rintracciarsi altrove, in casa
Love Records sicuramente. Label nata nel 1966
per volere del giornalista Atte Blom, del batterista
Christian Schwindt e del compositore Henrik Otto
Donner ed anticipatrice oltre che dei correnti trend
freakadelici anche di un diverso sentire etnico e di
un approccio ‘verticale’ al jazz d’avanguardia. Scorazzando attraverso raccolte del calibro di Eri Esittaja (Psychedelic Phinland – Finnish Hippie & Underground Music 1969-1974) o Arktinen Hysteria
(Suomi-Avantgarden Esipuutarhureita) si scorgono
in nuce i germi della nuova proliferazione etnopsichedelica posta in essere da Fonal. Un eredità
conseguenziale. Anche del compositore elettronico
Erkki Kurenniemi - che per Love ha licenziato l’antologico Aanityksia – non solo i Pan Sonic sembrano
aver seguito la rotta, lo stesso Sami con l’alter ego
solista Es, sembra alludere parzialmente alle trovate
analogiche dell’insuperato maestro.
Detto questo è importante stabilire la posizione quasi privilegiata di Fonal, distante da qualsiasi
sudditanza intellettuale, fuori dalle contingenze
mercantili e fiera nell’inseguire una propria poetica.
Quanto proposto negli anni da gruppi quali Kiila,
Kemialliset Istavat, Islaja, Lau Nau o Paavoharju è
di dominio pubblico. Le stesse eminenze grigie del
rock americano ed europeo (Ecstatic! Peace, Locust
e Fat Cat) hanno fatto carte false per aggiudicarsi
le performance part-time di questi ispirati cantori
bucolici e lisergici, segno di un’evidente fascinazione per il profilo inedito di questi artisti. Del resto
nell’ora della globalizzazione un ritorno in flagrante
sui luoghi della world music può assumere connotati davvero stravaganti, perchè a voler essere pignoli l’opera confezionata da Fonal è in forte odore
etno-rock. Ciò non vuol dire impacchettare bellamente un disco dopo aver distrattamente assorbito
le istanze di un Graceland o di un Remain In Light.
Qui il discorso è più ampio, ogni artista in catalogo risponde ad un preciso DNA, quasi a voler
seguire un tradizione orale (vedremo come l’idioma
inglese è contemplato in rarissimi casi), che dice di
Drop Out /
25
un’immersione totale nella wilderness e di una pop
music che diventa oggetto non identificabile. Un respiro ancestrale potrebbe essere quello dei Paavoharju di Laulu Laakson Kukista, disco che insegue
un’idea di musica periferica, tra interferenze elettroniche, beats da dancefloor evanescente, canzone
folk strappalacrime e turkish delight (paradosso dei
paradossi queste musiche potrebbero mandare fuori di testa l’Hendrix turco Erkin Koray).
Addirittura una manifestazione à la page come il
Sonar ha dedicato uno showcase all’etichetta di Sami,
segnali di una distensione politica o politica dell’investimento estroso? Non è questo il punto, sono i
riconoscimenti puntuali di tutti i media internazionali
a sancire l’interesse nel progetto, che ancora una volta - preme sottolinearlo – non è il resoconto su una
scena che scimmiotta i più appariscenti cugini inglesi
od americani alla deriva dell’isola di Wight, bensì un
manifesto coerente di come produrre rock lontano
anni luce dagli stereotipi. Partendo magari anche dalla
cura maniacale con cui vengono impacchettati i singoli prodotti, che rispondono ad una chiara esigenza
estetica, puntuale come forse solo quella della canadese Constellation. Eliminato il jewel case i dischi Fonal sono sempre racchiusi in stilose confezioni cartonate, che anche distrattamente vanno a sollevare un
universo di riferimenti ancestrali. Dischi che appunto
non hanno l’outlook ‘rock indipendentista’, semmai
piccole scatole cinesi pronte a narrare di antichi rituali, ogetti che colgono la nostra fugace immaginazione, di soppiatto.Anche di questo abbiamo in breve
ragionato con lo stesso Sami.
Quali erano gli obiettivi che ti eri posto
con l’etichetta agli esordi?
Non c’era altro obiettivi se non quello di pubblicare
la mia personale musica. L’orientamento era molto
casalingo agli inizi (un sintomatico grassroots operations viene utilizzato come termine di paragone,
ndi) e l’idea alla base di puro divertimento. Abbiamo
registrato della musica ed ho voluto fare tutto da
me, in completa autonomia. Non ho mai pensato ad
ottenere un contratto discografico, l’idea non mi hai
mai sfiorato. Sono stato sempre cosciente del fatto
che la musica da noi prodotta avrebbe comunque
avuto un importanza davvero marginale.
Era intenzionale l’idea di pubblicare unicamente formazioni finlandesi? Ti apriresti mai ad artisti di altra nazionalità?
Non è stata intenzionale la scelta. Ma mi sento mol-
26
/ Drop Out
to vicino agli artisti finnici quindi è questo il mio
ruolo al momento.
Hai una sorta si contratto in esclusiva con
i tuoi artisti o permetti loro di pubblicare anche per altre etichette (mi sembra
lapalissiano il caso di Islaja che ha anche
inciso per la Ecstatic Peace!di Thurston
Moore)?
Sì, questo non è affatto un problema. Solitamente
abbiamo l’esclusiva per la pubblicazione di un album
completo su Fonal, quindi se gli artisti hanno la possibilità di pubblicare in altri formati più piccoli per
altre etichette non c’è alcun tipo di problema. Lo
stesso dicasi per i dischi dal vivo. Non ho un atteggiamento protezionista nei confronti degli artisti. Se
decido di pubblicare un album, mi auguro che porti
esclusivamente il marchio Fonal, anche se abbiamo
licenziato alcuni dischi per altre labels. Ma ora che
sono concentrato sul formato ‘esteso’ non c’è più
bisogno di questi espedienti.
Anche se può suonare obsoleto, sono portato a catalogare la Fonal come un’etichetta di world music, piuttosto che
come l’ennesima compagnia indie-rock.
Se avessi un negozio di dischi non farei
alcuna fatica ad inserire i vostri dischi nel
settore ritmi globali...
Per me va bene, non credo sia errato. Ogni disco
potrebbe essere segnalato in una categoria diversa.
Penso a questa musica generalmente come ad un
pop dal taglio sperimentale.
Il progetto Es è ancora la tua principale
attività o stai lavorando ad altro al momento?
Sì, gli Es sono la mia principale attività musicale.
Mentre Fonal è il mio lavoro a tempo pieno. Aldilà
di questo cerco di produrre dei video musicali – è
accaduto per Paavoharju – e dei piccoli cortometraggi nei ritagli di tempo. Questo è il modo in cui
occupo il mio tempo al momento.
Qual’è la tua idea di musica popolare e
quali sono state le etichette e gli artisti
che hanno avuto un grande impatto su di
te?
Ho ammirato etichette che sono parse coerenti
negli anni con le loro pubblicazioni. Una sorta di
visione in cui poter credere. Ascolto una montagna
Sami Sänpäkkilä
Drop Out /
27
di indie pop ed al contempo musica sperimentale e
minimalista
Pensi che un audience più ampia si stia
approcciando alla Fonal Records? Almeno ora che importanti media come The
Wire, Dusted magazine o Pitchfork hanno riservato numerose attenzioni ai tuoi
dischi...
È quello che è accaduto 2 anni fa. Ora lo della Fonal
è piuttosto stabile. Se qualcosa riceve un’attenzione minore, ciò è dovuto al fatto di non essere più
trendy. Mi auguro ci siano altrettante buone pubblicazioni che possano consentire all’etichetta di crescere ulteriormente, vorrei essere capace di creare
maggiori opportunità per gli artisti di cui pubblico
materiale. è stata sempre una grossa difficoltà poter
parlare di questioni di ‘successo’, dato che non ho
proprio i minimi termini di paragone. Ho sempre
dovuto cercare la soluzione più difficile per portare
a termine il lavoro.
Esiste una carta d’identità dell’ascoltatore medio di Fonal?
È un pò difficle immaginarlo, ma direi che non c’è
una grossa distinzione tar i sessi e l’età è idealmente
compresa tra i 20 ed i 35 anni
Ogni aspetto delle tue pubblicazioni è
così preciso, le copertine ed i packaging
così curati nel dettaglio. Rispetto a questo sforzo non comune mi chiedevo anche quale fosse la tua posizione rispetto
al downloading ed ai conflitti quotidiani
rispetto alla musica disponibile gratuitamente.
Cerco di non pensarci troppo onestamente. Mi piacciono i vinili e le confezioni in cd cartonate, il mio
desiderio è che questi formati non scompaiano.
Dove vedi la tua etichetta da qui a 5 anni?
Sei certo di aver raggiunto tutti i tuoi
obiettivi ad oggi?
Non sono mai stato abituato ad avere dei grossi
obiettivi. Mi auguro di essere ancora qui, su queste
posizioni da qui ai prossimi anni.
Hai mai avuto qualche sogno proibito?
Voglio dire nessun artista o progetto che
avresti voluto sponsorizzare con la tua
etichetta?
No, davvero. Sono felice con le mie pubblicazioni ad
oggi, completamente soddisfatto di come siano state lavorate le cose. Questo l’ho detto dagli inizi, mi
fermerò nel momento esatto in cui sarò costretto
a pubblicare cose che non mi piacciono.
Occhio al catalogo...
Islaja
“Merja è un nome troppo personale per me… È difficile aggiungere glamour a qualcuno che conosci così bene.
Islaja è più misteriosa e non ha nemmeno niente di artificiale”. La prima donna di casa Fonal, al secolo Merja
Kokkonen, in arte Islaja, esordisce nel 2004 con Meritie che altro non è se non un distillato delle primissime registrazioni fate avere a Sami Sämpäkkilä un suo ex compagno di studi in quel di Helsinki. Sembra che
la cosa non sia stata immediata, Sami stava lentamente mettendo in piedi il catalogo della Fonal: “Inizialmente
non ho mandato le mie prime registrazioni a nessuno. Un mio amico mi disse però della Fonal e dal momento che
io e Sami Sämpäkkilä avevamo studiato nella stessa scuola, un giorno gli chiesi di prenderci un caffè insieme e ne
approfittai per fargli sentire il mio nastro. A lui piacque ma non mi promise nulla. Quando Meritie fu finito mi promise di farne un mastertape e allora finalmente realizzò che avrebbe voluto distribuirlo con la sua etichetta. Credo
che fossimo entrambi realmente contenti della cosa”. La musica di Islaja inizialmente non si discosta di un millimetro dalle coordinate della scena: strumenti desueti, costruzioni folk sempre a due passi dall’astrattismo
avantgarde, canto umorale in lingua autoctona. Nel 2005 Palaa Aurinkoon è un degno capitolo secondo,
ma il salto di qualità lo compie nel 2006 con Ulual Yyy che segna un parziale allontanamento dal forest
folk finlandese avvicinandosi verso una forma di canzone d’autore molto colta e femminile, con venature
persino jazz (Nico, Bridget Fontaine, Nina Simone).
Quali saranno le tue prossime uscite?
Il nuovo disco degli Es: Kesämaan lapset è un mix
tra i miei ultimi album Sateenkaarisuudelma e Kaikkeuden kauneus ja käsittämättömyys. Ci sono alcuni brani pop con tanto di cantato ed altri con
lunghi archi di muro del suono. Non è ambizioso
come il mio ultimo doppio album, mi auguro anzi
che quest’ultima pubblicazione possa adattarsi ad
un caldo party casalingo, anche a due (risate tra le
righe, ndi)
© Susanna Majuri
Sami Sänpäkkilä
isl aja
28
/ Drop Out
Drop Out /
29
Kemialliset Ystävät
Paavoharju
30
/ Drop Out
© Jyri Pitkänen
Kemialliset Ystävät
Sono i più liturgici e mistici della scena e vengono da un piccolo centro nel nord della Finlandia, chiamato
Savonlinna. I Paavoharju ruotano intorno a due fratelli, Lauri e Olli Ainala. che sono cristiani luterani devotissimi, da qui tutta un’estetica religiosa, con tanto di ricerche bibliografiche / fonologiche su canti sacri
degli anni ’20 / ’30, con frammenti presi e inseriti nelle composizioni della band nel disco di debutto Yhä
hämärää. I Paavoharju suonano davvero come poche altre cose in giro, con un sound che è finissima e
articolata filigrana di piccoli dettagli e un taglio etereo e incantato che ha presto mandato in visibilio la
maggioranza silenziosa di ascoltatori freak di questo primo scorcio di secolo. Citando la press di Fonal: “The
sound is something between Bollywood music, church hymns, beautiful pop tunes and ambient esoteric noises. The
music is unlike anything heard on this planet yet still oddly comforting”. Complice anche il trend che nel frattempo si è addensato intorno all’etichetta di Sami, la band dei fratelli Ainala gode di uno dei maggiori battage
pubblicitari mai avuti da una gruppo finnico, finendo con recensioni entusiaste in testa a tutte le playlist del
2004. Ci riprovano quindi nel 2008 con il successivo Laulu laakson kukista mancando parzialmente il
bersaglio.
© Irwin Badman
Dietro la sigla Kemialliset Ystävät, che in finnico significa “Fratelli chimici”, si nasconde lo strambo genio di
Jan Anderzén, attivo anche in proprio con la sigla Tomutonttu, che per intenderci significa “gnomo di polvere”… è quindi abbastanza chiaro quale siano le premesse della musica prodotta, ovvero uno stiracchiato e
ultraterreno tappeto psichedelico con assonanze che vanno dai primi Pink Floyd al prog bello e buono. Gli
Ystavat sono quasi subito diventati i best seller del catalogo e sono quelli dal profilo più internazionale potendo vantare pubblicazioni non solo su Fonal, ma anche su etichette estere dalla denominazione controllata come Fusetron, Beta-Lactam Ring, Jewelled Antler, Celebrate Psi Phenomenom. Nel 2004 il loro secondo
album Alkuhärkä diventa un piccolo caso underground facendoli diventare i primi portabandiera della
scena finnica. La palette di soluzioni sonore messe in essere dalla band può essere incredibilmente varia:
da composizioni dal taglio più etereo si passa, senza soluzione di continuita a groove ritmici dal sapore di
giungla. Un umore pan-etnico costantemente in primo piano e un quadro d’insieme che sa di droga e oblio
dalle miserie ultraterrene. Quanto a Tomutonttu il discorso non cambia poi molto, Anderzén è una sorta
di novello pifferaio magico. Di recente ha anche suonato per bambini e scolaresche nel planetario della sua
città natale, Tampere, oltre ad aver collaborato con gente del calibro di Mike Bernstein (Double Leopards,
Religious Knives), Joshua Burkett, Tara Burke (Fursaxa), The Skaters, Glenn Donaldson (Jewelled Antler).
Paavoharju
Drop Out /
31
Lau Nau
The Others… i minori dell’etichetta
32
/ Drop Out
© Sami Sänpäkkilä
l au nau
© Susanna Majuri
Se Islaja è la femme fatale della Fonal, Lau Nau è la piccola fiammiferaia bisognosa di un po’ di calore. La
differenza tra le due regine del nord non è di poco conto e si riflette anche nella musica. Laura Naukkarinen,
vero nome di Lau Nau, nonostante la giovane età è una delle figure centrali della scena forest folk finlandese.
Collabora ad un gran numero di progetti musicali tra cui Kiila, Päivänsäde, Anaksimandros, Avarus, Maailma,
Chamellows e il trio tutto al femminile Hertta Lussu Ässä, in compagnia di Islaja e Kuupuu, di contro la
maggior visibilità la ottiene proprio da sola esordendo nel 2005 con Kuutarha un concentrato arcano e
lirico di folk nordico, fragile e complesso come un origami giapponese e pieno di stravaganze sonore, compiute con strumenti tra i più desueti e originali: “bicchieri per marmellate colorate”, “megafoni per streghe
urlanti”, “lattine di birra”. Complice anche l’esser diventata mamma, Laura si trasferisce successivamente
dalla metropolitana Helsinki in un piccolo centro nella provincia del nord della Finlandia. Il risultato di
questo cambiamento e il secondo album Nuukuu(che in finnico significa “sonno”), in pratica una raccolta
di ninna nanne intime per baite e focolari, che aumenta di molto la potenza immaginifica della sua musica
acquistando tantissimo sul piano mitico ed evocativo.
Non di sola psichedelia folk vive il catalogo
della Fonal. Sami è abbastanza intelligente da
cercare ogni tanto di diversificare il portafoglio
della sua proposta, evitando contemporaneamente di allargare troppo lo spettro perdendo
il vantaggio competitivo dato da una nicchia
che da Fonal sembra volere sempre gli stessi
suoni. Sotto quest’ottica oltre i quattro nomi
di cui sopra, che un po’ danno una fisionomia
di insieme del “Fonal sound” si inseriscono altre voci, che cercano di allargare il discorso
e di attrarre un po’ di visibilità. Tra questi si
segnala il caso di Fricara Pacchu, il quale
addirittura inizia a fare musica come rapper
nei Backdoor Funkers, scioltisi prima di produrre alcunché di rilevante. Lasciato da solo a
trafficare con strumentali in odore di motorick kraut e stramberie assortite, Fricara Pacchu riesce nell’impresa di far sparare a Sami
la boutade promozionale d’ordinanza quando
sentenzia che è la miglior cosa che egli abbia
sentito dai tempi dei Faust Tapes… Ancora più
Eleanoora Rosenholm
eclatante il caso di Eleanoora Rosenholm,
che traffica con cose del tutto desuete da queste parti, come elettro disco e pop wave, in un modo del tutto assimilabile a gente come ABBA, Madonna
e Kylie Minogue. Una roba da non crederci se non quando si ascoltano le note di Vainajan Muotokuva
disco di debutto, datato 2007, che vanta anche Maailmanloppu una piccola hit in patria con tanto di video
controverso (diretto dallo stesso Sami).
Altri suoni sintetici arrivano dal quartetto dei Shogun Kunitoki, che si possono tranquillamente allineare ad una deriva precisa del recente trend neo kraut, che rigetta laptop e strumentazioni tecnologiche, per
riprendere i vecchi sintetizzatori valvolari e inscenare vignette acide come i vecchi maestri teutonici degli
anni ’70. Parziali compagni
di vedute in questo senso sono i TV-Resistori,
che suonano un po’ come
la risposta finnica agli Stereolab. Il richiamo ai sintetizzatori kraut e alla tastierine vintage procede di
pari passo con il disegno di
ariette pop, un po’ naive un
po’ kitch. Il catalogo della
Fonal è quindi abbastanza
ricco da proporre anche
rock anni ’60 con tanto di
influenze beatles e trovate
a due passi dai Blur di Risto... shogun kunitoki
Drop Out /
33
I
luoghi e le passioni
C
C’è del marcio
nelle Marche
C’è del marcio nelle Marche? Troppi indizi
per non costituire una prova.Troppi suoni
e troppo rumore per non essere ascoltati.
Troppa attività per passare inosservata. C’è
del marcio nelle Marche e non potevamo
esimerci dal rubare le parole al bardo
inglese per tentare di sondare, parzialmente
e senza pretesa di completezza, quello
che sta succedendo in quello spicchio
d’Italia troppo banalmente definibile come
provincia…
Jesus Franco & The Drogas
34
/ Drop Out
- Stefano Pifferi
oordinate socio-geografiche spicciole.
A nord l’assordante brusio del divertimentificio più noto d’Europa (o almeno,
quel che ne resta dopo i fasti dei ’90). A
sud l’Abruzzo, terra silenziosa smossa anch’essa da
impeti rock non banali (AfricanTape e (C)lapDance,
giusto per far due nomi a noi cari), oltre che da
devastanti e tristi rocchenroll del sottosuolo. Dietro
alle spalle la corona gentile degli Appennini che degradano dolcemente verso quel mare che apre ad
oriente e che tanta ispirazione contò nella poetica
leopardiana.
A differenza, però, dell’isolazionismo del tanto
vituperato – almeno dagli studenti delle superiori – gobbo di Porto Recanati, nei giovani del luogo
c’è una notevole tendenza all’aggregazione, spesso
e volentieri in nome di un suono tutto fuorché regionalistico.
Una volontà aggregativa ferma e decisa che fa
nascere collaborazioni musicali e travasi stilistici e
di personale, amicizie nel nome del rock e festival
improvvisati dai nomi attraenti e al tempo stesso ludici. Prima che arrivi la polizia dell’estate 2008
targato Valvolare, ad esempio: 4 serate nei centrali
giardinetti delle ex-carceri di Jesi che hanno visto
per ogni serata due gruppi locali – Lleroy/Bhava,
Butcher Mind Collapse/Gerda, Jesus Franco & The
Drogas/Oginoknaus, Lebowski/Guinea Pig, queste
le coppie – assistere e confrontarsi coi forestieri
Oshinoko Bunker Orchestra, Putiferio, Microwaves
With Marge e Jealousy Party in incendiari e chitarristici live. Oppure il Gaiomeriggio, l’happening di outmusic pomeridiano a scadenza mensile (in attuazione mentre scriviamo) gestito da un’altra congrega
di folli di stanza a Senigallia, il Marinaio Gaio. Meno
chitarre in senso stretto e più attenzione alla ricerca a cavallo tra elettroacustica e world music afasica,
come dimostra la presenza di interessanti progetti
autoctoni e forestieri: Above The Tree (Marco
Bernacchia dei M.A.Z.C.A. in solitaria, anche artista
con mostre personali alle spalle), Il Mototrabasso,
Joseba Irazoki. Non esistono confini, né di genere,
né tanto meno geografici, sembrano comunicarci da
quelle parti.
O ancora sempre all’insegna del faccia a faccia
tra indigeno e non – caratteristica fondamentale e
irrinunciabile per l’ambiente marchigiano, a quanto
sembra – il festival invernale, giunto alla fase #2, Non
torno più normale il cui sottotitolo (Rassegna itinerante di musica straniante) rende perfettamente l’idea
di continuo movimento tra Jesi (Circolo Anarchico), Ancona (Thermos Club), Senigallia (Macondo)
e di effetto sull’ascoltatore. Nella fase #1 (gli ultimi
mesi del 2008) spiccavano i release-party di Jesus
Franco & The Drogas (insieme a Satantango) e
Lebowski (coi R.U.N.I.), oltre che le accoppiate in
nome del post-punk furioso di Bhava e Trans VZ
e del noise sull’orlo del baratro di Butcher Mind
Collapse e Plasma Expander.
Non da meno la fase #2, in cui a rispondere al
fuoco incrociato degli ospiti Fuh e Dead Elephant
(da Cuneo, altra scena furiosa e rumorosissima da
indagare), Zippo (da Pescara) e Lucertulas (da Padova) sono 4 giovani formazioni jesine in fissa col post
(rock, punk, core, grunge): Paperoga, Mondrian
Oak, .cora e 4Misura.
Infine, l’ultimo arrivato. Emersioni, collaborazione
tra Bloody Sound e Hot Viruz, col supporto di altre
realtà tra cui la già citata Valvolare, occuperà l’intera
primavera al Thermos di Ancona allargando proprio
in questi giorni i confini regionali a glorie nazionali
(Uochi Toki e Zen Circus, tra gli altri) e internazionali:
gente come Mi Ami, USA Is A Monster, Experimental Dental School, gli oriundi Ulan Bator, calcherà i
palchi del locale anconetano per devastare orecchie
e far bruciare ampli proprio come nella miglior tradizione locale. Si sarà capito, da questa lunga carrellata di nomi e incroci. Si parla in definitiva di una
serie incredibile di appuntamenti che non offre solo
serate di ottima musica di matrice genericamente
“rock”, ma evidenzia anche il brulicare irrefrenabile
di un sottobosco che è un vero e proprio formicaio di suoni guitar-oriented. Per i forestieri nomi di
punta italiani e/o stranieri, c’è sempre almeno una
coppia di progetti indigeni pronti a dare man forte
e – importantissimo – mai sfigurare. Che sia a colpi
di furente noise-rock devastato, post-punk poetico
e rurale, grezzo rock dei primordi o in progetti di
elettroacustica rarefatta, poco importa. C’è energia,
c’è passione, c’è tensione (pro)positiva; ed esce da
ogni poro di un sottosuolo marchigiano mai così
vivo e pulsante.
Tutto nasce in un perimetro tutto sommato
ristretto. Di provincia che tale non si sente e dimostra ad ogni live, incisione e/o iniziativa di avere
pienamente ragione. Un quadrilatero a ben vedere,
racchiuso in una manciata di km quadrati in cui si
coagula un concentrato di sporco rock rumoroso, sguaiato e slabbrato che ci fa tornare in mente
per violenza quello targato Nyc inizi dei ’90 e per
origine “periferica” quelli della Minneapolis di Tom
Drop Out /
35
Hazelmyer e della sua AmRep o della Austin, sede
della Trance Syndicate di King Coffrey dei Butthole
Surfers.
In mezzo la Ancona di Bloody Sound Fucktory. A nord e sud, Senigallia – base di Marinaio
Gaio e About A Boy – e Macerata del dolce
orsacchiotto Sweet Teddy a fare da supporto.
A guardare le spalle, appena nell’entroterra c’è Jesi,
quartier generale degli svalvolati di Valvolare, al
tempo stesso etichetta, booking e sala prove.
Come ci conferma Nicola Amici (o Nik Droga che
dir si voglia) – chitarrista proprio per Jesus Franco
& The Drogas oltre che per Butcher Mind Collapse
– Valvolare prende il via per volontà sua e di Riccardo Franconi (sempre BMC e Lebowski) sull’onda
lunga dell’esperienza Bloody Sound, l’etichetta anconetana fondata da Jonathan Iencinella (voce dei
Butcher Mind Collapse e gestore del Thermos ad
Ancona) e Andrea Refi (grandissimo grafico r’n’r
e voce dei Jesus Franco & The Drogas, nonché dj
r’n’r attualmente coi Detroit Mafia Sound System):
L’associazione VALVOLARE nasce nel maggio 2005 con,
allora, l’unico scopo di creare e gestire una sala prove
pubblica per i gruppi della zona dove si potesse far musica a basso costo. Ironia della sorte è che tutti i membri
fondatori di Valvolare avessero già delle sala prove con i
propri gruppi di appartenenza […]. Non è infatti solo
la necessità di avere una sala prove comune, a dir la
verità, a smuovere gli svalvolati. C’è anche il discorso legato ad un percorso di crescita del territorio…
vuoi perché siamo parecchio legati alla nostra cittadina,
vuoi perché era già da un paio di anni che avevamo
intrapreso un percorso di sensibilizzazione nei confronti
36
/ Drop Out
dell’Amministrazione Comunale (anche tramite petizione e raccolta firme) alla fine siamo riusciti a realizzare il
nostro intento. Da lì all’avviare un’etichetta indipendente
sono trascorsi un paio di anni. Verso la fine del 2007,
infatti, si sono verificate delle situazioni propizie che ci
hanno spinto a fare “di necessità virtù”: i gruppi di cui
fanno parte i membri del direttivo dell’associazione, infatti, avevano tutti registrato un disco o erano in procinto
di farlo ed avevano comunque l’esigenza di trovare una
label.
Detto, fatto! visto il catalogo niente male messo
su, spesso se non sempre in coproduzione, da Valvolare: BMC, Jesus Franco & The Drogas, Bhava sono
passati di qui e presto si aggiungeranno altri nomi,
come i quotati Guinea Pig.
Bloody Sound Fucktory invece è una etichetta “piccola ma tignosa” partita dall’universo
delle fanzine e dei dj-set roccherroll per approdare
ad una sorta di laboratorio creativo capace di muoversi agilmente tra cd, organizzazione eventi e grafica da sballo. Proprio “Records, Graphics, Events &
Communication” riporta a mo’ di sottotitolo il loro
myspace, giusto per rivendicare il potenziale dinamico della sigla.
Alessandro Gentili – uno della trimurti Bloody
Sound insieme ai fondatori Iencinella e Refi – ci racconta qualcosa in merito alle origini del collettivo:
L’esperienza Bloody Sound nasce nell’estate del 2004
in una provincia anconetana in gran fermento: è il momento in cui tutto un sottobosco musicale, culturale e di
costume, sembra stia spingendo per emergere alla luce
del sole...
È così che più o meno casualmente si incontrano
un manipolo di djs che suonano rock’n’roll, new
wave, indie rock in locali come il Thermos e
l’Ilè Aiyè ad Ancona, il Gratis a Senigallia, il c.s.o.a. Kontatto di Falconara, il
Circoletto di Osimo. A quel tempo molte realtà cominciavano a farsi notare non solo
entro i confini regionali,
ma anche fuori da essi.
È il caso di musicisti, ma
non solo. Anche di entità di raccordo che
molto incideranno nelle dinamiche
della (ancora non)
scena marchigiana:
Ci sono poi diverse
band i cui nomi iniziano ad oltrepassare
i confini regionali grazie
a etichette indipendenti quali
Wallace e Psychotica che ne
pubblicano i dischi; questo stimola gli altri complessi ed inizia
ad attirare l’attenzione della gente,
grazie anche a Kathodik, sito dedicato al rock e alla cultura indipendente con
base a Macerata, sulle cui pagine le band
e gli eventi locali vengono spinti e valorizzati. Non solo promozione, dunque, ma
anche interazione. Sarà proprio Kathodik a
tenere a battesimo nel proprio grembo virtuale, un
evento fondamentale per lo sdoganamento oltreconfine del movimento musicale di quelle parti, la
compilation MarcheIngegno Sonoro sulla quale
torneremo più avanti.
Nonostante le varie realtà in fermento – …ci furono i primi tentativi di produzione indipendente, come
la Anomolo di Osimo; o di organizzazione di concerti
come la Hot Viruz, o ancora pubblicazioni come MusicClub e L’Urlo – dove tutto ciò cominciava ad avere un minimo di visibilità, la realtà doveva ancora
compattarsi. Coordinarsi e fondersi in una specie
di unicum dalle mille anime e dai mille volti. Ecco
allora intervenire BS, che si interpone in queste dinamiche ancora ferme alla fase embrionale: …qui
nasce Bloody Sound, che si pone come obiettivo a lungo
termine quello di sollecitare il verificarsi di condizioni
che possano far emergere quel flusso e quel dialogo
di musiche, eventi, idee e soprattutto persone. Ovvero
creare “La Scena”.
E il superamento della stessa,
verrebbe da dire, visto che …se nella prima fase l’attenzione era rivolta
soprattutto alla dimensione locale,
ben presto l’esperienza ha acquisito un respiro più ampio, stabilendo contatti con realtà distanti
ed eterogenee, pur rimanendo
fermamente legata al territorio. Insomma, azione locale, pensiero globale, il tutto
rigorosamente in stile do it
yourself.
Segno di questa crescita
organica sono sia i numerosi titoli targati Bloody
Sound (date uno sguardo
al catalogo sul myspace per
togliervi ogni dubbio, considerando per pronte le new
releases di Gerda e Guinea
Pig), sia le numerose attività cui
abbiamo accennato nella prima
parte di questo approfondimento,
cui ultimamente si è aggiunto il poster art studio Soul Food sempre
di Refo.
Due realtà, si sarà capito, forti
e centrali nel movimento marchigiano; due realtà che fanno
della collaborazione e della
condivisione un punto di forza che tende ad agglomerare
piuttosto che a separare, senza
per questo accartocciarsi in una molle riproduzione di se stesso ma tentando vie nuove e stimolanti.
Prova ne sono le altre varie realtà discografiche (ma
non solo, come ci insegnano da quelle parti) della
regione, di cui non possiamo che accennare sbrigativamente ma che, fidatevi, non sono da meno. Come
quelle sorte a Senigallia, che come ogni porto di
mare che si rispetti ha i suoi marinai. Anzi, di più;
Senigallia ha un Marinaio Gaio che è innanzitutto
una sfilza di non è (rintracciabili sul myspace) che
definisce molto più di qualsiasi altra parola. Passione
ludica e dissacratoria al servizio di un suono tra i più
innocenti e genuini: Oginoknaus, Dadamatto,
Chewingum, M.A.Z.C.A. hanno il proprio domicilio da quelle parti.
Ma Senigallia ha anche un bambino sotto forma
di piccola etichetta, anzi un’etichetta piccola come un
Drop Out /
37
bambino: About A Boy, il nome che evidenzia la
freschezza e l’irriverenza di un progetto solitario e
sentito che non disdegna collaborazioni con realtà
come Tafuzzy e Records! S’il Vous Plait. O ancora la
Macerata dell’orsacchiotto Sweet Teddy di Andrea Bontempo (anche dj di vintage r’n’r e corresponsabile dell’esordio di Dadamatto) o la Osimo
di Anomolo e del Loop, per non parlare dei tantissimi spazi, più o meno piccoli, più o meno ufficiali,
che sbucano in ogni dove, pronti a diffondere il verbo sonoro delle Marche marce.
I
suoni e i rumori
Padrini spirituali di questo “suono” ce ne sono. Molti consumati su supporto digitale, mp3 o, si spera,
solchi di vinili. Ma due almeno fatti e cresciuti in
casa. Di zona. Due trii per certi versi accomunabili
se non per suoni, per lo meno per attenzione alla
ricerca e sviluppi di carriera, oltre che da nomi tal-
38
/ Drop Out
mente normali e quotidiani da sfiorare
il banale. Nomi però secchi e diretti
proprio come le musiche prodotte:
Altro e Sedia.
Post-punk teso e poetico per i primi; noise-rock corposo e sui generis
per i secondi, tanto per essere banali
e descrivere in due parole le musiche
ruvide da loro prodotte. Entrambi i
progetti sono però accomunati anche
da quel senso di (neanche tanto) latente commistione che ha avuto sviluppi
piuttosto evidenti da un lato nella carriera di artista visivo di Baronciani (che
di Altro è voce e chitarra), apprezzatissimo e quotato “fumettaro”; e dall’altro nelle evoluzioni sempre musicali di
Mattia Coletti, riconosciuto chitarrista/produttore della scena avant-rock
nazionale e non, e del duo Calbucci
e Compagnucci, sempre pronti alla
sperimentazione (visti ultimamente al
fianco di Damo Suzuki nel suo Network o in solo, come nel progetto basso/batteria a nome Beasts).
Restando fermi ad Altro e Sedia,
senza deragliare in territori di ricerca,
le due suddette linee – insieme all’insana passione per il rock-garage più sudato, tirato, urlato e grezzo – sembrano tornare e riemergere in molti dei
nomi che trattiamo in questa indagine.
Indagine che non può non partire da un evento virtuale di qualche tempo addietro cui accennavamo in
precedenza e che per primo gettò un po’ di luce sul
marasma in movimento da quelle parti. Parliamo di
MarcheIngegno Sonoro, compilation in doppio
cd in due volumi e free dwld (produci, diffondi, consuma… il nuovo motto del 2.0) in cui a sfilare erano/
sono tutte le realtà indipendenti della regione e in
pratica tutti gli stili e generi masticati da questi brutti ceffi.
Nel Vol. 1-2 facevano bella mostra di sé i Lush
Rimbaud da Falconara, col loro post-wave-funk
bianco e nervoso testimoniato dall’ottimo album su
FromScratch Action From The Basement, ben
supportati, tra gli altri, dal post-punk ruvido degli
Edible Woman, dallo screamo di Gerda, dal garage marcio e dilatato di Guinea Pig. Nel Vol.
3-4, era invece l’onda più giovane formata da praticamente tutti i nomi che ricorrono in questa inda-
gine – Oginoknaus, BMC, Lebowski, Lleroy,
ecc. – a fare bella (o brutta, dipende dai punti vista)
mostra di sé, insieme a qualche nome storico e/o
di altro contesto stilistico (gli Affluente, i già citati
Altro, IOIOI, Scarabocchio, ecc.).
Le linee genealogiche, si diceva. Accomunabili a
quella larvatamente targata Altro, prevalentemente
giocata cioè su un uso ricercato dell’italiano misto
ad un bruciare da dopo-punk teso e vibrante, sono
un paio di nomi già trattati da SA in tempi non sospetti: i Dadamatto e i Lebowski.
Dei primi colpì più il secondo album Il Derubato Che Sorride che l’esordio del 2007 Ti Tolgo
La Vita, per il suo concentrato di pura poesia della
provincia, come scrivemmo mesi addietro, spalmata su ritmi e sonorità da dopo-punk; dei secondi
l’ironia tagliente dei testi, come sottolineava il buon
Zampighi, che non è mezzo ma fine di un approccio
ludico e lucido alla materia rock nel terzo millennio.
Non resta perciò che occuparci dell’altra linea
genealogica, quella più marcatamente rock-rumorosa declinata di volta in volta a seconda delle peculiarità di gruppi che – giova ricordarlo – sono spesso
se non sempre frutto di un unico humus comune.
Ci occupiamo perciò, in ordine di apparizione, di
Butcher Mind Collapse, Lleroy, Bhava e Jesus Franco
& The Drogas. In poche parole del marcio che c’è
nelle Marche.
B utcher M ind C ollapse
Mesi addietro arrivò a far bella mostra di sé un dischetto con una copertina talmente oscena da far
tornare in mente, solo al guardarla, i peggiori incubi
a stelle&strisce: da Butthole Surfers e/o Dwarves in
giù, tanto per rendere l’idea.
Vomito, sangue, sessi femminili. Roba materica,
fastidiosa, invadente sin dall’iconografia scelta ma
che rispecchia esattamente quello che si trova concentrato in pochi pezzi (sette ad esser precisi) e ancor meno minuti (non si arriva alla ventina) in Sick
Sex And Meat Disasters In A Wasted Psychic
Land. Titolo chilometrico – ci vuole più a leggerlo
che ad ascoltare tutto il mini – che mescola spavaldamente spazz-core e puzza di feci, equilibrismi ritmici da forsennati in calore e devastazioni circensi
indiavolate messe in scena da un quartetto di veterani: Jonathan Iencinella (voce), Riccardo Franconi
(chitarre e synth, anche Lebowski), Nicola Amici
(chitarra e sax, anche Jesus Franco…) e Giampaolo Pieroni (pelli).
Butcher Mind Coll apse
Come quartier generale hanno il classico garage
in periferia (di Jesi, ad esser precisi) e come influenze citano nomi impegnativi (Captain Beefheart, Pere
Ubu, Jesus Lizard…), ma non è roba da poseurs o
fighetti dell’ultim’ora. Nei fatti, i Butchers non sono
da meno dei maestri, anzi.
Hanno dalla loro l’attitudine dissacratoria propria del grande gruppo; l’immediatezza punk che si
fa sintesi estremizzata ed essenziale (less is more?);
l’autoironia sublime di chi sa stare al gioco che, sia
chiaro, non vuol dire non prendersi sul serio, ma
avere bene in mente quale posto occupare nella
scala del rock. Inoltre, giusto per non farsi mancare
nulla, spolverano il tutto con una coltre di nebuloso
noir ellroyiano che non guasta affatto, sposandosi
assai bene con le sonorità urbane (e newyorchesi,
nello specifico) evocate dai pezzi.
La voce di Iencinella rievoca un David Yow più
ubriaco e claudicante o al limite uno Stu Spasm
ancor più al vetriolo. L’interplay strumentale sciorina un bignami completo della wave più fratturata,
del noise più forsennato e senza freni, del rock più
sudato e abrasivo. La sensazione generale è quella
di una messinscena della depravazione più becera
e squilibrata, esasperata e sboccata (Cunt Face vale
più di mille saggi di sociologia) nella sua tendenza
all’autodistruzione.
Due pezzi su tutti rendono l’idea della metabolizzazione di anni e anni di ottimi ascolti: Goddess
Dustman, improbabile jam tra i Pere Ubu e i Primus, costretti in uno scantinato del Lower East Side
nel ’93; e Monkeys Don’t Suck, furibonda e sfrenata
discesa agli inferi, che prende a bordo i Cows più
spastici e free e trascina con sé la schizofrenia dei
suoni più disturbanti dell’ultimo trentennio. BMC è
il suono del circo delle atrocità.
Drop Out /
39
lleroy
L leroy
Se uno che di rumore se ne intende, diciamo un
Giulio “Ragno” Favero a caso (One Dimensional
Man, Teatro Degli Orrori, Putiferio, Zu…come dire
un bel pezzo di storia rumorosa italiana), in un post
concerto incensa un trio di pischelli sconosciuti considerandoli un gruppo-bomba, un motivo ci
deve pur essere.
40
/ Drop Out
Fre’, Gia’, Cecca’, al secolo i fratelli Zocca (Giacomo al basso e Francesco alla chitarra/voce) +
Riccardo Ceccacci, sono i Lleroy da Jesi, per autodefinizione un power-trio mud-core dedito allo psychovandalismo.
Ingannevole è la giovane età, più di ogni cosa, verrebbe da dire parafrasando il titolo del libro che ha
portato la fama al quasi omonimo fake letterario J.T.
Leroy. Perché l’esordio lungo racchiude in sé la esagitata furia iconoclasta – cifra stilistica fondamentale
dalle parti del Conero – e vi aggiunge maturità di
applicazione e lucidità di intenti da lasciare attoniti.
I tre Lleroy recuperano infatti il marasma interiore,
tutto sconquassi e bruciori, del grunge primigenio,
quello virato al nero che rese Juice Of BimboBleach il monolite che è e quello che King Buzzo riuscì, grazie all’ottusa insensibilità delle major, a
vendere alla Atlantic.
Quella però è solo la base di partenza, il canovaccio iniziale, la tela nero pece sulla quale spennellare
schizzi di post-hc materico (i Breach di It’s Me
God, qualcuno se li ricorda?), fratture e passaggi arzigogolati degni dei migliori Dazzling Killmen,
squadrature metalliche completamente addicted
al verbo degli Helmet. In Juice Of Bimbo c’è
trance agonistica, sottomissione al verbo del rumore privo di cacofonia, catarsi istintuale e cruda in
ogni passaggio urlato e/o martirizzato di chitarra,
basso o batteria.
Paradigma del suono Lleroy è Naked Violet, concentrato di puro dolore su pentagramma: ugole
bruciate da post-hardcore schizzato, chitarra pesante come un macigno, basso caterpillar incazzato e
batteria in modalità doppiacassa. Tutto irrimediabilmente distorto ed amplificato a livelli insostenibili.
Come un urlo munchiano in un mondo di sordi, che
lega per affinità il trio a progetti già indagati da SA,
come Dead Elephant e Lucertulas.
A fare la parte del leone è la chitarra di Fre’ – in
ballo anche in Guinea Pig e Gallina, trio di postpunk agricolo (?!) con Michele Grossi di Dadamatto
e Marco Bernacchia – ma basso e
batteria non sono da meno, pronti a
fondersi e sostenersi nel creare un
magma incandescente mobilissimo
e plasmabile.
Sarà chiaro. I Lleroy flirtano di
brutto con le musiche estreme senza apparire tali. E sono forse i più
“pesanti” tra i nomi citati in questo
spazio.Tre facce da bravi ragazzi che
saliti su un palco qualsiasi o attaccato un jack ad un ampli si trasformano in potenziali killer e/o stupratori
di pentagrammi.
Non è un caso che stiano per
partecipare al vol. 3 di Leviatani & Zanzare, festival-manifesto
bhava
di sonorità estreme organizzato da
un altro ricettacolo di educande, la bolognese CynicLab.
B hava
Pane e furia, ricordano sempre questi Bhava, e
l’ascolto di Double Jump Carpiato (anche in
uscita americana, per la Radio Is Down di Olympia)
non li smentisce: 8 pezzi per 15 minuti di brutale
noise-core spastico e spigoloso come da manuale. Urlato nella lingua di Dante dall’ugola sgraziata
e straziata di Raffaele Cascia; devastato nei suoni
dall’urticante interplay di Alessandro Guerri (batteria, anche Paperoga), Manuel Volpe (basso, il soloproject Vertebrae) e Lorenzo Marinangeli (chitarra, in solo come Hey! Team).
Progetto più giovane tra quelli di cui stiamo parlando – per questioni sia anagrafiche (una età media
di soli 21 anni!) che musicali – Bhava prende il via
nel 2007, quando Ale, Lorenzo e Raffaele militavano
nei Virginia. Questo giusto per tenere a distanza
l’idea di emulazione che in un contesto stimolante e
pieno di travasi come quello marchigiano potrebbe
essere dietro l’angolo: I Bhava nascono con i Bhava e
la spontaneità con cui è iniziato tutto è la nostra bandiera per continuare a fare ciò che ci piace.
E quello che piace a loro, piace anche a noi, visto
che si tratta di un puro panzer rock già maturo nel
suo mescolare sulla solida base (quasi) post-hc tensioni da noise-rock dei 90s, destrutturazioni nowwave e chitarre a grana grossa garage; dettagli, scatti
e screziature varie però proiettano verso lidi japanoise (altezza Melt Banana) e anche – complice
il sax dell’ospite Davide Uncini in L’impero Delle Vac-
Drop Out /
41
Menzione speciale alla scelta di cantare in un
italiano mai banale, nei testi come nelle metriche;
liriche in cui Raffaele dimostra molto più dei suoi
venti anni. Crediamo di fare cosa gradita concludendo con uno stralcio dal distico iniziale di Il Mio
Compleanno, che dice più di qualsiasi descrizione: e
allora adesso vieni qua che ti insegno io come vivere
al margine / anche le situazioni di cui sei l’indiscusso
protagonista.
J esus F ranco & T he D rogas
bhava
che Di Bhava – verso aperture jazz-core.
Ovviamente, anche per il quartetto jesino è valido il discorso della interazione tra forze diverse
portato avanti sin qui, non solo per l’aspetto produttivo del disco (coproduzione tra Valvolare, Bloody
Sound et alii). La forte carica aggregativa – in questo
caso rappresentata proprio da Bloody Sound – è
al centro dell’universo Bhava come ci confermano
Manuel e Raffaele: Poi c’è la Bloody Sound e il fermento
che ha creato negli ultimi anni nella nostra provincia
(Ancona) dove tantissimi ottimi gruppi dal sottosuolo
hanno trovato una via d’uscita grazie anche al loro aiuto e noi, essendo il gruppo più giovane di tutti abbiamo
visto crescere tutto ciò consumandone dischi e amando
le loro band che hanno fatto da apripista […] le occasioni che la nostra città (Jesi) ci offriva per mantenere
una vita sociale accettabile erano e sono pari a zero, la
routine del circolo reduci e dei bar a poco prezzo non
faceva altro che annientare tutte le aspettative e quindi
suonare per noi ha sempre rappresentato un evento
extra-ordinario con il quale puoi ancora esprimere te
stesso e ciò che ami di più.
Scoramento tutto sommato comprensibile in
provincia, ma Bhava è un torello giovane e supera
le dinamiche provinciali partendo di corna, stando a
quanto dice di sé: un toro che ti disarciona con movimenti bruschi e convulsi solo apparentemente casuali.
42
/ Drop Out
La panoramica sulle Marche rumorose non può
che concludersi col supergruppo dei supergruppi,
ovvero la dimostrazione vivente della trasversalità
e degli inarrestabili travasi della scena marchigiana.
Lebowski, BMC, Lush Rimbaud, Bloody Sound; grafica, attitudine, organizzazione e devasto più totale,
tutto questo confluisce in JF&TD, gruppo di furioso
rock’n’roll che non sfigurerebbe affatto nel catalogo
In The Red.
Jesus Franco – aka Michele Prosperi (già Ego e
prossimamente NewLaserMen) alla batteria – e
i 4 Drogas – alle chitarre Nicola Amici (BMC) e
Andrea Carbonari (Guinea Pig), al basso Marco
Giaccani (Lush Rimbaud), alla voce il già citato
grafico rocchenroll Andrea “Refo” Refi – snocciolano un esordio che non puzza di America, ma è America! tanto grasso e grezzo è il rosario in 11 tracce
esposto in Get Free Or Die Tryin’.
L’attacco (Honolulu Baby) è già da brividi su per
la schiena: cassa dritta, fischi di ampli, rullatona e via,
una corsa scavezzacollo che sembra un r’n’r trasfigurato in rito voodoo, tanta è la carica primitiva che
i cinque ci buttano dentro.
Proprio carica ed energia sono il miglior pregio
di JF. Impossibile tirare il fiato negli 11 pezzi dell’album, vera e propria discesa negli inferi del rocchenroll più sudato e ignorante, incurante di modelli di
riferimento che non siano da stuprare, sporcare,
deformare. Una irruenza che tramortisce tanto è
delirante e scomposto l’assalto all’arma bianca di
Zombi Polka, Mompracem, Yeti. Pezzi che rimandano
indistintamente a Clinic e Cramps, Sonics e blues
deforme e stravolto à la Crypt.
Il rock in ogni sua forma masticato & risputato
dai Drogas – dai tardi sixties alle ultime cose targate
ITR – è però rivestito di dissonanza noise che non
può non essere debitrice della fase più calda del NY
sound dei 90s. Tutta quella genia di giovani white
trash drogati capaci di rivitalizzare il blues a forza
di violente iniezioni di rumore bianco, iconoclastia
e incapacità tecnica. Di capacità, i cinque Jesus ne
hanno da vendere, ma come per i Boss Hog – da
poco riformati e definiti mille anni fa come combo
di riciclo per fidanzate stanche di musicisti noise di Ny
– sono anch’essi un supergruppo in grado di fornire una versione insieme 2.0 e sanguigna del r’n’r.
Non caustici ed abrasivi come i Pussy Galore,
veri e propri geni inetti della musica, ma più “lineari” e consoni come gli Honeymoon Killers o i
Crunt di Stu Spasm e Kat Bjelland.
Prendendo il nome in prestito dal cineasta spagnolo autore di una caterva di b-movies, titoli ed
iconografia tutta rimandano all’immaginario filmico
più depravato, come un Tarantino meets Rodriguez
sparato a folle velocità giù per i vicoli di una Ancona underground mai così vicina al Lower East Side.
East Coast chiama e costa est risponde, verrebbe da
chiosare. Senza sfigurare affatto.
C onclusioni
Di solito, in ambito rock, ad essere ricercato e con-
diviso tra più band era sempre e solo il batterista,
per le ovvie questioni legate alla difficile reperibilità
di un drum-kit. Questa indagine parziale e limitata
sull’agitazione delle Marche spera di aver dimostrato che scambi, travasi, prestiti in nome di passioni
comuni e tendenze stilistiche più o meno rumorose
sono, in quello spicchio d’Italia a torto considerabile
periferico, non sono solo una sorta di way of life
per uscire dall’isolamento, ma anche in grado di far
scattare dinamiche incredibilmente stimolanti.
Lo dimostrano i gruppi tirati in ballo – frutto di
una scelta personale e arbitraria, non qualitativa, sia
chiaro – e i moltissimi (gruppi, etichette, locali, festival) che per questione di spazio e tempi non vi sono
stati inclusi. O quanti – pensiamo a Gerda, Guinea
Pig, NewLaserMen, Above The Tree, tanto per fare
dei nomi – escono proprio in questi giorni o nei
prossimi mesi, continuando a portare alto il vessillo delle Marche marce. Quelle rumorose e cooperative. Quelle trasversali e aggregative. Quelle che
preferiamo.
Jesus Franco & The Drogas
Drop Out /
43
Recensioni::::maggio::::
►►►►
A Hawk And A Hacksaw Délivrance (Leaf, Mag 2009)
G enere : O ld E st F olk
Tanto ci ha messo Jeremy Barnes ad appropriarsi
dell’Est nel senso più universale del termine che
ora la tentazione di tacciarlo d’eccessiva ortodossia
è forte come è stato irresistibile criticarlo per gli
espedienti avant con i quali era partito sotto l’attuale pseudonimo. Del resto consigliare oggi A Hack
And A Hacksaw, passata tanta acqua sotto il ponte
del trans-folk, significa per forza di cose guardare
oltre e puntare dritto allo scaffale delle più rinomate compagini del settore. A livello di preparazione e
sofisticazione, il duo del New Mexico non ha niente
da invidiare alle Instanbul oriental ensemble, Fanfare
Ciocarlia e Kocani Orkestar del caso, anzi, per buon
un 90%, è in tutto e per tutto assimilabile ad esse.
Ma attenzione c’è una differenza, sarebbe un grosso
torto tralasciare la componente di ricerca in Délivrance. Barnes e Trost si spacceranno anche per autoctoni suonando ai ristoranti rumeni o nelle piazze di Gerusalemme ma non lo sono. Si definiscono
outsider e musicisti Americani. Sul loro my space,
come location, c’è una località del New Mexico e
sulla carta d’identità della The Hun Hangár Ensemble, con la quale hanno firmato il precedente e questo lavoro, ci sono pur sempre studi Occidentali.
Sotto il vestito minimalismo e free, arte povera e il
suo contrario, il massimalismo. È uno stra-folk che
non si spoglia d’Occidente quello di AHAAH perché è pur sempre con l’intelligenza e le tecniche di
quest’ultimo che si guarda a Est.
Se ascoltando Deliverance questi mondi vi sembreranno più vivi e lucidi che nella Kocani o nelle
varie bande total folk, ecco lo spettro della post
modernità incombere su di voi. Tradotto vuol dire
Foni Tu Argile, una canzone tradizionale greca per
bouzouki e canto che il duo, con l’aiuto del collaboratore Chris Hladowski, si trasforma in un virtuoso
stomp per Scatter e Nalle. Niente voci solo la melodia e percussioni a mo di spezie. Oppure, se Kertész
vi fa tanto Est sappiate che è su quelle note che
Romania e Ungheria s’incontrano in una girandola
44
/ recensioni
di fisarmonica, violino e cymbalum, uno strumento
simile al dulcimer suonato con le bacchette. Barnes
stesso, nella press, spiega che il brano omaggia la
café music di Bucarest degli anni Sessanta influenzata a sua volta dalla musica turca del 18° e 19°
secolo.
Chiaro? Non abbiamo a che fare con musicisti che
hanno bisogno di ideologie pro o contro qualcosa,
nemmeno gente che sacralizza la musica della quale
si sono impadroniti. C’è una forte fascinazione, ma
siamo ben oltre, è lo spirito di ricerca e di confronto
la base. Di più, una ricerca non spasmodica, non tesa
a esaltare questa cultura su quella. Uniti allo studio
in loco delle tradizioni, sono i migliori presupposti
per una musica scoperta, assimilata e vissuta. E si
sente. Niente cartoline. Niente field recording. Qui
si suona con la S maiuscola.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
AA. VV. - Private Domain. Iko Invites
(Naïve Maison D’Artistes, Apr 2009)
G enere : E lectro P op / C l as sica
I tentativi di attingere al patrimonio classico (quello
che qualche musicologo definisce Canone Occidentale, come se si trattasse di sacre scritture), di superare la barriera culturale immaginaria che separa (o
almeno ci prova) la musica “colta” da quella popular,
non si contano più. Ovviamente ci riferiamo solo
ai tentativi espliciti di intervenire su un repertorio
pre-esistente, ché i casi di semplici influenze sarebbero tanto numerosi, da risultare inutile e poco
pertinente qualsiasi elencazione. In ogni caso, nell’incontro tra il pop e la musica cosiddetta classica, quasi mai il primo è riuscito ad
avvolgere nel suo leggero e rassicurante mantello,
l’austerità che spesso accompagna il riferimento al
classico. A questo proposito, il progetto di Iko, musicista e produttore inglese di formazione classica
ma avvezzo all’indie pop , va esattamente nella direzione opposta e questo, di per sé, rappresenta già
un elemento di interesse. A supporto della sua idea,
Iko (personaggio semi anonimo, che in questo caso
highlight
33 Ore - Quando Vieni (Garrincha Dischi, Mag 2009)
G enere : canzone d ’ autore
Il contenuto e la forma piacevolmente avvinghiati. Canzone d’autore, certo, ma alla maniera di
Marcello Petruzzi, di professione musicista. Uno che nei Caboto frequentava tecnica e preziosismi e nei Franklin Delano affinava stile e melodia, in previsione di un progetto solista quasi
inevitabile.
33 Ore: saliscendi melodici appiccicati a un jazz in pillole, ad arrangiamenti minimali ma raffinati
(ottoni, archi, wurlitzer, batteria, chitarre, tastiere, la strumentazione), ma soprattutto a un presente autobiografico ancorato profondamente al passato. Quello dello stesso Petruzzi. Sembra
evidente in brani come Diventi nuvola, con le atmosfere rarefatte e la
disillusione à la Piero Ciampi che traspare da ogni dove. Tanto che
viene da pensare che il Nostro abbia perfettamente appreso le dinamiche alla base del lavoro dei cosiddetti “cantautori”, sintetizzate a
dovere in quell’irrefrenabile desiderio di liberare sullo spartito i vuoti
dell’esistenza e le sue contraddizioni. Il tutto senza filtri che garantiscano l’anonimato e con il rispetto per la materia che ogni buon neofita dovrebbe sempre dimostrare. Un’innocenza nascosta dietro alle
andature a singhiozzo e nei ricordi malinconici della title track, confusa
nel battere morbido di Un nome, mascherata dalle inquietudini di Per quando mi mancherai, cullata
dagli archi di Gennaio, sottolineata dal blues di Gioca.
Dovessimo contestualizzare la musica di 33 ore, ci affacceremmo probabilmente sugli anni sessanta, epoca di crooner in bianco e nero dalla spiccata eleganza e i significati profondi, da cui il
Nostro riprende il mood e il coraggio per una scrittura ricca di particolari. Soppesati, magari, da
un Nick Drake periodo Bryter Layter capace di collezionare rime di spessore su tablatures
originali e di farsi rapire dalle strutture ariose della musica. Insomma, segni distintivi di una proposta già matura in cui le potenzialità di una parte musicale plastica e multiforme si sommano al
carattere introverso della poetica. Per dar vita all’ennesimo disco di valore in un inizio 2009 a dir
poco sorprendente.
(7.5/10)
Fabrizio Zampighi
veste i panni del direttore artistico) ha invitato un
ensemble (Private Domain) e alcuni artisti, noti e
meno noti negli ambienti dell’elettronica, a rivisitare
alcuni brani del repertorio che va da Purcell a Verdi, con la licenza di poter semplicemente utilizzare
i brani, senza doverne rispettare necessariamente
tutti i parametri. Il risultato sono nove perle di leggerezza e intensità
che hanno la soavità del più raffinato electro pop,
ma anche il sapore di sistemi musicali non più in uso
anche se ancora efficaci ed attuali. Come nel caso
della splendida aria di Didone “When I Was Laid”
recensioni /
45
tratta da Dido And Aeneas di Henry Purcell
(Remember Me) o dell’andamento dolorosamente
discendente del Lamento De La Ninfa di Monteverdi (Amor), nei quali, grazie a Emile Simon e
Murcof, il pop elettronico scopre di avere una particolare affinità con le melodie pre-tonali del Seicento. Così come le timide
cadenze del teorico della
tonalità Rameau, riescono a risultare ancora
attuali per costruire un
divertente quanto interessante motivetto (Here
Is The Place), intonato da
Paul Et Louise. Ma come
dimenticare il melodramma? Finalmente, dopo tanti
abusi, un’opera tanto popolare quanto straordinariamente commovente come La Traviata, si alleggerisce di tutto il peso della storia per diventare
una languida ballad (Addio, dall’aria “Addio Del Passato”). Completa un quadro alquanto variopinto, il cut
up dal Requiem di Mozart (che richiama da vicino
gli arrangiamenti di Walter Carlos in Arancia
Meccanica) di Para One, il quale si destreggia
benissimo anche nelle rivisitazioni di Beethoven
(Sèptieme, dalla Settima Sinfonia) e Bach (Passion, dalla celebre Johannes Passion). Un approccio privo di timore reverenziale, che, con
un geniale doppio colpo infonde nuova linfa al pop e
fa rivivere grandi classici, troppo spesso considerati
inutili reperti archeologici.
(8/10)
Daniele Follero
Ah, Wildness! - Don’t Mess With The
Apocalypse (Riot Maker, Apr 2009)
G enere : L o - fi rock
Stanchi delle band patinate che usano lo studio
come strumento? Voglia di buon vecchio rock
che puzzi sudore e che faccia muovere il culo?
La Riotmaker si discosta dalle proposte dancefloor based e spara una cartuccia che suona
come la blues explosion dello Spencer più frizzante che mai. Tutto ovviamente italico. In particolare qui si va di lasagne al ragù in salsa emiliana.
Come il primo piatto più basico ma esagerato
che ben conosciamo, anche l’esordio del sestetto mette a posto lo stomaco e ci rassicura senza stupirci. La carica c’è e anche se la formula è
ormai cliché, la proposta sta in piedi grazie all’attitude grezza e senza compromessi del punketti-
no The Tomorrows, del blues marcio di Unsold, del
post-p-funk di Puff Off (anche se i componenti
del gruppo non si sentono vicini a quest’estetica) e di altre bordatine che fanno muovere il culo.
Dopo questi quaranta minuti vien voglia di andare
a vederli live. Sicuramente per pogare e fare stage
diving. Magari con un paio di pantaloni a zampa e
con una camicia con le punte lunghissime. Into the
(Ah!) wild(ness).
(6.3/10)
Marco Braggion
Akron/Family - Set Em Wild, Set Em
Free (Dead Oceans, Mag 2009)
G enere : A lt F olk
Passi il richiamo a Fela Kuti e Sly Stone ma che la
Akron Family si facesse contagiare da Paul Simon
quello no, non ce l’aspettavamo. Come avranno fatto dall’afro a risalire il fiume fino ai Vampire Weekend? Semplificandoci la vita possiamo dirvi che
passando dalla serietà Young God alla Dead Oceans
la band s’è presa una vacanza. E vacanza significa trip
dalle loro parti. Viaggi che la band non s’è mai fatta
mancare e sempre nel più hippy dei modi.
Il recinto era quello non è vero? L’amore sviscerato
per il periodo aureo del rock li aveva uniti e chiusi.
È vero, avevano risposto free su questo punto ma
senza uscirne completamente spogli. Così, la mossa
etno via rockista è perfetta (Evereyone is Guilty), specie se condita di qualche scappatella wave (Cratures)
o meglio caraibica (River). Sperimentano i nostri.
Come al solito eppure il titolo del disco non deve
confondere. Mettere in libertà non significa espettorare ancora una volta il primo e inarrivabile amore come dei Black Mountain al ventesimo disco.
Uscire da tutto ciò vuol dire gioco. Sole. Reinvenzione e Casa che ritrovi puntualmente in They Will
Appear e, chiaro, il contrario di essa lo spazio aperto
(i King Crimson indisciplinatamente vostri di MBF).
Sempre uno e cento dischi dentro a un disco dei
loro. Impossibile non elogiarli ancora una volta. Bestemmia chi cataloga (Per chi fa il pre-order sul sito
della label, c’è la copia digitale in download).
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Andromeda Mega Express Orchestra - Take Off! (Alien Transistor,
Mag 2009)
G enere : bigband colonna sonora ‘50
Bolle qualcosa nella pentola che cucina ricette anni
Cinquanta. Un crepitio che manca poco che si trasformi in fenomeno. C’è qualcosa che bolle e che
ci ha fatto comunque piacevolmente ricordare quel
milieu ascoltando l’ultima Kevin Blechdom, filologica fino alla mimesi completa. E sull’onda di
quella vi parliamo anche dell’Andromeda Mega
Express Orchestra, creatura di Daniel Glatzel
come di una schiera di altri musicisti impegnati in
fiati, archi e persino un vibrafono.
E qui ci sono quelle big band che facevano colonne sonore e ambientavano situazioni – lounge di
albergo, film dal sapore raffinato, attesa e suspance
(Cotton Candy Nebula) o giochi classici (Gamma Pluto Delta). Frac e palchi da ristorante presentati con
un’estetica - nel packaging del dischetto come nei
titoli delle tracce – in qualche modo spacey. L’unico
collegamento alla cosmicità – a parte il finale spettrale di Postludium- è musicalmente parlando una
curiosa abitudine, che scorrendo le tracce diventa
da caso a caratteristica; parliamo dell’accompagnamento di fiati e di lento jazz sornione con una batteria da motorik. In sordina, come di fatto questo
disco, che non può essere troppo preso sul serio,
ma segna uno sguardo. Un’inquadratura. Aspettiamo
la sceneggiatura.
(6/10)
Gaspare Caliri
Au Revoir Simone - Still Night, Still
Light (Our Secret Record, Mag
2009)
G enere : indie ( pop ) tronica
Non c’è dubbio che questo terzo album sia il più
riuscito della carriera discografica delle tre eteree
ninfette, a conferma di una maturità stilistica finalmente raggiunta: idee chiare e semplici messe in
atto senza troppi fronzoli né chissà quali pretese.
Still Night, Still Light si muove su un sinth pop
che rimanda direttamente a quel Moon Safari
airostatico con tanto di incursioni indietroniche in
territori Morr Music (Lali Puna, su tutti). Ma ciò
che lo differenzia positivamente dai suoi predecessori è l’atmosfera molto più sommessa e crepuscolare, scevra di inutili kitcherie, che circonda le dodici canzoni - malinconia e nostalgia da cielo grigio
primaverile -, emanata appunto da una semplicità di
intenti che lascia dedurre la presa di coscienza delle
Nostre circa il loro potenziale artistico.
Speriamo solo, però – sì, c’è un però -, che proprio
questa autoconoscenza non finisca per rappresentare il limite artistico delle Au Revoir Simone, ovve-
ro l’incapacità di rinnovarsi e cambiar pelle che in
quest’epoca ultrafrenetica e senza memoria sembra
prerogativa fondamentale (Radiohead docent).
Il futuro dirà. Sicuramente ad oggi la loro pelle ci
sembra splendente e liscia, e questo è ciò che conta.
Il lifting, al momento, è affare di qualcun altro.
(6.7/10)
Andrea Provinciali
Baby Blue - Come! (Autoprodotto,
Apr 2009)
G enere : rock - blues
Dei Baby Blue ci è sempre piaciuta la schiettezza.
Quel lasciare in primo piano l’impeto della batteria
e l’essenzialità della chitarra elettrica, l’istinto per
una melodia smozzicata e il fragore di crescendo
improvvisi. Insomma, per capirci, il rock & roll.
Nel 2006 ne apprezzammo le gesta in un Baby
Blue EP che recuperava le lezione di White
Stripes e Kills mediandola con gli spigoli di una
P.J. Harvey periodo Uh Huh Her, ora ne rimastichiamo le cesure e il rumorismo scosceso nel
primo disco “lungo” della
carriera del gruppo. Che
a dire il vero non si discosta molto dagli esordi,
tanto da riprendere la River già in scaletta nell’Ep
di cui si diceva - pezzo da
novanta della produzione della band - per sommarla ad altre dodici schegge sullo stesso stile. Stile
che viaggia con sicurezza tra freakerie funk traviate
da artifici free/noise (Took Me Long e Miss) e blues
impasticcato (Far From Home), rimembranze Birthday Party (Silently) e dissoluzioni à la Blues
Explosion (Mess). Per una tracklist il cui minimo
comune denominatore sembra essere la dissonanza,
uno scarso rispetto per la forma canzone, l’attrazione fatale per ruvidezze quasi primordiali e una voluta involuzione estetica che diventa segno distintivo
e possanza.
Sono a buon punto di maturazione, i Baby Blue.
Stanno per abbandonare i retaggi-bruco che ne
hanno fatto una band seminale ma profondamente
dipendente dagli ascolti giovanili per diventare, finalmente, farfalla.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
recensioni /
47
Ben Harper - White Lies For Dark
Times (Virgin, Mag 2009)
G enere : rock
Disperavo, ma non sono del tutto stupito. Il Ben
Harper che mi mise con le spalle al muro coi primi
due album possedeva davvero quella cosa che non
si spiega e impasta la musica estorcendoti emozione. Quello venuto poi si è demolito con una via crucis al contrario, ha edificato l’idolo di flanella e
vitamine di se stesso, con
una pulitissima efficacia
che di nuovo mi ha convinto quanto non fosse
più il caso. Ed ecco, oggi,
il colpo di scena: l’Harper
medaglietta d’autenticità
mainstream per il colosso Virgin viene scosso da
un sussulto d’orgoglio, d’immediatezza, di musica in
primis come schiaffo generoso.
Licenziati gli ormai bolsi Innocent Criminals, scordate - graziaddio - le escursioni gospel coi Blind
Boys Of Alabama, ha lasciato che i Restless 7 gli
coagulassero intorno - il bassista e tastierista Jesse
Ingalls, il batterista Jordan Richardson e il secondo
chitarrista solista Jason Mozersky -, la barra puntata verso un rock impetuoso, graffiante, dalla calda
asprezza seventies.
Si è talmente invaghito del piglio grintoso di questa
quadratura che avrebbe persino voluto sparire nella
nuova ragione sociale (la Virgin lo ha ridotto a più
miti consigli).
C’è da capirlo, perché ha davvero azzecato la mossa.
Ha evitato con saggezza di rifugiarsi nella verginità soul degli esordi scoprendo con bella disinvoltura l’acqua calda del southern (una Why Must You
Always Dress In in odor ZZ Top, una Number With
No Name e una Boots Like These di stampo Black
Crowes...) e persino le sgarberie del grunge (quella Shimmer And Shine che la mente torna ai Pearl
Jam, vecchio amore harperiano, rievocati del resto anche in Fly One Time), concedendosi il lusso di
escursioni Stones altezza Black And Blue (Lay
There And Hate Me, Keep It Together). Quanto al Ben
del misticismo trepido, ci sarebbe una The World
Suicide pervasa d’estro e visioni Neil Young, una
placida Faithfully Remain (con gradevole intreccio
d’hammond e weissenborn) e una Skin Thin dalla
frugale intensità, tipico ballatone dei suoi insomma,
un po’ scontato ma ci sta di volergli bene.
Non è un grande album, ma è il massimo che po-
48
/ recensioni
tevo aspettarmi da uno con la sua storia e le sue
frequentazioni. Me lo faccio bastare.
(6.4/10)
Stefano Solventi
BJ Nilsen/Stilluppsteypa - Man
From Deep River (Editions Mego,
Feb 2009)
G enere : ambient / drone / elettronica
Li avevamo lasciati con Second Childhood
(Quecksilber/Wide 2007), alle prese con derive
elettroacustiche d’inizio novanta prive di direzione.
Li ritroviamo oggi nelle profondità di Man From
Deep River.
Compito certo a tratti difficoltoso - doveroso è un
attento ascolto in cuffia -, quello intrapreso da BJ
Nilsen e il duo Stillupsteypa, che lavorano su
una registrazione su cassetta risalente al 1975, sottoponendola a un’abile maquillage ambient - il più
oscuro e criptico che si possa immaginare.
Coesistono naturale e artificiale, nelle indagini sonore del trittico di Man From Deep River, completato tra Berlino e Reykjavik nel corso del 2008,
articolato in fields recordings - di una certa scuola
cara al Francisco Lopez -, isolate derive analogiche
e synthetiche: il tutto trainato da un medesimo ipnotico stato di passaggio che a lunga disanza si scopre
tema di fondo, nel suo lento divenire di lacerate,
puntuali o visionarie identità sonore.
Si fanno notare le modularità ben lontane dalla ciclicità, come smosse da un naturale evolversi degli
elementi a metà strada tra fluttuanti granularià, microsuoni dall’animo concreto e risonanti spazialità.
Lungometraggi in matrice futuristica e di raffinata
levità da cui lasciarsi affascinare.
(7.2/10)
Sara Bracco
Bob Log III - My Shit Is Perfect
(Voodoo Rhythm, Apr 2009)
G enere : trash blues
Un disco di Bob Log III riconcilia con la vita e con il
rock’n roll, quello diretto, sporco, rozzo, analfabeta.
Non stiamo parlando di un presenzialista, con una
pubblicazione ogni due / tre mesi, ma di uno di quelli
(sempre più rari) che si fanno desiderare. Ma viva
Dio ecco il quarto album della sua serie solita nel
dopo Doo Rag, My Shit Is Perfect, un disco che
ti prende per il culo già dal titolo, sfrontato e ironico come è. Bob Log è il compagno di scuola che ti
insulta e disegna cazzi sulle pareti dei cessi, quello
che se inciampi e cadi a terra fa la corsa a sfotterti,
quello che fa gli scherzi e si diverte, “the one who
fucks”, quello che ha un rapporto con il gentil sesso
da machista da bar e in tal senso sono ormai celebri
le sue hit Clap your tits (ritmo onomatopeico a colpi
di vere tette che sbattono) e Boob Scotch (con tanto
di performance dal vivo in cui il Nostro ordina uno
scotch e lo fa miscelare dal seno di una fan). Come
fai a non volere bene ad uno così? Uno che sta sempre nascosto dal suo elmetto da motociclista e non
gliene fotte proprio niente di niente, figuriamoci di
me che recensisco il disco nuovo poi...
Bob Log III sembra un po’ il fratello blues e disgraziato dei Daft Punk, quello sfortunato che la mamma
ha buttato via appena uscito dall’utero. La musica
poi è come lui: un blues isterico e stirato, spigoloso
e claudicante, ma di grande maestria nella sua elementare elaborazione ritmica e con un gusto per la
slide guitar (Mississipi Fred McDowell per sua
stessa deferente ammissione) che rimane sempre
in ombra quando si parla di lui. Una canzone di Bob
Log III non può essere difficile o eccessivamente
meditata. Lui ha bisogno di vomitare le parole e le
corde con piglio primitivista e una battuta ritmica
poco più che elementare. Qualcosa che dopo un
po’ di ascolti ti entra nel cervello per direttissima,
anche se cercare tracce di melodia nelle sue composizioni è come trovare un senso a testi come
Bump Pow! Bump Bump.
Di contro il rischio è di avere un disco eccessivamente uniforme e monocorde, anche se incredibilmente pieno di energia. Non che i precedenti
eccellessero nell’arte di depistare l’ascoltatore e
mantenere desta l’attenzione, ma Trike rimane a
tutt’oggi il suo parto più studiato in questo senso.
My Shit Is Perfect è comunque un bell’affare per
party selvaggi e fa pure ridere l’idea che un simile
personaggio possa mai evolversi come musicista.
(7/10)
Antonello Comunale
Boxcutter - Arecibo Message
(Planet Mu Records, Mar 2009)
G enere : dubstep
Ritorna dopo due anni Barry Linn con il suo dubstep di qualità. Che però non fa più rima con novità.
Perché oggi è sempre più difficile surfare sull’onda
giusta. La domanda del mercato protounderground
ha girato sul wonky e il tagliascatole ha perso il
tram chiamato desiderio. Questo non vuol dire che
si sia dimenticata la tecnica o la capacità di produrre
canzoni con l’anima. Vedi ad esempio le vocal di Sidetrack che rimandano al magnaccia Burial, il funk
acido di squarepusheriana memoria di BSpacebass,
il d’n’ardkore di Mya Rave, le atmosfere dark à la
Vex’d di Arecibo Message e in generale un sentimento che si discosta dall’ipertecnicismo delle prime due prove per assestarsi su un uso più organico
e analogico dei suoni. Una pausa di riflessione per
una delle promesse dell’electrostep.
(6.4/10)
Marco Braggion
Brakes (The) - Touchdown (Fat Cat
Records, Apr 2009)
G enere : I ndie rock
Tra i tanti gruppi britannici che si distinguono per
lo humour (la biografia del gruppo presente sul sito,
dice che è stata la loro canzone -di nove secondi“Cheney, stop being such a Dick” a far vincere le elezioni ad Obama) i Brakes, composti da ex membri di
British Sea Power ed Electric Soft Parade,
suonano meno “inglesi” di tutti: non che manchino
i richiami alla tradizione
nobile dell’isola, ma passa
tutto attraverso uno stile
caratterizzato dalla voce
sottile e ruvida di Eamon Hamilton che evoca
spossatezze Grandaddy, dalla corposità della
chitarra acustica e a una
certa pesantezza Black Keys dell’elettrica.
La quale sa spostarsi sulle corde alte quando deve
spingere la leggerezza Housemartins di Worry
About It Later o quella country di Eternal Return, altrimenti spinge dal basso i B&S di Ancient Mysteries,
la notevole apertura di Two Shocks che parte glam
per decollare in un finale psichedelico nerboruto,
gli stacchi Who di Don’t Take Me To Space (Man);
satura nei J&MC di Oh! Forever e tiene su anche
la filastrocca -vagamente lagnosa e quindi possibile
hit- di Crush On You.
L’aria è più anni ‘90 che odierna, ma funziona grazie
a una solidità sonora venata di lieve malattia che è
il pregio maggiore del disco, soprattutto perché dà
corpo alle canzoni senza appesantirle né incatenarne la varietà.
(7/10)
Giulio Pasquali
recensioni /
49
Bronnt Industries Kapital - Hard
for Justice (Get Phisical, Apr 2009)
G enere : A mbient , IDM, C inematica
Escludendo la soundtrack vera e propria, è il secondo capitolo per Guy Bartell ovvero Bronnt
Industries Kapital, multi strumentista, turnista per
Gravenhurst e soprattutto scenografo sonico per
missione.
Anche in questo capitolo, entrando nello streaming
della memoria, la colonna sonora assume i tratti
dell’autonomia artistica e del prodotto d’ascolto
tout court. Ed ecco così un bel esempio di lavoro
strumentale senza distinzioni di sorta tra elettronico e/o suonato: l’esperienza soundtrack tastieristica e quella acustica (Bartell è famoso per reperire
strumenti stravaganti e di difficile reperimento), il
kraut rock e il post rock che ci ha fatto i conti, i
grandi sceneggiatori sonici dei Settanta (Vangelis,
Jarre) e i Kratwerk quando erano un misto di Ralf,
Florian e Neu! Persino del Canterbury prog (lato
jazz lovers) e qualche espediente elettro del post
punk storico, il tutto confezionato con l’abilità del
progger sanno di mente. Più vestiti assieme servono di volta in volta a una
coreografia precisa. Condite con gusto, serietà d’incisione e già una notevole abilità di “aprire” partendo da un motorik e avrete un progetto di gran classe che si distingue senza seguire nessuna moda.
(7/10)
Edoardo Bridda
Bushman’s Revenge - You Lost Me
at Hello (Rune Grammofon, Mag
2009)
G enere : jazz metal
Melvins meets Ornette Coleman. Questo in una
secca frase il profilo dei Bushman’s Revenge, power
trio composto da Even Helte Hermansen, già negli Shining, alla chitarra, Rune Nergaard al basso
e Gard Nilssen alla batteria. Simili per profilo ed
intenti agli Scorch Trio e ai Moha! i Bushman’s
Revenge sono gli ultimi sperimentatori del jazz rock
o per meglio dire, nel loro caso, del jazz metal, visto
che la chitarra di Hermansen si prodiga per tutto il
disco in una plumbea coloritura doom con accenti
quasi black. La caratteristica del trio è appunto quella di movimentare con la ritmica free un panorama
che non potrebbe essere più classicamente metal.
Count The Notes In Your Head apre il disco in modo
lento e teatrale quasi alla maniera degli Harvey
Milk e fa un po’ da introduzione perché il reperto-
50
/ recensioni
rio successivo si concentra sul dialogo impossibile
tra chitarra e sui ritmi diagonali e tarantolati della
sezione ritmica. Non mancano episodi diversi, come
la dark ambient di Hell Is For Hello o la ballatta jazzata di Ghostwriters In The Sky, ma suonano un po’
come episodi di corredo, un po’ fini a se stessi, così
come tutto il disco.
(5.8/10)
Antonello Comunale
Charles Spearin - The Happiness
Project (Arts & Crafts, Feb 2009)
G enere : musica prosodica
“All of the melodies on this album are the melodies of every day life”. Che vuol dire? Che Charles
Spearin ha preso le voci dei suoi vicini, quelli che
quando viene estate si mettono tutti in veranda a
conversare mentre i bambini giocano, ne ha tratto
delle frasi conversazionali e le ha usate come materiale per comporre. The Happening Project è
cioè un album fatto di tracce che traggono spunto
musicale (cioè melodico e armonico) dalle intonazioni, dagli accenti, dall’euforia o meno delle frasi,
colte nel loro concreto vivere.
È quindi un progetto di musica costruita su quella
che in linguistica si chiama prosodia, e che a volte ci
fa dire, quando sentiamo una persona con inflessioni particolarmente musicali, “potrebbe essere uno
spunto per un tema melodico”. Quello che ha fatto Charles è esattamente questo, cioè trattare la
prosodia delle voci attorno a lui come strumento,
materia per la composizione; e il risultato, secondo
chi scrive, è esaltante. Almeno per una manciata di
motivi. Innanzitutto perché l’esperimento potrebbe sembrare intellettualistico, eppure ne scaturisce
un’autentica avanguardia ludica, con toni che nulla
hanno della meninge spremuta ma molto della leggerezza di calviniana memoria; e ciò fra l’altro giustifica, anche se solo parzialmente, il titolo un po’ naif
del disco. Charles usa – ovviamente, per prossimità
evidente - anche tecniche di musica concreta, ma
sentite cosa ne fa dei cinguettii di Anna; in un picco
melenso direi che sembra dargli da mangiare direttamente dal palmo della mano.
Poi c’è la storia di Spearin, che non ci avrebbe fatto
pensare a un’uscita così; d’accordo che a volte lo si
cita come eminenza colorata dietro alla nascita del
progetto Broken Social Scene, ma è altrettanto vero che va associato anche al post-rock di Do
May Say Think. Cose meno divertite insomma.
E questo disco ci fa divertire. Ci ricorda i momenti
highlight
Au - Verbs (Aagoo Records, Mag 2009)
G enere : happening folk
Gli Au vengono da Portland e sono portlandini nell’animo – almeno se si pensa a Portland come
quella sacca più a Nord dove si riproduce quel senso di comunità associato normalmente a Berkeley. Hanno un cast che pesca da altre band cittadine: Parenthetical Girls, A Weather,
Saw Whet, Yellow Swans, Evolutionary Jass Band. Non è una novità allora che in
Verbs si senta qualcosa di collettivo, di più mani incrociate e dedite al folk americano con uno
sguardo non individuale. E questo nonostante il fatto che sia stato scritto e prodotto da una
persona sola, cioè Luke Wyland.
Non c’è quasi mai un elemento musicale isolato in questo album; né la strumentazione si raccoglie nella classicità piana del rock; nella convincente Rr Vs. D spunta persino una banda di strada, scanzonata, a infiocchettare la proposta, insieme a un happening sonoro tra piano, triangoli,
handclap poliritmici e voci quasi all’unisono. Ma ci si ravvede immediatamente della natura degli
Au, già dall’ampio respiro e dai ritmi plurali dell’iniziale All My Friends – titolo che sembra fatto
apposta per questo discorso, e brano che raccoglie al suo interno ben
25 strumentisti.
Non è comunque solo da un punto di vista della sua genesi e registrazione ontologica che in Verbs appare l’idea di un’opera collettiva.
Nei cori, nel pullulare giunglesco si trova un’intersezione tra due formazioni che di questa essenza hanno fatto il cuore dei loro interventi,
cioè – e naturalmente – Akron/Family e Animal Collective,
a proposito di flusso organico (e la seconda traccia si chiama All Animals…).
Si sente certo anche un po’ di Canada, specie in quel modo di essere struggenti ma dopo tutto
non patetici, catartici ma contenuti. Quella soglia che i Silver Mt. Zion minano sempre. Ogni
tanto ci sono anche i difetti di una condivisione, come nei passi lenti, che sembrano attendere un
crescendo, della finale Sleep, in definitiva poco credibile nel suo sviluppo. C’è comunque e sempre
il contrasto tra riflessione e risoluzione; Prelude ha per esempio una lunga introduzione che sembra un mèlange dei fiati del Terry Riley più riflessivo e un sostrato free-jazz. E poi si scatena la
catarsi. Che sia generazionale?
Qui sta il punto. Perché si alludeva sopra agli aspetti generativi e non genetici di questo disco. Il
fatto cè che Verbs mette a frutto e fa il punto di quel punto di vista corale, comunitario, che ha
contraddistinto i Duemila.Ve lo segnaliamo come uno di quegli album che sanzionano un periodo,
un modo di suonare, un’idea estetica e un approccio alla musica. È anche in questo che gli Au
ci parlano di famiglie di Akron e degli animali. Non a caso arrivano nel 2009 – o per esser più
precisi nel 2008, dato che la prima e più limitata distribuzione di Verbs è dell’anno scorso. E lo
suggeriamo per chiederci per quanto tempo sarà ancora sul pezzo suonare così. Forse poco. Ma
per oggi – il disco lo dimostra – ancora sì.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
migliori di Music From The Body di Waters e
Geesin, ma spesso lo supera, per esempio quando
fa sprizzare un violino capriccioso dall’esclamazione
improvvisa di una voce fanciullesca, dando un senso
di assoluta capacità di maneggiare le proprie intenzioni (Ondine). Qui sta il terzo motivo. La naturalezza con cui fiati chitarre pianoforti mimano le voci
e ne traggono spunti su cui costruite intere mini-
recensioni /
51
suite. Come in Vanessa, quando l’ultima frase di una
conversazione (quella di Vanessa, evidentemente)
diventa il tema su cui sviluppare la traccia musicale.
Padronanza e misura. Gioco e felicità. Se non altro,
ci ha fatto respirare un sereno ambiente quotidiano,
Charles.
(7.5/10)
Gaspare Caliri
Cheval Sombre - Self Titled (Double Feature, Apr 2009)
G enere : slow - core shoegaze
Cheval Sombre è una one-man band e viene da NY.
All’anagrafe è Christopher Porpora, lontane origini
italiane ormai sepolte nelle nebbie dei tempi. Suona
tutto lui, anche se il tutto si circoscrive a chitarra
acustica e voci, più qualche effetto sparso qua e là.
Una musica semplice, sognante ed evocativa che si
pone esattamente al guado tra slowcore di matrice
folk-blues e shoegaze dreaming and floating.
Tutto qui? Manco per
niente. Perché tanto per
cominciare attorno a sé
per questo esordio – che
raccoglie molti dei suoi
ormai introvabili singoli
usciti per Trensmat e Static Caravan – CS ha avuto gente mica da ridere:
Peter Kember, meglio noto come Sonic Boom,
ad esempio, che produce il tutto e accompagna con
organo ed effetti. Poi Britta Philipps (a basso e tastiere) e Dean Wareham (chitarra in alcuni pezzi),
che messi insieme sono proprio i Luna, oltre che i
titolari del marchio che produce il tutto, la Double
Feature. Già il fatto che nomi del genere mettano
la faccia nell’esordio di un emerito sconosciuto dovrebbe far riflettere sulla bontà dell’offerta.
E così è, infatti. Cheval Sombre è un disco non
originale, ma classico. Non un capolavoro, ma di
quelli che non toglieresti mai. Non innovativo, ma
semplicemente sublime, tanta è la delicatezza con
la quale Christopher disegna, in punta di plettro,
melodie malinconicamente perfette. Che si appoggi
ora ad un immaginario Slowdive senza elettricità
o a quello in totale slow-motion dei Low, che accartocci su se stesso un pezzo minore dei Doors
(Hyacint House), tratteggi un dream-pop lunare su
una texture filamentosa ed evanescente (I Sleep) o
rielabori in chiave estatica qualche traditional (Troubled Mind è letteralmente da brividi sulla schiena),
52
/ recensioni
Clues - Clues (Constellation
Records, Mag 2009)
G enere : indie rock
Gli Unicorns hanno fatto in tempo a pubblicare
solo un album, Who Will Cut Our Hair When
We’re Gone? nel 2003, ottenendo comunque un
discreto ritorno. Quanto agli Arcade Fire, sono a
tutt’oggi la gallina canadese dalle uova d’oro per
quanto riguarda il mondo indie. È naturale quindi
che si sia subito creato un certo interesse intorno ai Clues, che mettendo insieme Alden Penner e
Brendan Reed, più un gruppo nutrito di strumentisti
e amici del giro di Montreal, si riaggancia dichiaratamente alle esperienze dei due gruppi succitati suonando al tempo stesso come una naturale e diretta
conseguenza, tanto quanto un’ipotesi ulteriore di
indie rock anni 2000. La musica dei Clues è tutta spigoli post-punk a carezze pop-folk, spesso anche all’interno di uno stesso brano. Haarp fa capire subito l’andazzo: melodia in gran spolvero, chitarrine che più indie non si
può, salvo poi cambiare improvvisamente registro e
lanciarsi in attacco rock sostenuto. Attacco che poi
prosegue nella successiva Remember Severed Head
che è un piccolo gioiello di missaggio con ritmica e
chitarre angolari da far invidia proprio agli ultimi Arcade Fire. La filosofia dei Clues è questa. Originale
quasi per nulla, ma parecchio efficace nell’andare a
cercare le soluzioni migliori nelle pieghe di discorsi
usati e abusati. Vanno letti in questo modo le arie
quasi morriconiane delle radioheadiane In The Dream e Perfect Fit o i coretti Ok Computer della super ballad notturna Elope, per non parlare del post
punk fugaziano di Cave Mouth o della marcetta in
odore di cuore nero di Crows. La maestria e l’astuzia della band sta tutta nel saper
miscelare gli ingredienti con il giusto piglio post modernista. Facendo così riesce a metter giù classici
istantanei da arena come Ledmonton. I Clues sono
una band che cavalca l’hype come i surfisti di Malibu
Beach fanno con le onde più alte e pericolose.
Coathangers (The) - Scramble (Suicide Squeeze Records, Apr 2009)
G enere : indiepostpunk
The Coathangersè un quartetto femminile di
Atlanta, che si fregia di un’oscillazione stilistica tra
più anime che è sicuramente difficile tenere insieme.
Scrambleci fa annuire con gradimento e sospendere il giudizio, dubitare e tirare avanti le tracce, a
volte tirarle indietro per riascoltarle.
Difficile insomma dare un’identità a queste ragazze,
data la variabilità manifestata dalle canzoni. Si parte
(dopo l’intro) con Toomerhead, che colpisce per la
vocalità strozzata che contrasta con il brano che di
fatto è un motorik molto semplice. Non può poi
non piacerci Time Passing, che contiene i Mars. Ecco
chi ci ricorda quella gola trattenuta: una sorta di
Sumner Crane al femminile. Stop Stomp Stompin’ci
ricorda invece qualcosa di vicino al post-punk, che si
insinua di fianco al garage caricaturale dei Pere Ubu
ma soprattutto risulta
molto prossimo ai Devo;
ecco forse cosa sono le
Coathangers: delle devolute.
C’è poi anche San Francisco, i Deerhoof, dei garage più tirati (Bury Me);
persino il funk-punk;
principalmente però c’è un gruppo che in un disco
ci fa cogliere tutta una parabola, dalle origini arrembanti alle distensioni più pop e mature, come una
coesistenza compressa di White Light/White
Heat e Load, ovviamente con le dovute distanze e
proporzioni. Parliamo quindi di normalizzazione dei
toni accesi; da un certo punto di vista è normalizzato anche un punk bell’e buono come quello di Gettin’
Mad And Pumpin’ Iron; quasi da manuale. A ulteriore
elemento di confusione, alla voce simil-Craniana ce
n’è un’altra, che sembra provenire dal Sol Levante –
che ci ricorda episodi come Limited Express…
Has Gone. Doppia voce e doppia identità, verrebbe da dire. Ci accorgiamo di questo proprio quando
le due ugole cantano insieme, in Cheap Cheap, in
una specie di duetto. Un lavoro di contrapposizione multipla, Scramble. Rasenta la dispersione, ma
azzecca alcuni numeri, sbagliando ma solo di poco
degli altri. Cosa che ci fa sperare che non scelgano
un’unica strada sicura.
(7.3/10)
(6.5/10)
poco importa. Resta la certezza di un disco al tempo stesso magico, bucolico, pulviscolare, astratto, intimo, notturno, sospirato. Che non è poco di questi
tempi.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Antonello Comunale
Gaspare Caliri
Color Of Violence (The) - Youthanize (Epitaph, Apr 2009)
G enere : D eath (E mo ) C ore
Nato da personaggi per metà legati ad origini grindnoise, via via spostatisi verso i territori maggiormente redditizi dell’emo core, seppure di qualità, The
Color Of Violence (side-project dei From First
To Last, Derek Bloom e Travis Richter) incarna
alla perfezione gli stili sopraccitati. Ne consegue un
impatto disorientante sia per l’ascoltatore avvezzo
ai generi estremi del metal, sia a quello più rivolto al
punk. La voce di Richter, urlata e distorta, potrebbe
camuffarsi benissimo in un qualsiasi disco black metal, ma il sound complessivo va ben oltre le gelide
lande del nord Europa. L’hardcore di band come i Black Flag è un punto
di riferimento, facilmente riconoscibile. nei riff essenziali di Rock Music, mentre c’è sapore di emo nelle eufoniche armonizzazioni di God Gave Me Deeze
Nutz e Me And My Enormous Spiritual Erection. Una
tendenza, quella dell’uso/abuso di giri armonici semplici e orecchiabili, che attutisce la carica potente e
ipnotica che la band sa infondere a brani più “tirati” come Christina, Christina, una sorta di grind dallo
stranissimo appeal garage o al death-prog di Crapandemic. Punk e Black Metal, Garage e Hardcore e
un’ironia di fondo che ricorda gli Impaled Nazarene. Passaggi improvvisi da un picco all’altro, fino a
culminare nello strano abstract hip hop (con tanto
di scratch parodiato dalla chitarra) di Look I Made It!
I’m Dating An Actress. L’album, del resto, è caratterizzato complessivamente da una varietà stilistica che,
lungi dal rappresentare un problema di identità, crea
una continua incertezza nelle aspettative. Un meccanismo di spiazzamento, di tradimento delle attese
che è poi il sale della musica stessa.
(7/10)
Daniele Follero
Conor Oberst - Outer South (Wichita Recordings, Mag 2009)
G enere : rock , country rock
Accantonato momentaneamente lo pseudonimo
più famoso Bright Eyes, Conor figlio fiero d’America ritorna “artisticamente” in proprio (e accompagnato dalla fida Mystic Valley Band) con un secondo
lavoro che lo conferma definitivamente nei panni
del rocker da pub del middle-south con nel taschino l’abilità di condurre l’immaginario comunicativo
dylaniano ai bicipiti di uno Springsteen.
La bellezza dell’esordio era tutta lì e proprio per
recensioni /
53
questo ci delude Outer South, un lavoro che porterà a compimento il percorso rock venato country
iniziato con Cassadaga che di contro non regala
la scrittura sicura e brillante del precedente album
(e figuriamoci una Cape Canaveral). Rimangono assodati gli arrangiamenti impeccabili e gli smalti adult
country rock ed è chiaro che il ragazzo per primo
ha giocato in consapevolezza di questi limiti: ben
7 brani sono stati scritti e cantati dalla Mystic Valley, un aspetto non trascurabile per un innegabile
egocentrico. A riprova le restanti canzoni, più figlie
dell’interpretazione che della scrittura, come dire,
parando sul sicuro si rischia un bell’anonimato, pur
con qualche centro (Ten Women su tutte). Vi accontentate?
Dragon’s pare essere se ascoltate in fila il lungo intro
del brano successivo, Teeth Of All Types. E in Nicaragua c’è un crescendo che non è poi troppo dissimile
dai Cul De Sac.
In Wrong Way la pseudo-MArshall sembra venire da
uno pseudo-Moon Pix. Ma c’è contenuta nella stessa
traccia anche la chiave dell’ironia, dietro i gridolini in
coda alla canzone. Ma ciò che riesce meglio al combo è la riproduzione della scena post-fok, al punto
che Strong Swimmers come altri brani contengono al
loro interno piccoli decostruzionismi country-folk.
Il tutto senza troppe nostalgie, solo con un senso
del sostrato culturale.
Ps: Ovviamente la cantante non è Chan Marshall; si
chiama Shana Cleveland.
(5.5/10)
(7/10)
Alessandro Grassi
Gaspare Caliri
Curious Mistery (The) - Rotting
Slowly (K Records, Mag 2009)
G enere : post - folk / songwriting
A primo ascolto non è affatto un mistero; non si pensa solo “questa somiglia a Cat Power”, ma “questa
è Cat Power”. Di volta in volta sembra accompagnata dai Dirty Three, dai Low, da tutte le più famose formazioni del folk
desertico dello slo-core.
E infatti Rotting Slowly è un disco americano
fino al midollo, che viene
in qualche modo dal giro
Red Red Meat e Calexico, come da mille altre Americhe del rock.
Tornando alla cantante, rimaniamo colpiti dalla prossimità a Chan per il modo inconfondibile di trattare
la debolezza melodica, la debolezza della linea melodica della voce, tramite quella che comunemente
si chiama “stecca”, ma che se usata in modo saggio
dà un tocco distintivo e quasi struggente, una dimostrazione di coinvolgimento e sensibilità in prima
persona a quella debolezza, a quelle ferite. Insomma,
abbiamo deciso, come si faceva nel Medioevo per le
opere dei padri della chiesa della cui paternità non
si era proprio sicuri, di chiamare la voce femminile dei Curious Mistery la pseudo-Marshall, tipo
lo pseudo-Kilwardby. C’è anche una voce maschile,
comunque, e ci sono anche brani senza voci; in effetti i brani strumentali (Dragon’s Crotch, che sembra suonata dai Meat Puppets) sono avvincenti;
sembrano essere il preludio a qualcosa – cosicché
Depedro - Self Titled (Pias, Apr
2009)
G enere : desert pop - rock
Chi nell’autunno scorso presenziò ai concerti italiani dei Calexico ricorda forse - nel ruolo di spalla
e “sideman” - la figura discreta di Jairo Zavala in
arte Depedro, cantautore madrileno del quale solo
ora si rende disponibile questo disco fuori dalla madrepatria. E poiché la regola popolare del “dimmi
con chi vai“ di rado sbaglia, non faticherete a capire
quali atmosfere si respirano nella dozzina scarsa di
brani qui contenuti: Messico e nuvole, polvere del
deserto e passi cinematici, arrangiamenti stratificati
e cura del dettaglio. Presupposti ottimi e altrettanto
valga per la presenza del duo Burns/Convertino,
accompagnati dagli scudieri Jacob Valenzuela e
Craig Schumacher.
Il guaio è l‘ugola di Jairo, clone dello Sting maturo
ripiegato su un irritante birignao che affossa la scrittura, di per sé appena discreta qualora non vacua e
banale (esemplare il pessimo rock “un po’ latino”
Comanche.) Si fosse limitato a inseguire le timbriche
alla nicotina dell’amico Joey - come nelle passabili
Tomorrow e Two Parts In One - avremmo scritto di
un gradevole artigiano con conoscenze importanti.
Invece no, lodiamo la regia strumentale e il resto
mancia; c’è soltanto colorata buccia e niente polpa.
Consola il fatto che ci è risparmiato un possibile effetto Jarabe De Palo. Quello no, non l’avremmo
proprio tollerato.
54
/ recensioni
(5/10)
Giancarlo Turra
highlight
Blank Dogs - Under And Under (In The Red Records, Mag 2009)
G enere : synth - pop lo - fi
Eccolo di nuovo, mr. Blank Dogs, ormai ufficialmente affetto da elefantiasi compositiva. I suoi
(molti) detrattori diranno che è semplice di questi tempi, con tutto l’hype che circonda la sigla,
trovare etichette disposte alla pubblicazione di ogni suo vagito nella speranza di poter sfruttare
le potenzialità (ehm) commerciali del suddetto; o addirittura, qualcun’altro dirà che è ancora più
facile produrre vagonate di canzoni che alla fin fine hanno ben poco
di originale e si somigliano pure quasi tutte tra di loro.
Però, c’è sempre un però. Stavolta a mettere il proprio marchio su
Under And Under è la In The Red, etichetta che non ha certo bisogno di farsi pubblicità, visto il catalogo alle spalle. In secondo luogo
perché, ognuno la pensi come vuole, sotto la coltre di rumore in lo-fi
(anzi, sarebbe meglio dire no-fi) architettata da Sniper non c’è solo
fumo, bensì molto arrosto. L’effetto sorpresa di queste piccole e semplici canzoni di matrice synth-wave sepolte sotto cumuli di rumore è
bello che scaduto, e dunque a restare è la qualità delle canzoni che, pur giocando con una tavolozza di colori piuttosto esigua (diciamo tra il nero JD e il grigio synth-wave), valgono eccome.
L’opener No Compass, la finto-Cure Falling Back, la già edita Setting Fire To Your House sono al solito
gemme liofilizzate di mille ascolti passati, ma riescono a mantenere intatto il fascino della prima
volta.
Qualche spigolatura prima di chiudere. Della partita sono anche Vivian Girls e JB dei Crystal
Stilts, mentre l’edizione in doppio vinile promette ben 5 pezzi in più.
(7.2/10)
Stefano Pifferi
Dirty Projectors - Bitte Orca
(Domino, Giu 2009)
G enere : P rog pop / A vant - garde
Possiamo dire di “averlo visto crescere”, come
fanno gli amici di famiglia con i figli che diventano
grandi. È da anni che ci interessiamo e stimiamo il
lavoro di Dave Longstreth, seguendo passo passo
le sue rocambolesche sperimentazioni musicali, che
hanno saputo accostare nel tempo, sorrette da un
poco comune spirito avanguardista e un’ apertura
alle influenze senza limiti, la musica da camera, il
rythm’n’blues,il folk e il progressive. Nessun passo
falso finora, per il compositore/cantante/chitarrista
residente a Brooklyn, neanche dopo la decisione
di cristallizzare (almeno per ora) il progetto in un
quartetto fisso, completato da Brian McComber,
AngelDeradoorian e la vocalist Amber Coffman. E possiamo affermare, dopo l’ascolto di Bitte Orca,
quinto album firmato da Longstreth, che Dave non
ha perso la bussola, neanche nel momento delle dif-
ficili conferme, quello in cui gli artisti, forgiato ormai
uno stile definito e autonomo, tendono a fissare
le loro idee a scapito della sperimentazione. Dirty Projectors ormai, richiama uno stile ben preciso,
costruito su saltellanti ritmiche irregolari e sincopate, cori dissonanti, su quel particolare modo di suonare la chitarra di Dave che tanto ricorda la mbira
africana e su melodie poco lineari, che procedono
per salti ampissimi, intonate con la particolarissima
impostazione vocale del Nostro. Tutto questo è Dave Longstreth e tutto questo
è Bitte Orca. Niente di più e niente di meno che
un’occasione per fermarsi, per lasciar decantare le
idee messe in campo finora. Certo è che, a partire
dal singolo scelto come apripista per l’uscita dell’album, Stillness Is The Move (il cui titolo potrebbe, per
una simpatica coincidenza, sottoscrivere il discorso
fatto finora), si nota una disposizione alla semplificazione che è un po’ la base di tutto l’album, ben
lontano dalle arzigogolate strutture di The Getty
recensioni /
55
Address e più equilibrato nei timbri vocali, con la
voce della Coffman a fare da dolce contraltare femminile ai gorgheggi di Dave. Quello di Longstreth non è, però, un riparo verso
le forme più tranquillizzanti (per il pubblico) della
canzone ma un tentativo di contenere la creatività in spazi più piccoli, senza esitare a decostruirli
a piacimento, come avviene negli zig-zag ritmici di
Temecula Sunrise, nell’incerto dondolare di The Bride,
che sfocia in un improvviso riff alla Led Zeppelin, o nel minimalismo di No Intention. Ma sappiamo
che, anche nella semplicità, a Dave piace, di tanto
in tanto, complicare le cose. Ed ecco allora, il prog
di Useful Chambers, che mescola elettronica, hard
rock e passaggi corali che ricordano i primi Queen. È così marcato Longstreth questo album, da far
passare quasi inosservata la partecipazione di gente
come Sufjan Stevens, Decemberists e Grizzly Bears. È lui il più “sporco progettatore”. Nel
bene e nel male. Ma soprattutto nel bene.
(7.1/10)
Daniele Follero
Discharge - Disensitise (Vile Art,
Mar 2009)
G enere : hard - core
Autoprodotto e venduto ai concerti già da agosto
2008, ora stampato da Vile Art, il nuovo album, 14
pezzi, 37 minuti, dei Discharge non si distanzia troppo dal disco dell’homecoming D-beat, l’omonimo
datato 2002. Troviamo la stessa miscela di hardcore
punk (la ritmica, la voce) e metal tra hard e thrash
(la chitarra, soprattutto nei soli).
E si capisce quanto la batteria possa fare la differenza: con un doppio pedale di mezzo, la nostra percezione sarebbe sbilanciata sulla seconda componente, mentre così puntiamo più sulla prima. Prevale
allora il tu-pa tu-pa marchio di fabbrica della band
(non mancano piccole variazioni, come Becomes
Again and Again), i pezzi sono le solite aggressioni
fisiche, i riff portanti il solito esercizio di compressione ossessiva su un ristretto repertorio di accordi e dinamiche. La formazione è quella stabile dal
2006: il nuovo batterista Dave Caution, “Proper”,
due membri storici, Roy Wainwright, “Rainy”, e Tony
Roberts, “Bones”, e a sostituire il cantante-simbolo
Melvin Morris, “Cal” (la voce dell’epico ed epocale
Hear Nothing... dell’82), Anthony Martines, “Rat”, dai
discepli Varuckers. La sua è una voce più “attuale”, meno declamatoria, diciamo tra l’HC classico e
certe sporcature crossover, forse per questo meno
56
/ recensioni
personale.
I Discharge sono mitologia, c’è poco da dire, tra i
primissimi a prendere e mischiare da punk e metal,
aprendo la strada alle loro ali più estreme, crust e
grind, influenzando dai Napalm Death (e quindi
anche gente come lo Zorn Naked City) ai Metallica ai Sepultura (e quindi molte frange Nu)
ai Boredoms. Ma oggi il loro peccato più grande
pare quello di rincorrere proprio quegli stessi fenomeni che hanno contribuito a fondare.
(5.7/10)
Gabriele Marino
Disrupt - The Bass Has Left The
Building (Jahtari, Feb 2009)
G enere : nerdy microdub
Se non hai giocato almeno 8 ore al giorno per
plurime estati invece di andare al mare, o se andavi al mare (perché eri costretto) e non avevi i calli per le partite alle Olimpiadi in sala giochi
non puoi capire questo disco. Questa è la rivincita dei (breakbeat) Nerd che si stacca del basso
(vedi il titolo programmatico) ed estremizza la lezione di Harmonic 313 (Hail The Robots) sputtanandosi come solo gli innamorati sanno fare.
Una palese dichiarazione d’amore per i
Kraftwerk, per la
scena electro d’antan à
la Mantronix e per il
dub puro. Nostalgia fine
a se stessa? No, in questo 2009 la tendenza
è questa, solo che nessuno l’aveva applicata
così pedissequamente al dub. Con l’esperienza di
un disco del calibro di Foundation Bit (guardacaso su Werk, 2007), il nostro Jan Gleichmar
se lo può permettere. Anche se esagera un po’, noi
nerd siamo consapevoli che qui l’eccesso porta innovazione. E quindi ben venga l’ortodossia in slow
motion (It’s More Fun To Dubpute), la dimensione
glitch-chill (Impossible Mission III), le voci nelle intro
e la sirena di Echobombing che fanno tanto ‘ardkore continuum, la dimensione spacey vicina alle visioni di Luke Vibert e i cut sporchi old school.
Praticamente un dancefloor stoned popolato di robot drogati di slo-mo-breakdance. Una visione che
ha tonnellate di prodromi glitch-dub (il lungo intervallo che va da Mad Professor a Pole), che oggi per
farla così fresca si rischia veramente il culo. Only the
strong will survive, e stavolta il nostro per salvarsi
è diventato un transformer. Esce dal dub classico e
prende una strada a 8 bit con lo sguincio alle roots.
Senza alcun tipo di ‘-step’. Disrupt is the coolest robot.
(7/10)
Marco Braggion
Dj Hell - Teufelswerk (International Dee Jay Gigolo Records, Mar
2009)
G enere : VIP tronica
Europa + Elettronica + Eredità = Berlino. Quando
dici classe e storia dici Hell. Lui alla 250ma uscita
per la sua monumentale Gigolo esce con un doppio
che ha nelle vene tutti questi ultimi anni di vagabondaggio electro.
Che sia minimal, che sia techno, che sia progressivo o che sia un oltraggio, la mecca attorno a cui ruota tutto il pianeta ritmo si riconferma di importanza cruciale per la costruzione di
uno stile solido, un’ortodossia post-Kraftwerk.
E allora per fare la cattedrale di solito si chiamano
i migliori progettisti. I nomi sono Peter Kruder,
Roberto Di Gioia, Christian Prommer, Anthony Rother, la G-Stone di Vienna, i cameo di
Bryan Ferry (U Can Dance) e P. Diddy (The DJ).
Il lavoro è organizzato in due parti. Day e Night. La
notte parte con la bordata di Ferry che è uberminimal con dei bassi da panico, senza compromessi,
puro stile Gigolo. Si va poi direttamente in Autobahn con Electronic Germany e allora risenti tutto
quello che ti hanno detto i robot di Düsseldorf direttamente in acido vocoderato, vai poi di brutto
nel soul più cupo con lo spoken di Diddy e ti gasi,
perché anche se non sono mixate queste tracce
hanno un tiro che spaventa.
Un tunnel che Canzian ha stravolto e che qui ha un’aura di perfezione barocca da brivido: vedi il 10 minuti
di The Disaster che sono già là nell’olimpo della trance
più progressiva che mai, i glitch sexyminimal da urlo
di Bodyfarm2 e quella cosa post-Jack che è Hellracer.
Si passa poi al giorno e qui la mano di Kruder e
Prommer si sente di brutto, con quello stile Vienna
che fa suoni ovattati e che è G-Stone. La hybris
scende un po’ e visto che la sommità del monte
Olimpo è già stata conquistata ci si adagia su una
lounge room infinita, il recupero dell’eredità Tangerine Dream (Germania) e dei suoni puliti postsballo. L’importante è non citare troppo nè il passato
nè il futuro. Qui si è. Per una volta la consapevolezza
di rappresentare uno stile che solo pochi eletti incarnano, senza nascondersi dietro mode effimere.
Hell is the king of the VIP area.
(7.4/10)
Marco Braggion
DJ Olive - Triage (Room40, Dic 2008)
G enere : S oundscapes
Disco appositamente concepito per conciliare il
sonno, Triage del DJ Olive, chiude un percorso,
quello delle Sleeping Pillows, iniziato con la label
Room40 nel 2004 con l’uscita di Buoy e proseguito, esattamente due anni dopo, con la pubblicazione
di Sleep.
Il discorso, per Triage, progetto sonoro nato come
installazione per la Biennale di Whitney del 2008,
potrebbe limitarsi alle tecniche di scrittura, tra timbriche che si vanno sfaldando progressivamente e
ricercato rallentamento ritmico.
Ma la poetica dell’artista, esemplificata anche dalle
sue passate collaborazioni (Christian Fennesz, David Watson, Vija Brazus,
Karl Francke e DJ Reaganomics) va ben oltre
questi rilievi, facendosi
mezzo di un delicato linguaggio elettroacustico
sulla texture. La base di
partenza è una materia
grezza ottenuta con una
strumentazione più o meno acustica (percussioni,
chitarra, cornamuse e synth), ma successivamente
trasformate con innegabile grazia, filtrata e consegnata in frequenze, loop, ondularità in sincronismo,
similitudini o contrasti che inducono nell’ascoltatore un effetto quasi anestetizzante, un continuo alternarsi di stati della mente e di percezioni.
Un ristoro indispensabile per chi sentisse la necessità, una buona volta, di abbassare, per poco più di
mezz’ora, il livello di vigilanza e consapevolezza.
(6.8/10)
Sara Bracco
El Perro Del Mar - Love Is Not Pop
EP (Licking Fingers, Apr 2009)
G enere : electro pop
Mini album o ep lungo che dir si voglia, questo Love
Is Not Pop suona come un passaggio importante
nella carriera di Sarah Assbring, conosciuta ai più col
curioso moniker El Perro Del Mar. Prodotto da Rasmus Hägg, ovvero una metà del duo electro scan-
recensioni /
57
highlight
DJ Vadim - U Can’t Lurn Imaginashun (BBE, Mag 2009)
G enere : electro reggae - dub
Dalla Ninja alla Berlino della BBE. Vadim cambia rotta scostandosi dalla sampledelia strumentale
guardando all’organicità del dub. Ovviamente le radici sono là, nei magici 90 in cui l’etichetta londinese spopolava con Funky Porcini e Amon Tobin. Ma oggi l’imperativo è aggiornarsi al melt-hop.
E anche se l’obiettivo non è dei più facili, il giovanotto occhialuto ci riesce senza troppi problemi.
La ricetta la senti dall’intro: ‘Paris to London, France to England’ dice la voce del doppio featuring
di Big Red e 5nizza. La matrice comune delle due metropoli è il
reggae. Non sorprende, almeno a noi, che già con Missill avevamo
sentito questa connessione. Solo che dopo la virata dub di un re dello step del calibro di Disrupt, qualche antenna verso Kingston si è
ulteriormente allungata. E allora oggi a sentire questa Selecta nel migliore stile roots ti vengono le molle ai piedi ed è inevitabile ballare.
A guardare bene poi questa traccia Londra Parigi poi finisce a Berlino.
Come a dire che l’eco Rhythm And Sound non è per niente distante.
Ma se là c’erano le equazioni di scuola Hard Wax e quindi ci si andava di
spigoli e di filtraggio visionario, qui, visto che il nostro ha la tecnica Ninja nei polpastrelli, ci si va di
gusto per il cut-up. Suoni di vocoder robotici (R3 Imaginashun, Saturday), soul da strada arricchito
con archi uberjazz (That Life), dubsteady senza compromessi (Under Your Hat), french-hop di classe
(Maximum) e le inevitabili tracce strumentali che inframmezzano con ricordi pieni di stile a 8-bit.
Vadim è tornato al posto giusto e al momento giusto. Senza l’intellettualismo nerdy che lo avrebbe fatto cadere nella ripetitività, con la leggerezza che solo i grandi sanno di avere in tasca. Poker
d’assi per lui.
(7.3/10)
Marco Braggion
dinavo Studio, trasla il già noto talento per le trepidazioni oniriche della ragazza in una dimensione
ancor più evanescente e ipnotica, costeggiando soul
algidi vagamente Eurythmics con giocosa grazia
Royksopp e garbo malizioso Isobel Campbell
(Heavenly Arms), surgelando morbose apprensioni
Notwist (L Is For Love) e solenni gelatine Mùm
(Is It something) nella ghiacciaia lirica Goldfrapp,
rischiando talora una trasfigurazione Enya che graziaddio non arriva (A Better Love).
La veste sintetica non stravolge la calligrafia di Sarah,
anzi le dona un erotismo differito (la deliziosa Change Of Heart), conferendole una levigatezza liquida
dove puoi scorgere inquietudini fantasma tipo una
Kate Bush stregata Cocteau Twins (Let Me
In), dove la wave pop trova modo di narcotizzarsi
Bacharach (I Gotta Get Smart).
In tutto ciò lei si muove agile come in una pelle
appena mutata.
58
/ recensioni
Confezionando un piccolo, soffice gioiello pop. E se
non è amore, pazienza.
(7/10)
Stefano Solventi
EL-B - The Roots Of El-B (Tempa, Apr
2009)
G enere : drum & bas s , dubstep
Evidenza è che da qualche tempo sia in corso una
riscoperta del drum and bass: mai davvero scomparso da che finì sotto i riflettori tre lustri or sono,
a questo fenomeno è andata dunque assai meglio
che al downtempo. Rientrato nella nicchia d’origine,
si è in tal maniera sottratto allo sgradevole ruolo
di tappezzeria sonora; nel frattempo lasciava che
i suoi metodi produttivi “casalinghi” penetrassero
dapprima nello UK garage e poi in dubstep e grime.
Quello stile metropolitano al sapor di ketamina che
restituisse lo stordimento di una vita in progressiva
accelerazione e l’agio di fare musica approfittando
dell’innovazione tecnologia prendeva infatti le mosse nella prima metà dei Novanta. Quanto tale sentire sia ancora attuale è fatto noto ai capoccia dela
Tempa e a Lewis Beadle a.k.a. El-B (da Streatham,
Londra sud), qui oggetto di compendio in quindici
rari “white labels” e remix risalenti all’inizio del corrente decennio.
Sorta di cerniera tra le due epoche, El-B raccolse
in quell’epoca un’interessante combriccola attorno
alla propria etichetta Ghost, adattando ritmi drum
‘n’ bass e spazialità jungle al nascente UK garage,
ostentando spesso e volentieri uno stile piuttosto
personale. Sarà un caso, ma è proprio lì che il corposo programma offre quanto di più memorabile e
cioè una Among The Stars indecisa tra jazz reinventato e Arabia e le tastiere cosmiche in orrorifico
divenire di Serious, l’incontro tra soul e ragamuffin
Neighborhood e l’algida Celebrate Life. Tutto questo e il classicismo che muta pelle in Show A Little Love
e Time Out - inducono a raccontare una figura acuta e affatto schiava dei luoghi comuni. Un nome da
riscoprire nel frastagliato panorama “post-dance”
d’oltremanica: indagate e non ve ne pentirete.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Eric Woolfson - The Alan Parsons
project That Never Was (Limelight
Records, Apr 2009)
G enere : P op
Eric Woolfson canta l’Alan Parsons Project
che non è mai stato. Ovvero, il co-fondatore di uno
dei più celebri progetti che si ricordino nella vita relativamente breve della musica pop, tenta di uscire
dall’anonimato dopo tanti anni vissuti, di nome e di
fatto, all’ombra del famoso produttore inglese, rispolverando alcuni brani scartati in passato dai due.
Scartati, soprattutto, a detta dello stesso Woolfson,
per volontà di Parsons, con il quale, evidentemente,
la complementarietà delle esperienze non compensava del tutto le discordanze nelle scelte estetiche. Operazione pretestuosa, a dir la verità, e utile soltanto a chiarire i motivi dell’esclusione dei brani in
questione dal repertorio dell’APP. Canzoncine innocue come Golden Key e Rumor Goin’ Round, (appartenenti, peraltro al periodo più buio del duo, quello
degli assai bruttini Ammonia Avenue e Stereotomy) sarebbero state meglio negli scaffali dei ricordi dell’autore, per non parlare dei nuovi lavori.
I brani tratti dai recenti musical dell’autore, Dan-
cing Shadows e Poe, si dimostrano perfettamente all’altezza (ma sarebbe meglio dire bassezza) dei
ripescaggi, con l’eccezione di I Can See Round Corner,
una mosca bianca che sta lì a ricordare che l’APP
non è stato (soltanto) un giochino da hit single da
parte di gente che conosceva il mercato musicale
come la propria casa. Inevitabili le scopiazzature (l’arpeggio di Immortal
richiama quello di Eagle Will Rise Again, anche se poi,
per il resto, c’è un abisso), da dimenticare gli arrangiamenti (è qui che la mancanza di Parsons crea un
vuoto imbarazzante). La voce è sempre quella. Aiutato dalle nuove tecnologie, il timbro di Woolfson è
ancora quello che ha marchiato in maniera indelebile brani come Eye In The Sky, Don’t Answer Me e Time,
diamanti del pop che ancora risuonano nelle orecchie e nella memoria di più di una generazione.
(4/10)
Daniele Follero
Farmer Sea - Low Fidelity In Relationships (I dischi de l’amico immaginario, Apr 2009)
G enere : emo indie pop
Dopo un lustro di gestazione che ha fruttato due
interessanti ep - puntualmente intercettati in We
Are Demo - i Farmer Sea concretizzano la fregola
indie-pop emozionale esordendo in lungo con Low
Fidelity In Relationships, undici tracce come
altrettanti sommovimenti dell’anima, l’epicentro localizzabile dalle parti degli Smashing Pumpkins
più quieti e accattivanti (quelli di 1979 per intendersi), con propensioni sintetiche, movenze lo-fi, retaggi post e giusto una spolverata jazzy a stemperarne
i margini. Un linguaggio che rifiuta clamori, giusto
qualche ammiccamento che però stempera ruggini
e guizzi in una costante emulsione di spleen giovanilista, canzoni da linea d’ombra come le già note
Teenage Love e Neil Young Is Watching Me (recuperate
dai suddetti ep), oppure le nuove Everywhere You Are
e Dream? Science!, coi singulti Teenage Fanclub
immalinconiti tra palpiti Go-Betweens e indolenza Malkmus. Si registrano gustose oscillazioni
stilistiche mimetizzate dalla sostanziale monotonia atmosferica, tipo la trama soul robotica a fare
sostrato in The Place Where I Sleep At Day, la forza
gravitazionale Franz Ferdinand tra fragranze
electro Yuppie Flu in Blurry Nation o la caligine
onirica da Yo La Tengo fanciulli nella conclusiva
She Dreams Of Airports And Planes. Se mancano intuizioni originali e d’impatto, i ragazzi sono altresì
recensioni /
59
abitati da una convinzione inscalfibile, dalla capacità
di calibrare gli arrangiamenti sul mood con bella disinvoltura. Un disco appagante.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Freaky Mermaids - Freaky Circus
(‘Ave It, Mar 2009)
G enere : theatrical folk
L’autodefinizione di theatrical folk calza a pennello
alle bresciane Freaky Mermaids, nate dall’incontro
fra due musiciste e un’attrice, rispettivamente Ombretta Ghidini dei Le Man Avec Les Lunettes, Angela Scalvini (già conosciuta come Angela
Kinczly con l’elettrofolk de The Legendary Indian
Aquarium and Other Stories, 2006) e Laura Mantovi,
attrice di teatro di movimento.
La formazione classica delle musiciste si fonde con
la canzone d’autore, in una sarabanda ricca di strumenti consueti e non, tra banjo, fisarmoniche, clarinetti e fiati. L’EP d’esordio si snoda tra nostalgie
evocative, songwriting
jazzy con omaggi a Tom
Waits (nel valzer con
clarinetto di The Less I
See The More I Love), carillon nella leggera White,
vaudeville con Killer Loop,
country con Love Is Here, ethno rock nella theatrical
versione di The Less I See The More I Love.
Un po’ Cocorosie, un po’ Hanne Hukkelberg,
Jolie Holland e Cat Power, le sirene strambe
confezionano un bell’esordio. Le aspettiamo sulla
lunga distanza.
(7/10)
Teresa Greco
Frogwomen/Alexander De Large
- 66.6 (Lepers Produtcions, Apr
2009)
G enere : avant psych
Sessantasei minuti e sei secondi di flusso di coscienza o free jam tra due mammasantissima di casa Lepers, uno starsi e darsi addosso a base di vaudeville
e strali jazz, blues e svalvolate hard-noise, countrydark e psych fricchettona, reminiscenze Beatles
(Oh, Darling) masticate a crudo col pane frugale lo-fi,
galleggiando in un liquido amniotico di romanticherie intossicate e sognanti come un Bowie avariato
Smog, blaterando Gino Paoli per poi abbando-
60
/ recensioni
nandosi a un lentivo soul-rock con la minaccia dietro l’angolo, cavalcando l’estro selvaggio del garage e pizzicandosi il culo di taranta a vicenda, fino a
deragliare Blue Cheer e prostrarsi in un delirio
acido da Crazy Horse all’ultimo stadio. Eccetera.
Una traccia che traccia un solco terapeutico, demoniaco, liberatorio, beffardo, stranamente gradevole.
Come un gas esilarante a basso voltaggio cui finisci
per assuefarti. Come una lunga, amichevole frustata.
In download gratuito.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Fuzz Orchestra - Comunicato N.2
(Wallace Records, Apr 2009)
G enere : noise - rock
Assume sempre più toni da chiamata alle armi, la
musica di Fuzz Orchestra, sin dalle prime note di
questo secondo album. E non solo per la sirena
antiaerea, il messaggio del testo campionato o lo
strumentale assalto all’arma bianca che Luca Ciffo,
Fabio Ferrario e Marco Mazzoldi (con l’ospite Edoardo Ricci al sax e clarinetto) inscenano nell’opener
Il Terrorista.
È tutto l’immaginario – sonoro, filosofico, grafico –
evocato dai tre + 1 a scuotere, ancor più che in
passato, le coscienze di chi ascolta, ricordare ancora
una volta, ancora di più che la musica è (comunic)
azione, non solo barzelletta da lustrini e paillettes.
Sin dall’iconografia della copertina, graficamente
ineccepibile nel suo b/n sparato in faccia; sin dal suo
avant-noise corposo e monolitico; sin dal messaggio delegato, come sempre, a stralci di dichiarazioni
politiche, brani cinematografici, interferenze radio e
quant’altro campionato sapientemente dal trio, Fuzz
Orchestra rivendica un messaggio, uno scuotimento
dall’apatia.
Musicalmente Comunicato N.2 è ancor più virato al nero e cupo rispetto al debutto, forse per essere al passo coi tempi. Questo non significa che le
8 tracce siano omogenee o statiche, anzi risultano
ancora più screziate e variegate nella commistione
di pesantezze doom, svisate free, compatti attacchi
noise-core in cui prende ancora più senso anche
una acidissima cover di Volo Magico N.1 – ribattezzata Volo Fuzz N.1 – di Claudio Rocchi.
Fuzz Orchestra sconquassa ampli e coscienze e
proprio per questo merita rispetto ed attenzione.
Anzi lo esige.
(7/10)
Stefano Pifferi
Gentleman Reg - Jet Black (Arts &
Crafts, Feb 2009)
G enere : I ndie pop
Già al centro della scena indie del suo paese attraverso collaborazioni e militanze (Hidden Cameras e Broken Social Scene tra gli altri), il
canadese Signor Reginaldo anche stilisticamente si
pone all’incrocio di varie correnti dell’indie pop, con
una personalità che si afferma più nella scrittura e
nella varietà di influenze e richiami che non nella
creazione di un marchio sonoro immediatamente
riconoscibile (la vocina ruvida ed esile ne ricorda
altre, e anche le chitarre si adattano -bene- ai pezzi
più che dare un’impronta loro). Un po’ come i suoi
ex-sodali ma meno folle, più misurato sia nell’ironia
che nei momenti più seri.
Nel primo disco “vero” per la Arts & Crafts (il
precedente compendiava i primi tre, cui la piccola Three Gut Records non aveva potuto garantire
grande diffusione), il nostro vaga tra pennate glam
(Coastline) che a volte fanno un passo indietro verso
gli Stones, morbidezze veloci alla Belle & Sebastian (To Some It Comes Easy, ma anche altrove)
e morbide ballads (splendida Oh My God su un tappeto percussivo tra il Robbie Robertson pellerossa e certo Peter Gabriel); e quando in Rewind
rischia di eccedere in morbidezza vira subito dopo
sulla cassa in 4 e i vocalizzi quasi night-soul di We’re
In A Thunderstorm (offerta anche “a pezzi” sul sito
per farla remixare ai fans).
Fans che potrebbero crescere, visto il buon livello
del canzoniere, basta non crearsi false aspettative
facendosi ingannare dal titolo: Jet Black non c’entra nulla col batterista degli Stranglers, significa
“nero come il carbone”. E tra l’altro il disco non è
neanche tanto nero, diremmo piuttosto che, magari
senza accecare, ma in più di un punto splende.
(7/10)
Giulio Pasquali
Giorgio Tuma - My Vocalese Fun
Fair (Elefant Records, Mar 2009)
G enere : pop jazz lounge
Una cosa è azzeccare un plotoncino di belle melodie. Un’altra è allestire una calligrafia, un ambiente,
un mood ben definiti. Altro ancora è riuscire a fare
entrambe le cose. Eh sì: con My Vocalese Fun
Fair il salentino Giorgio Tuma mette a segno uno di
quei dischi capaci di segnare una carriera. Già l’album
di debutto Uncolored (Amico Immaginario, 2005)
lasciava intuire la qui presente straordinaria capa-
cità di impastare languori bossa, morbidezze folk,
suffumigi cosmic-pop e stregonerie jazz-soul come
se, abitandogli tutti assieme in qualche stanzetta del
cuore, fosse la cosa più naturale del mondo.
Canzoni sbocciate senza sforzo apparente, che siano dei beat pastello avvampati Beach Boys (Saltamontes), dolciastri northern soul screziati di clavinet
e flauto (Coney Island Memories), digressioni bucoliche come Clientele ipnotizzati Polyphonic
Spree (Musical Express) oppure palpitazioni spacey
tra fatamorgane beat (Astroland By Bus), sempre col
tremolio bossa sullo sfondo, come vecchie istantanee vacanziere dai colori dileguati, con le allegrie
dolciastre e gli incantesimi obliqui (Let’s Make The
Stevens Cake!!!), coi pensosi miraggi da salotto (Dedicated To Timmy The Whale), gli spersi malanimi (ML
DB) o la circense apprensione (Faye’s Flying Shoes).
È un gioco accurato che prevede sapienti impasti
vocali (tra cui quella seducente di Matilde De Rubertis, già Studiodavoli), pianoforti trepidi, organi e fisarmoniche all’occorrenza, più un costante
disincanto che alleggerisce il senso di ossessione, così che mollezze e
malanimi somiglino ad
una spuma, tanto più effimera e burlona quanto
più struggente e maliosa.
Del resto, cosa attendersi da chi ha battezzato la
propria backing band Os Tumantes? Invischiato
com’è in un soffice immaginario vintage, viene spontaneo dire: un disco che crea un’atmosfera.
(7.4/10)
Stefano Solventi
Gomez - A New Tide (ATO, Apr 2009)
G enere : folk rock
Quei bravi ex-ragazzi dei Gomez. Senza rinnegare
ciò che sono stati e che - giustamente - non potranno essere più, decidono di scremare la verve
giocherellona, sedare le derive psych e stemperare
certi azzardi electro. Ragion per cui questo A New
Tide - sesto album d’inediti e secondo per la ATO
di Dave Matthews, prodotto da un’autorità in
materia come Brian Deck (già Red Red Meat dal cui repertorio arriva il singolo Airstream Driver
- e Califone e al lavoro per Iron & Wine, Josh
Ritter e Counting Crows tra gli altri) - non
ti sembra più quella gincana d’idee ed espedienti,
generi e atmosfere, umori e azzardi che così pesan-
recensioni /
61
temente - e talora gradevolmente - li caratterizzava
nei primi lavori. Quello era appunto ciò che non
potevano - non dovevano - essere più.
Per continuare ad esserci era necessaria una resa
dei conti con la capacità di scrivere canzoni in grado di stare in piedi da sole. Poi è chiaro che non si
smette di essere i Gomez così da un giorno all’altro. Ecco infatti che nella verve suadente di Natural
Selection, tra i guizzi quasi Eels di If I Ask You Nicely
o nel fervore cyber-folk di Win Park Slope (tipo i
Califone - inevitabile influsso Deck - soggiogati Radiohead) finiscono col sembrarti i soliti nerd da
laboratorio col pallino degli alambicchi sonori. Ma la
vera novità è che forse per la prima volta un disco
dei Gomez si arricchisce col passare degli ascolti,
rivelando una raffinatezza di scrittura che spesso e
volentieri sopravanza l’acume strutturale e delle orchestrazioni (le trepide Other Plans e Bone Tired, la
quasi pearljammiana Very Strange...).
Insomma, una specie di rivoluzione copernicana. E
alla fine, pur in questa dimensione da band oramai
normalizzata, fanno la loro più che discreta figura.
(6.7/10)
Stefano Solventi
Great Lake Swimmers - Lost Channels (Nettwerk Music Group, Mar
2009)
G enere : I ndie
Quarto album per i “nuotatori del grande lago” della malinconia, medesimo specchio d’acqua nel quale
in molti si sono specchiati dopo che i Red House
Painters mossero le prime lentissime onde circolari. Questi cinque canadesi, capitanati da Tony Dekker, nel 2003 decisero addirittura di tuffarsi nello
slow core e nuotare in puro stile folk, forgiando così
album fuori dal tempo per dilatazione sonora ed
evocazioni ancestrali.
Lost Channels non fa che continuare il tragitto trascorso agitando però le acque in superficie. Infatti, le
dodici canzoni che compongono l’album sono come
mosse da una fresca brezza primaverile che le rende
movimentate quel tanto da farsi piacevolmente apprezzare. Ovviamente, basta solo osservare l’abisso
per rendersi conto di quale nostalgica lentezza sta
alla base della loro cifra stilistica, espressa fedelmente in Concrete Heart e Stealing Tomorrow. Ma c’è da
felicemente constatare che l’aumentare e il rullare
della risacca, alla stregua dell’ultimo Iron & Wine, di
molti episodi rappresentano il vero valore aggiunto
di Lost Channels. Che in futuro sia anche possibile
62
/ recensioni
fare surf nel “grande lago”? Questo è improbabile,
ma sicuramente oggi i Great Lake Swimmers sono
riusciti a rianimare un vento antico e salvifico in grado di allietare durante le ore della Canicola.
(7/10)
Andrea Provinciali
Grizzly Bear - Veckatimest (Warp
Records, Mag 2009)
G enere : surf balearic folk rock
Il brivido Stone Roses, i lenti di Neil Young quando ancora li scriveva (All We Ask), i Modest Mouse
mescolati ai Supertramp (Two Weeks): praticamente
dici rock acustico e visione in eco Mercury Rev. Ma
non solo Rev, anche Freddie. Periodo A Night At
The Opera, con quel barocchismo che arrivava al
limite e quasi scoppiava. La regina c’è perché questo è un disco 70. Anche se sull’etichetta c’è scritto
Warp, non confondetevi. Ogni tanto anche in UK
sparigliano le carte. Qui l’elettronica è scomparsa.
Solo voci, cori a cappella à la Beach Boys e tanto
tanto camp che inevitabilmente si rifà ad una cento mille icone. Last but not least: David Bowie.
E questo salto che ci riporta alle settimane astrali di
Van Morrison e ai King Crimson di Islands è il
segno che il sole di Brian Wilson splende ancora
ed ha voglia di farci sorridere con quelle strumentazioni prettamente baleariche (vedi le percussioncine di Cheerleader o le chitarre woodstockiane di
While You Wait For The Others) e con quelle voci distillate di bianco ma comunque piene di anima (Foreground, Fine For Now). Per finire, la connessione con
gli Akron Family l’avevamo sentita nel Friend
EP di qualche tempo fa, ma qui il sentire estatico si incarna ancor di più nelle atmosfere pastello con l’aura fumè che fanno retrostyle e coolness.
Il nuovo corso del rock guarda ancora una volta agli
anni d’oro, a quella Mecca settanta di sperimentazione convogliata poi nella wave 80. La rivisitazione
ha del magico e ci ricorda per un momento che in
questi anni 00 si può sognare senza glitch. L’orso
grizzly ha lanciato l’incantesimo dall’isoletta sperduta Veckatimest. Lasciamoci ammaliare.
highlight
Gala Drop - Self Titled (Gala Drop Records, Feb 2009)
G enere : giungl a dub cosmica / fourth world
Se fossimo portoghesi e volessimo un contributo al missaggio di qualche figura rilevante, a chi ci rivolgeremmo? A Rafael Toral, probabilmente. Così hanno fatto i Gala Drop, cioè Afonso Simões, Nelson
Gomes e Tiago Miranda. Nota di cronaca; punto e a capo. Segnaliamo
la cosa solo per contestualizzare in quella Lisbona questa autoproduzione; se infatti anche per Gala Drop si può – parzialmente - parlare
di spazio, bisogna precisare che l’attenzione non va focalizzata sulla
rarefazione dell’aria, ma sul punto di decollo, che avviene in un quarto mondo hasselliano, in un terreno di evidente melma dub. Insomma: Jon Hassell? Dub? Psych?
Eno-Byrne-ismi? Quando un disco è importante non ha un’etichettatura facile, specie se chi lo ha
confezionato conosce quanto te i riferimenti facili che si possono fare. Intrigante ancor di più se
chi ti sta suonando in faccia tanti colori e spezie conosce pure quelli più difficili. E se Ital è un dub
quasi sci-fi, la successiva Ubongo - un poliritmo che collega la giungla al cielo, l’Africa alla Kosmische Musik del ronzare di synth analogici - ci fa già capire lo spessore e l’entità dell’album.
Tirare in ballo My Life In A Bush Of Ghosts è un esercizio da ragazzini mentre orecchiare
l’Anas Symphonie dei Kraftwerk un po’ meno. Figuriamoci se sotto a quella fai girare un intarsio di
didgeridoo e batteria che puoi dire afro-funk come rock. È Frog Scene; roba da stenderti a terra.
Una tirata di crack. Ne vuoi ancora e subito e mica di certa robaccia in stile Laswell; i Gala Drop
sono spaccini seri che scavano in ricette serie. C’è tanto Steve Roach, quello buono che parte da Dreamtime Returns per finire fino agli Halcyon Days in compagna di Stephen Kent
e Kenneth Newby. Di più; se qualcuno già dubitasse – a ragione - della necessità d’aggiungere
qualcosa a quelle splendide ricerche, al senso del magico e alla serietà da etno-musicologici, gli
abili Gala Drop oppongono un bello stempero alla On-U di Adrian Sherwood. Altra scuola
furba da cui attingere, un buon modo per buttarla sul trip senza banalità, per liberarsi da pesanti
confronti ma anche per aprire certe porte percettive (Dabum).
Come se non bastasse, a tracklist già carica e soddisfacente, una Holy Heads introduce elementi
gospel come se a suonarli fossero Eno & Byrne dello scorso anno ma con la voglia di osare come
ai tempi di My Life…. E ancora: a qualcuno è venuto in mente un confronto con gli Animali più
trendy dell’underground? In chiusura la psych liquida in odor di down tempo di Crystals ricorda
persino la batteria spezzata e tamburelli del miglior McCombs (Tortoise dove siete?). Ma soprattutto c’è Parson. Una sfida. Sherwood + progressioni kraute + gospel afro. Di più: c’è tutto il
mondo di Mark Stewart, Pop Group compreso, che si trasmuta ancora in un dub astrale, con
tanto di muggiti dei synth da manuale, e poi in una cavalcata tropicale. Forse il brano più riuscito
dell’album. Forse quello che risente meno degli automatismi da sballo dub, l’unico elemento di
pesantezza (o stagnazione) di questo Self Titled. Ma, l’avrete capito, è il pelo nell’uovo. Cercatevi
il disco, piuttosto che il pelo.
(7.5/10)
Gaspare Caliri, Edoardo Bridda
(7/10)
Marco Braggion
Hanne Hukkelberg - Blood From A
Stone (Nettwerk Music Group, Apr
2009)
G enere : pop
Hanne Hukkelberg, colei che ci estasiò in Little
Things (2004) e addolcì nel successivo Rykestrasse
68 (2006) torna.Torna con un disco che è la naturale somma delle precedenti sortite. Novella trentenne (compiuti il mese scorso), la norvegese si è fatta
artista meno estrosa a vantaggio di un songwriting
quadrato, o per meglio dire, maturo. Bent Sæther
(Motorpsycho) e Ivar Grydeland (Huntsville)
sono tra i tanti che aiutano Hanne per questo Blo-
recensioni /
63
od From A Stone. Dieci tracce che all’esuberanza di
un tempo preferiscono la forma asciutta e ordinaria
del modello Bjork (Midnight Sun Dream e la graziosa Blood From A Stone). Dimentichiamoci quindi
le astruse trovate che ce l’hanno fatta amare e che
rendevano il suo debutto spigoloso e amorevole
insieme. Dopo un attento ascolto, salvo la wave al
femminile di No One But Yourself e la wyattiana Salt
Of The Earth da ricordare rimane ciò che la Hukkelberg era e ciò potrebbe diventare.
Momento di transizione. La classe rimane intatta.
determinati strumenti (per la cronaca: un sintetizzatore modulare Buchla, combinato ad un computer
analogico Comdyna) e dei complessi processi elettroacustici che stanno alla base della composizione dei brani, è proprio l’essenza materica dei suoni,
che acquistano volume quasi fossero oggetti solidi, a
colpire l’ascoltatore attento. Qualcuno (forse molti)
potrebbe gettare la spugna dopo i primi tre minuti.
L’invito è quello di riprovarci almeno una volta, tenendo conto di queste piccole avvertenze.
(7/10)
Daniele Follero
(6/10)
Gianni Avella
Hecker - Acid In The Style Of David
Tudor (Emego, Mag 2009)
G enere : A vanguardia E lettronica / 3D S ound
Avevamo già avuto modo di ascoltare (ed apprezzare) il radicalismo dell’elettronica di Florian Hecker, in occasione di una raccolta di registrazioni
pubblicate per la Rephlex di Aphex Twin (Recordings For Rephlex, 2006). A distanza di quattro
anni, dopo una miriade di collaborazioni e una vasta
produzione di musiche concepite per installazioni,
il compositore tedesco, dà vita al primo full-lenght
ufficiale della sua discografia e, come al solito, lo fa
senza scendere a compromessi con le tradizionali
modalità di ascolto. L’interesse per la costruzione di un suono “tridimensionale” che caratterizza le sue composizioni, presuppone la
messa in discussione di
tutti i parametri musicali,
sia strutturali, sia estetici.
Nessuno mai si era avvicinato così tanto, nelle
intenzioni, alle avanguardie del Novecento, esplicitamente omaggiate qui,
nel titolo, dal nome di David Tudor, lo storico
pianista che, abbracciando le idee di John Cage,
ne divenne presto un simbolo, oltre che il suo più
grande interprete di sempre. Il decostruttivismo di
Hecker potrebbe apparire incomprensibile e superfluo, attraverso un ascolto convenzionale, a chi non
tenga conto del suo particolare approccio all’elettronica, tutto proiettato verso la creazione di veri e
propri oggetti sonori, apprezzabili soltanto mediante un ottimo impianto stereo, capace di riprodurre
i suoni in tutta la loro materialità. Al di là delle raffinatezze “per pochi”, come l’uso di
64
/ recensioni
Hermas Zopoula - Espoir (Asthmatic Kitty Records, Mag 2009)
G enere : world
La prima cosa che stupisce in Espoir è il marchio
Asthmatic Kitty, benché sarebbe arduo considerare Hermas Zoupula l’ennesimo latore del pop genialmente deviato che è specialità della casa. Basterà, a far cambiare idea, uno sguardo alla copertina
dell’esordio di costui, ultimo di 36 figli (!) venuti al
mondo nel Burkina Faso. Sta tutto lì lo spirito di
questo bravo ragazzo lontano parente di griot, proprietario di un internet cafè e salmista attivo nel
volontariato, la cui presenza nel catalogo del Micio
Asmatico è frutto della segnalazione del regista canadese Jonathan Dueck, divenuto amico di Hermas durante un soggiorno a Ouagadougou.
Edita in madrepatria nel novembre del 2008, questa
mezz’ora abbondante rivela dunque un solare “afro
pop” dal vago sapore caraibico, intessuto di cristalline chitarre sguscianti, passi saltellanti e canto
partecipato che poco insegue le mode occidentali
(quando lo fa, mal gliene incoglie: pessimi il vocoder
nella ballata soul Attention! e la voce da cartoni animati della title-track), prossimo per brio e rotondità
a certe intuizioni svelateci da quel Graceland cui oggi
si guarda nuovamente con rispetto. Leggermente
appesantito da sonorità sintetiche, il resto della scaletta piace ma non si imprime nella memoria, ad eccezione di Jesu Hiesu Luri, Wend Nana Douina e San
Bi Willila. Colpa della monotonia di schemi e di una
penna poco incisiva, limiti che riaffiorano nell’altro
dischetto qui accluso recante otto tracce acustiche
registrate sotto il portico di casa, gradevoli epperò
passeggere. Non un peso massimo, Zoupula, ma alla
luce della simpatia e benevolenza che ispira, d’essere
troppo severi con lui proprio non ce la sentiamo.
(6.6/10)
Giancarlo Turra
Hildur Gudnadottir - Without Sinking (Touch Music UK, Mar 2009)
G enere : elettroacustica
Dalle collaborazioni con Pan Sonic, Johann Jóhannsson, Múm o BJ Nilsen ai
lavori da solista in Mount A (Touch 2006)
- esordio discografico della giovane compositrice pubblicato sotto il nome di Lost In
Hildurness -, l’arte della violoncellista Hildur
Gudnadottir si è costantemente distinta nella
sua critallina purezza.
Merito di quello schietto e comuncativo carattere
espressivo che la caratterizza, esemplare in ogni circostanza, adagiato su forme più o meno mutevoli ed
attento alla natura e ai
movimenti del suono, regole che diventano sembianze anche delle dieci
tracce del suo più recente Without Sinking.
Le intuizioni timbriche
e le partiture tra dinamiche, risonanze e sincopi procedono per accostamento, accorpandosi
o allontanandosi, fungendo da controcampo o da
sommaria traiettoria d’origine (Elevation), seguiti da
monologhi d’illuminata partecipazione (Overcast),
tensioni e contemplazioni dal disinvolto carattere
teatrale (Erupting Light).
Memorie per archi, sobrie, terse o d’oscillante
modularità (Circular), dall’indubbio gusto melodico
(Ascent) ma che si portano dietro l’eco della matrice
sperimentale che le ha generate (Whiten). Per poi
attraversare l’incanto dell’armonia, quella che caratterizza le stratificazioni della partitura, gli umori
variabili (Opaque) dell’arpa o degli strumenti a fiato
(Aether), i drones di effimeri e minmali landscape
(Unveiled).
Disco di totale devozione, libera, dotta, spontanea
ed intuitiva: un vero e proprio atto d’amore per il
suono.
(7.3/10)
Sara Bracco
Iron & Wine - Around The Well (Sub
Pop, Mag 2009)
G enere : A lt country
Around The Well non è il nuovo album di Iron And
Wine: le ventitré canzoni qua assemblate non sono
altro che una raccolta di b-sides, cover e inediti che
come un film ripercorrono i cinque anni di carriera
discografica di Sam Bean, dal suo esordio del 2002
The Creek Drank The Cradle fino al suo ultimo
lavoro del 2007 The Shepherd’s Dog.
Il paragone con un film non è certo un caso: il titolo
dell’album, infatti, non è che un verso della bellissima
The Trapeze Swinger, traccia scritta dal Nostro appositamente per la colonna sonora di In Good Company
(regia di Paul Weitz, 2004), e qui riproposta a chiusa
dell’album a evidenziare tutto il suo peso specifico
nella produzione ferrovinosa. E proprio come una
pellicola autobiografica, Around The Well passa
in rassegna i momenti più propriamente lo-fi e scarni del passato, quelli più profondi e malinconici del
periodo Our Endless Numbered Days fino a quelli più
maturi e strumentalmente più stratificati dei giorni
nostri. Il tutto impreziosito da tre interessanti riletture: Waitin’ For A Superman dei Flaming Lips, Love
Vigilantes dei New Order e la più nota Such Great
Heights dei Postal Service.
Molti di questi episodi erano già reperibili sulla Rete,
ma la Sub Pop ha deciso ora di donargli una veste
ufficiale in doppio cd, così da accontentare sia chi
se li fosse persi sia i nostalgici “feticisti” del supporto fisico. Le luci in sala si stanno spegnendo: inizia
Around The Well.
(6.8/10)
Andrea Provinciali
Isis - Wavering Radiant (Conspiracy Records, Apr 2009)
G enere : A mbient M etal
Si fa fatica a credere, già dopo il primo ascolto di Wavering Radiant, che ci si trova di fronte ad un nuovo
lavoro degli Isis. Che la band fosse involuta in uno
stile piatto e scontato, lo avevamo notato da tempo,
ma che avesse abbandonato ogni ambizione, come
chi abbandona armi e bagagli per farsi trasportare
dalla corrente, nessuno lo sperava. In sostanza: gli
Isis non hanno proprio più nulla da esprimere, se
non ripetersi in una variazione infinita del già detto. Limate le spigolosità, ciò che resta è uno stile sobrio, ipnotico, lento, che naviga negli stessi mari dei
Motorpsycho e in alcuni casi scivola verso l’ambient (la Title-Track), abbandonandosi ad improvvise
scariche metalliche o ad arpeggi post-rock triti e ritriti (Stone To Wake A Serpent). Il tutto, come al solito,
dilatato all’estremo della pazienza umana. Se non ci
si annoia ascoltando questo disco, vuol dire proprio
che si è “fedeli alla linea”.
(5/10)
Daniele Follero
recensioni /
65
highlight
Golden Silvers - True Romance (XL Recordings, Apr 2009)
G enere : pop rock
L’esordio dei londinesi Golden Silvers è una parata di farneticazioni algide e carezzevoli, di romantiche veggenze in reverse, di enciclopedismo accennato con arguta impudenza, quella che consente ai tre ragazzi di far andare a braccetto Ultravox! e Joe Jackson (tra i rimbombi apprensivi
e solenni di The Seed), di esorcizzare Blur gli Style Council (nella felpata acieria doo-wop
di Please Venus), oppure di stringere a sandwich il Bowie di Let’s Dance tra Clash sandinisti e
capricci Prince (True N°9 Blue). Uno di quei dischi che ti fanno stare scomodo sulla sedia per la
natura elusiva dell’insieme, continuamente strattonato tra le dimensioni alternative e mainstream,
sperimentali e popoular, dissacrando il carezzevole e stemperando frammenti di presente nel
passato, obbedendo al miraggio frenetico di una musica onnicomprensiva come diversamente la
net-generation non può concepire.
Basso, batteria e tastiere tramano con arguzia insolente e stranamente patinata, sfornando tracce
non eclatanti dal punto di vista delle intuizioni melodiche ma dotate di una specie di candida morbosità, l’innocente lascivia di chi mette il dito nella marmellata senza
preoccuparsi di nascondere la mano, perché così fan tutti nell’epoca
della disponibilità & simultaneità dello scibile culturale. Non stupiscono quindi certi mostriciattoli Smiths ibridati doo-wop (Magic Touch,
Here Comes The King) e synth-funk Kajagoogoo (Arrows Of Eros),
così come l’Hendrix bizzarro e incandescente altezza Axis come lo
avrebbero trasfigurato i Devo (Shakes), ma anche un Badly Drawn
Boy strattonato beat (Queen Of The 21st Century) e perfino postumi
glam proiettati tra new frontiers Donald Fagen e onirico lirismo
Beach Boys in Another Universe, che invero tenta il passo più lungo della gamba inciampando
tra sogni avariati prog.
Chiude come una cicatrice Fade To Black, devota al passo crepuscolare del Dylan più solenne
strizzando l’occhio a Randy newman, e questo sprazzo di fiera commozione è forse il seme
di ciò che sarà, o almeno piace crederlo. Alla prossima, quindi, con una certa fiducia.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Japanther - Tut Tut Now Shake Ya
Butt (Southern Records, Mag 2009)
G enere : art - punk
Vive di una dicotomia piuttosto netta questo Tut
Tut…, ennesimo album a nome Japanther.
Da una parte il solito incedere del duo di Brooklyn
– Matt Reilly alle chitarre e Ian Vanek dietro pelli e macchine – tra electro spastica e appiccicoso
bubblegum-pop ipercolorato, cantilene e ritornelli
da dementia precox e lo-tech anthems da memorizzazione immediata. 9 pezzi da nemmeno due minuti
l’uno capaci di evocare tanto dei Suicide brufolosi (Radical Business, con l’ospitata di Spank Rock)
quanto degli Offspring malati e insani (Um Like
66
/ recensioni
Your Smile), con tutto ciò che è possibile immaginare
ci sia nel mezzo.
Dall’altra parte però, ecco che i due tirano fuori
due pezzi che da soli ammontano a più della metà
dell’intero album e che si staccano completamente
dalle atmosfere – invero un po’ pallosette e ritrite –
dei suddetti pezzi. Complice la presenza della voce
di un monumento della musica “contro” che risponde al nome di Penny Rimbaud di crassiana memoria,
Africa Seems So Far Away e I The Indigene sono due
strepitose prove di art-rock dilatato e evocativo a
metà strada tra haunted spoken word sul modello
del Tibet più visionario ed electro in bassissima (ed
antropologica, verrebbe da dire ad ascoltare i testi)
battuta/pulsazione. Roba che puzza al tempo stesso
di delirio sub-urbano e atavico pulsare di terre e
tempi lontani.
Ovvio che sono proprio queste due spoken-poetries a segnare l’aspetto più interessante e coinvolgente di Tut Tut Now Shake Ya Butt nonché
a risollevarne le sorti da un inevitabile oblio simile
all’indifferenza.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Jason Lytle - Yours Truly, The Commuter (ANTI-, Mag 2009)
G enere : pop rock
Alla fine Jason ce l’ha fatta. Si è liberato della propria
creatura senza morirne, è uscito dal bozzolo con
tutto il proprio immaginario di modernariato raccogliticcio, derelitto, avariato, per ritrovarsi in una
mezza età di carne, il cuore confuso ma sintonizzato
su un presente che non rinnega nulla anzi rivendica
con morbida fierezza. A sentire questa dozzina di
pezzi appare chiaro come i Grandaddy fossero
lui, ma anche e soprattutto che il robot (Jed l’umanoide?) si è pinocchiescamente incarnato nell’uomo
che oggi scende a patti con la possibilità di canzoni
un po’ più “normali”, un po’ meno trasfigurate dalla toccante fantasmagoria po-mo che tanto ci fece
amare la band (vi basti il fantasma George Harrison in Ghost of My Old Dog).
Il Jason che dichiara di tornare a casa porta con sé
tutto il dolce e l’amarognolo che ben sappiamo, che
fin troppo bene sappiamo: quel retaggio prog stemperato tra evanescenze spacey (Flying Thru Canyons),
le perturbazioni Moroder-Kraftwerk (Birds Encouraged Him), l’angoscia pungente e cinematica à la
Air (Furget It), le marachelle fuzz-pop (It’s the Weekend) e le soffici allucinazioni di zio Neil Young
(Here for Good). In più c’è una certa voglia di svolta
orchestrale, una febbricola che attraversa tutto il
programma (la title-track, This Song Is the Mute Button) scomodando retrogusti neanche troppo vagamente Brian Wilson. Ma come al solito il genio
sta nelle intuizioni povere e ostinate, quel giustapporsi di tastiere (mellotron, moog) che s’impastano
con la voce proseguendone lo struggimento, quegli
assolo di poche note o addirittura una soltanto (in
Rollin’ Home Alone) a raccontare la stasi dell’anima
nel fortunale emotivo, la ripetitività (elettro)meccanica a rievocare l’ultimo domicilio conosciuto della
trepidazione (l’emblematica Brand New Sun).
Un disco che insegue la sostanza per dribblare lo
smarrimento di un artista improvvisamente solo,
che zoppica per eccesso di prevedibilità, ma riesce a
stare in piedi, ed è già più di qualcosa.
(6.3/10)
Stefano Solventi
Jean Philippe Goude - Pour
l’instant (Ici d’ailleurs, Apr 2009)
G enere : C l as sica contemporanea
L’anno trascorso dal precedente Aux Solitudes
ha potuto contribuire, merito anche delle consapevolezze affinate con il tempo, al significato profondamente innovativo dell’operato del compositore
francese Jean-Philippe Goude.
Soluzioni plasticamente comunicative che l’artista
ha esercitato non solo al servizio dell’avanguardia,
ma dedicandosi anche alla scrittura di composizioni
per la TV Francese.
Materiale raccolto in questa nuova uscita dal titolo
Pour L’Istant, che seleziona le più ispirate vicende sonore, quelle che introducono le primissime
stesure del 1992 di De Anima, passando per La
Divine Nature Des Choses (1996), il Rock de
Chambre (2001) o il già citato Aux Solitudes.
Trasparente l’orchestrazione di Caractères-Pavane,
per fiati ed archi, o il cantato così autentico e nitido
tracciato tra materiche riprese e tensioni armoniche in Embarqués dans les pentes.
Ci sono poi gli ossessionati ed impulsivi dialoghi di
corde in Market Diktat, brano dotato di una visionaria lucidità; le cornici narrative di teatrale gestualità
(Allemande); i bozzetti impressionisti ed i connubi
in naturalismo a ricordare le ambientazioni di uno
schietto Renoir (Pastorale); o le liriche che emergono dalle polverizzazioni in pianoforte di A nos reves
vanouis.
Consigliato piccolo capolavoro di musica colta,
Pour L’Istant attinge dalle più significative sintesi
di classico e moderno (Debussy, Satie) per arrivare al Nyman più minimale.
(7/10)
Sara Bracco
John Vanderslice - Romanian
Names (Dead Oceans, Mag 2009)
G enere : indie pop
Di certo non un “innovatore indie rock” come si
legge da qualche parte, John Vanderslice: in questo
suo settimo disco che l’etichetta ci spaccia come il
suo più riuscito, il ragazzo si impegna a fondo e nondimeno mostra chiaramente i propri numi tutelari.
recensioni /
67
Niente di disdicevole in questo, perché - con frequenza via via calante - è di calibri come Magnetic
Fields, Eels e della scuola scozzese facente capo
a Paddy McAloon e Stuart Murdoch che si
parla. Di tutto un pop, arguto, ingegnoso e comunicativo, sulla carta un affare perfetto per accogliere
sorridendo l’ennesimo americano colto in adorazione di Albione.
In barba ai presupposti, però, Romanian Names non
decolla mai totalmente e dal punto di vista qualitativo ha l’aspetto di un saliscendi; regala alcune perline
di buona caratura e un capolavoro, peraltro avulso
dal clima generale (Hard Times, sensazionale meditazione di violoncello e tastieristiche lame degna
di Arthur Russell), incappando altrove in arrangiamenti che appesantiscono composizioni affatto
disprezzabili e qualche melodia prive di adeguato
sviluppo.
Magagne spiacevoli in un artista sulle scene da parecchio tempo, e altrettanto effetto fa la dipendenza
a tratti eccessiva dai succitati modelli: perché intrigano il pianoforte tra jazz e classicismo nascosto
nella leggiadra Fetal Horses, le vivaci Tremble And Tear
e Sunken Union Boat e quel sapore di techno pop
restituito a dignità tipico del Maestro Stephin
Merritt (l’elegante D.I.A.L.O.; un possibile Brian
Wilson illuminato dagli ’80 per Too Much Time).
Insieme delizia e fonte di grattacapi per il critico
la generosa manciata di canzoni quietamente belle
qui offerte, che però non possiamo né dobbiamo
ignorare. Fortunatamente, tra ragione e sentimento
un compromesso si riesce sempre a trovare.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Jon Hopkins - Insides (Domino, Mag
2009)
G enere : A mbient , IDM
Fatta propria ancora una volta l’estetica IDM via
Kid A, e strette alcune mani (Coldplay, King Cresorte e il coreografo Wayne McGregor), il non
troppo noto Jon Hopkins torna a far parlare di sé
con Insides, una collezione d’ambient music che se
da una parte odora di rediviva folktronica dall’altra
intinge abilmente il biscotto nelle recenti scoperte
tech di gente come Nine Inch Nails e, non ultimi, i
Depeche Mode.
È tutta materia di grande effetto: atmosfere appena tinte di noir (piano, synth, archi filtrati) e ritmi
ora soffusi ora d’attacco, pulizia massima tra le note
mentre sotto s’agitano le lezioni white hip hop di
68
/ recensioni
quindici anni d’elettronica albionica. Di più, emozioni cinematiche à la The Fragile (NIN). Un Brian
Eno recente e tutto un corollario ambient psych
da salotto buono con qualche sprazzo rave-tronico
da grandi occasioni (Orbital e gli stessi NIN). Non
manca nulla tranne una nota che gli abituali acquirenti d’elettronica non sappiano già. E non un difetto che sia uno che renda questo lavoro un minimo
figlio di qualcuno.
(5/10)
Edoardo Bridda
Jonathan Kane - Jet Ear Party (Table Of Elements, Mag 2009)
G enere : blues rock
Il nuovo disco di Jonathan Kane ha addosso lo stesso abito di blues infetto e kraut psicotico che si
era visto alcuni anni or sono sul debutto February, denominazione poi passata a chiamare l’intera
live band di accompagnamento. Nei fatti Kane è il
deus ex machina del suo stesso mondo, il motore
ultimo di ogni singola nota, mettendo mano a chitarra, batteria e basso per tutto il disco, salvo qualche marginale intervento altrui qui e li, come le voci
di Lisa B. Burns e Peg Simone che ancorano ad un
lato umano la ballata di Up In Flames. Kane rilegge il
blues attraverso la lente della ripetitività arrivando
all’anello principale che lega le sue ipnotiche frasi di
chitarra western ai pattern ritmici di un’avanguardia
comunque più colta di lui.
Quindi da un lato si ha l’impressione che a lui piacca
recitare la parte del cowboy solitario che entra nel
saloon al suono dei più classici riff country blues
come nell’introduzione di Smear It. D’altro canto,
messa così sarebbe solo l’ultimo sfrontato chitarrista da pub che suona gli stessi giri di sempre, ma l’ex
Swans usa la ripetizione per ipnotizzare e prendere
lentamente l’ascoltatore in quelli che poi diventano
veri e propri mantra ipnotici del tutto assimilabili a
Terry Riley o La Monte Young. Certo il disco è davvero tutto così. Ascoltato un brano, ascoltati tutti e
il gioco di Kane arrivati al secondo disco mostra un
po’ troppo le corde o per lo meno adesso è davvero troppo scoperto.
(5.8/10)
Antonello Comunale
Junior Boys - Begone Dull Care
(Domino, Mag 2009)
G enere : electro pop
Imboccata la strada giusta, una volta intuita, è bene
perseguirla. I Junior Boys, tenendo fede alla loro
onestà intellettuale, vanno avanti per sfumature senza snaturare l’originaria cifra stilistica. Detto questo,
il confine che separa So This Is Goodbye dal nuovo
parto è sottile, quasi nullo. Due anni l’uno dall’altro,
ecco l’unica differenza.
Un lavoro ad ogni modo impeccabile e alla maniera dei Junior Boys, questo Begone Dull Care. Jeremy Greenspan e Matt Didemus - ormai colleghi
a distanza poiché uno a Berlino e l’altro nella natia
Hamilton, in Canada - si
dichiarano, oggi, ispirati
dall’ideologia Mor dei
‘70 (Middle Of The Road,
format radiofonico ai
tempi rappresentato, ad
esempio, da gente come
Steely Dan e Carol King
il cui fine era l’heavy rotation. In pratica l’Aor su
scala più ampia), la proto disco di Tom Moulton
e Patrick Adams e sperimentatori quali Delia Debyshire e Steve Reich tra i tanti. Nulla che non si
sappia sul conto del duo, specie per quanto riguarda
l’appeal friendly delle loro sortite, e niente che vada
a lenire l’inerzia di un disco il cui titolo omaggia
un cortometraggio d’animazione del cineasta Norman McLaren. Il pop al silicio dei Junior Boys,
dunque, è al solito funky e vertiginoso (Bits & Pieces
e Hazel, con quest’ultima a giocare il ruolo che fu
di In The Morning), Hi-NRG (Work), erotico (Parallel
Lines), furbo negli ammiccamenti ’80 (Sneak A Picture riprende certe cose dei Style Council quando
armeggiavano di elettronica) e chilly (The Animator,
il pezzo che i Royksopp non scriveranno più). La
voce di Greenspan, sensuale come Daryl Hall e sintetica alla Neil Tennant, si conferma valore aggiunto.
I soliti.
(7/10)
Gianni Avella
King Creosote - Flicking The Vs
(Domino, Apr 2009)
G enere : songwriting
Comincia spiazzandoci Flicking The Vs: No One
Had It Better si apre con un intro al vocoder, prosegue con echi krautrock, bassi pulsanti e ritmiche
dance. Poi man mano ritroviamo il Kenny Anderson alias KC che conosciamo, già fondatore
a metà dei ’90 della scozzese Fence Records e
animatore della locale scena musicale.
C’è nell’album tutto il suo songwriting discreto: il
folk e il pop venato di echi country, bluegrass e soul,
agitato qua e là da pulsioni elettroniche, il carattere
fortemente scozzese ma non localistico, insomma
una personalità ben declinata la sua. La consueta
ispirazione Mc Cartney-iana già eviscerata qui si
consolida, facendosi sodale del macca più artigiano
e one man band; sfiora gli Ottanta del soul bianco di
Dexys Midnight Runners e co. (Coast On By)
aggiornandolo all’oggi degli Hot Chip; lambisce
territori strumentali vicini ai Talk Talk e in generale al songwriting inglese Ottanta (in area Ben
Watt e simili), per avvicinarsi con Rims a quanto
di recente fatto da autori quali Jens Lekman in
odore di lustrini broadwayani. Insomma un campionario variegato delle sue ispirazioni, rielaborate con
il consueto gusto pop folk.
Un gran bel ritorno per lo scozzese.
(7.2/10)
Teresa Greco
Kong - What It Seems Is What You
Get (KonGenial, Mag 2009)
G enere : industrial
Ne parlavamo il mese scorso citandoli come pietra
di paragone per il disco di K-Branding e ora li
ritroviamo, a sorpresa, con un disco nuovo. Parliamo dei Kong, quartetto olandese che ebbe ben più
del proverbiale quarto d’ora di celebrità agli albori
dei ’90, con una serie di dischi d’area grosso modo
industrial usciti per Peaceville e Roadrunner.
Oggi, qualche membro in meno (dei fondatori resta solo il basso di Mark Drillich e la produzione di
Dirk de Vries) e qualche anno in più, ritroviamo quel
quadraphonic sound di cui andavano già all’epoca
fieri e che dal vivo, con i quattro membri disposti
ai quattro angoli delle venues, dava il meglio di sé
investendo il pubblico con la sua circolarità.
What It Seems… inanella 12 pezzi prevalentemente strumentali in cui a farla da padrone è l’interplay heavy tra le due chitarre e il basso, capace di
creare un wall of sound notevole e ben sorretto da
grooves di batteria, campionamenti e sound effects
che screziano un suono in partenza tutto sommato
omogeneo e squadrato. Non monolitico, sia chiaro,
ma pur sempre di ascendenza “industrial con chitarre”, in cui i momenti di alternanza vuoto/pieno
dimostrano esperienza e polso.
Non siamo ai livelli di Phlegm (Peaceville, 1992)
ma What It Seems… è pur sempre un disco che
riuscirà nella difficile impresa di mettere d’accordo
recensioni /
69
fan di heavy metal, progressive rock, elettronica e
avant-garde.
(6.8/10)
Stefano Pifferi
Leonard Cohen - Live in London
(Columbia Records, Mar 2009)
G enere : F olk rock
Registrato due settimane prima dei concerti italiani,
nella fase del tour in cui le canzoni di Ten New
Songs erano state ridotte a un paio per recuperare
qualche altro classico (ma prima, ahimè, di quella
che ha visto il recupero di Famous Blue Raincoat),
il quarto live della carriera del canadese testimonia la tournée del grande rientro costituendo, con
qualche dolorosa assenza come quella nominata, un
ottimo compendio della sua carriera.
Rispetto al precedente Cohen Live (la cui scaletta
era in parte complementare a questa) il suono è più
caldo, amalgamato ma senza rinunciare alla nitidezza
dei dettagli. Pur essendo cambiato quasi del tutto
il gruppo che lo accompagna (rimane il solo Bob
Metzger alla chitarra), la resa delle canzoni risulta
qua e là simile all’altro live, ma in realtà è un po’ più
morbida e meno “sdraiata”, e lo stato di grazia aiuta i musicisti ad uscire felicemente dalla stretta tra
l’inevitabile uniformità sonora di un live e il rispetto
degli originali. Il fatto di essere davanti ad un pubblico inglese, poi, permette a Cohen di esprimere
il suo spirito nelle introduzioni alle canzoni o nella
gag sul finale di Tower of Song.
In conclusione, i (tanti) pregi e i (pochissimi) difetti
del concerto ci sono tutti, il che è il massimo che
un live senza canzoni nuove può raggiungere; e per
quelli che mancano c’è anche il dvd dal vivo.
Vivamente consigliato.
(7.2/10)
Giulio Pasquali
Les Italiens - Verdeluna Dancing
Hall (Silence, Apr 2009)
G enere : swing folk
Italiani, popolo di santi, navigatori e... Ballerini. Eh sì,
liberi di sentirvi disgustati dal recente surplus mediatico attorno alle avventure e sventure danzerecce dell’italico popolo, fatto sta che tra le specialità
nazionali c’è proprio il ballare, un vero e proprio
movimento che non ha mai smesso di germinare
godendo di un costante ricambio generazionale.
Ovviamente poi c’è sempre stato bisogno di musica
che incendiasse la fregola dei piedi, possibilmente
70
/ recensioni
di buona musica. Un tempo - correva il secondo
dopoguerra - era addirittura buonissima, allestita da
orchestre di tutto rispetto, swinganti ed esotiche,
dirette dai Pippo Barzizza e dai Cinico Angelini, pasturate dalle penne dei Gorni Kramer
e dalle ugole dei Natalino Otto, degli Alberto
Rabagliati e del Quartetto Cetra. A quell’universo sonoro che fondeva sapientemente le istanze
latin-jazz alla melodiosità italica, in ragione di ciò apprezzato all over the world, guarda il progetto Les
Italiens, big band capitanata da Alessandro Di Puccio,
vibrafonista fiorentino già al lavoro tra gli altri con
Enrico Pierannunzi e Rita Marcotulli.
All’omonimo esordio del 2003 segue questo Verdeluna Dancing Hall, dieci tracce originali dedicate ad altrettanti tipi di ballo, dalla beguine al jump
passando per il foxtrot, la polka, il merengue ed il
boogie, col canto allusivo della bassista Francesca
Taranto, la ficcante chitarra manouche di Jacopo
Martini e le orchestrazioni puntuali, puntigliose e
mai eccessive (sentitevi Potevi dirlo subito, la trascinante Dora, una Rock And Go che rivanga il Conte
di qualche anno fa e una Tarantissima che sembra
Roy Paci in delirio surf). Un carosello in diretta
dall’altroquando, una gustosa parata di garbo e arguzie, di fervore e compostezza, di languide indecenze
sapientemente sublimate. Da ballare, certo. Anche
solo con l’immaginazione.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Lindstrøm/Prins Thomas - II (Eskimo Recordings, Mag 2009)
G enere : space disco
La riscoperta - e la ricomparsa - di Daniele Bandelli, le compilation a tema: la cosmic disco, a questo punto, è più di un semplice vezzo. Causa di questo ritorno alla musica da club come l’avrebbero
intesa i Grateful Dead di Dark Star, Lindstrøm and
Prins Thomas.
In due. Insieme. Di nuovo. Hanno fatto talmente
bene lontani l’uno dall’altro (You Go I Go Too e
Goettsching) che quasi ci si dimenticava della loro
sinergia. II, laconico titolo come essenziale fu l’omonimia del debutto. Opera più concentrata (otto
tracce di contro alle tredici scorse) e fluida della
precedente. Psichedelica e lasciva. Visionaria e austera.
Rothaus parafrasa Harmonia e Faust e li proietta nel 2009. Kraut, ovvio, ma declinato oggigiorno.
Non il biglietto da visita, poiché quello spetta a Ci-
highlight
Horrors (The) - Primary Colours (XL Recordings, Mag 2009)
G enere : wave - gaze
Altro che ragazzini; o, comunque, non è assolutamente più questo il punto – sempre che lo sia
stato in precedenza. Gli Horrors sono lì a pretendere che li si tratti con serietà, con orecchio
non distratto. Ma, ecco il punto, ascoltando Primary Colours la cosa viene spontanea, non c’è
neanche bisogno di pretenderlo.
Partiamo da ciò che era previsto nel menui. Ovviamente non possono mancare il basso e altri
tratti distintivi degli Interpol – cioè del post-punk rifatto e tirato a
lucido; neanche le tastiere di Who Can Say, che sanno di Cure fino al
midollo. Il baritono di Faris Badwan “Rotter” si concede in New Ice
Age persino di essere epico come un John Lydon, il cui nomignolo
ai tempi dei Pistols quasi li accomuna; Only Think Of You è la loro All
Tomorrow’s Parties, perchè sempre là si torna, mescolata con NYC degli
soliti Interpol; la finale Sea Within A Sea è addirittura un motorik alla
Neu!, a testimoniare quanto poco innocenti sono gli Horrors, quanto
sanno cogliere ciò che va e può non passare esteriormente per moda
passeggera; un motorik cantato che si trasforma in un synth pop alla Battiato de La Voce Del
Padrone.
Ma se di mancata innocenza e di serietà si parla, la chiave con cui aprire la scatola di Primary
Colours non proviene dall’Inghilterra dei primi Ottanta. Il riferimento principale di come suona
quest’album va allo shoegaze maturo, alla sua capacità iper-evoluta di giocare sui livelli di produzione. Un lavoro di avvicinamento che già aveva fatto il primo disco degli Interpol, appunto;
chiaramente ci riferiamo a Loveless; ce ne accorgiamo quasi subito, e ne abbiamo la conferma
quando Do You Remember sembra citare espressamente una traccia dei My Bloody Valentine.
E finalmente, pensiamo, ecco qualcuno che li ri-prende sul serio, che si dedica con concentrazione
a sfruttare gli effetti di certe tecniche compositive e produttive, per di più in un ambiente – quello
del revival wave – che dovrebbe aver poco a che fare con lo shoegaze.
Loveless era costruito su un principio che si avvaleva di piccole dissonanze di accordatura e
post-produzione, divergenze emotive, digitali, distorsioni che creavano, nel marasma dei layer di
suono, qualcosa di straniante, di deformante rispetto alla coerenza percettiva delle note. Gli Horrors ci hanno fatto ripensare alla genialità e all’efficacia di quel monumento. Il loro album non è
un capolavoro, e probabilmente sarà considerato fuori tempo massimo; ma oltre alla scaltrezza
di nascondere sotto la cotonatura dei capelli delle ottime idee importate ad hoc, al di sotto della
corteccia celebrale la band riesce pure a scrivere buone canzoni. È quello che offrono, asciugando
il tutto, che ci fa promuovere gli Horrors. Quello che ci costruiscono attorno ci appoggia sopra
una lente che ingrandisce. Lasciamoci tranquillamente ingannare dall’effetto ottico.
(7.2/10)
Gaspare Caliri
sco: basso killer (e psycho, visto che a tratti rimanda
ai Talking Heads) cinto di percussioni e tastiere. È
un funk dopato. Si leva il crescendo. Si schiudono
le porte. Rett Pa le spalanca: tipo dei Boredoms a
78 giri nati in laboratorio. Come costume del duo
norvegese, alle jam progkraut di cui sopra (per chia-
rirci: ora più selvagge, scure e misteriche) accorpano quella componente edonistica propria del clima
balearico: For Ett Slikk Og Ingenting, Skal Vi Prove Naa?
(con echi dei primissimi Boards Of Canada, uno
dei tanti amori di Prins Thomas), Gudene Vet + Snutt
e Note I Love You + 100 (passo felpato e aplomb mol-
recensioni /
71
to The Blue Nile) sono episodi in surplass viziosi
sottopelle, fattore assente nel debutto.Flue Paa Veggen chiude ancora nel segno dei krautrock: ci potete
sentire un che dei Faust ma anche i Can in stato
di grazia. Tredici minuti di rapimento. Sono il vertice
alto della cosmic disco. l’hanno confermato.
(7.5/10)
Gianni Avella
Long Blondes (The) - Singles (Angular Recordings, Apr 2009)
G enere : I ndie pop
Una raccolta celebrativa dopo due soli album poteva sembrare strana, se non fosse per la notizia
dell’infarto che ha colpito il chitarrista Dorian Cox,
con conseguente stop all’attività del gruppo (che dichiara che difficilmente andrà avanti). A quel punto
andrebbe da sé chiudere la pratica con un’antologia
in attesa che le voci sulla
carriera solista di Kate
Jackson si concretizzino,
ma una scorsa ai titoli ci
dice che non è di questo
che si tratta. E nemmeno
di un nuovo album intitolato così per giocare
col titolo del precedente
“Couples”: è vero che nel gruppo c’erano due coppie ora separatesi, ma questo era successo durante
le sessioni dell’album precedente, da qui le virgolette nel titolo.No, i Singles del titolo sono proprio
singoli discograficamente intesi: ma sono quelli che
agli esordi i Long Blondes avevano pubblicato per
svariate etichette indipendenti, ora raccolti su cd
per la prima volta insieme all’inedito Peterborough: in
pratica quelle canzoni che li avevano messi in luce
creando il primo clamore intorno al loro nome.Alcune come si sa erano già finite sull’esordio Someone to Drive You Home in versioni nuove, che
ne smussavano gli -ahem- angoli e le ripulivano di
qualche asperità. Ma il materiale, nonostante la scarsa qualità delle registrazioni e certe ruvidezze più
indie che pop, era valido già allora, non solo quello rielaborato per l’esordio; talento verve e classe
c’erano già, e il disco è qualcosa di più che un utile
complemento agli altri due.
Un ritorno a quando il futuro era luminoso che, visti
i guai recenti, si spera funzioni anche come scaramanzia.
(7/10)
/ recensioni
(7/10)
Teresa Greco
Meanderthals - Desire Lines
(Smalltown Supersound, Mag 2009)
G enere : cosmic disco
Gli Idjut Boys, al secolo Dan Tyler e Conrad
McConnell, e il pioniere dell’elettronica norvegese
Rune Lindbæk (in giro da metà ’80 e collaboratore, tra i tanti, di Röyksopp e Hans-Peter Lindstrøm) uniti sotto la sigla Meanderthals.
Il territorio battuto dal trio è quello cosmic (o space) declinato balearic, con chitarre west-coast e arie
world (Kunst or Ars), funk laccati alla maniera di A
Mountain Of One (Desire Lines), quartomondismo laboratoriale (Andromeda - Prelude To The Future) e movenze etno (1-800-288-SLAM). Ad eccezione di Lasaron Highway - cassa dritta e basso iperfunk
- la battuta quasi mai varca la soglia del downtempo;
anzi, in Collective Fetish (forse l’episodio migliore) e
Bugges Room il registro vira in una quiete prossima
al David Sylvian di Dead Bees On A Cake.
Escono nel mese del ritorno di Lindstrøm & Prins
Thomas, e questo non gioca a loro favore. Anche in
caso contrario, comunque, la visibilità sarebbe stata
poca e circoscritta ai fan dei musicisti coinvolti. Nulla aggiungono e nulla tolgono. Una versione meno
ispirata di Tom Middleton.
(6/10)
Giulio Pasquali
72
Luminal - Canzoni di tattica e disciplina (Fridge, Mar 2009)
G enere : new wave , songwriting
All’esordio i romani Luminal spiccano per chiarezza
d’idee e sintesi programmatica. Una new wave la loro
memore degli Ottanta, ibridata con nostra canzone
italiana degli ultimi 20 anni e più. Con la produzione
accorta di Cristiano Santini ex Disciplinatha, la
formazione riesce nell’intento di mescolare lo spirito
dei CCCP e dei CSI, quello dei Massimo Volume e dei Marlene Kuntz, in una spigolosità naturalmente cantata in italiano, in cui recitativi, urgenze,
nevrosi ma anche distensioni e riflessioni si mescolano, tra punk rock, noise e songwriting.
Un orecchio ai Sonic Youth e l’altro alla nostra gioventù sonica, temi affrontati con ironia e consapevolezza, cosa che permette loro di liberarsi da uno
steccato forzato e ristretto, all’insegna di un songwriting d’autore che in alcuni degli episodi più intensi (L’uomo bicentenario, la title track, La Distruzione,
Il fiume) viene fuori con una bella urgenza.
Gianni Avella
Men Without Pants - Naturally (Vicious Circle, Mag 2009)
G enere : electro - rock
Analizzando le dinamiche creative di una band capita
a volte di sbagliarsi ed è teorema applicabile anche
ai Men Without Pants (un nome migliore però non
c’era, eh?), progetto allestito da Russel Simins batterista della Jon Spencer Blues Explosion
- con Dan “The Automator” Nakamura,
noto soprattutto per Gorillaz e Deltron 3030
e già presente in quell’Acme che è di fatto l’ultimo
disco dell’Esplosione da mettersi in casa a cuor leggero.
Naturally testimonia un sontuoso dispiego di ospiti,
da Sean Lennon e Yuka Honda delle Cibo
Matto allo Yeah Yeah Yeahs Nick Zinner
fino a un paio di elementi dei Mooney Suzuki:
se, di norma, tali premesse creano attese eccessive
e finiscono per zavorrare il risultato finale, qui si
resta a metà del guado, perplessi e poco impressionati. Lo scenario è un turbo-rock metropolitano iniettato d’elettronica che rincorre i bei tempi
spenceriani, cercandone una vaga modernizzazione
(And The Girls Go, Superfine) o ricalcandone l’impeto
(Never Gonna Do That Again, Rock Show); discreto e
niente più, così come garantiscono la sufficienza un
paio di cavalcate Neu! (cremosa e pop My Balloon,
più articolata e deragliante All You Need Is Luck) e la
filmica Let’s Meet In Real Life.
Fuori dai territori di competenza, tuttavia, succede che i Nostri s’impantanino in tracce piuttosto
ingessate e ridondanti e invochino gli Lcd Soundsytem con troppa sfacciataggine per farla franca.
Sulla conclusiva ballata acustica (!) Goodbye facciamo
di conto: siamo poco sopra la mediocrità e lontani
dall’unico lavoro dei Butter 08, altro dopolavoro
di Simins in cui compariva la Honda e referente non
ignorabile. Talvolta ci si sbaglia su chi è il genio nel
gruppo, talaltra no.Vatti a fidare.
(6.5/10)
Giancarlo Turra
Merger - Exiles In A Babylon (Makasound, Apr 2009)
G enere : roots reggae
Al pari di altri generi, la musica giamaicana è faccenda composita e multiforme dove è ancora possibile
asportare terra imbattendosi in tesori perduti. Pur
facendosi rispettare, della categoria non fanno parte
questi Merger, formati nell’impazzare del tempestoso Settantasette londinese da Barry Ford - già
batterista per B.B. King e a capo dei carneadi
funk Clancy - col bassista e tastierista Michael
Dan e Adetokumbo Illorin a voce e chitarra.
Se la ragione sociale che in inglese significa “fusione” e l’epoca in cui i brani furono messi su nastro
potrebbero indurre a pronosticare contaminazioni
con (post)punk e rock, ogni aspettativa va all’aria
appena si fa largo la classica sensualità roots adeguatamente screziata di latinità e Continente Nero di
Understanding, Life Song e African Lady. Se ne deduce allora che il trio fondeva, sì, nondimeno filandosi
poco e anzi nulla gli amici bianchi.
Bene in ogni caso, perché
il materiale di Exiles Ina
Babylon - registrato tra
Londra e Kingston nello
spazio di un triennio e rimasto sinora inedito - si
racconta di apprezzabile
caratura: in linea con gli
standard dell’epoca una
Rebel parecchio marleyana e la militante e corale
title-track, l’estesa Massa Gana che invoca la “version” dub e l’ottima 77, tesa e meditativa e lo stesso
dicasi per una Freedom Fighters, dal vago e singolare
piglio surreale. Convince un po’ meno il rimanente, giocato tra una vocalità non sempre all’altezza e
modelli che divengono eccessivamente schiaccianti.
Pepita di lucore non luminosissimo ma neppure pirite, Merger restano una discreta nota a margine del
grande romanzo del reggae.
(6.8/10)
Giancarlo Turra
Mesmerico - Magnete (Octopus,
Mar 2009)
G enere : industrial - noise
C’è la mano di 2 personaggi chiave dell’underground
italiano dietro l’esordio di Mesmerico. In primis quel
Pupillo di zuiana memoria che prima ha suonato un
pezzo su Magnete e poi se li è portati in tour per
la promozione del recente Carboniferous. L’altro
– sempre legato al marchio Zu, visto che ne è il
fonico/curatore dei suoni per eccellenza – risponde
al nome di Giulio Ragno Favero, eccellente musicista (Teatro Degli Orrori, Putiferio) nonché
apprezzato esperto di suoni dietro i più massicci
gruppi italici.
Che due personaggi del genere possano sbagliare
valutazione, si diceva, risulta piuttosto difficile. E infatti, ascoltando Magnete, prima prova dell’entità
recensioni /
73
highlight
Kevin Blechdom - Gentlemania (Sonig, Mar 2009)
G enere : anni C inquanta
Prima il problema era sul come farle saltare. Pardon. Sul cosa farsene delle regole. Trame e linguaggi, qualunque essi o esse fossero erano barbie e abiti presi in prestito per una messy fiesta
di tecnologie portatili d’assalto. Divertirsi e mattare erano le filosofie e i compagni di merende
(californiani) erano spettacolari.
Parliamo di Matmos, Lesser e appunto Kevin Blechdom, dentro al celeberrimo e geniale duo
Blectum From Blechdom; tutta gente oramai lontana dall’ortodossia taglia e cuci di quegli anni, con la sola Blevin, peraltro divina e
ispiratissima in Gular Flutter, a rimanergli fedele; per tutti gli altri,
Kevin in testa, il cambiamento ha voluto dire musica “suonata” e gioco
di sponde, reinterpretazione e riappropriazione delle regole, non più
far saltare i confini (ricordate Disc?) ma spostarli sempre più nel tempo e nello spazio. La combriccola dal mouse è passata alle chitarre, ai
fiati e a tutto lo spettro dell’analogico, e Kevin, giunta al terzo album
solista dopo vicissitudini e incertezze su Cheeks On Speed, ha pensato bene di indagare l’estremo opposto dello scenario iniziale. A dieci
anni dalle BFB, tolto laptop e pastoie kitch, l’ex ragazza ci propone un disco – diciamo – di anni
Cinquanta.Via il concetto e dentro l’interpretazione come se la più classica delle parabole dell’età
adulta dovesse essere consumata qui e ora ma in un altro spazio tempo.
Gentlemania è Hollywood, cabaret, vaudeville, tutto il pane dei giovani albionici ma con lo scarto e l’esuberanza di una grande diva démodé ed esattamente come accadeva in The Chaddom
Blechbourne Experience (2008) in compagnia di Eugene Chadbourne con i classici per
banjo, il gioco è serissimo e neppure quello houmor che si scorge qui e li è fuori dalle regole.
L’ironia innocua di una Marilyn? Esatto proprio quella come la Minelli, un po’ di drama da teatro
in/off, del balletto, una badilata d’avant spettacolo e vaudeville. Kevin non fa seghine al pop o per il
pop e nemmeno è la big band à la Herbert quello a cui aspira. Tutto si basa sul gusto e sull’abilità
della californiana di confondere il tempo. Puoi passare in setaccio il disco cercando dove e quando
trasgredisce e non troverai nulla se non un presentimento: Kevin potrebbe strappare la tela e
svelare il trucco in ogni momento. Non lo farà e il nonsense dell’esistenza è un po’ questo. Chissà,
se al pari di Sufjan pure lei punti a qualche mappatura della tradizione americana.
(7.6/10)
Edoardo Bridda
chitarra/batteria a nome Mesmerico, la sensazione
è che i due abbiano fatto centro pieno.
Un duo, si diceva. Cosa che va di moda ultimamente ma che, hype a parte, ha il merito di asciugare
le proposte senza perdere in potenza di fuoco. E
di fuoco, Luca Bottigliero (batteria) e Fabrizio Piccolo (chitarra) ne hanno da vendere. Avete presente tutto il campionario della musica pesante degli
ultimi (almeno) 30 anni? Beh, Mesmerico li fonde
in un tutt’uno agile e screziato che passa con nonchalance da Melvins a Neurosis, da Lightning
Bolt a Zu.We Live In A Paradise (Inhabitated By De-
74
/ recensioni
vils), attacco dell’album, parte da lidi paradisiaci (o
infernali?), attraversa le catramose lande Neurosis
periodo Through Silver In Blood e si spezza in
aperture tanto free quanto convulse. A ruota l’attacco da epilessi Oneida meets post-hardcore di
Silos non è un’altra freccia ad un arco nero pece,
avvalorato dallo schizzo da espressionismo postGravity di Rasoterra, dalla sfuriata contratta, repressa e poi trasfigurata in collasso di Dentro Al Vesuvio e
dalla catacombale title track, percorsa da un marciume da Melvins depressissimi. Quando le atmosfere
si dilatano e rarefanno ed emerge pure l’uso evoca-
tivo dell’elettronica (la chiesastica Lagher) il duo da
prova di sentire, oltre che di conoscere la materia
cupa di cui si è cibato.
Musica che sembra procedere per frattali, tanto è al
tempo stesso dotata di disegno ma completamente frastagliata e tortuosa. Ottimo segno, di questi
tempi.
(7/10)
Stefano Pifferi
Moderat/Apparat - Moderat (BPitch
Control, Apr 2009)
G enere : minimal disco IDM
Modeselektor + Apparat = Moderat. E dall’equazione
hai già detto tutto. Hai già detto minimalismo e melodie vocali. Hai già detto 00. E recupero 09. La nuova onda che è stata innescata dal sasso Circlesquare
(che annovera tra i suoi preferiti proprio Apparat) si
ingrossa sempre di più e lo tsunami è lì che ci guarda.
E seppure parliamo di minimal non è ancora ‘roba
vecchia’. Perché Sascha Ring (aka Apparat) sa ancora cantare. Però c’è un però. La contaminazione
con i suoni più street derivati da Gernot Bronsert e Sebastian Szary non sta nelle sue corde.
Sì, Berlino è sempre Berlino direte voi. E il ricordo
del discone che aveva fatto con la Aillen qualche
tempo fa (Orchestra of Bubbles) è ancora vivo.
Se là si era fatto il Dark Side of The Moon, qui si punta
al canto. Ma non si affonda, proprio come in Walls. Perché la strada non c’entra col glitch. Bpitch è
scuola. Ma non quella drogata e spastica di Ellen.
Qui il parallelo se proprio vogliamo è col belcanto
ultramarino di Wyatt unito alle ultime cose Radiohead (che peraltro hanno annunciato future ispirazioni ai Kraftwerk...) e ai sempreverdi musicisti
per le masse Depeche Mode.
E allora ci stanno le solite cavalcate melo che fanno
Apparat (A New Error), le ballad leggermente sporcate dal glitch (Rusty Nails), i tunnel cupi che incarnano la krautedine con la K maiuscola (Seamonkey)
e per finire le bordate pop à la Gahan (Porc#1 e #2).
Ma non si capisce proprio lo struscio con il ragga di
Slow Match o con il decadence-step di Out Of Sight.
A parte qualche caduta di stile, un disco che tiene
alto l’onore della capitale del ritmo mitteleuropeo e
che ci fa capire come dal cilindro minimal verranno
ancora estratti conigli. Un Apparat che non si adagia
e che attraversa impavido la bufera. Lui, uno degli
ultimi romantici in circolazione.
(7/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
My Latest Novel - Deaths and Entrances (Bella Union, Mag 2009)
G enere : indie folk orchestrale
Fattisi conoscere tre anni fa con l’interessante debut
album Wolves, in odore di post rock e indie folk,
i cinque di Glasgow ora ridisegnano il proprio assetto musicale, mantenendo la base del loro sound
e sfrondando giusto un po’ della propria epicità, a
favore di un più misurato indie folk orchestrato.
Così come l’ultimo album dei Decemberists di
cui si parlava tempo fa, anche questo Deaths and
Entrances dei redivivi My Latest Novel è un concept album, ispirato in questo caso dalla letteratura.
Sin dal titolo infatti, che si rifà a un poema di Dylan
Thomas, siamo in atmosfere epiche, tra natura,
vita, morte e rinascita, incubi e cicli della vita. Argomenti che del resto si adattano perfettamente alla
loro musica.
Siamo allora dalle parti di un songwriting talora
asciutto (le ballad Lacklustre e Re-Appropiation Of
The Name), spesso orchestrale e d’atmosfera (nella maggior parte dei pezzi), dove le armonie vocali
maschili/femminili, la malinconia e il pathos di fondo
- che possono far pensare a degli Arcade Fire più
rilassati o meglio a degli Arab Strap – rimandano
in più di un’occasione a un folk revival primigenio (A
Dear Green Place), ad atmosfere in odore di Mogwai e ad orchestrazioni ambiziose e stratificate che
ci ricordano il migliore Sufjan Stevens (I Declare
A Ceasefie).
In sostanza quindi qualche aggiustamento qua e là
per una buona riconferma.
(7.1/10)
Teresa Greco
Neil Young - Fork In The Road (Reprise, Apr 2009)
G enere : blues rock
Neil Young non se ne frega. Se ne incarica. Reagisce con spregio volitivo. Lo ha fatto due anni fa
con Living With War e lo scorso anno, in parte,
con Chrome Dreams II. Torna a farlo con questo
Fork In The Road dedicato alla crisi economica ai suoi risvolti drammatici e demenziali - spargendo
ulteriore sale sulle crisi parallele, quelle delle fonti
energetiche e della global pollution. Ok, dio ci salvi
dal pistolotto moral-ambientalista del vecchio fricchettone incanutito. E poi, ok, cos’altro vuole dimostrarci? Perché dovremmo avere voglia di ascoltare
altri country rock rocciosi e funky o ballate da tramonto sul deserto delle nostre vite? Come se po-
recensioni /
75
tessero aggiungere qualcosa ai Freedom, ai Rust
Never Sleeps, ai Deja Vu, persino ai Re-Actor o
agli Harvest Moon, tanto per circoscrivere il raggio d’azione di quest’ultimo lavoro, trentottesimo
titolo solista se non ho fatto male i conti.
No, il punto non è questo. Conta poco che Singing A
Song sembri una nipotina sfigata di Like A Hurricane
o che il corettino di Johnny Magic (dedicata al meccanico del Milwaukee Jonathan Goodwin che ha
progettato un motore ad
emissioni zero) rimandi
un po’ scioccamente a
quello storico di Hey Hey
My My (che chiamava in
causa un tal Johnny
Rotten...). Conta semmai che Young sembra
davvero aver ritrovato
l’urgenza di sbraitare
rock in risposta al turbamento, allo sdegno, al giramento di palle o se volete a una speranza. Nel
segno di uno sgarbato e acido keep it real che lo
sbatte in prima linea anche se lontano dalle prime
pagine, Don Chisciotte forse balzano ma ben dentro il solco del presente. Sentitevi come scapicolla
e scollaccia boogie rock nella title track, come azzardi stralunato impasto funk e psych in Cough Up
The Bucks, e che bel crepuscolo di voce regala alla
trepida Light A Candle.
Tutta roba inessenziale, certo. Ma c’è del fascino in
questa sua noncurante e scontrosa persistenza.
(6.6/10)
Stefano Solventi
Nothing People - Late Night (S-S
Records, Apr 2009)
G enere : psichedelia
Nomen omen dicevano i latini e, benché il nostro
decantato progresso vorrebbe un così antico motto
ormai superato, esso è quanto mai valido oggi, qui,
con un disco come questo.
A meno di un anno di distanza dal loro debutto
– Anonymous – sempre su S-S., tornano i californiani Nothing People con un album che ha appunto
nel titolo la tanto sintetica quanto inequivocabile
descrizione del materiale in esso contenuto. Abbandonate le sonorità proto-punk molto ‘70 dell’esordio, l’ex-terzetto di Orlando – ora quartetto dopo
l’aggiunta del precedente tastierista dei Monoshock
– rallenta e annerisce decisamente i toni, confezionando una serie di nenie circolari ed ipnotiche che
76
/ recensioni
sembrano essere concepite ed arrangiate, appunto,
a tarda notte; proprio come di notte, più ci si addentra, più il buio si inspessisce ed avvolge tutto.
Così echi di Barrett (When I Drink) e di My Bloody Valentine (It’s Not Your Speakers) lasciano
progressivamente posto a narcolessie dal gusto
molto Paisley Underground (Crunch Time), fino a
che la desertificazione notturna non prende il sopravvento, tinteggiando paesaggi lunari ed onirici.
Chiude il tutto la title track, nonché cover del sopracitato Syd Barrett, e non è un caso: ora è veramente
notte fonda e i battiti (cardiaci quanto ritmici) sono
estremamente dilatati, lenti, ed un senso di indolente sonnolenza cala su astanti e musicisti.
Infine l’artwork di Christopher Ilth, già autore di
copertine per i Daily Void e Functional Blackouts,
rende pienamente giustizia al sapore antelucano di
un disco non di immediata assimilazione ma di sicuro valore.
(7/10)
Andrea Napoli
Novi_sad - Jailbirds (Sedimental,
Nov 2008)
G enere : elettronica / ambient - sperimentale
Immediata è l’attenzione che Thanasis Kaproulias in
arte Novi_sad pone al dettaglio sonoro, strutturato
in Jailbirds in formule d’ordine e priorità, merito
di quella perfetta padronanza dei contenuti, svincolati da qualsiasi condizione di tratto, a cui l’artista
concede piena capacità di agire in materia, stile e
dimensione.
Due uniche tracce di circa venti minuti l’una danno forma nero su bianco alle suddette premesse, a
cui l’artista interviene sperimentando il suono alla
differenza di elementi disposte ad azione metriche
temporali, direzionali e timbriche.
Condizioni germinali per Komdu!Hvert? a cui affidare
lo scorrere degli eventi,supportati in field recording
di natura ambientale - acquisiti sul Lago Mamori in
Amazzonia, Ponte Alphos ad Olimpia, tra Svezia e
Danimarca - o fissati nei proclami centrali del Nói
Albínói di Dagur Kàri.Eventi sonori, che lentamente
emergono da un unificato tappeto in microtoni, filtrato o mandato in loop tra profondità in drones e
texture d’astratto segno.
Con Torched Estates il campo di registrazione mutà
d’aspetto acquistanto quelle che potrebbero essere
le lezioni migliori del Ryoji Ikeda in elettronica di segnale e borbotti atonali a cui imporre procedimenti
in staticità e dominio.
Eventi sonori autosufficenti in singolarità ma, consapevoli della loro coesistenza e della loro intensa
azione tra presente ed immaginato.
(6.9/10)
Sara Bracco
O Voids (The) - Self Titled (Troubleman Unlimited, Apr 2009)
G enere : post - punk
Dopo un EP e un paio di split 7” (rispettivamente con i conterranei Wicked Awesomes sulla loro
Lost Space Records, e coi Daily Void questa volta
su Don’t Hit Record!) i canadesi O Voids giungono
al primo full-length per l’iperattiva e chiaccherata
TroubleMan Unlimited di Mike Simonetti.
Sia che abbiate familiarità con il sound proposto dal
quartetto di Montreal, sia che ne siate all’oscuro,
cosa ha in serbo per voi questo debutto è presto
detto. Com’era infatti ragionevole aspettarsi, gli O
Voids continuano il cammino già intrapreso con le
precedenti uscite, confezionando 14 tracce (troppe forse?) di quello stesso tipico sound: post-punk
fedele al biennio ‘78-’80, piuttosto secco, sghembo
e talvolta claudicante, non immemore però dalla
melodia e dall’efficacia di refrain orecchiabili, capaci
di ricordare in egual misura Wire e Pere Ubu,
Mission Of Burma e Wipers.
In casi del genere, non ha molto senso sottolineare
un titolo piuttosto che l’altro; le canzoni, tutte sui 2
minuti di durata circa, scivolano via agilmente, il che,
se da una parte è senz’altro un pregio, dall’altra può
essere anche un limite perché, come si dice, easy
come, easy go. L’esito complessivo risulta dunque un
sostanziale tributo ad un periodo, ad un sound ed
ad un manipolo di band evidentemente importanti
per i componenti del gruppo in questione, come anche la copertina stessa sottolinea col suo fin troppo
evidente citazionismo. Il tutto è registrato in analogico (altra scelta di fedeltà alla linea) allo studio
Treatment Room delle loro città natale da Gilles
Castilloux, già produttore dei primi singoli.
(6.8/10)
Andrea Napoli
Official Secrets Act - Understanding Electricity (One Little Indian,
Apr 2009)
G enere : indie pop , funk
Si rifà prepotentemente agli Ottanta (ancora?) questa nuova formazione proveniente da Leeds.
Funk white pop tra Talking Heads di ieri e
Vampire Weekend di oggi, ma anche echi glam
Sparks, guitar pop inglese tutto dell’epoca, Television, Smiths, ritmiche XTC, Associates,
Gang Of Four e via elencando.
Non c’è solo quel decennio, comunque, tra le loro
ascendenze. I più contemporanei Bright Eyes e
Neutral Milk Hotel si affacciano qua e là a ricordarci che di oggi si tratta e non delle passate
adolescenze che furono.
Un buon blend tra armonie vocali e mistura tra le
sonorità citate, unite a una discreta padronanza lirica e testuale ne fanno un gruppo che si distingue
dal marasma delle ultime sensazioni inglesi. A dimostrazione che c’è del buono in loro.
(6.9/10)
Teresa Greco
Ottodix - Le notti di Oz (Top Music,
Mar 2009)
G enere : synth pop , wave , songwriting
Sintesi dell’omonimo soggetto teatrale di Alessandro Zannier alias Ottodix, Le notti di Oz
è concept sospeso tra mondo reale e virtuale, una pungente disamina dell’attualità che stiamo vivendo e della massiva spersonalizzazione a cui siamo andati/stiamo andando incontro.
Musicalmente synth pop, wave elettronica e songwriting in italiano confluiscono, un ideale punto
d’incontro dell’immaginario Ottanta, che ricollega da
un lato Bowie, Garbo, Depeche Mode estendendosi sino alle fascinazioni Bjork e Massive
Attack. Nel mezzo, i ’90 e oltre italiani di Subsonica e Bluvertigo per fare qualche nome. Con
forti fascinazioni estetico-concettuali, dall’espressionismo a Metropolis, da Tim Burton a Brazil.
Coordinate precise per un progetto musicale cantato in italiano ben messo a fuoco, che fa della nostalgia evocativa e delle fascinazioni decadenti la sua
cifra stilistica. Alcuni ospiti come Madaski (Africa
Unite) e Georgeanne Kalweit (Delta-V) nelle bonus
e successive rielaborazioni con il succitato Garbo
seguiranno. Lavoro interessante nel suo genere questo di Zannier.
(6.8/10)
Teresa Greco
P.G.R. - Ultime notizie di cronaca
(Universal, Apr 2009)
G enere : rock autoriale
Cerchi che si chiudono con questo terzo lavoro targato PGR. Il primo, quello più pressante, è la fine dei
recensioni /
77
highlight
mi stupirebbe se decidessero di portare avanti il testimone (di cosa, però?) in duo.
Maisie - Balera Metropolitana (Snowdonia, Mag 2009)
G enere : pop rock
Sembrava che i Maisie si fossero concessi un letargo di quattro anni, invece dalla pubblicazione
di Morte a 33 giri (Snowdonia, 2005) non si sono fermati un attimo impegnandosi a realizzare questo Balera Metropolitana, doppio cd, quarantaquattro canzoni col resto di qualcuna
(messa da parte per un altro album che pare sia già in cantiere), due ore e mezza abbondanti di
idee, ideuzze e colpi di genio all’insegna della svampita impertinenza che ben conosciamo, obbedendo spesso alla promessa danzereccia del titolo.
Potremmo vederlo come un collage fatto coi ritagli di riviste scandalistiche, misere cronache
del quotidiano ed epica da coatti all’ultimo stadio, innocenti perversioni intercettate dal parrucchiere del quartierino, stralci di dramma
socioesistenziale ad altezza d’uomo e rigurgiti di poesia allibita, scazzi
meditativi su massimi (L’amore in città, Hanno ammazzato un bambino,
La centrale nucleare) e minimi sistemi (W le aliene!, l’esilarante Quando
morì Cristicchi) avendo cura di confondere i confini degli uni e degli altri
con lieve agghiacciante disinvoltura, roba che neanche al mauriziocostanzoshow.
Ne esce un carosello di subcultura indomita che pulsa di vita a passo
yeh yeh e pop wave, italo disco e liscio funky, grind e gospel, house e
lounge, in un’alternanza spuria che ti ubriaca, ti sbalestra, beffardamente t’inquieta. Partecipano
una pletora di ospiti imprevedibili e illustri come la polistrumentista statunitense Amy Denio
(anche cantante come nella stupenda Si sveglia), Mario Castelnuovo (per una toccante versione di n. 79 - ISTITUTO MARINO), Flavio Giurato (che scrive e interpreta una trepida Ivana e
Gabriella) più membri di El Ghor, Aidoru, Egokid e via discorrendo. Ha tutta l’aria di un’opera
definitiva per i Maisie. Il loro Blonde On Blonde. Quel che si dice un capolavoro.
(8.1/10)
Stefano Solventi
PGR stessi, progetto esausto più per sfilacciamento
umano che per inaridimento della vena, visto che
comunque questo disco, iniziato quasi di malavoglia
per onorare l’impegno con la Universal, consegue
una compiutezza, un piglio e una ispirata concisione
come negli altri due non s’avvertiva. Ma così vanno
le cose, così devono andare. Se a Ferretti interessa poco proseguire sul versante del rock, Canali e
Maroccolo al contrario oggi vi si impegnano come
non mai.
Registriamo quindi la chiusura di un cerchio più
grande, quello avviatosi ormai troppi anni fa coi
CCCP e proseguito CSI, idealmente celebrato con
l’uscita del qui presente disco in contemporanea coi
titoli di Ginevra Di Marco (assieme a Magnelli) e del Canali solista, a seguire di pochi mesi uno
Zamboni che del resto da un pezzo è il meno
78
/ recensioni
sincronizzato della ex-accolita. Con il che si torna
al Ferretti, ai cerchi più complicati: quello musicale
di Co.Dex (Mercury, 2000) alla cui calligrafia abbacinante e androide spesso capita di ripensare nelle
qui presenti “cronache” (più per frasi come “la carne
s’è fatta vendetta/ il corpo è la bomba perfetta” che
per il ricorso alle elettroniche e alla drum machine),
e quelli etici, civili, spirituali, questioni private con
ricadute pubbliche (e viceversa?) puntualizzate anzi
ribadite con la fierezza cocciuta, altera e vagamente
beffarda del vecchio battagliero (di cui rispetto la
coerenza - lo so, non è facile scorgerla, ma c’è - e
digerisco male certe frequentazioni).
Maroccolo e Canali lavorano per sottrazione ma
non sono mai stati tanto in primo piano, artefici (si
producono da sé) di un suono assieme spoglio e
prezioso, crudo e intenso, brusco ed evocativo. Non
(6.7/10)
Stefano Solventi
Paper Chase (The) - Some Day This
Could All Be Yours Vol.1 (Southern
Records, Mag 2009)
G enere : dramatic indie - rock
È sin dalle note iniziali di questo atteso comeback
che il progetto Paper Chase dimostra di essere sempre uguale a se stesso, pur nel lieve e impercettibile
cambiamento. Non che la cosa sia negativa, anzi.
Riascoltare quel senso di melodramma (post)indierock, teatrale e pomposo, inscenato ormai da alcuni
anni e numerosi album da John Congleton, principale responsabile della sigla – checché se ne dica, i
PC sono la “sua” finestra sul mondo – può portare
all’amore istantaneo o all’odio subitaneo nella stessa identica maniera in cui lo facevano i precedenti
album.
Quel senso di latente ubriachezza degli arrangiamenti, di andatura claudicante e sghemba dei ritmi,
quel fare a metà tra il circense e il fanfaresco – mai
buffonesco o gratuito, è da dire – ricopre i dieci pezzi di questa prima parte di Some Day…, così come
quel cantato sempre sull’orlo della stonatura che è/
sono ormai da tempo la cifra caratteristica più evidente dei Paper Chase. E come al solito, riescono a
catturare l’ascolto, a fare propria l’attenzione di un
disco che è anche – e soprattutto – il primo set di
un concept sulle disgrazie naturali, cui sono dedicati
i sottotitoli dei 10 pezzi, e sulla pochezza dell’umanità messa al confronto con la grandezza a volte distruttrice della natura. E in quest’ottica conflittuale
assumono ancor più senso le aperture orchestrali
sempre in bilico tra dissonanza e bellezza poetica
e delicata, tra straniamento e riconciliazione, tra
scontro e risoluzione.
John Congleton è uno dei pochi geni attualmente in circolazione e noi non possiamo che gustare
questa collezione di canzoni classiche con in mente
la certezza che tutto questo un giorno sarà anche
nostro.
(7.5/10)
Stefano Pifferi
Peaches - I Feel Cream (XL Recordings, Mag 2009)
G enere : meshy retrofuturism
Ritorna la queen queer radioattiva del rock mu-
tante e mutato trash electro. E ritorna se stessa soltanto alla prima passata, perché alla ‘pesca
fresca’ quel classico menù rrriot delle amiche
di vecchia data Chicks On Speed sta un
po’ strettino e dall’esordio sono passati secoli.
I Feel Cream è un 12 tracce carico di retrofuturismi Kittin, Crookers e Oizo. In pratica la crema di
certo sottobosco special K e Thunderheist. Creme
brulée già battute da molti ma Peaches più che fare
la porca questa volta spara colpi di lato e di sguincio,
sempre nello stesso recinto ma con la grinta di chi
vuole essere la numero uno. L’energia c’è, ancora, e
lei soprattutto è una performer. Ha voluto esserlo talmente tanto che oggi più di ieri non sembra
più un azzardo paragonarla a(lla solita) Madonna.
O perlomeno a una che, come Miss Ciccone parte
dalle scene off per salire. E Merrill non c’è dubbio
salirà.
La Kittin è gonfia di soldi e droghe perciò il gioco è anche più facile, specie se come Veronica C.,
Merrill cavalca agilmente una palette di generi/anni/
stili che vanno dalla sfacciataggine 80 con il basso flashdancey di scuola moroderiana (Lose You) al
mesh in stile Furtado con gli inserti fidget (Mommy
Complex), dalla cassa dritta electroclash (Serpentine) al pop-hip-punk di facile consumo (Talk To Me,
Billionaire). Un calderone che ingloba le esperienze
dell’ultimo lustro EdBanger da palco e che si lascia
ascoltare come qualsiasi disco pop in odore di hit
parade. Natura morta con pesche? Se ti avvicini al
quadro vedi che c’è qualche vermetto che spunta
fuori dalla composizione, pronto ad innestarsi nei
timpani e a farti muovere il culo. (6.5/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
Peter Von Poehl - May Day (Tôt ou
Tard, Mar 2009)
G enere : indie pop
Il “viaggiatore svedese”, come si definisce egli stesso
- perché scandinavo di nascita ma perso nel mondo tra la terra d’origine, la Francia e la Germania -,
ci aveva positivamente colpito ai tempi del debutto
Going To Where The Tea-Trees Are del 2006.
E continua a farlo, migliorandosi, con il recente
May Day, album registrato in uno studio in mezzo
ai boschi svedesi, edito da una piccolissima etichetta
francese.
La voce ricorda in maniera sorprendente Phil
Collins ma sono una delicatezza, una malinconia
recensioni /
79
strutturali e un approccio strumentale in bassa fedeltà a distinguerlo. Il tutto porta a un pop autentico
alla stregua di un David Kitt meno folk, cacciando
così il fantasma succitato. Poche le cadute di tono in
May Day: brani ben scritti e interpretati che non cavalcano mode del momento. Non resta, allora, che
ascoltare questa dolce e sofferta richiesta d’aiuto,
facendosi ammaliare.
non far felici i tecnici della chitarrismo classico, e al
tempo stesso i suoi sono brani sorprendentemente
lirici e desueti ancorati come sono ai tempi caldi e
nervosi del Flamenco. C’è un minimo comune denominatore che questo disco condivide con il primissimo Rainy Day Raga, il lasciarsi andare quasi
come una entusiasmante rivelazione.
(7.5/10)
Antonello Comunale
(7.3/10)
Andrea Provinciali
Peter Walker - Spanish Guitar
(Birdman Records, Apr 2009)
G enere : guitar folk
Peter Walker è il genio della sei corde che è scomparso per anni dopo aver codificato con due album
usciti su Vanguard negli anni ’60 il canone psych folk.
Rainy Day Raga e Second Poem to Karmela
or Gypsies Are Important si intotalano e sono
in testa alle preferenze di uno come Ben Chasny
che gli deve moltissimo del suo stile lirico e arcano,
parlando infatti di “una influenza superiore a quella di
John Fahey e Robbie Basho”.
Walker fu amico di Karen Dalton e Sandy Bull, fece
parlare poco di se, la sua musica finì sulla bocca di
pochi e sulle orecchie di pochissimi. Si eclissò come
un mistero inspiegabile,
andò in Spagna e studio
le tecniche chitarristiche
dei Gitani alla base del
Flamenco. Poi questione di questi anni, Joshua
Rosenthal di Tompkins
Square lo ritrova e lo
convince a pubblicare
quattro nuovi brani nella raccolta del 2006 intitolata
Raga For Peter Walker a cui partecipano epigoni contemporanei come Steffen Basho-Junghans,
James Blackshaw, Greg Davis, Shawn David McMillen, Thurston Moore, e Jack Rose. Poi l’anno scorso
Echo Of My Soul accompagnato da una dichiarazione d’artista che può essere usata anche per
questo questo nuovo disco dal vivo: “With its roots
in ancient East Indian music, Flamenco has influenced
much of the world’s music. These Spanish-inspired pieces reflect my passion for this musical rubric”. Registrato in presa diretta, dal vivo, nel corso di una serie di
appuntamenti live, Spanish Guitar è una meraviglia di ricerca e sentimento, tecnica e stile.
Walker ha un controllo sulla tastiera della sei corde e sugli arpeggi della mano destra che non può
80
/ recensioni
Phoenix - Wolfgang Amadeus Phoenix (Cooperative Music, Mag 2009)
G enere : fashion pop
Molti pensavano che il gruppo francese sarebbe
sempre rimasto attaccato a quella If I Ever Feel Better che tanto gli diede visibilità, ma a partire dal sorprendente It’s Never Been Like That i Phoenix
si sono scoperti ottimi interpreti dell’indie rock più
diretto dando vita alla loro versione 2.0.
Questo nuovo disco porta avanti il discorso virandolo verso un brillante power pop infarcito dalle
tastiere e dalla produzione dell’amico Philippe Zdar
dei Cassius. Si avverte un’ulteriore rafforzamento
strutturale dei brani e una maneggevolezza pregevole della freschezza pop che tende a partorire l’effetto “ogni traccia come possibile singolo”. Le chitarre
si intrecciano giocose nel singolo Lisztomania e nella
ritmica vivace di Lasso per poi lasciare trasparire un
lato soul speziato di spirito dance come potrebbero
intenderlo alla DFA nella coinvolgente Fences. Zdar
mette lo zampino decisivo nei synth circolari di
1901, nella traduzione del post rock nelle due parti
di Love Like A Sunset (dove synth spacey e riverberi
la fanno da padrona) e nell’effettistica della ballata
Rome. Countdown e la conclusiva Armistice sono altri
due numeri di solare power pop lontano dalla mera
semplicità ma miscelante incastri melodici di rilievo
e un certo gusto per il fascino d’impatto.
Il notevole lavoro di produzione e quel tocco di
synth hanno aggiunto quell’ingrediente in più che
prende una formula già testata e la porta avanti senza blocchi compositivi e con un’immediatezza che
colpisce sulla breve distanza e convince lungo gli
ascolti. Da quel french touch in chiave dancefloor
che fu ad un pop che gioca con la pista facendosi
beffa della faciloneria del 4/4. E dopo la sorpresa, c’è
la conferma.
(7.3/10)
Alessandro Grassi
Piers Faccini - Two Grains of Sand
(Ponderosa, Apr 2009)
G enere : folk rock
Prova a studiare da grande, Piers Faccini. Si produce
da sé il fatidico terzo album cercando la polpa del
proprio quid espressivo. Scandendo le forme con
garbo essenziale, reinventandosi radici piantate nel
cuore di un’Africa più mentale che altro, sbocciata
attorno alle andature blues, ai fremiti gospel e alle
apparizioni jazz. L’influsso Ben Harper è ancora
evidente nella rurale intensità di A Storm Is Going To
Come, nell’arcaico intimismo di My Burden Is Light e
tra le venature orientali
di Your Name No More,
formalmente diligenti ma
melodicamente accademiche per non dire aride,
per giunta interpretate
con disarmante arrendevolezza.
Se la calligrafia ci guadagna in coesione, evapora
ahimé quel senso di imprendibile vaghezza che regalava fascino alle atmosfere di Leave No Trace e
Tearing Sky. Magia di cui scorgiamo qualche eco
nelle meditazioni buckleyane di Time Of Nought e
Save A Place For Me o nel John Martyn trasognato di Who Loves The Shade e The Dust In Our Eyes.
Pezzi che testimoniano una visione sonora di tutto
rispetto, che promuovono Faccini al grado di musicista vero e proprio, non più quel pittore prestato al
mondo delle sette note che sembrava. Tale “investitura” significa anche una normalizzazione, ovvero la
capacità - il mestiere - di confezionare ciò che prima
sembrava scaturire per chissà quale prodigio.
In ragione di ciò puoi apprezzare la solenne compostezza della title track, i guizzi fragranti à la Paul
Simon altezza Graceland di Home Away From
Home, il romanticismo laconico tra M. Ward e
Rufus Wainwright - archi, cori, glockenspiel - di
The Wind That Blows. Vada infine un plauso alla generosa gravità dei testi. Ma quel mistero, quella magia
- ahinoi - non ci sono più.
(6.1/10)
Stefano Solventi
Remano Eszildn - R-Tracks (Mu Ziq,
Mar 2009)
G enere : bbreaks 09
Immagina di avere appena scartato quel disco con
il robot che ascolta in poltrona il suono Warp. Sì,
quella compilation che si chiamava Artificial Intelligence. Era il 92. Ti ricordi? Autechre, Squarepusher, Aphex e compagnia bella. L’abbiamo già
detto troppe volte quest’anno. I draghi son tornati.
E con il manifesto Harmonic 313 siamo ancora là,
seduti in poltrona ad ascoltare, rilassati dopo il rave.
Remano Eszildn è una delle voci che viene fuori da
quella covata con i suoni post-bbreaks nel DNA. Ovviamente targato Paradinas: Mu Ziq, l’angolo acido
della faccenda. R-Tracks è un plagio, una copiatura eccellente, il barocco che prelude alla decadenza e che
ci mostra come stare sulla cresta della storia sia un
affare di classe, una cosa per pochi eletti che guarda
caso quegli anni li hanno vissuti sulla pelle e sull’anima.
Oggi entrare a far parte di quel gotha è arduo e per
avere le chiavi che aprono le porte giuste bisogna
vendere il culo alla Roland 303, in una sola parola: rischio. Qui si sente invece come l’azzardo sia ancora
distante, quasi si ha paura di andare fuori dai binari
sicuri dell’IDM. E se ogni tanto ci sono degli squarci
al mondo ignoto del sogno post-E (The Brink, Alterant Arch) sono ancora troppe le citazioni inutili e
ritrite (il drill di Countdown To Meltdown, le vocine
dai B-movie di Audio80, i suoni a 8 bit di Telistrex e
gli altri cliché ormai ‘di moda’) che annoiano.Troppa
tecnica, poco sangue.
(5.9/10)
Marco Braggion
Revolution (The) - The Revolution
present Revolution (Rapster, Giu
2009)
G enere : electronica - l atin
Progetto Rapster, sorta di Buena Vista Social Club
ribaltato, che fa pensare anche al BrasilInTime (2006)
della Mochilla. Lì percussionisti brasiliani, batteristi
jazz e produttori e dj black. Qui giovani musicisti
cubani (nomi che (ancora?) non ci dicono nulla
come Damien Nueva Cortes, Armando Cosama, Alfred Di Maio, Yaroldy Abreo Rodles, Roberto Arrechea Vilches) e produttori anglosassoni responsabili
di tanto di quel pop tra legno e plastica che negli
ultimi anni ha più flirtato con l’electronica: Norman Cook (sì, Fatboy Slim), Guy Sigsworth
(Bjork, Madonna), Marius Devries (Bjork,
Massive Attack, Moloko), la coppia Cameron McVey e Jan “Stan” Kybert (Massive
Attack, Portishead), Rich File (Unkle), Poet
Name Life (Black Eyed Peas). Due pezzi a
testa. Pasta omogenea nonostante l’immediata riconoscibilità, materiali per lo più ballabili, cantato bilin-
recensioni /
81
gue, inglese e spagnolo, coi titoli che traducono da
una lingua all’altra, voci femminili sensuali e maschili
spesso anche rappate, tante percussioni. Leggero e
piacevole Fatboy, in apertura col fido Lateef Truthspeaker, in Siente Mi Ritmo (self-explanatory),
il più cubano di tutto il lotto. Sigsworth tra i picchi
di ballabilità, tra pulsazioni quasi techno e miscele
nu-latin-r’n’b. Devries a suo agio con Roisin Murphy, zuccheroso, e tamarrissimo (non divertente,
proprio brutto) con Guantanamero (fin dal titolo).
McVey-Kybert rullante cento per cento Massive
Attack, narcotici, riprendono poi gli accordi di
Riders on the Storm per
Black Dollar, per la voce
bellissima di Jenna G.
File è l’aporia, i suoi sono
siparietti eterei che spezzano prima e chiudono
poi il disco, belli, ma di
cubano non hanno niente, inglesissimi, algidi e crepuscolari come sono. Poet, un meticciato tamarro
(divertente) con fiati spumeggianti, e una Dark House (anche qui, self-explanatory) con intro d’archi e
house in levare. Quindi: disco estivo in tutti i sensi
(esce a giugno), un paio di potenziali hit, tra cui l’iniziale di Fatboy, nomi importanti, suoni golosi, non ci
si annoia. Però ecco, mica rivoluzionario.
(7.2/10)
Gabriele Marino
Richard Swift - The Atlantic Ocean
(Secretly Canadian, Mar 2009)
G enere : soul pop rock
Ok, a questo punto Richard Swift è a tutti gli effetti un caso. Anche col qui presente The Atlantic
Ocean mette in mostra un talento non comune,
prestandosi stavolta alla fregola soul-errebì venata vaudeville come potrebbe un figlioccio segreto
di Randy Newman. Sembra quasi che dopo la
sventagliata polimorfa di Dressed Up For The
Letdown (2007) il Nostro voglia mettersi alla
prova in territori più specifici, siano le alambiccate
escrescenze electro ambient di Music from the
Films of Richard Swift (Secretly Canadian, 2008)
col moniker Instruments Of Science And
Technology, siano i ruggiti garage-blues di stampo sixties sciorinati in As Onasis (2008). Se quelli ti
lasciavano col dubbio che il tipo più che altro ci menasse per il naso, scordandosi quel quid che rende
l’espressione trascinante (a meno che non intendes-
82
/ recensioni
se mettere se stesso - il divenire dell’uomo dell’artista - al centro della questione, e allora sticazzi), qui
a dire il vero viene fuori un qualcosa d’accorato, il
gioco s’increspa di sbrigliatezze e struggimenti che
fanno presa, cui ti vien voglia di credere malgrado si
presentino spesso incorniciati tra ghirigori sintetici
e folate robotiche che li contagiano di una inconfondibile aura post-moderna.
Appunto: il caso è tutt’altro che risolto. Il buon Richard non è uno da palpitazioni del tutto autentiche.
Ovvero, in lui la rappresentazione è una materia su
cui occorre sempre ponderare, un pedaggio che paghi sapendo che ne avrai in cambio di belle e buone.
Però, in qeusto caso, come dicevo, ci sono anche
le canzoni. E c’è da goderne: col rag floscio e le fughe oniriche di Ballad Of Old What’s His Name (più
o meno la Band colta da estasi Beatles), col soul
carburato power pop di Lady Luck (all’insegna di
cuore e immediatezza come Kravitz ha smarrito
da un secolo), con la marcetta garrula di Hallelujah,
Goodnight! (un Badly Drawn Boy strattonato
Capossela? Massì...), con l’ipotesi glam civettuola
e androide di The First Time (il Jim O’Rourke più
gaio in fregola Bolan) e una title track che appunto
scomoda piglio errebì-vaudeville virato post-wave
da Randy Newman cibernetico.
Quindi: stai a vedere che col suo cazzeggiare metastilistico Swift alla fine ha imboccato la strada giusta.
Oppure: figurati se al prossimo giro non butta di
nuovo tutto all’aria. Ergo: godiamoci questa delicatessen, e più non dimandiamo.
(7/10)
Stefano Solventi
Riverboat Gamblers - Underneath
The Owl (Volcom Entertainment,
Mar 2009)
G enere : P unk
Considerato uno dei più incendiari live-act in giro,
punk senza prefissi post- né suffissi -funk e nemico
dichiarato dell’emo, questo gruppo texano arriva al
quarto disco tra qualche perplessità.
Gli elementi pop nel loro stile ci sono sempre stati bilanciando sul versante discografico la furia dei
live, in un equilibrio che nell’ambiente aveva fatto
riscuotere ai RG stima e consensi.
Ma se lo studio era il luogo dove concedersi qualche
raffinatezza, questa volta il produttore sembra aver
ripulito troppo (altro che “produced under extreme duress” come scritto sul disco), come emerge
dal confronto col precedente To The Confusion
Of Our Enemies (e dai commenti di chi li ha visti
live).
Nulla di scandaloso, la furia qua e là rimane (l’apertura di DissDissDissKissKissKiss, una Victory Lap che la
rimette in pace con la melodia o l’Iggy-punk notturno di Castastrophe) e l’energia non viene mai meno:
è che forse non era il caso di togliere il muro sonoro in un disco le cui composizioni brillano poco
(e tralasciamo la visita al country di The Tearjerker e
i suoi accenti coatti di cassa e chitarre sul chorus),
anche perché poi finisce che il loro punk-anthemico,
che avendo schivato sia gli Wire che Sandinista!
potrebbe essere stato inciso in un anno qualsiasi,
una volta spogliato invece riveli l’età quando, per
esempio, nella pur efficace A Choppy,Yet Sincere Apology emergono assonanze Green Day.
Insomma, flessioncina onesta di gruppo onesto che
fa il suo, entrambi adatti agli amanti del genere e
non strettamente indispensabili per gli altri.
(5.3/10)
Giulio Pasquali
Scary Mansion - Every Joke Is Half
The Truth (Talitres Records, Mag
2008)
G enere : folk indie
Comincia con una ballad psych piuttosto compressa
e chitarra distorta (Captin) l’esordio di Leah Hayes da Brooklyn e del suo gruppo Scary Mansion,
uscito in realtà l’anno scorso e distribuito solo ora.
Dicevamo dell’incipit del disco, che poi diventa da
subito altro, vale a dire un’incarnazione della Cat
Power malinconica - dalle parti di What Would
The Community Think - (Go To Hell) in ballad
umorali e sbilenche cariche della giusta inquietudine
(Scum Inside, Sharkish Sea).Altrove è folk rock carico
di inflessioni soul, e qui si ricorda l’ultima Chan. O
ballad gotiche retaggio post punk (Sorry We Took All
Your Money) e folk intimista alla Tara Jane ONeil.
C’è la semplicità del folk e la cura nel costruire le
canzoni.
Un passato in Francia come metà del duo noise-rock
Satan’s Fingers insieme a David Ivar degli Herman
Dune, Leah sembra voler andare oltre il paragone
con la Marshall (anche per una voce molto simile)
riuscendo a mostrare potenzialità che promettono.
(6.7/10)
Teresa Greco
Scratch - Loss 4 Wordz (Gold Dust,
Mag 2009)
G enere : hip - hop
Kyle Jones aka Scratch, beatboxer e dj del giro Roots (sue tracce dal vivo e su disco da metà Novanta
a primi Duemila), alla seconda prova solista dopo
tante collaborazioni (De La Soul, Jay-Z, P!nk,
Musiq, Zap Mama) e dopo essere stato uno
degli animatori dei Dino 5 e del loro Baby Loves
Hip-hop (2008), progetto appunto di “hip-hop zerododici” ideato dal tuttofare Andy Hurwitz, con
la voce narrante di Ursula Rucker e altri pezzi
grossi black come Prince Paul. L’esordio The Embodiment of Instrumentation (2002, RopeADope) era
basato su un uso misurato del beatbox (una banalità: Scratch non è Rahzel), che faceva da scheletro
portante per tutte le composizioni, mimetizzandosi
però sobriamente con gli altri elementi produttivi.
Un disco asciutto insomma, senza eccessi di tecnica o virtuosismo, orientato su un hip-hop oldie,
spesso jazzato. Questo Loss 4 Wordz (qualcosa tipo
il nostro Ho perso le parole) era annunciato già per
agosto 2008 e ha richiesto tre anni di lavorazione.
Se Scratch voleva stupire cambiando rotta, c’è riuscito. Il disco è molto più prodotto del precedente,
più pieno di suoni, una confettura plasticosa (non lo
si dice in senso negativo) influenzata dall’ultra-pop
nu-soul e nu-r’n’b anni 2000.
E ci sono cose davvero tamarre, come il pezzo assieme a Arthur Baker, praticamente un pezzo
house, abbastanza fuori contesto. Scratch si rivolge
a un nuovo pubblico, diverso da quello che lo ha
seguito coi Roots e in conseguenza dei Roots. Illuminante in tal senso la teoria di vocal guest, come
per l’esordio (ma con nomi diversissimi), lunga e
prestigiosa. Il pezzo con Benfield è praticamente
Justin Timberlake, belli quelli con le vellutate voci
di Estelle e di Jeymes Samuels, fratello (vedi
un po’...) di Seal, bello il pezzo con un etereo (stile
Tender) Damon Albarn, in compresenza con un
Talib Kweli che ci viene però negato dalla versione promo, che edita pesantemente. La superstar
Kanye West compare, assieme a Consequence, su uno dei pezzi meglio riusciti di tutto il lotto,
Ready To Go.
Normalizzazione in chiave black-pop d’oggi, ma normalizzazione dignitosissima.
(6.6/10)
Gabriele Marino
recensioni /
83
Sebastien Grainger - Sebastien
Grainger & The Mountains (Saddle
Creek Europe, Apr 2009)
G enere : indie rock
L’ex batterista del disciolto duo canadese Death
From Above 1979 all’esordio solista sulla lunga
distanza.
Il dance punk sostenuto della band di origine qui
si arricchisce di chitarre, per un sound che vira al
rock di chiara matrice dance; un incontro ideale tra
l’indie rock, il power pop (sentire il contagioso I’m
All Rage qui in versione dal vivo), gli influssi di marca
Pixies, tutti passati attraverso un’attitudine prettamente dancefloor, che da New Order arriva a
LCD Soundsystem. Passando per alcuni slanci
dei conterranei Arcade Fire.
C’è del lirismo e dell’intensità in questo Self Titled, forse non perfettamente bilanciati e messi a
fuoco, ma si intravvedono margini di sviluppo.
(6.6/10)
Teresa Greco
Sholi - Self Titled (Touch & Go /
Quarterstick Records, Mar 2009)
G enere : post - ball ads
Sholi ha come sostrato gli anni Novanta, come un
bacino, come il letto di un fiume; l’acqua di questo
fiume arriva alle caviglie, e per questo si può vedere
cosa c’è sotto; e però l’acqua che passa sopra è una
lenta corrente melodica, che in qualche modo basta
a se stessa, che passa sopra agli anni Novanta senza
rimanerne poi troppo condizionata in superficie; del
resto si sa che i fluidi si adattano al recipiente ma
non si modellano sul fondale.
Gli anni Novanta in questione sono quelli del postrock, obviously, quello americano, quella sorta di
math e quel post “sensibile” che può essere accostato volgendosi al Canada a A Silver Mt. Zion,
le cui punte patetiche a tratti vengono sfiorate dagli
Sholi. Si sente anche qualcosa dei Polvo (Tourniquet), qualche altra di For Carnation; ma l’essenza è presto definita; l’album è fatto di ballate dove
la voce e la sua melodia potrebbero avere qualsiasi
mondo attorno; farebbero le stesse cose.
Metafore a parte, se c’è qualcosa che fa direttamente
pensare al decennio passato quella cosa è la batteria,
che rimanda nella sua arrembante ma non fragorosa presenza a Don Caballero maturi, Storm &
Stress, e quindi Damon Che e soprattutto Kevin
Shea. E comunque questa batteria a volte si stacca
dagli anni Novanta, arriva in superficie e si mette a
84
/ recensioni
scorrere insieme alla melodia vocale, diventandone,
ma a livello meno profondo rispetto al fondale, un
brusio di sottofondo quasi free-jazz – ecco Shea;
un continuum, una continuità spezzettata, quasi un
accompagnamento esistenziale.
Poi ci sono va detto delle tracce che riescono ad
autonomizzarsi, a usare la struttura musicale come
fonte di emancipazione dalla decade di cui sopra. Citiamo tra tutte Spy In The House Of Memories.Certo
il “novantume” riemerge sempre, ma in modo non
riflesso, non riflettuto, non ostentato e forse non
auto-riconosciuto; a dirla tutta neanche fastidioso.
Date le premesse, va riconosciuto anche solo questo merito, oltre alla bontà generale del disco.
(6.6/10)
Gaspare Caliri
Sleepy Sun - Embrace (ATP Recordings, Mag 2009)
G enere : psych rock
Gli Sleepy Sun sono una giovane band di Santa Cruz,
che si è trasferita da poco a San Francisco, probabilmente alla ricerca di una maggiore visibilità e contemporaneamente di maggiori mezzi. San Francisco
va però letta anche come una città simbolo della
psichedelia anni ’60 e quindi del loro immaginario,
perchè difatti è questo l’affare principale con cui i
sei trafficano nel loro debutto su Atp. Psichedelia
come i bei vecchi tempi andati, in cui loro nemmeno
esistevano, ma che paradossalmente al giorno d’oggi suona particolarmente di moda, forte del contributo di nuovi alfieri come Black Mountain,
Brightblack Morning Light, Crystal Antlers e di buona parte degli amici che Gregg Weeks
mette sotto contratto per la sua etichetta Language
of Stone.
Detto questo uno potrebbe anche chiudere la recensione qui, calcando la mano sul fatto che gli Sleepy Sun sono solo gli ultimi di una serie recente che
va a parare in qualche modo dalle parti di Jefferson
Airplane e compagni e capirai che novità… I pezzi
però ci sono e pazienza se l’originalità non abita da
queste parti, il punto è che nemmeno venie perseguita o ricercata in alcun modo. Essere originali qui
proprio non interessa a nessuno e che il rock sia un
genere ormai completamente passatista questo non
lo scopriamo oggi. Gli Sleepy Sun però ci mettono
una certa urgenza adolescenziale che fa bene alla
salute, specie nei frangenti maggiormente sostenuti
da un impeto hard che i sei fanno ricondurre direttamente a Blue Cheer e Black Sabbath, e da qui
highlight
Pink Mountaintops - Outside Love (Jagjaguwar, Mag 2009)
G enere : indie emul - rock
In Stephen McBean convivono due anime e in ciò non vi è nulla di male, dal momento che colossi come Neil Young sulla schizofrenia artistica hanno eretto un’intera carriera. Il problema,
nel caso specifico, si pone allorché il lato più muscoloso e ridondante cade preda di una serietà
che non può più appartenere a certi generi, da tempo consegnati alla pattumiera della Storia.
Parliamo ovviamente di quello che, di norma, viene considerato il progetto principale del Nostro,
quei Black Mountain portati in palma di mano grazie al celebrato In The Future. Che a noi non
piacque, lo ricorderete: appesantito da seghe prog e banalità hard ‘70
ci spinse a invocare il pronto ritorno dei riflessivi Pink Mountaintops.
Diciotto mesi di preghiere dopo, Outside Love scrive il terzo capitolo
di un romanzo interessante per come rimesta la pluridecennale storia
del rock e ne cava un’identità artistica. Dei suoi predecessori assaporavi la sintesi di folk stralunato e riverberi noise in bassa fedeltà, la
fusione tra Stooges e Velvet al cospetto di Jason Spacemen e
Julian Cope. In essi la citazione non scadeva nella copia conforme,
prevaleva l’incrocio e la penna mostrava costituzione sana e robusta.
Cosa che si ripete anche qui con immutata freschezza, nonostante il dispiego di ingenti forze (una
dozzina i musicisti impiegati: spiccano elementi della Montagna Nera, la sirena Jesse Sykes e
il suo chitarristico braccio destro Phil Wandscher, Sophie Trudeau di A Silver Mt.
Zion), un John Congleton più del solito misurato al mixer e l’aria da disco “importante”. Le
medesime premesse della frittata In The Future, sostanzialmente, tuttavia - merito dell’ambito stilistico di lignaggio colto e della sua saggia gestione - ascoltate stavolta canzoni salde e convincenti,
collocabili in una landa attigua al gospel sonico degli Spiritualized, all’acid-rock morbido precursore dello shoegaze e a talune rustichezze country. Più America(na) che si rivolge ad Albione
che viceversa ed ecco la differenza rispetto al passato: perché se Axis:Thrones Of Love ed Execution
sono i Jesus & Mary Chain di Darklands prodotti da Phil Spector, While You Were Dreaming
restituisce dei Mazzy Star chiesastici; se Come Down immagina un sereno Micah P. Hinson,
Vampire è una Queen Jane Approximately natalizia figlia di After The Gold Rush. Perché se Outside Love
si porge oceanica con gusto, Bill Callahan potrebbe far causa per And I Thank You. Per una The
Gayest Of Sunbeams che martella sul classico asse Velvet/Suicide/Modern Lovers, il commiato soul Closer To Heaven non varca la soglia del kitsch.
Perdonateci lo spreco di nomi eccellenti, nondimeno sappiate che il gioco dei rimandi è qui non
solo inevitabile ma addirittura parte della magia. Ancora irrisolta, peraltro, poiché l’album conferma questo lato del talento di un McBean vieppiù trincerato dietro lo scaltro riassunto di tre lustri
di (indie) rock. D’altra parte è l’ennesimo erede del riflusso culturale o, almeno, tale è l’idea di sé
che vuole restituire, acuta e spruzzata di salutare sarcasmo. Se ci sia o ci faccia, è sentenza che
lasciamo ai posteri.
(7.5/10)
Giancarlo Turra
pesanti anthem lisergici come l’iniziale New Age e
White Dove.
I momenti strappa mutande non mancano con la
ballatona da accendino sospeso in aria di Lord. Gli
svacchi da acido però riescono meglio a Brightblack
Morning Light, questi giovanotti si drogano troppo
poco o per nulla per il genere che hanno scelto di
fare. Un disco rock vecchissimo eppure attuale, ab-
recensioni /
85
bastanza gradevole per l’estate che arriva, ma poco
incisivo in generale.
(6/10)
Antonello Comunale
snd - Atavism (Raster Noton DE,
Mar 2009)
G enere : elettronica
Un’ispirato viaggio tra poliritmie di derivazione
techno e sonorità minimal-house, questo Atavism,
nuova uscita per Raster Norton del duo Mark Fell e
Mat Steel (alias snd).
A portare a compimento, ed a evidenziare le
peculiarità di quello che
è l’ormai standardizzato
linguaggio stilistico del
duo, ci pensano le cerebrali dinamiche di Atavism.
Sessantadue minuti pervasi da pioggie in beat, articolati binari ritmici, parametri noti che guadagnano
continuità e forma nel cambio, quello che si fa mezzo
del battere, e del timbro a cui accordare modularità.
Eletronica sensibile al cambiamento votata al materiale più puro e dal tratto minimale a cui concedere
orgie ritmiche, progressioni vitalizie, controlli, pause, aritmie o brusche variazioni.
L’elaborazione puntuale dei suoni e del ritmo si
spoglia del superfluo concentrandosi sugli astrattismi in pattern che portano a compimento sistemi
di micro-equilibri che trovano fissità e fierezza nelle
variazioni al tema.
(6.9/10)
Sara Bracco
Starsailor - All The Plans (Virgin,
Mar 2009)
G enere : B rit pop
Quasi dieci anni di carriera, gli Starsailor, e resistono:
erano fuori moda all’epoca e continuano ad esserlo
anche ora, che in teoria sarebbe anche un pregio. In
teoria.
La voce di Walsh è tanto inconfondibile quanto
uguale a se stessa, come il loro pop-rock fatto di
canzoni quadrate e professionali, con inizio, centro
e fine e i ricami tutti dove te li aspetti e dove manuale vuole, e inevitabilmente enfatiche (che Walsh
non potrebbe cambiare impostazione nemmeno se
volesse è più di un’impressione).
Tell me It’s Not Over, primo singolo che apre anche
86
/ recensioni
l’opera quarta, ha un giro di accordi sentito n volte
un po’ vivacizzato dal piano (altro ingrediente immancabile) e il ritornello che inizia con un “now the
lights out” che a quelle poche decine di milioni di
persone che conoscono Smells Like Teen Spirits suonerà vagamente familiare; ma alla fine ha una leggerezza che tutto sommato funziona. Più del resto di
un disco nel quale i pochi segnali di novità vengono
dallo stomp col tremolo di The Thames e dal boogie
di Stars And Stripes animato anch’esso dal tremolo
e da un hammond salutare: le strofe, perché poi i
ritornelli rassicurano i fans rientrando di corsa nei
canoni abituali dello stile di casa (né poteva scuotere più di tanto le cose la figurina di Ron Wood
nella title-track).
Qualche vibrazione acida movimenta anche Listen
Up, ma in generale siamo sempre lì: Safe At Home,
come dice il brano di chiusura, senza essersi mai
allontanati troppo.
(5/10)
Giulio Pasquali
Steve Roden - Ecstasy Showered
Its Petals With The Full Peal Of The
Bells (Ferns Recordings, Ott 2008)
G enere : ( s ) culture sonore
Pioniere instancabile Steve Roden, artefice di un approccio al suono e all’oggetto del tutto poetico, dai
cui attendersi profonde attività d’ascolto.
Faccende di superfici e architetture minimali quelle
che avete ritrovato tra gli astrattismi in colore di
Colorfiled Variations in uscita per 12k/Line o
quelle con cui interagire invece per Ecstasy Shorewed Its Petals With The Full Peal Of The
Bells, alla ricerca di nuovi suoni.
Ad incuriosire l’artista questa volta sono le sfumature sonore che circondano una piccola campana,
memoria di un viaggio estivo a Parigi, che si fa generatrice di suono in un unica traccia strutturata
con le tecniche del Roden più conosciuto, quelle
del bricoleur che si serve di crescite in dissolvenza
e dinamiche in loop avviate alla lentezza.
Concentriche modularità si susseguono trascinando dietro di se nuovi segni: quelli di cechi rumorismi
stratificati che fluiscono tra vibrandi infinitesimi di
dettaglio, tensioni aggiunte in tones and crackles ed
articolati tintinnanti spettri così puri che lasciano
talvolta intravedere la fonte.
Omaggio nel titolo alla più celebre opera ,Brugesla-Morte del poeta e novellista belga Georges Rodenbach, Ecstasy Shorewed Its Petals With
The Full Peal Of The Bells è non così lontano
dalle atttudini di A slow moving boat (New plastic music, 2008) ma segna un ennesimo passo in
avanti per la scrittura di Steve Roden.
Una musica che vuole pochi paragoni per vastità e
documentazione ma certo non per mancato carattere, contraddistinto per fruibilità colore e narrativa.
(7/10)
(6.9/10)
Sara Bracco
Symbiosis Orchestra - Live Journeys (Baskaru, Gen 2009)
G enere : elettroacustica / sperimentale
Un altro punto a favore per la Baskaru lo segna la
nuova uscita firmata Symbiosis Orchestra a breve distanza dal notevole lascito del giovane artista
americano Ethan Rose (Oaks-Baskaru 2009).
L’obiettivo della label, attenta alla ricerca di nuove
proposte nell’ambito dell’elettronica sperimentale
e della sound-art, è raggiunto anche con le undici
tracce di Live Journeys, la cui geometria in acustica ed elettronica tracciata in mutue e mutevoli
relazioni evidenzia indiscussa maestria in armonica
simbiosi.
Distante da qualsiasi termine in catalogazione di
genere ma, oppurtunamente responsabile di quei
metodi in improvvisazione tra stesure più o meno
concrete ed ambient a cui corrispondere un’ottima
scrittura e conoscenza di forme e strutture musicali. Il valore è certamente dato dalle combinazioni
d’artisti e dal materiale raccolto, quello in live che
nel 2005 l’italiano Andrea Gabriele ha saputo annotare e fissare con estrema precisione.
Racconti di viaggio dai panorami differenti responsabili di quella fluidità che va in aiuto dell’insieme,
alleggerendo il fardello ma senza mai perdere per
strada quelle che sono abilissime orchestrazioni in
elettroacustica.
Tappe fondamentali quelle in quartetto di Live at
Peam (2005, Ecoteca Pescara) tra le percussioni di
Stefano Tedesco, gli archi di Diego Conti e le iconiche vocalità di Iris Garrelfs che Andrea Gabriele
lascia correre immacolate tra punteggiature, prese
dirette e sottili sovrapposizioni in loop che sanno
giocare con la sospensione in Cinematic Naples tra
le strumentazioni in fiati di Geoff Warren e distese
in drones.
C’è poi l’elettroacustica chiaroscurale ed eterea di
Live at GAM-Gallarate 1, quella demarcata in sintetica tra similitudini in ritmo Live at GAM-Gallarate 2
a cui concedere comtrappunti elettro di esemplare orientamento (Live at FabbricaEuropa-Florence 2)
concordate con l’artista Robin Rimbaud-aka Scanner.
Sara Bracco
Tara Jane ONeil - A Ways Away (K
Records, Mag 2009)
G enere : folk
Tara Jane O’Neil è la madre di tutte le neo-cantautrici, che si tratti della lineare Marissa Nadler o
dell’ultima, obliqua Grouper.
Al quinto lavoro - primo per la K Records - e assistita, tra i tanti, dai sodali Jean Cook e Daniel Littleton, l’ex Rodan è la solita e flebile chanteuse che ha
fatto proprio il registro
più sedato dei Velvet
Underground (Dig In)
e le docili pagine di Judee Sill (In Tall Grass) e
Joni Mitchell (Drowning) per travasarlo in
quell’universo che fino
a qualche tempo fa veniva etichettato post-rock. Solita O’Neil insomma,
l’ugola trasognata come se cantasse alle prime luci
dell’alba (Biwa), classica e ormai matura alla stregua
dei nomi di cui sopra (la splendida Howl), sinistra
(Beast, Go Along sembra una versione al femminile
di We Will Fall degli Stooges), visionaria come Ry
Cooder (Pearl Into Sand) ed elegiaca che manco alla
Kranky (The Drowning Electric).
Dopo una carriera più che decennale, spendere
altre parole sul personaggio crediamo sia inutile.
Come il caro amico che non cambia mai e che sai
esserci per sempre. Chi la conosce sa cosa fare. Chi
non la conosce, anche.
(7/10)
Gianni Avella
Technogod - Pain Trtnment (Tack
At, Apr 2009)
G enere : industrial funk
Darli per dispersi era forse più che lecito, visto lo
iato pluriennale che li separa da Undo, ultima – se
non andiamo errati – chiamata alle armi per il collettivo italiano, targata 2001.
Stando però a quanto offre Pain Trtnment, l’entità Technogod (rinominabile anche Tack At per
recensioni /
87
highlight
St Vincent - Actor (4AD, Mag 2009)
G enere : avant pop orchestrale
Il songwriting prettamente pop orchestrale della chitarrista e polistrumentista americana Annie
Clark, ex-Polyphonic Spree e Sufjan Stevens band, che ci aveva favorevolmente colpito
un paio di anni fa al debutto con Marry Me, si arricchisce ora di nuove spezie.
Fermo restando la sua base, questo nuovo Actor spinge ancor di più verso una cinematicità di
fondo, che fa sì che ogni canzone sia un piccolo frammento sonoro, fatta anche di unità minimali,
e che nel loro insieme compongano un vero e proprio “score”. Frammenti che la Clark definisce
come “technicolour animatronic rides”.
L’ispirazione è infatti derivata proprio dalle colonne sonore, che siano di Disney o morriconiane o di Broadway (Il Mago di Oz viene
citato in Marrow), oppure ispirate a Igor Stravinsky, Carl Orff,
Erik Satie. Il respiro orchestrale è infatti ampio e stratificato, combinandosi con altri elementi apparentemente “dissonanti”, quali layer
sonori, distorsioni, ripetizioni alla maniera del coacervo sonoro ottanta di marca Peter Gabriel (prettamente periodo Scratch/Melt), si
veda l’opener The Strangers; altrove (Actor Out Of Work) si viene rimandati, anche melodicamente, al coevo esperimento Scary Monsters
(dalle parti quindi di Bowie/Fripp). Non senza far pensare al lato più pop di una come Laurie
Anderson.
E ancora un’attitudine di marca Bjork-iana, già rilevata nel precedente lavoro si sposa alla teatralità di una Shannon Wright e alle atmosfere chamber dell’ultima My Brightest Diamond, mentre è puro Broadcast The Bed, con un retrogusto melanconico sua cifra stilistica
da sempre.
Actor è quindi album che rappresenta un passo in avanti rispetto al pop jazzato del precedente,
segno di un’evoluzione anche stilistica della Nostra. Gran bel comeback.
(7.3/10)
Teresa Greco
uscire dal vincolo technoide e cercare nuove forme
identificative per reinventarsi) è più viva che mai, così
come pulsante e mai arrendevole è il postindustrial
sociopolitical paranoid toxic funk spalmato in 15 tracce tra sintetico e materico. Cosa che, sin dai tempi
dell’esordio Hemo Glow Ball, è sempre stata la
cifra stilistica predominante di Technogod insieme al
dissacratorio impegno da agitatori culturali.
La tripletta iniziale è letteralmente da sballo: Blank &
White, Interessi Di Conflitto/In Search Of The Enemies e
Girls Just Wanna Have Funk tirano in ballo funk technoide, flirtano con dance apocalittica e prendono
per il culo i p-funksters dell’ultim’ora con una dose
da cavallo di ironia e sarcasmo. Il resto dell’album
non è poi da meno. The Day The World Stop Shopping
rimembra Pankow et similia nel suo calarsi acidi
88
/ recensioni
mitteleuropei a base di ebm berlinese; Free’n’Lonely è
i Talking Heads tutti lustrini e droghe sintetiche
nati nella città globale post-www; Get Closer To God
(Bypass The Vatican) cortocircuita il funk industriale
con la synth-wave d’inizi ’80, altezza Limbo. Insomma, i Technogod sanno bene cosa hanno in mente e
soprattutto come ottenerlo.
Come da tradizione, intorno al nucleo formato da
Loz e Y:dk, con Francesco “Fresh Drummah” Brini alla batteria, si coagula uno stuolo mai banale di
ospiti, tra cui spiccano la voce di Tying Tiffany (in No
Fun Pour Moi?, autodefinita franclish gabber’n’roll) e
quella dello scrittore Girolamo De Michele in L’Italia Mangia I Suoi Giovani).
(7/10)
Stefano Pifferi
Thermals (The) - Now We Can See
(Kill Rock Stars, Apr 2006)
G enere : P ower P op
Il terzetto di The Body, The Blood, The Machine continua l’ascesa. Now We Can See è
l’ennesima conferma dei Thermals come misto di
contagioso storytellin’ ed energico power pop ora
punky ora garagy. Aspetto fondante del nuovo lavoro: scrittura più sciolta e personale, meno espettorazione e maggiore accento sul pop nel senso di
USA.
In pratica i ragazzi stanno puntanto a entrare nei
cuori della gente come dei nuovi Green Day (con
i quali iniziano ad avere in comune la facilità del ritornello generazionale), e meglio, dei Replacements
00s (con i quali condividono l’attitudine alla diversificazione degli arrangiamenti e la capacità d’analisi
scarna ma efficace). Direi che ci siamo: nel 2009,
non riesco a pensare a niente di più fresco e immediato nell’indie americano.
(7.1/10)
Edoardo Bridda
Thunderheist - Thunderheist (Big
Dada Recordings, Mar 2009)
G enere : bbreak disco - mesh
La mutazione della Ninja (via Big Dada) passa attraverso tre nomi: Qemists, Yppah e Thunderheist. Da
turntablizm stretto a mesh globale e più che mai 09.
L’album omonimo e infarcito di hype che finalmente abbiamo in ascolto conferma l’ampliamento degli
orizzonti dell’etichetta londinese, baluardo di una
estetica oggi d’antan ma che spopolava nei ‘90. Del
resto nella contemporaneità meshy la parola d’ordine è futurismo. I guru di tanto tempo fa l’hanno
capito e ci presentano una cosa che è post-p-funk
con sfacciati sculettamenti da dancefloor, ammiccamenti glitter con qualche acidità synthetica.
Basso che pompa, basi cosmico-prog a firma
Grahm Zilla, batteria DFA e uptempo di newyorchese memoria. La ricetta è questa, signori. In
più su tutto questo miscuglio c’è la voce di Isis, generazione Missil/Santogold via Salt-N-Pepa,
quel break mezzo hop mezzo sexy che piace tanto
ai remixatori della Furtado (Jerk It, Slow Roll) e che
guarda al trash-fidget truzzo (i due minuti da pelle
d’oca di Anthem). In aggiunta la componente 8-bit
tanto cara ai Crystal Castles (LBG, Space Cowboy), l’inevitabile recupero del break con gli effetti
nerd (Bubblegum appunto) e l’immancabile citazione
all’Hacker di Grenoble (Freddie è il singolo manca-
to di Miss Kittin).
Se l’electropop robotico rifondato dai Daft Punk
si è reincarnato in infiniti golem, questa deviazione
Ninja ci preannuncia la break-dance del futuro prossimo. Saremo tutti ancora immersi in neon lights,
magari con qualche collanona d’oro al collo e con
qualche pastiglia in tasca. Acid trapassato dal break.
Thunderheist nuovi profeti.
(7.1/10)
Marco Braggion
Tiga - Ciao! (Wall Of Sound, Apr
2009)
G enere : retrofuturdisco
Se Oizo aveva rifatto i novanta con le scariche fidget della scuola Crookers, riasumendo tutto in un
discone del calibro di Lambs Anger, oggi ritorna
Tiga, il ragazzo da un milione di dollari dell’electro
pop internazionale. E anche qui come da molti anni a
questa parte (almeno da quando la Kitsuné ha fatto della Disco una seria questione da passerella) c’è
lo sguardo retrofuturista che guarda agli 80. Ciao!
è un disco che ripercorre l’immaginario sfocato di
quegli anni da bere, tutti dietro ai Ray Ban (oggi e
sempre più indossati da Miss Kittin), robotizzati dalle prove da discotechina dei Depeche Mode
e rimpolpati da una tonnellata di gruppi melo, che
della lacrimuccia hanno fatto un marchio di fabbrica.
Dunque è tutto in linea con il fortunatissimo Sexor
del 2005 con una differenza che vedi direttamente
in faccia al ragazzo sul My Space: il fondotinta e gli
abiti sono neri e il sound gli fa il paio come dire
che se c’è Peaces nell’aria è meglio batterla nel suo
stesso recinto. Ma, meglio, che se stai troppo dentro
certi ambienti il nichilismo ti viene naturale ed è
proprio lui alla fine a fregarti l’asso.
Dunque attenzione Tiga: dalla versione geek del video Far From Home a quella sexy black del nuovo
Shoes, ci perdi in melodia anche se a salvarti è ancora l’Ambizione.Voglia di trono che ti porterà probabilmente, come un Williams variante Bond, al podio
dell’electro ma con uno stile e una missione ben più
pericolosi che in passato.
Pericolosi gli smalti morbosi e sexy sui vecchi modi
‘80 ma poi c’è tanto in Ciao! Varietà e generosità in primis e sta li la differenza rispetto all’ultimo
Fischerspooner. La cattedrale barocca risplende di
richiami breakbeat (Mind Dimension è uno studio di
scuola Jack virato french), di singoli leccaculo (Luxury
con quei pad à la Gazebo, Turn The Night On con il
basso in overdose uberpop Moroder), di cavalca-
recensioni /
89
te che ricordano le prove della trimurti Lindstrøm
Circlesquare Øye (i dieci minuti da panico Cerrone nella nonsoloballad progressiva Love Don’t Dance
Here Anymore) e di una vernice glitter che fa risaltare
quanto il ricordo sia più che mai now. Ma ancora:ci
vuole poco a sputtanarsi con i rifacimenti e i plagi.
La coca e le paillettes fanno male. Del resto, questo
è il nuovo corso del dopo Tellier. Rifatevi l’armadio.
L’estate è alle porte. Ma attenzione...
(6.9/10)
Marco Braggion, Edoardo Bridda
Tom Brosseau - Posthumous Success (Fat Cat Records, Mag 2009)
G enere : folk
Dopo aver dato alle stampe nel giro di un anno –
era il 2007 – due dischi esemplari come Grand
Forks e Cavalier e non essersi spostato di un
millimetro da quel “bravo ma per pochi” che ormai
sembra rappresentare un po’ il contrappasso a cui è
stato condannato, Tom Brosseau deve aver pensato
di non avere più nulla da perdere. E allora un titolo
come Posthumous Success per il nuovo episodio,
quasi a ironizzare – la versione ufficiale della storia,
in realtà, chiama in causa Albert Camus - sulla
cronica mancanza di attenzione per una proposta musicale, comunque,
di valore. All’interno tredici episodi che abbandonano coscientemente
l’uniformità di vedute
messa in bella mostra nelle uscite precedenti, per
unire al folk elegante da sempre marchio di fabbrica
dell’americano un approccio meno in linea con la
tradizione.
Giusto un paio di post-it in apertura per ricordarci
il Brosseau più canonico e poi si decolla – o forse sarebbe meglio dire si atterra - sulle batterie in
loop di You Don’t Know My Friends, il synth un po’
“sciapo” di New Heights, il Lou Reed di Drumroll,
gli aromi sud americani di Axe & Stump. Alla ricerca
di un feeling non ben identificato, di un processo
di ringiovanimento che sa tanto di chirurgia estetica, di un punto di contatto tra blues rurale e Anno
Domini 2009. Un’operazione che nella maggiorparte dei casi, non dà il risultato sperato. In mezzo al
labirinto di intenzioni che fa da corollario ai suoni, ci
si imbatte in parentesi strumentali da un paio di minuti (Boothill, Youth Decay), richiami rassicuranti alla
90
/ recensioni
produzione più recente, ma, soprattutto, idee poco
chiare. Molte e mal disposte, confuse tra la voglia di
rimanere fedeli a se stessi, affrancarsi definitivamente dal passato o magari esplorare mondi musicali
altri solo per vedere che aria tira. Il problema, oltre
al fatto che alla lunga del contenuto di questi corsi
di aggiornamento non ci si ricorda proprio, è che il
meglio lo si ascolta ancora nei brani più in linea con
l’immaginario del musicista. Quelli che da cinque
anni a questa parte il Nostro mostra di saper scrivere su un fingerpicking ormai riconoscibile - Favourite Colour Blue e Been True - o magari affidandosi a
un country sobrio e elegante (Wishbone Medallion).
Verranno tempi migliori. Nell’attesta, recuperate gli
scatti in bianco e nero di qualche anno fa.
(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Tomas Phillips - Six Notes (Koyuki
sound, Mar 2009)
G enere : minimalismo
All’insegnamento e alla scrittura l’artista Tomas Phillips da sempre ha alternato la composizione, per
essere precisi quella in musica elettronica, dominata
dalle tradizioni, riscontratate alle migliori ed eleganti scritture in contemporanea.
A corrispondere a tali istanze ci pensa Six Notes,
esordio dell’artista per la Koyuki Sound a due anni
dall’uscita per la Non Visual Objects Drink Deep.
La sezione è quella conosciuta, un unica traccia a
cui assistere al comporre, quello che prende forma
nelle malinconiche ed isolate note di un pianoforte
al confine con le traduzioni più criptiche del Ryuichi
Sakamoto.
Prevalenze conosciute al Phillips di Intermission/
Six Feuilles (Line 2006) che tornano care ai ventuno minuti di Six Notes tra termini in decostruzione ed eleganti danze in sfumature. Principale divenire spetta al pianoforte, fluttuante a mezz’aria
tra microidentità in particelle, sottofondi in drones,
autorigenerati in riverberi o appoggiati al silenzio. Il
discorso da qui in poi va oltre la questione di qualità, bellezza o armonia per accordarsi con quell’arte
rara nel rappresentare e plasmare le note.
(6.8/10)
Sara Bracco
Toy Fight - Peplum (City Slang, Mag
2009)
G enere : indie pop
Un esordio discografico niente male per questi nuo-
vi Belle And Sebastian francesi. Sì, certo, il pericolo di sconfinare nella copia carbone del combo
scozzese è sempre in agguato, ma le sedici canzoni
confezionate per l’occasione fanno letteralmente
esplodere una primavera di suoni, armonie, sfumature, ritornelli alla quale è impossibile resistere.
Una durata media che
raramente sfora i tre minuti, un approccio graziosamente lo-fi alla forma
canzone, una stratificazione strumentale varia
ma mai invasiva: questi gli
ingredienti che i sei transalpini amalgano con cura
e maestria inseguendo la
segreta ricetta del brano pop perfetto. E, dobbiamo
ammetterlo, la scintilla dell’alchimista esplode qua
e là, forgiando caramelle dolci e zuccherate dal gusto variegato da assaporare freneticamente. Anche
perché i Nostri riescono a personalizzare il tutto
tramite quella contagiosa erre moscia della loro
pronuncia inglese, impossibile da non cogliere e non
apprezzare tra ballate delicate e immediate e vivaci
cantilene. Peplum, un “appiccicoso” album solare.
(7/10)
Andrea Provinciali
Vanessa Peters - Sweetheart, Keep
Your Chin Up (BMI, Apr 2009)
G enere : folk rock
C’è veramente poco da aggiungere su Vanessa Peters rispetto a quanto già detto all’epoca del precedente Little Films (Little Sandwich Music / BMI, 20
novembre 2006): la calligrafia folk rock di questa ragazza texana ormai di casa in Italia continua a sembrare una via di mezzo credibile e a tratti adorabile
tra le trepidazioni pensose di Suzanne Vega e
quelle più frugali ma urbane di Beth Orton, senza
scordare i ruggiti intimi di zia Lucinda Williams
e certi guizzi da cuginastra garbata di Liz Phair.
Casomai, va sottolineato come anche questo Sweetheart, Keep Your Chin Up confermi il vizietto del concept, sostanziando ogni canzone su un
personaggio leggendario, mitologico o fiabesco (da
Icaro a Penelope passando dalla Strega del Mago di
Oz) alle prese con le inquietudini e i dilemmi della
contemporaneità.
Vanessa si disimpegna con la consueta intensità e
freschezza sia ai testi che alle melodie, potendo
contare sulla puntuale assistenza dei suoi Ice Cream
On Mondays (backing band da Castiglion fiorentino senza macchia né alcun timore reverenziale) col
contributo di Guglielmo Gagliano al violoncello e
Alex Akela a violino e mandolino. Tra i pezzi spiccano Just Down per la fiera tensione tra camera e
deserto, una First Lesson dal piglio funky screziato
brit, quella specie di mischia tra Counting Crows
e Dire Straits di The War e soprattutto Keep Your
Chin Up col suo toccante accumulo di afflizione.
(6.9/10)
Stefano Solventi
Venetian Snares - Filth (Planet Mu
Records, Apr 2009)
G enere : acid drill techno
Venetian Snares sforna un disco dietro l’altro. E la
sua visione è quella della drill acida che fa capo a
Kid606 e ai padrini Warp prima maniera (Aphex
e affini). A leggere il comunicato stampa si capisce
che il ragazzo è in overdose di acido, con tutti quei
riferimenti al suo membro che comanda i potenziometri della 303. Poi vai ad ascoltare le 10 tracce di
questo Filth (oscenità, appunto) e ti accorgi che la
proposta non è poi così sconvolgente. A rifare quei
ritmi targati 90 ormai è capace qualsiasi nerd smanettone. La produzione è buona, ma a chi importa
di riascoltare cose stantìe? Buono per chi è stato in
letargo 3 lustri.
(4.5/10)
Marco Braggion
Von Bondies (The) - Love, Hate And
Then There’s You (Fierce Panda UK,
Feb 2009)
G enere : shampoo commercial indie
Li avevamo lasciati lo scorso anno alle prese con
un e.p. di gusto assai britannico ma dagli esiti poco
significativi, i Von Bondies. Tali e quali li ritroviamo
oggi all’altezza del terzo album, che una volta potevi
considerare quello “definitivo” circa il valore di una
band. Poiché le cose stanno ancora così, Love, Hate
And Then There’s You rappresenta per la formazione
un’autentica pietra tombale artistica. A un lustro di
distanza dal predecessore Pawn Shoppe Heart che
- sotto l’egida della Sire e la produzione di Jerry Harrison - provava a inscenare una sorta di
White Stripes in chiave post-adolescenziale, il
quartetto gioca la carta del beat-pop e occhieggia i
“favolosi” Sessanta. Si è in sostanza gettata via la
chiave del garage e cambiato il carro su cui saltare
in un disco che ha tutto l’aspetto dell’estremo ten-
recensioni /
91
tativo di passare alla cassa. Niente di disdicevole in questo se il risultato non facesse venire in mente degli Shed Seven americani
appena più dignitosi, ovvero dei pallidi epigoni con
poco da dire in un ambito stilistico sovraffollato. Eccezion fatta per la brillante 21st Birthday le canzoni
a presa intelligentemente rapida latitano, il suono
è fiacco, poco incisivo. Al loro posto ci sono scopiazzature di riff arcinoti e strutture altrettanto, un
cincischiare attorno a brani privi di identità come
del resto è chi li scrive ed esegue. Il leader Jason
Stollsteimer sostiene che questo disco riflette
“una nuova direzione; nulla di premeditato, è soltanto il
luogo dove ci stiamo dirigendo.” Che ci vadano pure,
là. Tanto noi non li seguiremo.
(5.5/10)
Giancarlo Turra
Wavves - Wavvves (Bella Union,
Mag 2009)
G enere : N o -F i
Noise-pop in modalità lo-fi dalla assolata California
atto secondo. Ed è ancora centro pieno per Nathan
Williams. Uno che in questi mesi è cresciuto sopra
e sotto il successo mediatico della rete e non se n’è
fatto prendere. Lui che è il più scanzonato e il più
romantico. Il Barrett dello shitgaze massì (Surf Goth).
Quello che ti interpreta il noise pop e lo condisce
di futurismo straccione come manco un branco di
punk giapponesi sotto LSD potrebbero fare.
E poi un grande album anche per i riferimenti di
prossimità a contorno: sentite la chitarra psych
Crystal Stilts in Suns Open My Eyes, il garage in
gonnella sixties delle migliori Vivian Girls in Get
The Sun e gli smalti shoegaze goth dei Blank Dogs in
Jet Plane. In pratica, è la crema di certo sottobosco
per il quale ci siamo esaltati recentemente. Di più,
corsi e ricorsi, non fa altro che piacere vedere che
nel mentre Beck ri-pubblica il manifesto anti-folk,
One Foot In The Grave, una nuova generazione
di lo-fi singers sta crescendo. Williams prende da
quel Beck la libertà di imbracciare chitarre e/o tecnologie povere (vocoder, synth che paiono chitarre
e sequencers) fregandosene della coerenza (Goth
Girls persino vicina a Nathan Fake). Nel suo arco
infine una carica naif diretta come quella sincerità
tutta sua d’essere punky. Ora è moda. D’accordo.
Domani rimarranno sicuramente alcune di queste
gemme: la citata Surf Goth e So Bored che è l’altro
bell’affondo à la Vivien Girls: distorsore a palla, ululati scemi e un altro modo banale ma vero per dire
92
/ recensioni
giovani 00s (e sempre con i vecchi Velvet Underground nel cuore...)
Wavvves è ora - maggio - distribuito in italia sotto
Bella Union. La copia sotto Fat Possum gira già da
febbraio, stessa cover ma con due tracce in più.
(7.3/10)
Edoardo Bridda
Wildbirds & Peacedrums - The
Snake (Leaf, Apr 2009)
G enere : punk - temporary gospel
Heartcore, l’esordio di questa ennesima coppia
art punk, aveva fatto gridare al miracolo anche i
millennium-scettici più ferventi e così, a un anno di
distanza e sempre su Leaf arriva The Snake, non
tanto il sophomore del duo quanto la logica e compiuta continuazione dell’opera prima.
Benché inciso di filata al precedente e, per i più attenti, già edito nel marzo 2008 su Caprice Records,
il lavoro porta a compimento quel percorso pop
colto e brillante che Andrea Werliin e Mariam
Wallentin avevano coraggiosamente intrapreso.
Forse manca ancora un po’ alla quadratura del cerchio, ma siamo ben oltre la semplice evoluzione di
sound. The Snake è un lavoro dosato e maturo,
dove la febbrile vena compositiva e l’urgenza espressiva si bilanciano perfettamente e nel quale il calore
umano e divino avviluppano come solo nelle esecuzioni dei grandi interpreti. Mariam Wallentin
ricorda tanto Abbey Lincoln quanto Annette
Peacock e, nei momenti di nostalgia roots, Betty Davis in una versione addolcita e malinconica;
l’estemporaneità del jazz è qui affastellata in numerose takes, l’anarchia punk ridotta a minimal wave.
Maturando, il sound del duo si confronta ad ampio
raggio con l’art pop e l’alt-folk di questi ultimi anni:
gli Xiu Xiu in versione sub-sahara (Great Line) o
gli Indian Jewelry minimali, come nella ballad
sghemba Wo ho ho ho, cantata all’unisono e sorta di
contropartita di quella Battle In The Water che fece
definitivamente innamorare la stampa.
I momenti migliori li troviamo però in There is No
Light, alter ego incendiario di Doubt/Hope (il tormentone da Heartcore), dal quale si discosta per
la più decisa traiettoria arty e l’abbandono progressivo del roots, e in Chain Of Steel, in cui Mariam si
avvicina alle colleghe Hanne Hukkelberg e St.
Vincent (o alla connazionale Frida Hyvonen),
salvo mettere del suo senza tralasciare la sfumatura
wave (Siouxsie è un’influenza occulta che ricompare anche altrove). Chiude il carosello la passionale
highlight
William Basinski - 92982 (2062, Apr 2009)
G enere : avanguardia
Le questioni d’archivio sono ormai attitudini per Wiliam Basinski, oltre che un procedimento caro
alle generazioni seriali cresciute tra laptop ed estetica rduzionista. Sono un modo per avviare
critiche e nuove direzioni modellandole tra ricordi e nostalgie, anima e sfumatura. Lungo questa
prassi 92982 i contorni conosciuti nelle prime tre tracce risalgono ai primi ‘80, mentre l’ultima
a quest’anno. Ci riferiamo al Basinski di Variations: A Movement In Chrome Primitive
(pubblicato poi nel 2004) e a quello del successivo The River (risalente all’83 successivamente
edito nel 2002).
Ed è da qui che occorre partire, acquisita l’esperienza con i manifesti dei Disintegration in
Loop, il musicista si muove tra decadenza e malinconia liberata al
sonoro fluire in stratificazioni, procedendo per sfuggenti frammenti
di melodia in feedback e precari istanti d’intrappolata realtà (sample
catturati dal centro di Brooklyn poi trattati).
Processi granulari, innervano le quattro tracce compiendo atti celebrativi di brillante e luminoso avvento. Sono incantesimi in sinfonia,
metafore del tempo, un rituale in divenire infinito fatto di narcolettici
passaggi e contrapposti ricompensi d’innegabile immensità. Basinski
nega, o comunque argina, l’intervallo dando massimo risalto alla progressione che sia essa reclusa in un pianoforte o in un drone tout court.
Conosciuto per le sue fughe al passato, recluse tra alchimie in ambient ed apprezzato per i suoi
capolavori, William Basinski ci accompagna con 92982 verso quella che è una sentita certezza
stilistica e un sublime talento. Quell’arte contemplativa ed incantata che difficilmente i trascorsi,
i confronti, i lavori compiuti ed il tempo porteranno via.
(7.5/10)
Sara Bracco
My Heart, gioiello pop colto e disarmante, summa
delle varie anime dei Wildbirds & Peacedrums, con
tanto di cori gospel in coda.
Un disco che suona “pieno”, nonostante la parsimonia degli arrangiamenti, lacerante e luminoso come
la verità.
(7.6/10)
Francesca Marongiu
Willie Isz - Georgiavania (Lex
Records, Mag 2009)
G enere : H ip H op
Nato dall’incontro tra il produttore hip hop di Philadelphia Jneiro Jarel (noto anche come autore con
il nome Dr. Who Dat) e il rapper georgiano di
Atlanta Khujo Goodie, il duo Willie Isz, dopo qualche apparizione anticipatoria l’anno scorso, esordisce per la Lex con questo Georgiavania, un album
che non sembra smuoversi più di tanto dalla matrice
hip hop che contraddistingue il profilo di entrambi i
musicisti. Beats e rapping si riferiscono inconfondibilmente a questa radice comune, anche se Khujo e
Jneiro dimostrano che, quando vogliono, si muovono
bene anche in contesti più “contaminati”, mescolando electro (Autopilot), shoegaze e funk-soul (In The
Red). Ma la perla dell’album, isolata rispetto al basso
profilo del resto dei brani, è senz’altro The Grussle:
un brano strutturato su moduli melodico-ritmici di
matrice popolare, che richiamano la pizzica e la tarantella, sovrastati da un rapping imponentemente
ricolmo di echi, raddoppi e filtri. Un occhio di riguardo all’artwork, realizzato dall’ “artista di corte”
del fantomatico regno di Georgiavania, James Jarvis.
(6.4/10)
Daniele Follero
recensioni /
93
Wooden Shjips - Dos (Holy Mountain, Apr 2009)
G enere : hard - psych
È all’altezza del secondo album – terzo se consideriamo la raccolta di rarità Vol. 1 – che i Wooden
Shjips decidono di compiere il salto decisivo, abbandonando la California smostrata, deforme, psych e
fattona che aveva da sempre fatto da scenografia
subliminale (manco tanto in realtà) alle loro proposte sul medio e lungo metraggio.
Un salto che non supera solo l’oceano, recapitando
l’immaginario evocato dal quartetto americano sul
grigio urbano del Regno Unito, ma anche un paio di
decenni buoni giungendo orientativamente in pieno marasma post-Tatcheriano. Niente più Doors,
insomma, né tanto meno 13th Floor Elevators
o rimandi alla psychosummer of love. (Quasi) niente
più fuzz o tradizione west coast lisergica. È il pulsare ossessivo del basso
a guidare ormai le danze,
verso un panorama fatto
di grigia cementificazione
“industriale”. A suonare
robotico e subumano, incessante come una fordista catena di montaggio.
È dunque Spacemen
3 il nome di riferimento
del suono Wooden Shjips, così come tutte le pepite
che in quello stralcio di secolo da lì presero il via,
dimostrando di aver appreso la lezione dei padrini krauti e di saperla evolvere al passar del tempo:
Loop in primis, per la meccanicità reiterata delle
strutture; e a ruota Hair & Skin Trading Co.
per il pulsare vivo del basso e Main per l’alone di
alterità che circonda le composizioni.
Un piede fermo nell’universo imploso di Can e Neu,
l’altro nella psichedelia hard inglese degli anni 80,
insomma. Per chi scrive un ottimo e deciso passo in
avanti, rispetto agli esordi.
(7/10)
Stefano Pifferi
X-Mary - Tutto Bano (Wallace
Records, Apr 2009)
G enere : freak rock
Esperienza psycho-geografica, quella del quarto disco dei folletti freak-rock X-Mary. Stavolta Mattia,
Scisci, Jeanluc D e Jeanluc F – sostituti di Cristiano
Cristiana, Lo Sposo, Bocca Mai Stanca e Il Piccolo
Lord – assumono le sembianze di surreali indagatori
94
/ recensioni
del circondario di San Colombano al Lambro, ridente località riprodotta in una stampa d’annata nel retrovinile, nonché sede della cascina Bovera quartier
generale di questi 4 brutti ceffi.
Il crossover spastico si ripropone come al solito in
tutta la sua degenerazione: dall’inno a Gatto Pancieri,
sex-symbol del mondo carnascialescamente rovesciato di X-Mary (Voglio Gatto Pancieri) alla sensualità smostrata alla Fata Faiella di Gin Tonic; dalle sfuriate da hcantiagonistico al funk in melodia post-Alan Sorrenti di
Stasera (La Luna); dalle avvisaglie caciaron-avanguardistiche da pubblicità regresso (Stai Scherzando Con La
Droga) al tributo ubriaco e fake-piacione alla musica
soul e all’immaginario ficaccione tutto (Black Power);
dalle acustiche fughe indietro verso un idealizzato
passato in b/n (Scappo Negli Anni Cinquanta) alla feroce
lucidità post-precariato della bonus track in cui l’istituzione principe della società neo-conservatrice – la
famiglia – viene tranquillamente mandata affanculo.
Insomma, di X-Mary – si sarà capito – è il messaggio che conta. Quel prendere e prendersi poco sul
serio un mondo che invece di seriosità e boriosità
ha fatto una ragione d’essere. Come al solito, un
disco di denuncia verso un panorama sempre più
da denuncia.
(7/10)
Stefano Pifferi
Yeah Yeah Yeahs - It’s Blitz (Interscope Records, Apr 2009)
G enere : pop , wave
A ben vedere, allo scoccare del decennio il vecchio
teorema dell’emul rock (lettori di vecchia data, battete un colpo…) rischia di trasformarsi in un maldestro autogol critico, laddove ormai l’assimilazione
degli stilemi passati è norma codificata, accettata e
ampiamente digerita, e le band un tempo “incriminate” veleggiano salde con la loro bella discografia
alle spalle, infischiandosene allegramente di paturnie da scribacchino ed annessi arricciamenti di naso.
Com’è giusto che sia. E allora la prospettiva odierna,
per certi versi liberatoria, ci rivela ancora meglio
l’essenza di un’entità come i Yeah Yeah Yeahs, che a
questo punto sarebbe meglio intenderli per quello
che realmente sono stati finora, e promettono ancora di essere, ovvero un discreto gruppo pop (più
o meno alternativo, fate vobis). Più che gli album in
catalogo sono i singoli a parlare chiaro, e la nuova
Zero, con una Karen O che si (ri)scopre Madonna punk per le strade della grande Mela, funziona a
dovere sui dancefloor indie e meno indie.
D’altronde, la potente virata ’80 alla MGMT di questo It’s Blitz è l’azzeccata mossa di una band che
sa tastare il proprio peso e caratura, e fa del proprio
apprezzamento – la critica internazionale è andata
in visibilio, confrontate un po’ Metacritic – un’arma affilata quanto i vocalizzi sexy della frontwoman,
i synth taglienti e ruffiani q.b. di Nick Zinner e la
produzione smagliante del veterano Nick Launay e del “solito” Dave
Sitek. Restando sui singoli episodi, Soft Shock è
una ballata dai toni wave
che pur senza il romanticismo di una Maps è di
quelle che rinvigoriscono
il repertorio, così come la
truculenta Heads Will Roll
o la drammatica Runaway, mentre Dull Life spinge
su geometrie di marca Blonde Redhead / Siouxsie
vecchio stampo; sul versante di Skeleton, Hysterical
(prossimo singolone, ne siamo certi) e la conclusiva
Little Shadow ci si gioca invece la carta di un dreampop / shoegaze foderato di electro, che nelle tessiture sa riprendere la lezione dei TV On The Radio e
di certe intuizioni para-orchestrali dei Flaming Lips.
Tutto molto giusto, e sicuramente al passo coi tempi.
In altre parole, tutto molto pop. Squisitamente.
(6.9/10)
Antonio Puglia
Yppah - Gumball Machine Weekend
EP (Ninja Tune, Apr 2009)
G enere : breakelectrodelia
La tattica di DJ Shadow prima di diventare il guru
del turntablizm anni 90 è stata quella di pubblicare
alcuni EP che lo hanno fatto apprezzare per le sue
qualità di selector (e solo in parte di smanettone).
L’esca che prelude all’album è usuale e obbligatoria
nel music system contemporaneo, e spesso non ci
rendiamo conto che il botto sulla lunga distanza ha
già dei prodromi eccellenti. Oggi ci capita di avere
sottomano un EP che potrebbe segnare molte strade nel mondo del ritmo. Il brivido di avere qualcosa
che pulsa e che a breve scoppierà è da pelle d’oca.
Il nome su cui la Ninja Tune ha puntato gli occhi è
Joe Corrales Jr., in arte Yppah, una cosa che se la
cercate nei blog specializzati è un passaparola continuo. Le solite voci di next big thing (anche se il ragazzo non è all’esordio), annunci di LP, concerti, etc.
Ma a noi sta a cuore quello che si sente dalle casse.
E allora che dire di queste quattro tracce + remix?
La citazione di Shadow non sta solo a mo’ di intro:
Yppah rifà oggi ...Endtroducing senza street-hop:
si respira quindi aria di mesh che insiste sul looping
sconfinando in nessun mondo e in tutti, dal rock
semiacustico wave (Gumball Machine Weekend) alle
atmosfere minimalist-IDM dei Fields (Shutter Speed),
dalla visionarietà blues à la Belbury Poly (They Know
What Ghost Know) all’acidità chitarristica che insinua
lo shoegaze dei Jesus and Mary Chain (The Drag).
Un mondo fatto di echi e melanconie che riporta
tutto alla base rock (in particolare all’icona Doors)
sporcando con il giusto tocco di glitch. Adatto insomma per qualsiasi orecchio post-00. L’anima oldschool della Ninja rigenera in questi 20 minuti il
gusto 70 per l’atmosfera che seleziona strumenti
inconsueti (flauto e organetti) e che ci fa sognare,
dazed and confused. Se fosse un po’ più lungo sarebbe disco dell’anno. Per ora è ‘solo’ un colpo al
cuore.
(7.1/10)
Marco Braggion
Zerouno.2 - Self Titled (Discipline
Venus, Gen 2009)
G enere : rock , electro pop , songwriting
“I pensieri affollano la mente quando non hai niente
da dire”.
Dopo quattro anni fa ritorno il collettivo Zerouno.2, voluto da Simone Cattaneo, nelle cui fila troviamo LeLe Battista, voce e chitarra acustica,
Luca Urbani (Soerba) voce e synth, Cattaneo al
synth, e poi Pedro Fiamingo, chitarra elettrica, Matteo Agosti, chitarra elettrica, Marco Ferrara, basso,
Stefano Floriello, batteria. Quindi pezzi assortiti di
band quali Bluvertigo, Soerba e La Sintesi.
Un progetto fluido Battista/Urbani che partendo in
origine dai synth, ora approda in atmosfere decisamente wave e pop rock, con richiami psichedelici
(di marca floydiana) e prettamente cinematico-lirici.
Una canzone d’autore raffinata la loro, frutto degli
stili ed energie di ognuno, per uno marchio riconoscibile che fa dei testi di buona scrittura e mai banali, della musicalità decisa, degli arrangiamenti curati e
di una produzione attenta i suoi punti di forza. Non
manca comunque la matrice elettronica ben dosata
e in equilibrio con il resto. Né una levità e dell’ironia
in sottotesto.
Un album intelligente e niente affatto prescindibile
quindi.
(7.1/10)
Teresa Greco
recensioni /
95
il dvd
il libro
AA. VV. - Colorfield Variation (12k/Line, Feb 2009)
Quello che accade In Colorfield Variation è il nascere di un intenso ed intimo
rapporto tra artista e opera quella narrata in audio e video,da una schiera di diciotto sound-artist chiamati da Richard Chartier e Taylor Deupree (Line/12k) a dibattere
in elettroacustica minimale sull’omonimo movimento pittorico Color Field nato tra
1940-1950 a New York (Mark Rothko, Kenneth Noland, Bernett Newman per citarne alcuni), ispirato all’espressionismo
astratto e al suprematismo.
Non vi è nulla di casuale in questi tredici episodi liberati dai
puri fini estetici ma fortemente affini alla plasticità, tra superfici
piatte e astrattismo in colore che Steve Roden (Dark Over Light
Earth) sperimenta in violino e harmonium intorno a punteggiature elettroacustiche, lavorate in sequenze con poche ma
intese cromie a cui appoggiare tra sfumature dalle tonalità più
calde,indagini di bordo.
Elettroacusitca che Alan Callander (CF01) ispirandosi alle campiture di Rothko compone su tela, legate da naturale scorrere
in sequenza, mentre Frank Bretschneider (Looping i-vi) lavora
trai toni più freddi con elettronica di segnale immolata tra loop
e bozzetti in ritmo e monitoraggi in scanner.
I passaggi, quelli cromatici per Stephan Mathieu (Orange Was
the Color of her dress) in fluidità sintetiche, in timbrica per Tez tra analisi in spettro da
imprimere sul silenzio, o in bianco e nero e in continuo segnale per Bas Van Koolwijk
dal visibile passaggio di scala concordato in spessore di tratto.
Liberano dalle superfici Chris Carter e Cosey Fanni Tutti in pieno astrattismo, lungometraggi in ambient devoti all’arte esposta, mentre con il capitolo Ryoichi Kurokawa e
Sawako si lavora sulla scrittura, su immacolato fondale tra pennellate istintive e gestuali
più prossime all’action painting.
In chiusura Mark Fell ed Ernest Edmonds quello più vcino alla precedente uscita Attack
on Silence tra schemi fissi bande verticali e dripping in glitch.Riuscite simbiosi e comunicativi stati dell’arte a far dialogare con il linguaggio migliore, suoni ed imaggine.
(7.3/10)
Chris Ott - Unknown Pleasures (No reply)
Era ora che qualcuno decidesse di fornire in traduzione le bellissime edizioni targate 33
1/3, appannaggio soltanto dei pochi che volessero avventurarsi nella lettura in lingua originale.
Alla No Reply, piccola ma decisa e agguerrita casa editrice, hanno fatto anche di più: non
solo hanno proposto una selezione – finora formidabile, c’è da dire – dei titoli in circolazione nel mercato anglosassone, ma vi hanno anche aggiunto dei volumi esclusivi allargando la
collana Tracks anche a dischi italiani. Sì, perché la collana originaria, e conseguentemente
questa della No Reply, è completamente dedicata alla trattazione di un
singolo album di gruppi più o meno famosi e più o meno underground,
trattati di volta in volta da un critico, un giornalista, un artista e/o un
musicista. Che si approcciano, ovviamente, alla materia col piglio distaccato del critico, ma anche con la passione fervida del fan.
Nel caso dei Joy Division la scelta è ovviamente caduta sull’unico
vero album registrato dal gruppo di Manchester, Unknown Pleasures e la lettura che ne da Chris Ott, già caporedattore di Pitchfork,
è decisamente ottima. Indagando la figura di Ian Curtis – giocoforza
centrale soprattutto in virtù del tragico evento che lo consegnò al
mito del rock – Ott si avvicina alla fase della composizione e della
registrazione di Unknown Pleasures seguendo passo passo la vertiginosa crescita stilistica del gruppo, dai primi incerti passi post-punk
all’elaborazione di una scrittura talmente personale da rappresentare una pietra miliare del
rock underground.
In un racconto appassionato ma al contempo piuttosto lucido nel contestualizzare, sia al
tempo delle gesta della band, sia negli sviluppi postumi del lascito dei mancuniani, l’epopea
JD, Ott fornisce una eccellente prova della sua conoscenza della materia: alternando cioè
la trattazione critica dei pezzi a stralci dalla vita quotidiana del quartetto, il gossip antelitteram – il ruolo giocato dalla famosa fiamma belga di Curtis negli ultimi momenti dell’esistenza del gruppo – alle testimonianze dirette dei protagonisti (le varie dichiarazioni dei tre
JD sopravvissuti, Debora Curtis, Tony Wilson).
Al centro del libro però c’è quel monolite nero che è Unknown Pleasures e le sue sessions di registrazione con Martin Hannett, i cui mix leggendari, la ricerca sui suoni, la perizia
maniacale ed avanguardistica nella cura dello studio sono pari solo alla sua follia e alla sua
dipendenza dalle droghe. È perciò un vero piacere leggere questo libro, poiché sembra realmente di entrare nello studio in compagnia di quattro giovani disadattati britannici e un
pazzo produttore drogato che hanno semplicemente fatto la storia del rock.
Sara Bracco
Stefano Pifferi
96
/ recensioni
recensioni /
97
live report
Squarepusher/Bochum Welt
17 aprile //C lub : E stragon , B ologna
Era da tanto tempo che non si vedevano tante facce
da Link tutte assieme in un locale. E non parliamo
dell’ultima sede dell’ex centro sociale ma di quella
storica di Via Fioravanti, mancata la quale il popolo
rave-tronico non ha più avuto un locale e un punto
focale.Tom, spacciatore di poliritmi con basso a tracolla stile playstation, è dunque questa grande scusa
per tornare a respirare i bei vecchi tempi andati
dove i Novanta puntavano dritti ai FUTURE (e a
velocità max).
Non sarà un Aphex Twin, per il quale tanti anni fa nel
capoluogo sono confluite quasi 8000 anime, ma un
messia di ripiego e pur sempre un messia e, giusto
per farvi i conti della serva, al botteghino si traduce
in un incasso che il 90% delle band con le chitarre si
possono scordare. È la coda lunga dei Novanta a farsi sentire e per chi se lo fosse scordato; Rave significa tirar dentro in nome di un sogno tanti ragazzi di
tribù diverse. Rasta, raver, skunks ad ampio spettro,
gente che si materializza solo in queste occasioni, il
fumato che non esce mai, l’amico dell’amico che ti
passava le cassette di Ibiza, l’ingegnere informatico,
l’Universitario che gli manca la mensa occupata del
25, sono tutti qui per la macchina che ti regala (a 18
euro) un mix istantaneo di tutte le piste che animavano il vecchio scatolone fumogeno dietro la stazione (sul quale ora c’è il bel palazzone del Comune).
Nessun adolescente. Facce note per la maggioranza
più che venticinquenni.
Quest’anno poi, magia delle magie, è il tempo di un
bel revival ‘ardkore targato 92. Come dire. Le origini.
Number Lucent EP,nel banchetto con le magliette XL colorate e ultima uscita del nostro è infatti
proprio questo: la Jenkins way di tornare a pensare
E con i classici espedienti slappati e IDM della casa.
Prima, in apertura, non dimentichiamo Bochum
98
/ recensioni
Welt aka Gianluigi DiCostanzo, famoso, per chi lo
conosce bene, per lo scavo di sonorità ’80 barra
Novanta tra tastiere d’antan e drum machine in forte odor di hip hop convertito white brit. In pratica
è come dire prequel. La saga completa dall’episodio
-1 e 0. Non a caso chiusura del set con esecuzione per nulla irriconoscibile di Warm Leatherette dei
The Normal.
Il post è in mano a Tom ed è un affare di contaminazioni sulla base tech. All’uomo, non so se lo sapete, ma piace l’applauso e un bel metal da stadio
è quello ci vuole per ottenerlo. Funziona sempre. E
con un batterista umano che umanamente ti rifà un
po’ di rullanti drum’n’bass è delirio. Delirio e noia
diciamocelo, anche perché un truzzo karaoke di riff
e luci sparate da tre schermi spacca pupille stancano dopo dieci minuti figuriamoci dopo un’ora. È
quel troppo voluto che fa Novanta, che fa vecchio
Link, WARP e Cunningham, tutta la famiglia Inglese,
soprattutto quando, oltre agli appena rinati Prodigy, le sonorità più i video citati sono esclusiva Squarepusher.
Il live continua con altri 45 minuti, questa volta di
vero brand della Casa: un’arena poliritmica fatta
di codici morse, ritmi robo bastardi e gran casino
generale. Una wrek-tronica comandata a pedale e
smanettata con il maledetto basso che, fortuna nostra, contiene l’attitudine fusion per un funk angolare ultra pompato, slappa memore di quei grandi
dello strumento citati sempre che in sala nessuno
conosce (forse Jaco Pastorius e Les Claypool).
Le luci, dicevamo, sono inumane, una sala giochi e il
piccolo Guitar Hero che c’è in ogni Tom ci fa sorridere con un inevitabile retrogusto di nostalgia che
oramai aleggia in questo incorruttibile desiderio
Tech. Edoardo Bridda
squarepusher
David Byrne
20 aprile //C lub : T eatro F il armonico , V erona
Il Teatro Filarmonico di Verona è una bomboniera
solenne e preziosa: stucchi, cristalli, ori, velluti, balconcini e loggione, roba che dopo un quarto d’ora
ti aspetti che piombino sul palco non meno che un
Otello o una Mimì. Invece, ecco sciamare in perfetto
orario la gioiosa combriccola allestita da Mr. David
Byrne per celebrare i frutti del pluriennale sodalizio
con Brian Eno. Sono in dieci, tutti biancovestiti,
batteria, percussioni, tastiera, basso, tre coristi e
tre ballerini, più il leader ovviamente con la criniera candida e l’aria allampanata da Steve Martin del
pop-rock. È un party, non ci sono storie. Condotto
con dinamismo e maestria, sfruttando con leggerezza e implacabile competenza le tensioni sonore, le
distensioni coreografiche e l’impasto fra queste. Se
volete, è l’onda lunga dello stop making sense spinta
ad alleviare gli spiriti affannati della contemporaneità.
Gli astanti assistono con entusiasmo sì ma anche
con la compostezza che conviene alla location, almeno fino a Crosseyed & Painless, quando qualcosa
s’innesca incendiando l’estatico idillio. Allora i culi
si separano dai velluti delle poltroncine e scattano
le danze nei corridoi e sotto il palco. A quel punto
di svolta sale in cattedra il vero protagonista della serata: si tratta di un solerte funzionario di sala
che, con spirito encomiabile, approfitta della relativa quiete della successiva Born Under Punches per
far rientrare gli scalmanati nei ranghi. Roba da non
credere: con puntiglio sacerdotale e cipiglio militaresco riesce a far tornare ogni culo sul velluto di
competenza. Tanto fideistico zelo mi smuove una
insospettata tenerezza, che raggiunge la commozione quando le successive Once In A Lifetime, Life
During Wartime e una clamorosa Poor Boy scatenano
la bolgia definitiva, che vivrà apoteosi col secondo
bis, una Burning Down The House eseguita dagli undici
allegri officianti rientrati sul palco con un buffo ma
dignitosissimo tutù.
Scorgo il funzionario ormai arreso alla soverchiante
forza del nemico, lo seguo mentre si dilegua avvolto
in un’incazzatura palpabile e scorbutica come uno
sciame di vespe. È una figura esilarante e patetica,
meritevole d’essere eletta a campione di chi non
recensioni /
99
david byrne
mi ami
concepisce - non per colpa sua, s’intende, ma per
incommensurabili zavorre e retaggi - la possibilità
di un’espressione artisticamente divertente e divertita. Il pezzo di commiato Everything That Happens
(Will Happen Today) si rivolge idealmente anche a
quelli come lui. Ma, meschino, non lo saprà mai.
Stefano Solventi
Mi Ami
18 aprile //C lub : I nit , R oma
Sfidando il traffico infernale di un sabato sera primaverile di Roma – e soccombendovi senza possibilità di scampo – arriviamo all’Init giusto in tempo
per assistere al concerto dei Mi Ami, headliner di
una serata a grosso voltaggio rock con i garagers
olandesi The Madd e i nostrani The Rippers e
Steelfingers a scaldare cuori ed amplificatori.
Salgono sul palco i tre Mi Ami e solo al guardarli
capisci quanto sono nerd e impossibili da catalogare. Proprio come la loro musica. Damon Palermo
alla batteria è intento a collocare un campanaccio
sopra il rullante con una tale cura che sembra che le
sorti del live si decideranno da quei pochi rintocchi;
Jacob Long sembra appena uscito da un convento
con quella sua barba da monaco e ha una espressione talmente assente che sembra capitato sul palco
100
/ recensioni
per sbaglio. Daniel Martin-McCormick, scheletrico
e stralunato, è uno sbarbatine ventenne che si presenta scalzo e timidissimo, quasi impacciato di fronte all’audience.
Appena però attacca la macchina Mi Ami – senza bisogno di soundcheck o di riscaldamento alcuno – si
capisce che non ce n’è per nessuno. Quella del trio
americano è una vera e propria macchina da guerra. Che non fa prigionieri, ovviamente. Si è lì, tutti,
completamente rapiti dal furore punk e dal tribalismo funk del trio, tanto che un Martin-McCormick
affatto timido (le prime impressioni, si sa, non sono
mai esatte) chiama a sé il pubblico, lo vuole nel sottopalco, vicino al cuore della propria musica.
Musica che, come dimostrava l’ottimo Watersports, è nera come la pece, di un nero africano,
primordiale, tribale e percussivo, tanto quanto è
bianca, sub-middle class, white trash che accatasta su
di sé i rimasugli del punk 77 e della no-wave più arty.
È urgente la musica dei Mi Ami. Urgente e bruciante.
Di una urgenza urlata e stridula che non ha pietà
per le orecchie di chi ascolta e che fa di McCormick
una silfide incastrata in un corpo da uomo, di Long
un metronomo inflessibile e di Palermo un cuore
pulsante senza soste. Non c’è pausa. Non c’è possibilità di tirare il fiato. Se su Watersports c’erano
vuoti pneumatici di matrice dub, live la sensazione è
quella di un continuo pugno in faccia. Sono giovani, i
Mi Ami, ma hanno il suono, oltre che l’età, dalla loro
parte.
Un grazie sentito ai ragazzi dell’Init per la passione
con la quale continuano a mettere su un cartellone
di estrema qualità.
Stefano Pifferi
Ktl
28 marzo //C lub : B ronson , R avenna
I commenti in sala sono sempre il massimo dalla
vita. Belli netti, grezzi e senza incertezze. Frasi buttate li come gli eroi di Carpenter. Sputate senza pietà
e con la sicumera da vecchio West nostrano che è
anche la nostra Romagna. Alle volte sono delle vere
genialate come quella che un noto affezionato degli
happening Indie mi ha rifilato tra capo e collo.“Questo è il nuovo kraut” dice Mr No e, tra il fumo tossico di Reberg e i delay di O’Malley, è la sentenza
definitiva di un processo cortissimo e deludente.
Per il noto chitarrista e il londinese Peter Rehberg, quella del Bronson è stata la classica data
“filling” e non li biasimo. Inevitabile che il cartellino
lo si timbri con un siffatto impianto. Meglio ancora:
utopico pensare un coinvolgimento e un trasporto mesmerico ai massimi livelli ad ogni sacrosanta
esibizione, come se chiedessimo loro d’evocare gli
inferi ogni volta. Dura, del resto, accontentarsi del
professionismo di base pur con la garanzia di non
scendere sotto la soglia di un metal ambientale ultra patinato per ragazzini brufolosi. Il pubblico ha
dimenticato i vent’anni da un bel pezzo e le motivazioni d’interesse, sotto gli sguardi attoniti e un po’
annoiati, s’aggirano proprio attorno a quella parola
di cui tanto si parla in questi ultimi mesi, il Kraut,
evidentissimo nell’elettronica rumorosa e spaziale
di Rehberg, e nei pulviscoli di suono dello svedese.
Dal grand guignol metal si è caduti poco lontano dal
rigor mortis secondo i teutonici. Pur senza la paura
che quei suoni provocavano e evocavano. Eppure,
ancora in parallelo, allora come ora, la penetrazione
psicologica o quel senso di mistero si fanno al di
fuori di un sound chiuso e autoreferenziale. Senza
appigli melodici. Senza presenza umana. Era il cosmo a fare paura e non la musica. Così, figuriamoci
oggi, niente panico per i due KTL. Niente studio
di frequenze alla Throbbing Gristle. Nessuno
thrilling. La loro è una catarsi Post (Rock), l’altra
faccia della medaglia. Non è forse vero che il suono Slint più dilatato andava a cadere tra Berlino e
Colonia? Il cerchio si chiude. Come pure i nostri
ragionamenti finiscono assieme a un deludente concerto di sessanta minuti. KTL sono un progetto tra
i tanti di OMalley. Per farlo funzionare non basta
l’affiatamento bensì l’esperienza e le costrizioni del
lavorare assieme continuativamente.
Edoardo Bridda
recensioni /
101
WE ARE DEMO
#36
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Bancale - Bancale EP
Trio orobico allestito nel 2006 da Luca Barachetti
(voce) e Alessandro Rossi (chitarre) cui si è aggiunto Fabrizio Colombi (già Infarto Scheisse!) ai
tamburi. Questo ep d’esordio contiene cinque pezzi
ovvero il coagulo di un biennio speso a mettere a
punto un linguaggio radicato nel blues, scarno e intenso, spampanato di cupe proiezioni post, tra percussioni che si aggirano misteriche e il ghigno noise
delle chitarre mentre la voce mormora uno spleen
melmoso attorno a temi riconducibili al Ferretti
periodo CSI e ai più affini Bachi Da Pietra.
Non mollano neanche per un attimo, ci stanno dentro con tutti e due i piedi, con la testa, stomaco
e cuore. Non cercano esorcismi né liberazioni, ma
una disanima che ti scuota e t’inchiodi. Devo dire
che ci riescono piuttosto bene.(7/10)SS
Fasti (I) - Lei si è alzata dal sordo
mormorio
C’erano una volta i Seminole da Torino, noiseband con una lunga storia alle spalle e un presente
evidentemente poco sostenibile. La loro dissoluzione ha dato vita a I Fasti, due bassi, chitarra, voce ed
elettroniche, esteticamente in scia Offlaga Disco
Pax però come allucinati in una poetica più febbrile, visionaria, rabbiosa, sia per quanto riguarda i testi
(declamati con un piglio mediano tra il Ferretti dei
bei tempi e un Freak Antoni catatonico) che le
musiche, sperse e ossessive come una wave maldigerita Warp. Hanno il torto di essere arrivati dopo, irimediabilmente dopo alla band di Collini, già abbastanza definitiva di suo. Non escludo però che possano
ritagliarsi un loro ambito peculiare, non mancandogli
competenze, vena, attitudine.
(6.8/10)SS
102
/ recensioni
Granits - Where Trees Are Shaped
Like Smiling Guillottines
Suonano bene, in qualche caso ci si scuote pure per
l’energia che riesce a trasmettere la loro musica,
tuttavia sembrano avere le idee un tantino confuse.
Nel senso che ci si ritrova a interagire con brani
che richiamano parabole emo-dark (Wine Skinned
Overdose), intermezzi wave piuttosto canonici nello
stile (Onion And Dedalus) e incursioni interlocutorie
in territori post-rock (New Style Of A Bad Insomnia).
Insomma, moltissima carne al fuoco in pochissimo
spazio, come se il disco in oggetto fosse un post-it
e non una pagina bianca. Su cui scrivere in fretta
e senza curare la grafia, sacrificando così sull’altare
dell’immediatezza un linguaggio potenzialmente elegante.(6.1/10)FZ
Inbloom - Cloud Trails
Inbloom ovvero Stefano Panza ma anche - in arte Opal, bergamasco con la fregola electro dark parecchio pronunciata. Casomai vi stuzzicasse una ricettina a base di ugge Joy Division, tremori sintetici
Depeche Mode e sguardo torvo Trent Reznor, non esitate ad avventarvi su questo Cloud
Trails, esordio covato per almeno tre anni - dacché
il progetto è in piedi - e quindi bello turgido e cupo
con le sue tredici tracce scaricabili gratuitamente
dall’official site (sotto licenza Creative Commons).
Detto che non è la mia cup of tea, non nascondo di
aver apprezzato la cura dei dettagli, così come l’intensità oserei dire fideistica o se preferite la convinzione che pervade gli “ambienti” sonori. Che sanno
concedersi strane deviazioni come quella sorta di
Rockets avariati Moroder di Conceit o gli effluvi
ambient-world come sostrato di Underskin: Awake.
(6.7/10)SS
Törst - Po(p)tential
I Törst sono un duo sulla breccia da una dozzina d’anni, da quando cioè
i salentini Paolo Marcellini e Adriano Elia decisero di allestire questo
percorso parallelo agli Exu’, band undeground in cui militavano dal
‘93. Con la nuova ragione sociale sfornano un bel po’ di titoli sperimentando sonorità disparate in un turbillon stilistico che chiama in
causa - riporto quasi testualmente - kraut, psych e minimalismo passando per l’immancabile post, il kraut e l’ambient.
Con Po(p)tential, album numero nove, tentano un approccio più accessibile, una sorta di folktronica terrigna, discreta, sì carezzevole però
abbastanza schiva per non dire austera, frutto poco appariscente che
sotto la scorza nasconde polpa succosa, maturata nei tempi e nei modi
che dicevamo, capace di risolvere complessità che avvertiamo in filigrana. Un gradevole piccolo mistero difficilmente inquadrabile, miraggio desertico tra caligini mediterranee, ugge metropolitane e
fragranze bucoliche, sostenute dalla calma dei forti o dei disillusi non saprei ben dire. In ogni caso,
molto bravi. (7.2/10)SS
Lowave - Warpage
Quattro pratesi meno che trentenni alle prese con
una wave scossa da tremori electro e percorsa
da brume autoriali, ciò che li pone più o meno al
centro di una quadratura Notwist, Placebo, gli
U2 nel guado tra War e Pop e un pizzico di quel
Paolo Benvegnù che non a caso li ha aiutati a
confezionare questo Warpage. Sette tracce dal
tiro spigliato ed essenziale, forse fin troppo pulito,
fidando più sulle soluzioni soniche (i sampler, i loop,
l’action painting digitale) che non sulla passionalità
per condire le melodie. Il che va bene, scelta stilistica indiscutibile, però temo che per scuotere il
pachiderma occorra pungolarlo più in profondità.
Dateci dentro!(6.7/10)SS
Retrolover - E.P.
Creature ambigue e affascinanti questi Retrolover. Li
incontri sulle note di Ade e ti viene da paragonarli a
dei Nirvana punk-rock, solo un pizzico più melodici; ci fai due chiacchiere con Lo stesso e ti vengono
in mente dei Verdena con una spiccata vena pop;
li ascolti in Siberia e vedi in loro degli Afterhours
traviati dal rumorismo dei Marlene Kuntz. Le
costanti rimangono le chitarre elettriche – grasse
e rumorose – e testi essenziali ma efficaci, per un
suono pulito e a buon punto di maturazione. Anche
se l’impressione è che ancora non si viaggi a pieno regime, soprattutto nei brani meno “d’assalto”.
(6.5/10)FZ
Stephane TV - Self Titled EP
Quintetto pavese in azione da inizio 2008, gli Stephane TV ci sottopongono il frutto del loro elucubrare con un EP d’esordio omonimo all’insegna del
pop-rock cosiddetto “indie”, cantato in inglese, le
chitarre che s’intrecciano con tensione accorta e
indolenzita, le melodie pervase di inafferrabili retaggi dEUS, Tears For Fears, Pastels, David
Sylvian, Prefab Sprout e poi avanti verso le
apprensioni di Editors e certi struggimenti Manic Street Preachers. Impressiona la matura
compostezza dell’insieme, da cui non ci possiamo
attendere che sviluppi interessanti. (6.9/10)SS
Two Left Shoes - Two Left Shoes EP
Leggiamo sulla biografia del gruppo che tutto è
iniziato “coverizzando” Strokes, Dirty Pretty
Things, Pixies e Artic Monkeys. Ora dalle
cover si è passati ai brani originali ma le cose non
sono cambiate poi di molto, se è vero che con i
quattro episodi in scaletta si frequentano, grossomodo, sempre le stesse compagnie. Con fare fin
troppo rispettoso, verrebbe da dire, visto il ritmo
perennemente in levare, le chitarre ripetitive e un
cantato che rimanda ad articoli pregiati soprattutto
del campionario della band di Julian Casablancas. Un
minimo di originalità in più non avrebbe guastato,
questo è certo, considerata anche una scrittura che
nonostante i rimandi evidenti, pare comunque possedere una propria ragion d’essere.(6.5/10)FZ
recensioni /
103
the monks
il tempo dei monaci
- Gaspare Caliri
104
/ Rearview Mirror
Ormai non sono più così sconosciuti; il loro straordinario disco è già stato sdoganato,
recuperato, riascoltato da molti. Ripercorriamo tutta quella vicenda aperta e chiusa
in un paio d’anni, che c’è chi dice sia stata profondamente influente. Il tempo dei
monaci.
U na
storia da raccontare
“Read on! It’s monk time - it’s hop time. Don’t read
this.We said: don’t read this.” (dalle note di copertina
di Black Monk Time)
La storia è di quelle che si sentono una volta e
poi si corre dagli amici a diffonderla. Gustosa, ma attenti; può classificarvi come dei fissati, non proprio
dei nerd, ma dei cultori dello stesso aneddoto. In
effetti gli elementi ci sono tutti per farvi pervenire a
questo stato dal punto di vista dei vostri ascoltatori.
E però oggi il caso vuole che una concomitanza di
ristampe ci faccia finalmente riprendere quella storia e ri-diffonderla.
Non che sia una fragile tradizione orale da mettere per iscritto, anzi; ha fatto la sua comparsa in
un libro arcinoto, il libro più famoso sul krautrock.
Ovviamente si tratta di Krautrocksampler di
Julian Cope, quella breccia, uscita a metà dei Novanta, che con entusiasmo intaccabile ha rimesso
in circolazione un giro di nomi che arrivando dalla
Germania già si sentivano nominare in Inghilterra
tra fine Sessanta e inizio Settanta. Un libro da infervorato appunto ma soprattutto una guida personale,
come l’autore tiene a sottolineare a più riprese; ciononostante non scevra di alcuni spunti interessanti
da un punto di vista più ampio rispetto a quello musicale; diremmo culturale; ed è qui che – nel discorso introduttivo alla nascita del krautrock – trova
posto la vicenda di The Monks. Parliamo dunque
di un primo importante tassello, che riguarda l’importanza, quando si parla di krautrock, di sviscerare
la relazione tra rock tedesco e rock anglosassone.
Uno di quegli elementi sociali che Cope mette a
fuoco è appunto quanto la Germania dell’Ovest di
metà Sessanta fosse vittima dell’impero, e quanto ne
fosse lontana provincia disposta a subire l’imprinting. Il rock era arrivato ai tedeschi d’Occidente e
ne aveva irrimediabilmente colpito i giovani. Eppure
quella cosa da far strapazzare i corpi era già virata
in un ambiente che oggi chiameremmo senza misure mainstream. Era musica commerciale che seguiva
l’andamento delle vendite, punto. In quel contesto
cercarono forse inizialmente di inserirsi cinque
ragazzi americani di stanza a Francoforte, cioè in
trasferta forzata in Germania in quanto GI – cioè
militari di fanteria, soldati semplici - a copertura di
uno dei baluardi dell’Occidente verso la DDR e il
mondo sovietico.
I loro nomi sono Gary Burger, Larry Clark, Dave
Day, Roger Johnston e Eddie Shaw. Iniziano a suonare insieme – tutti tranne Roger, che si aggregherà un paio di anni dopo, già nel 1962. Nel 1964 la
formazione è fatta; il nome che si scelgono è The
Five Torquays, poi semplificato in The Torquays. Gary, oltre a suonare la chitarra, è la voce
principale, ma ai cori partecipano tutti; Larry si dedica all’organo; Dave, Roger ed Eddie si occupano
invece, come si confà a un gruppo tradizionalmente
rock and roll, della sezione ritmica, rispettivamente
chitarra ritmica, batteria e basso. I cinque iniziano
a suonare nei club di mezza Germania (non è un
modo di dire, come potete immaginare), da Heidelberg a Berlino, e si prestano alla tendenza di cui sopra; cercano di riprodurre gli standard che in quegli
Rearview Mirror /
105
anni gli ambienti anglosassoni propongono; fanno
cover di Chuck Berry, scimmiottano la surf del paese d’origine e seguono naturalmente gli esiti di quella che oggi (dopo la Seconda, forse anche la Terza, la
Quarta, chissà) chiamiamo la First British Invasion.
Insomma partecipano a quella funzione ideologica,
stando al post-strutturalismo delle scienze sociali,
che la musica giovanile stava acquisendo nella Germania legata alla NATO. Eppure basta un anno e
poco più perché si crei quello scarto che oggi ci
invita a parlarne. I cinque giovani americani si stufano presto di seguire le mode del rock a loro coevo di altre parti nel mondo; cosa che li fa arrivare
all’attenzione di quegli altri giovani musicisti in erba
che in quelle lande stanno studiando composizione
con Stockhausen; coloro che in quegli anni ancora
considerano i generi sbarbini della musica popolare
anglosassone come un gioco da classifica o poco
più; i futuri krautrocker, insomma.
T empi
monastici
Di fatto i Monks alla fine del ‘65 scoprono di
voler sperimentare un poco, con la propria musica,
con lo spasso di suonare, con la propria immagine,
con gli automatismi del rock, e con la provocazione
di testi e argomenti anti-militareschi. Anziché scegliere uno stile o un altro tra quelli che si davano
il cambio in America o Inghilterra, iniziano a miscelarli tutti; anziché selezionare un registro o un altro
– quello “militante” o quello comico, quello pop o
quello grottesco - danno vita a un calderone; atteggiamento per Cope non così lontano dal krautrock
prossimo venturo. Alla fine dell’esperienza Torquays
iniziano a registrare quel fantastico e incomprensibile (senza argomentazioni contestuali) capitolo
che è stato Black Monk Time. Cambiano il loro
nome in “Monaci” e per sottolineare l’estetica pro-
106
/ Rearview Mirror
vocatoria – ma anzitutto caciarona – si fanno rasare
la sommità del capo; si fanno la chierica, come il loro
nuovo statuto immaginifico impone. Ma soprattutto immolano tutta la propria musica al sacro fuoco
della percussività. Se devono salvare una cosa del
rock’n’roll, quella si chiama beat, non di certo melodia. “Bam, bam, bam. Over-beat”, come sottolinea
con un guizzo di espressività quasi-verbale Eddie, il
bassista, le cui quattro corde diventano settimana
dopo settimana sempre più una massa critica amplificata al limite. La chitarra ritmica di Dave diventa
un banjo suonato esclusivamente dandoci di pennate, come un tamburo armonico. Roger elimina quasi
del tutto i piatti dal proprio strumento e si dedica
esclusivamente all’ipnosi folle dei tamburi.
Non solo: è forse la “prima” chitarra di Gary
a subire lo stravolgimento più interessante, se valutato con la profondità del tempo. Accade infatti
che, dopo un anno di tentativi per trovare il timbro giusto, un giorno il nostro abbandona le prove
per fare pipì e si dimentica amplificatore e volumi
al massimo. Il frastuono che ne risulta sorprende gli
altri Monaci, che lo trovano strabiliante e iniziano a
suonarci sopra. Una piccola invenzione del feedback
come migliaia di altre volte sarà capitata. Un aneddoto che permette a Gary di usare il rumore della
sua chitarra come parte del tribalismo rock’n’roll
che permeerà Black Monk Time, - che esce nel
1966 per la Polydor - dall’iniziale Monk Time alla finale That’s My Girl, passando per la citatissima Complication, con quel suo testo anti-militarista, urlato
nelle balere tedesche a gente che non capiva una
parola di quello che gli veniva blaterato addosso.
Ciò a cui spesso poi non si fa riferimento rispetto
ai Monks è proprio quel lavoro di ricerca, condotto
soprattutto in studio; un’attenzione recuperata solo
negli ultimi anni, specialmente grazie a due raccol-
te/ristampe: Demo Tapes 1965, uscita
a inizio 2007 per la Munster Records, e
Early Years, appena pubblicata dalla solita Light In The Attic - responsabile anche
di una agognata (vedremo perché) riedizione di Black Monk Time, in doppio
vinile a 180 grammi. Raccolte dove si sente maggiormente il filtro della produzione
soprattutto rispetto all’unico album dei
Monks, dove l’impatto vitale del combo
si accompagna a una resa quasi mono, per
virulenza e fedeltà dell’effetto live; cosa
che sarebbe stata impossibile, sottolinea
ancore Cope, se questo disco fosse finito
nelle mani di un’azienda musicale britannica.
Immaginatevi dunque cinque ragazzi
maturi vestiti da monaci e con la chierica
in testa fare a gara di ritmo tra di loro.
Ma non fatevi ingannare dalle parole scritte sopra. Lo sperimentalismo dichiarato
ed esplicitato in maniera intellettualistica è assente. Ciò che funziona di Black
Monk Time è il fatto che questa musica
è comunque r’n’r. I cori sono orecchiabili
e “mongoloidi”, il piglio è sempre ballabile. Le canzoni sono canzoni, il cantante
scimmiotta ancora gli shouter. E però il
tutto è un marasma tribale eppure evoluto, un ritmo corale; e tutto viene fatto con un senso del paradosso di suonare musica
aliena per un popolo alieno. Il disco non vende e
inaugura commercialmente una vicenda che non ha
mai permesso a questi cinque pazzi di fare dei soldi.
Ne seguono appena due singoli, in totale quattro ulteriori canzoni che già segnano un allontanamento
dall’aspetto sanguigno dell’album. E poi lo scioglimento del gruppo, per trent’anni.
Il resto della storia ci parla di una reunion, a fine
Novanta, dove come spesso accade i figlioli prodighi
tornano a casa; una tournèe negli Stati Uniti, dunque, compreso un documentato concerto a New
York a cui Gary arriva con la bronchite, con evidenti
problemi vocali conseguenti. Ci parla anche dell’ennesima sfortuna commerciale legata alla prima riedizione di Black Monk Time in CD, avvenuta nel
1994 per iniziativa della Repertoire Records; operazione dichiarata illegale dalla Polydor – detentrice
dei diritti di produzione – e mai riconosciuta dai
cinque ex-giovani e ormai attempati rocker americo-germanici. Pare addirittura che la cosa sia stata
possibile grazie al furto provvisorio di un master da
parte un funzionario della Polydor, che poi ha rimesso tutto a posto, senza farsi accorgere. Oggi le cose
paiono cambiate, se è vero che i Monks segnalano
come una liberazione la ristampa della Light In The
Attic di cui sopra.
Concluderemmo la vicenda condendo ancor
più l’influenza che la band può aver avuto sopra i
rocker di mezzo mondo, e soprattutto segnalando
una linea di lettura che imparenti in qualche modo
il loro sound con quei Nuggets a metà Sessanta ancora misconosciuti, e che fecero il botto quando il
krautrock era esploso e già abbondantemente masticato. Ma la mossa migliore è chiudere con l’immagine dei cinque Monks che urlano in un falsetto
surreale in una bettola di Francoforte. Cosa urlano?
“It’s monk time!”
Rearview Mirror /
107
Ristampe
Ensemble Pittoresque - For This Is
Past (Clogsontronics, Lug 2008)
G enere : post - punk / minimal - electro / synthpop
Il mondo di Ensemble Pitoresque era quello
del post-punk più oscuro, delle macchine e del diy
elettronico. I nomi sono quelli aurorali della scena.
Uno su tutti i Cabaret Voltaire, quelli tra 78 e
82. Ma anche quelle atmosfere mitteleuropee che
spopolarono a un certo punto in ambiente britannico. Il fatto è che però gli Ensemble Pitoresque erano olandesi, e quindi non
dovevano troppo vagare
per ritrovare i sapori
dell’Europa Centrale e
portarli nel post-punk.
Better Life’s, la prima traccia di For This Is Past
- esordio del combo datato 1983 -, è infatti un
incrocio pressoché da manuale tra The Normal
di Warm Leatherette e gli Ultravoxdi Vienna– a loro volta ibridati con i Kraftwerk, ovviamente. L’album è stato da poco ristampato dalla rinata
Clogontronics, etichetta olandese gestita dagli stessi
Ensemble che li produsse venticinque anni fa e oggi
ne ripromuove le vene, a dir loro, minimal-electro,
forse meglio definibile come proto-synth-pop, anche
a fronte di Artificials, un electro-pop ante-litteram,
con tanto di incastri tra drum-machine ed elettronica giocattolo e para-sci-fi.
I toni sono cupi, dunque, ma con una scrittura non
banalizzata. E se generalmente il viaggio del postpunk verso le terre germaniche passava generalmente dall’Inghilterra, qui una cosa interessante è la
ripresa più alla lettera dei Kraftwerk, messi a distanza solo dalle drum-machine (indice chiaro dei tempi), ma neanche troppo. Ralf & Florian sono regnanti
sovrani in O.B.W.T., in Maitre Satori, e in molti altri
brani. Non male neanche la narrativa industriale di
Building Brains, quasi IDM, per certi attimi, e forte
dell’intuizione di una frase-refrain-tema ripetuto (e
“concreto”) che accumula tensione nella sua ripeti108
/ Rearview Mirror
tività. Gioco ripetuto nella successiva Lovesong, brano per cui ce la sentiamo di citare Klaus Nomi, perché denota un fenomeno evidente, che va sempre
messo in rilievo: l’ironia. Del resto si deve andare
quasi all’analisi testuale, per giudicare queste uscite;
il resto è un retroterra abbastanza scontato, storicizzato, su cui giudicare è automatico, e soprattutto
rischia di essere vincolati ai gusti di ognuno. Detto
questo, gli Ensemble Pitoresque li consiglieremmo
senza meno da ambedue i punti di vista.
(7.1/10)
Gaspare Caliri
Fred Fisher Atalobhor - African
Carnival (Vampisoul, Mag 2009)
G enere : afrofunk
Gli anni Settanta furono un periodo musicalmente
assai eccitante per la Nigeria, tra gli stati africani il
più vicino agli Stati Uniti da poterne approfittare,
sviluppando una personalissima reinterpretazione
di soul e funk. Torna sull’argomento la Vampisoul
dedicando un doppio cd a Fred Fisher Atalobhor,
trombonista, cantante e compositore nato nel ‘51 e
attualmente attivo come sessionman. La sua reputazione, che procacciò addirittura un contratto con la
EMI, è soprattutto dovuta all’asolo rock, miscuglio di
funk e afrobeat benissimo esemplificato sul primo
dischetto dai cinque brani di Say The Truth, 33 giri
edito nel 1979 dalla Afrodisia. Meraviglioso nel suo
snodarsi fluviale e dilatato tra l’omonimo, luminoso
“quasi rocksteady” e una Iye-Ye-Mu/Elediamemisise
d’ineffabili storture; fenomenale nell’intricata selva
di chitarre, ritmico rimbombare e fiati possenti AsaSa (madre di Talking Heads e Peter Gabriel) e
l’urban-funk clintonianamente sardonico Open The
Door.
Lo chiudeva la disco stranita di Let Love Free e sarà
la pista da ballo, due anni dopo, a catturare il Nostro
e relativa Ogiza Dance Band per No Way, album
in toto danzabile senza tuttavia stupire. Che, va da
sé, finisce per influenzare il giudizio complessivo su
African Carnival, così come la scarsa resa sonora di
un pugno di tracce tratte da Wahala Dey For Town,
opera più solare che nell’88 segnava un certo riscatto (edita - con l’altrettanto discreto Ogiza del ’90
qui incluso - dai tipi EMI): crepitii di fondo esclusi,
esse sono fastidiosamente “fuori giri” e non si può
non tenerne conto. Spiace molto perché indice di
poca cura, elemento che nell’ambito delle ristampe
rappresenta parte consistente del piacere. Auguriamoci che si tratti di svista momentanea, poiché alla
salute della label ispanica ci teniamo, eccome.
(7/10)
Giancarlo Turra
Fridge - Early Output 1996-1998
(Domino, Apr 2009)
G enere : post - rock
Per una volta non si può dire, alla notizia di una
nuova uscita di Kieran Hebden, “ma quante ne fa?”,
perché Early Output è una raccolta di brani registrati da Hebden nel triennio ’96-’98 insieme ai
Fridge, sua vecchia formazione post-rock; chiaro
che dei Fridge qui ci siano gli aspetti più acerbi, ma
anche i dilemmi delle cose che sono venute appena dopo. Eppure diciamo subito che, primo, almeno
nella prima metà del disco, l’ascolto procede con
buona tenuta; e che, secondo, la misura e il peso
con cui prendere questa
raccolta è forse di eserciziario, quale in fondo era,
questo progetto dell’uomo “nella sua stanza con
laptop”.
Ci sono brani di Ceefax
e Semaphore e quindi
c’è l’aura degli zii d’oltreoceano, di quei Tortoise che basterebbe citare per
abbracciare gran parte di queste numerose tracce.
Come certamente si riconoscono perfettamente anche altri tributi dei primi output dei Fridge,
partendo per esempio dai Mogwai in Helicopter,
giusto per citare il pilota automatico forse più fastidioso; l’inciso che va di seguito è che nella mente
dei Fridge non transitava l’associazione necessaria
Mogwai-forte/piano; e quindi i Mogwai da loro rivisitati sono quelli più tenui, meno adolescenziali,
quelli delle tracce meno rimaste note dei primi dischi, Young Team su tutti, ovviamente (Concert In
Your House).
L’ascolto si fa innegabilmente più interessante con la
ripresa senza imitazione pedissequa di alcune tecniche dei June Of 44 di Four Great Points (Lojen
e Anglepoised), allora ancora a venire, peraltro; come
degli Ulan Bator della prima maturità. Ciò detto,
il resto è appannaggio dei Tortoise delle tracce conclusive di Millions Now Living… - anche qui con
una menzione in merito, cioè il modo in cuiAstrozero
va in un crescendo finale abbastanza inedito, rispetto ai chicagoiani. Come in Distanceci convince, pur
nella struttura classicamente tortoisiana, il break
che ci racconta di quegli anni a Canterbury…
Esercizi, prove, appunti; fuori il dente che non fa
male e così dopo ci sarà posto per For Tet. Non è
andata poi male.
(6.9/10)
Gaspare Caliri
Lenny Kravitz - Let Love Rule (Virgin, Apr 2009)
G enere : rock
L’ultima, gustosissima, imprescindibile notizia riguardo al buon Lenny narra della lettera speditagli da
Sarkò e Carlà, nella quale - dopo essersi dichiarati
suoi devoti fans - richiedono i di lui servigi quale
producer per il futuro
album della cantautrice
presidenziale. Roba da
Kravitz. Un’apoteosi glamour edificata a suon di
pose ultrapatinate, dio
tronista cui le più conturbanti muse e ninfette
dello shobiz si concedono obbedendo ad un rituale di sacrificio e appartenenza, rutilante pruderie che relega il cimento artistico (un tempo) principale del buon Lenny - tra le
altre cose rock star - a mero sottofondo da servizio
televisivo marchettaro.
Pensare che, un ventennio esatto è trascorso, il suo
album d’esordio fece sobbalzare più di un recensore sulla poltroncina dei sudati ascolti, aggrappandosi
al treno in corsa (senza macchinista) del rock-soul
asperso di psichedelia. Correva il settembre dell’89:
le tredici tracce di Let Love Rule furono una
scossa elettrica e ormonale, acida e romantica. Un
ricettacolo di singoli effettivi e potenziali (ne furono
estratti cinque ma avrebbero potuto essere il doppio): dal torrido struggimento di My Precious Love
alla morbida fricchettoneria errebì di Does Anybody
Out There Even Care, dal vago lennonismo di Be al
funk rutilante di Mr. Cab Driver fino ad una title track
che interseca e impasta psichedelia sognante e black
impetuosa. Di quella specie di prodigio che sembrò
Rearview Mirror /
109
prefigurare nuove eccitanti possibilità di sintesi tra
passato e presente, tra bianco e nero, tra rock e
popular, la santa alleanza Virgin/Emi ci propone oggi
una deluxe edition sontuosa, corroborata da diciotto tracce di cui quindici totalmente inedite.
Detto che il secondo dischetto contiene pezzi live
dell’epoca (tra cui spiccano una fluviale Fear e una
incendiaria cover di If 6 Was 9 del buon Jimi Hendrix), gli affezionati al verbo kravitziano potranno altresì bearsi dei bonus in calce al programma
originale, ovvero i consueti lati b dei singoli più i
demo caserecci di Mr. Cab Driver, Fear e Let Love
Rule, quest’ultima presente anche in un missaggio
più ruspante. Quanto ai comuni mortali, casomai
avessero da colmare la lacuna un pensierino lo facciano senz’altro. Per quanto mi riguarda, considero
oggi questo disco meno cruciale di quanto ebbe a
sembrarmi (troppi) anni fa, pur restando lavoro godibilissimo, turgido e lancinante come può sfornare
soltanto chi spreme meningi, cuore e coglioni per
fare la cosa al meglio anzi al massimo.
Peccato che poi Lenny - il bel Lenny - abbia smarrito
l’estro e l’immediatezza tra i molti festini, gli innumerevoli book fotografici e le mai troppe schermaglie
amorose, posterizzandosi in un’epifania di se stesso di cui la musica è un alone accessorio, sempreché s’intoni con la più recente mise. Ovvero: Lenny,
geneticamente predisposto per fare la rock star, si
pose fin da subito quale obiettivo la massimizzazione del successo. In ciò non v’è nulla di male. Anzi:
finché utilizzò il rock come ariete per sbaragliare
la piazza, ci regalò bei momenti, guadagnandosi ogni
stilla di rispetto e ammirazione. Col tempo però le
cose sono cambiate. Al punto che oggi sembra fare
dischi per giustificare a se stesso e al mondo quel
che si dice che egli sia: una rock star, appunto. Tra le
altre - ben più goderecce - cose.
(7/10)
Stefano Solventi
Mike Sammes Singers (The) - Hymns
A\’ Swinging (Trunk Records, Mag
2009)
G enere : exotica
Meglio elencare i fatti prima che pensiate a una
burla: Hymns A’ Swinging si compone di dodici inni
sacri cantati dai Mike Sammes Singers col supporto strumentale del Ted Taylor Organsound
e negli ultimi vent’anni pare essere diventato un
solido - ahem - “culto” oltremanica. Stanco di bootleg e di veder gli originali su Davjon passare di
110
/ Rearview Mirror
mano a decine di sterline, Jonny Trunk alias Jonathan Benton-Hughes s’è deciso a ristampare il disco in cd dopo averlo reso disponibile in
download. Capire cosa passi per la testa del Nostro
non è impresa semplice e men che meno in questa
circostanza: il problema è che sin qui si aveva proceduto al recupero di “musiche strane” senza cadere
in un’autoreferenzialità priva di progetto. È la prima
volta che rimani perplesso invece di sorridere, che
noti l’assenza di un valore aggiunto - uno qualsiasi
- capace di investire la mera stranezza di significati
extramusicali.
Perché l’idea di fondo (rileggere in chiave easy beat
brani ascoltati in qualsiasi funzione domenicale britannica) non regge lungo quaranta minuti; reiterata,
perde mordente e viene a noia. Lo confermano i brani più convincenti e che
si sforzano di infondere
vita tra le copie dell’iniziale Harvest Home: For
All The Saints vira in lieve
jazz un gioioso gospel
bianco; Glorious Things Of
Thee Are Spoken trasfigura Haydn con un groove
orientaleggiante; He Who Would Valient Be e Immortal
Invisible God Only Wise svoltano verso un’impronta
errebì e qualche spigolo (soprattutto la seconda)
grazie all’inserimento del sax di Tubby Hayes.
Se al posto del sottoscritto ci fosse il simpsoniano
Ned Flanders, Hymns A’ Swinging sarebbe la ristampa del mese. Così non è, ma suppongo che per
farla franca col mio (poco più di) sei politico, tre
“Ave Maria” basteranno.
(6.3/10)
highlight
Funkadelic - Toys (Westbound, Dic 2008)
G enere : funkadelia
Deve essere ben radicato il culto nei confronti di George Clinton
se, dopo le riedizioni del suo foltissimo catalogo, tuttora si cerca una
qualche rivelazione. Sarà perché la fame di musica che stimoli cervello
e fianchi è viva più che mai e oggi non sai quasi dove rivolgerti? Tocca
per lo più scavare nel passato e questo fa difatti Toys ripescando session del periodo ‘71-’72, quando cioè Funkadelic erano stilisticamente
ben distinti dai Parliament. Nel corso del decennio le due anime
si sarebbero pian piano fuse, nondimeno qui il suono si racconta peculiare fratello di Sly e Jimi, decolla da fondali urbani verso lo spazio profondo, sposa impeto
e raffinatezza. Nel magma sonoro risalta in particolare il ruolo di Bernie Worrell, evidente
nell’organo grasso di The Goose That Laid The Golden Egg e nella fluviale Slide On In, ma soprattutto
in Magnififunk, incrocio stordente tra suggestioni classiche, ribollire alla Booker T. e sottigliezze
degne di Herbie Hancock. Sul puntuale e secco rintoccare della ritmica, l’altro asso Eddie
Hazel è poco più che ventenne ma scaglia la sei corde oltre il sistema solare con fare da veterano.
Non manca insomma nulla di quanto fece immensa la funkadelia: senso per le radici e la loro
contemporanea trasfigurazione (Talk About Jesus un finto gospel in sardonico zoppicare jazz…);
strutture intricate che si sviluppano con naturalezza da lasciare allibiti (Vampy Funky Bernie: i Meters catapultati dentro Tago Mago; Heart Trouble: un anticipo di Remain In Light); abilità nel flettere
i muscoli senza forzature, lasciando la musica libera di sgorgare e impossessarsi dell’esecutore
come per il Miles Davis in versione elettrica e i Can (un’ineffabile, atemporale Stink Finger; la
“karaoke version” di Wars Of Armageddon). Ciliegina sulla torta - dal gusto misto di cioccolato e
acido lisergico - un video girato nei primi ’70, che ritrae i Nostri un po’ Magic Band a martedì
grasso e un po’ psicotici in libera uscita. I fan gradiranno assai lo scavo negli archivi che, a questo
punto, supponiamo definitivamente prosciugati; tutti gli altri si procurino prima una copia di Cosmic Slop.Vedranno, costoro, che culo e mente gli si libereranno in un battibaleno.
(7.3/10)
Giancarlo Turra
Giancarlo Turra
Victor Olaiya - All Stars Soul International (Vampisoul, Mag 2009)
G enere : highlife
“Pensavano che avessi tolto la Highlife dall’ordinarietà: credevano che il mio modo di suonare fosse un po’
fuori dagli schemi, ecco perché mi chiamarono il Genio
Cattivo della Highlife.” Così parlò Victor Olaiya, oggi
settantasettenne e ancora nome poco noto a noi
europei causa la scarsa circolazione di reperti discografici, nondimeno considerato nel paese natio
un Dio o quasi lungo gli anni ’50 e i primi ’60. Ne fa
fede un curriculum chilometrico che, riassumendo,
lo vede a sedici anni agli angoli delle strade di Legos
con la cornetta a capo di un nutrito ensemble per
passare poco dopo nelle migliori formazioni highlife; infine fondarne una propria, i colà gloriosi Cool
Cats, nella quale passarono fior di musicisti e tra
costoro Tony Allen, Sunny Ade, Fela Kuti.
Gli All Stars furono il passo immediatamente successivo allorché - tra 1967 e 1970 - lo juju sostituiva la
musica da ballo sullo sfondo della guerra del Biafra.
Tragedia cui il Nostro rispondeva con gli All Stars
Soul International e - sull’onda di una sessantottesca visita in Nigeria di James Brown - se ne
usciva alla fine del conflitto di cui sopra con questo
ellepi. Evidente modello omaggiato in una brevissima Mother Popcorn e in una Cold Sweat personale
quanto basta, “Mr. Dynamite” è altrove parafrasato
seguendo il gusto locale, ovvero schiacciando il pe-
dale di fissità ritmica e ottoni selvatici (Let Yourself
Go, I Feel Alright); swingando tra chitarre serpentine
e vivacità percussiva (Okere Gwonko, Soro Jeje Fun
Arogbo); proponendo un sensuoso crocevia tra soul
e calypso virato jazz in New Nigeria, una Everybody
Needs Love dal liquido solismo chitarristico e il funk
sardonico Magic Feet. Pur non sempre a fuoco, questa mezz’ora resta gustosissimo e intrigante assaggio che ci ha messo una voglia matta d’approfondire
il passato remoto di Mr. Olayia.
(7.2/10)
Giancarlo Turra
Rearview Mirror /
111
(GI)Ant Steps #27
classic album rev
Thelonious Monk
Fairport Convention
Alone in San Francisco (Riverside, Ott 1959)
Liege And Lief (Island, Nov 1969)
Cosa fa di Thelonious Monk Thelonious Monk? Le
partiture ambigue a metà strada tra melodia e stridore; uno stile rigido e compartimentato; una creatività che non teme la sindrome del pentagramma e
confeziona strumentali sublimi con una naturalezza
disarmante; il fascino sottile di una musica che prima di diventare esposizione corale è sussulto in solitaria, riflessività, introspezione. C’è una discografia
solista nutrita quanto necessaria a dimostrazione,
quasi a sottolineare che è nella forma più scarna
possibile che risiede davvero la poesia di Monk.
Composizione e scrittura prima che gesto tecnico,
personalità che oltrepassa l’imborghesimento istituzionale del jazz per trasformarsi in una fissità stilistica quasi immutabile e peculiare. Da Thelonious
Himself – pubblicato due anni prima di Alone
In San Francisco – in avanti il suono del pianista americano trova un baricentro fatto di distonie,
ritmiche pacate, temi immediatamente riconoscibili.
Frutto di un lavoro di cesello sulle atmosfere che
è profondamente legato all’intuizione e al fraseggio
più che al virtuosismo, a un pianismo che di lì fino
alla morte del musicista – avvenuta nel 1982 – non
cambierà quasi più.
La fine degli anni cinquanta e l’inizio dei Sessanta
rappresentano per Monk il periodo più prolifico e
fortunato della carriera, finalmente vissuto al centro
dell’attenzione del pubblico e lontano dalle invettive aspre dei critici più restii a istituzionalizzare un
sentire jazzistico così particolare. Universalmente
riconosciuto come una delle personalità artistiche
più eclatanti, grazie una proposta musicale slegata
dai canoni estetici del tempo – il be bop, l’impegno
politico, il free che verrà – e a un carattere solitario e stravagante. Una nota biografica, quest’ultima,
sintetizzata perfettamente dalla musica di Alone In
Oltre ad essere l’ultimo album registrato dalla formazione (quasi) al completo dei Fairport (il batterista Martin Lamble era morto, qualche mese prima,
in un tragico incidente stradale, sostituito da Dave
Mattacks), Liege And Lief rappresenta, per qualcuno,
la chiusura di un cerchio, per qualcun altro l’inizio
della decadenza della band più celebre del folk rock
inglese che la storia abbia generato, negli anni in cui
(verso la fine dei ’60) la musica giovanile, ormai matura, provava a riconciliarsi con le tradizioni popolari. Come ogni cosa che, improvvisamente, cambia radicalmente o quasi, una prospettiva, così l’album in
questione, nel bene e nel male, ha rappresentato uno
spartiacque, un punto su cui dividersi, tra chi, ancora, dopo il capolavoro di Unhalfbricking (pubblicato
solo pochi mesi prima) considerava i Fairport come
una sorta di versione britannica dei Jefferson Airplane e chi, invece, puntava tutto sull’aspetto folk
della band di Sandy Danny e compagni. Rispetto al
suo diretto predecessore, infatti, ricco di riferimenti
dylaniani, Liege And Lief focalizza l’attenzione sulla
tradizione britannica come mai prima. Attenzione
palesata dalla scelta di inserire nell’album ben cinque
brani (su otto, ma c’è da dire che le composizioni
originali seguono, più o meno, la stessa impostazione) arrangiati sulla base di traditional del repertorio
folclorico inglese. La ballata diviene la forma narrativa e letteraria
predominante e la straordinaria voce della Danny
(dotata di naturali cambi di registro tipici del canto di tradizione orale) insieme al violino di Dave
Swarbrick, l’elemento portante di tutta l’architettura sonora. Siamo ben lontani, comunque, dalle
112
/ Rearview Mirror
San Francisco, un sentire misurato, di poche parole ma al tempo stesso riconoscibile. Che lo si affronti partendo dallo “scherzo” di Blue Monk o dalla
raffinatezza di Ruby My Dear poco importa: l’intimismo rarefatto e meravigliosamente “altro” messo
in mostra trasforma i due brani – e lo stile che li
contraddistingue - in classici, oltre che in termine di
paragone per tutta la produzione a venire del Nostro. Come il resto del programma, che a vederlo
accadere in quel modo così goffo tra picchettate
“grossolane” e svisate – cercate un qualsiasi filmato
su You Tube e capirete –, non ti spieghi come possa
uscirne tutta quella poesia.
Eppure è così. Ce lo conferma Round Lights con il
suo blues “svirgolettato”, lo ribadisce Pannonica a
suon di scale e cambi di tono, lo sottolinea la conclusiva Reflections tra timbri variabili e malinconie
che si rincorrono. Mentre BlueHawk, con il tema
composto soltanto da quattro note, ci illustra brevemente pregi e difetti – pochi – della formula di
Monk: immediatezza e banalizzazione delle formalità, per indagare, invece, le gradazioni di colore. Nei
quarantacinque minuti del disco ci si imbatte anche
in quattro riletture che non fanno che ribadire la
statura artistica del pianista. Everything Happens To
Me è una cover di Matt Dennis che rimpolpata con
i fasti dell’improvvisazione, diventerà un evergreen
dei concerti del pianista; You Took The Words Right
Out Of My Heart è uno standard ripreso anche da
Benny Goodman; Remember di Irving Berlin è un
classico di Ella Fitzgerrald qui swingato e “espanso”;
There’s Danger in your Eyes, Cherie è un brano anni
‘20-’30 che Monk trasfigura e modernizza rendendolo quasi riconoscibile.
Fabrizio Zampighi
scelte radicali che la band compirà dopo la morte
di Sandy Danny e l’abbandono di Thompson, sbilanciandosi completamente dalla parte del folk. Anzi,
vista l’estrema vicinanza temporale con Unhalfbricking, si potrebbe addirittura ipotizzare una complementarietà tra i due album, un equilibrio a due
facce capace di metterli sullo stesso piano in quanto
prospettive diverse di una stessa filosofia musicale,
che univa la modernità degli arrangiamenti con la
tradizione popolare. In questo senso, la chitarra elettrica di Thompson
diviene un trait d’union fondamentale tra i due
mondi, sia in un brano come A Sailor’s Life, pietra miliare del lato più rock dei Fairport, sia in episodi più
espressamente folk come Matty Groves e Come All Ye.
Così come l’andamento cullante di The Deserter, la
dolce semplicità del commiato di Farewell Farewell
(dove la voce della Denny tocca uno dei suoi apici)
e il prog-folk di Tim Lin, non sfigurerebbero nell’album precedente al fianco di perle come Percy’s Song
e Genesis Hall. Certo, il Medleyl, si sbilancia eccessivamente verso la una forma modulare che è tutta
popolare, ma si tratta di un episodio isolato, che
non può da solo caratterizzare lo stile di un album
ancora attualissimo, come testimoniano le numerose riedizioni, infarcite di materiale inedito (tra cui
vanno ricordate almeno quelle del 2002 e del 2007,
contenenti materiale inedito). Un album che, in fin dei conti, rappresenta la fine di
un percorso, l’atto conclusivo di una band che, dopo
l’abbandono di Thompson e la scomparsa di Sandy
Danny, continuerà ad arrancare fino a dissolversi da
sola. Farewell, farewell..
Daniele Follero
Rearview Mirror /
113
Questione di cuore
F rancesca A rchibugi (I talia , 2009)
Una Roma d’altri tempi, quella dei ‘60 di Pierpaolo Pasolini, rivive nello scorcio del quartiere (il
Pigneto dove era ambientato Accattone) scelto
come sfondo popolare alla storia narrata in Questione di cuore, e insieme la Roma odierna della
post modernità, con tutte le contraddizioni del caso.
Tra amicizia, scontro di caratteri e famiglia, nel classico cinema di sentimenti di Francesca Archibugi.
La vicenda del film parte dalle corsie di un pronto
soccorso romano, dove i due protagonisti si ritrovano entrambi nell’emergenza di un infarto e poi nella
degenza che ne segue in terapia intensiva in ospedale. Si assiste quindi alla nascita di un’amicizia tra due
persone che più diverse non si potrebbe immaginare, e non solo per estrazione sociale: Angelo (Kim
Rossi Stuart), il carrozziere popolano circondato
dalla famiglia, e Alberto (Antonio Albanese), lo
sceneggiatore intellettuale del nord reduce da più di
una crisi (sentimentale, esistenziale, lavorativa). Un
legame il loro che supera le diversità e nella comunanza del dolore via via si costruisce e si cementa,
mentre intorno si vivono difficoltà familiari, sociali,
economiche.
L’Italia odierna resta sullo sfondo del film, ma c’è
tutta, e sempre presente nei richiami, nelle difficoltà
di lavoro, nella società anche interrazziale, mentre a
latere sono presenti gli altri personaggi, quindi l’infanzia e l’adolescenza (i due figli di Angelo), il mondo femminile popolare e non (le due mogli: l’attrice
Carla, interpretata da una misurata Francesca Inaudi, e la madre di famiglia Rossana - quest’ultima, Micaela Ramazzotti, prepotentemente al centro della
vicenda), il mondo borghese dei cosiddetti “amici”
dello sceneggiatore che è in realtà più solo che mai
(un breve cameo a inizio film del cinema che si autocita, con la presenza di Virzì, Luchetti, Sorrentino,
Verdone e Stefania Sandrelli). In un altro cameo, è
presente anche Paolo Villaggio.
E su tutto, la costruzione di una commedia a cui importa il carattere umano calato nella società del suo
tempo, mai banale quindi o stereotipata. Una commedia che ci ricorda Comencini piuttosto che
altri nomi e che la regista ha sempre praticato nel
suo cinema, sia pur con alti e bassi. La Archibugi qui
resta allora equilibrata, costruendo e sceneggiando
una storia (liberamente tratta dal romanzo quasi
omonimo Una questione di cuore di Umberto
Contarello, edito da Fetrinelli) basata essenzialmente sulle interpretazioni dei personaggi, qui resi al
114
/ La Sera della Prima
meglio delle rispettive sfumature e complessità.
Commedia dove non manca lo humour, che è quasi per intero nelle mani di Antonio Albanese, con
parecchi momenti godibili che suscitano più di una
risata. Alberto lo sceneggiatore è anche un pregevole indagatore del complesso rapporto tra realtà e
scrittura, un altro dei temi del film. Film che alla fine
infatti vedrà Alberto riprendere a scrivere, uscendo
dal suo stato di crisi, proprio la vicenda della famiglia dell’amico che l’ha conquistato, mostrando ai
suoi occhi scorci di realtà più vera delle sue storie
e di quelle che ricostruisce di frequente attraverso
l’osservazione minuziosa della gente. Un punto di
vista, quest’ultimo, molto vicino alla regista, che non
a caso gli dà come amici alcuni dei personaggi che
hanno popolato il proprio cinema, si veda il cameo
di cui si parlava poc’anzi.
In sostanza allora, questo Questione di cuore ci
permette di ritrovare l’Archibugi dei suoi tempi migliori, dal debutto Mignon è partita (1988) fino
a Il grande cocomero (1993).
Teresa Greco
The Reader
S tephen D aldry (USA - G ermania , 2009)
L’iniziazione sessuale e la relazione tra un ragazzo
quindicenne, Michael (David Kross) e una donna
trentacinquenne, Hanna (Kate Winslet), nella
provincia tedesca degli anni ’50 è all’origine della
storia raccontata in The Reader. Il regista Stephen Daldry ritorna da un lato al mondo degli adolescenti e alla loro crescita, temi già trattati in Billy Elliott (2000), dall’altro al concatenamento di
piani e scenari narrativi come nel precedente The
Hours (2002).
Nella prima parte assistiamo al rapporto tra i due,
mediato dal potere della narrazione e della parola:
la donna infatti ama farsi leggere dal ragazzo classici della letteratura. Nella seconda, lo sguardo viene
dirottato sul tema dell’Olocausto e sul senso di colpa che attraversa tutta una nazione, per spostarsi
poi sui singoli: sono passati più o meno una decina
d’anni e, da studente di legge, Michael scopre che la
donna, poi sparita senza lasciare tracce dalla sua vita
dopo qualche mese, è in realtà una delle imputate, in
qualità di kapò, di un processo ad impiegati di livello medio-basso dei lager di Auschwitz-Birkenau. La
narrazione procede su più piani temporali non concatenati, comprendendo anche l’oggi della vita del
protagonista, avvocato adulto (Ralph Fiennes).
The Reader ha suscitato più di una polemica,
come spesso quando viene trattato al cinema un
tema quale l’Olocausto; sia per le scene di nudo,
sia perché è stato accusato di essere troppo condiscendente verso le responsabilità dei tedeschi sulla
Shoah; infatti la scelta di un personaggio femminile
quale Hanna suscita alla fine la nostra pietà come
essere umano, anche per le sue dichiarazioni nel
corso del processo: l’ex carceriera afferma che per
lei quello di sorvegliante era un lavoro come un altro: l’ignoranza e l’incoscienza di quegli anni sull’intero meccanismo quindi, come origine degli errori.
La mancanza di informazione, la non consapevolezza
di quanto avveniva. D’altra parte c’è da dire che la
pellicola non mostra la minima indulgenza nei confronti della protagonista.
Film frutto di coproduzioni, Stati Uniti e Germania
in questo caso, ideato anche dallo scomparso Sydney Pollack, tra gli altri, The Reader è essenzialmente, nonostante l’ambientazione e la coppia di
attori europei protagonisti, un prodotto “americanocentrico”. Si capisce subito sin dall’inizio, quando
i libri del giovane, siano classici greci e latini o moderni e contemporanei, sono scritti in inglese; così
come nella seconda parte della pellicola, quando da
spettatrice passiva del sapere, Hanna decide di agire
ed imparare finalmente a leggere (era infatti analfabeta), è dall’inglese e dai libri in questa lingua che
imparerà. Controsensi che in epoca di globalizzazione “anglo americana” poco si tendono a notare ma
che fanno sicuramente la differenza.
Narrazione, oralità e memoria, personale collettiva
dunque i temi del film, tratto dal romanzo omonimo
di Bernhard Schlink (edito da Garzanti), adottato anche come libro di testo nelle scuole tedesche
e sceneggiato dal drammaturgo inglese David Hare.
Nonostante qualche incertezza e lungaggine, e tenendo conto dei controsensi linguistici su evidenziati, resta da segnalare anche un finale abbastanza
confuso e velleitario, nel quale si scontrano colpe
e responsabilità tra ieri ed oggi. The Reader si
risolleva però soprattutto per la vibrante e solo
apparentemente“fredda”, ma ragionata ed intelligente interpretazione della Winslet, che le ha fruttato giustamente un Oscar.
Teresa Greco
La Sera della Prima /
115
a night
at the opera
Schiff faccia a faccia
con Mozart
Il Bologna Festival prosegue la sua rassegna sui grandi interpreti, con una vecchia
conoscenza. Il pianista ungherese Andràs Schiff torna sotto le Due Torri con un
concerto per solo piano tutto dedicato a Mozart.
S
olo Mozart. Si ripresenta così, Andràs Schiff al
pubblico del Bologna Festival, con il quale, il pianista ungherese ha già una certa dimestichezza. Solo
Mozart. Una sfida, un faccia a faccia con il compositore salisburghese, un ritratto dei momenti più intimi del Wolfgang Amadeus pianista. In ogni caso, una
scelta ben precisa. Quella di proporre il repertorio
più significativo della storia dell’artista austriaco: il
periodo dell’abbandono definitivo della città natale
e della formidabile scoperta del pianoforte. Gli anni
a cavallo tra i ’70 e ’80 del Settecento, sono, infatti,
anni cruciali per la storia della musica, che segnano
l’inizio di un processo irreversibile: la trasformazione del compositore da semplice cortigiano a professionista autonomo, con tutte le conseguenze che
ciò determinò in seguito, con la nascita del Romanticismo e di un’arte per la prima volta svincolata
dalle catene del mecenatismo. Il famoso calcio nel sedere di Mozart all’arcivescovo di Salisburgo, suo protettore, è un gesto
emblematico della voglia di indipendenza artistica
diffuso all’epoca e presto divenuto il simbolo stesso
di una generazione di musicisti che, per la prima volta nella storia, rompono con un sistema produttivo
statico (anche se sicuro), provando ad autofinanziarsi attraverso l’organizzazione di concerti, lezioni
private e la diffusione delle partiture. Il fallimento
economico di Mozart è testimone, invece, della
fragilità di quello stesso sistema, ancora immaturo
per garantire al compositore una vita degna del suo
operato. Ma si sa, il pionierismo quasi sempre giova
ai posteri. Mozart scoprì i pianoforti di Johann Andreas
Stein ad Augusta nel 1777, durante uno dei suoi
viaggi. E fu amore a prima vista. Dotati di una meccanica agevolissima, predisposta per produrre una varietà timbrica e di tocco sconosciuta al clavicembalo
e al fortepiano, i pianoforti di Stein ben si adattavano
allo spirito innovatore di un Mozart ormai maturo
che, non a caso, avrebbe fatto dello strumento il
centro della sua produzione più matura. Produzione
a cui si riferice la scelta di Schiff, proponendo il lato
più sperimentale del compositore austriaco, rappresentato da generi come la variazione, ma incarnato
anche in pezzi isolati, di breve respiro, incompiuti o
semplicemente marginali. La sobrietà con la quale Schiff si confronta con
le due Sonate KV332 e KV570 è la diretta conseguenza di uno stile pianistico equilibrato, che riesce a mettere in luce sia gli aspetti leggeri, sia quelli
drammatici. Il musicista di Budapest accarezza i tasti
del piano senza mai abbandonarsi, se non nei finali,
a gesti strumentali eccessivamente intensi. Il suo è
un gioco di piccole sfumature, evidente negli abbellimenti, nelle pause riflessive, nei delicati rallentamenti, nelle fioriture improvvisate dal piano come
se fosse la voce di un soprano in un’Aria d’Opera.
Ma è nei due cicli di Variazioni, KV500 e KV455,
che vengono fuori più evidenti sia lo spirito sperimentatore di Mozart sia il virtuosismo di Schiff, che
è non solo precisione, ma anche (direi soprattutto)
attenzione alla varietà di effetti timbrici che risulta
dalle pagine del salisburghese, ancora intento a scoprire le magie del nuovo strumento. Quello scelto
e interpretato da Schiff, però, non è solo un Mozart che si mette in discussione guardando avanti,
verso nuovi linguaggi espressivi, ma anche (ri)scoprendo il passato, in particolare il contrappunto ba-
chiano, come si evince dalla Piccola Giga KV574,
che viene qui eseguita insieme al Minuetto KV
355/576b e alla Fantasia KV397, misterioso il
primo, ardita la seconda, con i suoi cromatismi e una
spiazzante libertà formale. Non è un boato quello del pubblico, ma un lungo
applauso che, comunque, riesce a richiamare Schiff
sul palco per tre bis. L’atmosfera diventa quasi confidenziale e il pianista magiaro, dopo lo stupendo
Adagio Per Glass Harmonica, una delle ultime
pagine scritte dalla penna del salisburghese, si abbandona al celeberrimo Allegro della Sonata n. 16
(uno di quei pezzi che quasi tutti conoscono, ma
nessuno sa come si chiamano) concludendo con la
Marcia Alla Turca, un brano talmente noto che
stimola nel pubblico, quasi fosse un riflesso incondizionato, la soffocata risatina di compiacimento di
chi vorrebbe dire “questo lo so pure io”!. Se ne va
così Schiff, con il Mozart più popular, dopo aver sezionato il suo spirito più recondito e avanguardista.
Un ritratto completo, in fondo, di un compositore
che ha sempre avuto due anime, e nel quale hanno
convissuto, sempre in un grande equilibrio, l’aristocratico e il popolare, il dramma e l’ironia, la semplicità e la complessità.
Daniele Follero
a night at the opera /
117
i cosiddetti
contemporanei
Cornelius Cardew
Da John Cage a Mao Tse Tung
Senza di lui l’Avanguardia inglese non sarebbe stata la stessa. O forse non sarebbe
neanche nata. Divulgatore in patria degli esperimenti aleatori di Cage, teorico del
grafismo e dell’improvvisazione radicale, risucchiato totalmente, poi, dall’ideologia
maoista e finito a comporre canzoni politiche, Cornelius Cardew appare ancora oggi,
a trent’anni di distanza dalla morte, uno dei personaggi più affascinanti e controversi
della musica europea del secondo Novecento.
“L’importante non sono gli errori che si commettono,
ma la capacità di ognuno di imparare da essi e cambiare direzione” (Cornelius Cardew)
S
ebbene nella storia europea e occidentale l’Inghilterra risulti spesso una nazione pioniera
nell’innovazione, nel bene e nel male (la rivoluzione
industriale e lo sfruttamento del lavoro operaio, la
democrazia e il colonialismo, la monarchia costituzionale, in entrambi i sensi), nel corso degli eventi
che riguarda l’ambito più ristretto della musica, non
si può affermare lo stesso. Se non proprio marginale, il ruolo innovativo e pionieristico dell’Inghilterra dei secoli passati, non ha certo avuto un peso
comparabile a paesi come l’Italia (dove nascono il
canto gregoriano, l’Opera) o la Germania e l’Austria
(patrie indiscusse del cosiddetto stile “classico”, ma
anche delle avanguardie “storiche”, a partire da
Schoenberg). La storia della musica anglosassone sembra aver sofferto un leggero ma consistente
ritardo rispetto al veloce fluire artistico dell’Europa
continentale. Il Novecento, è vero, rappresenta un’inversione
di tendenza, ma soltanto in alcuni ambiti (la popular
music) gli inglesi sono riusciti a sfondare gli argini
del conformismo. Un conformismo che li ha sempre contraddistinti, anche al di là del semplice immaginario popolare (non a caso il punk è nato lì e
non altrove: ad un’azione corrisponde sempre una
reazione uguale e contraria). Forse non sarà questo
il solo motivo per cui un movimento d’avanguardia
di una certa rilevanza, la Gran Bretagna non lo ha
mai avuto, ma resta il fatto che, se non fosse stato per Cornelius Cardew, un giovane musicista di
Winchcombe, nel Gloucestershire, affascinato dagli
ambienti di Colonia e New York, il silenzioso rumo-
re degli esperimenti di John Cage, così come i linguaggi radicali della Nuova Musica elaborata ai Ferienkursen di Darmstadt, avrebbero ancora tardato
a propagarsi nel terreno ormai fertile della musica
inglese degli anni ’60. Aveva appena 22 anni, Cardew, quando, uscito
dalla prestigiosa Royal Academy Of Music di Londra
con una buona reputazione di pianista (soprattutto
come interprete di Bach), riuscì, grazie ad una borsa di studio, a trascorrere un periodo di studi a Colonia, dove conobbe Karlheinz Stockhausen,
all’epoca molto indirizzato verso gli esperimenti di
musica elettronica. Il rapporto tra i due non risultò
per nulla idilliaco, nonostante il compositore tedesco abbia detto di lui: “come musicista era straordinario perché, oltre ad essere un buon pianista era anche
un ottimo improvvisatore, così gli chiesi di farmi da assistente”. Tre anni durante i quali, almeno secondo
quanto dice Stockhausen, Cardew ebbe la possibilità di lavorare sulla sua stessa partitura, un privilegio
mai concesso prima a nessun allievo. Quanta libertà
d’azione abbia avuto il musicista inglese, lo si può,
invece, dedurre dagli strascichi polemici che presto
portarono alla rottura tra i due.Troppo diversi i loro
approcci alla musica, con il razionalismo strutturalista del tedesco a cozzare con le idee improvvisative e già rivolte verso l’alea, dell’inglese. Il risultato
fu che Carrè (opera per quattro orchestre, cori,
piano, cembalo, arpa e vibrafono) uscì con la sola
firma di Stockhausen, mentre Cardew abbandonò
l’Europa per passare un po’ di tempo negli U.S.A.,
dove le idee sulla musica aleatoria di John Cage
e l’improvvisazione collettiva totalmente libera che
caratterizzava i primi passi del free jazz, meglio si sarebbero sposati con la sua prospettiva di “liberare”
l’esecutore dalle catene del compositore-padrone.
D agli esperimenti grafici di
T reatise all ’ improvvisazione
libera della AMM
Ritornato in patria nel 1961, ricco di esperienze
ma disoccupato, Cardew cominciò a porsi il problema dell’insegnamento, che per un musicista, sebbene rappresenti in ogni caso un problema etico, è pur
sempre un’utile e auspicabile forma di guadagno. Ma,
lungi da dargli il pane, almeno in una prima fase della
sua attività professionale, l’insegnamento diventerà
un vero e proprio cruccio artistico per Cornelius,
mentre i soldi gli arriveranno dal lavoro di “graphic
designer”. Un lavoro apparentemente innocuo, ma
che avrà la sua importanza nel processo di allontanamento definitivo del Nostro dalle tecniche seriali
e dodecafoniche che pure avevano contraddistinto
le prime composizioni (si vedano, ad esempio, i primi spartiti per pianoforte della seconda metà degli
anni ’50). Il problema dell’indeterminatezza, Cardew lo
risolse, in un primo momento, ricorrendo al grafismo, una tecnica compositiva che, abbandonando
i segni convenzionali della scrittura musicale, lega
l’esecuzione all’interpretazione di segni grafici che
nulla hanno a che fare con la semplice indicazione di
altezze determinate, lasciando liberi sia l’autore che
l’interprete (che si trasforma in autore a sua volta)
di stabilire nuove convenzioni attraverso indicazioni
e suggerimenti sulla partitura. Nasce così, Treatise,
una “graphic score” ispirata dall’opera del filosofo
Ludwig Wittgenstein e composta di linee, simboli, disegni geometrici e astratti. Risultato di anni di
riflessioni e di un periodo assai proficuo trascorso a
Roma al fianco di gente come Goffredo Petrassi (uno dei pochi compositori che si salverà dalla
condanna dell’”arte per l’arte” da parte di un Cardew trasformatosi in attivista politico) il Gruppo
d’Improvvisazione Nuova Consonanza e
Musica Elettronica Viva, la partitura, oltre a
centrarsi sulla capacità inventiva dell’esecutore, al
quale è lasciata molta libertà nelle scelte interpretative, esclude qualsiasi virtuosismo aprioristico, scardinando un altro muro che, secondo lui, costringeva
la musica ad un’eterna divisione tra professionisti
e dilettanti. Un concetto, questo, che sarà alla base
di tutte le esperienze didattiche di Cornelius e che
conduce direttamente alla Scratch Orchestra. Ma il
passaggio non è immediato, anzi.
”A dispetto dell’illusione di libertà delle partiture
grafiche come Treatise, le performance supervisionate
da Cardew lungo tutto l’arco del 1966 furono ancora
fortemente stilizzate, ben lungi da quella pura interpre-
i cosiddetti contemporanei /
119
tazione di segni cui il loro autore avrebbe voluto pervenire.” (Massimo Padalino). Il cammino verso la liberazione totale del suono è ancora lungo e passa per
l’improvvisazione. L’incontro con Keith Rowe, già
militante da qualche anno (insieme a Lou Gare, Eddie Prevost e Laurence Sheaff) negli AMM, fu, da
questo punto di vista, folgorante. Il contatto con un
combo di musicisti dediti ad una produzione musicale fortemente caratterizzata dal gesto e dal suo
risultato sonoro e legata al concetto più letterale
possibile di libertà esecutiva, ebbe un impatto fortissimo sulle idee di Cardew, personaggio, come si
vedrà, molto (fin troppo) disposto a mettersi in discussione. L’esperienza di Cardew negli AMM durò
un paio d’anni, ma fu tanto radicale quanto determinante: “L’improvvisazione mi aveva sempre terrorizzato; pensavo fosse qualcosa simile al comporre, ma
un milione di volte più veloce, un’impresa di cui sapevo
di non essere capace”. Nonostante le paure, però,
l’improvvisazione non solo divenne un punto fermo nella produzione successiva agli AMM (di cui è
d’uopo segnalare per lo meno AMMMusic 1966
-Elektra, un disco cardine per la free improvisation
di matrice anglosassone), ma anche il motore della
sua attività didattica, che nella seconda metà degli
anni ’60 si fece intensa e sempre più ideologicamente orientata.
A rte e politica : dalla
S cratch O rchestra alla
militanza Quando accettò la cattedra al Morley College
ed entrò a far parte del corpo insegnanti dell’Anti
University (sorta di bizzarra istituzione che si proponeva di rovesciare tutti i rapporti del sapere, in
perfetta sintonia con gli stimoli sessantottini), Cardew era già un convinto marxista-leninista. I corsi
furono un banco di prova importantissimo per la
traduzione musicale di certe idee socialiste, almeno
fino a quando il Nostro rimase legato ad un concetto di musica non propagandistico. Le lezioni, oltre
a prevedere momenti strettamente analitico-teorici
sull’improvvisazione radicale, comprendevano anche esercitazioni di esecuzione collettiva, basati su
una partitura del professore, The Great Digest,
idea embrionale di quello che sarebbe diventato il
suo ultimo capolavoro, The Great Learning. La
possibilità di prevedere organici mutevoli e che potessero comprendere musicisti dilettanti (cui erano
affidati strumenti ad altezza indeterminata come i
fischietti e le pietre strofinate) era alla base di questo collettivo. Idea, quella di un’organizzazione orizzontale, autodeterminata e anti-professionistica, che
divenne il chiodo fisso di Cardew.
La decisione di proseguire l’esperienza al di là
delle aule, fu il motivo principale della nascita della
Scratch Orchestra, un gruppo di musicisti con il
quale il compositore britannico sperimentò il “network principle”, un principio di organizzazione della
performance basato sulla divisione in piccoli gruppi
strumentali, che alternano le singole esecuzioni generandole da quelle precedenti. Una vera e propria rete
che si viene a creare dall’incastro tra le soluzioni musicali proposte dai singoli gruppi. Potremmo fermarci
qui o decidere di andare avanti, giacché qui si conclude il percorso artistico del Cardew sperimentatore e
comincia quello, completamente opposto, dell’attivista politico,“spogliatosi” di tutti i residui borghesi, per
dedicare le sue competenze alla causa maoista. Ora,
la dottrina politica derivata dalla rivoluzione culturale
di Mao, prevedeva il momento, fondamentale, dell’autocritica, alla quale nessuno poteva sottrarsi (ne sa
qualcosa Michele Santoro, espulso dal gruppo di
Servire Il Popolo, perché troppo poco “critico” con
se stesso –vedi Ferrante, La Cina non era vicina, Sperling & Kopfer, 2008). E infatti, con la convinzione che
contraddistingue i militanti, già a partire dal suo soggiorno a Berlino Est nel 1973, Cornelius cominciò a
mettere in discussione alla radice il concetto stesso
di arte “inutile”, e con esso il suo passato di artista,
facendo, con la stessa foga di una guardia rossa, un
rogo (solo metaforico, per fortuna) di tutta la sua
produzione precedente, senza salvare neanche grandi maestri come Cage e David Tudor. Stockhausen Serves Imperialism, testo che
raccoglie alcuni scritti-condanna rivolti alla musica
“borghese”, è emblematico già dal titolo, di quanto
fossero mutate le posizioni ideologiche di Cardew.
Che, di conseguenza, cominciò a comporre “per il
popolo”, attraverso un repentino quanto netto ritorno alla tonalità e alla semplicità della forma canzone.
Una scelta, a dir la verità, neanche così inusuale, dal
dopoguerra in poi, come testimonia la carriera di un
altro grande musicista comunista, Hanns Eisler, che
addirittura arrivò a comporre l’inno nazionale della
DDR. La produzione di questo periodo del musicista
inglese, è contrassegnata da canzoni concepite per
divenire inni, perfettamente rispondenti, nella loro
semplicità, ai dettami del realismo socialista. Canzoni che raccontano di lotte (Bethanian Song, Four
Principles On Ireland) o che riprendono direttamente canti di propaganda (Long Live Chairman Mao, Red Flag Prelude). Sono gli stessi
anni, per la cronaca, in cui Frederic Rzewski (già
in Musica Elettronica Viva) scrive le sue Variazioni sul tema di “El Pueblo Unido Jamas Serà
Vencido” degli Inti-Illimani. Un segnale in più
di quanto fosse diffuso l’ideale rivoluzionario anche
negli ambienti della musica d’avanguardia. Non è riuscito a ricredersi di nuovo, Cornelius.
Stroncato da un incidente stradale, il 23 Dicembre
del 1981, non ha fatto in tempo a rimettersi in discussione, come suo solito, né a bandire esperienze
come quella della People’s Liberation Orchestra, tutte concentrate nel recupero della tradizione folklorica, così come aveva fatto per la più lodevole Scratch Orchestra. Chissà quale nuova dimora
avrebbe trovato oggi per il suo spirito libero e senza
compromessi, quello sì, mai mutato nel tempo. Uno
spirito che, oltre ad infondere nuova linfa alle avanguardie europee, ha accompagnato la maturità del
rock inglese, a partire dalle raffinatezze jazz rock di
Canterbury e dalla militanza radicale di movimenti
come Rock In Opposition. L’esecuzione di Treatise
da parte dei Sonic Youth (Goodbye 20th Century, quarto capitolo della serie Syr) datata 1999, è
solo una delle tante soddisfazioni che oggi, Cardew
potrebbe prendersi, se fosse ancora tra noi, nei confronti della posizione alquanto marginale che finora
gli ha destinato la storia.
Daniele Follero
The Essential Cornelius Cardew • The Great Learning • Thälmann Variations • We Sing for the Future! • Four Principles On Ireland And Other Pieces • Treatise • Chamber Music 1955-1964 • Piano music 1959-70 • AMMMUSIC 1966 - (ReR Megacorp) • AMM The Crypt - 12 June 1968 (Matchless Recordings 1981) • AMM / MEV (Musica Elettronica Viva)- Live Electronic Music Improvised (1969)
i cosiddetti contemporanei /
121